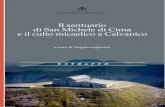a Michele e a Ilaria - Unisalento
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of a Michele e a Ilaria - Unisalento
Mariano Longo
L’ambivalenza della modernità
La sociologia tra disincanto e reincanto
STUDICollana a cura di Anna Grazia D’Oria,Giovanni Invitto, Marcello Strazzeri
92
Volume realizzato con il contributo del Miur
© 2005 Piero Manni s.r.l.Via Umberto I, 51 - San Cesario di Leccee-mail: [email protected]
Copertina di Vittorio Contaldo
Indice
7 Introduzione
CAPITOLO PRIMOLa modernità e i classici. Durkeheim, Simmel, Weber
19 1.1. Premessa. Dalla piramide alla sfera: l’individuo come principio ordinatore
27 1.2. Émile Durkheim: modernità, individuo, stabilità sociale41 1.3. Georg Simmel: modernità e vita dello spirito51 1.4. Max Weber: razionalità e disincanto
CAPITOLO SECONDOLa modernità semplificataHorkheimer, Adorno, Parsons
67 2.1. Premessa. La riduzione della complessità del moderno71 2.2. Critica della modernità illuministica: la Scuola di Francoforte85 2.3. La modernità normalizzata: Talcott Parsons
CAPITOLO TERZOCaratteri della modernità contemporanea
103 3.1. Premessa. La modernità/le modernità (?)106 3.2. Quale razionalità nella modernità contemporanea?
Jürgen Habermas, Niklas Luhmann115 3.3. La modernità contemporanea e il soggetto 117 Instabilità dei riferimenti sociali 118 Instabilità delle biografie120 Incertezza, rischio122 Da produttore a consumatore124 La crisi della rappresentanza126 Inclusione/(nuove) esclusioni
5
Introduzione
Il nesso tra sociologia e modernità non è solo storicamente deter-minato, nel senso che la sociologia nasce come ambito di studi inconcomitanza con il manifestarsi dei caratteri più tipici della societàmoderna. Quel nesso è anche costitutivo dell’identità disciplinare,dal momento che la sociologia appare all’osservatore come scienzadella crisi conseguente ai processi di disgregazione del vecchio ordi-ne e di graduale affermazione di nuove forme di organizzazione so-ciale1. La modernità rappresenta un momento di frattura e di di-scontinuità, tanto che la sua affermazione può essere analizzata, intermini sistemici, come catastrofe evolutiva, vale a dire come passag-gio ad un nuovo principio di stabilizzazione della struttura sociale2.Il pensiero sociologico, fin dai suoi esordi, è consapevole della pro-blematicità della transizione e per questo tematizza il passaggio dal-la società tradizionale alla modernità nella sua dimensione proble-matica. La sociologia delle origini è, dunque, scienza della crisi, va-le a dire un ambito disciplinare che cerca di legittimarsi come sape-re e come pratica scientifica in ragione della sua capacità di spiegarele trasformazioni sociali in atto, magari nel tentativo di proporrenon solo diagnosi accurate, ma anche possibili soluzioni dei proble-mi sociali emergenti3.
Il legame tra sociologia e crisi configura la disciplina come ana-lisi scientificamente orientata della modernità: se, infatti, il caratte-re più proprio del moderno è la costanza del cambiamento e dellamutevolezza4, se elemento che contraddistingue la modernità è unatensione costante indirizzata alla creatività distruttiva, e cioè la ten-denza a sovrapporre al vecchio il nuovo5, appare evidente il legamenon transitorio tra la nascente sociologia e il complesso dei fenome-ni cui siamo soliti dare il nome di modernità.
La sociologia degli esordi tematizza il mutamento sociale, le tra-sformazioni, i cambiamenti spesso repentini, da un lato nel tentati-vo di comprenderne le cause, dall’altro con uno sguardo rivolto alfuturo, con l’intento, cioè, di dar conto dei possibili ulteriori svi-
7
130 3.4. Reincanti 132 Reincanti politici134 Reincanti religiosi136 Reincanti mediatici
139 A mo’ di conclusione: la parzialità del reincanto
145 Bibliografia
6
ciologi possono chiedersi (come fanno da posizioni diverse Dur-kheim, Simmel, Weber) che cosa garantisca stabilità a una societàcaratterizzata da variabilità strutturale. La dimensione strutturaledell’ordine non è comunque la sola rilevante, nel senso che il con-tinuo mutamento incide sui soggetti, sulla loro capacità di dar sen-so e stabilità ad un ambiente costantemente perturbato. La moder-nità, per utilizzare una concettualità luhmaniana, è il luogo delleaspettative cognitive, il luogo cioè della disponibilità costante a ri-strutturare le attese8. Cognitiva è un’aspettativa se si lascia pertur-bare da ciò che si verifica nell’ambiente, imponendo al soggetto dirivedere i propri criteri di riferimento alla realtà: orbene, questa co-stante disponibilità al cambiamento delle attese, conseguente all’in-stabilità dei punti di riferimento sociali, non può che influire sulsoggetto e sulla sua capacità di venire a patti con il senso di ciò chelo circonda.
L’instabilità dei punti di riferimento (cognitivi, normativi, mora-li) diviene pertanto una delle chiavi di lettura del rapporto tra sog-getto e modernità. Quando l’osservazione del sociologo si volge al-l’attore sociale, la sociologia tenta di descrivere la condizione del-l’individuo moderno con l’utilizzo di termini, negativamente con-notati, i quali mirano a dimostrare le difficoltà dell’uomo contem-poraneo nella costruzione dell’identità personale, di linee di con-dotta coerenti, di una altrettanto coerente concezione del mondo: ilsingolo attore sociale percepisce la carenza d’integrazione e la tra-duce in insicurezza, in perdita di orientamento cognitivo9. Se “[la]modernità è l’epoca in cui il mutamento si fa norma, e tutto ciò cheè solido si dissolve per aria”10, ci si può legittimamente preoccupa-re dell’attore sociale, del suo smarrimento, evidenziando come es-so coincida con una perdita generalizzata di orientamenti normati-vi (anomia), o produca, quasi per reazione all’eccesso di stimoli,l’incapacità di uscire dalla logica del calcolo (intellettualizzazionedella vita nervosa), o ancora si converta nel disagio derivante dellanecessità che il soggetto avverte di uscire dalla gabbia d’acciaio pro-dotta dalla sua stessa tendenza a commisurare mezzi e fini.
La disgregazione (dei vincoli sociali, delle norme, delle creden-
9
luppi della società. Tutto ciò in un clima generalizzato di esaltazio-ne del progresso, che attiva una nuova concezione del tempo: nelfuturo si proiettano infatti le speranze nella realizzazione di una so-cietà migliore, in cui le contraddizioni del presente verranno elimi-nate e il vivere sociale apparirà, a seconda dei riferimenti teorici (oideologici) più razionale, più giusto, più equilibrato6.
Sebbene il mutamento sociale appaia il tema centrale attorno alquale si articolano le argomentazioni dei primi sociologi, l’idea diprogresso, che coincide con un’esaltazione in positivo delle trasfor-mazioni in atto, cede presto il passo ad una analisi meno ottimisti-ca, e per ciò stesso più realistica, dei problemi sociali (ma anchesoggettivi) derivanti dal cambiamento costante. Tranne eccezioni dirilievo (Auguste Comte in particolare) il pensiero sociologico clas-sico è stato in grado di sottrarsi ad una lettura acritica dei processidi mutamento.
I classici, piuttosto che analizzare la modernità come insieme diacquisizioni evolutive da accettare incondizionatamente, pongonocon forza la questione delle conseguenze del cambiamento, a livel-lo sia strutturale sia individuale. I primi sociologi possono così in-dividuare due livelli critici: il primo, relativo alle conseguenzestrutturali delle trasformazioni in atto, consente agli scienziati so-ciali di concentrarsi su fenomeni di ampia portata connessi, solo perfare alcuni rapidi esempi, alla crescente complessità sociale, al man-tenimento dell’ordine, alla crisi dei valori tradizionali. Il secondo li-vello è centrato sugli effetti che, a partire da quelle trasformazioni,si ripercuotono sui singoli attori, sulla loro percezione di se stessi edel mondo sociale, con una complessiva perdita di senso. La fran-tumazione di una comune visione del mondo viene connessa conuna sempre più marcata carenza di integrazione, spesso tematizza-ta come necessaria rinuncia alla sicurezza della comunità, in favoredelle incertezze della società.
Se, come afferma Jedlowski, “[l]a modernità è essenzialmentecrisi permanente, non solo e non tanto perché si radica in processiche sconvolgono progressivamente tutti gli ordini sociali tradizio-nali, ma perché il mutamento in se stesso è il suo principio”7, i so-
8
lando una duplice dimensione del sociale: una statica, al cui internoera possibile rintracciare le ragioni della stabilità, l’altra dinamica,capace di dar conto dei mutamenti e dei progressi sociali. Il proble-ma non riguarda l’individuazione di due ambiti sociologici tra diloro differenziati, bensì la necessità teorica, avvertita da Comte, didar conto del “duplice concetto dell’ordine e del progresso”. Alprimo concetto rimanda la statica, dal momento che “lo studio sta-tico dell’organismo sociale deve coincidere, in fondo, con la teoriapositiva dell’ordine, che non può infatti consistere essenzialmenteche in una giusta armonia permanente tra le diverse condizioni del-l’esistenza delle società umane”12. La dinamica sociale coincide in-vece con lo studio sistematico del mutamento, costituendo “neces-sariamente la teoria positiva del progresso sociale, la quale, elimi-nando ogni vano pensiero di perfettibilità assoluta e illimitata, deveridursi al semplice concetto di questo sviluppo fondamentale”13. Idue aspetti non appaiono in contraddizione, al contrario si integra-no, dal momento che “[l]’ordine e il progresso, che l’antichità con-siderava assolutamente inconciliabili, rappresentano sempre piùper la natura della civiltà moderna due condizioni egualmente im-portanti, la cui intima e indissolubile combinazione caratterizza or-mai e la fondamentale difficoltà e la principale risorsa di ogni verosistema politico”14.
Comte ha ormai acquisito consapevolezza del carattere mutevo-le della modernità e cerca pertanto di intravedere nel bilanciamen-to dei due concetti, non più contraddittori ma tra loro interdipen-denti, la soluzione dell’apparente opposizione tra stabilità e muta-mento: “nessun ordine reale –afferma infatti– può essere stabilito,né soprattutto durare, se non è pienamente compatibile con il pro-gresso; nessun grande progresso potrebbe effettivamente compier-si, se non tendesse infine all’evidente consolidamento dell’ordi-ne”15. Ma in che modo, per Comte, questa combinazione tra stabi-lità e mutamento diviene operativamente possibile?
In una società in cui il cambiamento appare insieme ineluttabilee costante, per far sì che esso assuma i caratteri positivamente con-notati del progresso, garantendo contemporaneamente contro il di-
11
ze magico-rituali) impone la sostituzione di ciò che è disgregatocon equivalenti funzionali credibili, pena l’incapacità generalizzatadi venire a patti con la mutevolezza assurta a norma. Non è quindiun caso che la sociologia si sia, fin dalle sue origini, proposta pro-grammaticamente come strumento di critica delle conseguenze delprogresso, della sua influenza sulle difficoltà individuali di costru-zione dell’identità11. I classici della sociologia hanno fatto oggettodella propria analisi la perplessità che consegue all’abbattimentodelle strutture sociali tradizionali, e ciò come riflesso soggettivodella dimensione strutturale del mutamento.
Come scienza del presente, la sociologia si pone fin dall’iniziol’obiettivo di spiegare le trasformazioni in atto, e tale obiettivo puòessere centrato solo tenendo conto del problema della aumentatacomplessità della società contemporanea. A tale aumento di com-plessità corrisponde, nella versione durkheimiana, l’estensione delmeccanismo di divisione del lavoro sociale, la quale ha la funzionedi garantire le molteplici esigenze di funzionamento che si manife-stano nella società contemporanea. Un incremento della differen-ziazione implica un aumento delle possibilità di azione individuale,un aumento della libertà. Il problema della disintegrazione del vec-chio ordine, nonché la questione della perdita di orientamenti sta-bili, sono correlati al processo che vede nella maggiore differenzia-zione sociale la caratteristica più tipica della struttura della societàmoderna. Se il vecchio ordine si disgrega, è necessario individuarenuovi meccanismi di integrazione, in grado di venire a patti con ladimensione, propriamente moderna, della mutevolezza e della col-laterale necessità di rinvenire nuove forme di stabilizzazione del-l’organizzazione sociale.
Il rapporto tra mutevolezza e stabilità è al centro della riflessio-ne sociologica dei classici. Già Comte aveva riflettuto su questionianaloghe, preoccupandosi dell’ordine sociale e del suo manteni-mento. Comte volle comunque mettere in evidenza come le ragio-ni della stabilità non potessero in alcun modo essere sovraordinateal progresso che, nella versione positivistica, appariva costante einarrestabile. Sul piano teorico, Comte risolse la questione postu-
10
Comte non nega dunque il fatto che le religioni tradizionali ab-biano ormai perso, nello stadio positivo, la capacità di fornire alsoggetto spiegazioni condivisibili del reale. Non per questo scom-pare il bisogno di integrazione e di coesione sociale a cui bisogna ri-spondere individuando adeguati equivalenti funzionali. Se, infatti,funzione prioritaria della religione è rispondere al bisogno di inte-grazione, fornendo una soluzione plausibile al problema della dis-soluzione della stabilità in presenza di una costante mutevolezzadel sociale, è necessario immaginare una fede razionale, compatibi-le con la fase scientifico-positivista di sviluppo dell’umanità. Que-sta fede, per quanto laicizzata, sembra a Comte in grado di fornireagli individui un comune bagaglio di valori socialmente condivisi.La religione appare così irrinunciabile anche nella modernità, ingrado come essa è di opporre la sua forza aggregante alle forze di-sgregative dell’egoismo e dell’interesse individuale, di fornire, dun-que, un punto di riferimento stabile contro la mutevolezza e le con-traddizioni del presente. Si tratta di una religione dell’Umanità, cheè da Comte concepita come tendenza verso una armonia di intentie di fini, come sintesi in cui convergono verso una meta comune lecomponenti individuali e collettive della società20.
In rapporto alla funzione integrativa del fenomeno religioso, losviluppo della società moderna non ha dato ragione a Comte. Ilprocesso di secolarizzazione, tipico della modernità, ha infatti gra-dualmente relegato l’esperienza religiosa nella sfera privata dei sog-getti e con ciò stesso ha delimitato la capacità della religione di pro-durre integrazione. Nel corso della sua evoluzione, la società ha do-vuto pertanto individuare nuovi meccanismi, propriamente moder-ni, di stabilizzazione del mutamento. Anzitutto, la forma assuntadallo stato di diritto nelle democrazie dell’Occidente industrializ-zato sembrava adeguata a garantire dalla costante instabilità tipicadel moderno. Derubricata la sua fase liberale, che lo impegnavaquasi esclusivamente alla garanzia dell’ordine pubblico e della pro-prietà privata, lo stato nazionale prendeva i caratteri del welfarestate, vale a dire di una forma di organizzazione politica che assu-meva compiti compensatori rispetto all’instabilità prodotta dalla
13
sordine e la frammentazione, Comte postula un nuovo ruolo di di-rezione e controllo affidato allo scienziato positivo. Nello stadiopositivo si attua il passaggio dal conoscere non-scientifico al cono-scere scientifico16, che consente agli uomini di “cessare di interro-garsi sull’origine assoluta o sugli scopi ultimi […]. In questo stadioil fine della conoscenza consiste esclusivamente nello scoprire le re-lazioni esistenti tra fatti osservabili”17. Lo stadio positivo nasce dalsuperamento degli stadi precedenti (quello teologico e quello meta-fisico), all’interno di una concezione processuale dell’evoluzionesociale: non si tratta, infatti, semplicemente di negare loro valoreconoscitivo, ma di mettere in evidenza –questa è l’interpretazioneche Norbert Elias dà della teoria della conoscenza di Comte– comelo sviluppo del sapere proceda per tappe intermedie, da forme pre-scientifiche a forma scientifiche di conoscenza, le prime essendopremessa delle ultime. Dal punto di vista cognitivo, la religione ap-partiene ad una fase antecedente allo stadio positivo, e da ciò deri-va per Comte la convinzione che essa abbia perso la capacità di for-nire plausibili spiegazioni del mondo e del ruolo che nel mondo ri-veste il singolo. La forza della razionalità scientifica impedisce diimmaginare un ritorno a un ruolo centrale del pensiero teologico,rendendo contemporaneamente vano ogni nostalgico tentativo diripristinare il vecchio ordine18.
Ciò che manca però a questa puntuale (e ancora non disincanta-ta) conoscenza scientifica della realtà, sono l’afflato etico e insiemela capacità di fornire ragioni per l’integrazione sociale: se la fase po-sitiva ha acquisito in capacità esplicativa, ha perso in relazione allapossibilità di fornire ragioni per la stabilità e l’integrazione. È que-sta necessità di legame, presente fin nell’etimologia del termine re-ligione, che fa emergere in Comte il convincimento nella necessitàdi un culto laico e positivo, che abbia il carattere di un insieme dinorme e valori condivisi in grado di raccordare le singole coscien-ze. La scarsa capacità del sapere teologico di approssimarsi al realenon impedisce a Comte di riflettere sulla funzione della religione,la quale, in quanto legata all’“ethos dell’affettività” può svolgere unimportante ruolo di regolazione sociale19.
12
nella perdita di rilievo dello stato nazionale. Che cosa produrrà tut-to ciò in relazione alla capacità della sociologia di ripensare e rico-struire le proprie categorie? La crisi attuale potrà risolversi, nell’in-dividuazione di nuovi fondamenti, di nuovi classici che integrino esuperino il pensiero dei founding fathers? Sono domande aperte, al-le quali il mio lavoro cerca di dare una prima risposta, che si basacomunque sull’individuazione dei modi diversi attraverso i quali lasociologia, fin dalle sue origini, ha reagito alla mutevolezza e all’in-stabilità del moderno. Il percorso che propongo è storico e insiemericostruttivo, nel senso che mio intento è quello di individuare nel-la modernità, intesa come tema centrale della riflessione sociologi-ca, il rapporto costitutivo tra sociologia e realtà contemporanea. Illavoro si articola in tre capitoli che rappresentano altrettanti snodidella frequentazione dei sociologi con il tema del moderno.
Quanto al modo in cui i classici hanno risposto teoricamente al-la crisi derivante dalla rottura del vecchio ordine, ho concentrato lamia attenzione sul rapporto tra mutamento strutturale e perdita disenso soggettivo. In quest’ottica ho analizzato Durkheim, Simmele Weber (Capitolo I), selezionando percorsi di lettura che da un la-to mi consentissero di delineare l’intelaiatura dei loro complessi ap-procci teorici, dall’altro di focalizzare la mia attenzione sul rappor-to tra mutamento strutturale, soggetto e modernità. Dai classiciemerge una lettura in chiaroscuro del moderno, in cui lo sguardomeravigliato per la grandiosità del processo convive con la preoc-cupazione per le sue conseguenze. Questa lettura ambivalente delmoderno ha consentito a Durkheim, Simmel e Weber una visionenon parziale della modernità, cui va connessa la capacità di struttu-rare categorie sociologiche per certi versi ancora persuasive.
Horkheimer e Adorno da un lato, Parsons dall’altro, sono statiassunti come poli antitetici di una sostanziale riduzione della com-plessità del moderno (Capitolo II). I Francofortesi propongonouna visione senza uscita della modernità, in cui si manifesta una al-leanza stretta tra razionalità e dominio. Ciò produce un senso dismarrimento che non riguarda tanto il soggetto (ormai in grado so-lo di legittimare lo stato attuale, in cambio di compensazioni deri-
15
modernità, in particolare dall’economia capitalistica. Si creava unaserie di supporti all’instabilità biografica del soggetto, strutturaticome grandi burocratizie (sistemi previdenziali, sanitari, educativi,ecc.) il cui compito era dare realizzazione concreta all’idea della so-stanziale eguaglianza dei cittadini, nella logica della garanzia dellepari opportunità.
Tutto ciò consentiva di configurare la modernità come moderni-tà solida (Baumann). Il mutamento diventava strutturalmente esoggettivamente tollerabile, e ciò grazie al nuovo ruolo della politi-ca la quale, senza pretendere utopisticamente di eliminare le disu-guaglianze, si assumeva il compito di delimitarle, garantendo con-temporaneamente al sistema economico la possibilità di riprodursiall’interno di una mitigata logica di mercato. La sistematizzazionedella sociologia, prodotta dai sociologi del Novecento, fa riferi-mento a questa modernità solida. Si tratta di una sociologia fiducio-sa (tranne eccezioni di rilievo, Horkheimer e Adorno in particola-re) nel fatto che sia possibile gestire razionalmente la complessitàsociale e, dunque, garantire, come aveva immaginato un secolo pri-ma Comte, stabilità nel mutamento. Se la modernità produce, se-condo la lezione di Weber, disincanto, è questo pur sempre un di-sincanto reso meno doloroso dalla crescita del benessere, dall’incre-mento delle possibilità soggettive, dalla stabilità delle biografie, dal-la generalizzata fiducia nel futuro come luogo di ulteriori acquisi-zioni.
Nella modernità contemporanea le cose cambiano, tanto che ilsociologo si trova nuovamente in una situazione per certi versi ana-loga a quella dei classici. Le vecchie concettualità sociologiche nonsembrano più in grado di fornire rappresentazioni plausibili delmondo contemporaneo. Si manifestano processi e fenomeni ineditia livello macro (la globalizzazione, la nuova rilevanza del rischio, larete come medium della comunicazione globale, per fare pochiesempi) a cui si affiancano processi e fenomeni localizzati (l’esalta-zione dell’identità locale, l’incertezza biografica, nuove forme del-la comunicazione, e con esse nuovi atteggiamenti e nuovi valori). Equesto all’interno di una crisi marcata della politica, che si traduce
14
Note
1 Cfr. tra gli altri E. V. Trapanese (1997), “La ‘grande trasformazione’ e le ori-gini del pensiero sociologico”, in Id. (a cura di), Sociologia e modernità. Problemidi storia del pensiero sociologico, NIS, Roma, pp. 15-46.
2 Cfr. N. Luhmann (1995), “Die Tücke des Subjekts und die Frage nach denMenschen”, in Id., Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch,Westdeutscher Verlag, Opladen, p. 161.
3 In posizione critica rispetto alla tendenza dei classici della sociologia di con-cepire la modernità come frattura, cfr. A. Appadurai (2001), Modernità in polvere,Meltemi, Roma, p. 15: “Una delle eredità più problematiche della teoria sociale oc-cidentale classica (Auguste Comte, Karl Marx, Ferdinand Tönnies, Max Weber,Émile Durkheim) è che ha costantemente avvallato l’idea di un qualche momentospecifico (detto il momento moderno) che con il suo apparire costituirebbe unafrattura drammatica rispetto al passato. Reincarnata come frattura tra tradizione emodernità, e tipologizzata come differenza tra società apparentemente tradiziona-li e società moderne, è stato dimostrato in più occasioni che questa prospettiva di-storce i significati del cambiamento e le concezioni riguardo al passato”.
4 Cfr. D. Frisby (1992), Frammenti di modernità. Simmel, Kracauer, Benjamin,Il Mulino, Bologna, p. 29 e sgg.
5 Cfr. D. Harvey (1993), La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano, pp. 31-32.6 Cfr. R. Koselleck, C. Meier (1991), Progresso, Marsilio, Venezia, in particola-
re p. 87 e sgg., ma cfr. anche R. Koselleck, (1986), Futuri passati. Per una semanti-ca dei tempi nuovi, Marietti, Genova.
7 P. Jedlowski (1995), Introduzione a G. Simmel, La metropoli e la vita dellospirito, Armando, Roma, p. 19.
8 Sul concetto di aspettativa normativa cfr. N. Luhmann (1977), Sociologia deldiritto, Laterza, Roma-Bari, p. 50 e sgg.
9 Cfr. U. Schimank (1985), “Funktionale Differenzierung und reflexiver Sub-jektivismus. Zum Entsprechungverhältnis von Gesellschafts- und Identität-sform”, in Soziale Welt, a. XXXVI, n. 4, p. 447.
10 P. Jedlowski (1995), op. cit., p. 19. 11 Cfr. O. Rammstedt (1985), “Zweifel am Fortschrift und Hoffen auf Indivi-
duum. Zur Kostitution der modernen Soziologie in ausgehenden 19. Jahrhun-dert”, in Soziale Welt, a. XXXVI, n. 4, pp. 483-502, il quale analizza il tema dellaperdita di fiducia nel progresso e la generale crisi delle certezze individuali in rife-rimento all’opera di Durkheim, Weber e Simmel.
12 A. Comte (1967), Corso di filosofia positiva, UTET, Torino, vol. I, p. 216.13 Ibidem.14 Ivi, p. 48.15 Ibidem.
17
vanti dalla tecnica e dai sistemi di welfare), quanto piuttosto l’intel-lettuale che ha perso fiducia nella capacità di intervento pratico del-la sua riflessione critica. Parsons produce una esemplificazione disegno opposto della modernità: l’ammirazione per il processo ditrasformazione, che per lui prende la forma di un incremento di ca-pacità adattiva del sistema sociale, gli impedisce di riflettere sulleimplicazioni soggettive e strutturali del mutamento. In entrambi icasi, emerge l’immagine di una modernità senza scampo, concepibi-le come destino.
Nel dibattito attuale, seguendo la traccia del rapporto tra cam-biamenti strutturali e loro conseguenze soggettive, la crisi dellestrutture sociali che hanno dato alla modernità il suo carattere soli-do (lo stato nazionale, le politiche di welfare, la stabilità del rappor-to di lavoro nelle grandi aziende, ecc.) si traduce in una perdita dicertezze per il soggetto, ma anche in una generalizzata perdita dipersuasività dei presupposti teorici sui quali si era fondata l’analisisociologica della modernità. In particolare, viene messa in discus-sione l’idea di razionalità, sia allo scopo di proporne una rivaluta-zione in chiave comunicativa (Habermas), sia nel tentativo di evi-denziarne la parzialità come strumento utile per il controllo delleemergenze ambientali (Luhmann). Ecco perché all’interno di que-sta crisi realizzo un primo approccio ad alcuni possibili processi direincanto. Se Weber poteva legittimamente sostenere che l’afferma-zione della razionalità occidentale producesse, insieme al processodi modernizzazione, anche la perdita delle antiche certezze e la ca-duta delle vecchie divinità, è plausibile affermare che la crisi attua-le della razionalità può concretizzarsi in nuovi reincanti, la cui fun-zione è quella di compensare l’insicurezza e la rischiosità della mo-dernità contemporanea, percepite a livello individuale e collettivo.Il quadro che emerge dalla sintesi proposta è quello di una sociolo-gia alla ricerca di strumenti concettuali capaci di dar conto dellamodernità contemporanea, al cui interno sono però già individua-bili linee di convergenze che potrebbero produrre un rinnovamen-to profondo del nostro modo di intendere il mondo e la società.
16
CAPITOLO TERZO
Caratteri della modernità contemporanea
3.1. Premessa. La modernità/le modernità (?)
Ciò che accomuna, al di là delle differenze, approcci diversi inrelazione all’analisi della modernità, è il richiamo a un bagaglio co-mune di concetti, in parte derivati dai classici, che hanno acquisito,soprattutto a partire dalla standardizzazione accademica della so-ciologia, lo statuto di concetti chiave attraverso cui spiegare e com-prendere la realtà sociale. Basterebbe osservare la struttura di unqualsiasi manuale di sociologia, al cui interno la disciplina si pre-senta al lettore in forma compendiata e semplificata: i temi dellaclasse, della stratificazione, delle differenze e delle ineguaglianze, lequestioni relative ai valori e alla loro dissoluzione, la secolarizza-zione, la famiglia, l’istruzione, la religione, ecc. sono i presupposticoncettuali attorno a cui si struttura la disciplina. In quanto presup-posti, non sono messi in discussione, semmai li si analizza tenendoconto di come sotto-paradigmi sociologici (in genere il funzionali-smo e la teoria del conflitto) tendano a sottolineare, in riferimentoai concetti chiave, una accresciuta o diminuita razionalità (e dunquegiustizia ed equità) della società moderna rispetto alle società delpassato. Beck parla del permanere, nella sociologica contempora-nea, dell’asse Marx-Weber e ironicamente così si esprime: “ […]nella sociologia, al di là di tutte le contraddizioni teoriche, predo-mina sempre sulla modernizzazione un grande consenso Ma(r)x-Weber, ancora in gran parte integro”1.
Ciò dipende probabilmente dal fatto che la sociologia (funzio-nalista o critica poco importa) è sì prodotto della modernità, ma èanche responsabile dell’idea che la modernità sia concepibile comeprogetto: un progetto complessivamente emancipante (dalla mise-ria, dalle superstizioni, dal mito, dalle disuguaglianze). Le diverseprospettive teoriche non mettono in discussione il progetto nel suo
103102
concetti in grado di dar conto della contemporaneità, forse a parti-re dai classici, ma sicuramente oltre i classici. La costruzione dinuovi concetti in grado di dar conto della complessa situazione at-tuale è allo stadio iniziale del work in progress. Ciò implica che par-te della difficoltà legata alla analisi dell’attuale fase della modernitàè da rintracciare non tanto, e non solo, in qualche suo carattere so-stanziale (il passaggio dallo stadio solido a quello liquido, ad esem-pio) quanto piuttosto in un problema di prospettiva temporale:mentre la teoria sociale ha potuto elaborare con comodo una de-scrizione plausibile della prima modernità, la sociologia contempo-ranea ha solo di recente intrapreso un percorso di adeguamentodella propria concettualità alle trasformazioni in atto.
Ciò che si può asserire senza eccessivi timori di essere contrad-detti, è che la modernità che stiamo vivendo non si presenta con icaratteri di una cesura netta rispetto alla prima modernità, bensì co-me un approfondimento e una accentuazione di alcune sue caratte-ristiche essenziali. Si prenda ad esempio il principio di individualiz-zazione, quel principio, cioè, che ha consentito alla prima moder-nità di fare riferimento all’individuo al di là e oltre le connotazionisociali: esso permane come carattere della modernità contempora-nea, assumendo però nuove e più radicali connotazioni, anche inrelazione allo svuotamento delle categorie di classe, di ceto, di na-zione intese come contenitori identitari per i soggetti (Beck, Bau-mann, Appadurai). L’individuo affronta nuove sfide di fronte al-l’accresciuta complessità sociale, e ciò spinge legittimamente i so-ciologi a parlare di nuovo individualismo3 – ciononostante, si trat-ta pur sempre di un individualismo che si costruisce sulla logicadell’achievement contro quella dell’ascrizione.
Allo stesso modo, la società moderna ha acquisito consapevolez-za di sé, ha assunto come ineliminabile la sua costante mutevolezza,ha tentato di applicare a contesti periferici i processi che si eranoprodotti spontaneamente in Occidente e, infine, ha cominciato a ra-gionare sulla specificità e in certa misura sull’inefficacia delle proprieautodescrizioni. È a questo che ad esempio si riferisce Beck quandoparla di una sorta di modernizzazione della modernità, esemplifica-
105
complesso, semmai si differenziano in relazione alla diversa perce-zione del suo grado di attuazione, nonché ai mezzi diversi indicatiper portarlo ad effettivo compimento2. Se si parte dal presuppostodella sostanziale correttezza di quel progetto, si può supporre chele promesse della modernità, per esempio delineate con fiducia daParsons (più inclusione, più democrazia, più benessere complessi-vo, maggiore comunicazione, maggiore coinvolgimento dei sogget-ti), non hanno trovato pieno adempimento, il che implica la neces-sità di riprenderle in una nuova ottica, in cui alla delusione per laragione espressa dai Francofortesi, subentri una nuova concezione(comunicativa) della razionalità. È questa la prospettiva rinvenibilein Habermas, per il quale la modernità va riattualizzata a partire daquegli aspetti del progetto moderno rimossi o rimasti inattuati. Inquesta prospettiva, la modernità del moderno va difesa contro lederive postmoderne che fondano la forza delle loro argomentazio-ni su una negazione sostanziale della correttezza degli ideali su cuiessa si fonda. Oppure, non rinunciando al concetto di modernità erifiutando le impostazioni postmoderne, si può sottolineare comefattori nuovi, legati alla globalizzazione, al rischio, al parziale esau-rimento del progetto moderno, impongano di riflettere sulle cate-gorie fondative della modernità, quella di razionalità in particolare(si leggano, tra gli altri, Luhmann, Beck, Giddens).
È comunque in corso una ridefinizione concettuale del lessicosociologico, di cui è prova la difficoltà di definire in maniera univo-ca la modernità contemporaena. Si tratta di una modernità qualifi-cata, una modernità che, non bastando a se stessa, ha bisogno diqualificazione. Faccio ricorso (solo una volta) a quest’espressionenon allo scopo di aggiungere un’ulteriore, e poco efficace, defini-zione della modernità contemporanea, ma semplicemente per ac-cennare alla difficoltà di individuare una base terminologica comu-ne. Viviamo la post-modernità o la modernità liquida, la tarda mo-dernità o la seconda modernità, una modernità in polvere (o at lar-ge, cioè in fuga) oppure una modernità riflessiva? Non lo sappiamoancora: si può però intuire che i problemi di definizione indicanoinsieme difficoltà e crescita, indicano cioè la necessità di costruire
104
tomi di una profonda crisi della modernità, che si sarebbe manife-stata solo più tardi: forse per questo l’idea di società postmodernagli sembra semplicemente priva di capacità esplicativa. Che sensoha interrogarsi sul post della modernità, quando ancora la societàmoderna non ha trovato piena realizzazione?
Quando entrano in crisi i presupposti su cui si fondava lo strut-tural-funzionalismo, si avverte forte il bisogno di ripensare all’otti-mismo parsonsiano, magari recuperando una critica della raziona-lità e del progresso con forti coloriture francofortesi. Alla crisi del-la modernità, ci spiega Alain Touraine, si può rispondere in duemodi alternativi. La prima risposta, “quella dei postmodernisti, af-ferma che la scomposizione [della modernità] è irreversibile; la se-conda, dichiara che la modernità può e deve essere difesa e addirit-tura estesa”7. È a questa seconda, possibile, risposta che è legata lariflessione di Jürgen Habermas, per il quale il postmoderno nasce-dalla convinzione “che si sia verificato uno sganciamento tra mo-dernità e razionalità”8. Viene dunque meno quel connubio che, daWeber fino a Parsons, per giungere ai teorizzatori funzionalisti delprocesso di modernizzazione e delle teorie della convergenza, ave-va sorretto l’idea sociologica di modernità: il moderno inteso comepieno sviluppo e diffusione planetaria della razionalità occidentale.A questa idea, il postmoderno, anche sulla scorta della riflessionefrancofortese, oppone una ragione finalmente “smascherata comesoggettività assoggettante e al contempo soggiogata, come volontàdi impadronimento strumentale”9.
La modernità, afferma Habermas riferendosi a Koselleck, hamodificato radicalmente il rapporto con il passato e il futuro. Lad-dove il passato era nelle società premoderne il luogo in cui si eranoconsolidate esperienze che assumevano i tratti rassicuranti di aspet-tative fondate sulla tradizione, la modernità sostituisce alle attesefondate sulla ripetizione del medesimo, aspettative non più ancora-te al passato, bensì rivolte al futuro. Con la modernità, alla rilevan-za di un passato inteso come modello e direttiva si sostituisce l’im-magine di un futuro concepito come realizzazione costante delnuovo. Questa presenza continua della novità viene esorcizzata at-
107
ta nel concetto di modernità riflessiva la quale “deve significare: au-totrasformazione della società industriale” per la quale “la primamodernità deve dissolversi nella seconda, i cui contorni e principidevono essere scoperti e modellati”4.
C’è però da chiedersi: basta alla coscienza del sociologo propor-re il superamento della prima modernità come soluzione della crisidella modernità? Basta, cioè, individuare nuove etichette allo scopodi descrivere la fase attuale della società moderna? È sufficiente evo-care la fine della modernità, magari sotto l’etichetta del post-moder-no, per voltare pagina e, contemporaneamente, individuare soluzio-ni (sociologiche) per la molteplicità di questioni sul tappeto?
3.2. Quale razionalità nella modernità contemporanea?Jürgen Habermas, Niklas Luhmann
Il concetto di post-moderno è più datato di quanto non si pensisolitamente5. Già Talcott Parsons, nel 1973, metteva in guardia ri-spetto all’ipotesi che si fosse giunti ad una fase “post-moderna”della società, dal momento che gli sembrava ancora lontana la rea-lizzazione piena dei caratteri che egli aveva individuato come tra ipiù tipici della modernità (ad esempio la crescita della capacità adat-tiva e dell’inclusività del sistema, la preferenza per le componentiGesellschaft delle variabili strutturali). È evidente che la fase dellamodernità non durerà per sempre, eppure bisogna dar tempo, sem-bra dire Parsons, alla società moderna perché realizzi se stessa, pri-ma che sia sensato derubricarla tra i modelli passati di società:
Il parlare oggi di una società “post-moderna” è […] decisa-mente prematuro. Pur tenendo conto dell’innegabile possi-bilità di distruzione totale, ci aspettiamo tuttavia che la ten-denza prevalente del prossimo secolo sarà verso un comple-tamento di un tipo di società che chiamiamo “moderna”6.
Quando scrive queste parole, Parsons non avverte ancora i sin-
106
Habermas è uno dei più strenui difensori della ragione, la cui di-fesa si attua però non a partire da una ingenua accettazione della ra-zionalità strumentale, bensì dal superamento dell’idea, nata all’in-terno dell’economia politica classica, secondo cui un soggetto iso-lato sia in grado, poiché libero e autonomo, di garantire con le suescelte razionali benessere a sé stesso e ordine al mondo. La conce-zione habermasiana tenta di superare il soggettivismo di questa e dialtre impostazioni, proponendo di sostituire alla razionalità fonda-ta sul soggetto una razionalità basata sul dibattito e sulla comuni-cazione, dunque sulla possibilità, garantita ai singoli attori, di criti-care le pretese di altri attori, all’interno di interazioni la cui finalitàprioritaria è l’intesa14.
Nel frattempo, ci si è accorti però della debolezza della raziona-lità, che diventa tanto più marcata quanto più differenziati e com-plessi divengono gli ambiti sociali cui essa si applica. Ci si è gradual-mente resi conto che il tentativo di attuare il progetto razionale del-l’Illuminismo (come ogni tentativo di attuare un qualsiasi progettoche abbia di mira la trasformazione pianificata della società) ha pro-dotto e produce effetti contrari a quelli immaginati. Gli studiosi delwelfare hanno da tempo individuato il paradosso per cui disugua-glianze specifiche vengono prodotte proprio da quelle politichepensate come strumento di delimitazione delle differenze sociali15.Allo stesso modo, i fenomeni di esclusione non vengono circoscrit-ti, ma spesso accentuati, dalle ricette politiche, non importa quantoarticolate e sofisticate, e ciò non per la loro mancata implementazio-ne, ma proprio a causa della loro implementazione16. Se la ricetta ti-picamente moderna era configurabile come incremento delle politi-che sociali (ancora più istruzione, ancora più supporti assistenziali,miglioramento della progettualità), la crisi fiscale e ideologica dei si-stemi di welfare, connessa ai processi di globalizzazione in atto e al-la conseguente sempre minore centralità dello stato, pone seri vin-coli all’allargamento delle forme statali di intervento.
Di fronte al sostanziale fallimento del progetto illuministico, sipuò tentare una sua strenua difesa immaginando nuove forme di ra-zionalità in grado di rimetterlo in carreggiata. Oppure, orfana di
109
traverso l’idea di progresso: si è persuasi che il processo storicoconsista in un’innovazione rivolta al miglioramento costante, di cuisi conoscono a grandi linee i tratti.
Tutto ciò comporta, osserva Habermas, una difficoltà, legata al-la concezione del progresso come trasformazione indirizzata versotraguardi almeno in parte noti. Le aspettative rivolte al futuro assu-mono caratteri predefiniti (ad esempio nelle diverse versioni dellafilosofia della storia). L’idea di progresso contrasta l’ansia legata adaspettative ripetutamente deluse, normalizza il futuro, rendendolosoggettivamente e socialmente meno oscuro. Ciò produce però esi-ti per certi versi paradossali, legati al “[…] fatto che il concetto diprogresso non è servito soltanto […] a realizzare l’apertura utopicadell’orizzonte delle aspettative, bensì anche a ostruire […] quellafonte di inquietudini che è il futuro”10. L’idea di progresso, renden-do in certa misura meccanica l’apertura delle aspettative al futuro,nega a quest’ultimo “la qualità del nuovo, l’accentuazione dell’ini-zio imprevedibile”11.
Secondo Habermas, che in ciò fa riferimento a Benjamin, l’oriz-zonte temporale della modernità non può accontentarsi della sem-plice proiezione quasi meccanica verso un futuro prefigurato comeprogresso o innovazione. È necessario, infatti, tener conto di unpassato in cui si sono sedimentate aspettative deluse, che invece van-no rimemorate allo scopo di recuperare alla modernità aspetti che lastoria ha rimosso, sottaciuto, occultato. Si effettua, così, una opera-zione anamnestica che non serve solo come riparazione verso la ri-mozione del passato, ma anche come risorsa per il futuro12. È inquest’ottica, che accetta la prospettiva temporale del moderno inte-grandola con uno sguardo rivolto al passato e alle sue potenzialitàinespresse, che la modernità può apparire ad Habermas come pro-getto incompiuto: il problema non è quello di aderire alla critica po-stmoderna della modernità bensì, al contrario, quello di individuarele promesse mancate del moderno, anche allo scopo di operare unloro recupero, utilizzando non più forme strumentali di razionalità,fondate sulla capacità di calcolo di un soggetto isolato, bensì una ra-zionalità di nuovo tipo, basata sull’intesa nella comunicazione13.
108
rappresenta al contrario null’altro che “il pieno sviluppo dei mediadella comunicazione e della differenziazione funzionale”, cioè deicaratteri più tipici della modernità, i quali hanno oramai raggiuntodimensioni tali da porre “la società moderna su un piano di irrever-sibilità”19.
Tutto ciò non implica che la modernità contemporanea si pre-senti con gli stessi caratteri della prima modernità: il sistema socia-le diventa sempre più complesso, consolida la sua globalità comesocietà del mondo e, contemporaneamente, si affanna per garanti-re, a livello locale, inclusioni sempre più improbabili. Pur tuttavia,accentuando i meccanismi che consentono ai sistemi funzional-mente differenziati di operare, la modernità contemporanea mani-festa appieno l’improbabilità del progetto illuministico. Operandoa regime, infatti, i sistemi sociali tendono ad accentuare esponen-zialmente piccole differenze iniziali: solo chi ha denaro può ottene-re credito, solo chi ha doti naturali o capitale culturale può sfrutta-re appieno i vantaggi dell’istruzione20. Ciò implica che l’operare au-tonomo dei sistemi sociali produce da sé un numero maggiore diesclusioni di quante non siano tollerabili per le idee illuministichedi uguaglianza ed equità21. Rifiutando l’idea di post-moderno e ri-manendo ancorato alla convinzione parsonsiana che la piena mo-dernità sta ancora costruendo se stessa, Luhmann può osservare lasocietà contemporanea con sguardo distaccato. Gli ideali illumini-stici, sui quali la modernità ha costruito le sue rappresentazioni del-l’individuo e della società, appaiono per quello che sono: non i re-sidui accantonati di un passato da recuperare, bensì semantiche pri-ve di riferimenti oggettivi, modalità dell’autodescrizione della so-cietà.
Il tempo che Luhmann rivendica per la modernità è un temponon pianificato. Mentre l’Illuminismo aveva visto nella ragione lostrumento per attuare, in un futuro che diventava il luogo di realiz-zazione di aspettative sociali diffuse, un progetto complessivo di ri-forma e trasformazione, ora appare sempre più chiaro che la com-plessità sociale non è efficacemente governabile: la pianificazioneha, infatti, il più delle volte, effetti contrari a quelli progettati. La
111
concetti in grado di dar senso alla sua spiegazione del sociale (sta-to, nazione, equità, uguaglianza), la sociologia può attivare nei con-fronti della sua capacità esplicativa forme di disincanto, spesso te-matizzate come crisi. C’è però una terza possibilità: assumere ledifficoltà concettuali e esplicative come altrettanti motivi di aggior-namento del nostro bagaglio concettuale. Mi pare che il discorso at-tuale sulla modernità e sulle sue qualificazioni in autori come Bau-mann, Beck, Giddens, Appadurai, Luhmann solo per citarne alcu-ni, costituisca un tentativo di venire a patti con la modernità delmoderno e, dunque, con i caratteri instabili e mobili della societàcontemporanea. A ben guardare, infatti, il problema non è tantoche la società contemporanea si presenta con i caratteri della novi-tà: la società cambia, a prescindere dalla capacità di analisi dei so-ciologi e, d’altronde, la modernità, almeno a partire da Baudelaire,è “il transitorio, il fuggitivo, il contingente”17. Il problema è piutto-sto che i cambiamenti in atto mettono in crisi l’immagine consoli-data della modernità, i presupposti (in gran parte illuministici) sucui si è strutturata l’esaltazione (strutturalista) e la critica (conflit-tualista) dei caratteri del moderno. Si attiva così una riflessione sul-la modernità contemporanea, sulla sua crisi, la quale manifesta unaprofonda autoconsapevolezza del moderno.
Di questa autoconsapevolezza, individuata da Beck come carat-tere contemporaneo del moderno, il testimone forse più acuto èstato Niklas Luhmann il quale, in una prospettiva teorica diversa(per molti versi antitetica) rispetto a quella habermasiana, riprendel’idea espressa da Parsons secondo cui, sebbene il moderno abbiaoramai consolidato i suoi caratteri strutturali, è ancora prematuroteorizzare la transizione a una fase che lo superi e lo modifichi ra-dicalmente. A partire dalla connessione tra tempo e modernità, per-de consistenza l’idea stessa di postmoderno, e ciò per ragioni diver-se da quelle individuate da Habermas. Non sembra ci siano perLuhmann ancora indizi della nascita di una nuova struttura dellasocietà, che configuri nuove forme della differenziazione, nuovisottosistemi sociali, nuove modalità dell’etero e dell’autoreferen-za18. Quello cui alcuni si riferiscono con il termine post-moderno
110
alla complessità del reale, unita al convincimento costruttivista chenon esistono rappresentazioni oggettive, ma solo selezioni dell’os-servatore dall’infinita complessità della realtà.
L’incertezza, che per molti sociologi è il tratto più tipico del-l’epoca in cui viviamo, assume così in Luhmann un carattere strut-turale: non riguarda infatti solo il singolo attore, bensì nel suo com-plesso la comunicazione sociale, i suoi esiti e, in particolare, gli esi-ti delle decisioni socialmente rilevanti. Si tratta, dunque, di una in-certezza consapevole, in cui il non sapere è concepito come uno deicaratteri più marcati della modernità attuale: non solo una moder-nità in cui aumentano i rischi sociali e le incertezze soggettive e col-lettive, ma anche una modernità nella quale si avverte forte la disil-lusione per la razionalità strumentale la quale, dopo aver contribui-to a dare avvio alla società moderna, sembra ora incapace di forni-re soluzioni plausibili a problemi concreti. In che modo scegliere,ad esempio, tra rischio ambientale legato al nucleare e rischio deri-vante dall’effetto della combustione degli idrocarburi sul clima glo-bale? È possibile attuare una scelta razionale, capace di individuareil percorso meno rischioso? O non è invece, in assenza di elementicerti, preferibile differire la scelta? Ma l’eventuale differimento del-la decisione non implica già una decisione (magari di natura politi-ca o, nella peggiore delle ipotesi, elettorale)?
Al posto della fede compromessa nella ragione, subentra la con-sapevolezza dei suoi limiti. Rimane aperta la questioni di come ga-rantire che il sistema sociale continui a riprodurre se stesso, trasfor-mando insicurezze in motivi perché la comunicazione, comunque,continui. Sembrano infatti esser venuti meno, in questa situazionedi incertezza diffusa, i meccanismi tradizionali (in particolare l’au-torità e la competenza) sulla cui base la società aveva provveduto ariassorbire le incertezze. Si tratta di una questione aperta anche perLuhmann, il quale, però, rifiuta soluzioni facili o di compromessoe si chiede se la riflessione sociologica sull’incertezza e sul non sa-pere possa permettere alla società “di sviluppare figure di pensiero,con le quali essa possa tollerare l’inosservabilità del mondo e far di-ventare produttiva la non trasparenza”25.
113
società appare come contingente, instabile, incapace di controllaree gestire il proprio ambiente. Nella prospettiva sistemica, infatti,l’ambiente è sempre troppo complesso perché il sistema possa pro-durre su di esso effetti durevoli: al sistema è ignoto l’insieme delleinterdipendenze ambientali e, per questo, esso opera, nella miglio-re delle ipotesi, in condizioni di razionalità limitata, tenendo contodei soli aspetti dell’ambiente di cui è a conoscenza22. Ma se il siste-ma sociale non riesce a cogliere la complessità del presente, qualesarà la sua capacità di prevedere il futuro? È possibile dar creditoall’idea positivistica di progresso, nel momento in cui cede il passola nostra convinzione che la razionalità possa fornire, nel presente,i mezzi per raggiungere obiettivi futuri? Questa sfiducia nella ra-zionalità assoluta manifesta i limiti della capacità previsionale dellascienza, della sociologia in particolare: sempre più circoscritta ap-pare, rispetto a quanto si credeva in passato, la nostra capacità diprevisione, dunque la capacità di descrivere il futuro come futuropossibile23.
In questa modernità, che ha consolidato i suoi caratteri (la diffe-renziazione funzionale, i media della comunicazione) fino a render-li irreversibili, è possibile attivare descrizioni della società insiemepiù plausibili e meno consolatorie di quelle proposte dai continua-tori del progetto illuministico. A livello della teoria della conoscen-za, si fa strada la consapevolezza che tali descrizioni, prive di refe-renti oggettivi nel mondo, si fondano su distinzioni e sono, dun-que, costruite da colui che osserva, il che implica la messa al bandodel convincimento positivista che la conoscenza derivi da una effet-tiva congruenza tra osservazione e fenomeno osservato24. A livellosociale, ciò rafforza il dubbio che ci possa essere una conoscenzapuntuale degli ambienti del sistema sociale: viene così messa in di-scussione la capacità del sistema di programmare (anche in manie-ra razionalmente limitata) il suo intervento sull’ambiente. Luh-mann definisce questa discrepanza tra complessità dell’ambiente econoscenza che dell’ambiente ha il sistema Nichtwissen, cioè igno-ranza, non sapere. Si tratta, invero, di un’ignoranza prodotta dal-l’acquisizione, tipicamente moderna, della consapevolezza relativa
112
zione teorica, è però probabile che essa contribuirà ad un rinnova-mento necessario all’interno della sociologia, la quale potrà cosìcontinuare a fornire rappresentazioni plausibili del mondo contem-poraneo e delle trasformazioni che si attuano al suo interno.
3.3. La modernità contemporanea e il soggetto
Nonostante le difficoltà cui sopra accennavo, è possibile indivi-duare alcuni caratteri emergenti nel dibattito sociologico, senzapretendere di fornire una sintesi completa né di articolare un qua-dro omogeneo. Coerentemente con l’impostazione data alla letturadei classici, anche in questo caso mi concentrerò, in particolare, sulrapporto tra individuo e struttura sociale, con l’intento di metterein relazione le trasformazioni strutturali in atto e i loro riflessi suisoggetti e sulle biografie. Prima di sintetizzare e di connettere fram-menti del dibattito attuale, mi sembrano però opportune alcuneconsiderazioni preliminari. La discussione attuale si concentra inparticolare sull’aumento dell’instabilità, delle incertezze, del ri-schio. Ciò rende la fase attuale della modernità per certi versi com-parabile alla sua prima fase, quella sottoposta ad analisi critica daparte dei classici. Sarebbe pertanto erroneo costruire una dicotomiatra prima modernità, intesa come luogo delle certezze e della stabi-lità, e modernità attuale, al cui interno quelle certezze e quella sta-bilità si dissolvono irrimediabilmente. Una dicotomizzazione diquesto tipo tenderebbe, infatti, ad idealizzare la prima modernità,attribuendole caratteri astorici e, perciò stesso, poco realistici.
Rispetto alla complessiva precarizzazione dei percorsi biografi-ci che caratterizzano la fase attuale della modernità, si tende a sot-tovalutare il fatto che la stabilità è stata garantita solo in alcune areegeografiche e per un breve periodo storico. Se non si tiene conto diquesto limite storico-geografico, si drammatizzano aspetti legati al-la crescente insicurezza delle prospettive biografiche, senza però te-ner conto del fatto che la stabilità è stata un’acquisizione in granparte occidentale, risultante soprattutto dall’applicazione negli sta-
115
I cenni alla riflessione sociologica sulla modernità fin qui svi-luppati evidenziano il fatto che la sociologia più recente si sta inter-rogando sulla modernità contemporanea anche nel tentativo di ri-formulare complessivamente i suoi presupposti teorici e concettua-li. La sociologia contemporanea può riprendere temi e problemi giàdiscussi dai classici, inserendoli però all’interno di un quadro teori-co di riferimento innovativo. Può, al contrario, proporre nuoveforme di riflessione, nuovi percorsi teorici, nuove modalità di spie-gazione dei processi in atto. Questa attenzione della sociologia sul-le sue categorie costitutive non nasce in maniera autonoma, all’in-terno di processi interni alla disciplina, ma deriva dal fatto che lamodernità contemporanea pone sfide costanti alle categorie attra-verso le quali la sociologia ha cercato di descrivere la realtà sociale.La modernità attuale acuisce alcune caratteristiche della prima mo-dernità, ne dissolve altre, ne rinviene di nuove, il tutto all’interno diprocessi articolati, a livello sia globale sia locale, difficili da defini-re e circoscrivere solo con i concetti datici in eredità dai classici.
La riflessione sulla modernità contemporanea spinge infatti lasociologia a rielaborare il proprio bagaglio concettuale, individuan-do nuove categorie (una tra tutte, quella di globalizzazione) utili aspiegare le trasformazioni sia globali sia locali che si verificano nel-la società contemporanea. In questo modo si aggiorna il lascito deiclassici, i quali non vanno semplicemente reinterpretati, come ave-va fatto Parsons, all’interno di un quadro teorico coerente che diaunitarietà alla sociologia come scienza. Al contrario, i classici stori-cizzati come espressione dello sbigottimento intellettuale nei con-fronti della prima modernità, vanno ora integrati e superati, utiliz-zando nuove distinzioni, nuove concettualità, nuovi approcci teo-rici in grado di dar conto della complessità del presente.
Non è dato ancora sapere quali effetti produrrà sulla riflessionesociologica la crisi attuale della modernità. Si perverrà ad una sinte-si finale, all’individuazione di un paradigma sociologico unitario?Oppure, come è più probabile, si provvederà ad aggiornare i con-cetti chiave della disciplina, senza pretendere dalla sociologia coe-renza paradigmatica? Qualunque siano gli esiti di questa rielabora-
114
Instabilità dei riferimenti socialiA livello strutturale, si assiste ad una generale dissoluzione e a
una perdita di rilevanza dei gruppi sociali che garantivano forme distabilità all’individuo nella modernità industriale. Non si riesce adar vita ad aggregati sociali stabili, nei quali il soggetto possa rico-noscere altri individui che hanno i suoi stessi interessi, differenzian-dosi al contempo dal resto della società. Questi aggregati (la classe,il ceto, l’appartenenza politica, il sindacato) che consentivano agliindividui di condividere identità collettive, riconoscendosi in fina-lità comuni, ora appaiono sempre più come contenitori vuoti. Sequei contenitori avevano garantito “percorsi di vita socialmente or-ganizzati” e “sociologicamente rappresentabili”29, ora non “vengo-no più fornite ‘case’ per l’‘accasamento’ e tutte quelle eventualmen-te postulate si dimostrano fragili e spesso crollano prima che l’ope-ra di insediamento venga completata”30.
Fuor di metafora, la prima modernità consentiva al soggetto, li-berato del vincolo ascrittivo dell’appartenenza ad uno (e ad uno so-lo) degli strati sociali, di costruire biografie relativamente stabili,nonostante il carattere acquisito della sua collocazione sociale. Ciòperché “a tutti i fini pratici, classe e genere erano ‘fatti di natura’ el’unico compito lasciato all’autoaffermazione di gran parte degli in-dividui fu quello di ‘adattarsi’ alla nicchia loro assegnata”31.
Nella modernità contemporanea, al contrario, si verifica un’er-ranza nomadica all’interno di gruppi sociali instabili (le tribù cui fariferimento Maffesoli32). Si tratta di gruppi che valgono come purocontenente e che, proprio per questo, non sembrano in grado divincolare il soggetto, il quale può trasmigrare da un aggregato al-l’altro, sull’onda delle più diverse motivazioni personali. Si produ-ce, così, nella migliore delle ipotesi, una sorta di nuovo tribalismo,caratterizzato dall’accettazione soggettiva dell’incertezza, che siconverte nella possibilità di rinunciare al richiamo di gruppi di ri-ferimento stabili, accettando il rischio soggettivo della peregrina-zione perenne. È però probabile che questa mancanza di riferimen-ti certi si traduca in uno spostamento continuo che non dà “alcunappagamento, nessun tipo di relax, nessuna sensazione di essere ar-
117
ti nazionali di specifiche politiche sociali. Queste politiche, legate alpieno sviluppo della modernità industriale, contraddistinte dal ten-tativo di garantire il soggetto di fronte all’instabilità di un ambien-te reso turbolento dalle crisi cicliche del capitale, nascevano percontrastare politicamente le conseguenze sociali del capitalismo li-berale. Lo sviluppo dell’economia capitalistica di tipo concorren-ziale produsse infatti un sovvertimento complessivo della strutturasociale, cui vanno connessi fenomeni noti come l’urbanesimo e l’in-dustrializzazione. Tali fenomeni provocarono una radicale e rapidatrasformazione della struttura sociale, che si convertì in una insicu-rezza generalizzata sia a livello soggettivo che sociale26.
La fase della relativa stabilità dei percorsi soggettivi e del conte-sto sociale è tipica della stagione (relativamente breve) connessa al-la nascita, allo sviluppo, e alla crisi dei sistemi di welfare. L’epocadella stabilità va temporalmente ridotta al periodo della contrappo-sizione tra i blocchi occidentale e sovietico, il che implica la neces-sità “di non assolutizzare il breve sogno di eterna prosperità econo-mica di un ordine sociale”27 che, al contrario, va contestualizzatonel tempo e nello spazio. All’instabilità contemporanea non è pos-sibile contrapporre un’altra modernità come luogo delle certezze eciò sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista geografico (sipensi all’instabilità biografica tipica dei così detti paesi in via di svi-luppo). Vero è semmai che la modernità contemporanea produceun effetto singolare di convergenza tra aree geografiche: esclusione,instabilità, incertezza, insicurezza biografica non sono più concettiche individuano situazioni geograficamente lontane, dunque estra-nee all’Occidente, bensì caratterizzano sempre più, a livello indivi-duale e collettivo, il mondo sociale intorno a noi28.
Allo scopo di selezionare dalla molteplicità delle suggestioni cheil tema della modernità comporta, adotterò anch’io, nell’analisi chesegue, un approccio geograficamente e storicamente delimitato,poiché il raffronto sarà operato tra la modernità stabilizzata dallepolitiche sociali (indicata con l’espressione modernità industriale) el’instabilità diffusa nella contemporaneità (cui si farà riferimentoutilizzando l’espressione modernità contemporanea).
116
turati sulla base dell’anzianità) e quello post-lavorativo (in rappor-to alla maturazione di una pensione statale). L’impresa privata siadattava a questo modello routinario di stabilizzazione delle aspet-tative biografiche, tanto che la fabbrica fordista “con la sua metico-losa separazione tra pianificazione e realizzazione, libertà e ubbi-dienza, invenzione e determinazione, con la sua rigida sincronizza-zione degli opposti di ciascuna di queste operazioni binarie, fu sen-za dubbio il più grande successo dell’ingegneria sociale orientata al-l’ordine mai ottenuto fino ad oggi”37 Una sorta di modello anchesociologico, laddove con Baumann la si associ al “parsonsiano ‘si-stema sociale’ autoriproducentesi, governato dal gruppo ‘centraledei valori’”38.
Nella modernità industriale, tutto convergeva verso la stabiliz-zazione dell’esperienza biografica: la macchina burocratica, i mo-delli di produzione e il carattere stabile dell’esperienza lavorativaall’interno di grandi aziende. Nella modernità contemporanea, laperdita di rilievo delle routines comporta l’affermazione della fles-sibilità come principio ordinatore delle produzione e, corrispon-dentemente, della biografia individuale. La flessibilità radicalizza ilpassaggio dai caratteri ascritti a quelli acquisiti, nel senso che il sog-getto è costantemente indotto a dar prova delle proprie competen-ze e capacità, adattandole a contesti sociali e lavorativi in costantemutamento. Flessibilità e flessibilizzazione dell’esperienza riman-dano a caratteristiche dell’azione soggettiva che esaltano la compo-nente della scelta e della capacità adattiva. È anche vero, però, che“la libertà senza precedenti che la nostra società offre ai suoi mem-bri è correlata […] ad un’impotenza senza precedenti”39.
Mentre la biografia nella modernità industriale assumeva i carat-teri di una narrazione lineare connessa allo sviluppo anche esso li-neare di una carriera lavorativa, la biografia contemporanea perdeil carattere di stabilità, disperdendosi in una serie di carriere possi-bili, spesso legate a fattori economici contingenti e in particolare aiprocessi di ristrutturazione e di ridefinizione dell’organizzazioneaziendale40. Solo a livello apicale, ciò può essere soggettivamentepercepito come incremento di possibilità. Ai livelli più bassi della
119
rivati, di aver raggiunto la meta finale, il luogo in cui si possa alfinedeporre le armi, rilassarsi e abbandonare ogni preoccupazione”33.
La percezione soggettiva e sociale della crisi che caratterizza ilperiodo che stiamo vivendo è connotata dalla perdita dei riferimen-ti più o meno stabili che avevano garantito coerenza alla biografiaindividuale e continuità all’organizzazione sociale. I luoghi socialidell’accasamento stabile (per riutilizzare la metafora di Baumann)erano il risultato di una serie di processi sociali e politici, cui corri-spondevano “consolidati sistemi di contrattazione neocorporativi-stici, la forma industriale e della produttività, i partiti di massa aforte radicamento sociale, i sistemi di previdenza sociale affidabili eben funzionanti, la famiglia nucleare basata sulla tradizionale sud-divisione dei ruoli tra uomo e donna, i rapporti di lavoro normalicaratterizzati da biografie professionali standardizzate”34. Tutto ciòviene messo in crisi dai processi in atto di dissoluzione della primamodernità, il che non può, ovviamente, che produrre sconcerto,preoccupazioni individuali e sociali e, all’interno della sociologia,rielaborazioni teoriche e mutamenti di prospettiva.
Instabilità delle biografieA fronte di una condotta metodica di vita, strutturata sulla base
di regole e di rountines, la modernità contemporanea assume i ca-ratteri spaesanti di un costante nuovo inizio. A livello biografico, leroutines organizzative, istituzionali, relative alla produzione, ave-vano il benefico effetto di definire possibilità e produrre sicurezze.La vita assumeva i caratteri di una “narrazione lineare”. Era una vi-ta forse noiosa ma non vuota, in cui, anche al livello più basso del-la scala sociale, “rata dopo rata” il soggetto percepiva se stesso co-me creatore della propria biografia, il che “gli consentiva di svilup-pare un senso di autostima”35. Alla stabilità routinaria della biogra-fia soggettiva faceva da contraltare la stabilità, anch’essa routinaria,delle strutture sociali: i progetti biografici a lunga scadenza eranoconsentiti dalla presenza “[…] di quella che Weber chiama ‘gabbiad’acciaio’”36, attraverso cui era possibile prevedere il proprio per-corso lavorativo (ad esempio in relazione ai livelli di reddito strut-
118
mezzi a disposizione e senza badare alla scarsa possibilità di una lo-ro utilità a lungo periodo”45.
A questa incertezza dei fini va collegata la diffusa percezione delrischio come caratteristica essenziale della modernità contempora-nea. L’accresciuta rischiosità dipende dall’accresciuta intensità del-le minacce (per esempio ambientali), dal loro carattere globale e dallivello, anche esso globale, dell’interconnessione degli eventi con-tingenti. Ciò produce un incremento dell’instabilità ambientale,dunque la percezione dell’inaffidabilità della scelta razionale sia alivello soggettivo sia a livello istituzionale, cui il soggetto si adattaattivando, laddove possibile, la sua capacità di rimozione o affidan-dosi ad un rinnovato fatalismo46. I criteri razionali di scelta vengo-no in certa misura offuscati dall’imprevedibilità delle conseguenzedell’azione (soggettiva o istituzionale, poco importa): “Come mo-tore di trasformazione della società, non vale più la razionalità fina-lizzata a uno scopo, ma le conseguenze secondarie: rischi, pericoli,globalizzazione, individualizzazione”47.
La razionalità orientata allo scopo richiedeva, infatti, una com-binazione di fiducia e rischio, che garantiva alla società la possibili-tà di “scommettere sul futuro” sulla base di “una forte predisposi-zione al rischio e alla sua calcolabilità”48. Gli investimenti per l’in-novazione tecnologica, i sistemi di previdenza sociale, le riforme ele politiche per il lavoro o l’istruzione sono testimonianza di que-sta sostanziale fiducia nella razionalità allo scopo, che si traducevanella fiducia di controllare i rischi di un futuro incerto, ma ad ognimodo non totalmente indeterminato.
La modernità industriale faceva convergere molti degli sforziistituzionali e organizzativi verso la delimitazione della rischiositàderivante, tra l’altro, dalla piena affermazione del capitalismo comemodo di produzione. Ad essa, e non alla modernità contempora-nea, pertiene il dibattito “sull’ascesa e il declino della produzione dimassa fordista, della produzione di massa e della piena occupazio-ne standardizzata, nonché l’immagine della società strutturata el’applicazione dei principi keynesiani”49. Lo stato nazionale garan-tiva la delimitazione della rischiosità e della contingenza ambienta-
121
scala sociale e lavorativa, anche in ragione della tendenza allo sman-tellamento delle politiche sociali, l’incertezza diviene caratteristicadelle biografie: si assiste a una complessiva perdita di riferimenti so-ciali stabili, cui è connessa la difficoltà di gestire il presente e confi-gurare possibilità future. Mentre “[l]a routine –direbbe Sennet–può indebolire ma anche proteggere; può smontare il lavoro, maanche comporre una vita”41, la flessibilità non sembra in grado disvolgere alcuna funzione di integrazione42.
Si assiste a quella che Beck ha definito efficacemente brasilianiz-zazione dell’Occidente, cioè la tendenza al dissolvimento delle dif-ferenze tra Primo e Terzo Mondo in relazione alle certezze biogra-fiche e esistenziali che avevano caratterizzato la modernità indu-striale: “Ciò cui assistiamo è l’irruzione della precarietà, della di-scontinuità, della flessibilità, dell’informalità all’interno dei bastionioccidentali della piena occupazione”43. Un effetto inatteso e insiemequasi una conferma paradossale delle teorie della convergenza, percui aspetti tipici del lavoro del Sud del mondo, e in particolare “lavarietà, la confusione e l’insicurezza delle forme lavorative”44, fannoirruzione in Occidente, modificando stabilità consolidate.
Incertezza, rischioLa razionalità rispetto allo scopo rendeva il mondo un luogo
privo di incanto, comunque controllabile sulla base di un oculatocalcolo dei mezzi in relazione ai fini: questo calcolo era sufficientea rassicurare il soggetto, la cui azione appariva coerente con gliobiettivi da raggiungere. Nella modernità contemporanea, lo sche-ma weberiano non sembra più in grado di svolgere la sua funzionerassicurante, e ciò non solo per la complessità costitutiva del reale,ma per una sorta di deficit di progettualità che impedisce al sogget-to di individuare fini coerenti: “Non è più –afferma Bauman– que-stione di cercare in condizioni di conoscenza incompleta, di calco-lare i mezzi […] a fronte di determinati fini. È piuttosto una que-stione di considerare e di decidere, a dispetto di tutti i rischi noti osemplicemente supposti, a quali dei molti, fluttuanti, seducenti fini‘a portata di mano’ […] dare priorità, considerata la quantità dei
120
società così come si era venuto configurando nella prima moderni-tà: la concezione weberiana dell’imprenditore rimanda a una corre-lata concettualità, tipicamente moderna, che vede nell’individuo,inteso come homo faber, non solo il tassello costitutivo della socie-tà, ma anche il responsabile della complessiva razionalità di que-st’ultima. Il soggetto non è più, come per Hobbes, l’individuo da-gli appetiti insaziabili che richiede l’intervento del Leviatano comestrumento di garanzia dell’ordine sociale. L’individuo della moder-nità è, al contrario, concepito come essere razionale, capace di con-trollare la realtà esterna anche perché è ormai riuscito a socializza-re (dunque a controllare e a tenere a freno) la propria componenteirrazionale. Il soggetto della prima modernità ha appreso la lezionedi Elias: è un soggetto civilizzato, dunque in grado di trasformarele costrizioni provenienti dall’ambiente sociale in autocostrizioni,regolando in maniera autonoma la propria condotta. È dunque unsoggetto in grado di differire il piacere, razionalizzando le pulsioniin vista di un maggiore guadagno (in denaro, potere, prestigio so-ciale)52.
La produzione flessibile, basata sui sistemi just in time, modifi-ca il rapporto tra produttore e consumatore e tra consumatore eprodotti. Si accorcia il tempo di semivita del prodotto e si manife-sta “[…] una maggiore attenzione alle mode mutevoli e alla mobi-litazione di tutti gli artifici di creazione dei bisogni e della relativatrasformazione culturale. L’estetica relativamente stabile del mo-dernismo fordista ha lasciato posto al fermento, all’instabilità e allequalità fuggevoli dell’estetica post-fordista che celebra la differen-za, la caducità, lo spettacolo, la moda, la mercificazione”53. Baumansostiene recisamente che “[…] la società postmoderna coinvolge isuoi membri principalmente nella loro capacità di consumatori an-ziché produttori”54. Ciò implica un’ulteriore messa in discussionedella razionalità allo scopo. Il consumo è infatti regolato dal desi-derio e non dal differimento della sua soddisfazione, il che implicache, nel desiderio, tutti gli scopi (d’acquisto) appaiono egualmentelegittimi. In relazione al consumo, non esistono scelte sbagliate, masolo scale di priorità: “Il fatto che non esiste pericolo di sbagliare è
123
le, anche perché disponeva delle politiche di welfare, dunque distrumenti in grado di delimitare, almeno in parte, turbolenze socia-li ed economiche. Diluita la capacità di intervento statale nel pas-saggio alla costellazione postnazionale 50, il rischio si globalizza, econtemporaneamente lo stato perde in capacità di intervenire uti-lizzando strumenti di politica nazionale per delimitare contingenzeglobali.
Proprio per questo, il rischio non sembra più delimitabile attra-verso soluzioni tecniche di tipo razionale, ma appare come condi-zione ineliminabile, con cui convivere e che, in ultima analisi, au-menta la contingenza delle decisioni e la rischiosità delle scelte. Edè per questo che, in relazione all’incremento della rischiosità, puòindividuarsi un’ulteriore differenza: “La distinzione da operare –af-ferma Beck– […] è quella tra le sicurezze, le certezze e i limiti chia-ri della prima modernità e le insicurezze, le incertezze, e l’assenzadi confini ben definiti della seconda modernità”51.
Da produttore a consumatoreLa produzione fordista, che aveva caratterizzato la modernità in-
dustriale, cede il passo a forme di produzione flessibile, just in time,capaci di adattarsi alle mutevoli trasformazioni del mercato, in ragio-ne della nuova centralità assunta dal consumatore. Anche qui è pos-sibile evidenziare la difficoltà di adattare concetti tradizionali all’ana-lisi del presente. Il modello weberiano si concentrava sulla capacitàinnovativa dell’imprenditore, all’interno di un approccio razionale incui l’innovazione era collegata con l’individuazione di nuove nicchiedi produzione a costi più contenuti, secondo una complessiva razio-nalizzazione del processo produttivo. Il modello just in time non sifonda sul ruolo innovativo della produzione, ma su un suo costanteadeguamento alle esigenze sempre mutevoli del consumatore: il gu-sto e la sua trasformazione diventano guida del processo.
Il nuovo ruolo assegnato al consumatore non ha rilievo solo inragione delle mutate strategie (flessibilizzate) della produzione,quanto piuttosto perché indica una complessiva ristrutturazionedell’immagine del soggetto e, dunque, del rapporto tra individuo e
122
dividuo: ogni uomo è padrone di se stesso e nessuno ha un altro pa-drone”59.
Il problema che si pone alla politica della prima modernità ri-guarda la possibilità di fare del riferimento al soggetto e alla sua au-tonomia un principio inviolabile, connettendolo, al contempo, allaforza vincolante dell’autorità e della decisione politica. La rispostaal problema, attuata nei sistemi di welfare, è legata all’ampliamentodei diritti soggettivi che cominciano a configurarsi non come dirit-ti alla libertà, bensì come pretese soggettive di attivazione dell’in-tervento statale. Si struttura così una sorta di patto fiduciario tracittadino e politica il quale, se formalmente si fonda sulla delegadella rappresentanza e sulla legittimità delle procedure, nella so-stanza impegna lo stato ad attivare meccanismi di compensazioneogni qual volta emergano situazioni percepite socialmente come li-miti alla stabilità biografica e all’autonomia del soggetto.
La logica dello stato del benessere è di tipo compensatorio, dalmomento che si assicura lealtà proprio in ragione dei benefici che èin grado di garantire60. Il carattere compensatorio è però responsa-bile di un processo di costante allargamento degli ambiti di inter-vento e dell’incapacità della politica di rispondere adeguatamente.Da un lato, infatti, il progetto illuministico appare in larga misurainattuato. Il principio di uguaglianza, ad esempio, richiede costantiinterventi per le pari opportunità, che di volta in volta assumonocaratteri diversi. Ci si accorge, ad esempio, che il programma egali-tario dell’Illuminismo, universalizzando l’idea di cittadino, avevacontemporanemente trascurato le disuguaglianze di genere, quelleetniche, quelle relative all’età.
Contemporaneamente, i processi di globalizzazione rendono lostato, che pretendeva di universalizzare i diritti pur relegando la suaazione a un contesto territorialmente delimitato, sempre meno capa-ce di dare risposte efficaci alle questioni emergenti: “[…] i diritti disovranità dei singoli stati-nazione sono ormai da tempo diventati il-lusori di fronte a intrecci economici mondiali e della sicurezza mili-tare, così che le arene della decisionalità democratica e le effettive di-pendenze si dissolvono, quasi irrimediabilmente”61. L’alleanza di
125
un’arma a doppio taglio, di certo una gioia ambigua, dal momentoche il prezzo da pagare è una perpetua incertezza e un desiderio im-possibile da saziare”55.
A livello sociale complessivo, il passaggio da una società incen-trata sulla produzione ad una incentrata sul consumo ha comeconseguenza una significativa perdita di rilievo dei limiti: “[l]a vi-ta organizzata intorno al produttore tende ad essere regolata nor-mativamente. C’è un limite minimo a ciò di cui si abbisogna per re-stare vivi ed essere capaci di fare qualsiasi cosa il ruolo di produt-tore possa richiedere, ma anche un limite massimo a ciò che si puòsognare […] e al contempo contare sull’approvazione sociale […]Tutto ciò che oltrepassa tale limite è un lusso, e desiderare il lussoè peccato. La principale preoccupazione è dunque quella dellaconformità”56. Il consumo come strumento di organizzazione del-la biografia attiva, al contrario, una sistematica svalutazione dellanorma sociale: “[la vita] è guidata dalla seduzione, da desideri sem-pre maggiori e da capricci volubili, non più da regolazioni norma-tive”57. Al loro posto, si struttura un’estetica dell’effimero, in cui sicerca di definire un nuovo rapporto con la temporalità, fatto diun’inestricabile contaminazione tra un passato immaginario che sidistende sul prodotto come patina, un futuro inteso come innova-zione costante e un presente caratterizzato dal valore contingentedell’acquisto58.
La crisi della rappresentanzaLe semantiche della modernità fanno perno sulla razionalità del
soggetto come elemento costitutivo sulla cui base spiegare com-plesse strutture sociali. I codici giuridici moderni, ad esempio, sistrutturano sull’idea di diritti soggettivi inviolabili, di cui il sogget-to è depositario, e che garantiscono la razionalità dell’architetturagiuridica. L’economia liberale si definisce in relazione a un sogget-to capace di gestire razionalmente transazioni di tipo economico.La politica, infine, democratizzandosi, fa riferimento al cittadinocome premessa della sua legittimazione: “[l]a democrazia moderna–afferma Beck– si basa sull’assioma del dominio autonomo dell’in-
124
getto, evidenziandone, contemporaneamente, le debolezze, il rife-rimento forse più certo è quello al concetto di uguaglianza. L’ugua-glianza implica infatti attenzione per i caratteri acquisiti e irrilevan-za di quelli ascritti, agisce come elemento di razionalizzazione, inquanto è garanzia di accesso sulla base dei meriti (versione struttu-ralista), assume i caratteri del monito nel momento in cui si osser-vano discrepanze tra l’uguaglianza de jure e la fattualità delle con-crete inuguaglianze sociali (teorici del conflitto). Nella versione piùmoderata, l’uguaglianza è, dunque, configurabile come uguaglianzad’accesso, nella forma di pari opportunità garantite, a prescinderedalle differenze di natura ascrittiva (etniche, di genere, di classe,ecc.). Nella versione più radicale, invece, l’incompiutezza del pro-getto illuminista chiama all’azione per la costruzione di una socie-tà di eguali. Uguaglianza implica comunque inclusione, cioè aper-tura ai soggetti di una pluralità di ambiti sociali.
L’idea moderna di inclusione è connessa al sempre maggiore ri-lievo dei ruoli acquisiti rispetto a quelli ascritti. I primi, basati co-me sono su ciò che l’individuo fa e su come agisce, piuttosto che susupposte qualità innate e ereditarie, necessitano di un quadro socia-le che, in linea di principio, premi il soggetto in relazione alle sueazioni. Di fatto, è solo quando la società cessa di strutturarsi in ba-se a blocchi eterogenei (i ceti sociali dell’antico regime) che è pos-sibile individuare nella disuguaglianza un problema sociale e insie-me un motivo di conflitto tra gruppi. Se, infatti, gli individui sonouguali di fronte allo stato e al diritto, appare plausibile la pretesache essi godano di un accesso non diseguale alle risorse sociali.
La modernità industriale ha, più di altri momenti storici, accen-tuato la conflittualità tra gruppi in competizione per l’acquisizionedi risorse scarse, e ciò –sostiene Robert Castel– “attraverso la gene-ralizzazione e differenziazione del salario. Una ‘società salariata’funziona in base a una differenziazione generalizzata e centra lapropria dinamica attorno alla coppia uguaglianza-disuguaglianza:contrattazione e scontro fra gruppi sociali si cristallizzano intornoalla ridistribuzione della ricchezza”65. Non essendo più legittimabi-li differenze di tipo qualitativo (ad esempio nobile-plebeo, servo-
127
fatto tra fordismo come modo di produzione e stato del benesserecome modalità di gestione della politica (quell’alleanza cui Harveysi riferisce come configurazione di potere politico economico fordi-sta-keynesiana62), aveva assicurato stabilità e delimitazione delle in-certezze correlate alle crisi cicliche dell’economia capitalistica.
In un ambito territorialmente delimitato, lo stato nazionale ap-pariva, a torto o a ragione, in grado di garantire insieme ordine ebenessere, e questo anche in connessione con l’attivazione di poli-tiche economiche di stampo keynesiano, fondate sul presuppostodel controllo, pur limitato, della politica sull’economia. Lo statoveniva configurato come “quel complesso di regole e di norme [cheavrebbero trasformato] ciò che è contingente nel determinato,l’ambivalenza nell’Eindeutigkeit –la chiarezza–, la causalità in rego-larità; in breve, la primitiva foresta in un giardino ben disegnato, ilcaos in ordine”63.
Forze transnazionali, non solo di tipo economico, cui il dibatti-to si riferisce col termine di globalizzazione, limitano attualmentela capacità di intervento statale. Politica ed economia non appaionopiù in grado di attivare connessioni nella forma di politiche econo-miche coerenti: si attiva, al contrario, un processo di dismissione(sotto forma di deregolamentazione, liberalizzazione, flessibilizza-zione) dell’intervento statale, che ha come suo effetto immediatoquello di rendere inefficace ogni forma di regolazione politica del-l’economia (globalizzata). Tra le altre conseguenze, ciò produce an-che la rottura del patto fiduciario tra cittadini e loro rappresentan-ti. Lo stato non ha più gli strumenti per garantire la strutturazionedi politiche e burocrazie pubbliche (le gabbie d’acciaio weberiane)capaci di dare stabilità e coerenza alla biografia individuale. Ciòproduce una disaffezione per la politica che spesso assume i carat-teri di una crisi profonda del processo democratico e del principiodella rappresentanza64.
Inclusione/(nuove) esclusioniSe si cerca tra le parole chiave del progetto illuministico quella
meglio di altre in grado di dar conto delle ambizione di quel pro-
126
zione; nell’innovazione tecnologica, che a fronte di investimenti,può incrementare la produttività, migliorando le condizioni di la-voro; nella politica, in ultimo, cui è demandato il compito di gesti-re i meccanismi di mutamento, producendo giustizia sociale e legit-timazione per il sistema nel suo complesso. Il rischio connesso alcambiamento costante, tipico della modernità, appare comunquecalcolabile e ciò produce una fiducia generalizzata nel futuro: “Si-no a quando le società industriali sono state capaci di scommetteresul futuro, a questa fiducia corrispondeva una forte predisposizio-ne al rischio e alla sua calcolabilità”68.
Nella modernità contemporanea, al contrario, la globalizzazio-ne dei rischi, insieme alla generalizzazione della loro percezione,produce un diffuso senso di insicurezza e instabilità. A questa sen-sazione diffusa, va affiancata l’incapacità di immaginare interventifuturi in grado di attivare processi di inclusione sociale. L’economiafa affidamento non sulla stabilità della produzione fordista, bensìsulla flessibilità del just in time e, soprattutto, sulla flessibilizzazio-ne dei rapporti di lavoro69. La politica, prigioniera della crisi (fisca-le e ideologica) dello stato del benessere e dei nuovi scenari prodot-ti dalla globalizzazione, non riesce a individuare nuove strategie ca-paci di produrre inclusione e di delimitare disagio e vulnerabilitàsociale70. E in tutto ciò, l’individuo appiattisce il proprio orizzontetemporale sul presente: un presente in cui le scelte soggettive appa-iono come “cambiamento adattivo” piuttosto che come individua-zione razionale di “mete percepite come preferibili”71.
Venuta meno la forza unificante dello stato-nazione, anche inragione del complessivo fallimento delle politiche sociali (non soloincapaci di produrre inclusione, ma spesso responsabili di disugua-glianze derivanti dalla loro implementazione), venuta soprattuttomeno la fiducia in un futuro controllabile sulla base di scelte ope-rate in ambito economico, politico, sociale, la logica dell’inclusioneappare sempre più subordinata alla forza persuasiva delle esclusio-ni di fatto. Aumenta il divario tra i veramente ricchi e i veramentepoveri, aumenta complessivamente il numero di chi vive al di sottodella soglia minima di povertà, si assiste ad un affanno biografico e
129
padrone), le disuguaglianze assumono principalmente il carattere didifferenze di reddito, sulle quali si può intervenire con politiche diriequilibrio e redistribuzione. La conflittualità tra gruppi vienedunque mitigata da un ruolo forte assegnato alla politica.
Da una prospettiva poco attenta alla conflittualità, Parsons haper primo fatto riferimento all’inclusione come processo: nella suaconcezione ottimistica del progetto illuministico, l’inclusione ap-pare come un percorso in certa misura obbligato. L’idea di inclusio-ne e la sua rilevanza sociale sono infatti per Parsons il correlato del-la differenziazione, dunque dell’incremento delle differenze indivi-duali, della maggiore disponibilità di ruoli e di status socialmenteaccessibili. L’inclusione è intimamente legata al “processo di diffe-renziazione che ha prodotto una struttura sociale crescentementepluralistica”66. Ciò implica, se non un indebolimento della lealtàdell’individuo ad un gruppo sociale specifico, quantomeno la ne-cessità di far convivere il legame che unisce il singolo al gruppo conla cittadinanza, vale a dire con “la piena appartenenza […] alla co-munità sociale”67. L’idea di inclusione, così come viene presentatada Parsons, si tiene insieme anche grazie ad una alleanza sociale inrapporto a valori collettivamente condivisi. Inclusione implica ac-cettazione delle differenze, ma ciò è possibile solo a patto che la so-cietà disponga di strumenti di integrazione che consentano al sin-golo di accettare la propria posizione subordinata, senza percepirlasoggettivamente come iniqua. Tutto ciò presuppone uno stato-na-zione forte, dotato della capacità di mobilitare risorse simboliche edi promuovere identità sociale, attivando processi complessivi diintegrazione.
A prescindere dal punto di vista teorico (strutturalismo, teoriadel conflitto) la modernità industriale evidenzia la necessità di at-tuare inclusione sociale attraverso una consapevole progettualitàpolitica che rivolge al futuro la fiducia nella realizzazione di mag-giore equità. Riequilibrio e redistribuzione sono concetti legati aprocessi che richiedono fiducia: nell’economia, ad esempio, che,sfruttando a proprio vantaggio i meccanismi di ripartizione del red-dito, può giovarsi di un aumento dei consumi, quindi della produ-
128
gnifica disincanto del mondo. Non è più necessario, come fail selvaggio per il quale esistono tali forze, ricorrere a mezzimagici per dominare o propiziare gli spiriti. Ciò si ottienecon mezzi tecnici e con il calcolo. Questo, soprattutto, signi-fica intellettualizzazione in quanto tale73.
Razionalità e disincanto sono dunque connessi: l’affermazionedella prima è conseguenza dell’affermarsi del secondo, ed entrambiattivano una sorta di supporto reciproco, all’interno di un proces-so circolare per il quale ulteriore razionalità produce disincanto ul-teriore e ulteriore disincanto è responsabile di un’accresciuta razio-nalizzazione del mondo. Cosa succede, però, se è proprio la razio-nalità ad entrare in crisi? È possibile immaginare un consolidamen-to del disincanto, oppure il suo definitivo superamento? Oppureancora l’attivazione di forme locali di disincanti limitati?
Le domande non sono oziose, soprattutto se si pensa che il ca-rattere forse più evidente della modernità è la perdita di capacitàpersuasiva della razionalità (individuale e sociale). La razionalitàappare, nella migliore delle ipotesi, limitata (Simon) o frammentatain una pluralità di razionalità parziali, siano esse legate ad un ambi-to specifico del funzionamento della società (si pensi a Luhmann ealle molteplici razionalità dei singoli sistemi), ovvero a razionalitàlocali, costruite ad hoc per dar conto di un contesto sociale minutoin continuo mutamento (si pensi alle pratiche di accounting analiz-zate dall’etnometodologia). A questa complessiva svalutazione del-la capacità unificante della razionalità va aggiunto il fatto che essanon appare più in grado di garantire coerenza al progetto illumini-stico. Il disincanto tollerabile, di cui ho parlato in riferimento a We-ber, si trasforma in disagio soggettivamente difficile da sostenere,anche perché vengono meno i supporti che la modernità aveva ap-prontato per rendere soggettivamente accettabile una rappresenta-zione del mondo priva di ogni magia. In una situazione di incre-mentata rischiosità globale, dunque di instabilità ambientale, vienemeno la capacità soggettiva (ma anche istituzionale) di controllareil mondo in riferimento ad una qualche razionalità delle scelte e
131
esistenziale della classe media (cioè della classe che beneficiava del-la gran parte delle politiche sociali, finanziandone anche l’attivazio-ne), si rafforza la differenza tra metropoli e periferie della moder-nità. E tutto ciò senza che si possa più far riferimento ad alcuna ipo-tesi di allargamento delle politiche sociali, senza che siano ormai at-tive le ottimistiche previsioni relative alla modernizzazione collega-te alle diverse teorie della convergenza. Rimane lo scandalo del-l’esclusione, la sua capacità, come afferma Luhmann, di dimostrarel’artificiosità e l’improbabilità della differenziazione funzionale,l’artificiosità e l’improbabilità, dunque, della modernità72.
3.4. Reincanti
Se questa è una rappresentazione plausibile della portata dei mu-tamenti in atto, ci si può chiedere: è davvero irrealistico immagina-re forme individuali e collettive, socialmente indotte, di reincanto?Il disincanto weberiano è connesso alla affermazione della raziona-lità orientata allo scopo, la quale fa prova di sé in una pluralità diambiti (in primo luogo l’azione del soggetto), dimostrando all’indi-viduo la sua capacità di condizionare, in virtù del carattere raziona-le della sua condotta, l’ambiente circostante. Per Weber disincantoè correlato di razionalizzazione, di capacità di gestire il mondo sul-la base di un calcolo efficace perché razionale. Lascio a Weber ilcompito di dare rappresentazione efficace del rapporto tra ragionee disincanto:
La crescente intellettualizzazione e razionalizzazione non si-gnifica […] una crescente conoscenza generale delle condi-zioni di vita nelle quali ci troviamo. Ma essa significa qual-cosa di diverso, cioè la consapevolezza o la fede che sia pos-sibile apprendere solo ogni qual volta si voglia, e che dunqueper principio non esistono forze imprevedibili e misterioseche entrino in gioco, ma piuttosto tutte le cose, per princi-pio, si possono dominare attraverso il calcolo. Ma questo si-
130
continua ad affermare la validità di valori costitutivi della democra-zia (chi metterebbe in dubbio la democrazia come valore? Comedelegittimare l’avversario con più efficacia se non tacciandolo diantidemocratico? Come legittimare occupazioni di stati nazionali,se non sostenendo che si tratta di importare il modello razionaledella democrazia occidentale?). Si attiva piuttosto un reincanto li-mitato, che ha lo scopo di dare fiato ad uno stato nazionale in af-fanno, deprivato di molti degli strumenti a sua disposizione (adesempio, la crescita dell’indebitamento pubblico), anche allo scopodi proiettare sull’ambiente limiti di incisività e deficit di razionalitàdel sistema politico.
Se si esce dalle vicende provinciali di casa nostra, ci si accorgeche il reincanto opera in politica anche altrove, a mio avviso comeforma spesso contraddittoria di compensazione delle difficoltà diattuazione del progetto illuministico. Bush vince ad esempio le ele-zioni riproponendo un rinnovato sogno di supremazia, attuandolodi fatto con il supporto della destra religiosa oltranzista, opponen-do la sua immagine visionaria (in larga misura reincantata) allacompostezza razionale dell’avversario democratico.
Collateralmente, da quando si è dimostrato impraticabile, con-traddittorio e profondamente iniquo il progetto di modernizzazio-ne fondato sulle teorie della convergenza, si sono consolidati i fon-damentalismi, non tanto come affermazione di identità collettiveautoctone, quanto piuttosto come forma di rivalutazione della for-za della tradizione opposta alla dura prospettiva della subordina-zione. Come afferma Giddens, il fondamentalismo è possibile soloall’interno del mondo contemporaneo, in quanto nasce come tenta-tivo di contrastare il dubbio radicale. Esso: “non è niente di più eniente di meno della ‘tradizione nel suo senso tradizionale’, anchese schierata in ordine di battaglia e non più in posizione di supre-mazia”77.
Di fronte all’incapacità di proporre il modello occidentale comemodello globale, di fronte ai fallimenti del processo di modernizza-zione di paesi terzi, di fronte alla contemporanea incapacità deglistati nazionali occidentali di legittimare la propria azione attraver-
133
della condotta. Si diffonde la consapevolezza del rischio, a frontedell’impossibilità di convertire insicurezze in “‘certezze’ del sape-re religioso o magico”74.
Contro ogni prognosi ben intenzionata, l’azione sociale non ri-sponde a questa accentuata rischiosità, assoggettandosi sempre piùalla logica della scelta razionale: si tende a favorire, al contrario,meccanismi non razionali (emotivi, ludici, rituali, ad esempio) didelimitazione delle insicurezze. Non si tratta di un “risveglio dellatradizione”, bensì dell’adozione di stili di vita modellati sulla basedella tradizione75. Senza pretesa di completezza analitica, propon-go alcuni ambiti in cui si attivano forme limitate di reincanto comerisposta parziale all’evidente perdita di capacità incisiva della razio-nalità illuministica.
Reincanti politiciL’elemento irrazionale diventa movente della scelta politica la
quale soffre dell’incapacità di mobilitare, come volevano i funzio-nalisti, risorse sociali per rendere decisioni politiche collettivamen-te vincolanti. Possono costruirsi, in risposta a queste difficoltà, ri-ferimenti storici fittizi che hanno però la capacità di incidere sullescelte politiche, anche in ragione di identità etniche immaginate e didifferenziazioni anche esse immaginate. Basterebbe far riferimento,in Italia, alla costruzione di un’identità culturale priva di riferimen-ti storici, la Padania, per verificare empiricamente come l’ineffica-cia dell’azione politica possa trovare alibi in differenze immaginate,configurabili come netta opposizione tra Nord produttivo e impo-litico e Sud politicamente ed economicamente parassitario76.
La politica, costretta alla dura pratica della negazione (no ad ul-teriori interventi, no ad ulteriori finanziamenti, delimitazione dellaspesa pubblica, delimitazione degli investimenti) reagisce propo-nendo racconti affabulanti, in cui la forza della ricetta semplice, ap-parentemente dettata dal buon senso, si oppone alla logica raziona-le dei parametri da rispettare. Il problema non è configurabile co-me sostituzione della forza irrazionale del leader carismatico allalogica razionale delle strutture politiche formali. Al contrario, si
132
tà e in particolare i processi della decisionalità politica80. È a questoprocesso che può imputarsi una serie di rivalutazione dei principireligiosi, che assumono il carattere di guida della decisione politicao di critica alla sua eccessiva laicizzazione. In Occidente, ad esem-pio, si riafferma il valore assoluto delle tradizioni religiose tantoche ha trovato credito nel dibattito pubblico la polemica sulla man-canza di riferimento ai comuni valori cristiani nella costituzioneeuropea. L’assolutizzazione delle differenze religiose può addirittu-ra diventare fonte per giustificare contrapposizioni internazionali,le quali assumono il carattere di scontri (non solo ideologici) tra ci-viltà. Negli Stati Uniti in maniera più marcata che altrove, il rein-canto religioso assume i tratti del fondamentalismo protestante, siistituzionalizza e diventa movente della decisione politica e motivodi successo elettorale.
Nella modernità contemporanea si assiste, dunque, ad una rin-novata collettivizzazione dell’esperienza di fede. Laddove il perma-nere di fenomeni religiosi socialmente visibili (ad esempio, il cultodei santi nel Mezzogiorno d’Italia) poteva, fino a qualche decenniofa, essere tematizzato come permanenza di elementi arcaici e irra-zionali in luoghi periferici della modernità, ora esso assume carat-teri nuovi, probabilmente connessi alla necessità della rimitizzazio-ne di un mondo in cui le certezza sono sempre più scarse. A livelloquotidiano del comportamento individuale e collettivo, il sacro di-viene motivo di scelte che incidono sull’attuale geografia del turi-smo, laddove luoghi decentrati assumono nuova rilevanza e visibi-lità (si veda, ad esempio, il fenomeno non solo nazionale del pelle-grinaggio a San Giovanni Rotondo). La santità viene celebrata co-me aspetto normale e non eccezionale, tanto che è possibile molti-plicare le santificazioni in un gioco al rialzo che non può essere piùrubricato come reazione alla crisi di legittimità della religione isti-tuzionalizzata. Si tratta anche in questo caso di reincanti locali,provvisori, parziali, in larga misura mediatici (si pensi all’attesa perla morte recente del papa e alla commozione che ha coinvolto inmassa i fedeli). Alla nuova visibilità del fenomeno religioso noncorrisponde, infatti, una sua riacquisita centralità sociale: non sia-
135
so l’individuazione di soluzioni efficaci, la politica appare bisogno-sa di nuovi miti. Nella sua sostanza, questo reincanto parziale ha ache fare con l’incapacità delle forme procedurali di legittimazionedi giustificare l’azione del sistema politico, all’interno di uno scol-lamento tra progetto illuministico di modernizzazione e democra-tizzazione del mondo e forme concrete, geograficamente diffuse, diinefficacia della decisione politica.
Reincanti religiosiLa modernità ha tematizzato la religione in connessione con la
sua sempre più limitata capacita di condizionare la vita individuale,i rituali collettivi, gli ambiti istituzionali. Il tema ricorrente prendeil nome di secolarizzazione, con cui si indica l’autonomia semprepiù marcata di ambiti socialmente differenziati da condizionamen-ti di tipo religioso. La secolarizzazione compromette la pervasivitàdella religiosità, limitando contemporaneamente la rilevanza socia-le della religione, che al più sembra poter assumere funzione inte-grativa della biografia individuale: essa è ancora in grado di fornireun senso altrimenti socialmente non disponibile, perdendo però inmodo irrimediabile il suo carattere ordinatore del mondo (sociale,naturale, soprannaturale)78. La religione diventa invisibile (Luck-mann), si intimizza, dunque, fornendo indicazioni utili al soggettoche non si aspetta però, in un’epoca di diffuso pluralismo, di tra-sformare i principi religiosi che muovono la sua condotta in orien-tamenti complessivi della condotta altrui (individuale o colletti-va)79. È solo un apparente paradosso che questa complessiva deli-mitazione del carattere vincolante della religione ha origine, se si dàcredito alla versione weberiana, in un disincanto che nasce propriodall’evoluzione del cristianesimo occidentale.
Nella modernità contemporanea, si assiste ad una ritrovata visi-bilità sociale dell’esperienza religiosa, da intendersi come sua pro-gressiva deprivatizzazione, in grado di condizionare parzialmenteambiti istituzionali e comportamenti quotidiani: le religioni preten-dono, cioè, di riassumere un ruolo socialmente centrale, che coin-cide col nuovo compito di rimoralizzare complessivamente la real-
134
globatizzati di entrare nella quotidianità dei soggetti, costruendocontaminazioni tra culture ed immagini, così da attivare forme direincanto basate su un’immaginazione anch’essa globalizzata, ingrado di ridefinire progetti di vita, biografie, modi della condotta83.In questo nuovo spazio dell’immaginazione, i media recuperano informa ludica gli aspetti del mito e del magico, proiettandoli in con-testi locali tra loro profondamente differenti e producendo integra-zioni apparenti, transitorie, fuggevoli.
Si assuma come esempio del reincanto dei media globalizzati ilsuccesso internazionale della trilogia del Signore degli anelli. È que-sto un successo in parte imputabile ad un accorta politica di marke-ting: è difficile però che si tratti solo di questo. Il successo della tri-logia dipende anche dalla sua capacità di presentare un mondo ma-gico, in cui si muovono personaggi archetipici, dotati di una capa-cità di presa sul reale che non si fonda sulla commisurazione dimezzi e di fini, bensì su valori arcaici (l’eroismo, la lealtà, la fiduciareciproca, il gesto esemplare, ecc.) in grado di dar vita ad una tradi-zione plausibile all’interno di un mondo ormai configurabile comepost-tradizionale84. Le acquisizioni tecniche e le strategie razionalidell’industria culturale approfittano del bisogno di tradizione e direincanto, producendo mondi artificiali che riescono a dar luogo aidentità parziali reincantate, non solo collegate alla fruizione del-l’evento (si pensi, ad esempio, al fenomeno contemporaneo dellefandoms e alle attività sociali collaterali alla fruizione dei prodottidell’industria culturale).
Il reincanto mediatico passa a mio avviso anche attraverso la ca-pacità affabulatoria dei nuovi media, di internet in particolare. Larete fornisce all’immaginazione del soggetto un mondo privo di li-miti e di vincoli oggettivi. Tutto sembra a portata di mano, traspa-rente, raggiungibile. I caratteri solidi della razionalità moderna, fat-ta di barriere, di luoghi non accessibili, di conoscenze specialistiche,sembrano disperdersi nella retorica del mondo (e della conoscenza)a portata di mano. On line è possibile una fruizione senza limiti esenza filtri, nel senso che i siti (o almeno tutti quelli gratuiti) sonoaccessibili senza ulteriori forme della selezione. Internet accentua
137
mo in presenza di un nuovo (e quanto mai improbabile) monotei-smo dei valori ma, più probabilmente, a motivazioni soggettiva-nente differenziate come base di comportamenti collettivamenteconformi.
Reincanti mediatici Il rapporto tra media e riflessione intellettuale è stato connotato
da una critica che vedeva nella cultura di massa una banalizzazionedell’immaginazione, il cui esito finale sarebbe stato un più strettocontrollo dei soggetti e della loro capacità di opposizione. L’analisidel rapporto tra cultura di massa e cultura elevata, tematizzato innegativo, ad esempio come perdita dell’aura dell’opera d’arte nel-l’epoca della sua riproducibilità tecnica, tendeva a enfatizzare gli ef-fetti negativi della modernità sia a livello soggettivo (facendo riferi-mento alla perdita di capacità cognitiva), sia a livello collettivo (inrelazione alla supposta incapacità delle masse di individuare le con-traddizioni interne al processo di modernizzazione). “Un’abbon-dante e autorevole letteratura –ci informa Appadurai – prodotta so-prattutto dai teorici critici della scuola di Francoforte e anticipatanell’opera di Max Weber, vede nel mondo moderno svilupparsi co-me una gabbia d’acciaio, e ha previsto che lo sviluppo dell’immagi-nazione sarebbe stato arrestato dalle forze del consumismo, del ca-pitalismo industriale e dalle forme di controllo generalizzato e disecolarizzazione del mondo”81. Il disincanto di questa impostazio-ne non riguarda tanto la percezione soggettiva degli effetti dei me-dia, quanto piuttosto la diffidenza degli intellettuali nei confrontidell’oralità, dell’immagine, dell’immagine in movimento, cioè diquei mezzi tecnici di riproduzione che sembravano scardinare itratti più tipici della cultura occidentale. Il contraltare di questaconcezione critica dei media è da rintracciare nelle ricerche empiri-che che, soprattutto in America, cercavano di individuare l’efficaciadel messaggio mediatico, con l’intento di verificarne la capacità ma-nipolatoria, utilizzandola al fine di incrementare l’efficacia del mes-saggio propagandistico e pubblicitario82.
Recentemente, Appadurai ha riaffermato la capacità dei media
136
A mo’ di conclusione: la parzialità del reincanto
I reincanti che ho individuato non hanno, ovviamente, carattereesaustivo: si fondano su impressioni, rimandano alla collocazionescomoda del soggetto nella modernità contemporanea e si propon-gono come meccanismi soggettivi e insieme istituzionali, di com-pensazione. A ben guardare, si tratta di reincanti limitati, la cui na-tura è per molti versi fittizia e frammentata. Sarebbe infatti diffici-le immaginare, nonostante l’arretramento del processo di raziona-lizzazione e la crisi contemporanea della razionalità, un complessi-vo capovolgimento del grandioso processo di disincanto individua-to da Weber. Nella sociologia post-weberiana, la demitizzazionedel mondo veniva concepita come uno degli aspetti, tra i più rile-vanti, dell’affermazione della modernità occidentale; andava dun-que di pari passo con la costruzione di solide strutture sociali checonferivano al moderno Occidente il suo carattere di unicità, di-stinguendolo dalle società del passato e dalle società contempora-nee non occidentali. Disincanto era correlato di razionalizzazione,rappresentando a livello soggettivo la forza dell’accentuata capaci-tà di controllo e gestione dell’ambiente naturale e sociale e, contem-poraneamente, l’impossibilità di dare risposte plausibili a domandeesistenziali per le quali la razionalità rispetto allo scopo si dimostra-va inadeguata. Disincanto era, dunque, un aspetto coerente dellaprima modernità, ne indicava il carattere ambivalente, la sua capa-cità di allargare complessivamente le possibilità d’azione individua-le e collettiva ma anche la connessa disaffezione per un mondo pie-namente razionalizzato. Nel nostro caso il reincanto appare, inve-ce, come un processo collaterale delle difficoltà che la razionalitàoccidentale incontra nel corso della fase più recente del processo dimodernizzazione.
La razionalità contemporanea appare limitata, parziale, locale:ciò non significa che essa scompaia dall’orizzonte dell’azione socia-le. Si presenta, è vero, con caratteri circoscritti, che le derivano dal-la sua incapacità, evidente a livello soggettivo e strutturale, di gesti-re un ambiente in cui rischio, instabilità, insicurezza appaiono co-
139
con la sua mancanza di delimitazioni tematiche, caratteristiche tipi-che della società contemporanea. Uno dei caratteri della contempo-raneità è la mancanza di una gerarchia dei discorsi possibili. Si atti-va, infatti, una molteplicità di punti di vista, i quali rimandano adaltrettanti sistemi sociale o ad altrettante formulazioni soggettive.Internet incrementa il carattere non gerarchico della comunicazio-ne sociale, eliminando i filtri per la selezione tematica. In linea diprincipio, non ci sono direzioni predefinite della comunicazione,ma solo selezioni da una molteplicità di percorsi possibili. Analo-gamente, la rete risolve il problema dell’inclusione, che appare in-vece come carattere critico della modernità contemporanea. Pre-scindendo da limitazioni di carattere economico, tecnico o cultura-le, l’accesso è consentito a chiunque.
All’accessibilità complessiva della comunicazione, si aggiunge lapossibilità di creare, sempre on line, identità fittizie, in certa misu-ra sussidiarie delle identità reali. Lo spazio virtuale, condiviso nel-la contemporaneità dagli utenti, fornisce la ribalta di un’interazio-ne in cui ciò che importa è soprattutto la costruzione dell’immagi-ne di sé che i diversi interlocutori proiettano nella comunicazione.Alla ribalta, corrisponde una molteplicità di retroscena, in cui cia-scun interlocutore sa di mentire o di dire il vero, sa di poter presen-tare aspetti del suo sé altrimenti celati, oppure di giocare con iden-tità improbabili. La comunicazione si verifica all’interno di un fra-me (il cyberspazio, o più semplicemente il programma che consen-te il collegamento tra utenti) in cui tutto questo è presupposto: èsolo un apparente paradosso che on line l’intrasparenza dei sogget-ti non solo consenta comunicazione, ma che la comunicazione sibasi proprio su questa intrasparenza. Si interagisce, infatti, in certamisura a prescindere dall’identità effettiva (qualunque cosa essa sia)dell’interlocutore e si accetta come rischio della comunicazione ilfatto di avere a che fare con nicknames, cioè con identità sintetiche,che assumono rilievo solo nella comunicazione on line.
138
Note
1 U. Beck (1999), “L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizzazionedella modernità”, in U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizzazione riflessiva. Po-litica, tradizione e estetica nell’ordine sociale della modernità, Asteorios Editore,Trieste, p. 43.
2 Cfr. anche D. Harvey (1993), op. cit., p. 25 e sgg. 3 Cfr. U. Beck (2000), La società del rischio, Carocci, Roma, in particolare il
Capitolo V. 4 U. Beck (1999), “L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizzazione
della modernità”, op. cit., p. 35. 5 Sul postmoderno cfr. N. Salamone (1999), Postmodernità. Quotidiano e oriz-
zonte nella società contemporanea, Carocci, Roma. 6 T. Parsons (1973), Sistemi di società II. Le società moderne, op. cit., p. 224. 7 A. Touraine (1993), Critica della modernità, op. cit., p. 212. 8 J. Habermas (1987), op. cit., p. 4. 9 Ibidem.10 Ivi, p. 13.11 Ibidem.12 Cfr. ivi, pp. 15-16. Sulla modernità come progetto incompiuto e sulle sug-
gestioni che a Habermas derivano da Benjamin, cfr. M. Strazzeri (1997), L’eclis-si del cittadino. Attore e sistema sociale nella modernità, Pensa, Lecce, pp. 165-169.
13 Cfr. J. Habermas (1986), Teoria dell’agire comunicativo. Razionalità nel-l’azione e razionalizzazione sociale, vol. I, Il Mulino, Bologna, in particolare p. 73,dove si sottolinea come la razionalità comunicativa “si manifesta nel fatto che ilconsenso raggiunto in modo comunicativo deve poggiare in ultima istanza su ra-gioni. E la razionalità di coloro che partecipano a questa prassi si commisura al fat-to se sono in grado di fondare le proprie espressioni in circostanze adatte”.
14 Si tratta di una concezione nota e complessa sulla quale non mi soffermo.Oltre alla Teoria dell’agire comunicativo cfr. anche J. Habermas (1987), Il discorsofilosofico della modernità, op. cit., in particolare il Capitolo 11 dal titolo “Un’altravia d’uscita dalla filosofia del soggetto. La ragione comunicativa contro la ragionesoggettocentrica”, pp. 297-327.
15 Cfr. M. Hill (1999), Politica sociale. Un’analisi comparata, Il Mulino, Bolo-gna, p. 307.
16 Cfr. U. Beck (1999), “L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizza-zione della modernità”, op. cit., p. 84 e sgg.
17 Cfr. D. Frisby (1992), Frammenti di modernità, op. cit., p. 29 e sgg. 18 N. Luhmann (1996), Osservazioni sul moderno, Armando, Roma, p. 27. 19 Entrambe le citazioni sono ibidem.
141
me caratteristiche sempre più rilevanti. Alla razionalità non si chie-de più (tranne qualche importante eccezione) di dare voce e coeren-za al progetto incompiuto dell’Illuminismo: le si chiedono piutto-sto soluzioni provvisorie per problemi emergenti, senza che le sipossano affidare complessivamente le sorti delle biografie indivi-duali e il processo di trasformazione della struttura sociale.
A questo permanere circoscritto della razionalità fa da contral-tare non un totale reincanto del mondo, bensì una serie di reincan-ti possibili, i quali hanno la funzione di rendere tollerabile, a livel-lo individuale e collettivo, l’incoerenza (apparente o effettiva) dellafase storica in cui viviamo. Non ci troviamo dunque di fronte aduna rimitizzazione del mondo, ad un recupero complessivo delpensiero magico-mitico. La politica può ricorrere a immagini miti-che nella forma di ricette semplici, oppure di passati costruiti pergiustificare fratture altrimenti inaccettabili: può però difficilmentefare ricorso ad oltranza a quelle immagini mitiche, pena la sua inca-pacità di gestire, anche parzialmente, la complessità ambientale. Alreincanto il diritto oppone i caratteri formali e razionali dell’ordi-namento giuridico moderno. La religione può riattivare forme col-lettive di comportamento orientato al sacro, ma è improbabile cheneghi validità alle conoscenze tecnico-scientifiche ed è altrettantoimprobabile che, per risolvere problemi contingenti, si preferiscaattendere il miracolo senza far ricorso a competenze specialistiche.I media globalizzati, internet in particolare, possono attivare rein-canti parziali, nella forma dell’esaltazione di figure eroiche e ierati-che, oppure come valorizzazione della soggettività nella comunica-zione on line, ma difficilmente possono pretendere dal soggetto latraslazione dell’eroismo magico nella quotidianità, o imporre agliindividui di continuare il gioco della comunicazione senza limiti,eludendo la dura logica dei ruoli sociali e delle aspettative ad essiconnesse.
140
46 Cfr. A. Giddens (1994), Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bolo-gna, p. 125 e sgg.
47 U. Beck (1999), “L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizzazionedella modernità”, op. cit., p. 45.
48 C. Ranci, “Fenomenologia della vulnerabilità sociale”, in Rassegna Italianadi Sociologia, a. XVIII, n. 4, p. 526.
49 U. Beck (2000), Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro. Tramonto delle si-curezze e nuovo impegno civile, op. cit., p. 101.
50 J. Habermas (1999), La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazio-ni e democrazia, Feltrinelli, Milano.
51 U. Beck (2000), Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro. Tramonto delle si-curezze e nuovo impegno civile, op. cit., p. 101.
52 Sulla doppia valenza del termine procrastinare, sulla sua rilevanza per l’ethosmoderno del produttore e per quello più recente del consumatore cfr. Z. Bauman(2000), Modernità liquida, op. cit., in particolare p. 183.
53 D. Harvey (1993), op. cit., p. 195. 54 Z. Bauman (2000), Modernità liquida, op. cit., p. 79. 55 Ivi, p. 63. 56 Ivi, pp. 79-80. 57 Ibidem.58 Cfr. A. Appadurai (2001), op. cit, Capitolo III, passim.59 U. Beck, “L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizzazione della
modernità”, op. cit., p. 73. 60 Per una analisi del rapporto tra individuo e stato nei sistemi di welfare cfr.
N. Luhmann (1987), Teoria politica nello stato del benessere, Franco Angeli, Mi-lano.
61 U. Beck (1999), “L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizzazionedella modernità”, op. cit., p. 72.
62 D. Harvey (1993), op. cit., p. 155. 63 Z. Bauman (2000), Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone,
Laterza, Roma-Bari, p. 69. 64 Cfr. ivi, Capitolo 3, passim.65 R. Castel (1997), “Disuguaglianze e vulnerabilità sociale”, in Rassegna italia-
na di sociologia, a. XXXVIII, n. 1, p. 41.66 T. Parsons (1975), “Piena cittadinanza per gli americani negri”, op. cit., p.
330.67 Ivi, p. 324. 68 C. Ranci (2002), “Fenomenologia della vulnerabilità sociale”, in Rassegna
italiana di sociologia, a. XVIII, n. 4, p. 526. 69 Sul rapporto tra esclusione, vulnerabilità sociale, forme di lavoro flessibile
cfr. R. Castel (1996), “Le insidie dell’esclusione”, in Assistenza sociale, n. 2, pp. 37-52; cfr. anche G. Fullin (2002), “Instabilità del lavoro e vulnerabilità sociale: di-
143
20 R. De Giorgi (1991), “Modelli giuridici dell’uguaglianza e dell’equità”, inSociologia del diritto, vol. XXII, n. 1, p. 32.
21 Cfr. N. Luhmann (1981), “Subjective Rechte. Zum Umbau des Rechtsbewu-ßtsein für die moderne Gesellschaft”, in Id., Gesellschaftsstruktur und Semantik.Studien zur Wissensoziologie der modernen Gesellschaft, vol. 2, Suhrkamp, Fran-kfurt, p. 89.
22 Cfr. N. Luhmann (1996), Osservazioni sul moderno, op. cit., in particolare ilCapitolo III dal titolo “La contingenza come valore proprio della società moder-na”, pp. 59-80.
23 Cfr. ivi, in particolare il Capitolo IV dal titolo “La descrizione del futuro”,pp. 81-92.
24 Cfr. ivi, p. 62 e sgg. 25 Ivi, p. 135. 26 Sull’instabilità tipica della prima modernità cfr. R. Sennet (1999), L’uomo
flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita delle persone, Feltrinel-li, Milano.
27 U. Beck (2000), Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro. Tramonto delle si-curezze e nuovo impegno civile, Einaudi, Torino, p. 26.
28 Cfr. ivi, pp. 3-4.29 U. Beck (1999),“L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizzazione
della modernità”, op. cit., p. 46. 30 Z. Bauman (2000), Modernità liquida, op. cit., p. 25. 31 Ibidem.32 Cfr. M. Maffesoli (1988), Il tempo delle tribù, Armando, Roma, p. 21, ma cfr.
anche Id. (2000), Del nomadismo. Per una sociologia dell’erranza, Franco Angeli,Milano.
33 Z. Bauman (2000), Modernità liquida, op. cit., p. 25. 34 U. Beck (2000), Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro. Tramonto delle si-
curezze e nuovo impegno civile, op. cit., pp. 26-27. 35 Cfr. R. Sennet (1999), op. cit, p. 14. 36 Ibidem.37 Z. Bauman (2000), Modernità liquida, op. cit., p. 55. 38 Ibidem.39 Ivi, p. 12. 40 Cfr. R. Sennet (1999), op. cit., p. 45 e sgg. 41 Ivi, p. 43.42 Sulla differenza tra modernità fordista e post-modernità flessibile, cfr. Har-
vey (1993), op. cit., pp. 412-415. 43 U. Beck (2000), Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro. Tramonto delle si-
curezze e nuovo impegno civile, op. cit., p. 3. 44 Ibidem.45 Z. Bauman (2000), Modernità liquida, op. cit., p. 60.
142
Bibliografia
ANDERSON B. (1996), Comunità immaginate. Origine e fortuna dei nazio-nalismi, Manifestolibri, Roma.
ADORNO T. (1983), Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, Einau-di, Torino.
ALTHUSIUS (1624), Politica methodica digesta, edizione anastatica (1961),Scientia Verlag, Aalen.
APPADURAI A. (2001), Modernità in polvere, Meltemi, Roma.BAUMAN Z. (1996), “Modernità e ambivalenza”, in M. Featherstone, Cul-
tura globale. Nazionalismo, globalizzazione, modernità, EdizioniSeam, Roma, pp. 43-71.
BAUMAN Z. (2000), Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari. BAUMAN Z. (2000), Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle per-
sone, Laterza, Roma-Bari.BECK U. (1999), “L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizza-
zione della modernità”, in Beck U., Giddens A., Lash S., Moder-nizzazione riflessiva. Politica, tradizione e estetica nell’ordine socia-le della modernità, Asteorios Editore, Trieste, pp. 29-99.
U. BECK (2000), La società del rischio, Carocci, Roma. U. BECK (2000), Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro. Tramonto delle
sicurezze e nuovo impegno civile, Einaudi, Torino.BERGER P.L. (1970), Il brusio degli angeli. Il sacro nella società contempo-
ranea, Il Mulino, Bologna. BERGER P.L. (1994), Una gloria remota. Aver fede nell’epoca del plurali-
smo, Il Mulino, Bologna. BERGER P.L., BERGER B., KELLNER H. (1973), The Homeless Mind. Mo-
dernization and Consciousness, Penguin, Harmondsworth.CARBONE L. (2000), Razionalità e dominio. Teoria critica e modernizza-
zione, Manni, Lecce. CASANOVA J. (2000), Oltre la secolarizzazione. La religione alla riconqui-
sta della sfera pubblica, Il Mulino, Bologna. CASTEL R. (1996), “Le insidie dell’esclusione”, in Assistenza sociale, n. 2,
pp. 37-52.CASTEL R. (1997), “Disuguaglianze e vulnerabilità sociale”, in Rassegna
italiana di sociologia, a. XXXVIII, n. 1, pp. 41-56.
145
mensioni, punti di equilibrio e fragilità”, in Rassegna italiana di sociologia, a.XVIII, n. 4, pp. 553-586.
70 Sul rapporto tra rischio, vulnerabilità sociale, esclusioni e politiche di welfa-re, oltre a C. Ranci (2002), “Fenomenologia della vulnerabilità sociale”, op. cit.,pp. 521-552, cfr. anche E. Pavolini (2002), “Il Welfare alle prese con i mutamentisociali: rischio, vulnerabilità, frammentazione”, in Rassegna italiana di sociologia,a. XVIII, n. 4, pp. 587-618. Cfr. anche C. Ranci (2002) Le nuove disuguaglianzesociali in Italia, Il Mulino, Bologna, in particolare p. 23 e sgg.
71 C. Ranci (2002), “Fenomenologia della vulnerabilità sociale”, op. cit., p. 545.72 Cfr. N. Luhmann (1995), “Inklusion und Exclusion”, in Id., Soziologische
Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch, op. cit., pp. 237-264. 73 M. Weber (1997), La scienza come professione, op. cit., pp. 50-51. 74 A. Giddens (1994), Le conseguenze della modernità, op. cit., p. 126. 75 Cfr. Id. (1999), “Vivere in una società post-tradizionale”, in U. Beck, A. Gid-
dens, S. Lash, op. cit., p. 151 e sgg.76 Si tratta di un processo analogo a quello individuato da B. Anderson (1996),
Comunità immaginate. Origine e fortuna dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma,sebbene proceda nella direzione contraria (disgregativa dell’unità nazionale e fa-vorevole ai particolarismi locali) rispetto alla nascita del moderno stato nazionale.Sulla “denazionalizzazione dello stato” e sulla “privatizzazione della nazionalità”,processi opposti a quello di formazione degli stati nazionali fondati sul progettodell’assimilazione culturale, cfr. Z. Bauman, “Modernità e ambivalenza”, op. cit.,pp. 68-69.
77 Cfr. A. Giddens (1999), “Vivere in una società post-tradizionale”, op. cit.,p.151.
78 Per un’analisi sociologica della secolarizzazione come elemento costitutivodella modernità cfr. A. Ferrara, M. Rosati (2005), op. cit., Capitolo 4, passim.
79 Per la testi della soggettivizzazione della religione moderna cfr. T. Luckmann(1969), La religione invisibile, Il Mulino, Bologna; P. Berger (1970), Il brusio degliangeli. Il sacro nella società contemporanea, Il Mulino, Bologna e Id. (1994), Unagloria remota. Aver fede nell’epoca del pluralismo, Il Mulino, Bologna.
80 J. Casanova (2000), Oltre la secolarizzazione. La religione alla riconquistadella sfera pubblica, Il Mulino, Bologna, p. 77 e sgg.
81 A. Appadurai (2001), op. cit., p. 20.82 Cfr. M. Wolf (1992), Gli effetti sociali dei media, Bompiani, Milano.83 Cfr. A. Appadurai (2001), op. cit., p.19.84 Cfr. A. Giddens (1999), “Vivere in una società post-tradizionale”, op. cit., p.
151 e sgg.
144
FILORAMO G., PRANDI C. (1987), Le scienze delle religioni, Morcelliana,Brescia.
FRISBY D. (1985), Georg Simmel, Il Mulino, Bologna.FRISBY D. (1992), Frammenti di modernità. Simmel, Kracauer, Benjamin,
Il Mulino, Bologna. FULLIN G. (2002), “Instabilità del lavoro e vulnerabilità sociale: dimensio-
ni, punti di equilibrio e fragilità”, in Rassegna italiana di sociologia,a. XVIII, n. 4, pp. 553-586.
GIDDENS A. (1998), Durkheim, Il Mulino, Bologna. GIDDENS A. (1994), Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna. GIDDENS A. (1999), “Vivere in una società post-tradizionale”, in Beck U.,
Giddens A., Lash S., Modernizzazione riflessiva. Politica, tradizio-ne e estetica nell’ordine sociale della modernità, op. cit., pp. 101-160.
HABERMAS J. (1986), Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, BolognaHABERMAS J. (1987), Discorso filosofico della modernità, Laterza, Roma-
Bari. HABERMAS J. (1999), La costellazione post-nazionale. Mercato globale, na-
zioni, democrazia, Feltrinelli, Milano. HAMILTON P. (1989), Talcott Parsons, Il Mulino, BolognaHARVEY D. (1993), La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano.HILL M. (1999), Politica sociale. Un’analisi comparata, Il Mulino, Bologna.HORKHEIMER M. (1969), Eclissi della ragione, Einaudi, Torino. HORKHEIMER M. (2005), “Il concetto di ragione”, in E. Donaggio (a cura
di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, op. cit., pp. 195-209.HORKHEIMER M., ADORNO TH. (a cura di) (1966), Lezioni di sociologia,
Einaudi, Torino.HORKHEIMER M., ADORNO T. (1980), Dialettica dell’illuminismo, Einau-
di, Torino.INFANTINO L. (1997), “Economia e sociologia: paradigmi a confronto”, in
Trapanese E.V., Sociologia e modernità. Problemi di storia del pen-siero sociologica, NIS, Roma, pp. 47-60.
JAY M. (1979), L’immaginazione dialettica. Storia della Scuola di Franco-forte e dell’Istituto per le ricerche sociali 1923-1950, Einaudi, Torino.
JEDLOWSKI P. (1995), Introduzione a G. Simmel, La metropoli e la vitadello spirito, Armando, Roma, pp. 7-32.
KOSELLECK R. (1986), Futuri passati. Per una semantica dei tempi nuovi,Marietti, Genova.
KOSELLECK R., MEIER C. (1991), Progresso, Marsilio, Venezia.
147
CERTEAU M., DE (2001), L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro,Roma.
COMTE A. (1967), Corso di filosofia positiva, UTET, Torino.CIUFFOLETTI Z., COLLINA V., DE BONI C. (a cura di), Progettualità e po-
litica nella Rivoluzione Francese, G. D’Anna, Messina-Firenze.DAL LAGO A. (1994), Il conflitto della modernità. Il pensiero di Georg
Simmel, Il Mulino, Bologna.DE BONI C. (1989), La progettazione della legge, in Ciuffoletti Z., Colli-
na V., De Boni C. (a cura di), Progettualità e politica nella Rivolu-zione Francese, op. cit., pp. 113-200.
DE GIORGI R. (1991), “Modelli giuridici dell’uguaglianza e dell’equità”, inSociologia del diritto, vol. XXII, n. 1, pp. 19-33.
DONAGGIO E. (2005), Introduzione a Id. (a cura di), La scuola di Franco-forte. La storia e i testi, Torino, Einaudi, pp. IX-XLVIII.
DUMONT A. (1984), Homo aequalis. Genesi e trionfo dell’ideologia econo-mica, Adelphi, Milano.
DURKHEIM È. (1962), La divisione del lavoro sociale, Edizioni di Comu-nità, Milano.
DURKHEIM È. (1963), Le forme elementari della vita religiosa, Edizioni diComunità, Milano.
DURKHEIM È. (1963), Le regole del metodo sociologico, Edizioni di Comu-nità, Milano.
DURKHEIM È. (1972), La scienza sociale e l’azione sociale. Sociologia e pra-tica sociale, Il Saggiatore, Milano.
DURKHEIM È. (1972), “L’individualismo e gli intellettuali”, in Id., Lascienza sociale e l’azione sociale. Sociologia e pratica sociale, op. cit.,pp. 281-298.
DURKHEIM È. (1972), “L’avvenire della religione”, in Id., La scienza socia-le e l’azione sociale. Sociologia e pratica sociale, op. cit., pp. 333-342.
DURKHEIM È. (1972), “Il dualismo della natura umana e le sue condizionisociali”, in Id., La scienza sociale e l’azione sociale. Sociologia e pra-tica sociale, op. cit., pp. 343-359.
ELIAS N. (1986), Saggio sul tempo, Il Mulino, Bologna. ELIAS N. (1990), Che cos’è la sociologia, Rosenberg & Sellier, Torino. FERRARA A., ROSATI M. (2005), Affreschi della modernità. Crocevia della
teoria sociale, Carocci, Roma. FILLOUX J.-C. (1972), Introduzione a È. Durkheim, La scienza sociale e
l’azione sociale. Sociologia e pratica sociale, op. cit., pp. 7-71.
146
PARSONS T. (1962), La struttura dell’azione sociale, Il Mulino, Bologna PARSONS T. (1971), Teoria sociologica e società moderna, Etas Kompass,
Milano.PARSONS T. (1971), “La sociologia della conoscenza”, in Id. Teoria socio-
logica e società moderna, op. cit., pp. 127-151.PARSONS T. (1971), Sistemi di società I. Le società tradizionali, Il Mulino,
Bologna. PARSONS T. (1973), Sistemi di società II. Le società moderne, Il Mulino,
Bologna.PARSONS T. (1975), Sistema politico e struttura sociale, Giuffrè, Milano.PARSONS T. (1975), “Piena cittadinanza per l’americano negro”, in Id., Si-
stema politico e struttura sociale, op. cit., pp. 323-372. PARSONS T. (1983), “Il ruolo dell’identità nella teoria generale dell’azio-
ne”, in Sciolla L. (a cura di), Identità. Percorsi di analisi in sociolo-gia, Rosenberg & Sellier, Torino, pp. 63-88.
PAVOLINI E. (2002), “Il Welfare alle prese con i mutamenti sociali: rischio,vulnerabilità, frammentazione”, in Rassegna italiana di sociologia,a. XVIII, n. 4, pp. 587-618.
POLANYI K. (1974), La grande trasformazione, Einaudi, Torino. RAMMSTEDT O. (1985), “Zweifel am Fortschrift und Hoffen auf Indivi-
duum. Zur Kostitution der modernen Soziologie in ausgehenden19. Jahrhundert”, in Soziale Welt, a. XXXVI, n. 4, pp. 483-502.
PONSETTO A. (1986), Max Weber. Ascesa, crisi e trasformazione del capi-talismo, Franco Angeli, Milano.
RANCI C. (2002), “Fenomenologia della vulnerabilità sociale”, in Rasse-gna italiana di sociologia, a. XVIII, n. 4, p. 521-552.
RANCI C. (2002), Le nuove disuguaglianze sociali in Italia, Il Mulino, Bo-logna.
RUSCONI G.E. (1968), La teoria critica della società, il Mulino, Bologna. SALAMONE N. (1999), Postmodernità. Quotidiano e orizzonte nella socie-
tà contemporanea, Carocci, Roma. SCHIMANK U. (1985), “Funktionale Differenzierung und reflexiver Sub-
jektsmus. Zum Entsprechungverhältnis von Gesellschafts- undIdentitätsform”, in Soziale Welt, a. XXXVI, n. 4, pp. 447-475.
SCIOLLA L. (a cura di) (1983), Identità. Percorsi di analisi in sociologia, Ro-senberg & Sellier, Torino.
SENNET R. (1999), L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismosulla vita delle persone, Feltrinelli, Milano.
149
LONGO M. (2001), Struttura della società e semantica del soggetto, Pensa,Lecce.
LÖWENTHAL L. (2005), “Individuo e terrore”, in E. Donaggio (a cura di),La scuola di Francoforte. La storia e i testi, op. cit., pp. 234-247.
LUCKMANN T. (1969), La religione invisibile, Il Mulino, Bologna.LUHMANN N. (1977), Sociologia del diritto, Laterza, Roma-Bari. LUHMANN N. (1977), “Interpenetration – Zum Verhältnis personaler und
sozialer Systeme”, in Zeitschrift für Soziologie, a. VI, n. 1, pp. 62-76. LUHMANN N. (1981), “Subjective Rechte. Zum Umbau des Rechtsbewu-
ßtsein für die moderne Gesellschaft”, in Id. Gesellschaftsstrukturund Semantik. Studien zur Wissensoziologie der modernen Gesel-lschaft, vol. 2, Suhrkamp, Frankfurt, pp. 45-104.
LUHMANN N. (1987), Teoria politica nello stato del benessere, Franco An-geli, Milano.
LUHMANN N. (1989), “Individuum, Individualität, Individualismus”, inId., Gesellschaftsstruktur und Semantik, vol. 3, Suhrkamp, Fran-kfurt, pp. 149-258.
LUHMANN N. (1990), Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, IlMulino, Bologna.
LUHMANN N. (1995), Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und derMensch, Westdeutscher Verlag, Opladen.
LUHMANN N. (1995), “Die Gesellscaftlische Differenzierung und das In-dividuum”, in Id., Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie undder Mensch, op. cit., pp. 125-141.
LUHMANN N. (1995), “Die Tücke des Subjekts und die Frage nach denMenschen”, in Id., Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie undder Mensch, op. cit., pp. 155-168.
LUHMANN N. (1995), “Inklusion und Exklusion”, in Id., SoziologischeAufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch, op. cit., pp. 237-264.
LUHMANN N. (1996), Osservazioni sul moderno, Armando, Roma. LUHMANN N., DE GIORGI R. (1994), Teoria della società, Franco Angeli,
Milano. MAFFESOLI M. (1988), Il tempo delle tribù, Armando, Roma.MAFFESOLI M. (2000), Del nomadismo. Per una sociologia dell’erranza,
Franco Angeli, Milano. MERTON R.K. (1957), “The Role-set. Problems in Sociological Theory”,
in British Journal of Sociology, vol. 8, pp. 106-120. PARKIN F. (1984), Max Weber, Il Mulino, Bologna.
148
151
SIEYÈS E.-J., DE (1972), Che cos’è il terzo stato, Editori Riuniti, Roma.SIMMEL G. (1982), La differenziazione sociale, Laterza, Roma-Bari.SIMMEL G. (1984), Filosofia del denaro, UTET, Torino.SIMMEL G. (1989), Sociologia, Edizioni di Comunità, Milano.SIMMEL G. (1995), La metropoli e la vita dello spirito, Armando, Roma.SOLARI G. (1951), Individualismo e diritto privato, Giuffrè, Milano. STRAZZERI I. (2004), Critica dell’ideologia post-moderna, Lupetti, Milano. STRAZZERI M. (1997), L’eclissi del cittadino. Attore e sistema sociale nella
modernità, Pensa, Lecce. TINLAND F. (1989), “La notion de subject de droit dans la philosophie po-
litique de Th. Hobbes, J. Locke et J.J. Rousseau”, in Archives dePhilosophie de droit, numero monografico dal titolo Le sujet dedroit, vol. 34, pp. 51-66.
TÖNNIES F. (1963), Comunità e società, Edizioni di Comunità, Milano. TOURAINE A. (1993), Critica della modernità, Il Saggiatore, Milano. TRAPANESE E.V. (a cura di) (1997), Sociologia e modernità. Problemi di
storia del pensiero sociologico, NIS, Roma.TRAPANESE E.V. (1997), “La ‘grande trasformazione’ e le origini del pen-
siero sociologico”, in Id. (a cura di), Sociologia e modernità. Proble-mi di storia del pensiero sociologico, op. cit., pp. 15-46.
WALLACE R.A., WOLF A. (2000), La teoria sociologica contemporanea, IlMulino, Bologna.
WEBER M. (1945), L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni,Firenze.
WEBER M. (1967), Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino. WEBER M. (1976), Sociologia delle religioni, UTET, Torino. WEBER M. (1997), La scienza come professione, Armando, Roma.WOLF M. (1992), Gli effetti sociali dei media, Bompiani, Milano.
150