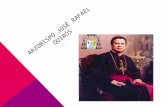San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare di San Pietro in Vaticano...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare di San Pietro in Vaticano...
La chiesa dei Santi Michele e Magnoin Borgo S. Spirito
e
l’Arciconfraternita del SS.mo Sacramento
nella Basilica Vaticana
Storia e documenti
2010Città del Vaticano
Studi e doCumenti Sulla Storia del Capitolo VatiCano e del Suo Clero Collana diretta da Mons. Prof. Dario Rezza, canonico vaticano
archivum sancti petri
7
L e poche testimonianze attraverso le quali fin dal secolo XVII è stato possibile ricostruire, almeno per sommi capi, la primitiva storia dell’an-tica chiesa dei Ss. Michele e Magno in Borgo S. Spirito1 si trovano in
massima parte conservate all’interno di quel formidabile e inesauribile serbatoio di conoscenze storiche che è l’archivio capitolare di S. Pietro in Vaticano2. Esso
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare di San Pietro in Vaticano
(854-1350)
di Mirko Stocchi
1. La chiesa sorge tuttora sulle estreme propaggini occidentali del colle Gianicolo, ad appena cinquanta metri di distanza dal colonnato berniniano di Piazza S. Pietro. Vi si accede dal Borgo Santo Spirito per due rampe di scale, di cui una – la seconda per chi proviene da S. Pietro – tradizionalmente denominata “scala santa”. La prima pubblicazione a stampa interamente dedicata a illustrare la storia di questa antica cappella risale al 1629 e si deve a Francesco Maria Torrigio (1580-1650), assiduo frequentatore dell’archivio capitolare di S. Pietro, delle cui testimonianze egli si avvalse largamente per la redazione delle sue numerose opere (Torrigio 1629). Dopo l’opuscolo del Torrigio, per ritrovare uno studio espressamente dedicato alla chiesa dei Ss. Michele e Magno bisogna attendere il 1906, quando cioè le pagine del “Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma” ospitarono le note storiche dedicate da Petrus Johannes Blok alle “antiche memorie dei Frisoni” (Blok 1906). In parte debitrice di quest’ultimo lavoro è la breve ma esaustiva monografia sulla chiesa, di cui furono autori Mario Bosi e Piero Becchetti, apparsa nella collana diretta da Carlo Pietrangeli intitolata “Le chiese di Roma illustrate” (Bosi – BeccheTTi 1973). Gli stessi Bosi e Becchetti tornarono sull’argomento appena due anni più tardi, per comunicare nella rivista “Studi Romani” l’importante scoperta, da loro fatta, di alcuni disegni fino ad allora ignorati, raffiguranti la struttura dell’edificio sacro prima dei radicali rifacimenti settecenteschi (Bosi – BeccheTTi 1975). Quasi un ventennio separa quest’ultima pubblicazione dalla monografia, corredata di un ricco apparato illustrativo, dedicata alla chiesa dei Ss. Michele e Magno da mons. Martino Muskens (Muskens 1993). Il lavoro di Muskens rappresenta il primo prodotto di una nuova stagione d’interesse attorno alla nostra chiesa, all’origine del quale contribuirono certamente le indagini archeologiche – seppure limitate – di cui la medesima fu fatta oggetto sul principio degli anni Novanta del secolo scorso (vd. anche in proposito heres 1992-1993 e MoorMann 1992-1993). Il merito di aver compiutamente esposto, contestualizzato e analizzato criticamente i risultati di queste indagini va tuttavia attribuito a Sible de Blaauw, autore in quegli stessi anni di un voluminoso articolo sulla chiesa apparso nei “Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome” – il periodico scientifico del Reale Istituto Neerlandese a Roma – (de Blaauw 1992-1993), che rappresenta oggi il punto di partenza imprescindibile per qualsiasi studio critico sulla storia di questa antica chiesa, divenuta nel frattempo, per intercessione del Capitolo di S. Pietro, di cui essa è “chiesa filiale”, la chiesa nazionale degli Olandesi a Roma. Infine, notizia di altri autori che, prima del 1927, hanno trattato incidentalmente della nostra nelle loro opere, si potrà reperire nella scheda – invero in sé piuttosto scarna – a essa dedicata nella nota opera sulle chiese di Roma nel medioevo di Christiano Hülsen (hülsen 1927, p. 388, s.v. S. Michaelis de Porticu) e in CBCR, III, pp. 126-128.
2. Sull’archivio capitolare di S. Pietro in Vaticano, sue vicende storiche, consistenza e strumenti di corredo, vd. schiaparelli, pp. 393-418 e rezza – sTocchi 2008, pp. 9-40.
Mirko Stocchi
8
ha fornito, per così dire, l’unico spiraglio attraverso il quale è stato possibile fare un po’ di luce sulle vicende trascorse di questo umile ma antichissimo luogo del culto cristiano, oscurato per secoli – e, è il caso di dirlo, non solo in senso meta-forico – dalla grandezza e magnificenza della poco distante basilica del Principe degli apostoli.
Questo fatto è facilmente comprensibile se si pensa ai ben noti legami che unirono la ecclesia Sancti Michaelis – come si denominò la nostra per tutto il corso del medioevo3 – al Capitolo dei canonici vaticani, forse documentati già dalla metà del secolo XI4.
A ciò si aggiunga che dal 1512 la nostra chiesa – in origine, come presto vedre-mo, centro del culto e della devozione della nazione frisone a Roma – perse del tutto la sua antica autonomia e divenne, per decisione di papa Giulio II, proprietà della Cappella musicale da questi fondata presso la basilica vaticana, la “Cappella Giulia”5. Poiché il governo del nuovo istituto sin dai suoi albori fu demandato dal papa ai canonici vaticani, anche il cospicuo fondo archivistico frutto della secolare amministrazione della Cappella e dei suoi beni – tra cui, come abbiamo detto, dal 1512 figurava la nostra chiesa – oggi costituisce una parte del più vasto archivio capitolare di S. Pietro6.
1. Le origini della chiesa di S. Michele e la schola dei Frisoni
Non conosciamo una data esatta a cui far risalire la prima fondazione di un edificio di culto sul luogo dell’attuale chiesa dei Ss. Michele e Magno7. Ciò nono-stante, le sue origini sono quasi certamente da mettere in relazione con l’insediarsi a Roma di una comunità stabile di Frisoni – antica popolazione germanica già ri-cordata nel I sec. d.C. dallo storico romano Tacito8 – che, stando alle testimonian-
3. Solo in epoca moderna, infatti, e per ragioni ancora non del tutto chiare, al primitivo titolo di S. Michele si venne affiancando quello di S. Magno. Sull’«intricata questione della dedicazione della chiesa al vescovo San Magno» vd. Bosi – BeccheTTi 1973, pp. 34-53.
4. Usiamo il condizionale, dal momento che l’autenticità del documento che attesterebbe, già a questa data, la dipendenza della chiesa dai canonici di S. Pietro – un privilegio di Leone IX datato 21 marzo 1053 (cfr. infra, § 3) – è stata recentemente criticata e merita perciò un’attenta riconsiderazione. Cfr. infra, nt. 34.
5. La bolla di annessione si trova edita in BV, II, pp. 347-348. Sulla fondazione della Cappella Giulia per iniziativa di Giulio II, vd. DucroT 1963, pp. 180-185.
6. Cfr. Rezza – Stocchi 2008, pp. 69; Inventario ACSP, ff. 58-137.7. Tratteremo in seguito (§ 4) della versione, quasi certamente leggendaria, riportata da una lapide
tuttora conservata in situ, secondo la quale la sua fondazione spetterebbe al papa Leone IV (847-855).8. Cfr. Tac., Ann. I, 60; IV, 72-74; XI, 19; XIII, 54. La natio Frisiorum, come la definì Tacito,
abitava fin dall’Antichità le terre che si affacciano sul Mare del Nord comprese tra i fiumi Schelda e Weser. Questa vasta regione, che dal nome dei suoi abitanti prese il nome di Frisia, comprendeva grosso modo il territorio degli attuali Paesi Bassi. Nell’alto medioevo, dopo aver a lungo combattuto
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
9
ze in nostro possesso, sembra risalire a un periodo antecedente la fine del secolo VIII. La più antica fonte a farne menzione, il Liber pontificalis, ricorda infatti in un celebre passo che il 29 novembre dell’anno 799 ad accogliere presso Ponte Milvio Leone III, di ritorno a Roma dopo un doloroso esilio durato circa sette mesi, era-no presenti oltre ai più alti dignitari laici ed ecclesiastici, ai senatori dell’Urbe e a gran moltitudine di popolo: «cunctae scholae peregrinorum, videlicet Francorum, Frisonum, Saxonum atque Langobardorum»9.
“Scholae peregrinorum” si denominavano allora quelle fondazioni a carattere nazionale sorte nei pressi di S. Pietro allo scopo di fornire alloggio e assistenza ai nu-merosi peregrini, ovverosia “stranieri”10, che a quel tempo venivano a risiedere tem-poraneamente o stabilmente a Roma per motivi devozionali, commerciali o altro.
Ogni schola, fin dal momento della sua erezione, si dotò di una propria cappella ubicata nelle immediate adiacenze degli altri edifici e strutture che la compone-vano (forse una scuola, probabilmente un hospitium, certamente un cimitero)11 e adibita alle quotidiane esigenze del culto dei suoi afferenti: sicché, i Sassoni fecero capo alla chiesa di S. Maria, perciò detta in Saxia, i Longobardi a quella di S. Giu-stino, i Franchi a S. Salvatore de Terrione, infine i Frisoni alla nostra chiesa intitolata all’Arcangelo Michele. Tali cappelle erano servite in principio da un certo numero
contro il dominio franco, i Frisoni furono definitivamente sottomessi da Carlomagno verso il 790. In quell’occasione, giunse a compimento anche la loro conversione al cristianesimo, iniziata già alcuni decenni prima grazie alle missioni degli evangelizzatori anglosassoni Willibrord e Wynfrith-Bonifacio (cfr. sesTan 1952, pp. 300-301 e pp. 304-305, nt. 49).
9. LP, II, p. 6. Gli studi che hanno preso a oggetto d’indagine l’una o l’altra delle scholae peregrinorum del borgo di S. Pietro sono relativamente numerosi. Unico, tuttavia, ad averne offerto sinora una trattazione d’insieme abbastanza esaustiva resta, per quanto ci è dato sapere, perrayMonD 1979. Incentrato quasi esclusivamente sul periodo delle origini delle scholae è lo studio di cassanelli 1976. Senza voler qui ripercorrere una bibliografia, come detto, piuttosto vasta, ci limiteremo a segnalare ancora gli studi di De waal 1897, ehrle 1924, Moore 1937 e schieffer 1998, dedicati alla schola dei Franchi, alla quale nel panorama storiografico generale sembra aver arriso una particolare fortuna, forse in virtù della tradizione che vorrebbe identificare nello stesso Carlomagno il fondatore di questa schola. Sulla schola dei Frisoni, oltre agli autori citati alla nt. 1, interessanti e originali osservazioni si possono trovare in van kessel 1981. La questione delle scholae da un punto di vista topografico è stata affrontata da reekMans 1970 e, più di recente, da pani erMini 2001, pp. 319-320, con apparato cartografico. Un sommario profilo storico delle medesime è offerto infine in esposiTo 2001, pp. 220-223.
10. Questa pare la corretta interpretazione che in tale contesto va data al termine latino peregrini, spesso inteso invece, in un senso più restrittivo, come equivalente ai nostri “pellegrini”. Cfr. le giuste osservazioni al riguardo di van kessel 1981, pp. 42-43.
11. Ciò almeno è quanto suppone perrayMonD 1979, p. 187. Di queste antiche strutture delle scholae del Borgo di S. Pietro nulla è oggi rimasto, a eccezione, forse, di alcuni ambienti ipogei (una serie di grotte scavate nel tufo) posti dietro l’abside della chiesa dei Ss. Michele e Magno, emersi durante gli scavi del 1993 − ma già da tempo noti grazie alla dettagliata pianta del complesso realizzata agli inizi del XVII secolo dall’architetto del Capitolo di S. Pietro Prospero de Rocchis (cfr. CBCR, III, pp. 126-127) − che secondo alcuni potrebbero identificarsi con il luogo deputato dai Frisoni alla sepoltura dei loro connazionali. Cfr. Bianchi 1999, p. 75.
Mirko Stocchi
10
di chierici, detti scholenses, reclutati tra i membri della “nazione” di appartenenza di ciascuna fondazione12. Tra i loro compiti, principale sembra essere stato quello di garantire la sepoltura ecclesiastica dei propri connazionali13.
Dal momento che le testimonianze documentarie di cui ci accingiamo a trat-tare, come si vedrà, non sono state prodotte per o dall’ente la cui storia contribu-iscono almeno in parte a ricostruire (si tratta, in altre parole, di fonti che potrem-mo definire “esogene”), ci si potrebbe chiedere se sia esistita o meno in passato una documentazione propria della chiesa di S. Michele, forse identificabile – in parte o del tutto – con quella afferente all’antica schola dei Frisoni; e, se questa vi fu, per quali ragioni e in quali tempi andò, come pare, completamente perduta.
Occorre dire, innanzitutto, che la presunta perdita dei più antichi documenti concernenti la chiesa e la schola dei Frisoni, qualora si fosse verificata, non rappre-senterebbe certo un fatto isolato, bensì si accorderebbe pienamente con il quadro, piuttosto deludente, offerto dalla tradizione documentaria degli enti ecclesiastici romani in età altomedioevale: pochi, infatti, sono i documenti privati antecedenti il secolo XII giunti fino a noi; quasi del tutto assenti, più in particolare, gli atti privati prodotti da o per gli enti ecclesiastici secolari durante tutto il periodo che precedette la seconda metà del X secolo14.
Le ipotesi tradizionalmente avanzate per tentare di spiegare questo vuoto di documentazione hanno chiamato in causa di volta in volta le ricorrenti distruzioni provocate nell’Urbe da guerre, saccheggi e incendi15, quando non «il mero disin-
12. Dell’organizzazione e della gerarchia interna di questi scholenses la scarsità delle fonti non permette purtroppo di dire molto. Il testo di un privilegio falsamente attribuito a Carlomagno, di cui si discuterà in seguito (§ 4), vorrebbe che l’imperatore avesse stabilito in S. Salvatore, cappella della schola Francorum, tre sacerdoti e dodici chierici: «Itaque stabili iussu decrevit nostra auctoritas in prefata ecclesia tres presbiteros et duodecim clericos scolasticos litteras scientibus tonsis comis ministrent illic cum presbiteris ibidem Deo famulantibus» (schiaparelli, c. i). La conclamata inautenticità del documento in questione rende quantomeno discutibile il valore storico di questo dato, sebbene l’alta valenza simbolica dei numeri tre e dodici abbia lasciato supporre che esso possa rispecchiare l’effettiva situazione all’epoca della fondazione della schola o, quantomeno, a quella della redazione del falso, forse la prima metà del sec. XII (cfr. schieffer 1998, pp. 29-30). In ogni modo, verso la metà del XII secolo in S. Michele gli scholenses sembrano ormai aver ceduto il passo a un collegio di chierici, forse di tipo canonicale, con a capo un archipresbyter (cfr. de Blaauw 1992-1993, p. 160). Il passaggio allo status di collegiata durante i primi due secoli dopo il Mille fu, d’altronde, un destino comune a molte fondazioni altomedioevali romane (cfr. carpegna falconieri 2002, p. 191, nt. 280 e contesto).
13. Tutte le fonti qui esaminate concordano, a proposito della fondazione della chiesa di S. Salvatore della schola Francorum, che essa fu fatta ad sepeliendos peregrinos. La tutela dei rispettivi diritti di sepoltura, inoltre, costituirà come vedremo il Leitmotiv di gran parte della documentazione pervenutaci concernente le scholae.
14. Cfr. carpegna falconieri 2002, pp. 275-282.15. Tristemente celebre fra tutti è il saccheggio perpetrato ai danni dei borghi e della stessa basilica
vaticana dai Saraceni nell’846, il cui racconto ci è stato tramandato, tra gli altri, dal Liber pontificalis (cfr.
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
11
teresse per la conservazione archivistica» che avrebbe caratterizzato buona parte dell’alto medioevo romano16.
Nel caso specifico di cui qui ci occupiamo, vale a dire di un ipotetico, perduto fondo di documenti interessante la schola dei Frisoni e la loro chiesa di S. Michele, alcuni elementi ci inducono a non escluderne del tutto l’esistenza. Tralasciando il periodo altomedioevale, per il quale l’effettiva entità e diffusione della pratica scrit-toria in area romana rimane materia dibattuta17, ci limiteremo a osservare che anche il secolo XIII, durante il quale Roma partecipò al generale processo di «autenti-ca “esplosione”» della produzione di documentazione scritta18, tace quasi del tutto circa le sorti della nostra chiesa. Ciò appare perlomeno sospetto, visto che l’unica fonte che rompe questo silenzio, un atto di vendita di vasti appezzamenti di terreno fatta dai chierici di S. Michele in favore del cardinale Latino Malabranca nel 1286 (cfr. § 5), ci presenta la chiesa dotata di un discreto patrimonio immobiliare, la cui gestione dovrebbe aver richiesto, anche in precedenza, la conservazione di titoli di proprietà e la produzione di atti di eventuali locazioni o di compravendite.
Uscendo dal campo insidioso delle mere supposizioni per porre piede sul ter-reno più saldo offerto dalle fonti storiche, non può essere passata sotto silenzio la presenza di almeno un indizio concreto a riprova del fatto che la stessa coesistenza e interazione della comunità frisone con le altre, numerose istituzioni, ugualmen-te ubicate nei borghi attorno a S. Pietro, richiese probabilmente la produzione di documentazione scritta. Questo, infatti, è quanto sembra dirci un fugace ma ciò
LP, II, pp. 99-101). A questo si aggiunsero le tremende devastazioni provocate nel 1084 dalle truppe normanne al seguito di Roberto il Guiscardo, che rimasero nella memoria collettiva come uno dei momenti più bui della storia di Roma medioevale e che probabilmente provocarono la perdita di molti archivi romani, così come fino ad allora si erano venuti costituendo (cfr. GReGoRoviuS 1900-1901, I, pp. 349-351; carucci 1984). Ancora dal Liber pontificalis sappiamo che durante il pontificato di Pasquale I (817-824) un tremendo incendio distrusse quasi completamente il borgo dei Sassoni, non lontano dal quale sorgeva anche la schola dei Frisoni con la primitiva chiesa di S. Michele (cfr. LP, II, 53-54). A quel tempo, difatti, gli edifici delle scholae dovevano essere realizzati per la maggior parte di legno, come si evince dal fatto che lo stesso Pasquale I, sedato miracolosamente l’incendio, ai peregrini tanto duramente colpiti fece dono di «silvarum copia pro lignorum utilitate, quatenus domicilia sicut ante in eodem loco fuerant, utiliter restaurarent» (ibid.).
16. carpegna falconieri 2002, p. 277.17. Una nuova e interessante ipotesi si è fatta strada di recente tra gli studiosi per spiegare il vuoto
documentario a cui abbiamo fatto cenno. Si è ipotizzata, in altre parole, la permanenza nell’Urbe, più diuturna rispetto a quanto testimoniato in altri ambiti geografici, dell’uso del papiro quale supporto scrittorio, non solo per i solenni documenti pubblici emanati dalla cancelleria pontificia − fatto questo già da tempo noto e assodato (cfr. sanTifaller 1953, pp. 32-52) – ma anche per la redazione dei più semplici atti privati prodotti dai tabelliones e dagli scriniarii romani ancora nel IX-X secolo. Materiale più facilmente deperibile e pertanto meno idoneo alla conservazione rispetto alla coriacea pergamena – da cui fu in seguito completamente soppiantato – il papiro avrebbe in tal modo segnato negativamente le sorti della produzione documentaria altomedioevale a Roma, che per tale ragione potrebbe essere stata ben più cospicua di quanto sinora si è ritenuto. Cfr. carBoneTTi VenDiTTelli 2009, pp. 62-65; raDicioTTi 2009, p. 160.
18. caMMarosano 1991, p. 113.
Mirko Stocchi
12
nondimeno esplicito riferimento in un privilegio di Leone IX datato 21 marzo 1053 – del quale tratteremo ampiamente in seguito (§ 3) – a quello che pare potersi interpretare come un atto privato stipulato, prima di quella data, tra i chierici di S. Michele e quelli di S. Salvatore de Terrione19.
In ogni modo, se di queste testimonianze documentarie – di cui abbiamo ritenu-to, forse con qualche ragione, di poter supporre l’esistenza – qualcosa fosse soprav-vissuto nel 1512, quando cioè la chiesa di S. Michele con tutti i suoi beni passò, come detto, sotto l’amministrazione della Cappella musicale vaticana, pare ragionevole ammettere che oggi se ne troverebbe qualche memoria presso l’archivio capitolare di S. Pietro. Evidenti ragioni, infatti, rendevano in passato più che raccomandabile per il beneficiario del trasferimento di una proprietà – nel nostro caso il Capitolo di S. Pietro per interposizione della Cappella Giulia – far sì che fossero trasferiti nel proprio archivio tutti quei titoli, un tempo tenuti dall’ex detentore del bene acquisi-to, che potessero servire in futuro a tutelarlo nel pacifico possesso del bene medesi-mo, oltre che, in secondo luogo, per assicurarne a sé e ai posteri la memoria20.
Se si eccettuano alcune testimonianze monumentali ed epigrafiche21, sembra dun-
19. Nel privilegio Leone IX stabiliva infatti che: «Frises etiam qui infirmantur extra scolam Frisonum, que vocatur ecclesia Sancti Michaelis, in ecclesia Sancti Salvatoris sepelliantur secundum tenorem locationis quam presbiteri Sancti Michaelis susceperunt a presbiteris Salvatoris» (schiaparelli, c. xVi, il corsivo è nostro). Interessante notare che, dal tenore della nostra fonte, sembra lecito supporre che il documento in questione fosse custodito dai chierici di S. Michele (quam presbiteri Sancti Michaelis susceperunt a presbiteris Salvatoris).
20. Questa è la ragione per cui, per esempio, nell’archivio capitolare di S. Pietro si trovano oggi conservati numerosi documenti un tempo appartenuti all’archivio del monastero – oggi scomparso – di S. Caterina in Borgo, risalenti a una data anche di molto anteriore all’annessione di quest’ultimo al Capitolo vaticano avvenuta nel 1469 (cfr. BV, II, pp. 192-193; il ricco fondo archivistico di S. Caterina, comprensivo di lettere pontificie, strumenti di compravendita, locazioni, testamenti, ecc. occupa oggi le capsulae xxVi e xxix dell’archivio capitolare di S. Pietro, cfr. IS, ff. 199r-204r). La consuetudine di procedere a uno spostamento di “archivi” in occasione del trasferimento di una proprietà sembra, d’altra parte, molto antica e testimoniata a Roma già nell’alto medioevo (cfr. carBoneTTi VenDiTTelli 2009, pp. 56-57). Sul monastero di S. Caterina in Borgo (anche detto S. Caterina “de Portica S. Petri”, o “delle Cavallerotte”), demolito nel 1659 per far posto al colonnato di Piazza S. Pietro, si veda Monasticon Roma-Lazio, p. 47, n. 51, con rimando a relative fonti e bibliografia. Per altri esempi di fondi archivistici di enti ecclesiastici soggetti a S. Pietro confluiti, in toto o parzialmente, all’interno dell’archivio capitolare vaticano vd. rezza – Stocchi 2008, p. 10.
21. L’edificio chiesastico, oggi molto alterato dai rifacimenti settecenteschi, conserva tuttavia nella sua struttura l’originario impianto di XII secolo (cfr. CBCR, III, pp. 126-128). Un tempo si è creduto di poter identificare nel bel campanile romanico, posto sul fianco della chiesa, l’unica testimonianza superstite della precedente fondazione di età carolingia (cfr. Blok 1909, p. 44, seguito ancora da perrayMonD 1979, p. 198). Indagini successive ai lavori di restauro, che hanno interessato il campanile nei primi anni Novanta del secolo scorso, hanno tuttavia contribuito a smentire definitivamente questa ipotesi, riconoscendo nella sua architettura elementi tipici delle torri campanarie romane del secolo XII (cfr. de Blaauw 1992-1993, pp. 196-200). Ciò nondimeno, le pur limitate indagini archeologiche effettuate in quegli stessi anni hanno portato alla scoperta di alcune strutture murarie poste sotto l’attuale piano di calpestio della chiesa, nelle quali è forse possibile ravvisare i resti del primitivo
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
13
que legittimo ipotizzare che già nel secondo decennio del ’500 nulla più fosse rimasto presso l’antica chiesa dei Frisoni a memoria di una storia antica di oltre sette secoli22.
2. Il privilegio di Leone IV per S. Martino in Vaticano (854)
Il documento più antico dell’archivio capitolare di S. Pietro in cui si faccia menzione della chiesa di S. Michele è, come noto, un privilegio indirizzato da Le-one IV al monastero di S. Martino in Vaticano, recante la data del 10 agosto 85423. Il suo testo ci è pervenuto grazie a una copia realizzata dallo scriniarius Giovanni nel 114124 (Tav. 16), le cui numerose lacune, aggiunte, correzioni e ripensamenti confermano quanto denunciato dallo stesso Giovanni nella nota apposta in calce al suo lavoro: ovverosia, il pessimo stato di conservazione in cui si trovava, già ai suoi tempi, l’originale documento su papiro, che andò in seguito – non si sa bene quando – perduto25.
Poiché il medesimo scriniario fu anche l’autore della copia di un sedicente diploma di Carlomagno, di cui ci occuperemo in seguito (§ 4) e che si è rivelato manifestamente un falso, sembra opportuno far precedere all’analisi del contenu-to del documento dell’854, così come ci è stato tramandato, qualche osservazione
edificio di culto della schola dei Frisoni (de Blaauw 1992-1993, pp. 188 e 205). Sulle memorie epigrafiche che al presente si conservano in situ vd. ferrua 1966 e MoorMann 1992-1993.
22. Difficile comprendere appieno a cosa facesse riferimento Blok, quando sostenne di aver trovato «la colonia [dei Frisoni] nominata nelle scarse reminiscenze dell’archivio ecclesiastico del s. Michele, conservato nell’archivio di S. Pietro (caps. 27, fasc. 314)» (cfr. Blok 1909, p. 50, nt. 1). Stando, infatti, a quanto riportato nell’Index scripturarum dell’archivio capitolare, all’interno del fascicolo indicato da Blok gli unici documenti concernenti la nostra chiesa sono: un contratto di locazione con cui la medesima fu affidata, nel 1658, dal Capitolo di S. Pietro alla Compagnia del SS. Sacramento; e un memoriale, consegnato ai canonici dalla medesima Compagnia, «per il residuo delle candele e torcie rimaste nell’esequie di Clemente papa IX» (cfr. IS, f. 204r).
23. Regesto: J 1990; JL 2653; IP, I, 138, n. 15. Edizione: BV, I, pp. 15-17; schiaparelli, c. ii. Demolito verso la metà del XV secolo per dar luogo agli incipienti lavori di ricostruzione della basilica di S. Pietro, l’antico monastero di S. Martino – la cui prima testimonianza risale al 680 – si trovava sul lato settentrionale dell’antica fondazione costantiniana, in prossimità dell’abside. In esso si era svolta la formazione giovanile dello stesso Leone IV, il che contribuisce almeno in parte a spiegare il favore con cui il papa guardò a questo monastero, che il privilegio dell’854 sembra promuovere al rango di vero e proprio centro direttivo di buona parte dell’organizzazione ecclesiastica della nuova Città Leonina. Sul monastero di S. Martino vd. ferrari 1957, pp. 230-240 e Monasticon Roma-Lazio, pp. 69-70, n. 133, con relative fonti e bibliografia.
24. Sul corpo e l’attività degli scriniarii sanctae Romanae Ecclesiae, scrittori ufficiali di documenti privati alle dipendenze della cancelleria pontificia, la cui attività a Roma è attestata dalla seconda metà del X secolo, vd. carBoneTTi 1979.
25. «Ego Iohannes scriniarius sanctae Romanae Ecclesiae sicut inveni in thomo carticineo iam ex magna parte vetustate consumpto [...] diligenter exemplavi et scripsi atque a tenebris ad lucem perduxi» (schiaparelli, c. ii, nt. 1). Sulla scarsa qualità della copia eseguita dallo scriniario Giovanni vd. anche le osservazioni di carBoneTTi VenDiTTelli 2009, p. 60, nt. 41.
Mirko Stocchi
14
circa gli elementi che depongono a favore della sua autenticità e della diligenza con cui Giovanni tentò di portare a compimento, malgrado tutto, l’incarico a lui affidato. A tal fine potrà tornare utile un confronto con quanto rimane di un pri-vilegio papiraceo originale emanato dallo stesso Leone IV pochi anni prima del nostro: il frammento conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (Sala dei papiri, 1), datato all’anno 85026 (Tav. 17).
Purtroppo, come premesso, di quest’ultimo non resta oggi molto: oltre al si-gillo di piombo, sorprendentemente conservatosi, il frammento presenta l’ultima parte della sanctio, cioè la formula minatoria di una pena per i trasgressori della volontà pontificia, lo scriptum, vale a dire la menzione dello scrittore del documen-to, la formula di saluto (salutatio) nella caratteristica forma bene valete, e l’inizio della data lunga comprensiva della menzione del funzionario di cancelleria cui si dovette l’emissione del privilegio (datatio)27. Stando così le cose, è chiaro che non si può avere un riscontro puntuale su questo originale di tutte le formule e degli altri usi cancellereschi riprodotti nella nostra copia. Ciò nondimeno, a fronte di qualche divergenza nella resa della sanctio e dello scriptum, forse giustificabile con il diverso tenore dei due documenti, per la datatio si osserva una quasi perfetta corrispondenza tra l’uso seguito nel frammento originale vaticano e quello testi-moniato dalla nostra copia28. Inoltre, a conferma del fatto che il nostro copista ebbe effettivamente dinanzi agli occhi un privilegio originale di Leone IV, sembra decisivo osservare la sostanziale identità di forme tra la croce ornata che Giovanni riprodusse nella sua copia prima del bene valete e le due croci che nel frammento precedono e seguono lo stesso elemento della salutatio papale.
Appurata (una volta di più) la sostanziale affidabilità dell’apografo realizzato da Giovanni, va detto che le numerose omissioni che, come premesso, lo caratte-rizzano c’impediscono oggi di comprendere appieno il tenore complessivo delle disposizioni papali in esso contenute. In altre parole, sembra fuori di dubbio che il documento dell’854 elenchi una serie di proprietà e di prerogative spettanti a quella data ai monaci di S. Martino; non altrettanto chiaro è, invece, se Leone IV si limitò in quella circostanza a riconoscere e a confermare i diritti su beni già da tempo in possesso del monastero, oppure se questi furono da lui fissati per la pri-
26. Edizone: Marini 1805, p. 14, n. 12. Vd. anche: IP, 5, p. 39, n. 99; JL 2606. Riproduzione, analisi paleografica e trascrizione in sTeffens 1910, pl. 58; e Paleografia latina, tav. 68.
27. Per queste, come per le altre definizioni delle partizioni del documento pontificio, e più in generale diplomatistico, cfr. Bresslau 1998, pp. 48-51, e pp. 71-82.
28. «Datum pridias kalendas septembrias per manum Tiberii primicerii sanctae sedis apostolicae, imperante domino nostro piissimo perpetuo augusto Hlotario a Deo coronato magno imperatore, anno tricesimo tertio et post consulatum eius anno tricesimo tertio sed et Hlodouvico nobo imperatore eius filio anno primo, indictione tertiadecima», recita il privilegio dell’850; «Datum .iiii. idus augustus per manum Theophilacti secundicerii sancte Sedis apostolicae, inperante domno nostro piissimo perpetuo augusto Lothario a Deo coronatus magno inperatore anno tricesimo et septimo, et post consulatus anno tricesimo et septimo, indictione secunda», il nostro privilegio.
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
15
ma volta. Né – entrando in un ordine di considerazioni prettamente giuridico – è possibile stabilire con certezza se ci si trovi in presenza di una concessione, vale a dire del conferimento di un possesso in usufrutto, oppure di una donazione, cioè di un vero e proprio trasferimento di proprietà29.
L’ipotesi più verosimile finora avanzata sembra quella che ritiene il privilegio dell’854 una diretta conseguenza dell’erezione, da poco portata a termine, del-la cinta muraria costitutiva della civitas nova vaticana, la Città Leonina, e della necessità che ne derivò per il papa di riorganizzare i rapporti tra i numerosi enti ecclesiastici che al tempo sorgevano nella zona30. In questa prospettiva, la chiesa di S. Michele sarebbe dovuta divenire nei disegni del pontefice una sorta di cap-pella dipendente da S. Martino, come pure le altre quattro “cappelle nazionali”, ugualmente nominate nel privilegio: S. Salvatore dei Franchi, S. Maria dei Sassoni e S. Giustino dei Longobardi31.
Analizziamo in ogni modo più da vicino i relativi passi del documento nella trascrizione fattane dallo scriniario Giovanni.
Leo episcopus servus servorum Dei . . . . . . . . . . . . . . monasterii Sancti Martini qui situm est post absidam in introitu ecclesie beati apostolorum principis in perpetuum. Convenit apostolico moderamini pia religione pollentibus benivola compassione succurrere ac poscentium animu alacri devotione impertiri assensum; ex hoc enim lucri potissimum premium apud conditorem omnium Deum promeremur si venerabilia loca oportune ad meliorem fuerint statum sine dubio perducta * * * * * * * * * * * * * * * * * * * pontificalem
29. Circa la distinzione del diritto classico fra possesso (possessio) e piena proprietà (proprietas o dominium) e le sue applicazioni durante il medioevo in area romana vd. wickhaM 2008. Secondo Marazzi 1998, pp. 159-160, all’ambiguità dei termini utilizzati nel documento potrebbe in realtà corrispondere un concetto abbastanza chiaro, «vale a dire, la tutela del diritto eminente del pontefice su quanto ricadesse nella sua giurisdizione territoriale, che si esprime anche attraverso la fissazione di un canone ricognitivo annuo da versare alle casse papali». La possibilità che possa trattarsi di una donazione pare esclusa da lenzi 1999, p. 821. Un’altra questione di difficile risoluzione circa il nostro documento – che prescinde stavolta dal suo precario stato di conservazione – è poi se i diritti posseduti dal monastero di S. Martino sulle chiese soggette, compresa la nostra di S. Michele, avessero natura territoriale oppure patrimoniale; sempre che una simile distinzione continuasse ad avere senso in un periodo in cui nell’organizzazione ecclesiastica romana si avviava a scomparire «il concetto stesso di territorialità» (carpegna falconieri 2002, p. 201).
30. herBers 1996, pp. 255-258; schieffer 1998, pp. 26 e 37; Marazzi 1998, p. 158.31. Se così fosse, non si potrebbe far altro che convenire con Ehrle, quando scrisse che: «come la
bolla di Leone IX non è che la conferma d’una più antica bolla di Leone IV dell’854, non vi è dubbio che già questa data e la irruzione dei Saraceni nell’846, segna il principio della decadenza delle scuole, la fine della loro autonomia e della loro organica e vitale connessione con le madri patrie» (ehrle 1924, p. 32). Lo stesso autore, tuttavia, sembrò in parte attenuare i toni di questa prima asserzione, aggiungendo che, al 1361 sembrerebbe risalire «l’ultimo ricordo delle funzioni proprie della scuola dei pellegrini nella chiesa di S. Salvatore, già subordinata al servizio della Basilica Vaticana» (ehrle 1924, p. 33). Fondandosi sull’epigrafe dei cavalieri frisoni, di cui si dirà (§ 4), Blok giunse invece a sostenere che: «la colonia [dei Frisoni a Roma] era ancora nella più grande prosperità almeno nel secolo XIII» (Blok 1906, p. 49).
Mirko Stocchi
16
sacratissimam et finetenus * * * * * * * * * * * * * ecclesia Sancti Salvatoris Domini nostri ad sepeliendos omnes peregrinos, ecclesia Sanctae Dei genitricis virginis Marie que vocatur scola Saxonum * * *, ecclesia Sancti Michaelis que vocatur scola Frisonorum, ecclesia Sancti Iustini qui appellatur scola Langobardorum una cum ecclesia Sancti Zenonis cum casis, criptis, vineis, puteis, arboribus fructiferis et infructiferis cum omnibus pertinentiis, posite infra hanc nostram nova civitate Leoniana32.
Come si vede, ben poco nella copia si è conservato del protocollo del docu-mento originale: perduta l’intitulatio (la parte iniziale del documento, in cui era espresso il nome del papa e il titolo che egli si attribuiva nella prassi documentale), qui integrata dall’editore; quasi del tutto scomparsa anche l’inscriptio (dove era menzionato il destinatario, singolo o collettivo, delle disposizioni pontificie), di cui rimane la sola locuzione «Sancti Martini qui situm», significativa certo, ma non sufficiente a definire con la precisione che ci saremmo augurati il destinatario del privilegio: se si trattava, come pare probabile, del superiore della comunità, era egli qualificato nel documento come abbas? Oppure, come accadrà in seguito, con il titolo di archipresbyter? Era espresso il suo nome?
Passando all’analisi di quanto nella nostra copia resta del dispositivo del do-cumento originale, ovviamente solo per la parte che qui c’interessa, notiamo che la «ecclesia Sancti Michaelis» dei Frisoni è per nostra fortuna quasi pienamente espressa, in modo tale comunque da non lasciare adito a dubbi circa la sua identifi-cazione. D’altro canto, ci si rende conto che dal passo sopra citato nulla si desume circa il ruolo assegnato alle cappelle delle scholae peregrinorum nei disegni di Leone IV, che sembrano trattate qui al rango di mere pertinenze espresse propriis vocabu-lis, al pari di altri bona ubicati nei pressi della Città Leonina («... cum casis, criptis, vineis, puteis, arboribus... infra hanc nostram nova civitate Leoniana ...»).
Per concludere questa breve disamina, constatiamo che la copia del privilegio dell’854 di cui fu autore lo scriniario Giovanni, a prescindere dalle sue numerose lacune, getta ben poca luce sulle implicazioni pratiche che le decisioni di Leone IV ebbero nell’immediato sulle relazioni tra i chierici posti fino a quel momento al servizio esclusivo delle scholae e i monaci (o presbyteri?) del monastero vaticano. In altre parole, ci restano quasi del tutto ignoti i termini concreti della iurisdictio33 – certamente implicata dalla subiectio decretata in quell’occasione dal papa – eser-citata dai secondi sui primi.
32. Cfr. schiaparelli, c. ii. Si riproducono in corsivo i passi integrati dall’editore.33. In epoca posteriore, come vedremo, questa giurisdizione comportava spesso per la chiesa
soprastante l’esercizio di poteri di nomina, correzione e destituzione sul clero della chiesa soggetta, oltre al diritto alla riscossione di un censo con cadenza periodica (solitamente annuale) e a vari obblighi legati all’espletamento di particolari funzioni liturgiche.
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
17
Buone ragioni, come vedremo, ci inducono a ritenere le scholae ancora vive e attive alla metà del IX secolo, ed è dunque più che legittimo pensare che a quella data gli scholenses del borgo di S. Pietro continuassero a godere qualche preroga-tiva sulle rispettive cappelle o che, perlomeno, essi si sforzassero di rivendicarla. Purtroppo, però, l’assenza di qualsiasi fonte alternativa su cui poter condurre una simile indagine ci impedisce di scrivere questa pagina importante della più antica storia di S. Michele dei Frisoni.
3. Il privilegio di Leone IX per i canonici di S. Pietro (1053)
Alcune risposte ai numerosi interrogativi lasciati irrisolti dal privilegio dell’854 ci vengono forse offerte dal successivo documento oggetto della nostra indagine. Il privilegio emanato da Leone IX il 21 marzo 105334 (Tav. 18) ribadisce infatti, tra le altre cose, la giurisdizione del monastero di S. Martino sulla chiesa di S. Miche-le, come, più in generale, sulle altre cappelle delle scholae di S. Pietro.
Riguardo alla chiesa di S. Salvatore dei Franchi, Leone IX stabilì in quella circostanza che, qualora alcuno dei pellegrini d’oltralpe fosse deceduto a Roma o all’interno del suo circuitus («ab Alba usque Sutrium»), il suo corpo trovasse sepol-tura, come da antica tradizione, nella chiesa dei discendenti di Carlomagno.
[Confirmamus vobis (cioè ai canonici residenti in S. Martino)] ecclesiam Domini nostri Salvatoris que vocatur scola Francorum una cum suis possessionibus et usibus et utilitatibus, quas Karolus imperator ecclesie Sancti Salvatoris donavit et per privilegium confirmavit et Leo quartus privilegio concessit, et census quos de ultramontanis partibus annuatim statuerunt micti et recipi per manus
34. Regesto: J 3260; JL 4292; IP, I, 146, n. 4. Edizione: BV, I, 22; schiaparelli, c. xVi. Il privilegio, diretto a Giovanni «archipresbitero venerabilis ecclesie Beati Petri apostoli et eiusdem ecclesie canonicis in monasterio Sancti Martini nunc ordinatis et ordinandis», è stato considerato in passato in stretta correlazione con l’antecedente di Leone IV, alcune lacune del quale sono state per questa ragione colmate proprio sulla base del primo (così fece per l’appunto Schiaparelli nell’edizione da lui curata, cfr. supra, nt. 23). A esso, inoltre, è stato dato particolare rilievo nell’ambito delle ricerche concernenti le origini del Capitolo vaticano, in quanto pare dirci, tra le altre cose, che nella gestione dei rapporti tra le chiese delle scholae e il cenobio vaticano – come pure nell’amministrazione delle altre proprietà e prerogative di questo – ai monaci sarebbero a quel tempo subentrati i canonici. L’attendibilità di quest’ultimo dato, tuttavia, merita oggi di essere attentamente ridiscussa alla luce di uno studio recente, che ha sollevato non pochi dubbi riguardo all’autenticità dei tre privilegi, tra cui quello qui preso in esame, considerati sinora come indirizzati da Leone IX ai canonici di S. Pietro (cfr. JohrenDT 2009 e sTocchi 2010, p. 5, nt.1). Ciò nondimeno, per quanto attiene nello specifico al nostro documento, pare che esso debba considerarsi autentico, almeno nella sostanza: il privilegio indirizzato da Leone IX a S. Martino sarebbe stato, tutt’al più, reso anacronistico in alcuni luoghi dai copisti del XIV secolo, cui dobbiamo la sua tradizione (cfr. JohrenDT 2009, pp. 108-109).
Mirko Stocchi
18
ministrorum concedimus eidem monasterio permanendos ad utilitatem eorum qui in choro Beati Petri Deo alacri animo serviunt, positam iuxta murum civitatis nobie [sic] que vocatur Leoniana super Terrionem, constitutam ad sepulturam omnium hominum de qualibet parte mundi Romam venientium qualicumque ex causa, sicuti a Leone IIII concessum est dicte ecclesie Sancti Salvatoris. Set si de ultramontanis partibus fuerint peregrini et advene, divites et pauperes, nobiles vel ignobiles, quoscumque mori contigerit in hac alma urbe Roma vel in circuitu eius, sicuti ab Alba usque Sutrium, omnes in iam dicta ecclesia Salvatoris sepelliantur, nobiles et ignobiles, divites et pauperes, advene et peregrini, aut ubi vos iusseritis, si necessitas compulerit35.
Dalle prerogative funerarie di S. Salvatore, enunciate nel passo appena citato, Leone IX escluse però gli Angli il cui decesso si fosse verificato nella schola Saxiae: in tal caso gli scholenses di quest’ultima, in base a non meglio precisati accordi intervenuti in precedenza con la chiesa di S. Salvatore, avevano infatti ottenuto da quest’ultima il diritto – ora riconosciuto anche dal papa – di seppellire i propri connazionali presso la loro chiesa di S. Maria in Saxia.
Nullus presumat aliquem illorum aut bona eius occultare aut contra voluntatem vestram retinere, preter Anglos venientes de Anglia, qui, si in scola Saxie infirmantur et ibi moriuntur, ibi sepelliantur secundum cartulas locationum, quas presbiteri et hospites qui vocantur scolenses ipsius scole Saxie susceperunt ab ecclesia Sancti Salvatoris de ecclesia cum camminatis et scola Saxie et omnibus eius pertinentiis, nec non de sepultura Anglorum qui in ipsa infirmantur atque moriuntur scola; set si preter ipsam infirmantur, ubicumque moriuntur, in ecclesia Sancti Salvatoris sepelliantur secundum proprium ius36.
Inoltre, sull’esempio di Carlomagno e di Leone IV, che elargirono grazie e privilegi al fine di accrescere le sostanze del monastero vaticano, Leone IX stabi-liva che i preti di S. Maria versassero due volte l’anno una pensio al monastero di S. Martino e che fossero rispettati da ambo le parti gli accordi stipulati in prece-denza.
Imperator autem et Leo papa quod ecclesia Salvatoris habuerat non abstulerunt, set illi de gratia multa dederunt, et privilegiis concesserunt. Ideo nos concedimus pensiones in monasterio Sancti Martini bis in anno dari a presbiteris Sancte Marie et locationes ab utraque parte teneri37.
35. schiaparelli, c. xVi.36. Ibid.37. Ibid.
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
19
Le successive disposizioni di Leone IX in merito alla gestione dei rapporti tra S. Martino e le scholae peregrinorum del borgo di S. Pietro riguardano ciò che a noi maggiormente interessa, vale a dire i Frisoni e la loro chiesa di S. Michele. Il papa stabiliva che questi ultimi, qualora fossero deceduti al di fuori della loro schola – anche qui secondo accordi (secundum tenorem locationis) stipulati in precedenza con i chierici di S. Salvatore – fossero sepolti presso la chiesa dei Franchi. Per con-verso, si può dire che in quella circostanza fu loro riconosciuto dal papa, seppure implicitamente, il medesimo diritto riconosciuto in modo esplicito agli Angli di S. Maria in Saxia, vale a dire quello di seppellire i propri connazionali presso la loro chiesa, ma solo qualora questi ultimi fossero deceduti nell’ambito della schola di loro pertinenza.
Frises etiam qui infirmantur extra scolam Frisonum, que vocatur ecclesia Sancti Michaelis, in ecclesia Sancti Salvatoris sepelliantur secundum tenorem locationis quam presbiteri Sancti Martini susceperunt a presbiteris Salvatoris38.
Infine, Leone IX concesse e confermò a S. Martino il possesso di tutta l’area (unum fundum e duo burgura) dove sorgevano le scholae dei Sassoni e dei Frisoni, oltre naturalmente ai diritti sulle varie chiese e cappelle in quella esistenti.
Item concedimus et confirmamus unum fundum quod vocatur Palatiolum et duo burgura, unum qui vocatur Frisonorum et Saxonorum cum terminis limitibusque eorum et omnibus eorum pertinentiis una cum ecclesia Sancti çenonis et ecclesia Sancti Nicolai et ecclesia Sancti Michaelis que vocatur scola Frisonorum atque ecclesia Sancte Dei genitricis virginis Marie et ecclesia Sancti Salvatoris de Bordonia, nec non ecclesia Sancte Dei genitricis virginis Marie que vocatur scola Saxonum39.
Volendo ora riassumere i dati emersi dalla nostra analisi, osserviamo che dal privilegio di Leone IX del 1053 si evince un ruolo di preminenza riconosciuto a quel tempo alla chiesa dei Franchi nell’ambito dei rapporti con le altre cappelle delle scholae peregrinorum. A questo primato tuttavia, definito e legittimato da una serie di accordi scritti intervenuti in precedenza tra le parti40, non corrispondeva una piena autonomia sul piano istituzionale, dal momento che la chiesa dei Fran-
38. Ibid.39. Ibid.40. S. Salvatore pare svolgere un ruolo privilegiato anche nei rapporti tra le chiese dei borghi e la
comunità rappresentata da tutti gli abitanti della Città Leonina: più avanti nel documento di Leone IX si parla infatti anche di una locatio, «quam omni populo civitatis Leoniane fecit ecclesia Sancti Salvatoris de hospitandis oratoribus et vendendis necessariis, sicut ipsi ad recompensationem utilitatis locationis in presentia Leonis quarti concesserunt monasterio Sancti Martini et ecclesie Salvatoris, quod nos concedimus et confirmamus...» (schiaparelli, c. xVi).
Mirko Stocchi
20
chi, come abbiamo visto, sembra essere stata sotto il pieno controllo del monaste-ro vaticano di S. Martino fin dal tempo di Leone IV.
In questa struttura piramidale la base pare costituita dai chierici delle altre cappelle, cui sembra venire riconosciuto ormai soltanto il diritto di seppellire nella loro chiesa i propri connazionali, ma solo qualora questi per morire non si fossero allontanati dal territorio, verosimilmente non troppo esteso, segnato dai confini della rispettiva schola.
Per concludere: dal privilegio di Leone IX per S. Martino le scholae peregrino-rum di S. Pietro, con le loro cappelle nazionali, sembrano ancora ben vive e attive alla metà del secolo XI. Tuttavia, esse appaiono ormai sempre più assoggettate a quel processo di erosione, iniziato a quanto pare già due secoli prima, della loro autonomia e, dunque, anche della loro peculiare identità rispetto agli altri nume-rosi enti ecclesiastici della zona41.
4. Il falso diploma di Carlomagno e un’epigrafe medioevale nella chiesa dei Ss. Michele e Magno
Il medesimo scriniario Giovanni, a cui si deve, come abbiamo visto, la copia del privilegio di Leone IV dell’854, trascrisse pressappoco nello stesso anno 1141 un altro documento piuttosto controverso, oggi facente parte pur’esso dell’archi-vio capitolare di S. Pietro. Si tratta della pergamena contenuta nella capsula XI, fasciculo 18, per la quale è invalso da tempo l’appellativo di “falso diploma di Carlo-magno”, già più volte pubblicato e studiato da diversi autori fin dal secolo XVII42 (Tav. 19).
Nel falso diploma, in realtà, la chiesa dei Ss. Michele e Magno non è affatto menzionata e i Frisoni vi compaiono nominati solo incidentalmente. Eppure, un
41. Sembra di poter riconoscere in ciò un indicatore del più generale processo in atto a Roma, mediante il quale la geografia ecclesiastica dell’Urbe, abbandonate le incertezze e le fluidità del periodo altomedioevale, si avviava verso l’instaurarsi di rapporti sempre più definiti in modo gerarchico tra le diverse chiese, al termine del quale si sarebbe giunti all’affermazione del sistema organizzativo incentrato sul binomio ecclesia matrix-ecclesia filialis, ovverosia al definirsi delle circoscrizioni parrocchiali degli ultimi secoli medioevali. Sull’argomento vd.: passigli 1993 e 1998; carpegna falconieri 2002, pp. 195-226; sTocchi 2010, in particolare pp. 8-11.
42. Cfr. Torrigio 1639, pp. 503-510. Già Mühlbacher ne appurò la non genuinità (cfr. RI, I, 1, p. 152, n. 340). De waal 1897, pp. 12-16, fece delle ipotesi sull’identità del falsario: un francese piuttosto che un tedesco. schiaparelli (c. i), ne diede per la prima volta un’accurata edizione critica. Infine, in anni recenti ne hanno trattato herBers 1996, pp. 256-259, il quale ritiene che, a dispetto dei palesi indizi di falsificazione, esso possa contenere un nucleo autentico («Das Karlsdiplom bezeichnete zwar schon Mühlbacher als Fälschung, es enthält jedoch wohl einen echten Kern»); e schieffer 1998, che ritiene il falso documento, un prodotto confezionato intorno al 1000 ma probabilmente “ispirato” a un privilegio originale di Carlomagno: «grob gesagt, um 1000 angefertigte Fälschung einer Urkunde Karls des Großen von angeblich 797» (p. 37).
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
21
altro elemento lo rende per noi assai interessante: si tratta della singolare confu-sione che in esso si fa tra i papi Leone III (795-816) e Leone IV (847-855).
Nel falso diploma, infatti, lo pseudo Carlomagno menziona come suo contem-poraneo non il terzo papa di questo nome, come sarebbe stato lecito attendersi – ricordiamo che Carlomagno morì nell’anno 814 – bensì il quarto. Questo «strano e grave errore», come ebbe a definirlo uno dei suoi editori43, ripetuto più d’una volta nel testo del documento e dunque, con buona probabilità, non imputabile all’im-perizia del copista, compare anche in una epigrafe alquanto misteriosa conservata ancora oggi in situ nella nostra chiesa, il cui testo ricorda per l’appunto le vicende della sua fondazione «tempore Leonis IV papae, imperante Carulo Magno impe-ratore»44 (Tav. 20).
La singolare coincidenza fu notata già nel XVII secolo dal Torrigio, il quale, non possedendo gli strumenti critici di cui oggi disponiamo, ritenne a torto che l’epigrafe risalisse effettivamente ai tempi dell’imperatore franco e che, dunque, autentico dovesse considerarsi il testo del suddetto diploma; anzi, all’autorità di questo egli si appellò per giustificare l’incongruenza cronologica riscontrata nella lapide dei Ss. Michele e Magno: entrambi i documenti, a suo modo di vedere, avrebbero difatti avvalorato l’ipotesi «che il detto Leone III è stato alle volte chia-mato IV rispetto ad un antipapa successore di Sergio I creato nel 698»45.
Oggi sappiamo che né il testo del falso diploma né tantomeno l’epigrafe dei Ss. Michele e Magno risalgono ai tempi di Carlomagno. Per quanto riguarda la redazione di quest’ultima, è stato proposto lo scorcio del XIII secolo, più proba-bilmente proprio l’anno giubilare del 130046; mentre, per ciò che riguarda la com-posizione dell’antigrafo – probabilmente su papiro – del falso diploma di Carlo-magno copiato da Giovanni scriniario nel 1141, sono stati proposti i primi decenni del secolo XI47.
Sulla base degli elementi fin qui raccolti, vorremmo prospettare una diversa ri-costruzione, rispetto a quanto da altri è stato proposto, della genesi e delle finalità sia del falso diploma sia dell’epigrafe in questione. Per quanto riguarda in parti-colare quest’ultima, le spiegazioni finora avanzate, che ne vorrebbero attribuire la
43. Cfr. schiaparelli, p. 427 (c. i).44. Dei contenuti della stessa tratta diffusamente Muskens 1993, pp. 98-109.45. Cfr. Torrigio 1639, p. 503 e Torrigio 1629, pp. 40-41.46. Cfr. de Blaauw 1992-1993, p. 162; Muskens 1993, p. 108.47. Quale terminus ante quem per la redazione del presunto originale si è sempre tenuto fermo
sinora il 1053, dal momento che a quella data risale il già più volte citato privilegio di Leone IX per i canonici di S. Pietro residenti in S. Martino, il cui tenore per larghi tratti sembra seguire il testo dello pseudo Carlomagno (cfr. schieffer 1998, pp. 26-27). Tuttavia, le perplessità di recente suscitate circa l’autenticità di questo come di altri privilegi dell’archivio capitolare attribuiti a Leone IX (cfr. supra, nt. 34) ci costringono a riconsiderare anche la validità di questo termine cronologico.
Mirko Stocchi
22
48. Cfr. schiaparelli, I, p. 400.49. Cfr. schiaparelli, c. xxxVii. L’inscriptio del privilegio di Innocenzo II del 1138 – ricordiamo
conservatosi in originale – recita infatti: «dilectis filiis canonicis Sanctorum Iohannis et Pauli, Sancti Martini, Sancti Stephani maioris et Sancti Stephani minoris ad servitium ecclesie Beati Petri apostolorum principis deputatis»; e poco oltre: «sacrosanctas ecclesias Beatorum martyrum Iohannis et Pauli, Sancti Martini, Sancti Stephani maioris et Sancti Stephani minoris vestris usibus ac substentationibus destinatas presentis scripti pagina communimus».
50. Cfr. Blok 1909, pp. 59-60.51. Più tardi – ma quasi certamente prima del 1300 –, quando cioè si concretizzò la definitiva e
completa annessione del monastero al Capitolo di S. Pietro, anche questi due documenti, come molte altre carte un tempo appartenute ai quattro monasteri basilicari vaticani, dovettero passare a far parte dell’unico archivio dei canonici di S. Pietro. Su altri documenti, un tempo appartenuti ai monasteri vaticani e passati in seguito nell’archivio capitolare, vd. rezza – sTocchi 2008, p. 10.
committenza alla schola dei Frisoni, non appaiono infatti molto convincenti, per diverse ragioni.
Occupiamoci in primis del falso diploma. Al riguardo una prima attenta consi-derazione merita, a nostro parere, il fatto che Giovanni scriniario lavorò alla copia sia del privilegio di Leone IV per S. Martino sia del falso diploma di Carlomagno sotto il pontificato di Innocenzo II48. Ora, da un documento emanato da questo stesso pontefice in favore dei canonici di S. Pietro pochi anni prima (1138), si ri-cava che già a quel tempo tutti e quattro i monasteri vaticani erano senza dubbio destinati «ad usum et sustentationes» dell’arciprete e dei canonici di S. Pietro49.
Che l’originale privilegio di Leone IV su papiro si conservasse ai tempi di Gio-vanni presso il medesimo ente – S. Martino – in favore del quale esso era stato emesso circa tre secoli prima, e che venisse copiato nell’interesse del monastero stesso o di chi allora lo occupava, non sembra cosa su cui si possa ragionevolmente dubitare. Alcuni indizi, anzi, ci portano a ritenere possibile – se non addirittura probabile – che verso il 1141 anche il falso diploma di Carlomagno fosse custodito in S. Martino. Infatti, come già altri hanno notato, nel privilegio di Leone IX del 21 marzo 1053 (cfr. § 3) si riprendono quasi alla lettera alcune espressioni del falso diploma50. Questo potrebbe stare a indicare che, già verso la metà del secolo XI, il diploma “originale” dello pseudo Carlomagno si trovasse in possesso di S. Martino e che il suo testo venisse utilizzato per corroborare, presso Leone IX, i diritti un tempo appartenuti alla schola dei Franchi e ora ereditati dal monastero vaticano.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto non è da escludersi, crediamo, che i com-mittenti delle copie realizzate dallo scriniario Giovanni nel 1141 possano essere stati gli stessi canonici di S. Pietro, cui spettava a quel tempo, come si è visto, l’amministrazione del monastero vaticano e dei suoi beni51. Questo contribuireb-be a spiegare, tra l’altro, un fatto altrimenti difficilmente comprensibile, ovverosia proprio la presenza − da lungo tempo testimoniata − di questi due documenti, e specialmente del falso diploma, nell’archivio dei canonici vaticani.
Le ragioni che potrebbero aver indotto i canonici ad affidare a Giovanni scri-niario il compito di salvare dall’oblio il testo di questi antichi documenti sono
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
23
52. Conveniamo in ciò – anche per le ragioni che verremo esponendo – con quanto sostenuto di recente da Anna Esposito, ovverosia che il processo di decadenza delle cosiddette scholae peregrinorum, già in atto nel secolo X, si sarebbe definitivamente e irreversibilmente concluso nel XII (cfr. esposiTo 2001, p. 223).
53. Va notato inoltre che, se così fosse e se dovesse trovare conferma quanto sospettato da Jochen Johrendt, vale a dire che il termine “canonici” utilizzato nell’inscriptio dei privilegi di Leone IX “per i canonici di S. Pietro” del 1053, non sia originario bensì frutto del tentativo di “attualizzare” questi documenti operato dai copisti del XIV secolo cui dobbiamo la loro tradizione (cfr. JohrenDT 2009, in particolare p. 86, nt. 8), potremmo allora identificare proprio nel pontificato di Innocenzo II un momento decisivo nel processo di consolidamento dell’ente capitolare vaticano. In altre parole, si sarebbe compiuto allora – e non al tempo di Leone IX, come sembrano volerci dire i privilegi, forse manipolati, attribuiti a quest’ultimo – il processo mediante il quale i canonici subentrarono ai presbyteri dei quattro monasteri basilicari nei possedimenti e nelle prerogative da questi un tempo esercitate nell’ambito della Città Leonina. Se così fosse, si potrebbe individuare nell’incarico assegnato dai canonici nel 1141 allo scriniario Giovanni un tentativo non solo di salvaguardia, bensì anche, per così dire, di costruzione documentale di una propria memoria storica, che contribuisse a sancire i possedimenti e le attribuzioni – ancora in fieri e probabilmente oggetto di controversie – spettanti al loro nuovo ceto.
54. Cfr. anche Bianchi 1999, pp. 77-78: «L’analisi della scrittura riporta la datazione materiale dell’epigrafe almeno al XIII secolo, più probabilmente verso la fine [...] l’epigrafe dovette essere incisa con ogni probabilità in occasione del primo Giubileo del 1300».
presto chiarite, se solo si considera il nuovo assetto istituzionale venutosi a creare ai tempi di Giovanni nell’area vaticana. In primo luogo, le scholae peregrinorum erano venute estinguendosi o, quantomeno, il loro ruolo rispetto al passato si era fatto del tutto marginale52. Ai canonici di S. Pietro, invece, era stato conferito dai papi il possesso degli edifici dei quattro ex monasteri basilicari, cosa che quasi certamente comportò il loro subentrare anche nel ruolo direttivo – che era stato un tempo di S. Martino – nei confronti di ciò che restava delle scholae e delle loro cappelle. In questo stato di cose, si capisce l’interesse dei canonici di S. Pietro alla salvaguardia dei due documenti sopra citati. Questi – non importa qui se in modo autentico o meno – attestavano infatti una lunga serie di diritti e di privilegi: dell’ex monastero di S. Martino sulle scholae peregrinorum del Borgo (il privilegio di Leone IV) e della schola e chiesa dei Franchi su numerosi possedimenti e preroga-tive nell’ambito della Città Leonina e non solo (il falso diploma di Carlomagno). è probabile che, nel 1141, tali prerogative fossero rivendicate dai canonici posti al servizio della basilica, eredi, de facto e de iure, di quelle che erano state un tempo le attribuzioni dei monaci dei monasteri basilicari vaticani53.
Veniamo ora all’epigrafe. Se dal 1141 ci spostiamo verso le soglie del 1300, epo-ca alla quale secondo alcuni risalirebbe come abbiamo detto la redazione dell’epi-grafe dei Ss. Michele e Magno54, quale situazione troviamo nei dintorni della ba-silica vaticana? Certamente il Capitolo è ora una istituzione molto più strutturata e influente di quanto non fosse alla metà del XII secolo. Nei centosessant’anni circa che separano il lavoro di Giovanni scriniario e l’anno del Giubileo indetto da Bonifacio VIII, papi come Adriano IV (1154-1159), Innocenzo III (1198-1216)
Mirko Stocchi
24
55. Cfr. rezza – sTocchi 2008, pp. 49-54.56. Cfr. rezza – sTocchi 2008, pp. 52-54 e 181-182.57. Già Bianchi 1999 ha avanzato l’ipotesi di una «diretta derivazione» del testo dell’epigrafe «da
uno di questi documenti», la quale tuttavia non gli ha impedito, stranamente, di accogliere la tesi di Muskens, ovverosia la sua committenza da parte della schola dei Frisoni (cfr. ibid., pp. 78-79).
58. Un ultimo contributo alla composizione del testo dell’epigrafe potrebbe essere giunto dalle tradizioni epico-leggendarie, che a quel tempo largamente circolavano, sulle eroiche gesta dei Frisoni, combattenti al fianco di Carlomagno nella lotta contro i saraceni in difesa di S. Pietro. Cfr. BoSi – BeccheTTi 1973, p. 19-20; Bianchi 1999, p. 77.
e Niccolò III (1277-1280) – per non citare che i principali pontefici che beneficia-rono il Capitolo – avevano contribuito a conferire una ben diversa dignità all’ente capitolare vaticano55. Soprattutto quest’ultimo, con l’emanazione dei primi statuta capitolari (1279) e i ricchi donativi fatti in favore della basilica e dei suoi canoni-ci56, aveva consacrato definitivamente il prestigio e il potere del Capitolo petrino e, di conseguenza, consolidato il suo primato nei confronti degli altri numerosi enti ecclesiastici posti all’interno della cittadella vaticana o nelle aree a questa circostanti.
A fronte di ciò, non possiamo non riscontrare il totale silenzio delle fonti ri-guardo alla presunta sussistenza a Roma di una comunità di Frisoni, che potesse vantare ancora a quel tempo diritti sulla chiesa di S. Michele e sui suoi beni. Anzi, come meglio vedremo in seguito (§ 5), non è da escludersi che sulla gestione di tali beni verso la fine degli anni Ottanta del Duecento esercitassero una qualche forma di controllo proprio i canonici di S. Pietro.
è questa, dunque, la situazione in S. Pietro e dintorni alla vigilia della pro-clamazione dell’anno giubilare del 1300, mediante il quale si prefigurò l’arrivo a Roma, e soprattutto nella zona del Vaticano, di un gran numero di pellegrini pro-venienti da ogni parte d’Europa, desiderosi di ottenere l’indulgenza promessa e di visitare i luoghi santi della Città eterna.
A questo punto non sarebbe ingiustificato pensare che siano stati proprio i ca-nonici di S. Pietro i principali, se non gli unici, committenti dell’epigrafe dei Ss. Michele e Magno. Questa sarebbe dovuta servire, nelle loro intenzioni, a istruire i devoti visitatori – in particolare oltramontani – sulle origini antiche e gloriose di quella modesta cappella posta alle loro dipendenze e sui diritti che anticamente le erano stati attribuiti. Da ciò non sarebbe stato inoltre fantasioso per i canonici sperare nella generosa oblazione di qualche facoltoso pellegrino, emulativa di quella riportata dal testo dell’epigrafe (cfr. la trascrizione di Tav. 19). Per la composizione di quest’ultimo, infine, essi potrebbero aver attinto sia dal falso diploma di Carlo-magno (da cui l’insolito scambio tra Leone III e Leone IV che ritroviamo nell’epi-grafe), sia dai privilegi di Leone IV o di Leone IX57, documenti che già a quel tempo, come abbiamo supposto, potevano rinvenirsi nell’archivio capitolare58.
Quanto sin qui ipotizzato, potrebbe trovare ulteriore sostegno nell’esistenza di altri indizi a riprova della propensione dei canonici di S. Pietro a far incidere
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
25
59. Cfr. griMalDi 1972, pp. 418-419.60. Cfr. De waal 1897, p. 19, nt. 1. Un autorevole esempio di tale pratica, d’altra parte, era offerto
ai canonici dalla lapide – tuttora visibile nell’atrio della basilica vaticana – contenente la donazione a S. Pietro di una serie di oliveti, che la tradizione attribuiva a Gregorio Magno (590-604). Il testo dell’epigrafe – da attribuirsi più probabilmente a Gregorio II (715-731) – fu integralmente trascritto nella seconda metà del XII secolo dal canonico vaticano Pietro Mallio, che lo incluse nella sua operetta sulla basilica vaticana. Cfr. CTR, III, pp. 405-407.
61. Cfr. BV, I, pp. 208-210 e de Blaauw 1992-1993, pp. 164-167. Sul cardinale Latino Malabranca (ca. 1235-1294) vd. VenDiTTelli 2006.
su lapide quanto, tra i documenti in loro possesso, potesse servire a corroborare i diritti propri o delle loro chiese. Sappiamo, infatti, che proprio all’indomani della proclamazione del primo Giubileo del 1300, i canonici fecero scolpire su marmo il testo della bolla d’indizione donata loro da Bonifacio VIII, affinché venisse affissa nel portico dell’antica basilica per istruzione di visitatori e pellegrini59. Ancora più interessante, poi, sembra una notizia tramandata dall’Alveri, secondo il quale sulla parete di un’altra antica cappella nazionale divenuta anch’essa in seguito filiale di S. Pietro, la più volte citata chiesa di S. Salvatore de Terrione (anche detta de Ossibus), fino al XVII secolo si conservava affissa una lapide il cui testo, illustrante i diritti dell’ex cappella dei Franchi, era stato tratto di sana pianta da uno degli inventari medioevali dell’archivio capitolare risalente alla metà circa del XIV secolo60.
5. Gli instrumenta della vendita di terreni al cardinale Latino Malabranca (1286-1287)
Risale al 1 marzo 1287 la lettera, con cui Onorio IV confermò l’avvenuta vendi-ta di alcuni terreni adiacenti alla chiesa di S. Michele fatta dai chierici di quest’ul-tima al cardinale Latino Malabranca61. Nel testo della lettera, come era consuetu-dine in occasione di ratifiche papali di documenti pregressi, fu inserito il testo dei due instrumenta, entrambi rogati dal notaio Giovenale Petri de Narnia, mediante i quali nei mesi immediatamente antecedenti si era compiuta la compravendita suddetta: con il primo, stipulato a Tivoli presso l’hospitium del cardinale, il 4 set-tembre 1286, l’arciprete della chiesa «S. Michaelis Frisonum in Porticu Sancti Petri de Urbe», Leonardo de Jacobinis, e Giovanni Donadei «dicto de Sancto Michaele», chierico della medesima, procedettero alla vendita del terreno, di cui nel docu-mento vengono accuratamente descritti l’estensione e i confini. Con il secondo, redatto stavolta a Roma in una camera spettante alla stessa chiesa di S. Michele, il 17 gennaio dell’anno successivo, gli altri componenti il collegio di chierici al servi-zio della chiesa prestarono il loro assenso all’avvenuta vendita. Di questi ultimi il documento in questione ci dà i nomi: si tratta dei presbyteri Giovanni, figlio del fu Giacomo de Orphanis, e Giovanni, figlio di Bartolomeo Iohannis Belli.
Questi documenti sono per noi di grande interesse, non solo in quanto ci dan-
Mirko Stocchi
26
62. Una ipotetica ricostruzione del complesso di edifici e terreni in proprietà della chiesa al 1286 è stata tentata, sulla base di quanto riportato nel nostro documento, da de Blauuw 1992-1993, pp. 164-167 e fig. 12.
63. I dati desumibili dai due instrumenta concordano grosso modo con quanto sulla chiesa di S. Michele ci viene riferito dal catalogo delle chiese di Roma noto come “Catalogo di Torino”: «Ecclesia Sancti Michaëlis, quae est capella papalis, habet .iii. clericos» (cfr. CTR, III, p. 298). Si tratta, come noto, del celebre catalogo delle chiese di Roma, compilato da, o su istanza dell’associazione medioevale del clero romano nota come Romana fraternitas e oggi contenuto all’interno di un codice manoscritto della Biblioteca Nazionale di Torino. Il catalogo torinese riveste particolare rilevanza poiché, oltre a fornire i nomi dei luoghi di culto, fornisce dati statistici sul clero addetto alle singole chiese, ragion per cui è stato giustamente definito «la prima fonte demografica per il clero di Roma» (carpegna falconieri 2002, pp. 286-287). Sul Catalogo di Torino vd. anche falco 1909; hülsen 1927, pp. VIII-X.
64. Questa la conclusione cui giunse Blok ragionando del testo dell’epigrafe su riportata (cfr. § 4): «L’iscrizione sopra citata può provare in ogni caso che la colonia era ancora nella più grande prosperità almeno nel secolo XIII» (Blok 1909, p. 49). In ciò fu seguito da Bosi – BeccheTTi 1973 (p. 29) e da Muskens 1993 (p. 108). Più cauto de Blaauw, il quale conviene che: «After the regulation of the burial of pilgrims or emigrees from Frisia in the papal bull from 1053, there are no direct testimonies of the church being in use by Frisians»; ma, indotto anch’egli dal testo dell’epigrafe, non si esime dall’aggiungere che: «there were still Frisians at about 1300 who considered this church and its buildings as their Roman home» (de Blaauw 1992-1993, p. 162). Noi riteniamo che la diversa interpretazione, che qui è stata proposta, della genesi e delle finalità dell’epigrafe in questione, oltre alle osservazioni poco fa riferite circa il contenuto dei documenti concernenti la vendita del 1286-87, possano concorrere a far tramontare definitivamente un’ipotesi – quella della sussistenza e vitalità della schola dei Frisoni ancora nel tardo medioevo – a favore della quale non si possiede, in realtà, alcuna testimonianza certa. Non inganni in ciò quanto asserito da Blok, vale a dire che Eugenio IV, in una bolla del 1446, avrebbe ceduto la chiesa all’arcivescovo di Ravenna, Bartolomeo Roverella, imponendo perpetuum silentium «agli eredi della colonia frisone» (Blok 1909, p. 50): ripreso alla lettera, il testo della bolla del 1446 recita semplicemente: «cuicumque, qui dictam ecclesiam S. Michaelis ad se spectare assereret, perpetuum silentium imponentes» (BV, II, p. 108).
65. Cfr. MonTel 1988-1989, pp. 380 e 438; HC, I, p. 346.
no un’idea di quale fosse allora almeno una parte del patrimonio immobiliare di cui S. Michele disponeva62, ma anche perché ci forniscono un’immagine di rara ac-curatezza di quello che era, verso la fine del Duecento, il clero officiante la chiesa: si tratta in tutto, come si è visto, di quattro membri63, di nessuno dei quali, sulla base di considerazioni puramente onomastiche, è giustificato supporre un’origine straniera, più in particolare frisone. Questa considerazione ci sembra rivestire qui particolare importanza, giacché concorrerebbe a smentire un assunto per lungo tempo ripetuto: ovverosia che i Frisoni continuassero a godere o a rivendicare diritti sulla chiesa e sulle sue proprietà ancora alle soglie del XIV secolo64.
Merita invece di essere attentamente valutato, a nostro giudizio, il fatto che – sebbene nei documenti appena citati non si dica espressamente – le diverse tappe della compravendita suddetta sembrano essere avvenute sotto la supervisione del Capitolo di S. Pietro. Tra i testimoni al primo atto ritroviamo infatti, oltre all’in-caricato papale Pietro Saraceni, allora vescovo di Monopoli ma probabilmente già canonico vaticano65, un Archio «canonicus Basilicae Principis apostolorum de
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
27
66. Cfr. MonTel 1988-1989, p. 385.67. Cfr. MonTel 1988-1989, pp. 385 e 389. Non è da escludersi, tuttavia, che questo personaggio –
come già sospettò Montel – possa identificarsi con il precedente dominus Archio.68. Cfr. sTocchi 2010, p. 87 (Tabella 1), s.v. S. Michaelis.69. Regesto: Potth., 46. Edizione: BV, I, pp. 77-79. Edizione da registro: Reg. Inn. III, I, pp. 417-
419, n. 296.70. Così de Blaauw 1992-1993, p. 159 (con riferimento al nostro documento): «S. Maria of the
Anglosaxons and S. Michele of the Frisians maintained a more independent position. Contrary to the old national sisters which had lost their complete ius parochiale, they had only to concede some specific pastoral and formal rights to the Vatican Chapter. The clerics of both S. Maria and S. Michele were not appointed by the Chapter, but by the pope».
71. Questa la nostra interpretazione in sTocchi 2010, p. 10, nt. 27.72. Conferma delle disposizioni innocenziane in favore dei canonici di S. Pietro diedero Gregorio
IX nel 1228 (cfr. BV, I, pp. 111-116) e Innocenzo VI nel 1360 (cfr. BV, I, pp. 361-366).
Urbe»66; mentre, al secondo atto, oltre al già citato Pietro Saraceni, prese parte Diomedes (de Archionibus), canonico anch’egli della stessa basilica67.
6. Altre fonti fino al 1350
Nei documenti indirizzati dai pontefici successori di Leone IX ai canonici e alla basilica di S. Pietro in Vaticano, S. Michele fa la sua ricomparsa solo nel 119868. Il 13 marzo di quell’anno, infatti, Innocenzo III, da poco eletto al soglio pontificio, ribadì la soggezione ai canonici vaticani delle chiese di S. Michele, di S. Maria in Saxia e di S. Maria in Traspontina «in scrutinio, baptismo, processio-nibus et chrismatis confectione». Quanto ai chierici che le servivano, tuttavia, il papa preferì avocare a sé e ai suoi successori pieni poteri di nomina, destituzione e correzione69.
Questa limitazione dei poteri dei canonici di S. Pietro sulla nostra chiesa da parte di Innocenzo III è stata talvolta interpretata come il riconoscimento dato dal papa al mantenimento di una maggiore indipendenza di S. Michele rispetto a quanto era allora consentito ad altri enti ecclesiastici, ugualmente rientranti nella sfera d’influenza della basilica vaticana70. Tuttavia, la riserva di Innocenzo III, da poco eletto al soglio pontificio, potrebbe essere suscettibile di una diversa interpretazione: ovverosia, con il desiderio del pontefice neoeletto di disporre liberamente di un certo numero di prebende, al fine di beneficiare gli uomini della curia che veniva via via costituendo attorno a sé71.
Alcuni anni dopo il documento appena esaminato, il 15 ottobre 1205, lo stesso Innocenzo III emanò un altro importante privilegio, che avrebbe costituito il modello fedelmente seguito da tutte le successive conferme pontificie di beni e di diritti dei canonici vaticani per oltre un secolo e mezzo72. In esso il pontefice, facendo esplicito riferimento al precedente costituito dal suo documento del 1198, ribadì e confermò i termini della soggezione ai canonici di S. Pietro delle chiese di
Mirko Stocchi
28
73. BV, I, p. 84. Sull’importanza delle disposizioni emanate da Innocenzo III per l’organizzazione ecclesiastica del territorio adiacente a S. Pietro vd. sTocchi 2010, pp. 9-11.
74. Cfr. supra, nt. 63 e CTR, III, p. 297 (ecclesia Sanctae Mariae in Traspadina). La mancata assegnazione del titolo di «cappella papalis» a S. Maria in Sassia da parte del Catalogo di Torino si spiega facilmente, a nostro avviso, con il fatto che lo stesso Innocenzo III, già nel 1202, aveva donato la chiesa con l’annesso hospitalis Anglorum a Guido di Montpellier e ai suoi confratelli dell’Ordine di Santo Spirito. Cfr. DrossBach 1998, p. 1330.
75. sTocchi 2010, p. 10, nt. 27.76. Se ne veda ora l’edizione in sTocchi 2010, pp. 19-75.
S. Michele, di S. Maria in Sassia e di S. Maria in Traspontina: «Ab ecclesiis Sancti Michaelis, Sanctae Mariae in Saxia et Sanctae Mariae in Transpadina subiectio-nem et reverentiam in scrutinio, baptismo, processionibus et chrismatis confec-tione, sicut nos eis per aliud privilegium duximus concedendum»73.
Dal testo del documento del 1205 è tuttavia scomparso, come si vede, qualsiasi riferimento alla limitazione della giurisdizione dei canonici sul clero delle chie-se or ora menzionate, stabilita dal papa appena sette anni prima. Malgrado ciò, conferma del fatto che la riserva operata nel 1198 da Innocenzo III continuasse a mantenere ancora per un lungo periodo la sua validità, almeno in relazione a S. Michele e a S. Maria in Traspontina, ci pare giungere dal Catalogo di Torino (ca. 1313), in cui a entrambe queste chiese si attribuisce l’appellativo di «capella papalis»74. Come abbiamo proposto altrove, infatti, questo epiteto – la cui cor-retta interpretazione rimane però controversa – potrebbe stare a indicare «una chiesa non del tutto autonoma sotto il profilo dello ius parrochiale – da cui l’uso del termine capella – ma di esclusiva spettanza del pontefice quanto alla investitura e giurisdizione del clero che l’officiava»75.
A differenza delle fonti sin qui esaminate, le ultime che vogliamo fare oggetto della nostra indagine nacquero con intenti prevalentemente “amministrativi”; in altre parole, esse furono redatte dagli stessi canonici di S. Pietro con finalità di gestione o di revisione del loro patrimonio. Si tratta di tre cataloghi-censuali di “ecclesiae subiectae” compilati tra la metà del XIII e la metà del XIV secolo e rimasti – a dispetto della loro indubitabile rilevanza, non solo per la storia del Capitolo vaticano – fino a poco tempo fa inediti76.
Il primo in ordine di tempo non menziona, stranamente, la chiesa di S. Michele tra quelle soggette ai canonici di S. Pietro. Ciò sembrerebbe contraddire quanto abbiamo creduto di poter dedurre dalle fonti fin qui considerate, vale a dire che la ex chiesa dei Frisoni rientrasse certamente a quella data (metà circa del XIII secolo) nell’orbita giurisdizionale della basilica vaticana. Tale assenza, in realtà, po-trebbe essere giustificata dal fatto che questo catalogo sembra rispecchiare una si-tuazione istituzionale antecedente alla data della sua redazione, ovverosia una fase nella quale il Capitolo petrino non aveva ancora assorbito in sé tutte le pertinenze
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
29
77. Resta aperta tuttavia la possibilità di dare una diversa soluzione al problema posto dal numero troppo esiguo delle dipendenze urbane del Capitolo menzionate in questo catalogo: che, cioè, l’estensore del documento in esame intendesse limitarsi nel proprio elenco a enumerare quelle ecclesiae e quegli hospitalia, sui quali i canonici vaticani potevano esercitare al tempo la piena giurisdizione, ovverosia agli enti soggetti pleno iure al Capitolo. La frase premessa a questo primo catalogo, che recita «in hac pagina continentur omnes ecclesie et hospitalia, que ad nostre canonice ius spectant» (cfr. sTocchi 2010, p. 27), sarebbe allora da intendersi in senso restrittivo, cioè sottintendendo plenum (ius) e lasciando con ciò aperta la possibilità dell’esistenza coeva di altri enti, non nominati in esso ma sui quali il Capitolo poteva vantare una qualche forma di giurisdizione, seppure limitata. Questo concorrerebbe a spiegare non da ultimo l’assenza in questo primo catalogo anche delle altre due cappellae fatte oggetto della riserva papale da Innocenzo III, S. Maria in Sassia e S. Maria in Traspadina, sulle quali già nel 1198 era stata inficiata la piena giurisdizione dei capitolari.
78. Si veda soprattutto la voce relativa a S. Salvatore de Terrione, particolarmente interessante non solo per la menzione che vi si fa dei diritti «in sepulturam omnium ultramontanorum» – di cui dunque ancora a quel tempo godeva la chiesa – ma anche per la dettagliata descrizione della liturgia che vi si svolgeva il 9 novembre (in festo Salvatoris), a cui prendevano parte anche i canonici di S. Pietro (cfr. sTocchi 2010, p. 42, nr. 3 e pp. 58-59, nr. 2).
79. sTocchi 2010, p. 44 (documento 2), nr. 22; cfr. anche p. 63 (documento 3), nr. 23.
e le prerogative un tempo spettanti singolarmente ai quattro monasteri vaticani. In altre parole, come abbiamo sostenuto altrove, esso pare dipendere almeno nella sua parte iniziale – quella, per l’appunto, in cui vengono elencate le chiese soggette «in urbe Roma» – da un documento che non tiene conto dei cambiamenti istituzio-nali venutisi a creare nei borghi attorno a S. Pietro e nella Città Leonina a seguito delle anzidette disposizioni di Innocenzo III del 1198 e del 120577.
A conferma di ciò starebbe il fatto che la chiesa dei Frisoni è invece men-zionata in entrambi i successivi cataloghi, che abbiamo ritenuto di poter datare rispettivamente all’incirca al 1287 e al 1350. Sfortunatamente, però, mentre sulle altre antiche cappelle nazionali delle scholae peregrinorum questi documenti ci of-frono ragguagli ampi e talvolta ricchi d’interesse78, per quanto riguarda S. Michele le notizie che se ne traggono sono assai scarse. In entrambi, infatti, la citazione della nostra chiesa si riduce più o meno a queste poche parole: «Ecclesia Sancti Michaelis tenetur ad scrutinium, crismatis confettionem et processiones. Tenetur etiam exhibere subiettionem et reverentiam»79.
Niente più, come si vede, di quanto già sapevamo sulla base delle precedenti disposizioni contenute nel ricordato documento di Innocenzo III del 1205 che, molto probabilmente, costituì la fonte da cui gli stessi anonimi redattori dei nostri due ultimi cataloghi attinsero le loro informazioni al riguardo.
Ancora una volta, però, non possiamo esimerci dal costatare l’assenza, anche in queste fonti, di qualsiasi elemento a favore della presunta sopravvivenza della comunità dei Frisoni o di indizi che possano far anche solo supporre il persistere di una qualche forma di patronato sulla chiesa esercitato da altri che non fossero il papa o i canonici di S. Pietro.
Mirko Stocchi
30
80. L’epigrafe non sarebbe, in altre parole, una prova dell’esistenza di una colonia di Frisoni ancora attiva a Roma alle soglie del XIV secolo, la quale – riprendendo un’espressione colorita ed efficace di Muskens – avrebbe gridato in coro: «giù le mani dalla schola dei Frisoni!» (Muskens 1993, p. 108).
* * *
In sintesi: se attualmente, come nel passato, è possibile ricostruire una parte, sebbene minima, della primitiva storia della chiesa di S. Michele dei Frisoni (oggi Ss. Michele e Magno), lo dobbiamo, come si è visto, alle testimonianze custodite nell’archivio del Capitolo di S. Pietro in Vaticano e all’impegno profuso dai suoi canonici, nel corso di tanti secoli, per la preservazione delle proprie memorie sto-riche. Di altri documenti medioevali concernenti la chiesa e il clero posto al suo servizio, dei quali si può solo congetturare l’esistenza, già nei primi decenni del secolo XVI poco o nulla più si conservava.
La testimonianza più antica in nostro possesso riguardo all’esistenza della chiesa di S. Michele è un privilegio di Leone IV dell’anno 854. Esso sembra mo-strarci la chiesa dell’antica schola peregrinorum già entrata in una fase di precoce decadenza: privata dal papa della sua autonomia, viene da questi assoggettata al monastero di S. Martino in Vaticano.
Un vuoto di circa duecento anni separa quest’atto di Leone IV dalla successiva fonte da noi analizzata, il privilegio indirizzato da Leone IX nel 1053 “ai canonici di S. Pietro” dimoranti nel monastero di S. Martino. Sebbene vi si trovi attestata la presenza a Roma, ancora a quella data, dei Frisoni e della loro schola, dalla lettura di questo documento – della cui genuinità, tuttavia, si dovrà tornare a discutere – si ricava la sensazione di una ulteriore erosione dei diritti di quella comunità nazionale: lo stesso diritto-dovere dei Frisoni di dare sepoltura ai propri connazio-nali, che sembra essere stato tra i principali motori alla nascita stessa delle scholae peregrinorum, ha subito restrizioni a vantaggio della concorrente schola dei Franchi e della loro cappella intitolata al Salvatore.
Questo documento resta in ogni modo l’ultimo in ordine cronologico da cui si possa trarre testimonianza dell’esistenza di una comunità di Frisoni a Roma, la cui permanenza e vitalità anche in epoche successive è stata talvolta ipotizzata sulla base di un’iscrizione (datata alla fine del XIII o agli inizi del XIV secolo), nella quale si è voluto vedere l’estremo tentativo posto in atto dai Frisoni per difendere i propri diritti sulla loro schola80.
In realtà, diverse considerazioni ci hanno portato a ipotizzare una diversa committenza dell’epigrafe dei Ss. Michele e Magno: quella dei canonici di S. Pie-tro, interessati a che fossero note a tutti le origini edificanti e le prerogative di quell’antico tempio, posto dai papi alle loro dipendenze.
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
31
Abbreviazioni e bibliografia
ACSP = BAV, Archivio del Capitolo di S. Pietro.ASRSP = Archivio della Società Romana di Storia Patria.BAV = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana.Bianchi 1999 = L. Bianchi, Ad limina Petri. Spazio e memoria della Roma cristiana,
Roma 1999.de Blaauw 1992-1993 = S. de Blaauw, The medieval church of S. Michele dei Frisoni in
Rome, in MNIRA, 51-52 (1992-1993), pp. 151-221.Blok 1906 = P.J. Blok, Le antiche memorie dei Frisoni a Roma, in “Bullettino della
Commissione Archeologica Comunale di Roma”, 34 (1906), pp. 40-60.Bosi – BeccheTTi 1973 = M. Bosi – P. BeccheTTi, Ss. Michele e Magno, Roma 1973
(Le chiese di Roma illustrate, 126).Bosi – BeccheTTi 1975 = M. Bosi – P. BeccheTTi, Nuove ricerche sulla chiesa dei Ss.
Michele e Magno dei Frisoni, in “Studi Romani”, 23 (1975), pp. 56-61.Bresslau 1998 = H. Bresslau, Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia, trad.
it. a cura di A.M. Voci-Roth, Roma 1998 (Pubblicazione degli Archivi di Stato. Sussidi, 10); ed. or. Leipzig 1912-1931.
BV = Bullarium Vaticanum. Collectio bullarum, brevium aliorumque diplomatum Sacro-sanctae Basilicae Vaticanae, 3 voll., Romae 1747-1752.
caMMarosano 1991 = P. caMMarosano, Italia medievale: struttura e geografia delle fonti scritte, Roma 1991.
carBoneTTi 1979 = C. carBoneTTi, Tabellioni e scriniari a Roma tra IX e XI secolo, in ASRSP, 102 (1979), pp. 77-155.
carBoneTTi VenDiTTelli 2009 = C. carBoneTTi VenDiTTelli, «Sicut inveni in thomo carticineo iam ex magna parte vetustate consumpto exemplavi et scripsi atque a tenebris ad lucem perduxi». Condizioni materiali e trasmissione documentaria a Roma nell’alto medioevo, in oô pËn Ëzòmeron. Scritti in memoria di Roberto Pretagonisti offerti da Colleghi, Dottori e Dottarandi di ricerca della Facoltà di Lettere e Filosofia, a cura di C. BraiDoTTi, E. DeTTori, E. lanzilloTTa, I, Roma 2009, pp. 47-69.
carpegna falconieri 2002 = T. di carpegna falconieri, Il clero di Roma nel me-dioevo: istituzioni e politica cittadina (secoli VIII-XIII), Roma 2002.
carucci 1984 = A. carucci, Nel IX centenario del Sacco di Roma del 1084: Enrico IV, Gregorio VII e Roberto il Guiscardo, in “Rivista cistercense”, 1 (1984), pp. 269-274.
cassanelli 1976 = L. cassanelli, Gli insediamenti nordici in Borgo: le Scholae Peregri-norum e la presenza dei Carolingi a Roma, in Roma e l’età carolingia, Atti delle gior-nate di studio a cura dell’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Roma (3-8 maggio 1976), Roma 1976, pp. 217-222.
CBCR = R. krauTheiMer, W. frankl, S. corBeTT, Corpus Basilicarum Christiana-rum Romae, Città del Vaticano-New York 1937-1977.
Mirko Stocchi
32
CTR = Codice topografico della città di Roma, a cura di R. ValenTini – G. zuccheTTi, 4 voll., Roma 1940-1953 (Fonti per la storia d’Italia, 81-88-90-91).
De waal 1897 = A. De waal, La schola Francorum fondata da Carlo Magno e l’ospizio teutonico del Campo Santo nel secolo XV. Indagini storiche e topografiche, Roma 1897.
DrossBach 1998 = G. DrossBach, Innocenzo 3 nell’autocomprensione storica dell’ordine ospitaliero di Santo Spirito in Sassia, in Innocenzo 3. Urbis et Orbis, Atti del Congres-so internazionale, Roma, 9-15 settembre 1998, Roma 2003 (Nuovi studi storici, 55-56), pp. 1327-1345.
Duchesne 1914 = L. Duchesne, Notes sur la topographie de Rome au Moyen-âge. XII. Vaticana, in “Mélanges d’Archéologie et d’Histoire”, 34 (1914), pp. 307-356; oggi anche in iD., Scripta minora. études de topographie romaine et de géographie ecclésia-stique, Rome 1973 (Collection de l’école française de Rome, 13), pp. 253-302.
DucroT 1963 = A. DucroT, Histoire de la Cappella Giulia au XVIe siècle depuis sa fon-dation par Jules II (1513) jusqu’à sa restauration par Grégoire XIII (1578), in “Mélan-ges d’Archéologie et d’Histoire”, 75 (1963), pp. 179-240 e 467-539.
ehrle 1924 = F. ehrle, L’Oratorio di S. Pietro sul sito dell’antica “Scuola dei Franchi”, in L’Oratorio di S. Pietro, Roma 1924, pp. 25-43.
esposiTo 2001 = A. esposiTo, Pellegrini, stranieri, curiali ed ebrei, in Roma medievale, a cura di A. Vauchez, Roma-Bari, 2001, pp. 213-239.
falco 1909 = G. falco, Il catalogo di Torino delle chiese, degli ospedali, dei monasteri di Roma nel secolo XIV, in ASRSP, 32 (1909), pp. 411-
ferrari 1957 = G. ferrari, Early Roman Monasteries. Notes for the History of the Mona-steries and Convents at Rome from V through the X Century, Città del Vaticano 1957 (Pontificio Istituto di archeologia cristiana. Studi di antichità cristiane, 23).
ferrua 1966 = A. ferrua, Due iscrizioni medievali datate, in ASRSP, 89 (1966), pp. 37-45.
GReGoRoviuS 1900-1901 = F. gregoroVius, Storia della città di Roma nel Medio Evo, 4 voll., Roma 1900-1901.
griMalDi 1972 = G. griMalDi, Descrizione della basilica antica di S. Pietro in Vaticano. Codice barberini latino 2733, a cura di R. Niggl, Città del Vaticano 1972 (Codices e vaticanis selecti, XXXII).
HC = Hierarchia catholica medii et recentioris aevi sive Summorum Pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, München 1913-1978.
herBers 1996 = K. herBers, Leo IV. und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhnderts (Päpste und Papsttum, 27) Stuttgart 1996.
heres 1992-1993 = T.L. heres, The burial vaults beneath SS. Michele e Magno in Rome, in MNIRA, 51-52 (1992-1993), pp. 122-134.
hülsen 1927 = C. hülsen, Le chiese di Roma nel Medioevo, Firenze 1927.Inventario ACSP = Archivio del Capitolo di S. Pietro. Inventario a cura di Pio Pecchiai,
voll. 1-4 (BAV, Sala cons. mss., 407-410).IP = Italia Pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis Pontificibus
San Michele dei Frisoni nelle fonti medioevali dell’archivio capitolare
33
ante annum MCLXXXXVIII Italiae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque per-sonis concessorum, ed. P.F. kehr, 9 voll., Berlin 1906-1962; vol.10, Zürich 1975.
IS = Index omnium scripturarum archivii sacrosanctae basilicae Principis Apostolorum, etc. A.D. mdxcviiii (ACSP, K 1; olim BAV, Sala consultazione manoscritti, n. 401 rosso).
J = Regesta pontificum romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII, ed. P. Jaffé, Berolini 1851.
JL = Regesta pontificum romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII, ed. P.ewalD – F. kalTenBrunner – S. löwenfelD, 2 voll., Leipzig 1885-88.
JohrenDT 2009 = J. JohrenDT, Die Anfänge des Kapitels von St. Peter im Vatikan ? Zu den Urkunden Leos IX. für die Basilikalklöster der Peterskirche (1053), in “Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 65 (2009), pp. 83-110.
van kessel 1981 = P. van kessel, Frisoni e Franchi a Roma nell’età carolingia, in Les Fon-datións Nationales dans la Rome Pontificale, Actes du colloque, Rome, 16-19 mai 1978, Roma 1981 (Collection de l’Ecole française de Rome, 52), pp. 37-46.
lenzi 1999 = M. lenzi, Forme e funzioni dei trasferimenti patrimoniali dei beni della Chiesa in area romana, in “Mélanges de l’école française de Rome. Moyen âge-Temps Modernes”, 111/2 (1999), pp. 771-859.
LP = Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire, ed. L. Duchesne, 3 voll., Paris 1981 (Bibliothèque des écoles françaises d’Athenes et de Rome).
Marazzi 1998 = F. Marazzi, I «Patrimonia Sanctae Romanae Ecclesiae» nel Lazio (se-coli IV-X). Struttura amministrativa e prassi gestionali, Roma 1998 (Nuovi studi storici, 37).
Marini 1805 = G. Marini, I Papiri diplomatici, Roma 1805.MNIRA = Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome. Antiquity.Moore 1937 = W.J. Moore, The Saxon Pilgrims to Rome and the Schola Saxonum, Fri-
burg 1937.MoorMann 1992-1993 = E.M. MoorMann, Disiecta membra in the church of Ss. Mi-
chele e Magno in Rome, in MNIRA, 51-52 (1992-1993), pp. 135-150.Monasticon Roma-Lazio = Monasticon Italiae. Repertorio topo-bibliografico dei monasteri
italiani, I, Roma e Lazio, a cura di V. caraffa, Cesena 1981.MonTel 1988-1989 = R. MonTel, Les chanoines de la basilique Saint-Pierre de Rome des
statuts capitulaires de 1277-1279 à la fin de la papauté d ’Avignon. étude prosopographi-que, in “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, 42 (1988), pp. 365-450 (parte I); 43 (1989), pp. 1-49 (parte II), pp. 413-479 (parte III).
Muskens 1993 = M. Muskens, Ss. Michele e Magno dei Frisoni, Roma 1993.Paleografia latina = Paleografia latina: tavole, a cura di P. cheruBini − A. praTesi,
Città del Vaticano 2004 (Littera Antiqua, 10).pani erMini 2001 = L. pani erMini, Forma Urbis: lo spazio urbano tra VI e IX seco-
lo, in Roma nell’alto medioevo, Spoleto, 27 aprile - 1 maggio 2000, Spoleto 2001
Mirko Stocchi
34
(Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 48), pp. 256-324.
passigli 1993 = s. passigli, Geografia parrocchiale e circoscrizioni territoriali nei secoli XII-XIV: istituzioni e realtà quotidiana, in Rome aux XIIIe et XIVe siècle. Cinq études réunies par étienne Hubert, Roma 1993 (Collection de l’école française de Roma, 170), pp. 43-86.
passigli 1998 = s. passigli, Il territorio delle parrocchie romane durante i secoli XIV, XV e XVI, in Popolazione e società a Roma dal medioevo all’età contemporanea, a cura di E. sonnino, Roma 1998, pp. 63-91.
perrayMonD 1979 = M. perrayMonD, Le ‘Scholae Peregrinorum’ nel Borgo di San Pie-tro, in “Romano Barbarica”, 4 (1979), pp. 183-201.
Potth. = A. poTThasT, Regesta pontificum romanorum inde ab anno post Christum natum MCXCVIII ad annum MCCCIV, 2 voll., Berolini, 1875.
raDicioTTi 2009 = P. raDicioTTi, Copie da papiro nel medioevo romano (con un docu-mento di S. Maria in Trastevere), in “Scripta”, 2 (2009), pp. 159-168.
reekMans 1970 = I.A. reekMans, Le developpement topographique de la regione du Va-tican à la fin de l’antiquité et au débout du Moyen-Age (300-850), in Mélange d ’archéolo-gie et d ’histoire de l’art offerts au prof. Jacques Lavalleye, Louvain 1970, pp. 197-235.
Reg. Inn. III = Die Register Innocenz’III., ed. O. hageneDer et alii, Graz 1964-rezza – sTocchi 2008 = D. rezza – M. sTocchi, Il Capitolo di San Pietro in Vaticano
dalle origini al XX secolo, I, Città del Vaticano 2008 (Archivum Sancti Petri, I.1).RI = J.F. BöhMer, Regesta Imperii, I/1, Innsbruck 1908 (Hildesheim 1966)-sanTifaller 1953 = L. sanTifaller, Beiträge zur Geschichte der Beschreibstoffe im Mit-
telalter, mit besonderer Berücksichtigung der päpstlichen Kanzlei, 1 teil: Untersuchun-gen, Graz-Köln 1953.
schiaparelli = L. schiaparelli, Le carte antiche dell’archivio capitolare di S. Pietro, in ASRSP, 24 (1901), pp. 393-496; 25 (1902), pp. 273-354.
schieffer 1998 = R. schieffer, Karl der Grosse, die “Schola Francorum” und die Kir-chen der Fremden in Rom, in “Römische Quartalschrift für christliche Altertum-skunde und für Kirchengeschichte”, 93 (1998), 1-2, pp. 20-37.
sesTan 1952 = E. sesTan, Stato e nazione nell’alto Medioevo: ricerche sulle origini nazio-nali in Francia, Italia, Germania, Napoli 1952; rist. an. Napoli 1994.
sTeffens 1910= F. sTeffens, Paléographie latine, Paris 1910.sTocchi 2010 = M. sTocchi, Il Capitolo Vaticano e le “ecclesiae subiectae” nel Medioevo. I
cataloghi dei secoli XIII-XIV, Città del Vaticano 2010 (Quaderno d’archivio, 1).Torrigio 1629 = F.M. Torrigio, Narratione dell’origine dell’antichissima chiesa di San-
ti Michel’Arcangelo e Magno Vescovo e Martire, Roma 1629.Torrigio 1639 = F.M. Torrigio, Le Sacre Grotte vaticane, Roma 1639.VenDiTTelli 2006 = M. VenDiTTelli, Malabranca, Latino, in Dizionario Biografico
degli Italiani, 67 (2006), pp. 699-703.wickhaM 2008 = C. wickhaM, Iuris cui existens, in ASRSP, 131 (2008), pp. 5-38.