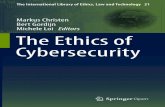Documenti per la città di Aversa, Michele Guerra, a cura di Giacinto Libertini
L'indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of L'indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza...
63
3.1 iL monAstero neL suo ComPLesso:LA PeriodizzAzione (s.g., A.A)
I resti del monastero di San Michele alla Verruca sor-gono a quota 440 m s.l.m., sulla cima del Monte Grande, su un breve pianoro che si estende poco più a est del Monte Verruca, sul quale sono ancora ben visibili i ru-deri dell’omonima fortezza (figg. 1-2).
Il sito dell’abbazia è stato oggetto di un’indagine ar-cheologica per otto anni, dal 1996 al 2003. L’interven-to si è inserito in un più ampio progetto di ricerca che ha compreso lo studio delle evidenze architettoniche superstiti e una ricognizione a campione sul territorio del Monte Pisano, volta soprattutto allo studio delle nu-merose fondazioni monastiche presenti all’incirca nello stesso periodo del San Michele1.
Lo scavo archeologico ha interessato l’intero comples-so monastico, anche se, ovviamente, non tutta l’area oc-cupata dal monastero è stata scavata. Tuttavia in molti punti, come la chiesa (abside esclusa), il sagrato, i ma-gazzini del lato ovest, il cortile, la sala capitolare e il corridoio est, è stato raggiunto l’affioramento roccioso naturale. Per motivi di carattere statico non è stato pos-sibile indagare la zona presbiteriale della chiesa (dove si sono dovute installare delle impalcature per mettere in sicurezza l’edificio); per gli stessi motivi di natura sta-tica si è ritenuto non opportuno neppure iniziare l’in-dagine di un ambiente (forse la sagrestia) ubicato tra il transetto sud della chiesa e la sala capitolare. Si è deciso, invece, di non aprire sondaggi o di non esplorare com-pletamente i corridoi nord, sud ed ovest e tutte quante le strutture ubicate a sud del cortile. Questo per motivi diversi. Il corridoio nord in quanto interessato da ingen-ti crolli della vicina chiesa abbaziale; i corridoi sud ed ovest perché caratterizzati dalla presenza di numerose
sepolture che, ad una pulizia superficiale, apparivano della stessa natura e distribuite con la stessa densità di quelle indagate nel corridoio est2; l’area ubicata a sud, dove riteniamo dovessero trovarsi il refettorio e forse le cucine, perché fortemente compromesso da episodi di collassamento del terreno che di fatto ne condizionava-no l’esplorazione (fig. 3).
L’intercettamento, in diversi punti, del recinto che doveva chiudere l’area monastica (conservato spesso ad un livello di poco superiore alla spiccata di fonda-zione), permetteva di avere un’idea abbastanza precisa dell’estensione degli spazi al di fuori della chiesa e delle strutture che si aprivano su chiostro. Mentre il lato set-tentrionale, a causa della strada carraia tuttora in uso, non risultava indagabile, lo spazio orientale (peraltro in parte occupato dal conoide di crollo del campanile) è stato ispezionato attraverso piccoli saggi (Area 5000), che tuttavia non hanno restituito elementi sufficienti per ricomporre un quadro preciso delle funzioni svolte da questa zona (solo induttivamente congetturabili).
La documentazione archeologica, insieme alle infor-mazioni ricavate dalle fonti scritte, ha permesso di pre-cisare sei periodi distinti di frequentazione; i primi cin-que compresi tra la fine dell’VIII e la fine del XV secolo e l’ultimo, relativo ad un uso sporadico del sito, databile tra il XVI/XVII e il XIX secolo, quando crollano definiti-vamente anche le strutture della chiesa abbaziale.
La sequenza che proponiamo si discosta, in alcuni punti leggermente, in altri in forma più accentuata, da quelle in precedenza pubblicate3. Ciò è comprensibile ed è dovuto non solo al completamento dell’indagine, ma anche ad una revisione generale ed approfondita della documentazione materiale, che ha consentito di rivede-re alcune proposte interpretative o di meglio precisar-le. Inoltre, rispetto a quanto pubblicato, si è preferito in
3. l’indagine archeologica del monastero di san michele alla Verruca: la Periodizzazione della sequenza insediatiVa
Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
64 65
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
1. Localizzazione del Monte Pisano.
2. Localizzazione del monastero di S. Michele alla Verruca sul Monte Pisano e distribuzione degli altri monasteri attivi nello stesso periodo.
66 67
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
questa circostanza utilizzare una numerazione progres-siva coerente con l’andamento temporale della sequen-za del sito (dal più antico al più recente). Anche se si tratta di una convenzione, l’abbiamo fatto per facilitare una immediata percezione delle relazioni cronologiche dei singoli Periodi (o Fasi) ed è giustificata dal fatto che in molti punti dell’insediamento lo scavo ha raggiunto l’affioramento roccioso naturale, consentendo quindi di ricostruire una sequenza cronologica relativa completa.
Periodizzazione:I: pre-monastero (fine VIII - fine del X secolo)II : monastero benedettino pre-romanico (fine X - pri-
mi del XII secolo)III: monastero benedettino romanico (primi del XII
secolo - 1260)
IV: monastero cistercense (1260-prima metà del XV secolo)
IVa: acquisizione e riorganizzazione (1260-XIV)IVb: ultima fase presenza dei monaci (fine XIV-prima
metà XV)V: assedio pisano-fiorentino (1496-1498)VI: frequentazione sporadica (XVI - XIX secolo)
3.1.1 PERIODO I (L’occupazione del sito prima del monastero benedettino)
Una chiesa di “S. Angeli in locho Verruchula” è atte-stata per la prima volta il 30 giugno 861 tra le proprietà di un certo Eriprando, il quale aveva ricevuto il patrona-to della chiesa da un suo avo, un certo Ferualdo, ricor-dato vivo nell’800 e presente in un placito lucchese del
3. Pianta generale del sito con le aree scavate e gli ambienti individuati.
785 (vedi Giuliani infra). Con un certo grado di certezza si può quindi asserire che una chiesa dedicata a S. Mi-chele e situata nel luogo detto Verruca esistesse almeno a partire dallo scorcio del secolo VIII. E’ inoltre probabi-le che tale edificio si trovasse nella stessa area dove, due secoli più tardi, verrà fondato il monastero.
L’indagine archeologica condotta nel monastero di S. Michele non ha portato alla luce evidenze certe relative alla frequentazione del sito tra VIII e X secolo, cioè prima della costruzione del monastero pre-romanico. La mor-fologia dell’area e le tecniche costruttive adoperate nel cantiere romanico e nei successivi interventi cistercensi, relativi ad opere di riorganizzazione delle strutture del cenobio, possono essere state la causa principale della perdita delle tracce di questo primo periodo di frequen-tazione. La superficialità dell’affioramento roccioso na-turale e l’uso dello stesso come base di appoggio per la fondazione degli edifici del monastero ha portato come conseguenza ad una conservazione del deposito archeo-logico parziale: la stratigrafia è stata più volte oggetto di asportazioni e di interventi in profondità, corrisponden-ti alle fasi di costruzione o di ripristino dei piani interni agli edifici dell’abbazia.
Le tracce di frequentazione relative al Periodo I sono state individuate, con un grado di certezza maggiore, all’interno della chiesa abbaziale e nell’Area 2000 (am-biente 4).
Si tratta in realtà di tracce in negativo individuate sul-la superficie della roccia naturale che risulta essere stata regolarizzata e rimodellata per creare piani e sentieri.
All’interno della chiesa, nella zona corrispondente al-l’angolo sud-ovest di facciata dell’edificio, la fondazio-ne della struttura ha tagliato una porzione del piano di calpestio ricavato direttamente sulla roccia. Si tratta di una porzione levigata dal calpestio e in parte rimodel-lata, con un accenno di almeno due scalini, in direzio-ne sud-ovest, da ricollegarsi con probabilità ai resti di affioramento che sono noti esternamente alla chiesa e nella parte corrispondente all’ambiente 4 di area 2000. In questo ambiente infatti, nella metà meridionale della base rocciosa su cui si fonda l’edificio romanico, è stato documentato un ampio tratto di sentiero, ricavato nella roccia, con direzione sud-ovest, delimitato verso orien-te da quattro piccole buche che potrebbero rappresen-tare altrettanti appoggi per una palizzata che seguiva il percorso leggermente scosceso verso valle. Il sentiero risulta interrotto dalla fondazione della struttura USM 2404, appartenente al complesso del monastero pre-ro-manico.
Sulla base di queste sole indicazioni è possibile ipo-tizzare una organizzazione del sito che comprendeva una piccola chiesa, solo documentata dalle fonti, vero-
similmente ancora edificata sul pianoro principale, e un ampio spazio aperto, antistante l’edificio, che si colle-gava almeno con il sentiero che dal pianoro verso valle raggiungeva probabilmente Noce, nei pressi di Uliveto.
3.1.2 PERIODO II (Il monastero benedettino nella fase pre-romanica: fine X – primi decenni del XII secolo)
La prima attestazione del monastero di S. Michele “sito in loco et finibus ubi dicitur Verruca” risale al 4 maggio 996, quando Gerardo vescovo di Lucca lo ce-dette a Maione, abate di S. Salvatore di Sesto. In quello stesso anno quindi il monastero era già fondato, con la chiesa e gli edifici relativi.
Ancora per le cause sopra accennate, i depositi rela-tivi a questo periodo di frequentazione, sono piuttosto scarsi, anche se i dati raccolti permettono di ipotizzare l’esistenza in quest’epoca di un insediamento piuttosto articolato.
Alcune porzioni di edifici presentano delle caratteri-stiche, quali la tecnica di costruzione, un uso e una fini-tura del materiale (oltre a chiari rapporti stratigrafici di anteriorità rispetto alle strutture del Periodo III), che li collocano cronologicamente in una fase precedente alla costruzione del complesso monastico organizzato intor-no al chiostro centrale.
Le porzioni residue di tali strutture sono state rin-venute entro il perimetro della chiesa abbaziale (Area 1000), nell’Area 2000 (ambiente 4), nell’Area 3000 (log-giato est) e nell’Area 4000 (sala capitolare).
Il cantiere romanico di riedificazione dell’intero com-plesso monastico ha causato la distruzione di quasi tutte le emergenze murarie preesistenti, ad esclusione di al-cune porzioni di edifici che sono serviti come appoggio o fondazione delle nuove murature, mentre per quanto riguarda i piani d’uso relativi questi sono sopravvissuti solo in quelle aree dove i nuovi livelli pavimentali ave-vano previsto una sovrapposizione su quelli precedenti e non una loro sostituzione.
All’interno della chiesa abbaziale è stata documentata una residua struttura muraria, di cui si è conservato per metà solo un filare, fondata direttamente sulla roccia e costruita con pietre sbozzate, con orientamento nord-sud. Il muro, che nelle due distinte porzioni si pone per-pendicolarmente all’orientamento canonico della chiesa al centro della navata, è stato riutilizzato nella fase ci-stercense (Periodo IV) come base per la delimitazione del coro dei monaci. Esso risulta tagliato dalla fonda-zione dei perimetrali lunghi dell’edificio ecclesiastico. In fase con la stessa struttura sembra essere lo strato US 1490=1500 che costituisce un piano d’uso probabilmen-
68 69
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
te esterno, anch’esso più volte interessato da interventi successivi: risulta infatti tagliato dalla fondazione dei perimetrali nord e sud della chiesa romanica ed è stato in parte asportato dagli interventi cistercensi.
La struttura meglio conservata attribuibile al Perio-do II è stata rinvenuta nell’Area 2000. Si tratta del peri-metrale di un non meglio precisato edificio che doveva estendersi verso sud (all’incirca come l’ambiente 1). La struttura che definisce i prospetti interno ed esterno è stata edificata con pietre irregolari e bozzette di medie e piccole dimensioni, solo spaccate e apparecchiate a spina-pesce entro un telaio portante a pilastri in bloc-chi di arenaria di grandi dimensioni, riquadrati e spia-nati senza segni di finitura sulle superfici a vista4. La fondazione della stessa struttura muraria interrompe il sentiero ricavato sulla roccia in posto relativo al periodo precedente.
Una porzione residuale di una simile muratura, per caratteristiche costruttive e di materiale utilizzato, si localizza nell’Area 3000, come base di fondazione di un segmento del muretto di delimitazione del portico orientale. In questo caso la struttura precedente ha un orientamento leggermente differente rispetto all’alzato, ma l’evidenza non restituisce comunque informazioni che permettano di stabilire il tipo di ambiente relativo.
L’indizio più importante da mettere in relazione con il Periodo II della frequentazione del sito di S. Michele riguarda l’area della sala capitolare (Area 4000). Il depo-sito stratigrafico interno all’edificio, tagliato dai perime-trali est e ovest, quindi precedente alla costruzione del monastero romanico, è stato interessato dalla presenza di quattro sepolture (tt. 19, 22, 23,24), due scavate nella roccia (19, 24) e le altre due in fossa terragna, con coper-tura in lastre di ardesia, l’una stratigraficamente succes-siva all’altra. Tutte le fosse hanno dimensione analoga e sono orientate parallelamente all’andamento della roc-cia in posto, in evidente dissimmetria con le strutture successivamente costruite (vedi Sbarra infra).
L’ubicazione delle strutture residue, in rapporto alla pianta attuale, ha fatto pensare ad una organizzazione dello spazio del monastero privo di una organica piani-ficazione, con l’edificio ecclesiastico ancora ubicato sul pianoro più alto e gli ambienti di servizio posizionati nello spazio immediatamente a sud.
La datazione dei livelli di frequentazione di questo periodo si basa, essenzialmente, sulla valutazione del-le associazioni ceramiche rinvenute in fase con alcune di queste murature: sia recuperate nella stratigrafia re-lativa alla struttura precedente all’edificio religiose di XII secolo, scavata al centro della navata, sia nei livelli in appoggio al tramezzo che divide gli ambienti 1 e 4 dell’area dei magazzini. I materiali ceramici considerati
non sono sempre diagnostici e dunque non si può nep-pure escludere, nel caso del contesto scavato all’interno della chiesa abbaziale, la possibilità che alcuni di questi livelli possano anche essere anteriori alla prima fase mo-nastica e dunque appartenere alla chiesa o agli annessi documentati già nel IX secolo.
I dati a disposizione, pur scarsi, riferibili alla fase pre-romanica del monastero di S. Michele permettono di delineare, pur in via ipotetica, l’organizzazione dell’in-sediamento. Le limitazioni che derivano dalla scarsità delle strutture e dei livelli riferibili a questa fase crono-logica non consentono di definire al meglio la planime-tria dei singoli edifici, d’altra parte la disomogeneità delle strutture di Periodo II attestate nell’intero spazio indagato può essere interpretata come la traccia di una pianta di tipo sparso, che insisteva sul medesimo piano-ro a causa della morfologia stessa del sito.
3.1.3 PERIODO III (Il monastero benedettino nella fase romanica: primi del XII secolo - 1260)
I primi decenni del XII secolo segnano una svolta nel-la politica patrimoniale del monastero di S. Michele alla Verruca, con molta probabilità in conseguenza del fatto che almeno dal 1097, anno in cui per la prima volta è documentato un abate di S. Michele, il cenobio si fosse svincolato completamente da Sesto5 (vedi Giuliani in-fra).
Il dato più significativo ed evidente dell’accresciuta ricchezza dell’abbazia si esplicita nella decisione di ri-costruire interamente il monastero, sulla base delle in-dicazioni della Regola benedettina.
All’impianto del cantiere “romanico” è da correlare l’attestazione della proprietà di cave di pietra, desumi-bile da una serie di testimonianze prodotte in seguito ad una controversia avvenuta tra l’arcivescovo di Pisa e l’abate del monastero della Verruca, in data non spe-cificata, ma che si fa risalire agli anni ’50 del XII secolo (sulla scorta del nome dell’abate presente alla stesura dell’atto), Ildebrando.
E’ in effetti questo l’unico documento conosciuto in cui si fa esplicitamente riferimento ad attività gestite dalla badia. La controversia riguarda la gestione di par-te del territorio e delle sue risorse, più specificatamente del mirto, delle felci, del carbone e delle pietre6 (An-dreazzoli infra). L’abate quindi controllava direttamente l’estrazione della pietra; la cava, nel luogo detto “Serra de Plaia”, era organizzata con “magistros” e “secantes lapides” che avevano a disposizione locali (“capanna”), con un sistema di trasporto (“asinarii”) che permette-va di trasportare le pietre già lavorate dalla cava fino all’Arno. Il toponimo “Serra de Plaia” non è indicativo
di un luogo specifico ma doveva comunque trovarsi tra Montemagno e Calci.
Il riferimento cronologico della proprietà della cava da parte del monastero dai primi decenni del XII seco-lo lo si deduce ancora dal documento sopra indicato: i testimoni giurano infatti di aver visto i fatti descritti già trenta o quaranta anni prima7.
E’ probabile quindi che l’impulso ad organizzare questa nuova attività sia derivato proprio dalla neces-sità di impiantare il nuovo cantiere per la ricostruzione del monastero, ma che in seguito essa sia divenuta una delle risorse economiche più importanti per il cenobio, visto lo sviluppo del costruire in pietra verrucana che si registra in quegli anni a Pisa e nel territorio circostante.
Ad un’unica fase progettuale e di realizzazione sem-bra infatti da attribuire buona parte dell’impianto del monastero così come è emerso durante lo scavo. Il ma-teriale utilizzato e le tecniche murarie impiegate nella chiesa e nelle altre strutture del cenobio organizzate in-torno al chiostro centrale, anche se in alcuni casi con la-vorazione e finitura differenti, confermano la datazione del cantiere entro la prima metà del XII secolo.
Il monastero nuovamente edificato si caratterizza per una pianta organicamente definita dai suoi edifici. La chiesa abbaziale (Area 1000) era ubicata a nord del complesso, sul pianoro più ampio e regolare sul qua-
le verosimilmente si collocavano gli edifici ecclesiastici dei periodi precedenti, con planimetria a croce latina ed orientamento canonico. Nell’ampio spazio a sud della chiesa abbaziale, molto probabilmente ricavato aspor-tando le asperità create dagli affioramenti rocciosi, ven-ne realizzato il chiostro centrale, a pianta rettangolare, con i loggiati che corrono lungo il suo perimetro (Area 3000) e la grande cisterna nell’angolo nord-est (Area 6000). Sui loggiati si affacciavano gli ambienti tipici di un monastero benedettino. A sud era ubicato un corpo di fabbrica (Area 7000) che corrisponde al refettorio dei monaci e alle cucine e che, almeno nella porzione centra-le, risulta sotto-scavato, quindi con cantine e magazzini. Ad ovest (Area 2000) il corpo di fabbrica era suddiviso in quattro ambienti, due dei quali (ambiente 2 e 3) anch’es-si sotto-scavati e probabilmente utilizzati come cantine. Questo fatto suggerisce l’ipotesi che tale spazio fosse usato come magazzino o comunque per vani di servizio. Ad est del chiostro, infine, si distribuiscono gli spazi più importanti del complesso monastico, quelli della sagre-stia, in appoggio al transetto meridionale della chiesa, e della sala capitolare (Area 4000). I dormitori dei monaci dovevano trovarsi ai piani superiori degli edifici: è que-sta, tuttavia, un’ipotesi che si basa essenzialmente sulla scorta dei confronti con piante-tipo di altri monasteri benedettini, in quanto non sono conservati perimetrali i
4. Ripresa dell’area di scavo alla fine della campagna 1999.
70 71
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
cui alzati superino il piano terra. Intorno al monastero, inoltre, correva un muro di cinta (muro della clausura) che delimitava il perimetro dello spazio monastico, che è stato interamente individuato nella porzione a oriente del complesso e che comprendeva, tra esso e gli edifici del monastero, un’ampia area aperta forse destinata ad attività artigianali e produttive. L’unico saggio aperto tra la chiesa e il muro di cinta non ha tuttavia restituito dati significativi in relazione all’uso di questi spazi. In questa zona doveva trovarsi anche il campanile, il cui conoide di deiezione è ancora facilmente visibile di fian-co al transetto sud della chiesa.
Il cenobio, così come descritto, nella sua strutturazio-ne più matura di complesso architettonico isolato dalla vita civile, cinto perimetralmente da un muro e facente perno su un chiostro, centro della vita quotidiana, cir-condato da quattro gallerie e da corpi di fabbrica a più piani, risponde a tutte le esigenze di spazio privato e comunitario8.
La matrice ideologica che si riflette nello sviluppo di una pianta organica del monastero è contenuta nella Re-gola di S. Benedetto, che propone un ideale di vita e di convivenza insediata in un nucleo chiuso9.
Alcuni capitoli della Regola sono univoci nell’indica-zione dei particolari costruttivi già ricordati a proposito delle evidenze archeologiche di S. Michele. Il c. LXVI prescrive l’autosufficienza del monastero, in cui è pos-sibile trovare l’acqua, un mulino, un orto, i reparti per le varie attività; il c. III dispone i modi di convocazio-ne del consiglio, anche se non prevede ancora una sala specifica; il c. XXII istituisce un dormitorio comune; il c. XXXIII destina agli infermi una stanza con adeguati servizi igienici; il LIII prevede un appartamento per gli ospiti a cui sia vicina la mensa dell’abate; il LV stabili-sce un luogo per la cura delle vesti e delle calzature; il LVIII istituisce un noviziato per chi voglia abbracciare la Regola10; il LXVI assegna al portinaio un locale accanto all’entrata del monastero11.
Con la nuova strutturazione del monastero inizia l’uso di seppellire i monaci all’interno dei loggiati del chiostro. In totale nei loggiati est ed ovest sono state in-dividuate, e quasi tutte scavate, una quindicina di tombe in cassa litica. Sul corridoio settentrionale, ancora occu-pato dai crolli, la presenza di tombe sembra indiziata da croci incise sui conci della chiesa e recuperati nei crolli superficiali della struttura. Nell’area antistante la chiesa solo la t. 16, ricavata nella roccia, può essere collocata entro questo Periodo. Le restituzioni monetali e la po-sizione, che ne conferma la precedenza, fanno pensare alla presenza di una originaria deposizione laica prima dell’uso strutturato dello spazio come cimitero, così come avviene nel Periodo IV.
Come per le poche evidenze strutturali di Periodo II, anche per il Periodo III pur conservandosi la quasi to-talità delle strutture, la stratigrafia residua è piuttosto labile, questa volta a causa esclusivamente degli inter-venti che opereranno i Cistercensi dopo il loro arrivo a S. Michele. In effetti i livelli d’uso più consistenti che sono stati documentati durante le operazioni di scavo si collocano entro l’ambiente 4 dell’Area 2000, mentre ad esempio all’interno della chiesa abbaziale la ripavi-mentazione operata dai Cistercensi ha causato l’aspor-tazione di tutti i livelli precedenti, tanto che i pavimenti conservati e i loro piani di preparazione e posa oblitera-vano direttamente le strutture e gli strati riconducibili ai Periodi I e II.
3.1.4 PERIODO IV (Il monastero cistercense: 1260 – prima metà del XV secolo)
Nel 1260 il monastero della Verruca risulta passato all’obbedienza cistercense come risulta da una vertenza nella stessa data tra il Comune di Pisa e i Cistercensi di S. Galgano; obbedienza riconfermata nel 1261 negli Statuti Cistercensi del Capitolo Generale (vedi Giuliani infra).
Evidentemente superati i primi tentativi da parte di S. Galgano di disfarsi dei questo istituto, a partire dal XIV sono attivi in S. Michele una serie di cantieri che apportano notevoli modifiche non tanto al complesso monastico quanto all’organizzazione interna di alcuni edifici (Periodo IVa).
Come l’architettura monastica benedettina era sorta per venire incontro alla vita quotidiana della comuni-tà, così anche per i Cistercensi rimasero, come principi fondamentali delle costruzioni, gli usi, i regolamenti e le consuetudini fissate nel Liber Usuum12.
La chiesa (ecclesia), dalla pianta a forma di croce, era suddivisa nella navata centrale nel chorus monachorum e nel chorus conversorum. Le file degli stalli sono l’una di fronte all’altra, e gli ultimi due stalli (dell’abate e del priore) nel coro dei monaci chiudono a ovest le file a forma di U, in modo che rimanga un solo passaggio al retrochorus, ambiente dove erano i banchi per i monaci malati. Per gli ospiti, familiari e domestici del monaste-ro, erano a disposizione posti solo nella parte occidenta-le o nelle navate laterali.
In capo alla chiesa, a est, si trova lo spazio per l’altare, il sopraelevato presbyterium (per la messa conventuale), fiancheggiato dalle cappelle laterali per le messe priva-te. Sulla crociera si erge un cavaliere, la sola forma tur-rita consentita.
Dal transetto nord si apre la porta dei morti verso il cimitero dei monaci. 5. Vista della chiesa abbaziale da ovest.
72 73
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
Dal transetto sud si accede alla sagrestia (vestiarium) e, per una scala, al dormitorio dei monaci.
L’ala orientale del monastero, l’ala dei monaci, si congiunge quindi con il transetto ed è composta da: sagrestia, aula capitolare, parlatorio, corridoio o scala, sala dei monaci, al pian terreno, e di sopra il dormitorio (dormitorium). Alla parte estrema dello stesso edificio (a sud), sul canale di scolo, si trovano le latrine (necessaria dormitorii).
La presenza dei Cistercensi anche nel nostro mona-stero determina quindi tutta una serie di modifiche in-terne agli ambienti da porre in relazione alle specifiche norme liturgiche e di convivenza proposte dalla nuova Regola.
L’intervento più rilevante è documentato all’interno della chiesa, dove lo spazio risulta suddiviso in almeno quattro settori scanditi dall’uso di una pavimentazione differente: il presbiterio con un pavimento in lastre qua-drate di pietre, con l’altare centrale e gli altari laterali nei transetti; il coro dei monaci pavimentato in mezzane di laterizio posate a spina-pesce in cui si riconoscono ancora le impronte degli stalli dei monaci che chiudono verso ovest con l’alloggiamento dello stallo dell’abate e, a destra dello stesso, quello del priore; il coro degli in-fermi, determinato da uno spazio in cocciopesto; il coro dei conversi ancora con pavimento in mezzane.
Anche lo spazio antistante la facciata della chiesa su-bisce profonde modifiche. Oltre alla ricostruzione della scalinata di accesso all’abbazia, ad un certo punto co-perta con tettoia lignea, di cui si sono documentate le buche per palo ai lati della scala, la porzione meridiona-le dell’area si trasforma in una vera e propria cappella funeraria, con la presenza di sepolture a cassa riservate ad inumazioni di laici.
Il piccolo cimitero si strutturerà definitivamente dopo l’ampliamento verso nord dell’edificio dell’ambiente 4 dell’Area 2000 che andrà a chiuderne il limite meridio-nale. Le restituzioni ceramiche e numismatiche colloca-no cronologicamente il cimitero dei laici così strutturato tra la metà del XIV e i primi decenni del XV secolo (fig. 5).
Non solo la chiesa abbaziale subisce importanti inter-venti, ma anche negli altri edifici del complesso mona-stico i Cistercensi intervengono più o meno profonda-mente. Il complesso della sagrestia-sala capitolare viene in parte modificato con la creazione di un vano ulteriore tra la sagrestia stessa e il capitolo. Questa spazio così ricavato doveva comprendere una grande scala in legno per l’accesso ai dormitori, i cui alloggiamenti sono an-cora visibili nei perimetrali superstiti nord e est. L’inter-vento è stato probabilmente coevo alla riorganizzazione del piano superiore dell’intero complesso orientale che
già accoglieva il dormitorio dei monaci. L’icnografia del monastero cistercense prevedeva infatti un passaggio stabile che collegava la chiesa, attraverso il transetto, con l’adiacente spazio dei monaci (come novità rispetto alla Regola benedettina che imponeva invece un perfet-to isolamento dello spazio sacro). Tali interventi sono ipotizzabili anche sulla scorta dei crolli scavati nel log-giato prospiciente l’area 4000, sulla base dei quali è le-gittimo supporre che la parte superiore, almeno della sagrestia, fosse stata costruita in questa fase interamente in laterizio, con finestre ad arco con mattoni sagomati a cuneo.
Il chiostro, già strutturato nel periodo precedente, probabilmente è oggetto di limitati interventi che ri-guardano le condutture che dalla grande cisterna por-tavano l’acqua al refettorio e alle latrine, che proprio in questo periodo dovrebbero essere state costruite nella porzione finale del complesso dell’Area 4000.
Nella fase finale di presenza dei monaci cistercensi a S. Michele, prima del definitivo abbandono del monastero e della successiva occupazione del sito ad opera delle truppe prima pisane e poi fiorentine, si documenta un generale depauperamento del cenobio con un progres-sivo abbandono di ampie porzioni del monastero per un uso sempre più esclusivo della chiesa e dello spazio immediatamente a sud di essa. Probabilmente dalla fine del XIV - primi del XV secolo e fino all’abbandono, co-munque entro la metà del Quattrocento, rimangono in uso ambienti del monastero che cambiano la loro fun-zione originale: il loggiato nord, con la costruzione di un forno da pane appoggiato al prospetto della chiesa; la sagrestia, collegata direttamente al presbiterio; l’am-biente 4 dell’Area 2000 che è ampliato fino ad appog-giarsi all’angolo sud-occidentale dell’abbazia e che co-mincia ad essere utilizzato come cucina.
Buona parte degli ambienti usati come magazzino (1 e 2 di Area 2000) risulterebbero già in questo momento in parte crollati: in effetti i piani di frequentazione si-gillati dagli stessi crolli dei perimetrali hanno restituito materiale ceramico collocabile tra la fine del XIV e i pri-mi del XV secolo.
A questo stesso periodo va ricondotto l’uso poco strutturato del chiostro come area di sepoltura, con la presenza di alcune deposizioni in cassa lignea che, per la loro dislocazione e la poca profondità, indicherebbe-ro chiaramente un cambiamento di funzione del cortile centrale rispetto ai periodi precedenti. La stessa funzio-ne di area cimiteriale non strutturata viene ad assumere il loggiato orientale, dove, ugualmente al chiostro, sono state documentate numerose sepolture in fossa terragna negli strati di obliterazione delle tombe a cassone (Sbar-ra infra).
3.1.5 PERIODO V (Assedio pisano - fiorentino: 1496-1498)
L’abbandono definitivo del monastero da parte dei monaci in base al dato archeologico avviene entro la metà del XV secolo. In effetti poco dopo, e precisamente nel 1463 il patrimonio di S. Michele fu affidato al ca-nonico pisano Ludovico Martelli, con l’istituzione della Commenda Concistoriale13.
Il sito tornerà ad essere occupato, questa volta però da truppe militari, solo alla fine del Quattrocento.
Le fonti narrative contemporanee o di poco posterio-ri sono piuttosto precise riguardo agli avvenimenti che interessarono S. Michele in quello scorcio di secolo. E’ tra il 1496 e il 1498, in più episodi, che dapprima si costi-tuisce nel monastero un ridotto fortificato dei Pisani di stanza al castello della Verruca e in seguito, dopo cruen-ti battaglie, il cenobio passa sotto l’occupazione fiorenti-na, che vi impianta un campo base dal quale sferrare gli attacchi al vicino fortilizio.
Lo scavo ha restituito chiarissime tracce dell’occupa-zione militare, non solo attraverso i materiali ceramici e soprattutto metallici e numismatici, ma anche attraver-so l’analisi di interventi occorsi ad alcuni edifici, come la chiesa, l’ambiente 4 dell’Area 2000 e la sala capitolare, che ne hanno in parte modificato lo spazio interno.
Distinguere gli interventi e la frequentazione pisana prima e fiorentina poi, succedutasi in un così breve lasso di tempo, è stato piuttosto difficoltoso sulla sola base dei materiali raccolti nelle stratigrafie relative al Perio-do V. E’ certo che la notevole quantità di contenitori da mensa e da fuoco raccolti nei livelli relativi a questa fase, soprattutto “maioliche arcaiche” monocrome, broc-che nude depurate e pentole e tegami invetriati, fanno pensare ad uno stanziamento delle truppe protratto nel tempo, così come le limitate opere murarie documen-tate in alcune zone del monastero fanno ipotizzare una progettata rifunzionalizzazione dello spazio del mona-stero in senso militare-difensivo. Sono quindi casomai i militari pisani che, secondo le fonti, si stanziano più a lungo in S. Michele, tanto da fortificarlo, cioè creare un ridotto fortificato. La loro presenza potrebbe essere testimoniata dalle tracce di un muro costruito a secco di fronte alla facciata della chiesa abbaziale, dalla chiusura o tamponatura di quasi tutte le apertura che dagli edifi-ci si affacciavano sul chiostro, dallo sgombero nel chio-stro dei crolli dei loggiati, probabilmente per creare una specie di piazza d’armi, comunque uno spazio ampio e aperto utile per le truppe.
I Fiorentini sono attestati a S. Michele per pochi gior-ni nel 1496, in assedio ai Pisani chiusi nel monastero, e ancora nel 1498 in attacco al castello vicino. Le tracce
6. Evoluzione del complesso monastico (strutture campite in nero). (6.1. Evidenze di Periodo II; 6.2. La ricostruzione di Periodo III;
6.3. Gli interventi di Periodo IV).
74 75
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
più vistose dei combattimenti sono rappresentate da notevoli quantità di punte di verrettone, di freccia, di lancia, proiettili in piombo, bombarde in pietra, concen-trate nell’area antistante la chiesa e nell’edificio abbazia-le stesso: sicuramente l’unica struttura ancora in piedi al momento dell’assedio e dunque uno dei bersagli più importanti da colpire per gli assediati.
3.1.6 PERIODO VI (La frequentazione sporadica di epoca moderna: XVI - XIX secolo)
Le tracce di frequentazione successive all’assedio fio-rentino sono piuttosto labili, e si riferiscono anch’esse quasi esclusivamente al deposito archeologico docu-mentato dentro la chiesa, che rimane l’unico edificio an-cora in piedi almeno fino alla fine del ‘700 (un quattrino del 1778 di Leopoldo Lorena arciduca di Toscana, rinve-nuto sotto i crolli, rappresenta un terminus post quem per il suo abbandono).
.Schematicamente il Periodo VI può essere suddiviso in almeno tre fasi:
Periodo VIa (XVI-metà XVIII secolo): ampio arco crono-logico in cui il monastero, dopo l’abbandono definitivo anche delle truppe fiorentine, subisce i collassamenti maggiori alle strutture ma non della chiesa;
7. Area 1000. Interno chiesa.(7.1. Periodo I. Tracce di usura e regolarizzazione della roccia; 7.2. Periodo I/II. Tracce di regolarizzazione della roccia in posto affiorante interna alla chiesa).
8. Area 1000.Periodo I/II. Regolarizzazione dell’affioramento roccioso (US 1636) nel saggio 2.
1 2
Periodo VIb (metà XVIII - inizi XIX secolo): è in questo scorcio di tempo, prima del definitivo crollo dei peri-metrali, che viene organizzata all’interno della chiesa, già priva del tetto, una attività legata probabilmente allo sfruttamento del bosco, con l’evidenza di tre buche interpretabili come carbonaie e una struttura con solo cordolo a secco in pietre di riutilizzo e probabile alzato in materiale deperibile, montata nell’area del presbite-rio; allo stesso periodo deve essere ricondotto un riparo simile ricavato nell’angolo esterno compreso tra il peri-metrale nord e il transetto della chiesa, un altro piccolo edificio costruito con pietre di riutilizzo e murato a secco in appoggio alla porzione meridionale del muro di cinta del monastero, mentre un semplice riparo e ricavato nei crolli interni alla grande cisterna del chiostro. Le poche restituzioni ceramiche recuperate nei depositi di crollo delle strutture del monastero e nelle fasi di frequenta-zione dei ripari sopraddetti comprendono forme aperte di ingobbiate policrome, maculate, invetriate, oltre ad alcuni esemplari di pipe che si collocano in una arco cro-nologico compreso tra il XVIII e il XIX secolo (fig. 6).
Periodo VIc (dall’inizio del XIX secolo): sono da datarsi a questa epoca il crollo dei perimetrali nord, sud e di facciata della chiesa abbaziale.
3.2 il monastero nelle sue Parti: LA ChiesA AbbAziALe (AreA 1000) (a.a., m.d.)
L’edificio ecclesiastico nella facies romanica ha pianta a croce latina, con una lunghezza interna di 27,70 m dal-la soglia di accesso al centro dell’arco del catino absidale ed una larghezza di 6,70 m nella navata e 17,70 m in corrispondenza del transetto.
L’opera di pulizia superficiale e disboscamento, che ha occupato l’intera prima campagna del 1996, ha per-messo in via preliminare di mettere in luce circa il 70% della pianta della chiesa, evidenziando anche la consi-stenza delle emergenze murarie residue. Se infatti il ca-tino absidale, pur spoliato della faccia vista esterna, e la parete orientale del transetto nord rimanevano in alza-to a testimoniare la presenza dell’antica abbazia, il resto dei perimetrali della chiesa erano per lo più ridotti alla rasatura dei muri individuabili alla quota di calpestio. Il primo intervento si è quindi concentrato nella metà occidentale dell’edificio, nella necessità di intervenire manualmente in modo da determinare la formazione dei depositi superficiali e delineare al meglio la genesi dei crolli dei perimetrali.
In seguito è stato condotto un approfondimento stra-
tigrafico di limitate dimensioni (saggio 1) nell’angolo nord-ovest della chiesa, con il fine di mettere in evi-denza la tipologia delle fondazioni dei muri; a partire dalla campagna 2000 è stata indagata anche la porzione orientale, ad esclusione del braccio settentrionale del transetto. Lo scavo è proseguito fino a giungere al sub-strato roccioso, permettendo di documentare tutti i con-testi conservati, dove l’indagine non avrebbe distrutto testimonianze significative delle ultime fasi edilizie, ov-vero specificamente nella metà occidentale della navata e in una parte limitata del coro dei monaci, denominata “saggio 2”.
In definitiva lo scavo stratigrafico, condotto quasi esclusivamente senza l’ausilio di mezzo meccanico, ha riguardato la quasi totalità dell’intero edificio, quantifi-cabile in un 80% circa, ed ha individuato testimonianze attribuibili ad un arco cronologico che va dall’VIII-X se-colo fino alla prima metà del XIX secolo.
Periodo ILe tracce della fase pre-monastica sul pianoro della
chiesa sono molto labili e di difficile interpretazione. Nell’angolo interno Sud-Ovest della chiesa l’affiora-mento roccioso (US 1208=1653) appare regolarizzato al fine di determinare un percorso con orientamento Nord-Est – Sud-Ovest (US 1642) (fig. 7). Gli evidenti se-gni di usura (US 1643), dovuti certamente al calpestio, e la corrispondenza di andamento con un simile contesto documentato all’interno dell’ambiente 4 dell’area 2000 permettono di attribuire queste tracce ad una viabili-tà precedente a tutte le strutture murarie individuate, che conduceva verso quella che naturalmente era l’area sommitale. In via ipotetica si potrebbe pensare che sul medesimo pianoro fosse presente la cappella documen-tata a partire dall’861 e che nell’area antistante avesse inizio un sentiero in direzione sud, che metteva in colle-gamento l’insediamento di S. Michele con la vallata.
Nell’approfondimento stratigrafico di 4,50 m x 3,50 m denominato “saggio 2”, ubicato nella metà meridionale della navata in prossimità del braccio Sud del transet-to, è stato possibile documentare contesti attribuibili ai primi Periodi di occupazione del sito. Le testimonian-ze di maggiore interesse e di più antica cronologia ap-paiono localizzate nella parte Est del saggio, grazie alla presenza di un avvallamento naturale della roccia che ha permesso una maggiore conservazione della strati-ficazione.
Su uno strato di livellamento direttamente individua-bile negli avvallamenti del substrato roccioso, composto sostanzialmente da frammenti litici senza supporto di matrice (US 1636), si impostano due buche di forma ar-rotondata (US 1635, 1639), una delle quali caratterizzata
76 77
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
9. Area 1000. Periodo I/II. Rilievo archeologico della struttura e dei livelli di fondazione appartenenti alla fase pre-romanica del sito.
10. Area 1000, interno chiesa.(10.1. USM 1625 nel saggio 2 interno chiesa; 10.2. USM 1625 nel saggio 2 interno chiesa).
11. Area 1000. Periodo II. Rilievo archeologico della fase di frequentazione del monastero pre-romanico sul pianoro della chiesa.
1 2
da un riempimento limo-argilloso con presenza di gru-mi giallastri (US 1637) (fig. 8). La loro funzione appare ignota e non connessa ad un chiaro piano di calpestio; questo contesto è poi obliterato da un livello d’uso che si estende in tutto il saggio (US 1616).
Periodo IIA questo periodo è attribuibile una serie di interventi
che, pur nell’assenza di rapporti fisici reciproci a causa delle successive asportazioni dei restauri cistercensi (US 1584), possono essere interpretati come coevi o quanto-meno coesistenti in alcune fasi della loro vita. Si tratta di una regolarizzazione dell’affioramento roccioso (US 1626), che probabilmente intacca anche la stratificazio-ne precedente, al fine di determinare un piano d’uso orizzontale (US 1615=1626) connesso ad un muro in ele-menti litici spaccati con orientamento N-S (US 1625 e 1492), conservato solamente per alcuni tratti del primo filare (fig. 9-10) e tagliato dalle trincee di fondazione dei perimetrali della chiesa romanica. Alcuni chiari piani di calpestio (US 1600 e 1597, 1532) caratterizzati da una
matrice limo-argillosa selezionata e di colore rosso piut-tosto intenso, sono da considerarsi come probabili livel-li pavimentali di un interno delimitato dalla struttura muraria già citata (fig. 11-12). Tre buche sub-circolari di limitata profondità (US 1537, 1525, 1528), allineate con orientamento NW-SE, sono di difficile interpretazione (fig. 13).
Ad Ovest di questo contesto, in un’area che ipoteti-camente possiamo considerare un esterno, si individua uno strato limoso omogeneo di colore giallastro, con nu-merosi piccoli frammenti litici, esteso per buona parte della navata (US 1490=1500) e anch’esso tagliato dalla fondazione dei perimetrali della chiesa (fig. 14). Quello documentato è comunque il contesto più sicuro prece-dente alla riedificazione del monastero che sarebbe av-venuta entro la prima metà del XII secolo.
Periodo IIIDella fase benedettina-romanica del monastero ri-
mangono testimonianze importanti dell’impianto archi-tettonico, mentre mancano quasi completamente i piani
12. Area 1000. Interno chiesa.(12.1. Periodo II. Livelli di frequentazione US 1600-1601 in saggio 2; 12.2. Periodo II. Tracce di arrossamenti nei livelli d’uso in saggio 2).
1 2
78 79
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
pavimentali ed una stratificazione diagnostica delle fasi costruttive o di vita.
A questo Periodo appartiene la costruzione dell’edi-ficio ecclesiale nella planimetria a croce latina che man-terrà fino all’abbandono, caratterizzata da una navata ad aula unica con transetto e abside semicircolare (fig. 15).
Il perimetrale Sud è conservato per un alzato maggio-re rispetto a quello Nord, ed è costruito con due diffe-renti tecniche murarie, forse attestanti due diverse fasi costruttive: una (USM 1388), ha fatto ricorso alla posa in opera di bozzette di varie dimensioni, che mantengo-no una apparecchiatura a filari orizzontale, alcune vol-te con zeppe verticali, malta piuttosto friabile di colore bruno-giallastro molto chiaro; l’altra, al di sopra di essa, ad una muratura pseudo-isodoma, con conci perfetta-mente squadrati e spianati in superficie, di grandi e me-die dimensioni, alternati in filari paralleli (USM 1018); la malta, di colore bianco-grigiastro, piuttosto tenace, è appena visibile nei sottili letti e giunti.
La costruzione dell’edificio religioso ha implicato un impegnativo lavoro di modellazione e asportazione del-l’affioramento roccioso del pianoro. La fondazione dei perimetrali nord e sud è avvenuta infatti, in alcuni tratti, all’interno di regolari tagli nella roccia, mentre l’angolo
interno sud, tra il braccio meridionale del transetto e la navata, si appoggia e copre una squadratura e spianatu-ra della roccia in situ (fig. 17).
Dei piani pavimentali ipoteticamente attribuibili alla fase benedettina rimane solo un lacerto presso l’angolo sud-occidentale della navata, in corrispondenza di una porta laterale dell’edificio, conservatosi poiché collassa-to e quindi ricoperto da uno strato di livellamento (US 1261).
Si tratta di una pavimentazione in mattoni disposti in folio su corsi paralleli (US 1260), che proseguiva nel vano dell’apertura laterale, poi tamponata, e che evi-dentemente altrove è stata completamente asportata (fig. 18).
Unico altro indizio relativo ai piani interni della chie-sa di XII secolo è una traccia orizzontale sulla prima fase del perimetrale Sud (USM 1388), attribuibile ad un livel-lo pavimentale in cocciopesto (US 1390), individuata ad una quota sensibilmente più alta rispetto al pavimento della fase cistercense.
Tale pavimentazione precedente dovrebbe essere sta-ta asportata proprio quando i Cistercensi hanno rico-struito i nuovi pavimenti, abbassando i precedenti piani interni.
13. Area 1000. Interno chiesa.(13.1. Periodo II. Rilievo archeologico dell’ultima fase di frequentazione nel saggio 2. Il taglio 1584 e il riempimento 1583 si riferiscono agli interventi cistercensi di
restauro dei pavimenti interni alla chiesa; 13.2. Livello d’uso US 1531).
1
2
14. Area 1000. Periodo III. Livelli preesistenti tagliati per la fondazione dei perimetrali della chiesa abbaziale.
15. Area 1000. Planimetria della chiesa abbaziale di S. Michele.
16. Area 1000. Periodo III. Taglio nell’affioramento naturale per la fondazione dei perimetrali della chiesa.
17. Area 1000. Periodo III. Taglio nell’affioramento naturale per la fondazione dei perimetrali della chiesa.
80 81
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
Periodo IVPeriodo IV aNel 1260 i Cistercensi sono a S. Michele, e la loro pre-
senza porta ad una serie di cambiamenti finalizzati ad adattare lo spazio monastico alle esigenze dettate dal-la loro Regola. Il confronto con piante tipiche dei mo-nasteri cistercensi14 ha facilitato l’interpretazione delle notevoli modifiche che hanno interessato sia la chiesa abbaziale sia gli spazi del monastero.
La chiesa è l’edificio che ha subito maggiori modifi-che interne legate alle necessità dettate dalla liturgia. La divisione canonica della navata in coro dei monaci, coro degli infermi e coro dei conversi, ha infatti trovato preci-sa testimonianza archeologica nella suddivisione dello spazio interno scandita da differenti tipi di pavimenti.
Le indicazioni archeologiche sono comunque molto chiare. Il cantiere di restauro aveva previsto la comple-ta sostituzione della pavimentazione precedente, e for-se modifiche o miglioramenti alla porzione superiore del fabbricato o del tetto. Il primo intervento attuato dal cantiere è stato quello dell’asportazione dell’intera pavimentazione della chiesa benedettina e dell’abbas-samento di quota dei piani di calpestio interni, che ha purtroppo asportato gran parte della stratificazione pre-cedente.
La seconda azione è stata quella relativa all’installa-zione del cantiere: le buche di palo, circolari o sub cir-colari, allineate soprattutto lungo il perimetrale Nord, sono ricavate sull’interfaccia di rasatura a cui gli in-terventi cistercensi sono giunti, riportando in luce uno
18. Area 1000. Periodo III. Porzione residua di pavimentazione della fase benedettina.
19. Area 1000. Periodo IV. Buca per palo relativa al cantiere di restauro cistercense. 20. Area 1000. Periodo IV. Rilievo delle evidenze della fase di cantiere cistercense per il restauro delle strutture della chiesa abbaziale.
82 83
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
21. Area 1000. Periodo IV. Planimetria delle strutture ricostruite nella fase cistercense nella chiesa abbaziale.
strato appartenente al Periodo II (US 1490=1500). Esse, quasi tutte con elementi per inzeppatura (US 1242, 1266, 1268, 1275, 1277, 1279, 1282, 1655, 1657, 1661), possono rappresentare l’impianto di una serie di pali allineati, molti dei quali paralleli al muro, che, forse sfruttan-do le preesistenti buche pontaie, avevano creato una struttura in legno come base per impalcature (fig. 19). A questa fase è anche attribuibile una lente in malta di colore biancastro (US 1280) che si individua nella parte meridionale della navata (fig. 20). I materiali ceramici rinvenuti nei livelli di preparazione dei piani e nei riem-pimenti daterebbero questa fase di intervento intorno ai primi decenni del XIV secolo.
In questo periodo si sarebbero costruiti, quindi, pavi-menti differenziati in base alle esigenze di suddivisione dello spazio (fig. 21). Nella metà occidentale, corrispon-dente al coro dei conversi, uno strato compatto, forte-mente arrossato in superficie (US 1214), costituiva il pia-no di posa in opera di una pavimentazione, della quale sono conservati in situ solamente alcuni laterizi disposti a spina-pesce (US 1244).
La parte centrale della navata costituiva il coro degli infermi, caratterizzato nel caso di S. Michele da una pa-vimentazione in cocciopesto piuttosto grossolano, ma
22. Area 1000. (22.1. Periodo IV. Particolare del pavimento in cocciopesto (US 1380) del coro degli infermi, in cui è evidente l’impronta del probabile scranno dell’abate;
22.2. Periodo IV. Resti della prima stesura del pavimento in cocciopesto).
23. Periodo IV. Livello di preparazione US 1517 del pavimento in cocciopesto.
1
2
84 85
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
24. Area 1000. Periodo IV. Pavimento in mezzane del coro dei monaci (US 1340) della chiesa abbaziale con l’asportazione parziale che ha messo in luceil livello di preparazione sottostante.
25. Area 1000. Periodo IV. Particolare del pavimento US 1340 con le buche per l’alloggiamento dei pali degli scranni dei monaci.
spianato in superficie, che presenta due fasi (US 1516, 1380), ed una preparazione costituita da ciottoli spac-cati e frammenti litici anche di medie dimensioni (US 1517) (fig. 22-23). Sul limite est dello stesso pavimento si trovavano due spazi quadrangolari costruiti in laterizio, l’uno centrale e di maggiori dimensioni (US 1486), l’al-tro nella parte Sud e più piccolo (US 1484), che, anche in base alle descrizioni tradizionali, potrebbero rappresen-tare l’impronta o la posizione degli scranni dell’abate e del priore del monastero, rivolti verso il presbiterio e posti al culmine dell’allineamento degli scranni dei mo-naci (fig. 24). Le due impronte, d’altra parte, potrebbero anche rappresentare le basi di appoggio di un eventuale pulpito con scala di accesso, segnalato proprio in quella posizione in alcune ricostruzioni ideali di una abbazia cistercense15.
Lo spazio antistante la zona presbiteriale rialzata era occupato dal coro dei monaci, che aveva una pavimen-tazione, conservata per circa la metà della sua estensio-ne originaria, in laterizi posati per foglio e disposti a spina-pesce (US 1340) sopra una preparazione in malta di esiguo spessore (US 1324) (fig. 25-26). Tale pavimen-tazione era delimitata verso la facciata da un piccolo
gradino in pietra e laterizi (US 1443), impostato sulla rasatura della precedente struttura muraria (US 1492-1626), e sul quale doveva trovarsi una specie di divi-sione o balaustra (fig. 27). Oltre tale gradino si trovava una fascia non pavimentata, forse occupata da strutture lignee che, sotto uno strato limoso di colore bruno chia-ro (US 1453), presentava numerose tracce di attività di cantiere con buche per palo (US 1507, 1508, 1518), buche di forma ellittica (US 1510, 1511) e lenti sabbiose di colo-re ocra (US 1499, 1506) (fig. 28-29). Verso l’abside, inve-ce, il limite era rappresentato dai due gradini di accesso all’area presbiteriale (US 1361, 1362, 1413), costituiti da grandi elementi litici squadrati. Nel pavimento erano previsti alloggiamenti quadrangolari di limitata profon-dità, disposti alla distanza regolare di circa 1,30 m dal rispettivo perimetrale e di 1,50-1,60 m l’uno dall’altro lungo l’allineamento. I tre appartenenti all’allineamento Nord (US 1364, 1366, 1368), individuati nella porzione di pavimentazione ancora conservata, testimoniano una realizzazione contestuale alla posa in opera dei mattoni pavimentali. Le altre tre buche (US 1494, 1495, 1496), al-lineate al perimetrale Sud, sono individuabili solamente nella preparazione in malta (fig. 30). Tali testimonianze
26. Area 1000. Vista dell’interno della chiesa.
86 87
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
sono interpretabili come tracce connesse alla presenza di panche o scranni per i monaci, che evidentemente poggiavano lungo i perimetrali e su sostegni o pali pro-babilmente in legno a sezione quadrangolare inseriti al-l’interno delle buche.
Il presbiterio, rialzato dal piano di calpestio del coro dei monaci, è stato indagato limitatamente alla porzio-ne meridionale, corrispondente in gran parte al braccio Sud del transetto.
L’ultima pavimentazione conservata, corrisponden-te alla fase cistercense, è rappresentata da lastre litiche quadrangolari, disposte su allineamenti regolari (US 1685=1686) (fig.31.1 e 31.2). Nella zona centrale dell’area scavata, infine, si trovava una struttura rettangolare in muratura (US 1664). Si tratta evidentemente di un altare laterale, conservato per circa 35 cm di altezza e man-cante della parte superiore e della lastra della mensa (fig.32).
Periodo IV bAd un momento successivo sono attribuibili alcuni
interventi di carattere puntuale che, sebbene denotino in qualche modo una ridotta cura dell’aspetto estetico, sono tuttavia indizi di una continuità di utilizzo della chiesa abbaziale. Le buche quadrangolari preceden-
27. Area 1000. Periodo IV. Gradino in laterizi appoggiati su struttura preesistente in funzione di base per balaustra che suddivide il coro dei monaci da quello degli
infermi.
28. Area 1000. Periodo IV: Buca relative al cantiere di restauro dei Cistercensi.
29. Area 1000. Periodo IV: Buca relative al cantiere di restauro dei Cistercensi.
30. Area 1000. Periodo IV: Particolare del pavimento US 1340 con l’allineamen-to delle buche per gli scranni, tamponate nel Periodo IVb.
temente citate vengono tamponate con laterizi fram-mentari posti in opera in modo da ricostituire il piano pavimentale (US 1444, 1446, 1448) (fig. 33). La volontà da parte dei monaci di ricreare l’ordinato disegno delle mezzane implica senz’altro la persistenza d’uso alme-no della chiesa, dopo che gli arredi originari erano forse stati trasportati in altro luogo.
Il gradino dell’ingresso al transetto Sud dalla zona del chiostro viene avanzato verso l’esterno con la col-locazione di un elemento litico squadrato (US 1383) ed una nuova pavimentazione posta in opera in filari pa-ralleli (US 1421).
Non è chiaro il significato di questo intervento, che può forse essere giustificato dal cattivo stato di conser-
vazione della porzione di piano pavimentale che va ad obliterare (US 1440) (fig. 34-35).
Il transetto Sud, inoltre, vede alcuni limitati restauri in laterizi della pavimentazione (US 1693, 1695) ed una ridefinizione del raccordo con l’area centrale del presbi-terio grazie alla costruzione di un muretto divisorio (US 1672), conservato solamente per un breve tratto e pochi filari, appoggiato alla lesena a destra dell’abside.
E’ inoltre in questa fase che si struttura definitiva-mente l’area antistante la chiesa con lo spazio a sud organizzato in cimitero per la sepoltura dei laici (vedi Sbarra infra) (fig. 36.1, 36.2). L’area occupata è delimita-ta a sud dal perimetrale di ambiente 4 di area 2000 e a nord dalla scalinata di accesso alla chiesa. La stessa sca-
31. Area 1000.(31.1. Periodo IV. Pavimentazione del transetto meridionale della chiesa; 31.2. Periodo IV. Resti dell’altare laterale destro US 1644).
32. Area 1000. Sezione Nord-Sud del transetto meridionale della chiesa abbaziale. (Per il posizionamento vedi fig. 15).
1 2
88 89
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
linata, restaurata in questo periodo risulta, coperta da una tettoia con pali portanti in legno, come dimostrano le quattro buche con zappature in pietra documentate, due per lato, lungo il limite nord e sud della struttura (fig. 37.1, 37.2).
Questa serie di interventi, assieme all’evidenza ar-cheologica dell’abbandono della porzione meridionale del monastero tra la fine del XIV e gli inizi del XV se-colo, può far ipotizzare che nell’ultima fase di presenza dei cistercensi, a S. Michele fosse rimasto un minimo numero di monaci, ormai sufficienti alla sola officiatura della chiesa.
Periodo VAll’indomani della prima conquista di Pisa da parte
dei Fiorentini e della seguente riacquistata libertà, la si-tuazione logistica deve essere divenuta insostenibile per i monaci di S. Michele. Nella seconda metà del Quattro-cento gli assedi si fanno sempre più frequenti fino allo stanziamento temporaneo prima di un distaccamento
pisano, poi di una guarnigione fiorentina nelle struttu-re del monastero ormai disabitato, nell’ultimo decennio del secolo XV. Le tracce archeologiche di questa pre-senza e del periodo di conflittualità anche cruenta sono molto chiare e riguardano non solo la cultura materiale, ma anche le modifiche apportate ad alcuni ambienti e alla chiesa, in un disegno di sistemazione militare del complesso architettonico del monastero.
La chiesa e la zona antistante la facciata sono le aree che hanno restituito la maggior parte dei materiali da porre in relazione con l’accampamento militare; eviden-temente l’edificio ecclesiastico era la struttura meglio conservata e quindi più difendibile e nella quale era possibile alloggiare il maggior numero di soldati.
Nell’edificio (fig. 38), nell’angolo sud-occidentale in-terno alla facciata, era stata posta in opera una porzione di pavimento (US 1008) riutilizzando forse alcune mez-zane crollate dal rivestimento interno della copertura, evidentemente in parte già crollato (fig. 39). A tale strut-tura sono da collegare alcune buche di difficile inter-
33. Area 1000. Periodo IVb. Tamponatura delle buche per gli scranni del pavimento in mezzane del coro dei monaci.
pretazione (US 1240, 1249, 1246) ed una grossa buca per palo quadrangolare (US 1238) nelle immediate vicinan-ze del perimetrale (fig. 40). Nella stessa fase uno strato di carbone e cenere (US 1358), esteso al centro della na-vata in prossimità della scalinata presbiteriale e prose-guente oltre il limite di scavo verso il transetto Nord, ci suggerisce un utilizzo come temporanea area di fuoco, coeva allo stanziamento militare. A favore di questa ipo-tesi propenderebbe il ritrovamento di alcuni particola-ri reperti metallici all’interno della US, tuttavia non è
possibile escludere un limitato evento incendiario, che potrebbe aver interessato l’area del transetto Nord e che comunque non ha comportato il crollo del tetto, visto che la deposizione di un omogeneo strato limo-sabbioso selezionato (US 1360), che si estende su tutta l’area del coro dei monaci, testimonia un abbandono prolungato delle strutture pavimentali della chiesa prima del defi-nitivo crollo della copertura.
In effetti un dato che si presenta con sufficiente chia-rezza è la presenza di una serie progressiva di crolli, in un quadro di continua, seppur sporadica, occupazione. Ad un primo momento sono attribuibili i crolli del ri-vestimento interno del soffitto della navata (US 1218, 1219), costituito da mezzane appoggiate plausibilmente su piccoli travicelli, che sono stati rinvenuti concentrati lungo i perimetrali forse a causa di interventi successivi. In alcuni punti è evidente una risistemazione dei primi crolli al fine di creare un temporaneo piano di calpestio (US 1023) i cui i reperti ci permettono di attribuire alla fase di occupazione militare (fig. 41-42).
Periodo VIDopo il definitivo abbandono del sito proseguono
i crolli: un consistente strato di lastre di ardesia e di mezzane del sottotetto si estende nell’intera navata con maggiori concentrazioni lungo i perimetrali (US 1003,
34. Area 1000. Periodo IV. Scalino di accesso del portale laterale del transetto meridionale della chiesa.
35. Area 1000. Sezione parziale Est-Ovest del transetto meridionale. (Per il posizionamento vedi fig. 15).
90 91
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
36. Area 1000. Periodo IV. Vista dell’area cimiteriale in facciata della chiesa.
37. Area 1000. Pianta dell’area cimiteriale destinata ai laici. 38. Area 1000. Periodo V. Rilievo delle evidenze della fase di occupazione militare della chiesa.
92 93
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
39. Area 1000. Periodo V. Ripavimentazione dell’angolo Sud-occidentale della chiesa (US 1008).
40. Area 1000. Periodo V. Interventi nell’angolo Sud-Ovest interno alla chiesa.
41. Area 1000. Periodo V. Livelli di frequentazione sui parziali crollo interni alla chiesa.
1004, 1013, 1336) e in corrispondenza del transetto Nord (1342), obliterando le tracce dell’occupazione militare e sancendo la defunzionalizzazione dell’edificio ecclesia-stico.
Buona parte dei perimetrali rimangono ancora in al-zato, ma l’assenza di copertura è la causa della deposi-zione all’interno, su tutta l’estensione del perimetro, di un deposito progressivo con evidente presenza di hu-mus (US 1004), di spessore differente, che documenta un lungo periodo di assenza di frequentazione.
Alcune grandi buche circolari e sub-circolari (US 1005, 1323) praticate in US 1004, che giungono fino ad intac-care l’affioramento roccioso, sono interpretabili, grazie ai riempimenti composto da carboni, come carbonaie. A questa attività è probabilmente ascrivibile anche una struttura (USM 1319, 1320) realizzata con materiale di recupero dai crolli; si tratta di un ambiente rettangolare ubicato nell’area presbiteriale in corrispondenza del-l’abside, costituito da uno zoccolo in muratura a secco e probabilmente da un alzato in materiale deperibile. La scelta della zona come ricovero ci suggerisce che al momento della costruzione la copertura nei pressi del catino absidale dovesse essere ancora integra e quindi offrisse un punto privilegiato come riparo dalle intem-perie. Il rinvenimento di questo contesto di occupazio-ne sporadica avvalora ulteriormente l’ipotesi proposta:
sappiamo infatti che la produzione del carbone neces-sitava un controllo assiduo e prolungato per diversi giorni, e che quindi sempre venivano realizzati ricove-ri temporanei, spesso unicamente composti da picco-li rami e frasche reperite in sito. Una simile traccia di muretti realizzati con materiale di recupero è presente anche all’esterno della chiesa, nell’angolo tra transetto e perimetrale Nord. Un quattrino di Leopoldo Lorena Arciduca di Toscana rinvenuto in uno strato contestuale (US 1002), datato 1778, colloca tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo la fase di frequentazioni sporadiche del sito e rappresenta un terminus post quem per il crollo del perimetrale Nord nella navata (fig. 43).
Dallo scorcio del XVIII secolo agli inizi del XX avven-gono i crolli dei perimetrali, con una successione che tal-volta è possibile cogliere nel dettaglio, grazie a fonti sia archeologiche, sia iconografiche.
Il primo crollo sincronico avvenuto è, come già detto, quello del perimetrale Nord, il cui paramento interno con parte del sacco è collassato verso l’interno dell’edi-ficio mantenendo tendenzialmente la disposizione in filari dei conci (US 1001), mentre il resto è crollato verso l’esterno. I crolli del perimetrale Sud, che sembra invece essere frutto di un’azione naturale progressiva, e della facciata, che è caduta quasi esclusivamente nella zona antistante la chiesa, si collocano in un momento succes-
42. Area 1000. Periodo V. Fase di abbandono del cimitero dei laici.
94 95
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
sivo da collocarsi entro i primi decenni del XX secolo. (fig. 44-45)
Una foto della prima metà del Novecento ci testimo-nia come ancora in alzato le strutture relative al transet-to Sud, che quindi sono andate in buona parte distrutte negli ultimi cinquant’anni (fig. 46).
3.3 iL monAstero neLLe sue PArti: i mAgAzzini e gLi Ambienti di serVizio (AreA 2000) (a.a.)
Il complesso localizzato lungo il lato occidentale del chiostro era composto da quattro ambienti distinti (am-bienti 1-4) che avevano la funzione di spazi di servizio e di magazzino per lo stoccaggio delle derrate alimentari (fig. 47).
La tipologia dei vani documentati (almeno due sot-toscavati in ambiente 2 e 3) trova confronti precisi con
la pianta di S. Gallo, che indica in questa posizione gli ambienti delle cantine16; la stessa posizione è occupata dalle cantine di Cluny II e Cluny III17. La pianta tipo dei monasteri cistercensi indica nell’edificio che si affaccia sul loggiato occidentale la dispensa del cenobio18.
La determinazione dello spazio riservato ai magazzi-ni del monastero è importante per le implicazioni deri-vanti dalle scelte economiche dell’abate.
Studi recenti, relativi ad un alto numero di monasteri medievali oggetto di indagine archeologica in Inghilter-ra, hanno previsto la comparazione delle planimetrie dei magazzini (monastic burns) in relazione all’organiz-zazione dello stoccaggio dei cereali prodotti nelle fat-torie del monastero19. E’ ipotizzabile che un magazzino molto grande non sia riferibile solo ai bisogni interni del cenobio, ma abbia piuttosto una funzione di immagaz-zinamento e successiva ridistribuzione verso le diffe-renti dipendenze.
Il corpo di fabbrica adibito a magazzino e cantina di S. Michele alla Verruca (Area 2000) misura in lunghezza circa 19 m, in riferimento alla pianta originale di fase be-nedettina, che non comprendeva la modifica cistercen-se della porzione di ambiente 4, all’estremo nord, che va ad appoggiarsi all’angolo meridionale della facciata della chiesa.
Questo edificio già in origine era suddiviso in quattro ambienti, collegati tra di loro con aperture interne, e con accessi sul cortile almeno per i due vani verso la chiesa (ambiente 1 e ambiente 4).
Con l’indagine archeologica sono stati completamente indagati gli ambienti 1, 2 e 4. Il vano 3 non è stato inve-ce scavato perché si potevano presupporre modalità di abbandono analoghe a quelle riscontrate nell’ambiente
43. Area 1000.(43.1. Periodo VI. Vista della navata della chiesa con le buche per la produzione del carbone; 43.2. Periodo VI. Particolare di una buca per la produzione del carbone).
44. Area 1000. Periodo VI. Crollo del perimetrale nord della chiesa.
12
2, indagato manualmente fino al livello della roccia af-fiorante.
L’edificio, di fabbrica unitaria, si articola nella succes-sione dei vani da nord a sud che si adattano al degradare dell’affioramento roccioso, che spesso è stato utilizzato come base per la fondazione dei perimetrali e in parte come piano di calpestio originale (fig. 48).
Periodo I e Periodo IIGli ambienti 1 e 4 nascono in una posizione in prece-
denza occupata da un’altra costruzione, ancora testimo-niata dal tramezzo caratterizzato da una tecnica costrut-tiva a spina-pesce, presumibilmente relativo all’assetto di X-XI secolo del monastero. Si tratta di un muro, po-sizionato est-ovest, costruito con pietre irregolari e boz-zette di medie e piccole dimensioni, solo spaccate e ap-parecchiate a spina pesce entro una struttura portante a pilastri in blocchi di arenaria di grandi dimensioni, ri-quadrati e spianati senza segni di finitura sulle superfici a vista (Andreazzoli infra).
La struttura muraria si fonda sulla roccia affiorante: si appoggia direttamente sulla regolarizzazione della stessa (US 2101) nella facciavista sud (USM 2087) (nel-l’ambiente 1); è fondata nel taglio (US 2400) dell’affiora-mento (US 2367) per la facciavista nord (USM 2404)
I dati a disposizione non sono sufficientemente completi per interpretarne la funzione. L’unica evidenza di rilie-vo è documentabile nell’angolo nord-occidentale della struttura stessa, dove è chiaramente visibile il taglio di un perimetrale ovest legato al muro 2087, sul quale si è impostato il nuovo perimetrale occidentale di ambiente 1. Solo sulla base di questo rapporto e delle quote della roccia naturale è possibile ipotizzare la presenza di un edificio che molto probabilmente occupava all’incirca la medesima posizione di ambiente 1. D’altra parte il de-posito stratigrafico in fase con la struttura, documentato nell’adiacente ambiente 4, era composto da livellamenti successivi di terra appoggiati al prospetto nord ma non da piani di calpestio interni ad una ipotetica struttura. Proprio per questo le evidenze dei periodo I e II verran-no trattati nell’esposizione di ambiente 4.
3.3.1 Ambiente 1L’ambiente 1 di area 2000 è un vano quadrangolare
che in pianta misura circa 3,50x5 m; nel perimetrale est (USM 2014) si apre l’accesso verso il chiostro costituito dalla soglia monolitica US 2105 (fig. 49).
Periodo IIIL’ambiente 1 assume una posizione particolare all’in-
terno della sequenza degli edifici del corpo di fabbrica in quanto è il risultato di un terrazzamento del fronte sud, dove il livello naturale sottostante presenta un brusco e notevole salto di quota (fig. 50). Il tramezzo 2110+2014 (perimetrale sud di ambiente 1), oltre a delimitare e a suddividere due ambienti distinti, ha la funzione strut-turale di terrazzare i riporti di terra interni ad ambiente 1, che si sono resi necessari per la creazione di livelli d’uso regolari.
L’edificazione di un primo muro divisorio USM 2110, che si lega al perimetrale occidentale, ha permesso la deposizione di un iniziale, notevole, riporto di terra mi-sto a lastre di ardesia, anche di medie dimensioni, inte-so come intervento di regolarizzazione dei piani interni (US 2049).
Sulla paleosuperficie dello strato sono stati documen-tati due focolari (US 2047 e 2048), non strutturati ma semplicemente costituiti da una concentrazione, in for-ma sub-circolare, di carbone e cenere (fig. 51).
Questa prima interruzione nella sequenza dei ripor-ti è da mettere in relazione forse con la fondazione dei perimetrali sud, est e ovest, mentre sul lato nord era an-cora a vista il muro più antico USM 2087, sul quale si costruisce il divisorio USM 2010+2011.
Costruito, in questo modo, il contenitore che rappre-senterà i perimetrali di ambiente 1, in un momento di poco successivo si interverrà con un ulteriore rialzamen-to interno costituito da un riporto di terreno e frammen-ti ardesia (US 2038, 2046), forse depositato successiva-mente al restauro del tramezzo sud, in parte ricostruito per un cedimento strutturale (USM 2014).
Anche sulla superficie di questo secondo livellamento si impostava un grande focolare (US 2039) (fig. 52).
45. Area 1000. Sezione Nord-Sud della chiesa abbaziale. (Per il posizionamento vedi fig. 15).
97
Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
46. M
atrix
del
dep
osito
arc
heol
ogic
o sc
avat
o al
l’int
erno
del
la c
hies
a ab
bazi
ale
di S
. Mic
hele
.
47. P
lani
met
ria g
ener
ale
dell’
area
200
0.
99
Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
48 S
ezio
ne N
ord-
Sud
di A
rea
2000
.
non
scav
ato
49. Area 2000. Periodo III. Soglia di accesso e perimetrale est di ambiente 1.
50. Area 2000. Vista generale dell’ambiente 1.
100 101
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
51. Area 2000. Pianta della fase di cantiere della costruzione dell’ambiente 1.52. Area 2000. Periodo III. Pianta della prima fase di frequentazione dell’ambiente 1.
53. Area 2000. Periodo IV. Piano pavimentale US 2025 dell’ambiente 1.
102 103
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
Periodo III/IVL’unico livello pavimentale documentato in questo
vano è il 2025, costituito da terra battuta, con superfi-cie arrossata, reso molto compatto dalla presenza di fini schegge di ardesia (fig. 53). E’ questo il piano di calpe-stio in fase con la soglia 2105 relativa alla porta del pe-rimetrale est, e che copre la risega del tramezzo di USM 2014, del perimetrale ovest 2007 ed è inoltre in fase con l’apertura USM 2306, al centro del muro di divisione tra l’ambiente 1 e il 4 (USM 2010+2012).
Come per i restauri cistercensi all’interno della chiesa anche in questo vano il ripristino di un nuovo pavimen-to non ha causato notevoli aumenti di quota. In effetti questo intervento è da mettere in relazione con una fase di cantiere immediatamente precedente alla stesura del nuovo calpestio e che ha interessato un restauro ulterio-re del tramezzo 2100+2014. Si è documentato infatti un taglio (US 2024) parallelo al muro di divisione, che cor-risponde alla ricostruzione della porzione del prospetto 2122 evidenziata sulla facciavista sud (in ambiente 2). Questo intervento ha tagliato i livelli della fase prece-dente (il focolare 2036 e il riporto 2039).
Nella fase finale d’uso dell’area magazzini, prima del definitivo abbandono del sito da parte dei monaci, è documentata una riconversione di funzionalità dell’am-biente 4 che causa la chiusura sia dell’accesso interno 2306, con la tamponatura 2088, sia di una delle porte presenti nel perimetrale orientale dello stesso ambiente 4.
Nel vano 1, si documenta un primo parziale crollo del tetto (US 2022), costituito da medie lastre di ardesia, di forma quadrangolare, che vanno in parte a coprire la soglia di accesso 2105. Sopra questo primo collassa-mento, e quindi in vista del definitivo abbandono del vano contemporaneamente al crollo di ambiente 2, si opera una sorta di regolarizzazione del crollo stesso e di una parte di bozze probabilmente relative al culmi-ne del tramezzo nord (US 2010+2012); in questo modo viene creato un piano d’uso relativo forse ad un utilizzo precario e temporaneo dell’ambiente. In un momento successivo, che è difficile collocare cronologicamente per l’assenza di materiale ceramico diagnostico (Perio-do V?), viene chiusa la porta di accesso al chiostro, il cui tamponamento copre il crollo del tetto anche sopra la soglia 2105, ed è aperto un varco verso l’esterno nel perimetrale ovest 2007.
L’abbandono definitivo è causato dal crollo completo del tetto (US 2003) e dei perimetrali (US 2001).
3.3.2 Ambiente 2L’ambiente 2, di forma quadrangolare, misura 4,20 x
4,90 m. La profondità del vano raggiunge i - 3 m rispet-
to alla quota della rasatura del perimetrale nord; esso, composto da cantina sottoscavata e porzione conservata del piano superiore, ha permesso di documentare una ricca sequenza stratigrafica cronologicamente compresa tra la costruzione di XII secolo e il definitivo collassa-mento dei perimetrali avvenuto in epoca moderna (fig. 54).
Periodo IIILa costruzione dell’ambiente 2 è coeva all’edifica-
zione degli ambienti adiacenti, risultato di un progetto unitario che ha previsto la fondazione dei perimetrali est e ovest e dei tramezzi di divisione tra un ambiente e l’altro.
Il muro 2110+2014 che terrazza e delimita ambiente 1 rappresenta il perimetrale nord della cantina di am-biente 2. Esso è fondato direttamente sull’affioramento roccioso, il quale oltre ad essere utilizzato come base per la muratura (USM 2117) è stato pure regolarizzato come piano d’uso interno (2057). Il perimetrale sud (USM 2035) ha una apertura al centro, con stipiti regolari, (USM 2104) che permetteva il passaggio all’altra cantina che si trovava in ambiente 3 (figg. 55-56).
Al Periodo III dunque va attribuito il trattamento dell’affioramento roccioso che è stato livellato con stru-mentazione manuale. Su questo piano irregolarmente spianato sono state riconosciute sei piccole buche che potrebbero costituire altrettanti alloggiamenti per pali in legno, di funzione però incerta; solo la buca US 2077, al centro del vano, potrebbe essere stata utilizzata come alloggiamento di un pilastro ligneo posto a sostegno del solaio in legno del piano superiore, forse semplicemen-te un ballatoio. L’esistenza di un solaio o di un terrazzo interno è infatti documentata dalle buche pontate pra-ticate nel perimetrale est e, allo stesso livello, in quello nord. Da questa struttura lignea poteva scendere una scala in appoggio al perimetrale nord, e le tracce di im-pronte nella roccia del piano pavimentale nell’angolo nord-est del vano ne potrebbero confermare la presenza (fig. 57).
Periodo IVLa stratigrafia interna, in base ai materiali ceramici
recuperati, è interamente riferibile al Periodo IV, di fre-quentazione cistercense. Molto probabilmente la conti-nuità di funzione come cantina-magazzino ha permesso solo una minima crescita dei depositi, che solo nella fase finale d’uso si sono molto accresciuti, forse in corrispon-denza di una lenta defunzionalizzazione del vano.
Si tratta di livellamenti, anche con riporti di elevato spessore, avvenuti all’interno dell’ambiente durante l’ultima fase di utilizzo (US 2056, 2054, 2053) e dello strato di terra (US 2052) formatosi immediatamente pri-
ma del crollo principale della struttura. Questo deposi-to stratigrafico, sigillato dal successivo collassamento di USM 2007 (US 2050), è databile in base alle restituzioni ceramiche tra la fine del XIV secolo e la prima metà del successivo.
Periodo IV bIl crollo 2050 di una ampia porzione del perimetrale
ovest (USM 2007) ha comportato il definitivo abbando-no della cantina e molto probabilmente anche di quella di ambiente 3, dato che il collassamento della struttura ha coperto per metà l’accesso tra i due ambienti sotto-scavati (fig. 58). E’ in questo momento che una buona porzione dell’area dei magazzini viene defunzionaliz-zata, mentre l’unico vano ancora in uso sembra essere l’ambiente 4 trasformato poi in cucina. In questo stesso periodo crolla anche il perimetrale orientale USM 2018, con la deposizione di US 2044, costituita dalla struttura
collassata mista a terra. Il crollo in questione potrebbe rappresentare un lento depositarsi di parti di struttura; in esso sono infatti delle concentrazioni di laterizi, pie-tre e lastre di ardesia, miste a terra depositatasi tra gli in-terstizi dello spesso livello. Il dato interessante ci è dato dai materiali recuperati: si tratta di una alta quantità di esemplari di contenitori da mensa, da conserva e da fuoco che si collocano cronologicamente entro la prima metà del XV secolo. Potrebbe a questo proposito essere ipotizzato un uso dell’ambiente, ormai in parte crollato e abbandonato, come scarico di materiale e di rifiuti.
Periodo VI crolli successivi, sono scanditi nel tempo e risultano
datati in base alle ceramiche raccolte negli strati di terra depositati immediatamente sopra. E’ probabilmente su uno di questi depositi intermedi (US 2043) che si docu-menta la frequentazione delle truppe militari di Periodo V, testimoniando l’uso sporadico anche delle strutture ormai irrimediabilmente cedute E’ questo il primo livel-lo interno ad ambiente 2 che ha restituito una punta di verrettone in ferro. Il collasso del perimetrale nord (crol-lo 2029 di USM 2014) sigilla questa fase.
Periodo VIDel tramezzo sud (USM 2035) non si ha traccia del
crollo, molto probabilmente perché collassato per inte-ro nell’ambiente 3.
I livelli che coprono il crollo del perimetrale nord sono dei semplici strati di terra, mista a pietre di picco-le dimensioni, depositati all’interno del perimetro del vano ad opera dell’azione degli agenti atmosferici: US 2027, 2016 e 2005 sono scivolati in ambiente 2 dal corri-doio occidentale del chiostro; US 2001-2002 rappresenta lo spesso deposito di crollo superficiale che copre per
54. Area 2000. Vista della cantina dell’ambiente 2 a fine scavo. 55. Area 2000. Ambiente 2 in fase di scavo.
56. Area 2000. Perimetrale sud dell’ambiente 2.
104 105
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
intero l’area 2000 seguendo la pendenza del terreno (da nord verso sud); US 2000 è anch’esso un livello superfi-ciale perlopiù di humus.
3.3.3 Ambiente 4L’ambiente 4 ha avuto una storia costruttiva più arti-
colata in quanto la pianta quadrangolare originale, an-nessa ai magazzini di area 2000, nella fase cistercense è stata modificata con un netto ampliamento verso nord, fino ad appoggiarsi all’angolo sud-occidentale della chiesa abbaziale.
L’area occupata da ambiente 4 è inoltre quella che ha restituito chiare indicazioni archeologiche di frequenta-zione dei Periodi I e II.
Periodo ILa roccia affiorante scoperta nella metà sud circa del-
l’area, presenta tracce di usura da porre in relazione con una fase precedente alla costruzione del muro a spina- pesce relativo al monastero di Periodo II.
L’affioramento naturale (US 2367), in pendenza da nord a sud, risulta infatti intaccato per una buona parte dal taglio di fondazione US 2400 della struttura muraria residua di Periodo II USM 2404. Il taglio ha interessato anche lo strato 2399 che in origine doveva colmare un avvallamento nel profilo irregolare della roccia (figg. 59-60). La porzione centrale dell’affioramento risulta piuttosto ben lisciato, con molta probabilità dall’usura dovuta al calpestio; questo settore è delimitato verso est
57. Area 2000. Pianta dell’ambiente 2 a fine scavo.
da almeno quattro buche, di cui tre di forma allungata, scavate in asse nord-sud secondo la direzione dell’ipo-tizzato sentiero. Sul lato ovest il limite è determinato da una sorta di fossetta di cui non si è chiarita con certezza la funzione, forse una canaletta di scolo delle acque pio-vane (fig. 61).
Periodo IICon la costruzione di alcune nuove strutture, relative
all’istituzione del monastero, ricordato per la prima vol-ta nel 996, quella sorta di passaggio o sentiero ricavato sulla roccia naturale è stato bruscamente interrotto. E’ infatti in questo periodo che viene costruito un ambien-te, forse quadrangolare, di cui ci rimane testimonianza solo nella struttura muraria USM 2404, riutilizzata an-che nel successivo Periodo III (fig. 62). Come già sopra detto in premessa alla trattazione di ambiente 1, i rap-porti stratigrafici con i lacerti murari residui fanno pen-sare alla presenza di un edificio che doveva all’incirca occupare lo spazio immediatamente a sud della super-ficie rocciosa. La stratigrafia, quindi, relativa ai livelli di riporto e regolamentazione delle quote, in relazione al prospetto settentrionale della struttura, sono da riferirsi ad uno spazio esterno, comunque frequentato tra il pia-
noro roccioso dove si trovava la chiesa e gli edifici di un complesso monastico piuttosto semplificato. Gli strati documentati obliterano la superficie del calpestio di Pe-riodo I fino a regolarizzare l’area con l’ultimo riporto di terreno misto a frammenti minuti di ardesia (US 2352) che va a coprire la risega di fondazione USM 2405.
Periodo IIILa costruzione dell’intero corpo di fabbrica di Area
2000 va ad occupare col nuovo ambiente 4 uno spazio in precedenza esterno. L’intervento iniziale consiste nella stesura di una serie di riporti (US 2356, 2357, 2358), in appoggio alla struttura preesistente, tesi a regolarizzare il piano in cui verrà fondato il nuovo vano. Di ambien-te 4 di fase benedettina rimangono solo delle porzioni ridotte, inglobate nella ricostruzione di fase cistercense che ha portato al raddoppio dello spazio costruito. Esse consistono con molta probabilità nella porta di accesso verso il chiostro con pilastro di sinistra e la soglia, obli-terata in seguito dal rialzamento delle quote interne; nei filari residui di appoggio al perimetrale ovest di Periodo III.
All’interno del vano, pur tagliati dalla fondazione del perimetrale est e ovest di Periodo IV, sono stati docu-
58. Area 2000. Periodo IVb. Evidenza del crollo US 2050 del perimetrale occidentale dell’ambiente 2.
106 107
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
59. Area 2000. Periodo I. Affioramento della roccia naturale con tracce di levigatura e usura entro il perimetro dell’ambiente 4.
60. Area 2000. Periodo II. Taglio della roccia in posto per la costruzione dell’edificio di Periodo II in ambiente 4.
mentati cinque piani d’uso (USM 2355, 2350, 2351, 2346, 2280), tutti costituiti da terra battuta, più o meno com-patti, di poco spessore, con maggiori o minori concen-trazioni di sabbia o di frammenti di ardesia. Tutti i pa-vimenti individuati si appoggiano alla soglia originale dell’accesso USM 2406 (fig. 63).
Periodo IVPeriodo IV aAnche in questo contesto è risultato piuttosto difficile
determinare la consistenza stratigrafica delle fasi d’uso appartenenti al Periodo IV. Se infatti l’intervento di ri-costruzione successivo, in base ai materiali ceramici, è coevo all’iniziale fase di defunzionalizzazione degli ambienti 1 e 2, i livelli d’uso della prima fase cistercen-se risultano in buona parte intaccati e/o asportati. Per questo motivo la maiolica arcaica è stato il materiale ce-ramico che ci ha indirizzato all’attribuzione di periodo quando maggiormente difficoltosa era la sequenza re-lativa individuata. In questo caso tutti i battuti scavati,
sopra indicati, non hanno restituito nessun frammento di maiolica arcaica, mentre il primo livello in cui essa è documentata è il primo piano pavimentale in fase con i nuovi perimetrali (US 2324).
La ricostruzione dell’intero ambiente ha infatti com-portato l’asportazione di ampia parte di roccia affioran-te, in origine esterna al vano. La roccia in posto, che dal pianoro della chiesa scendeva verso sud e forse delimi-tava un passaggio tra l’esterno e il chiostro, risulta in-fatti asportata fino all’angolo sud-ovest della facciata e grossolanamente regolarizzata sia per creare l’appoggio alla fondazione delle nuove strutture, sia per determi-nare il piano su cui creare il battuto d’uso interno (fig. 64). In appoggio ad essa è stato in parte edificato il pe-rimetrale nord a cui, dall’esterno, andrà ad appoggiarsi la tomba 10 dell’area cimiteriale antistante la chiesa. Le porzioni ricostruite sopra l’edificio precedente causano invece il taglio dei livelli anteriori.
Il nuovo vano è reso omogeneo dalla stesura di un ampio battuto di terra (US 2243+2324) che va a coprire
61. Area 2000. Pianta delle evidenze del Periodo I nell’ambiente 4.
108 109
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
il precedente piano US 2280 (relativo alla fase benedet-tina) e il livello di asportazione della roccia. E’ questo il primo strato che restituisce maiolica arcaica e del tipo monocromo.
Nello spazio così ricreato si susseguono una serie di piani d’uso che coprono interamente il nuovo vano (US 2252; 2152=2156=2160=2158).
Periodo IV b Gli ultimi interventi strutturali operati dai Cistercensi
a S. Michele sono riferibili alle fasi finali di frequenta-zione del monastero da parte dei monaci.
Queste opere sono funzionali ad un ormai inarresta-bile declino del cenobio, che vede in questo stesso perio-do l’abbandono, a causa dei crolli delle strutture, delle cantine, di ambiente 1 e presumibilmente degli edifici ubicati nella fascia meridionale del pianoro (refettorio e dormitorio).
In questo contesto di lento abbandono di buona parte degli spazi del monastero, l’ambiente 4, in precedenza probabilmente usato come magazzino, risulta per ulti-mo trasformato in vano cucina.
Sull’ultimo livello pavimentale, formato da riporti di terra non regolari, sono costituiti almeno tre focolari strutturati con elementi in laterizio di riutilizzo: due ad-dossati al perimetrale sud USM 2406 e uno appoggiato al perimetrale orientale, il quale risulta coperto dalla co-struzione del muro a secco USM 2310+2311+2312 della fase successiva (figg. 65-66).
In relazione alla rinnovata funzione dell’ambiente va vista l’edificazione del forno da pane, individuato nel loggiato nord del chiostro (area 6000), in appoggio an-ch’esso al prospetto sud della chiesa.
La costruzione del forno ha determinato la riedifica-
62. Area 2000. Periodo II. Muro a spina pesce.
63. Area 2000. Periodo III. Soglia di accesso al chiostro e piano pavimentale interno dell’ambiente 4 (US 2346).
zione dell’angolo nord-orientale di ambiente 4. Si tratta di una struttura di forma circolare, pavimentata in mez-zane e coperta con cupola in mattoni, di cui si è identifi-cato il crollo (US 6017) e parte dell’attacco al pavimento (US 6018, 6019).
Periodo VDopo l’abbandono dell’ambiente 4 e l’obliterazione
del contesto dei focolari, successivamente al crollo par-ziale del tetto testimoniato nella porzione nord dallo strato US 2315, è stato costruito a secco un tramezzo con pietre di riutilizzo, all’incirca al centro del vano in sen-so est-ovest, che chiaramente aveva lo scopo di bloccare l’accumulo di crolli già evidente nella metà dell’ambien-te verso la chiesa.
Si presuppone a questo proposito un intervento di Pe-riodo V inteso alla conservazione di un ulteriore spazio libero dai già invadenti crolli delle strutture utilizzato dai soldati (fig. 69).
3.4 iL monAstero neLLe sue PArti: iL Chiostro e L’uso deLLe risorse idri-Che (AreA 3000) (A.A.)
Il cortile al centro del cenobio ha una forma rettango-lare di 13 x 25 m circa. Il piano, leggermente in penden-za verso sud, è delimitato nella porzione settentrionale dalla grande cisterna e dall’affioramento roccioso che, sull’allineamento della struttura idrica, risulta model-lato a forma di gradini grossolani tesi a regolarizzare il sottostante calpestio del chiostro. Lo stesso chiostro è delimitato nei lati est, sud e ovest da un muro in pie-tra di cui si conserva una altezza dai 30 cm a 1 m circa (della porzione vicina alla cisterna). Si tratta del cordolo di base dei pilastri che dovevano scandire il percorso dei corridoi e su cui si appoggiavano i travi in legno del tetto del loggiato. Dei pilastri non si è trovata trac-cia nei livelli di crollo che in parte hanno coperto anche l’area del cortile. Con tutta probabilità doveva trattarsi
64. Area 2000. Periodo IV. Pianta della fase di ricostruzione dell’ambiente 4.
110 111
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
65. Area 2000. Periodo IVb. Focolare nell’ambiente 4 (US 2157).
66. Area 2000. Pianta della fase d’uso dell’ambiente 4 usato come cucina dei monaci (Periodo IVb).
di strutture costruite in conci di verrucano, forse pilastri a sezione quadrangolare, che il cedimento del tetto ha semplicemente disgregato.
La stratigrafia scavata entro i perimetrali del chiostro si riferisce quasi esclusivamente ai Periodi IV-V. In effet-ti la conservazione delle quote di calpestio in relazione ai muri di delimitazione dell’area e soprattutto dei piani ricavati dalla roccia affiorante, ha necessariamente com-portato un lento e regolamentato deposito, che ha avu-to un aumento di volume solo nelle ultime fasi d’uso, meno strutturate.
Se la costruzione delle strutture (cordoli dei loggia-ti e cisterna) vanno assegnati al Periodo III, le fasi di frequentazioni del periodo monastico che sono state documentate sono da ricondurre alla fase cistercense (Periodo IV), mentre poco evidenti risultano le tracce di frequentazione del Periodo V e VI (fig. 70).
Le strutture relative alla raccolta e conduzione del-l’acqua sono quasi tutte concentrate all’interno del peri-metro del chiostro centrale (fig. 71).
Come in tutti i monasteri la scelta del luogo dove far sorgere un nuovo ente era essenzialmente legata alla possibilità di creare una comunità autosufficiente e nel-la quale ci fosse la possibilità, come enuncia la Regola di S. Benedetto, di avere a disposizione soprattutto l’ac-qua20.
La facilità nell’approvvigionamento dell’acqua è quindi uno dei requisiti essenziali per la vita del ceno-bio. L’acqua non serviva infatti solo per bere ma per preparare il cibo, per lavare, per le attività produttive ed era necessaria, nella sua purezza, anche per i riti li-turgici. La difficoltà nello sfruttamento o addirittura la mancanza d’acqua sono stati spesso la ragione dell’ab-bandono di un insediamento monastico21.
La posizione di S. Michele rispetto ai corsi d’acqua è piuttosto distante, anche se il Monte Pisano è per sua natura terra ricca di sorgenti. La carta geologica attual-mente ne indica almeno tre nell’area immediatamente a sud del sito22, mentre nella Cartografia IGM meno recente una di esse era segnalata circa a un chilometro in linea d’aria a sud-ovest del monte Lombardona23, a monte quindi dell’abbazia .
I monasteri fondati nel medioevo sul Monte Pisano, o alle sue pendici, occupano tutti una posizione favorevo-le per l’uso delle risorse idriche del luogo24. S. Salvatore di Sesto sorgeva sulla sponda sinistra del lago di Sesto, nei pressi della foce del torrente Visona, che scende an-cora oggi dalle colline del Compitese. La località Badia, nei pressi di Buti, dove sorgeva il cenobio di S. Stefano di Cintola, ha segnalato due sorgenti a nord e a sud del sito, ed inoltre sorge sulla riva sinistra di un torrente che nascendo dal vicino Colle Volpaio si getta nel sot-
tostante Padule, ex lago di Sesto. S. Andrea in Silva e S. Iacopo in Lupeta sorgono rispettivamente sulla sinistra e sulla destra del Rio Piantoneta, e immediatamente a nord di S. Iacopo è segnalata una sorgente nominata “fonte Lupeta”. S. Salvatore di Cantignano sorge sulla riva destra di un torrente. Una sorgente è ancora segna-lata immediatamente a nord del complesso del Mirteto. Di S. Paolo di Pugnano, a poca distanza dalla riva sini-stra del fiume Serchio, esiste la documentazione scritta dell’impegno che le badesse dedicavano all’approvvi-gionamento idrico del monastero: il 3 maggio 1172 vie-ne concesso in perpetuo al monastero, dai proprietari di alcune terre in Pugnano, il diritto di condurre l’acqua da Civitone attraverso le loro proprietà; ancora il primo no-vembre 1172 la servità dell’acquedotto viene accordata da altri proprietari di terre25.
Della maggiore difficoltà nell’approvvigionamento idrico di S. Michele potrebbe esserne testimonianza la grande cisterna individuata nell’angolo nord-orientale del chiostro.
La cisterna (fig. 72.1, 72.2), di forma rettangolare, mi-sura 5,70 x 3,20 m.; è stata impiegata una tecnica costrut-tiva che utilizza bozze di verrucano di piccole e medie dimensioni, rivestite da un intonaco idraulico, struttura a sacco con un paramento interno, murato contro il ta-glio nella roccia a cui si lega la volta della cisterna ed uno esterno, con la fondazione scavata nell’affioramen-to naturale usato come piano di calpestio del chiostro. In essa confluivano le acque piovane provenienti dalle falde della copertura della chiesa e dei loggiati del chio-stro. Il pavimento, scoperto solo con un saggio in pro-fondità di 1,50 x 2 m nel deposito di crollo, è costituito da uno strato di cocciopesto, simile per colore e compo-nenti all’intonaco che riveste le pareti, ma leggermente più grossolano (fig. 73). Dall’attacco della volta al pavi-mento la profondità della cisterna supera i due metri.
Nel riempimento, costituito essenzialmente dal crol-lo delle strutture circostanti, era anche una macina (fig. 74). Lo strato di copertura del pavimento, che poi rap-presenta il primo strato depositatosi nella cisterna pri-ma dei successivi riempimenti, ha restituito esemplari di maioliche arcaiche pisane databili tra la fine del XIV secolo e i primi del successivo, confermando quindi il precoce inizio della defunzionalizzazione anche della cisterna.
Da questa struttura si dipartiva il sistema principale di conduzione delle acque verso gli altri ambienti del monastero.
Per permettere l’afflusso dell’acqua nelle canalette doveva essere impiegato un sistema di vuoto-pieno per cui quando l’acqua della cisterna raggiungeva un deter-minato livello era incanalata verso l’esterno in almeno il
112 113
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
primo pozzetto (US 3168) ricavato ritagliando in modo più o meno regolare la roccia affiorante circostante (US 3153). Da qui, con lo stesso sistema, l’acqua si inseriva in due distinte canalette: l’una raggiungeva il loggiato me-ridionale e presumibilmente il refettorio dei monaci (fig. 75); l’altra correva lungo il limite orientale del chiostro fino ad inserirsi nel loggiato est (fig. 76).
La prima canaletta che correva in direzione nord-sud in pendenza verso gli ambienti meridionali era costrui-ta in due modi differenti. Il primo tratto, fino quasi al centro del chiostro, è ricavato tagliando l’affioramento naturale. L’acqua esondando dal primo pozzetto dopo un breve tratto (US 3139) si gettava in una seconda buca (US 3308), forse di ulteriore decantazione, e infine si in-canalava nella struttura principale costruita tagliando la roccia (US 3307) e delimitando il taglio con due filari paralleli di bozze in pietra (US 3309). Il fondo non ri-sulta rivestito. Nella porzione ricavata nel deposito ar-cheologico, tagliando cioè gli strati d’uso a partire da US 3303 e 3154, la conduttura è caratterizzata da cordoli in pietra che contenevano tubuli in terracotta, dei quali ne sono stati ritrovati intatti sei esemplari, ancora inse-riti l’uno nell’altro e isolati con argilla (fig. 77). I tubuli si inseriscono nella conduttura ricavata entro il muretto di delimitazione sud del chiostro. Il loggiato meridionale è stato indagato solo superficialmente e quindi si può solo ipotizzare la presenza della canaletta sotto il piano di calpestio del corridoio fino all’ingresso nel vano del refettorio. In questo settore è stato praticato uno scavo in profondità per verificare il deposito archeologico con-servato e il tipo di strutture presenti. Anche in questo caso, come per l’Area 2000, l’ambiente è sottoscavato e a causa del crollo delle strutture in alzato si è persa trac-cia dei piani d’uso del refettorio e quindi dell’eventuale connessione della canaletta del chiostro con la funzione dell’ambiente.
I confronti con altri contesti simili scavati e con le piante di altri cenobi cistercensi farebbero pensare alla presenza di una qualche struttura in cui si utilizzava l’acqua della cisterna. Nella disposizione canonica degli spazi di un monastero cistercense26 viene detto che nel corridoio “iuxta refectorium”, in genere di fronte alla porta di accesso, si trova un “padiglione della fontana” con i lavandini. Le indagini archeologiche nel refettorio dell’abbazia di Fossanova confermano l’assetto indica-to27. Tra la fine del XII e i primi del XIII secolo i Cistercen-si, insediatisi nel monastero dal 1130, operano una serie di importanti modifiche tra le quali la ricostruzione del refettorio. Lo scavo ha documentato a questo proposito la presenza di condutture di adduzione e di scarico nel-la zona centrale della sala che attestano la presenza di una piccola fontana.
67. Area 6000. Periodo IVb. Forno da pane.
68. Area 6000. Pianta del forno da pane.
La seconda canaletta del chiostro di S. Michele (US 3164+3112) era anch’essa, come la prima, ricavata nel terreno con filari in pietra come delimitazione, mentre il tratto iniziale (US 3306) era ritagliato nell’affioramento naturale e si collegava al primo pozzetto di decantazio-ne. Dal primo pozzetto esterno alla cisterna l’acqua si incanalava in una serie di tagli regolari nella roccia in direzione est, verso il muretto di delimitazione del log-giato orientale; adiacente alla struttura muraria iniziava la canaletta strutturata che correva in direzione nord-sud fino a raggiungere l’angolo sud-est del chiostro. An-che in questo primo tratto dentro la canaletta dovevano trovarsi tubuli di conduzione in terracotta che sono stati raccolti solo in piccoli ma numerosi frammenti. Nella porzione iniziale, a fianco della cisterna, a questa stessa conduttura si collegava un altro taglio regolare nella roc-cia (US 3164) che partiva dall’angolo nord-est compreso tra il muretto orientale del chiostro e il perimetrale sud
della cisterna. Si tratta molto probabilmente del canale di scolo delle acque piovane che venivano convogliate in quel punto da un gioco di pendenze delle coperture dei loggiati.
La canaletta US 3164+3112 è passante entro l’angolo del chiostro, con un evidente innesto che ha provocato la modifica della struttura che quindi risulta precedente al raccordo, e si collega con una ulteriore struttura di conduzione, molto più grande e costruita con tecnica diversa. Si tratta di un canale (US 3297) che attraversa il loggiato est in modo longitudinale rispetto ai perime-trali e si innesta nel prospetto ovest della Sala Capitola-re (Area 4000) che risulta costruito contemporaneamen-te almeno in questa porzione, e continua il suo percorso (US 4159) in pendenza appoggiandosi allo stesso muro lungo il suo prospetto interno. La conduttura è costitui-ta da due filari di conci anche di riutilizzo e pavimen-tata con regolari lastre di ardesia. In questo caso è stata rinvenuta intatta anche la copertura di lastre di diverse dimensioni (figg. 78.1, 78.2, 78.3).
Non si conosce ancora con certezza la funzione di questa conduttura e neppure il suo percorso completo, perché la parte più meridionale del corpo di fabbrica della sala capitolare non è stato scavato per necessità di transito del mezzo meccanico. Anche in questo caso però i confronti con le piante di altri monasteri, anco-ra cistercensi, e con documentazione di scavo edita, ci confortano nel formulare ipotesi verosimili.
Facendo ancora ricorso alle descrizioni della pianta-tipo di un monastero cistercense, nella parte all’estremo sud dell’edificio orientale, quello della Sala Capitolare al piano terra e dei dormitori al primo piano, al di sopra di un canale di scolo, si trovano le latrine (“necessaria dor-mitorii”)28. La descrizione è perfettamente illustrata, in base ai dati archeologici, nella ricostruzione degli edifici orientali dell’abbazia di Valle Crucis in Inghilterra29.
In effetti la maggiore portata d’acqua dell’ultimo trat-to della struttura di conduzione potrebbe far pensare anche ad una ulteriore raccolta grazie alla possibilità di convogliare l’acqua piovana nell’angolo sud-est dei log-giati del chiostro.
Nella fase finale d’uso del chiostro da parte dei mo-naci di S. Michele si documenta un’importante modifica delle funzioni attribuite fino a quel momento al settore centrale del monastero. Se nel periodo di piena attività del cenobio il chiostro era utilizzato come spazio comu-ne e con funzionalità specifica nell’organizzazione dello sfruttamento delle risorse idriche disponibili, nella fase finale della presenza monastica il chiostro assume una funzione di area cimiteriale. Negli ultimi livelli d’uso del cortile, precedente all’abbandono e ai crolli delle strutture, sono state rinvenute due sepolture in connes-
69. Area 2000. Periodo V. Tramezzo costruito a secco che suddivide l’ambiente 4.
114 115
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
70. Pianta generale del chiostro con l’evidenza del sistema di conduzione idrica.
72. Area 3000.(72.1. e 72.2. Cisterna).
73. Area 3000. Pavimentazione della cisterna. 74. Area 3000. Riempimento della cisterna.
71. Sezione Est-Ovest del chiostro.
1 2
116 117
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
sione e resti di inumazioni privi di connessione anato-mica (vedi Sbarra infra).
Questa situazione è il segno univoco della cessazione dell’uso anche delle strutture di conduzione dell’acqua potabile.
Se le sepolture in connessione (T. 20 e 21) sono de-poste in fosse che tagliano i piani d’uso 3129 e 3151, le rideposizioni sconnesse sono invece deposte in buche irregolari nello strato US 3015 di copertura della fase di inumazioni precedente. In effetti sembra che ad una pri-ma rifunzionalizzazione in senso cimiteriale del chiostro ne sia seguita un’altra, non strutturata, definitivamente obliterata dallo strato US 3012 che insiste ancora entro i perimetrali del quadrilatero del chiostro (fig. 80). E’ questa la stessa fase d’uso documentata anche nel log-giato orientale, dove al di sopra delle tombe a cassa ora-mai definitivamente sigillate si impostano una serie di sepolture in fossa terragna successivamente coperte dai
livelli d’uso del Periodo V (vedi Sbarra infra).In effetti questa ultima fase di frequentazione dei mo-
naci, prima del definitivo abbandono e dell’occupazione militare, si colloca come per le altre aree indagate entro la metà del XV secolo. L’alta frammentarietà dei mate-riali ceramici e la grande quantità degli stessi esemplari computati sono indicatori della natura del deposito do-cumentato: si tratta di spessi strati di riporto evidente-mente prelevati nei pressi o in aree interne al monastero, forse una zona di discarica ricca di ceramica frammen-tata. Si potrebbe pure ipotizzare che il riporto di questi spessi strati di terreno fosse funzionale alla creazione di orti interni al perimetro del chiostro, trasferiti dall’area orientale, compresa tra la cinta e il complesso, per avvi-cinarli agli ambienti intorno alla chiesa oramai gli unici utilizzati dai pochi monaci rimasti.
L’indicazione cronologica che ci restituiscono le cera-miche raccolte in questi livelli data tra la metà del XIV e
75. Area 3000. Chiostro.(75.1. Tubazione fittile della canaletta centrale; 75.2. Elemento fittile della canaletta centrale;
75.3. Canaletta che corre lungo il perimetro est del chiostro).
1
3
2
la metà del XV secolo, essendo rappresentati, gli esem-plari più recenti, da non molti frammenti di contenitori prodotti in area fiorentina: zaffera a rilievo e italo-mo-resca. Per il resto si tratta di un alto numero di “maio-liche arcaiche”, soprattutto monocrome, e di pareti di contenitori nudi depurati che perlopiù si riferiscono ad esemplari di brocche di diverse dimensioni, monoansa-te e trilobate.
L’occupazione militare dei Pisani prima e dei Fio-rentini poi non ha lasciato tracce evidenti nel chiostro. Innanzitutto va sottolineato il fatto che l’area era quasi priva di crolli al momento dello scavo, se non per la por-zione nord-orientale, dove rimanevano parti del tetto e delle strutture del loggiato est collassate anche nel chio-stro. In effetti i crolli più consistenti degli ambienti che si affacciavano sul chiostro sono collassati su se stessi (ambiente 2 e 3 di Area 2000), verso sud (area 7000) e nei loggiati (area 4000). D’altra parte però la necessità di conservare un’ampia area aperta potrebbe aver indotto i militari a liberare buona parte dei piani dagli eventua-li depositi di macerie. Lo spazio al centro del cenobio rimase quindi libero dall’ingombro delle macerie degli edifici crollati e maggiori sono stati dunque gli interven-ti di epoca moderna che possono aver intaccato i depo-siti più antichi. A questo proposito vanno segnalate la serie di buche di incerta funzione (per il rimboschimen-to?) documentate e scavate (US 3016, 3020, 3023) e attri-buibili al Periodo VI.
Gli strati più superficiali US 3000, 3002 e 3003 sono stati inoltre scavati col mezzo meccanico per la necessità
di individuare il perimetro del chiostro prima della fine della campagna 1998, con la possibile conseguenza di alcune incertezze nell’attribuzione del materiale raccolto.
Gli elementi che in altre aree dello scavo sono dia-gnostici per l’attribuzione al contesto di Periodo V nel chiostro sono quasi assenti.
Innanzitutto rispetto alla grande quantità di oggetti metallici riferibili a parti di armi in dotazione alle trup-pe, gli strati del chiostro ne restituiscono una minima parte e solo nei livelli 3012 e 3015. Se per US 3012 è pos-sibile sostenere che all’arrivo delle guarnigioni questo stesso piano d’uso fosse ancora in vista e quindi almeno in una prima fase utilizzato anche dai nuovi occupanti, più incerta è l’attribuzione di due punte di verrettone e una di lancia nel livello 3015. E’ comunque verosimile pensare che già dalla fine del XIV secolo l’assidua pre-senza delle truppe pisane al castello della Verruca abbia determinato un consolidato rapporto di “buon vicina-to”. La stessa presenza di una punta di verrettone nella stratigrafia del cimitero esterno alla chiesa può suppor-tare questa ipotesi.
3.5 iL monAstero neLLe sue PArti: iL LoggiAto orientALe (A.A.)
Il corridoio che corre sul lato est del chiostro, e sul quale si affacciano gli ambienti più importanti del mo-nastero (la sagrestia e la sala capitolare) è in questa sede trattato più approfonditamente nel suo aspetto di spazio con funzione cimiteriale, che assume fin dalla costruzio-
76. Area 3000. Vista generale del chiostro. 77. Area 3000. Canaletta al centro del chiostro che conduceva l’acqua dalla cisterna al refettorio.
118 119
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
78. Area 3000. Loggiato est.(78.1. Canaletta che dal chiostro, attraverso il loggiato orientale, si collega con la conduzione che corre lungo il perimetrale interno della sala capitolare per raggiungere,
presumibilmente, le latrine del monastero; 78.2. La conduttura lungo il perimetro interno della sala capitolare (Area 4000);78.3. Canaletta di Area 3000. L’inserimento nel perimetrale della sala capitolare.
1 2
3
ne romanica del cenobio (vedi Sbarra infra per i Periodi III e IV) (fig. 81.1, 81.2 - 82.1, 82.2).
In riferimento al Periodo V della periodizzazione an-che il loggiato mostra evidenti tracce di frequentazione. Dopo l’abbandono del complesso da parte dei monaci, in questo settore documentato attraverso l’obliterazione definitiva dell’area cimiteriale, anche nelle ultime mani-festazioni di sepolture e rideposizioni in fossa terragna, lo spazio antistante l’accesso alla sagrestia mostra chiari segni d’uso.
Gli strati di riporto (US 3190-3195) composti da terra e frammenti di ardesia, sono intervallati da una serie di focolari, non strutturati, che hanno restituito ceramica da fuoco e da mensa, relativi all’occupazione molto pro-babilmente pisana del monastero (fig. 83).
Prima del crollo dei prospetti principali della sagre-stia e della Sala Capitolare anche il loggiato, dunque, è frequentato dai soldati di stanza a S. Michele, tra l’atro in una posizione piuttosto ben riparata e difendibile, in-serita tra il perimetrale est della cisterna e il transetto meridionale.
3.6 iL monAstero neLLe sue PArti: LA sALA CAPitoLAre (AreA 4000) (A.A.)
Il corpo di fabbrica orientale, con accessi sul loggia-to est del chiostro centrale, corrisponde all’edificio che comprendeva la sala capitolare e la sagrestia, dunque gli spazi più importanti del monastero.
L’indagine archeologica ha concluso lo scavo della
79. Planimetria del monastero con l’indicazione delle principali condutture idriche.
120 121
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
sala del capitolo, mentre nessun intervento è stato pre-visto nel vano sagrestia, in appoggio al transetto meri-dionale della chiesa, per motivi di staticità del perime-trale est e del transetto (fig. 84).
Periodo IILa stratigrafia documentata entro i perimetrali della
Sala Capitolare attesta fasi di frequentazione preceden-ti alla costruzione degli edifici di Periodo III, probabil-
mente in relazione al monastero pre-romanico. I perimetrali est e ovest, a differenza del tramezzo
4050 che taglia la roccia con la sua fondazione, si impo-stano su un deposito stratigrafico precedente alla loro costruzione, causando il taglio dei livelli preesistenti con le fosse di fondazione (US 4194 e 4198) che corrono parallele e strette lungo gli stessi perimetrali. Gli stra-ti tagliati dall’edificazione del capitolo si riferiscono ad una serie di livelli di terra successivi (US 4191, 4192, 4199, 4200, 4202, 4203, 4211, 4212), in alcuni casi coevi, che vanno a colmare la differenza di quota con la roccia in posto (US 4065) che nella porzione nord della sala è usata per la fondazione del perimetrale settentrionale e in parte risulta levigata anche se non perfettamente. In questi riporti sono state ricavate tre fosse per sepoltu-re, che in successione (t. 19, t. 23 e t. 24) hanno accolto una deposizione in fossa terragna (per la t. 23 e 24) con copertura di lastre di ardesia di piccole e medie dimen-sioni. La tomba più antica (t. 19) è quella che riutilizza la roccia affiorante come delimitazione e spalletta per la copertura seguendo, come per le altre, la direzione in lunghezza nord/ovest-sud/est (vedi Sbarra infra) (fig. 85).
La formazione degli strati, l’assenza di piani d’uso ri-conoscibili, ci restituiscono informazioni per la ricostru-zione delle fasi di frequentazione di un’area esterna, con funzione cimiteriale forse in rapporto ad un edificio che il cantiere romanico ha completamente asportato e di cui potrebbero rimanere labili tracce nel prospetto inter-no del perimetrale nord della sala.
Periodo IIILa costruzione del corpo di fabbrica orientale rientra
nella riorganizzazione e progettazione del monastero romanico di XII secolo.
Le evidenze documentabili per il periodo riguardano solo la disposizione, presunta, degli ambienti originali, mentre anche in questo caso i piani d’uso documentati, anche in lacerti, appartengono verosimilmente al pe-riodo cistercense, quando il cantiere di modifica degli spazi ha causato l’asportazione dei pavimenti originali. In questa fase l’edificio era probabilmente composto da due soli vani, divisi al centro dal muro USM 4050, rin-venuto a livello di rasatura (US 4099) in riferimento al Periodo V della periodizzazione.
L’intero corpo misura all’incirca, dato che la porzione meridionale non è stata riportata in luce, 33 metri dal prospetto del transetto meridionale della chiesa al li-mite interno del muro claustrale, per una larghezza di circa 5 m. Nella fase benedettina i due vani misuravano 15,40 m e 17,60 m.
80. Area 3000. Pianta della fase cimiteriale del chiostro. Le sepolture indicate non sono in fase ma localizzate per determinarne la distribuzione.
82. Area 3000. Loggiato est(82.1. Particolare della porta di accesso alla sagrestia che si affaccia sul loggiato orientale. 82.2. Il transetto meridionale nel loggiato est).
81. Area 3000. loggiato est.(81.1. L’area cimiteriale dei monaci nel loggiato orientale; 81.2. Il loggiato in fase di scavo. Evidenze di Periodo V).
1 2
1 2
122 123
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
Periodo IVNella riorganizzazione degli spazi operata dai Cister-
censi dopo il loro arrivo a S. Michele, il corpo di fabbrica orientale è quello che, all’interno dello spazio monasti-co ha subito maggiori interventi strutturali. In questo periodo infatti si opera una sorta di suddivisione dello spazio edificato che vede la costruzione di un ulteriore vano ricavato nella porzione meridionale di quella che in origine doveva essere la sagrestia.
L’ambiente quadrangolare è costituito da un nuovo perimetrale nord e dai perimetrali est, sud e ovest che vanno ad appoggiarsi ai preesistenti muri (fig. 86-87). Questa sorta di raddoppio e rifasciatura delle struttu-re murarie può essere funzionale al rafforzamento del-le strutture portanti per la modifica apportata al piano elevato e nello stesso tempo per la costruzione di una
scala in legno, di cui per altro rimangono buche regolari nel prospetto interno del perimetrale nord, che doveva condurre al piano superiore, riservato ai dormitori dei monaci. L’intervento è stato coevo alla ricostruzione di parte del livello superiore che ha visto l’uso predomi-nante del laterizio, come testimonia la grande quantità di mattoni recuperati nei crolli della struttura deposi-tatesi nel loggiato sottostante. Il cantiere per la costru-zione del vano scale ha causato l’asportazione di tutti i livelli preesistenti e la rimodellazione della roccia in posto che nel nuovo ambiente ricavato è resa irregolar-mente orizzontale ed in essa sono anche praticate una serie di buche (US 4117, 4120) strutturali all’impianto della scala.
All’interno della Sala capitolare sono stati individuati solo due lacerti pavimentali (US 4092, 4095), per altro
83. Area 3000. Periodo V. Tracce di focolari nel loggiato orientale.
84. P
lani
met
ria g
ener
ale
dell’
Are
a 40
00.
124 125
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
piuttosto compromessi, costituiti da lastre di ardesia di medie dimensioni, regolari nell’appoggio al prospetto interno del perimetrale ovest e al tramezzo nord USM 4050 (fig. 88).
L’appartenenza di questi piani d’uso al periodo ci-stercense, pur nell’assenza di materiale diagnostico che ci guidi nella datazione, è confermato dalla stratigrafia. In effetti essi sono coperti direttamente dai crolli del pe-rimetrale (US 4090).
Periodo VL’ultima fase di permanenza dei monaci a S. Miche-
le corrisponde, come visto, ad un parziale abbandono
degli edifici meridionali del complesso e ad una rifun-zionalizzazione degli ambienti vicini alla chiesa. Anche la Sala Capitolare sembra subire la stessa sorte; proba-bilmente in quel periodo parte dei piani superiori col-lassano all’interno dell’edificio, facendo crollare com-pletamente il tramezzo compreso tra la Sala e il vano scale. Questa evidenza sembra confermata dai livelli di frequentazione del Periodo V.
Nella fase di riduzione a fortificazione temporanea dell’abbazia, l’area 4000 è liberata dai crolli interni e il tramezzo 4050 risulta perfettamente rasato al piano del calpestio e in seguito coperto con una serie di riporti di terra che hanno determinato i piani d’uso interni. L’oc-
85. Area 4000. Periodo II. Sepolture della fase pre-romanica.
86. Area 4000. Periodo IV. Rifasciatura per la costruzione del vano scale.
87. Area 4000. Scorcio della sala capitolare con i piani d’uso ricostruiti dai militari dopo l’asportazione dei crolli del vano scale.
88. Area 4000. Periodo V. Rasatura del muro di suddivisione tra la sala capitolare e il vano scale.
126 127
L’indagine archeologica del monastero di San Michele alla Verruca: la periodizzazione della sequenza insediativa Sauro Gelichi, Antonio Alberti, Massimo Dadà
cupazione militare ha quindi riutilizzato la Sala Capito-lare, probabilmente priva del tetto ma con i perimetrali in alzato, essenzialmente nella porzione nord del corpo di fabbrica, compreso lo spazio del vano scale.
3.7 iL monAstero neLLe sue PArti: i sAggi neLL’AreA 5000 (A.A.)
L’area compresa tra l’abside della chiesa abbaziale e il muro di cinta del monastero, identificata come spazio aperto funzionale molto probabilmente alla presenza di orti e di attività artigianali interne al monastero, è sta-ta oggetto di indagini mirate a campione nell’intento di verificare la quantità e la qualità del deposito archeolo-gico conservato.
Il saggio I localizzato a ridosso dei resti della cinta muraria ha permesso di documentare i modi di costru-
zione del muro claustrale. Se l’alzato, conservato per uno o due filari, era costruito con pietre solo sbozzate, con facciavista e sacco interno, la fondazione era costi-tuita dalla roccia in posto, sagomata a gradoni (fig. 88).
Il saggio II ha inteso verificare la consistenza del de-posito accumulato nello spazio dove si trovava il cam-panile della chiesa.
L’asportazione solo parziale e con mezzo meccanico dell’accumulo, evidente in appoggio alla parete est del transetto meridionale, ha permesso di recuperare le co-lonne delle bifore del campanile stesso e di documenta-re ampie porzioni di muratura ancora legate e collassate sul posto.
Il saggio III, a fianco del transetto nord, lungo la stra-da che conduce a valle, ha restituito tracce in sezione di cordoli in pietra probabilmente riferibili a suddivisioni interne degli orti dei monaci.
89. Saggio I nell’Area 5000.
note1. Le indagini archeologiche e le ricognizioni hanno visto la parte-
cipazione di circa 250 tra studenti delle Università di Parma, Pisa e Ca’ Foscari Venezia e di volontari dell’Archeoclub d’Italia, sede di Pisa. Lo scavo è stato effettuato in regime di concessione mi-nisteriale e con il supporto economico dei Comuni di Vicopisano e Calci, dell’Archeoclub sede di Pisa, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pisa.
2. E’ stato valutato il rapporto dei tempi e dei costi di uno scavo del genere con il tipo di informazioni che se ne sarebbero potute ri-cavare: ferma restando l’importanza del campione antropologico, abbiamo ritenuto che quello già indagato nella zona dei loggiati fosse sufficiente.
3. ALberti-geLiChi 1998, pp. 117-125; geLiChi et al. 2000, pp. 336-356; geLiChi-ALberti-sbArrA 2002, pp. 86-95; geLiChi-ALberti 2002, pp. 293-298.
4. Il tipo di apparecchiatura e la qualità dei materiali utilizzati trovano confronto con murature simili in area lucchese datate tra la fine del X e l’XI secolo: quirós CAstiLLo 2002, p. 94.
5. siroLLA 1990, n. 78, pp. 170-171.
6. CAturegLi 1938, n. 421, pp. 283-289.
7. Ibid.
8. La definizione strutturale del monastero e il suo sviluppo architet-tonico-urbanistico sono il risultato di un lungo processo che rag-giunge la sua maturazione nel corso dell’VIII secolo, per arrivare a quella sorta di codificazione dell’organizzazione spaziale e strut-turale di un cenobio benedettino che è rappresentata dalla pianta di S. Gallo. La pianta è databile con precisione in quanto risulta inviata all’abate Gotberto che resse l’abbazia tra l’816 e 837. Si veda a questo proposito horAt 1991, p. 185; ourseL 1985, pp. 89-91; mA-CALLi 1974, col. 34.
9. mouLin 1991.
10. Quando il nuovo fratello sarà accettato dalla comunità dimorerà nella parte del monastero riservata ai novizi, dove questi studiano, mangiano, dormono: biAnChi 2001.
11. mACALLi 1974, col. 30; biAnChi 2001.
12. Cfr. Vongrey 1974, coll. 1037-1041.
13. benVenuti 1994, pp. 26-41.
14. mACALLi 1974, coll. 43-44.
15. Ibid.
16. horAt 1991, p. 186.
17. ourseL 1985.
18. Vongrey 1974, coll. 1037-1041.
19. bond 2001, p. 61.
20. biAnChi 2001.
21. bond 2001.
22. mAzzAnti 1994.
23. Si ringrazia Marcello Cosci per la segnalazione.
24. Le considerazioni che seguono nel testo si basano sulle informa-zioni desumibili dalla Carta degli Elementi Naturalistici e Storici della pianura di Pisa e dei rilievi contermini, in allegato al volume di mAzzAnti 1994.
25. CArmignAni 1965-1966, n. 1 e 7.
26. Vongrey 1974, coll. 1034-1058.
27. CoCCiA-fAbiAni 1997, pp. 55-86.
28. Vongrey 1974.
29. greene 1992, p. 8.

































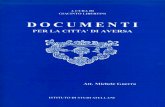





![La carestia del 1346-47 nell'inventario dei beni di un monastero del contado aretino [RSA 1970-2]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6318fa72e9c87e0c090fe974/la-carestia-del-1346-47-nellinventario-dei-beni-di-un-monastero-del-contado-aretino.jpg)