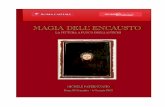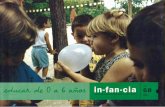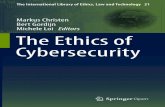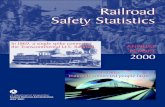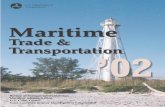Michele la Rosa e l'ipotesi balistica.
Transcript of Michele la Rosa e l'ipotesi balistica.
MICHELE LA ROSA E L’IPOTESI BALISTICA
LEDO STEFANINI, Università di Mantova
RIASSUNTO
Michele La Rosa (1880- 1933) , fisico di valore sia come sperimentatore che come teorico, è passato alla storia della
fisica italiana come inflessibile nemico della teoria della relatività di Einstein, almeno come veniva interpretata negli
anni ’20 del secolo scorso. La realtà è che egli non si arrese mai ad un postulato – quello dell’invarianza della velocità
della luce – che sentiva come ripugnante all’intuizione. Cercò quindi nell’ipotesi balistica di Ritz una spiegazione della
natura delle stelle doppie che fosse conforme ai principi della fisica classica e tentò anche di applicarla per dare base
teorica alla relazione tra magnitudine e periodo delle Cefeidi, scoperta empiricamente da Miss Leavitt all’inizio del
secolo.
1. STELLE BINARIE E IPOTESI BALISTICA
Negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione della prima memoria di Einstein1
1 Einstein, Albert (1905), «Zur Elektrodynamik bewegter Körper» in Annalen der Physik 17 , pp. 891-921
venne avanzata una teoria che sosteneva valere per le onde elettromagnetiche la legge galileiana di
composizione delle velocità. Il fatto che la velocità della sorgente si componga con quella della
luce, va sotto il nome di «ipotesi balistica» ed è comunemente legata al nome di Walther Ritz che la
espose in una comunicazione congiunta con Einstein2
2 Einstein, Albert, Ritz, Walter ( 1909), «Zum gegenwärtigen Stand des Strahlungsproblems», Physikalische Zeitschrift,
10 Jahrgang, No 9, pp. 323-324.
Nel 1913 l’astronomo De Sitter3, riprendendo idee proposte da Comstock
4 e da Tolman
5
3 De Sitter, Willem (1913), «Ein astronomischer Beweis für die Konstanz der Lichgeshwindigkeit»,
Physik. Zeitschr. 14, 429.
4 Comstock, Daniel F. ( 1910), «A Neglected Type of Relativity», Phys. Rev., 30, 267.
5 Tolman, Richard C. (1910), «The Second Postulate of Relativity», Phys. Rev., 30, 291..
qualche anno prima, avanzò una semplice argomentazione osservativa sulla base della quale
(pensava) sarebbe stato possibile discriminare fra le due ipotesi concorrenti: la «relativistica», per la
quale la velocità della luce è un invariante, e la «balistica», per la quale la velocità della luce si
compone con quella della sorgente, secondo le leggi della relatività galileiana. Per la verità, una
proposta in tal senso era stata avanzata fin dal 1911 dal matematico italiano Guido Castelnuovo in
un articolo divulgativo6.
6 Castelnuovo, Guido (1911), «Il principio di relatività e i fenomeni ottici», Scientia, Vol. IX, p. 71.
La proposta di De Sitter riguardava le stelle binarie visuali.
« Si immagini una stella binaria ed un osservatore su suo stesso piano, a grande distanza .
Fig.1. Stella binaria [De Sitter, 1913]
La luce emessa dalla stella dai punti in prossimità di A viene osservata, secondo la teoria di
Ritz, dopo un tempo
, la luce emessa da B, dopo un tempo
. Se indichiamo con T il
periodo orbitale della stella ( e la sua orbita, per semplicità, sia circolare), l’intervallo di
tempo tra le due osservazioni è
Se la stella, nella seconda metà del periodo, da B ad A, allora l’intervallo di tempo osservato
è
Nella teoria solita, gli intervalli sono ambedue uguali a T.
Ora, se
è dello stesso ordine di T, allora, se la teoria di Ritz fosse vera, sarebbe
impossibile ottenere osservazioni in accordo con la seconda legge di Keplero. Per tutte le
binarie spettroscopiche il termine
non solo è dello stesso ordine di T, ma probabilmente
in molti casi è anche molto maggiore. […] L’esistenza delle binarie spettroscopiche e la
circostanza che nella quasi totalità dei casi la velocità radiale osservata si accorda
perfettamente con la legge di Keplero, costituisce così una forte prova in favore della
costanza della velocità della luce. È opportuno anche ricordare che in molti casi le velocità
radiali sono corroborate anche da osservazioni visuali (come per Equ, Her, ecc.) o
dall’osservazione dell’occultamento di una componente del sistema binazio da parte
dell’altro ( come per le variabili di tipo Algol).»7
7 De Sitter, op. cit.
Adottando il modello di De Sitter, consideriamo una stella S che percorre con velocità costante un’
orbita circolare di raggio R.
Fig. 2. Stella doppia su orbita circolare. La velocità della luce emessa varia con la posizione.
Se t indica l’istante di partenza del raggio di luce diretto verso un osservatore remoto M , a distanza
d>>R, questi lo riceverà al tempo
dove è il periodo di rivoluzione. A questa si può dare la forma
avendo scelto di indicare con t i tempi ( espressi in unità del periodo della stella), conla velocità
della stella rispetto a c, e con la distanza dall’osservatore in unità di tempo.
Poiché il valore della velocità della stella è incomparabilmente minore di quella della luce, è
legittimo approssimare la (2) con la più maneggevole
dove
Il grafico, nel caso di è riportato in figura 3.
S
O
M
A
v
Fig.3. Tempo di ricevimento dei segnali di luce da parte dell’osservatore in funzione
del tempo proprio della stella.
Per un’ipotetica stella che percorra un’orbita circolare, quello che vedrebbe un osservatore vicino (
posto sul piano dell’orbita ad una distanza tale che il terzo termine della (3) fosse trascurabile)
sarebbe un moto armonico:
Ma per un osservatore distante, la relazione fra la posizione e il tempo non potrebbe più essere
armonica.
Infatti, per l’osservatore prossimo alla binaria, la velocità trasversale della stella sarebbe
Ma per l’osservatore remoto le cose stanno diversamente:
Se l’orbita, come abbiamo ipotizzato, è circolare, la velocità angolare che ne risulta è
il cui valore non è costante -come richiederebbe la seconda legge di Keplero- ma presenta periodici
massimi e minimi, la cui esistenza è condizionata dalla richiesta che
T
t
L’ entità dello scostamento dipende dal valore del parametro
Per esempio, per la alfa Centauri, e
per cui . Ne
segue che si avrebbe
solo ad una distanza , corrispondente a
anni luce. Una distanza enorme: per separare le componenti della binaria a questa distanza il
potere risolutivo del telescopio dovrebbe essere di qualche millesimo di secondo d’arco, cioè circa
cento volte superiore a quello dei più potenti telescopi (terrestri) attuali. Pertanto, non vi è alcuna
possibilità di osservare le eventuali anomalie del compagno di alfa Centauri.
2. CENNI BIOGRAFICI SU MICHELE LA ROSA
Michele La Rosa nacque a Palermo nel 1880 e prese la laurea in fisica nel 1902 sotto la guida di
Damiano Macaluso. Dopo aver trascorso un anno di perfezionamento a Firenze, nei laboratori dell’
Istituto di Fisica, allora diretti da Antonio Roiti, nel 1904 ebbe la nomina ad assistente presso il
gabinetto di fisica della Regia Università di Palermo con l’incarico, già ricoperto da Orso Mario
Corbino, di dirigere le esercitazioni di fisica pratica. Mantenne questa posizione fino al 1908, anno
in cui conseguì la libera docenza in Fisica Sperimentale presso la stessa università. Nel 1914,
entrato nella terna dei vincitori del concorso per il Politecnico di Torino, ottenne la nomina a
professore straordinario per la stessa disciplina, sulla cattedra palermitana, lasciata da Macaluso. Fu
membro della Società Italiana di Fisica e socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei. Nel 1925
G. Gentile lo chiamò alla direzione della sezione di fisica dell'Enciclopedia italiana, che mantenne
sino alla morte. Nel 1926 fu eletto preside della Facoltà di Scienze e nel 1932 rettore dell’ateneo di
Palermo. Morì improvvisamente lo stesso anno, a soli 56 anni. Fra le sue ricerche sperimentali, si
ricordano quelle sull’arco voltaico e sulla teoria elettronica dei metalli, culminata nel 1920 con la
scoperta - in collaborazione con Antonio Sellerio – di un effetto galvanometrico fino ad allora
sconosciuto, parallelo alle linee di forza e perpendicolare alla corrente. Scrive Sellerio nel suo
necrologio:
«Intanto il cielo della fisica al principio di questo secolo si andava oscurando. Al
lampeggiare dei quanti, successe la tempesta scatenata dalla relatività. Il La Rosa si
appassionò. Con la maggior parte dei fisici, non credette ai quanti in sul loro nascere; li
giudicava una forzatura matematica del PLANCK per giungere a qualunque costo a una
formula che si accordasse con l’esperienza. Egli che per la matematica aveva una
venerazione […] diffidava però della matematica, quando temeva che il suo ingranaggio
prendesse la mano all’osservatore e lo travolgesse. Ossequente però alla Natura e
consapevole della ignoranza dell’uomo, si arrese alle prove ed esaltò nei Suoi ultimi discorsi
le teorie quantistiche, augurandosi che l’elaborazione ulteriore riuscisse a dissipare le
oscurità che ancora rimangono.»8
8 Sellerio, Antonio (1934), Michele La Rosa, Memorie della Società Astronomia Italiana, Vol. 7, p.429.
Fig.4. Un ritratto giovanile di Michele La Rosa.
Di ben diversa natura fu la sua opposizione all’interpretazione che allora si dava della teoria della
relatività ristretta. E non si pensi che questo suo rifiuto derivasse da conservatorismo culturale o
meschinità di giudizio, in ciò essendogli sodale lo stesso Einstein che, per tutta la vita, non si piegò
alla cosiddetta « interpretazione dei Copenhagen» della meccanica quantistica, quale si era profilata
negli anni ’30. Scriveva nel 1924:
«La “teoria della relatività” di Einstein è uno dei possibili modi, uno dei tanti schemi teorici
di carattere relativistico che si possono costruire per rappresentare i fenomeni; esso è stato
costruito sulla base essenziale di un altro postulato: quello della “costanza della velocità
della luce”, 0 meglio “dell’indipendenza di questa velocità dal moto della sorgente”.
Affermazione questa che riguarda un “puro fatto di esperienza” e come tale soggetta al
vincolo necessario della sanzione sperimentale.»9
9 La Rosa, Michele (1924), «Prove astronomiche contrarie alla “relatività”: nuova teoria delle stelle variabili, fondata
sul postulato di Ritz», Il Nuovo Cimento, N°1, 1924, p. 50
La Rosa era ben consapevole che è possibile costruire schemi teorici di carattere relativistico
partendo da un ipotesi opposta quella di Einstein e l’ipotesi balistica è una di queste. Sulla base
dell’ipotesi che la velocità della luce si componga (nel senso classico) con quella dell’emettitore, è
infatti possibile spiegare l’esito (negativo) degli esperimenti alla Michelson; cioè è possibile
esterndere il principio di relatività dalla Meccanica all’Elettromagnetismo.
L’idea geniale di La Rosa fu quella di applicare l’ipotesi balistica alla comprensione della natura
fisica delle stelle variabili, interpretandole come binarie troppo lontane per essere risolte
telescopicamente. La tecnica delle Cefeidi, basata sulla scoperta di Henrietta Leavitt di una
relazione fra periodo e luminosità, fornì a La Rosa l’occasione per applicare anche a queste variabili
l’ipotesi che aveva mutuato da Ritz.
3. IL CONTRIBUTO DI LA ROSA AL PROBLEMA DELLE STELLE DOPPIE
Nel 1921 Michele La Rosa intervenne nella diatriba che la proposta di De Sitter aveva innescato
con un lavoro pubblicato sul Bollettino della Società Astronomica Italiana10
.
10 La Rosa, Michele (1921), «Il postulato di Ritz sulla velocità della luce ed i fenomeni delle stelle variabili. Nuova
teoria di queste stelle», Memorie della Società astronomica italiana, n.s., 1921, vol. 2, pp. 324-357
« Un’analisi più completa di ciò che l’osservatore terrestre dovrebbe vedere nell’ipotesi
balistica, ci permette di riconoscere facilmente l’errore delle conclusioni di De Sitter, in
quanto si fa riconoscere che osservazioni telescopiche e spettroscopiche sulla legge di
movimento di stelle doppie, sono largamente possibili, al sicuro di ogni inconveniente
dovuto alla sovrapposizione di luce; non solo, ma questa analisi ci induce a dare una chiara
e semplice spiegazione- ciò che è sommamente importante – di un vasto gruppo di fatti
astronomici dei più interessanti ed oscuri: quello delle stelle variabili, provandoci che
l’ipotesi balistica, nell’interpretazione dei fatti astronomici, si dimostra incomparabilmente
più feconda di risultati e più vicina ai fatti naturali, che non quella di Einstein.»11
11
La Rosa, Michele (1921), op. cit., p. 325.
Infatti, per le doppie risolubili telescopicamente – che solo su queste è stata riconosciuta la costanza
delle velocità areolari, ovvero la validità della seconda legge di Keplero- il valore di è talmente
piccolo che il termine periodico della (3) non comporta perturbazioni rilevabili sulla velocità
angolare osservata. Alla stessa conclusione arriva La Rosa per quanto concerne le doppie
spettroscopiche, troppo lontane per essere risolte al telescopio, per le quali le informazioni si
ricavano sulla base degli spostamenti Doppler delle righe spettrali.
Per apprezzare la «fecondità di risultati» dell’ipotesi balistica, rivendicata nel brano sopra riportato,
dobbiamo ritornare alla (3), dalla quale possiamo ricavare informazioni sulla luminosità della stella.
Infatti, la quantità di luce emessa dalla stella in un tempo dt viene ricevuta dall’osservatore in un
tempo dT che ha durata diversa. Questo significa che se la potenza irradiata è , quella ricevuta
dall’osservatore è
Se la distanza della stella è tale da soddisfare la (9), il fatto ha due importanti conseguenze:
1. L’osservatore riceve simultaneamente luce emessa da punti diversi dell’orbita, anche molto
distanti.
2. Vi sono intervalli finiti di tempo ai quali corrispondono intervalli brevissimi di tempo .
Questo comporta l’esistenza di picchi di luminosità molto pronunciati .
La conseguenza è che la magnitudine apparente della stella è soggetta ad una modulazione nel
tempo del tipo indicato in Fig.5 .
Fig.5. Andamento temporale della luminosità della stella registrata dall’osservatore.
Dal confronto fra le curve ricavate dalla (11), La Rosa ricava un’interpretazione unitaria delle curve
di luce delle stelle variabili, basata sul principio di Ritz:
« … la semplice sovrapposizione della ipotesi circa la composizione della velocità della luce
e quella della sorgente su ciò che si sa sulla costituzione delle doppie, ci permette di spiegare
i fenomeni presentati dalle stelle variabili della III classe, in modo completo ed in tutti i
particolari.»12
12 La Rosa, Michele (1921), op. cit., p. 351.
Le oscillazioni di luminosità sono apprezzabili solo per valori del prodotto fino a qualche unità,
mentre per valori superiori alla decina ogni variazione di luminosità diventa inapprezzabile e
«la stella diventerà incapace di svelarci per via di cambiamenti della sua grandezza apparente
il suo moto periodico, cioè la sua condizione di “satellite” di una doppia o di un sistema più
complesso.»13
13 La Rosa, Michele (1921), op. cit., p. 335..
La conclusione è che le osservazioni raccolte sulle stelle doppie non pregiudicano l’eventuale
correttezza dell’ipotesi balistica intorno alla velocità di propagazione della luce, e quindi non
possono essere assunte a sostegno del postulato di Einstein. Non solo, l’ipotesi balistica potrebbe
essere la chiave che consente di dare una spiegazione su un fatto importante che riguarda le stelle
binarie spettroscopiche.
Dal catalogo di Campbell relativo alle doppie spettroscopiche che fu pubblicato nel 191014
14 Campbell, William Wallace (1910), «Second catalogue of spectroscopic binary stars», Lick Observatory bulletin ;
no. 181Berkeley : The University Press, p. 17-54.
è possibile ricavare la loro distribuzione in funzione della magnitudine.
Magnitudine 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Numero
doppie
3 3 6 9 16 21 29 32 13 5 0
Questa distribuzione suggerisce il sospetto che vi sia una causa che limiti e impedisca la possibilità
di osservazione di doppie spettroscopiche, e questa potrebbe essere legata alla velocità di
propagazione della luce. Ora, a motivo della necessaria piccolezza della velocità relativa della stella
() , la possibilità di trovare valori di cresce all’aumentare della distanza. Cioè, quanto
maggiore è la distanza della stella, tanto meno è probabile che possa manifestare la sua natura di
doppia, perché valori grandi di richiedono, affinché il valore di sia inferiore a 10, valori
sempre più piccoli della velocità, e questo rende le osservazioni di spostamento Doppler sempre più
difficili. In questa constatazione potrebbe risiedere la spiegazione della ragione per cui al crescere
della magnitudine delle stelle, il loro numero decresce.
Ma anche i fenomeni connessi alle novae possono trovare una spiegazione nell’ambito dell’ ipotesi
balistica. Possiamo infatti immaginare una binaria molto lontana, con la compagna che percorra
un’orbita ellittica di grande eccentricità e dimensione, perciò di lunghissimo periodo. Gli enormi e
rapidi cambiamenti di velocità che hanno luogo in prossimità del periastro possono rendere ragione
dell’improvviso arrivo in tempo breve di una grande quantità di energia raggiante, emessa dalla
stella su un lungo periodo di tempo. Quindi spiegare l’improvviso aumento di luminosità apparente
della stella e la lenta sua diminuzione fino alla classe di magnitudine spettante ad una stella tanto
lontana.
Le conclusioni a cui porta la memoria di La Rosa sono che:
«1. È inesatto credere – con De Sitter – che le osservazioni sulle stelle doppie forniscano un
qualsiasi elemento di prova in favore del postulato di Einstein sulla costanza della velocità
della luce.»
« 2. Tutti i fenomeni fin’oggi noti nel campo delle stelle «nuove» e «variabili» che non
avevano ricevuto una spiegazione soddisfacente, trovano una chiara, semplice e naturale
spiegazione generale nella ipotesi opposta a questa di Einstein, cioè nell’ipotesi che la velocità
della luce si componga con quella della sorgente.»
«Devesi pertanto ritenere non solo come privo di base, ma come contrario ai fatti naturali, il 2°
postulato di Einstein e devesi perciò respingere in forza di questa testimonianza dei fatti la
«teoria della relatività» perché col secondo postulato cade il cardine di tutto l’edificio
teorico.»15
15 La Rosa, Michele (1921), op. cit., p. 356..
4. LE CEFEIDI COME BINARIE
Nel 1908 Henrietta Leavitt, dell’osservatorio di Harvard, aveva osservato che alcune centinaia di
stelle variabili - dette cefeidi - nelle Nubi di Magellano presentano una relazione fra la magnitudine
ed il periodo che aveva formalizzato nel 1912 in una famosa formula:
dove indica la magnitudine assoluta della stella e il periodo.
«Questa importante legge – osserva La Rosa in una memoria del 1931 – scoperta per le
variabili della Piccola Nube di Magellano, è stata confermata da altri, anche sopra stelle di
altri ammassi stellari, e forma una di quelle strane e misteriose regolarità – nel campo delle
variabili – di cui invano si è cercato di dare un qualsiasi elemento di giustificazione; e di cui
invece , riesce subito di dare una ragione semplice ed immediata non appena ci si metta dal
punto di vista della spiegazione balistica del fenomeno della variabilità.»16
16 La Rosa, Michele (1931), « Una nuova prova sulla dipendenza della velocità della luce dal moto della sorgente:
spiegazione balistica della legge di Miss Leavitt», Memorie della Società Astronomia Italiana, Vol. 5, pp.303-313.
Nel modello di La Rosa, la condizione affinché la doppia sia osservabile come stella di luminosità
variabile, è che
Questa relazione non esprime solo la condizione (necessaria e sufficiente) per la comparsa della
variabilità in relazione al moto, ma, a seconda del valore di , serve a individuare i diversi tipi di
variabili. Se consideriamo stelle appartenenti ad uno stesso ammasso, la distanza dall’osservatore è
la stessa per tutte, per cui, in forza della (4), la precedente prende la forma
o anche
dove
caratterizza dell’ammasso.
La (15) afferma che
« fra tutte le stelle doppie presenti in un ammasso, possono apparirci come variabili di un
determinato tipo, solo quelle per le quali il rapporto
è praticamente uguale al prodotto
della costante dell’ammasso per il parametro del tipo (diviso per )»17
17 La Rosa, Michele (1931), op. cit., p. 306
Se invece introduciamo nella (13) la velocità angolare Ω della stella e il raggio R dell’orbita,
acquista la forma
Questa afferma che
« possono apparirci come variabili di un dato tipo solo quelle doppie dell’ammasso per le
quali l’accelerazione media, a cui è soggetto il compagno girevole per parte dell’altro astro, è
uguale al prodotto della costante dell’ammasso per il parametro del tipo.»18
18 La Rosa, Michele (1931), ibidem.
Ma l’accelerazione centripeta della stella dipende dal raggio R dell’orbita e dalla massa ridotta M in
conformità alla legge di Newton:
dove G indica la costante di Cavendish. Introducendo questa nella precedente si arriva al notevole
risultato:
dove il secondo membro è costante per un dato ammasso. A tale costante, che caratterizza
l’ammasso, La Rosa attribuisce il nome di « costante di Leavitt.»
La (19) stabilisce che
«fra tutte le doppie di un ammasso, possono apparirci come variabili di un dato tipo solo
quelle per cui avviene che le masse dei centri attraenti siano proporzionali alla quarta
potenza del periodo di rotazione.»19
19 La Rosa, Michele (1931), ibidem.
Sinteticamente,
dove è la costante di Leavitt.
A questo punto, assodato che lo scopo di La Rosa è quello di ricavare la legge delle Cefeidi trovata
empiricamente da Leavitt, è necessario stabilire una relazione fra la massa della stella e la sua
luminosità. Negli anni ’20 del secolo scorso, gli studi teorici sulla struttura fisica delle stelle erano
agli albori; ma alcuni risultati erano stati raggiunti. Notevoli fra questi le relazioni fra la luminosità
della stella e la sua massa trovate rispettivamente da Eddington20
e Jeans21
.
20Eddington, Arthur Stanley (1924), «On the Relation between the Masses and Luminosities of the Stars», Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society, 84, p. 308.
21Jeans, James Hopwood (1925),«On the masses, luminosities, and surface-temperatures of the stars»,
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 85, p.196, 392.
Eddington proponeva per la relazione fra luminosità L e massa M della stella
La proposta avanzata da Jeans teneva invece conto della temperatura superficiale:
dove a è un opportuno esponente.
Poiché la magnitudine stellare è, per definizione, proporzionale alla luminosità, per la (21), si ricava
che
in ambedue i casi. Conclude La Rosa:
«L’accordo fra questo genere di regolarità, empiricamente scoperte, ed il nostro schema
teorico non potrebbe essere migliore. La legge di Miss LEAVITT può legittimamente essere
considerata come caso particolare del legame generale avanti stabilito. E poiché le basi delle
nostre considerazioni sono la relazione di EDDINGTON- JEANS fra m ed M e l’applicazione
del principio balistico alla velocità della luce, si dovrebbe potere concludere che la legge di
Miss LEAVITT costituisce una valida prova dell’esattezza di questi presupposti.»22
22La Rosa, Michele (1931), ibidem, p.312.
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In un suo recente saggio23
Fabio Toscano definisce Michele La Rosa (unitamente a Quirino
Majorana, anche lui siciliano) «oppositore ad oltranza di Einstein», come se la sua posizione fosse
colpevole o retrograda.
23 Toscano, Fabio (2004) , Il genio e il gentiluomo: Einstein e il matematico italiano che salvò la teoria della relatività
generale, Sironi, Milano, p. 246
Non era così, naturalmente. Tutte le filosofie veramente innovatrici incontrano ostacoli; è accaduto
per l’idea newtoniana della gravitazione universale, che ebbe come oppositori alcune tra le menti
più lucide del suo tempo ( tra cui Descartes), per il modello ondulatorio di Huygens, per le idee di
Boltmann in fatto di fenomeni termici. Il dibattito e il confronto fra paradigmi alternativi sono
l’essenza della ricerca scientifica, come ci ha insegnato Thomas Kuhn24
24 Kuhn, Thomas (1962), The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press.
Non corrisponde poi a verità il fatto che l’opposizione alla formulazione vigente in quel tempo della
«teoria della relatività» fosse preconcetta ed assoluta. Proprio a conclusione del citato lavoro sulle
Cefeidi, La Rosa riconosce infatti che
« La «relatività» ha reso senza dubbio grandi servigi agli sviluppi moderni delle teorie
fisiche; e non è possibile rinunziarvi. Ma a me sembra che l’adozione del «principio
balistico» non debba per necessità portare alla condanna di quella teoria; almeno nella parte
più sostanziale: di quella che è stata così feconda di aiuti alle costruzioni teoriche recenti.
L’apporto veramente utile, e che ha avuto un grande giuoco è quello che riguarda la
dipendenza della reazione d’inerzia (di un corpuscolo) dalla velocità del moto: ossia quanto
riguarda la revisione delle basi del 2° postulato della Meccanica classica. In questo punto la
teoria di EINSTEIN si è assicurato un indiscutibile successo. Ora a me sembra che il
medesimo risultato si sarebbe potuto conseguire con un diretto ed opportuno ritocco della
relazione fondamentale fra forza, massa ed accelerazione; e soprattutto senza la necessità di
ricorrere all’espediente ingiustificato della costanza della velocità della luce che è stato
sorgente delle tanto discusse e lamentate stranezze e che lo stesso Einstein ha dovuto lasciar
cadere negli sviluppi successivi. Un tentativo teorico in questo senso sarebbe forse assai
fecondo e certo molto istruttivo. »25
25 La Rosa, Michele (1931), ibidem, p.312.
Bruno Touscheck, grande fisico delle particelle di origine austriaca, ma naturalizzato italiano, usava
dire che i manuali scolastici di fisica somigliano a quelli di storia patria: la giustizia prevale sempre
sull’errore nel cammino verso la Verità. E poiché la storia della fisica – come la Storia politica –
ha vincitori e vinti, Michele La Rosa è indubbiamente tra questi ultimi. Ma solo ad una lettura
superficiale. Nessun paradigma vince totalmente sui rivali; spesso una teoria scaturisce mutata dal
confronto con le altre che si contendono un determinato ambito fenomenico. Così come quella che
oggi è nota come «Meccanica classica» ha poco a che vedere con quella di Newton, anche la
«Relatività Speciale» attuale è molto diversa da quella dei tempi di La Rosa. È mutato il modo di
presentarla e soprattutto di intenderla. Proprio la « dipendenza della reazione d’inerzia (di un
corpuscolo) dalla velocità del moto» ricordata da La Rosa è oggi confinata in qualche manuale scolastico
residuale, in quanto sono vari decenni che la famosa relazione fra la massa (relativistica) e la velocità è
consegnata agli archivi degli storici.26
26 Okun, Lev Borisovich (2009), «The mass versus relativistic and rest masses», Am. J. Phys., Vol. 77, No. 5.
Ma le idee che soccombono e vengono abbandonate in quanto giudicate errate, concorrono allo
sviluppo della fisica quanto quelle che finiscono sui libri di scuola, ripulite e vestite di nuovo come
nei giorni di festa i nostri nonni.