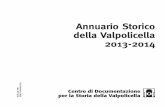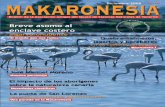El comportamiento climático como un desafío para la Ciudad de San José del Cabo
Un San Michele arcangelo di Romolo Balsimelli
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Un San Michele arcangelo di Romolo Balsimelli
IE~9:N:9$.::j:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: CONTRIBUTI ::~;~!;:~~;;;;~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~i:::~:~]
Un San Michelearcangelodi RomoloBalsimelli
Fabio Speranza
scorrere il corposo catalogo delle sculture del Mu-
Aseo N azionale di San Martino non poche sonoquelle che attendono ancora oggi una più adeguata ricognizione critica. È il caso, tra le opere dimaggior pregio collocate in parte nei suggestivi"sotterranei" gotici dell'ex complesso certosino,in parte ricoverate nei vicini depositi, di un inte-
ressante altorilievo cinquecentesco in marmo bianco - in realtà quasiuna scultura a tutto tondo - di ignota provenienza, raffigurante SanMichele arcangelo (fig. 1), rappresentato nell'atto di sconfiggere Satana secondo il consueto schema iconografico che trova nell'esemplaredi Monte Sant'Angelo (1506-1507) il suo momento più significativoin ambito meridionale!. Raccordato ad una basetta rocciosa, il piccolo fondale da cui si proietta con accresciuto impeto il San Michele èindizio di una collocazione originaria della statua entro una nicchia oun rincasso, quale coronamento - a giudicare dal punto di vista dalbasso che la postura della figura lascia intendere - di un portale, di unaltare o di un monumento funerari02.
Malgrado l'indiscutibile qualità del pezzo, la letteratura sul SanMichele, condizionata anche dalla totale mancanza di notizie relative al contesto originario dell'opera e alla sua immissione nellecollezioni del museo napoletano, è davvero esigua, circoscritta inpratica a due soli contributi3 •
Il primo è costituito da una breve scheda redatta da MarinaCausa Picone nel 1964, in occasione di una mostra allestita conuna selezione di oggetti d'arte e documenti storici, talvolta ancorainediti come il San Michele, prelevati dai depositi del Museo diSan Martino. La studiosa ricollegava la scultura"di altissima qualità formale, con quel naturalismo deformante, quasi doloroso, chesi ritrova nelle maggiori espressioni della plastica napoletana delprimo Cinquecento" ai modelli di vibrante e inquieto classicismoche l'ignoto autore del San Michele avrebbe tratto dalla lezionedei "doi spagnoli" Bartolomé Ord6fiez e Diego de Siloe, in ispeciedalle parti scolpite da quest'ultimo nella cappella Caracciolo diVico in San Giovanni a Carbonara a Napoli4 .
Spunto ripreso e sviluppato in maniera più ampia, quasi quaranta anni dopo, da Roberto Middione all'interno del suo lavorosulle raccolte di scultura del museo napoletan05• Mantenuto sempre nell'anonimato, il San Michele veniva con più decisione ricondotto all'ambito del de Siloe sulla base di un legame, in veritàtutt'altro che "strettissimo" come vorrebbe l'autore, con i due SanSebastiano di San Giovanni a Carbonara e della parrocchiale diBarbadillo de los Herreros (Burgos) e con la tomba del protonotario apostolico Giovan Giacomo Tocco nel duomo napoletano,opera del resto non riferibile direttamente al maestro spagnol06•
Nell'impossibilità di dare una fisionomia più definita all'autoredel marmo di San Martino, Middione provava ad estendere i confronti con altre personalità gravitanti attorno alla "maniera moderna" dei due scultori iberici. La figura del demonio - secondo lo
U~~9:N:9~:::~:i.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: CONTRIBUTI ::~;:~;~:~~;~;;~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~:~L::$:Z:I
2. Romolo Balsimelli,Santa Caterina d'Alessandria,particolare, Napoli,chiesa di Santa Chiara, coro delle clarisse
3. Romolo Balsimelli, Temperanza(particolare del sepolcrodi Galeotto Carafa e Rosata Pietramala),Napoli, chiesa di San DomenicoMaggiore, cappella Carafadi Santa Severina
studioso la parte più riuscita dell'opera malgrado lo stato di consunzione - mostrerebbe, infatti, forti affinità con le anime purganti della pala della Madonna delle Grazie realizzata da GirolamoSantacroce per la chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli, soprattuttonel modo di rendere le sfaccettature dei piani. La rassegna dei confronti stilistici si chiudeva con il richiamo, "nella posa fluida dellafigura e in certe pastosità di modellato", ad analoghe soluzioni riscontrabili nelle Sibille dell'ancona di Santa Maria la Bruna al Carmine di Napoli, confronto non condivisibile nel senso di unastretta derivazione, ma che quantomeno indirizza il San Michele come ora si dirà - entro un più pertinente contesto culturale, unavolta tolta all'entourage dell'Ord6fi.ez e ricondotta all'attività deltoscano Andrea Ferrucci e della sua bottega l'incomiciatura marmorea cinquecentesca che inquadra la sacra icona della chiesa carmelitana, come in seguito Riccardo Naldi ha ampiamente dimostrat07.
Rispetto all'accentuato patetismo, al fremito nervoso che percorre sottopelle le, ora febbrili, ora languide, figure dei "doi spagnoli", nella scultura di San Martino prevale una certa compostezza classica, ancora quattrocentesca, che scaturisce dalla studiatacalibratura dei movimenti: la robusta gamba sinistra, spostata inavanti e piantata saldamente sul torace del demonio, sembra quasi
CONTRIBUTI
bloccare la spinta in avanti del corpo del San Michele, mentre ilbraccio proteso dell'avversario sottomesso, che si aggrappa alla bilancia della psicostasia facendola pendere inesorabilmente verso ilbasso, fa da contraltare al movimento del braccio destro dell'arcangelo, nell'atto di sferrare con la spada il colpo decisivo. L'attento studio dell'anatomia, evidenziato dal morbido ma solidomodellato della corazza del santo e dal contrarsi dei muscoli dellacreatura infernale, si accompagna ad una particolare cura del dettaglio, come è dato osservare nella raffinata fattura dei calzari, impreziositi da motivi floreali, e nel gesto ricercato della flessuosamano sinistra del San Michele che elegantemente sostiene la bilancia con l'indice attraverso l'anello.
U n equilibrio formale, dunque, il quale - piuttosto che costituire una risposta al "naturalismo deformante" di Ord6fiez e deSiIoe, come sostengono la Causa Picone e Middione - mostra ancora in parte di essere debitore dei canoni compositivi della plastica fiorentina tardo-quattrocentesca, degnamente rappresentata aNapoli dagli illustri apici di Antonio Rossellino e di Benedetto daMaiano nella chiesa di Santa Maria di Monte Oliveto. E allora,credo, che al fine di delineare l'ambito culturale entro cui collocare il San Michele occorra dirigere il tiro verso quella cerchia discultori capeggiata proprio dal fiesolano Andrea Ferrucci, certamente non estranea alle dirompenti novità diffuse dall'inquietamaniera dei "doi spagnoli", ma che, nei primi due decenni delCinquecento, porta avanti, nella capitale vicereale, quel filone discultura verrocchiesca e tardo-maianesca, inaugurato proprio daimonumenti di Monte Oliveto, sviluppandolo poi sui nuovi indirizzi proposti da Andrea Sansovino.
Piuttosto che al Ferrucci stesso, con le sue aperture alla maniera moderna palesate soprattutto nel sepolcro di Giovan BattistaCicaro ai Santi Severino e Sossio, il San Michele andrà riferito alsuo sodale più conservatore, Romolo Balsimelli da Settignano, impegnato con Andrea nei lavori per la cappella Carafa di Santa Severina in San Domenico Maggiore, per la quale - oltre a completare la struttura architettonica - scolpisce la tomba di Galeotto Carafa e Rosata Pietramala (1513), in cui è già pienamente espressa lacifra stilistica del maestro, ancora dipendente da moduli maianeschi, sia pur vivificati da una profonda rilettura dell'antic08• Inparticolare, accostando alla scultura del Museo di San Martino laSanta Caterina d'Alessandria del coro delle clarisse nella basilicadi Santa Chiara a Napoli, "sorella" stretta delle due Virtù che decorano l'ora ricordato sepolcro di Galeotto Carafa, come efficacemente ha indicato Naldi9, è possibile cogliere numerose analogie.Anche a tener conto della più dinamica costruzione del San Michele (in qualche modo imposta dall'azione che egli sta compiendo), entrambe le figure presentano un impianto compositivo classico, solidamente imperniato sullo scarto in avanti della gamba sinistra con il leggero anchement del fianco destro; l'inclinazionedel capo determina sul volto dei due santi delicati trapassi chiaroscurali che evidenziano un medesimo modo di rendere il sottile taglio delle palpebre semichiuse, le ampie arcate sopracciliari, ii nasodritto dalla punta arrotondata, le fossette ai lati della bocca, ilmento pronunciato (fig. 2). Considerato anche lo stato mutilo della Santa Caterina, è opportuno allargare la serie dei confronti alledue Virtù della tomba Carafa, in particolare alla Temperanza (fig.3), dove si ritrova quel panneggiare a pieghe sottili, con ricaschimorbidi e ondulati, presente sul mantello che avvolge le spalle dell'arcangelo. Ulteriori indizi di identità sono la stessa maniera, un
U<~9:N:9~::~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: CONTRI BUTI ::~;~;;:~~;~;;~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:i::?§]
po' semplificata e non esente da qualche incertezza, di scolpire lepossenti braccia e la soluzione adottata nel risolvere il flettersi delpolso e l'articolazione delle dita piegate di quella mano che nelSan Michele sostiene la bilancia e nella Temperanza la caraffa.
Circa la cronologia del marmo balsimelliano, in assenza diqualsivoglia traccia documentaria, bisognerà attenersi a quella delle opere richiamate a confronto: dunque un'esecuzione intorno al1515 e comunque non molto oltre il 1520, in quanto di lì a poco lostile di Balsimelli ripiegherà su formule più stanche e ripetitive,come può leggersi nelle statuette che decorano la tomba di VitoPisanello in San Lorenzo Maggiore.
Referenze fotografiche: Fabio Speranza, Napoli (1); Luciano Pedicini, Archivio dell'Arte (2, 3)
NOTE
". Desidero ringraziare per i consigli e lo scambio di pareri gli amici RiccardoNaldi e Giuseppe Porzio.
1 Liberato dagli apparati devozionali che ne occultavano parzialmente i caratteristilistici, il San Michele del santuario garganico, che già vantava un prestigioso riferimento ad Andrea Sansovino, è stato restituito definitivamente al fiesolano Andrea Ferrucci da Riccardo Naldi (Rapporti Firenze-Napoli tra Quattro e Cinquecento: la "cona marmorea" di Andrea di Pietro Ferrucci per Maria Brancaccio, in"Prospettiva", nn. 91-92, luglio-ottobre 1998 [Omaggio a Fiorella Sricchia Santoro, voI. I], p. 114, nota 37; Idem, Andrea Ferrucci da Fiesole per il Gran CapitanoGonzalo de C6rdoba: il San Michele arcangelo nella grotta del santuario del Gargano (con una coda sul Cappellone di San Giacomo della Marca a Napoli), in "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, classe di Lettere e Filosofia", IV s., 12, Quaderni, 9-10, 2001 (Giornate di studio in ricordo di Giovanni Previtali. Siena, Università degli Studi, dicembre 1998; Napoli, Università degli Studi "Federico II'', febbraio 1999; Pisa, Scuola Normale Superiore, maggio 1999, a cura di F.Caglioti), pp. 171-190; Idem, Andrea Ferrucci. Marmi gentili tra la Toscana e Napoli, Napoli 2002, pp. 55-59; Idem, Scultura del Cinquecento in Puglia: arrivi daNapoli, in Scultura del Rinascimento in Puglia. Atti del convegno Internazionale(Bitonto, Palazzo Municipale, 21-22 marzo 2001), a cura di C. Gelao, Bari 2004,pp. 161-167).
2 La scultura, ricavata da un unico blocco di marmo bianco di Carrara, misuracm 96x41x26 (inv. 29808) ed è inserita nel percorso museale riservato alla "sezionesculture", attualmente chiuso al pubblico. L'esistenza sul fondale di tracce di colore blu potrebbe ricondursi alla presenza di una policromia originaria su tutta osu parte dell' opera.
3 Con ogni probabilità l'ingresso del San Michele a San Martino (registrato ufficialmente negli inventari solo nel 2001) dovrebbe cadere intorno ai primi anni delNovecento quando numerosi oggetti d'arte, soprattutto marmi e sculture, di pertinenza del Municipio di Napoli e in massima parte provenienti da edifici sacri ecivili demoliti durante il Risanamento, furono qui depositati. Un acquisto o unadonazione, peraltro, avrebbero più facilmente lasciato traccia scritta nell'archiviostorico del museo.
4 Museo di San Martino. Mostra di oggetti d'arte e di documenti storici sceltidalle raccolte dei depositi, catalogo della mostra a cura di M. Causa Picone e A. M.Bonucci, Napoli 1964, p. lO, cat. 2.
5 R. Middione, Museo Nazionale di San Martino. Le raccolte di scultura, Napoli2001, pp. 59-60, cat. 1.50.
6 Nella cappella Tocco a Diego de Siloe spetta piuttosto il bassorilievo con laMadonna in gloria, riconosciutogli già nel 1950 da Ferdinando Bologna (Problemidella scultura del Cinquecento a Napoli, in Sculture lignee nella Campania, catalogo della mostra a cura di F. Bologna e R. Causa, Napoli 1950, pp. 159-161) e sulquale da ultimo vedi F. Speranza, Sul soggiorno napoletano di Diego de Siloe: lapala della cappella Tocco in Duomo e altre questioni, in "Napoli nobilissima", Vs., IV, 2003,1-2, pp. 3-20; invece il sepolcro di Giovan Giacomo Tocco (1520), nelquale si palesa con chiarezza l'influenza dei modi di Diego - già colta dallo stesso
.~.C:.9..: ??. . <CONTRI 13UTI Fabio Speranza I<RONOS 13
Bologna - oscilla ancora nei pareri della critica tra i nomi di Giovan TommasoMalvito e Giovan Giacomo da Brescia (cfr. F. Abbate, La scultura napoletana delCinquecento, Roma 1992, pp. 82-83 e nota 29, con bibliografia precedente; C. Gelao, Il mausoleo di Angela Castriota Skanderbeg nella chiesa di Santa Sofia a Gravina e alcune precisazioni sulla scultura napoletana del primo Cinquecento, in Vedi Gravina. I Itinerario 83, Bari 1984, p. 167).
7 Cfr. la monografia di R. Naldi, Andrea Ferrucci... cit., pp. 117-141, a cui si rimanda per tutta la complessa vicenda storica e attributiva dell'altare del Carminee per l'operato del Ferrucci a Napoli (con bibliografia precedente) .
8 È possibile ricostruire l'attività napoletana di Romolo Balsimelli sulla scorta dialcuni documenti pubblicati a suo tempo da Gaetano Filangieri (Documenti per lastoria le arti e le industrie delle provincie napoletane, Napoli 1883-1891, III, pp.29-35; V, p. 24) relativi agli interventi, di tipo decorativo e architettonico, delmaestro nella cappella Carafa (1512-1515) e all'apprezzo di una quantità di piperni per la chiesa di Santa Caterina a Formiello (1519), la qual cosa in passato avevafatto credere ad un suo coinvolgimento nella ristrutturazione dell'edificio sacro(G. Ceci, La chiesa e il convento di Santa Caterina a Formello, in "Napoli nobilissima", IX, 1900, p. 70; R. Pane, Il Rinascimento nell'Italia meridionale, Milano1975-1977, II, pp. 203-205). Un altro tassello documentario è stato segnalato dachi scrive ed attesta la presenza di Balsimelli a Napoli nel 1521, quando risulta testimone di un atto notarile riguardante il duca di Gravina, Ferdinando Orsini (F.Speranza, Un tabernacolo della bottega di Andrea Ferrucci a Castellammare diStabia, in "Studi di Storia dell'Arte", 14,2003, pp. 114-115, nota 23). È merito poidi Francesco Abbate l'aver delineato un profilo definito del maestro toscano edesteso la cronologia balsimelliana al 1528, con l'attribuzione al settignanese del sepolcro di Vito Pisanello in San Lorenzo Maggiore (F. Abbate, cit., pp. 81, 98-101;Idem, Storia dell'arte nell'Italia meridionale. Il Cinquecento, Roma 2001, pp. 20,146-147). Ulteriori approfondimenti e altre significative acquisizioni al catalogodel maestro e della sua bottega sono in R. Naldi, Andrea Ferrucci... cit., pp. 79,146-148 e, in particolare, nota 59. La paternità del sepolcro di Galeotto Carafa e ilproblema della ricostruzione dell'intero corpus balsimelliano, che ad essa si collega, sono stati messi in discussione, a favore dell'ancora poco distinta personalitàdello scultore Cesare Quaranta di Cava de' Tirreni, da Francesco Caglioti con argomentazioni, in verità, tutt'altro che risolutive (cfr. F. Caglioti, Due "Virtù"marmoree del primo Cinquecento napoletano emigrate a Lawrence, Kansas. I Carafa di Santa Severina e lo scultore Cesare Quaranta per San Domenico Maggiore,in "Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz", XLVIII, 2004[2005], pp. 333-358).
9 Cfr. R. Naldi, Andrea Ferrucci... cit., pp. 147-148. L'originario contesto figurativo della Santa Caterina, insieme ad altre tre sculture raffiguranti i santi Francesco d'Assisi, Chiara e Antonio da Padova, sempre nel coro delle clarisse trannel'ultima esposta nel vicino Museo dell'Opera di Santa Chiara, è stato correttamente individuato da Caglioti nel semidistrutto sepolcro di Caterina della Ratta (t1511), eretto nella chiesa di San Francesco delle Monache (F. Caglioti, cit., p. 354).Per l'opera è stata proposta una datazione abbastanza avanzata, 1530-1535 (Caglioti), oppure 1528-1541 (cfr. Y. Ascher, The tomb of Caterina della Ratta andthe iconography of the reclining reader in Renaissance sepulchral art, in "Source.N otes in the history of art", XIV, 1994-1995, 2, pp. 11-18); più tardi corretta in"late 1520s" dallo stesso Ascher (Tommaso Malvito and Neapolitan tomb designof the Early Cinquecento, in "Journal of the Warburg and Courtauld Institutes",LXIII, 2000, p. 128); datazione che, più verosimilmente, andrà posta, credo, nonoltre gli inizi del terzo decennio sulla base dei riscontri con le Virtù della tombadi Galeotto Carafa.