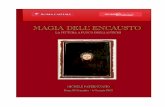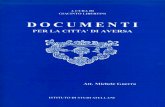Encausto, l'arte perduta e ritrovata. Incontro con Michele Paternuosto (2012)
Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
Direttore: Adriano Prosperi
Comitato editoriale: Carmine Ampolo, Paola Barocchi, Pier Marco Bertinetto, Luigi Blasucci, Lina Bolzoni, Glen W. Bowersock, Horst Bredekamp, Howard Burns, Giuseppe Cambiano, Ettore Casari, Enrico Castelnuovo, Claudio Cesa, Michele Ciliberto, Claudio Ciociola, Gian Biagio Conte, Marcello De Cecco, Francesco Del Punta, Furio Diaz, Maria Monica Donato, Massimo Ferretti, Carlo Ginzburg, Luca Giuliani, Anthony Grafton, Serge Gruzinski, Gabriele Lolli, Michele Loporcaro, Daniele Menozzi, Glenn W. Most, Giovanni Miccoli, Massimo Mugnai, Salvatore Nigro, Emilio Peruzzi, Armando Petrucci, Paolo Prodi, Giovanni Pugliese Carratelli, Mario Rosa, Salvatore Settis, Alfredo Stussi, Alain Tallon, Roberto Vivarelli, Paul Zanker
Segreteria scientifica di redazione: Giuseppe Marcocci
La quinta serie è pubblicata, con periodicità semestrale, in due fascicoli di circa 300 pagine ciascuno.
Abbonamento:
Annuale: Italia € 90,00 - Estero € 140,00Fascicoli singoli: Italia € 45,00 - Estero € 70,00
Le vendite vengono effettuate previo pagamento anticipato. A distributori e librerie sarà praticato lo sconto del 15%, a normalisti ed ex normalisti del 30%.Per informazioni: [email protected]
Annali della Classe di Lettere e Filosofia Scuola Normale SuperiorePiazza dei Cavalieri, 756126 Pisatel. 0039 050 509220fax 0039 050 [email protected] – [email protected]/it/edizioni/riviste/annalilettere/
Annalidella Scuola NormaleSuperiore di PisaClasse di Lettere e Filosofia
serie 5 2009, 1/2
Inquisizioni
Pubblicazione semestraleAutorizzazione del Tribunale di Pisa n. 7 del 1964Direttore responsabile: Adriano Prosperi
Periodico associato all’Unione Stampa Periodica ItalianaISSN 0392-095x
Indice
Inquisizioni
Frate Dolcino da Novara: un’avventura religiosa e documentaria Marina Benedetti 339
Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati (aprile 1559-aprile 1560) Simonetta Adorni Braccesi 363
Nel labirinto di Babilonia. Vergerio artefice della censura di Petrarca María Luisa Cerrón Puga 387
Rumours, Gossip and Crypto-Jewish Identity in the Sixteenth-Century Venetian Inquisition Giorgos Plakotos 425
Educating the Infidels within: Some Remarks on the College of the Catechumens of Lisbon (XVI-XVII centuries) José Alberto Rodrigues da Silva Tavim 445
«Con recato y sin estruendo». Puertos atlánticos y visita inquisitorial de navíos Carlos Alberto González Sánchez Pedro Rueda Ramírez 473
A proposito del processo a Galileo. Il problema del precetto Seghizzi
Vittorio Frajese 507
The Inquisition and the ‘Priestess of Zafra’: Hermaphroditism and Gender Transgression in Seventeenth-Century Spain François Soyer 535
La Inquisición de Palermo entre Saboyas y Borbones. Un tribunal español y un rey piamontés en el reino de Sicilia (1713-18) Marina Torres Arce 563
Celestini e inquisitori: Galiani, la Bibbia e la cultura napoletana Gustavo Costa 593
Ricerche e discussioni
Erodoto e Pseudo-Erodoto sulla sterminata antichità degli egiziani Benedetto Bravo 623
Arte e artigianato: l’importanza della ‘produzione in serie’ per l’arte antica Wolf-Dieter Heilmeyer 649
«Ecclesiae quam edificatis auxilium faciam». La lettera di Alfonso VI a Ugo di Cluny (1088): nuovi elementi Giulia Ammannati 665
Notizie degli allievi della Classe di Lettere e Filosofia 677
English Summaries 685
Autrici e Autori 691
Indice dei nomi 695
Illustrazioni 723
Le carte lucchesi del processo inquisitorialedi Michele di Alessandro Diodati(aprile 1559-aprile 1560)Simonetta Adorni-Braccesi
1. Premessa
L’apertura al pubblico del fondo criminale del tribunale arcivesco-vile di Lucca è una notizia destinata a suscitare forti aspettative fra gli studiosi del Cinquecento religioso e dell’Inquisizione. Soddisfano, in particolare, queste aspettative le filze superstiti del processo intentato dall’Inquisizione romana nel 1558 a Michele di Alessandro Diodati�, uno dei cittadini più prestigiosi nella Lucca del Cinquecento, padre di Carlo, emigrato religionis causa a Ginevra nel 1567�, e avo di Giovanni, celebre teologo ginevrino�.
Attraverso una pluralità di testimonianze, nessuna peraltro confron-tabile, come vedremo, per abbondanza e qualità di informazioni, con quella resa dallo stesso Michele Diodati nei propri articuli difensivi, queste carte ci restituiscono il modo nel quale i Lucchesi, fra gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo sedicesimo, entravano quotidiana-mente in contatto con le nuove idee religiose. Questa documentazione ci consente, non meno, di conoscere le modalità di difesa, messe effet-
Desidero qui ringraziare monsignor Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano e direttore scientifico dell’Archivio storico diocesano di Lucca, don Marcello Brunini, direttore amministrativo, e il dr. Pierantonio Piatti, vicedirettore scientifico, insieme con il personale dell’Archivio per la loro disponibilità. Ringrazio altresì il dr. Sergio Nelli dell’Archivio di Stato di Lucca.
1 Archivio storico diocesano di Lucca (AsdLu), Tribunale Ecclesiastico (TE), Fondo Criminale (FC), Processo Diodati, segnatura provvisoria 87 (pp. 1-114); segnatura prov-visoria 83 (pp. 1-213).
2 Si veda M. Turchetti, s.v. Diodati, Carlo in Dizionario Biografico degli Italiani, 40, Roma 1991, pp. 171-4.
3 La biografia più completa di Giovanni Diodati rimane ancora oggi quella di E. de Budé, Vie de Jean Diodati, Lausanne 1869.
�64 Simonetta Adorni-Braccesi
tivamente in atto da un imputato nel corso di un processo istruito dal tribunale romano dell’Inquisizione in un periodo relativamente preco-ce della sua attività. Un’acquisizione, quest’ultima, da mettere in par-ticolare rilievo, perché «nell’ambito dei fondi inquisitoriali conosciuti e accessibili alla ricerca – come afferma Massimo Firpo – gli atti delle difese degli imputati sono nel complesso assai rari»4, soprattutto quan-do l’imputato processato dal Sant’Uffizio è un laico�. Dalle disposizioni inviate al vescovo di Lucca dal commissario generale dell’Inquisizione, il domenicano Tommaso Scotti da Vigevano, ma non meno dalle de-posizioni dei testimoni a favore o a carico del Diodati, si apprende inol-tre come funzionava in quel tempo a Lucca l’Inquisizione vescovile, l’unico tribunale ecclesiastico deputato a giudicare in materia di fede in una città che non accolse mai un inquisitore delegato6. Qui, anzi, dal 1545 era attivo un «Offizio sopra la Religione», magistratura laica, ad-detta a controllare che i cittadini si conformassero, nei comportamenti esteriori, ai precetti della Chiesa e a punire gli inadempienti e i «chiariti eretici»�.
Chi scrive aveva potuto utilizzare, già in passato, alcuni documenti del fondo criminale nella stesura di una monografia sulla repubblica di Lucca nella crisi religiosa del Cinquecento: il più eloquente era costitui-to dal processo di Rinaldino da Verona, un soldato arruolato al servizio della Repubblica, il quale, negli anni centrali del secolo, era stato con-vertito alla Riforma da un frate del convento di San Frediano che aveva fatto propri gli insegnamenti del priore, don Pietro Martire Vermigli�. Mosso da uno zelo missionario quasi mistico, Rinaldino, che aveva
4 M. Firpo, Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Mo-rone (1509-1580) e il suo processo d’eresia. Nuova edizione riveduta e ampliata, Brescia 2005, pp. 371-98: 373.
5 Ibid., pp. 375-7.6 Si veda S. Adorni-Braccesi, «Una città infetta». La repubblica di Lucca nella crisi
religiosa del Cinquecento, Firenze 1994, pp. 319-85; S. Ragagli, Il mercante come in-quisitore nella libera Lucca del Cinquecento, in G. Paolin (ed.), Inquisizioni: percorsi di ricerca, Trieste 2001, pp. 131-80.
7 Adorni-Braccesi, «Una città infetta», pp. 420-1, e Ragagli, Il mercante come inquisitore, pp. 131-6.
8 Adorni-Braccesi, «Una città infetta», pp. 256-7; sul soggiorno lucchese del Ver-migli si veda in particolare Ph. Mc Nair, Peter Martyr in Italy. An Anatomy of Apo-stasy, Oxford 1967, pp. 206-38.
�6� Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
avuto la possibilità di frequentare anche le dimore di alcuni patrizi, nei suoi costituti offre una prospettiva molto articolata sulla diffusione del dissenso religioso a Lucca, ma pur sempre condizionata dalla sua estra-zione sociale di soldato forestiero.
Fino al rinvenimento dei documenti processuali attinenti a Michele Diodati bisognava ricorrere pertanto alle memorie redatte a Ginevra, dagli esuli e dai loro discendenti, per sapere come i patrizi lucchesi era-no entrati in contatto e quindi avevano aderito alle idee della Riforma; fra quegli scritti si distingue il bellissimo Libro di ricordi degnissimi delle nostre famiglie, redatti in prima persona o raccolti da Vincenzo di Fa-brizio Burlamacchi�.
Il processo a Michele Diodati segnò inoltre la fine di un’epoca. No-nostante l’adesione, talora notoria, al credo della Riforma, nessuno dei cittadini di governo aveva conosciuto l’umiliazione del carcere, i pro-cessi, le abiure, né a Lucca, né a Roma, fino al pontificato di Paolo IV. Certo due fra i mercanti più prestigiosi, Francesco Micheli e Vincenzo Buonvisi, erano stati denunciati come eretici, fra il 1551 e il 1552, da un gruppo costituito da sensali e artigiani, capeggiati da un uomo d’affari di modeste fortune, Agostino Puccini, e ispirati anche da un canonico della cattedrale, Domenco Menocchi�0. Rivalsa sociale, ambizioni o ven-dette personali, vaghe intese con l’Inquisizione romana e col duca di Fi-renze stavano sullo sfondo di questa vicenda, la quale lasciò comunque illesi gli accusati, sebbene Francesco Micheli aderisse già pienamente alla Riforma��, mentre procurò ai delatori, fra altri disagi morali e ma-teriali, anche la condanna alle galere e la scomunica��. L’impunità dei lucchesi, sul piano religioso, costituiva e aveva costituito una sfida so-
9 V. Burlamacchi, Libro di ricordi degnissimi delle nostre famiglie, ed. S. Adorni-Braccesi, Roma 1993.
10 M. Berengo, Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, Torino 1999 (1965), pp. 436-8; Adorni-Braccesi, «Una città infetta», pp. 222-32.
11 Adorni-Braccesi, «Una città infetta», pp. 228-30. Francesco Micheli, a Lione, «aderiva alle opinioni degli eretici», secondo Pietro Carnesecchi, già nel 1547 (M. Fir-po, D. Marcatto, I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi [1557-1567], 2, Città del Vaticano 2000, p. 1043).
12 Agostino Puccini venne condannato alle galere il 3 febbraio 1552 e Domenico Me-nocchi venne scomunicato nel corso dello stesso mese (U. Bittins, Das Domkapitel von Lucca im 15. und 16. Jahrhundert, Frankfurt 1990, pp. 305-8: 305-6); Adorni-Bracce-si, «Una città infetta», pp. 227-9.
�66 Simonetta Adorni-Braccesi
prattutto per Gian Pietro Carafa, il membro più influente dell’Inquisi-zione e quindi papa come Paolo IV, desideroso di umiliare quella che a suo dire, già dal 1550, era una fra le «città più infette d’Italia»��, ma non meno ansioso di trovare un appannaggio per i propri nipoti. Su uno scacchiere internazionale dominato fra il 1557 e il 1559 dalla guerra fra gli Asburgo e i Valois e contrassegnato dal ritiro progressivo di Carlo V dalla scena pubblica, ancora una volta la diplomazia repubblicana avrebbe comunque trovato una strada per evitare la temuta annessione al ducato mediceo�4.
2. Il «venerando» Michele Diodati, mercante e uomo di governo
Il segno tangibile della fine di una quasi totale impunità goduta fino allora dai patrizi lucchesi fu nel 1558 la convocazione a Roma di due di loro, Matteo Gigli e Michele Diodati, accusati di eresia��. Il Gigli, il cui casato era destinato prevalentemente «a conservarsi con l’aiuto delle entrate ecclesiastiche, non avendo ventura nelle cose della mercatura»�6, fra gli anni Trenta e Quaranta, aveva fatto parte di una colta e diramata «trafila erasmiana», per usare un’espressione di Salvatore Caponetto��, che, accanto ai mercanti e alle loro donne, ospitava anche letterati come Ortensio Lando e poi Aonio Paleario. Più tardi il Gigli ricoprì un ruo-lo preminente all’interno di una vasta conventicola ereticale, l’Ecclesia Lucensis, la cui consistenza e i cui membri erano stati resi noti all’Inqui-sizione vescovile dal soldato Rinaldino��.
Michele di Alessandro Diodati, «mercator in mercatura et negociis publicis Reipublicae Lucanae versatus», uso a frequentare «diversas mundi partes», «semper in eius vita et actionibus […] morigeratus, pro-bus vir, et amator et benefactor pauperum», era uno dei cittadini più
13 Adorni-Braccesi, «Una città infetta», p. 319.14 Ibid., pp. 350-67.15 Ibid., p. 368.16 Ibid. p. 14.17 S. Caponetto, Aonio Paleario (1503-1570) e la Riforma protestante in Toscana,
Torino 1979, p. 120.18 S. Adorni-Braccesi, s.v. Gigli, Matteo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 54,
Roma 2000, pp. 686-8.
�6� Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
influenti della Repubblica��. Di continuo eletto come Anziano, a partire dal 1543 fino al 1577, avrebbe ricoperto, nel corso dell’intera esistenza, per ben sette volte la carica di Gonfaloniere, la più prestigiosa dell’anti-ca città-Stato�0. Nel settembre 1541, allorché qui ebbe luogo l’incontro fra Carlo V e Paolo III, Michele ospitò nel proprio palazzo Margherita d’Austria, figlia di Carlo V, e vi accolse persino l’imperatore recatosi a visitarla��. Già dal 1532 gli eredi di Alessandro Diodati, fra i quali Mi-chele e Nicolao, occupavano il secondo posto fra i centocinquanta cit-tadini che godevano del reddito più elevato, preceduti solo dagli eredi di Benedetto Buonvisi, loro congiunti e con i quali facevano compagnia d’affari, in particolare, sulle piazze rivali di Lione e Anversa��. Incline alla Riforma era stato con certezza Nicolao, a cui «il Signore aveva fatto la gratia […] di conoscere la verità della religione –come scrive il figlio Pompeo – per mezo di messer Pietro Martire Vermigli, il quale in quel tempo […] predicava a Lucca liberamente»��. Nicolao aveva quindi «ri-soluto di partirsi di Lucca con la famiglia per ritirarsi da l’idolatria», ma glielo aveva impedito una morte precoce sopraggiunta nel 1544�4. Michele, da parte sua, allorché nei mesi di luglio e agosto 1543 ricopriva la carica di gonfaloniere, aveva svolto, secondo la testimonianza del cro-nista Giuseppe Civitale, un ruolo fondamentale nella «notabil conver-sione» del giovane gentiluomo Pietro Fatinelli�� che, l’anno precedente, aveva congiurato contro l’oligarchia lucchese, colpevole, ai suoi occhi di
19 Le citazioni nel testo sono tratte da AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, pp. 69-78 [Articuli] ad docendum de innocentia magnifici domini Michaellis Deodati, in part. pp. 71-2. Gli Articuli sono numerati da 1 a 33.
20 Michele Diodati nacque a Lucca nel 1510, dove morì nel 1582 (M. Seidel, R. Sil-va, Potere delle immagini, immagini del potere. Lucca città imperiale: iconografia po-litica, Venezia 2007, p. 347). Fu gonfaloniere nel 1543, 1549, 1555, 1566, 1561, 1572 e infine nel 1577. Si veda G. Tommasi, Sommario della storia di Lucca […] seguito da una scelta degl’indicati documenti per cura di Carlo Minutoli, Firenze 1847 (rist. anast. Bologna 1975), Documenti, pp. 227-9, e M. Fulvio, Una famiglia lucchese: i Diodati, «Actum Luce. Rivista di studi lucchesi», 12, 1983, pp. 7-31: 17.
21 Seidel, Silva, Potere delle immagini, p. 348. 22 Fulvio, Una famiglia lucchese, pp. 10-1.23 Burlamacchi, Libro di ricordi, p. 138.24 Ibid. Nicolao era nato a Lucca nel 1511 (ibid., p. 137).25 L’espressione è tratta da G. Civitale, Historie di Lucca, ed. M.F. Leonardi, Roma
1983-88, 2, p. 544. Le Historie vennero scritte dal Civitale nella seconda metà del Cin-
�6� Simonetta Adorni-Braccesi
«malgoverno» cioè di tirannia, ma non meno di «malsentire» in materia religiosa�6. Secondo una tarda, ma attendibile testimonianza ginevrina, Filippo Calandrini, un autentico oligarca, seguace del Vermigli, aveva composto e poi dato alle stampe, poco dopo l’esecuzione del Fatinelli, un libretto, nel quale aveva messo a punto una sottile operazione apolo-getica, al contempo della classe di governo e del movimento filo-rifor-mato��, libretto dal quale avrebbe attinto lo stesso Civitale��. Il Fatinelli infatti, durante la veglia precedente la propria esecuzione, avvenuta il 29 ottobre 1543 e, successivamente, sul patibolo, come si legge nella cronaca del Civitale, avrebbe condannato decisamente il significato politico del proprio gesto e, insieme, manifestato la piena, tranquilla consapevolezza della salvezza della propria anima, nei termini di una religiosità decisamente influenzata dall’insegnamento del Vermigli��. Nelle parole attribuite al Fatinelli, il cronista Giuseppe Civitale faceva emergere il ruolo decisivo avuto dal Diodati nella conversione religiosa del giovane ribelle:
Hora giudicate, fratelli, quanto siano fallaci gli aiuti et i remedij umani a comparatione del vero aiuto. E con tutto questo gli occhi miei erano ancora in tenebre, se il benedetto padre non avesse fatta alcuna provisione per la mia
quecento e per allora rimasero inedite (ibid., p. 3). Si veda la descrizione della «notabil conversione» (ibid., pp. 544-56).
26 S. Adorni-Braccesi, Eterodossia e politica nella «notabil conversione» di Pietro Fatinelli (1542-1543), «Critica storica. Bollettino A. S. E», 27, 1990, pp. 209-34: 211-2 e 220. Si veda inoltre C. Asso, s.v. Fatinelli, Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, 45, Roma 1995, pp. 321-4.
27 Dobbiamo queste informazioni a Benedetto o Bénédict di Jean-Louis Calandrini (Ginevra 1639-1720), autore delle Memorie familiari della famiglia Calandrini (Mémoi-res touchant la famille de Calandrin). Egli aveva parzialmente utilizzato e forse tradotto in francese il libretto menzionato, che presenta precise corrispondenze con parti del testo del Civitale (Adorni-Braccesi, Eterodossia e politica, pp. 214-5).
28 Mazzino Montinari aveva rilevato «echi valdesiani» nel racconto della «notabil conversione» del Fatinelli, tramandata dal Civitale; Marino Berengo vi aveva ravvisato uno dei molti «libretti luterani» che circolavano per la città (Berengo, Nobili e mer-canti, pp. 438-9). Una più recente lettura del testo si deve a L. Lazzerini, «Nessuno è innocente». Le tre morti di Pietro Pagolo Boscoli, Firenze 2002. Per un profilo biografico di Filippo Calandrini si veda F. Luzzati Laganà, Calandrini, Filippo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 16, Roma 1973, pp. 444-7.
29 Adorni-Braccesi, Eterodossia e politica, p. 216.
�6� Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
salute, il quale, vedendomi senza luce, fece che il Magnifico Gonfaloniero venne a me, eletto però da Lui, per instrumento di ridurmi alla sua cognit-tione e della mia ignoranza e dappocaggine, e dicovi che io stesso resto molto obbligato a M.D.�0.
ovvero Michele Diodati. Rivolto al Calandrini, che lo assisteva nella ve-glia di penitenza, il Fatinelli raccomandava di scrivere al Diodati, allora in Anversa,
con dirli che io conosco la cognizione che io ho da Dio haverla per suo mez-zo come instrumento del padre, e che non avendo io a vivere qua, poi che io non li posso far altro, sempre pregherò per lui, perché ora vado al padre, lasciando il mondo��.
Nella versione del libretto, tramandata a Ginevra, il condannato, av-viandosi al patibolo, avrebbe rifiutato ogni immagine, croce o crocifis-so, affermando che «quando si ha Gesù Cristo stampato nel cuore non si ha bisogno di altra immagine»��.
Saremmo tentati di mettere in relazione queste parole del giovane «convertito» con analoghe espressioni, attribuite nel 1559 a Michele Diodati dal suo principale accusatore, prete Nicolao Fanucchi da An-traccoli. Il gentiluomo nel 1546, durante la messa, al momento del-l’elevazione, secondo prete Nicolao, si copriva gli occhi con le mani. Ammonito dal sacerdote a non dare «scandalo» agli «ignoranti » né da «mormorare «a quanti lo vedevano», «si cittadini come contadini», il Diodati gli avrebbe risposto: «ogni huomo attendi a far i fatti suoi che io so che lo vedo meglio io con il cuor che non fanno loro con gli oc-chi»��.
30 Civitale, Historie, 2, p. 544.31 Ibid. Michele Diodati si era recato a Anversa col giovanissimo Turco Balbani nel
settembre precedente (Burlamacchi, Libro di ricordi, p. 113).32 Benedetto o Bénédict Calandrini cita direttamente dal libretto: «Lors qu’on le fit
sortir de prison pour le conduire au lieu du supplice il ne voulut aucune image, ni croix, ni crucifix disant: quand on a Jésus Christ gravé dans le coeur on n’a pas besoin d’autre image» (Adorni-Braccesi, Eterodossia e politica, pp. 214, 222). Questo brano non è riportato dal Civitale.
33 AsdLu, TE, FC, Processso Diodati, 87, pp. 9-15, costituto di prete Nicolao Fanuc-chi d’Antraccoli, «sacerdos Lucanae diocesis et cappellanus ecclesiae Sancti Columbani
��0 Simonetta Adorni-Braccesi
Da questo momento fino al 1559 conosciamo le opinioni religiose del Diodati solo grazie alle sue disposizioni testamentarie del 13 settembre 1555. Contrario a ogni esterna pratica del culto, il patrizio lucchese precisa addirittura che, se gli eredi gli tributeranno esequie solenni e comportanti una spesa superiore ai dodici scudi, come mette in rilievo Marino Berengo, ciò «sit super conscientia ipsorum quia contravene-runt menti et voluntati ipsius testatoris»�4. «Nessun nobile lucchese ha, inoltre, come lui – prosegue Berengo – vietato alle figlie di monacarsi prima di avere compiuto diciotto anni»»��. Anche dopo l’arresto per eresia di fra Girolamo da Pluvio, vicario del convento di Sant’Agosti-no, e la sua la fuga, nell’estate del 1542, Michele rimase devotissimo al convento e alla sua chiesa, come tutti i membri della sua famiglia�6. Egli ribadisce questa sua fedeltà nell’articolo trentesimo della sua difesa:
Idem dominus Michael semper solitus fuit quoddam anniversarium in ec-clesia Sancti Augustini celebrari facere, prandia fratribus eiusdem ordinis exhibere, certamque quantitatem grani eisdem persolvere��.
Ne verrà ricompensato allorché, insieme con altri membri del clero, lo stesso priore di Sant’Agostino, fra Paolino Campioni da Lucca, verrà a deporre in suo favore presso il vicario del vescovo, il 14 giugno 1559, scagionandolo dalle accuse di eresia��.
Michele Diodati era stato infatti convocato a Roma dall’Inquisizione il 28 marzo 1558��. Grazie alla mediazione del cardinale milanese Gio-van Angelo de’ Medici, prossimo a divenire il successore di Paolo IV, col nome di Pio IV, riuscì però a rinviare la partenza fino al novembre
pleberii Subgrominei, Lucanae diocesis […], examinatus et interrogatus diligenter su-per articulis et interrogatoriis in dictis litteris introclusis»: 18 aprile 1559, in part. p. 9. La trascrizione qui e in seguito è sempre fedele al testo.
34 Berengo, Nobili e mercanti, p. 447.35 Ibid.36 Marino Berengo fa notare il singolare attaccamento al convento agostiniano che
emerge dalle disposizioni testamentarie di Michele Diodati nel 1563 (ibid., p. 364).37 AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, p. 77.38 AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 83, pp. 34-9, costituto di fra Paolino di Nanni
Campioni da Lucca «prior modernus monasterii et conventus Sancti Augustini»: 14 giugno 1559, in part., p. 34.
39 Adorni-Braccesi, «Una città infetta», p. 368.
��� Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
successivo, quando dovette lasciare il suo ruolo di Anziano ricoperto in quei giorni40. La Repubblica aveva tentato di risparmiargli il viaggio, allegando l’impossibilità per un Anziano di interrompere la durata della carica, ma, di fronte alle accuse romane di favorire un eretico, il governo aveva dato ordine al giurista Vincenzo dal Portico, suo rappresentante presso la curia pontificia, «di non spendere il nome pubblico in giustifi-cazione di particolari»4�. Il cronista Gherardo Burlamacchi riferisce che il Diodati «fu accusato da un furfante prete, perché avesse detto havere poca fede in preti» e che, per questo, «Vincenzo, suo fratello gli scosse le spalle con un randello in piazza il ’59 di agosto e andossi al vescovo»4�. La vicenda dell’odio insorto fra il prete di campagna e il potente citta-dino lucchese, ancora tutta da chiarire, è vivacemente esposta nel quat-tordicesimo articolo della difesa del Diodati4�. Le cose sarebbero andate così: il patrizio lucchese avrebbe fatto in maniera che gli uomini di San Pancrazio, località del contado lucchese, dove egli dimorava spesso in una sua villa44, facessero cacciare dal rettore della pieve4�, «ob certum scandalum», prete Nicolao Fanucci d’Antraccoli, che lì prestava servi-zio come cappellano46. Carico di odio e di inimicizia verso il Diodati, il prete di campagna si era sfogato a vituperarlo e a minacciarlo in ogni luogo, non riuscendo a contenere la sua ira neppure davanti all’altare4�.
40 Ibid.41 Berengo, Nobili e mercanti, p. 447.42 Biblioteca di Stato di Lucca (BSLu), ms. 1941, sec. XVI, G. Burlamacchi, Notizie
della famiglia Burlamacchi e memorie storiche, c. 92v. 43 AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, pp. 73-4. 44 Si veda I. Belli Barsali, Ville e committenti dello Stato di Lucca, Lucca 1979, pp.
389-90.45 Sulla pieve di San Pancrazio, sita nel territorio lucchese delle Seimiglia, si veda G.
Concioni, C. Ferri, G. Ghilarducci (edd.), Lucensis ecclesiae monumenta, a saeculo VII. usque ad annum 1260, Lucca 2008, 2, pp. 97-120.
46 «Item ponit quod cum quidam presbiter Nicolaus Fanuccii de Antraccole Lucanae diocesis inserviret pro cappellano plebis Sancti Pancratii eiusdem Lucanae diocesis, in quo loco idem dominus Michael habet quandam suam villam in qua multotiens mora-tur, ob certum scandalum per eundem presbiterum in comuni plebis Sancti Pancratii causatum uti testes deponent, idem dominus Michael curavit quod homines dicti co-munis facerent per rectorem dictae plebis eundem presbiterum Nicolaum de dicto loco eiici, et repelli» ( AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, p. 73).
47 «non modico cum dicti presbiteri dedecore, quas ob causas idem presbiter Nico-
��� Simonetta Adorni-Braccesi
Nel preciso momento, nel quale aveva preso congedo dai propri parroc-chiani, il Fanucci avrebbe infatti proferito queste o parole simili, cariche di minacce: «Homini miei io mi parto per causa del venerando Michele Diodati, ma farò in modo che fra pogo tempo haverà bisogno di me»4�.
Bestemmiatore, giocatore incallito, dedito anche a giochi proibiti, mendace, uomo insomma di bassa condizione e fama è inoltre prete Fanucchi per il «venerando» Diodati4�. Uomo probo, in grado di affron-tare passabilmente la cura delle anime, mai inquisito o denunziato per crimine alcuno�0, è invece lo stesso per il suo vescovo, Alessandro Gui-diccioni, che, il 6 luglio 1559, si recò a testimoniare presso il suo proprio vicario, il dottore in utroque Giovanni Oliva da Perugia, in presenza e con l’assistenza del priore dei domenicani di San Romano, fra Angelo Bettini da Firenze��, in favore di Michele Diodati, da lui definito suo proprio «figlio spirituale»��.
laus adeo odiosus et inimicus factus fuit eidem domino Michaelli ut publice de eodem domino Michaelle obloquutus fuerit pluribus in locis et illi minando et in spetie ante altare praedictae parrochialis ecclesiae» (ibid.).
48 «coram hominibus parrochianis dicti loci dum esset discessurus de dicto loco ut supra eiectus dixit haec vel similia verba: “Homini miei io mi parto per causa del vene-rando Michele Diodati, ma farò in modo che fra pogo tempo haverà bisogno di me”, cum pluribus aliis verbis minatoriis et malum animum ipsius presbiteri Nicolai ostendendo prout testes de praemissis informati plenius specificabunt palam» (ibid., p. 74.)
49 «Homo male conditionis et fame solitus blasfemare Deum, lusor et ad plures ludos prohibitos, detractor solitus calumniare et plura mendacia dicere aliaque etiam deterio-ra facere» (ibid.).
50 «Dixit quod habet dictum presbiterum Nicolaum pro presbitero probo et tolle-rabili ad curas animarum exercendas […] et quod tempore suo in curia episcopali sua numquam fuit de aliquo crimine inquisitus vel denuntiatus» (AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 83, pp. 212-13, costituto di Alessandro Guidiccioni, vescovo di Lucca, 6 luglio 1559, in part. p. 212).
51 «Reverendissimus dominus dominus Alexander Guidiccionus […] episcopus Lu-censis […] constitutus personaliter coram praefato Johanne Oliva […] in praesentia et cum assistentia venerabilis patris fratis Angeli de Bettinis de Florentia» (ibid., costituto di Alessandro Guidiccioni, vescovo di Lucca, 6 luglio 1559, p. 212). Sul Bettini, che aveva partecipato in qualità di teologo alle sessioni VII, VIII e IX del concilio di Trento, si veda A.F. Verde, D. Corsi (edd.), La «Cronaca» del convento domenicano di San Romano di Lucca, «Memorie Domenicane», n.s., 21, 1990, pp. 258-9.
52 «Item interrogatus super 3 interrogatorio dixit quod non est affinis vel consan-guineus nec intimus amicus dicti domini Michaellis sed est amicus communis et tenet
��� Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
3. Le carte superstiti del processo di Michele Diodati (aprile 1559-1 apri-le 1560)
La prima carta superstite della «causa che verte davanti di noi», ovve-ro «fra l’Officio [dell’Inquisizione] da una banda, et Michaele Diodati dall’altra» è la lettera inviata, in data 8 aprile 1559, da Tommaso Scotti da Vigevano a Alessandro Guidiccioni, vescovo di Lucca, con la quale il processo entrava nella sua fase formale accusatoria��. Essa accompagna l’invio di alcuni documenti procedurali, ovvero gli «articoli e interroga-torii» su cui a Lucca si doveva effettuare la «repetitione dei testimoni»�4, che vengono nominati in calce��. Mentre sono andati perduti gli «arti-coli e interrogatorii» menzionati, sono invece conservate le deposizioni di undici testimoni esaminati dal vicario del vescovo, fra il 18 aprile 1559 e il 7 maggio successivo�6, secondo le procedure indicate da fra Tommaso Scotti da Vigevano:
però confidandoci della sua solita diligentia et prudentia li committemo la repetitione di detti testimoni et, non potendo intervenir lei personalmente, non manchi di commettere al suo vicario che gli reputa sopra li interrogato-rii et articoli et così, per la presente, vostra signoria reverendissima et il suo vicario et ciascuno di voi lo deputiamo et lo sustituimo in ogni miglior modo et guarderà la lista delli testimoni et li ricordi che vi si contengano��.
eum pro filio spirituali» (AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 83, costituto di Alessandro Guidiccioni, vescovo di Lucca, 6 luglio 1559, p. 213).
53 AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, pp. 3-4, copia della lettera di Tommaso Scotti da Vigevano a Alessandro Guidiccioni, Roma, 8 aprile, 1559, in part. p. 3. L’originale è andato perduto.
54 Ibid.55 Lo Scotti avverte inoltre che «se alcun testimonio nominerà alcuno conteste» è
opportuno «far citare il contesto anchora che non sia posto in questa lista» (ibid., p. 4).56 Una copia delle deposizioni, ovvero il «processum testium examinatorum pro
parte domini Michaellis Deodati et fisci», il giorno 10 aprile 1560, per commissione del vescovo Alessandro Guidiccioni, venne affidata a un «homo a posta», il tessitore Andrea Simi da Lucca, con l’incarico di recapitarla a Roma al commissario generale dell’Inquisizione, fra Tommaso Scotti da Vigevano (ibid., p. 1). Il testo delle deposizioni conservato a Lucca (ibid., pp. 3-44.) è verosimilmente una ulteriore copia.
57 Ibid., p. 3. Aggiungeva inoltre: « Et dopoi che haverà finito l’essamine con quella segretezza che può ne rimanderà lo esamine chiuso sigillato col suo solito sigillo per
��4 Simonetta Adorni-Braccesi
Le accuse più gravi a carico di Michele Diodati provengono, come ab-biamo visto, da prete Nicolao Fanucchi da Antraccoli, ma non meno da un altro e molto più influente membro del clero, Domenico Menocchi, primicerio della cattedrale��, noto allora per essere uno dei canonici più fedeli al Guidiccioni��. A favore del gentiluomo lucchese depongono, fra altri testimoni, anche due mercanti prestigiosi, Girolamo di Lazza-ro Arnolfini, già allora decisamente incline alla Riforma60, e Bernardi-no di Francesco Cenami, uno degli esponenti più in vista dei circoli erasmiani della città, il quale aveva ospitato nel suo palazzo Ferrante Sanseverino, principe di Salerno, allorché questi, nel 1551, stava fug-gendo in Francia per ragioni politiche e religiose6�. Senza anticiparne i contenuti, si deve sottolineare come, sia le testimonianze a carico, sia quelle a favore dell’inquisito, restituiscano il clima di libertà religiosa della quale nel pieno Cinquecento fruivano i Lucchesi, in particolare i patrizi. Nella propria deposizione, per esempio, Domenico Menocchi rievoca con quanta libertà il Diodati, nel 1550, all’uscita dalla chiesa di San Frediano, passando sotto le sue finestre in compagnia di alcu-ni cittadini, già allora fortemente sospetti di eresia, fra i quali proprio
nuncio fedele et pur che le cose vadino secretamente non ci curiamo se ben ci mettiate qualche giorno de più dandoli facoltà che pigli quel notario che li piace dandoli giura-mento sotto pena di scomunica che ‘l debba essere secreto de non rivelando nec dicta testium nec nomina nec cognomina» (ibid.). Le procedure inquisitoriali di questa fase del processo Diodati sono da confrontarsi con quelle descritte da Massimo Firpo e Da-rio Marcatto ne Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edizione critica, Roma 1984, 2/1, pp. 33-4, 589-622, 660-87, e quindi da Firpo, Inquisizione romana e Controriforma, pp. 379-80.
58 AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, pp. 27-32, costituto di Domenico di Gio-vambattista Menocchi, «sacerdos et civis Lucensis ac primicerius ecclesiae cathedralis Lucanae»: 30 aprile 1559, in part. p. 27. Sulle accuse del Menocchi si veda infra, in part. nota 64.
59 Berengo, Nobili e mercanti, pp. 388-9.60 AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, pp. 40-2, costituto di Girolamo di Lazzaro
Arnolfini, « nobilis et spectabilis vir […] civis et mercator Lucensis»: 7 maggio 1559, in part. p. 40. Si veda G. Miani, s.v. Arnolfini, Girolamo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 4, Roma 1962, pp. 266-9.
61 AsdLu, TE, FC, 87, Processo Diodati, pp. 42-4, costituto di Bernardino di Francesco Cenami, «nobilis et spectabilis vir […] civis et mercator Lucensis»: 7 maggio 1559, in part. p. 42. Sul Cenami si veda Berengo, Nobili e mercanti, in part. pp. 119-20, Ador-ni-Braccesi, «Una città infetta», pp. 95-7, e Caponetto, Aonio Paleario, p. 103.
��� Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
Francesco Micheli, commentasse le parole del predicatore, don Celso Massimiliano Martinengo6�:
Quod ipse testis [Domenico Menocchi] vidit pluries et pluries ab anno 1550 citra in diversis temporibus ac in diversis locis Lucensis civitatis dictum do-minum Michaellem conversare Francisco Micheli, Francisco Cattani, Nico-lao Balbani, Paulo Arnolfini et Christoforo Trenta et audire in ecclesia Sancti Fridiani praedicationes articulati Celsi Martinenghi tempore in quo artico-lati et nominati erant habiti tenti et reputati et habebantur et tenebantur et reputabantur heretici et Lutherani et quandoque vidit dictum Michaellem cum nonnullis ex praenominatis redeuntem a dicta praedicatione et dum transirent ante ipsius testis domum audivit ipse testis ipsum Michaellem di-centem aliis qui secum erant hec vel similia verba videlicet: «Ci erano pur per il passato state date ad intender di gran cose»6�.
Dagli articoli difensivi inviati il 6 maggio 1559 a Lucca dal commissa-rio generale dell’Inquisizione, documento di singolare interesse, come avremo modo di apprezzare anche in seguito, si apprende come lo stes-so inquisito vivesse in prima persona a Lucca questo clima di libertà64. Grande mercante, sempre in viaggio per i propri traffici, Michele Dio-dati entrava continuamente in contatto con i costumi e la fede altrui. Nelle terre germaniche, soprattutto, veniva a conoscere le «opinioni degli eretici», e non esitava a riferire in pubblico gli argomenti con cui essi le sostenevano, senza, a suo dire, minimamente condividerle, anzi, come sottolinea anche in seguito, condannandole fermamente:
VIII. Item ponit quod diversis vicibus et diversis temporibus praefatus dominus Michael discessit a civitate Lucana ad diversas mundi partes et postquam ad eandem civitatem Lucanam rediit pluribus publice narravit et
62 L. Ronchi De Michelis, s.v. Martinengo, Celso (Massimiliano), in Dizionario Bio-grafico degli Italiani, 71, Roma 2008, pp. 142-5.
63 AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, pp. 27-32, costituto di Domenico di Gio-vambattista Menocchi, 30 aprile 1559, in part. pp. 28-9. I mercanti Francesco Micheli, Francesco Cattani, Paolo Arnolfini, Cristoforo Trenta e il giurista Nicolao Balbani, al momento della deposizione del Menocchi, erano già fuggiti a Ginevra. Si veda Beren-go, Nobili e mercanti, pp. 442-4.
64 Su questi articoli difensivi si veda infra, in part. nota 74.
��6 Simonetta Adorni-Braccesi
narrare solitus fuit mores externarum nationum et in specie plurimorum Germanorum qui hereticas tenebant opiniones, eas opiniones cum his que dicti heretici pro eis confirmandis dicebant recensendo absque eo quod dictas opiniones ipse dominus Michael crederet et teneret […]6�.
Michele Diodati, nella propria difesa, se da un lato fa mettere in risal-to la continuità dei suoi comportamenti di buon cattolico, fa emergere dall’altro la sua indole di persona incline a parlare liberamente di que-stioni religiose, pur non essendo, a suo dire, uomo di lettere o preparato teologicamente, al punto da venire talora frainteso da coloro che non conoscevano o non volevano conoscere le sue buone intenzioni:
XI. Item ponit quod qualiter praefatus dominus Michael fuit semper solitus libere loqui et tanquam litterarum et terminorum theologorum ignarus, ali-quando potuit in materiis quae religionem concernunt forsan aliquid dixisse, quod ab audientibus, qui eius bonam mentem non cognoscebant vel cogno-scere nolebant, in alium sensum sumptum fuerit quam ab eodem domino Michaelle fuerit prolatum66.
Al contrario, chiunque avesse conosciuto profondamente Michele Diodati – ribadisce la difesa – mai avrebbe creduto che egli potesse ave-re detto qualcosa contrario alla dottrina della Chiesa, se non «ex lubrico lingue», persino «ex quadam animi levitate», o, comunque, solo per ri-ferire «opiniones aliorum»:
Propterea attentis bonis vita et moribus eiusdem domini Michaellis uti Ca-tholici et boni Christiani tanto tempore continuatis, et quod semper impro-bavit opiniones novas hereticorum in rebus fidei, quilibet, qui de dicto do-mino Michaelle notitiam haberet quatenus reperiatur aliquid dictum ab ipso domino Michaelle quod ab ipsa Catholica Ecclesia Romana deviet, quilibet – inquam – teneret et reputaret, id potius eundem dominum Michaellem ex lubrico lingue, vel ex quadam animi levitate qua et gravissimi et prudentissi-mi viri aliquando aguntur vel ut recenseret tantum opiniones aliorum potius dixisse vel protulisse quam ex eo quod id quod protulit teneret et crederet et
65 AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, p. 71. 66 Ibid., p. 72.
��� Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
ita ab omnibus qui de eo notitiam ut supra haberent iudicaretur et reputa-retur palam6�.
Anche nell’articolo nel quale si difende dall’accusa di avere letto libri proibiti6�, Michele Diodati si lascia andare a ammissioni che, insieme con le precedenti, inducono a indagare sulle ragioni per le quali egli poté far ritorno a Lucca nel 1560 «lucido e chiaro come homo dabbene»6�. Certo l’immagine che egli intende dare di sé negli articuli difensivi contrasta con quella dell’uomo di fede e, non meno, di colta sensibilità religiosa, quale è tramandata dal libretto sulla «notabil conversione» del Fatinelli, che non poteva essere stato redatto a sua insaputa. L’insigne cittadino lucchese dovette la sua salvezza, con verosimiglianza, all’intervento del vescovo Alessandro Guidiccioni, la cui deposizione, non priva di incon-gruenze, come si è visto, deve essere attentamente valutata nel contesto di tutto il comportamento tenuto dal presule in questa vicenda.
Uno degli aspetti più interessanti delle carte superstiti del processo Diodati consiste nel modo nel quale esse documentano come l’impu-tato poteva avvalersi del diritto di promuovere un vero e proprio «con-troprocesso», nel quale, come scrive Massimo Firpo, «spettava al reo il compito di indicare i nomi di coloro che il tribunale avrebbe dovuto ascoltare», a sua piena difesa�0. In particolare l’imputato godeva del di-ritto di presentare un preciso questionario, gli articuli difensivi, mentre al Fisco apostolico restava il compito di redigere un suo questionario, gli interrogatoria, da sottoporre preliminarmente ai testimoni��. Con una lettera del 6 maggio 1559, fra Tommaso Scotti da Vigevano inviava al vescovo di Lucca, Alessandro Guidiccioni, «li interrogatorii et articoli dati per la parte di Michele Diodati», sulla base dei quali egli doveva
67 Ibid.68 Nell’articolo ventottesimo il Diodati afferma: «in eventum in quem probetur ali-
quos libros qui in Civitate Lucana fuerint prohibiti legisse vel tenuisse et non aliter, id fuit ante dictum annum 1545» (ibid., p. 73). Il Diodati si riferisce all’elenco di libri indicati come proibiti dal Consiglio di Lucca in data 12 maggio 1545, sul quale si veda Index des livres interdits, J.M. de Bujanda (ed.), 3, Index de Venise 1549. Venise et et Milan 1554, Genève 1987, pp. 580-1.
69 BSLu, ms. 1941, sec. XVI, Burlamacchi, Notizie della famiglia Burlamacchi, c. 92v.
70 Firpo, Inquisizione romana e Controriforma, pp. 372-3.71 Ibid., p. 382.
��� Simonetta Adorni-Braccesi
«examinare li testimoni quali saranno per la parte del detto Magnifico messere Michele Diodati»��. In questo caso si conservano sia gli articuli della difesa��, che gli interrogatoria�4, redatti da Sebastiano Attracino, procuratore fiscale��. Il commissario dell’Inquisizione incaricava quindi il Vescovo medesimo di procedere a
examinare li testimoni quali serranno per la parte del detto magnifico messer Michele et quando serrà il tempo di esaminarli non mancherà di avisare il padre priore di Santo Romano [fra Angelo Bettini] che assisti et sia parte alle examine che se farranno, et se per sorte il priore di San Romano non fusse lì o vero fusse impedito, farete chiamare che assista alla esamina frate Simone da Pescia o vero il sottopriore o vero il padre lettore�6.
A loro il vescovo doveva ricordare di «far esaminare li testimoni se-condo il stile di Roma» ovvero prima «sopra li interrogatorii e poi sopra li articoli»��. Il commissario concludeva il dispaccio invitando il Guidic-cioni a usare grande prudenza nell’uso dei notai qualora questi ultimi non fossero stati esclusivamente al servizio della curia vescovile��.
Gli articoli della difesa indicano come il Diodati fosse pienamente a conoscenza di dove scaturivano le rivalse contro di lui:
72 AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, p. 57.73 Gli articuli vennero spediti da Roma in duplice copia, delle quali una si conserva
ibid., 69-78, una seconda in AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 83, pp. 13-23.74 Gli interrogatoria, redatti in ventuno punti, si conservano in duplice copia in
ASdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, pp. 61-4 e 65-8.75 Su Sebastiano Attracino si veda Firpo, Marcatto, Il processo inquisitoriale del
cardinal Giovanni Morone, 4, pp. 577-8.76 Si veda AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, p. 57. Fra Simone di Salvatore da Pe-
scia, al secolo Giovan Francesco Lotti, «sacerdos admodum apud omnes venerabilis», , il 28 ottobre 1569, vestì l’abito in San Romano, a Lucca dove morì il 30 settembre 1569 (Verde, Corsi [edd.], «La Cronaca», pp. 46 e 79).
77 Ibid. Questo avvertimento, «examinent testes prius super interrogatoriis», è ripe-tuto anche sulla prima carta degli interrogatoria (AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, p. 61). Si veda inoltre Firpo, Inquisizione romana e Controriforma, p. 382.
78 «Et perché messer vicario qua dice che aveva delli notarii della corte sua cqua ama-lati, vostra signoria ne prenda un altro, se li suoi de la corte non possono, ma li dia il giuramento super literis sacris evangelii di non rivelar le examine» (AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, p. 57).
��� Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
XIII. Item ponit quod praefatus dominus Michael dum plura negocia pu-blica in civitate Lucana gessit pluries et pluries fuit in publicis quibusdam officiis ad que spectat et pertinet plura delicta punire��.
Rivalse che affondavano le radici nelle sue dimensioni di uomo di po-tere, a cui spettava anche il compito di giudicare, in determinate occa-sioni, i propri concittadini. Si profila in particolare l’inimicizia con la famiglia Turchi:
XVII. Item ponit quod alias sequuto quodam homicidio in personam Hie-ronimi fratris dicti Michaellis facto per quemdam de familia de Turchis, ob quod homicidium idem de Turchis fuit maxima cum ignominia totius etiam eius familie per iustitiam ultimo supplicio traditus, inter familiam de Turchis et familiam de Deodatis ob id quod inter eos deventum sit ad san-guinem reputatur et tenetur esse inimicitiam pro ut vere esse reputari debet palam�0.
L’inimicizia fu causata dall’assassinio del fratello di Michele, Girola-mo, «mostruoso accidente», perpetrato in Anversa da Simone Turchi nel 1550, come scrive Gherardo Burlamacchi, e reso celebre anche da una novella di Matteo Bandello��.
Michele Diodati era pienamente consapevole in particolare, degli odi che si era attirato per il ruolo, ancora tutto da mettere in evidenza, da lui svolto nel 1552, come membro del Consiglio, nel punire severamente Agostino Puccini e i suoi complici, tra i quali figurava proprio il primi-cerio della cattedrale, Domenico Menocchi, suo implacabile accusatore
79 Ibid., p. 73.80 Ibid., p. 74.81 Si veda il racconto dell’atroce episodio tramandato da Gherardo Burlamacchi in R.
Sabbatini, «Cercar esca». Mercanti lucchesi a Anversa nel Cinquecento, Firenze 1985, pp. 123-6. A Vincenzo Busdraghi, editore lucchese che, nel 1554, pubblicò le Novelle del Bandello in tre volumi, venne impedito di inserirvi quella relativa a Simone Turchi, come scrive lo stesso Bandello, «a instanza de li parenti di esso Simone». La novella «Simone Turchi ha nemistà con Gieronimo Deodati lucchese: seco si riconcilia, e poi, con inaudita maniera lo ammazza, ed egli vivo è arso in Anversa», venne pubblicata come ventisettesima nel quarto volume della raccolta, edito a Lione nel 1577 (M. Bandello, Le opere, ed. F. Flora, Milano 1934-35, 1, p. xlvii, 2, pp. 801-2, 803-20). Si veda inoltre Fulvio, Una famiglia lucchese, p. 14.
��0 Simonetta Adorni-Braccesi
XIX. Item ponit quod alias in civitate Lucana fuit detectum etiam per legiti-mas reorum confessiones et alias probationes fide dignas quod quidam Au-gustinus Puccini, Iohannes Baptista Liena, Ioseph Massei, Ioannes Massei, Hieroninus Mordecastelli, Andreas Torellus et Dominicus Menochi qua-sdam falsas attestationes fecerunt contra aliquos cives Lucanos�� ob quam falsitatem plures ex praedictis in varias et diversas penas per Consilium Ge-nerale civitatis Lucanae condemnati fuere in quo Consilio idem dominus Michael interfuit […]��.
Questi articoli difensivi, mentre obbligano da un lato a scavare più in profondità dentro alcune pagine di storia della Repubblica, si collegano dall’altro a uno dei capi di accusa più pericolosi formulati dal procura-tore fiscale Sebastiano Attracino a carico del Diodati:
XXI. Item interrogentur an sciant vel dici audiverint quod praefatus Michael sit solitus se opponere semper executioni litterarum apostolicarum et quando petitur beneplacitus et consensus Reipublicae in executione litterarum apostolicarum semper in consiliis et aliis publicis oficiis idem Michael insurgit contra volentes exsequi litteras apostolicas vel aliis contradicentibus inheret�4.
Insomma a Roma si era individuato nel patrizio, come sembra, uno dei più tenaci difensori della giurisdizione della Repubblica nei con-fronti delle ingerenze ecclesiastiche e di quanti le sostenevano a Lucca, e per questo lo si voleva colpire nel suo lato debole, cioè attraverso quelle che, forse, erano o erano state le sue inclinazioni verso la Riforma.
Il vicario del vescovo, Giovanni Oliva da Perugia, secondo le dispo-sizioni ricevute da Roma, «in praesentia et cum assistentia», di alcuni domenicani del convento di San Romano, in particolare il fiorentino Angelo di Pietro Bettini, allora priore��, dal 13 giugno al 6 luglio 1559 interrogò quarantasei testimoni�6, ecclesiastici e laici, indicati dallo
82 «Inter quos erat etiam idem dominus Michael» cancellato nel testo ( AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, p. 75).
83 Ibid. Sulla partecipazione di Domenico Menocchi alla congiura di Agostino Pucci-ni si veda Adorni-Braccesi, «Una città infetta», p. 224, 227-8.
84 AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, p. 64.85 AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 83, p. 11.86 Le deposizioni sono ibid., pp. 25-213.
��� Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
stesso Diodati, e convocati dal fratello Vincenzo, fra tutti i quali il più autorevole, non occorre dirlo, era proprio il vescovo Alessandro Gui-diccioni, che venne a deporre per ultimo��. Sotto il profilo della storia civile e religiosa lucchese questa documentazione, di grandissimo inte-resse, rivela la compattezza di un campione altamente rappresentativo del corpo sociale cittadino, disposto a testimoniare a favore di un uomo che incarnava, per il prestigio familiare e il proprio individuale cursus honorum, le autonomie della Repubblica, anche nei confronti della Chiesa romana��.
Una lettera del 15 luglio successivo, indirizzata dal commissario ge-nerale dell’Inquisizione al vescovo di Lucca��, contiene il formulario re-datto a Roma per interrogare il capitano Antonio Guidiccioni, nipote di Bartolomeo, che era stato vescovo di Lucca dal 1546 al 1549 e, come cardinale, anche membro del tribunale dell’Inquisizione�0. La presenza fra i testimoni di questo uomo d’armi lucchese merita grande attenzio-ne: stretto congiunto del vescovo Alessandro, nel 1554 egli era entrato al servizio degli imperiali sotto il comando del marchese di Marignano, Gian Giacomo de’ Medici, fratello del cardinale Giovan Angelo��. Pro-
87 «Post que die decima iunii 1559 inditione seconda dominus Vincentius Deodati civis et mercator Lucensis frater et coniuncta persona dicti domini Michaellis Deodati ac etiam uti ipsius procurator prout de eius mandato constat per instrumentum publi-cum rogatum manu egregii viri ser Michaellis Serantonii notarii publici Lucensis sub suo tempore et datali quod etc. et habita notitia de commissione ipsi domino vicario data de examinandis testibus nominandis pro parte dicti domini Michaellis» (ibid., p. 23). I nomi dei testi seguono ibid., p. 24.
88 I nomi dei testi sono elencati complessivamente in AsdLu, TE, FC, Processo Dio-dati, 87, pp. 91-2, quindi raggruppati per categorie (Parrochianorum, pp. 81 e 95; Re-ligiosorum Instructio, pp. 85 e 97; Dottorum, pp. 83 e 89; Laicorum, p. 87) e accanto a ciascun nome sono indicati, mediante i numeri rispettivi, gli articoli di difesa sui quali i testimoni erano stati interrogati.
89 Tommaso Scotti da Vigevano a Alessandro Guidiccioni, Roma, 15 luglio 1559 (ibid., p. 99).
90 Ibid., p. 101. Antonio di Alessandro Guidiccioni e Lucrezia Menocchi, nato a Luc-ca nel 1502, era stato avviato alla carriera delle armi dallo zio paterno Bartolomeo (C. Sardi, I capitani lucchesi del secolo XVI, «Atti della R. Accademia lucchese di scienze, lettere e arti», 32, 1904, pp. 61-176: 147); cfr. Berengo, Nobili e mercanti, pp. 51-2. Su Bartolomeo Guidiccioni si veda orientativamente R. Becker, Guidiccioni, Bartolomeo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 61, Roma 2003, pp. 320-4.
91 In precedenza Antonio Guidiccioni aveva servito nell’esercito pontificio. Sardi, I
��� Simonetta Adorni-Braccesi
prio nel 1559, al servizio di Cosimo I dei Medici e come suo confidente, il capitano Guidiccioni si era reso inoltre assai sospetto ai concittadini��. Interrogato il 24 luglio coinvolse, in una deposizione dai toni ambigui nei confronti dell’imputato��, anche ser Francesco Mazzarosa, che si recò a testimoniare il giorno successivo�4.
Poco dopo, ovvero il 18 agosto 1559, morì Paolo IV, indicato esplici-tamente come «nemico» della Repubblica dal cronista Gherardo Bur-lamacchi, il quale, ricorrendo a parole di esplicita ammirazione nei confronti del Diodati, riferisce come «rotte le prigioni di Roma, e de l’Inquisizione, Michele haveria possuto uscire et non volse»��.
Il resoconto del Burlamacchi trova piena corrispondenza nella lette-ra del commissario generale dell’Inquisizione scritta al vescovo in data 5 aprile 1560�6. Fra Tommaso Scotti da Vigevano, mentre informa il Guidiccioni dell’incendio che, a Roma, aveva devastato il palazzo del-l’Inquisizione, precisa come «fra le altre scritture non si trov[i]no quelle de messer Michele Diodati», che egli suppone «brusciate» o «robbate»��. Desiderando giungere presto alla conclusione del processo, esorta il ve-scovo a «commettere al notaio che esamini li testimoni a deffesa di Mes-ser Michele» e a mandarne a Roma una copia quanto prima��.
4. Il ritorno a Lucca
Michele Diodati venne assolto il 24 ottobre 1560 e poté fare ritorno a Lucca, sappiamo, «lucido e chiaro come homo dabbene», come traman-da Gherardo Burlamacchi nel suo resoconto della vicenda, tutto teso a
capitani lucchesi, p. 147.92 Berengo, Nobili e mercanti, pp. 266 e 326.93 «Item interrogatus an sciat ipsum dominum Michaellem Deodati publice teneri
pro heretico respondit: chi sì e chi no lo trova per heretico, ma pubblicamente si dice che sia heretico» (AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, pp. 103-4, costituto di Antonio olim Alexandri de Guidiccionibus, 24 luglio 1559, in part. p. 104).
94 Ibid., pp. 104-5, costituto di Francesco olim magistri Antonii Massarosa, 25 luglio 1559
95 BSLu, Burlamacchi, Notizie della famiglia Burlamacchi, c. 92v.96 AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 87, p. 111.97 Ibid.98 Ibid.
��� Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
esaltare la statura e la dignità dell’illustre concittadino��. Senza entrare necessariamente in contraddizione con il Burlamacchi, un altro patri-zio, Nicolao Sergiusti, meno illustre e molto vicino agli ambienti della curia vescovile, riferiva, decisamente in un’altra ottica, che, alla morte di Paolo IV, il Diodati «ottenne per favore tornarsene a Lucha con gros-sa pagaria di rapresentarsi a ugni lor posta de la Inquisizione»�00.
Nemmeno l’assoluzione dissolse il discredito che il processo aveva procurato al Diodati, il quale volle comparire spontaneamente davanti all’«Offizio sopra la Religione» il 12 gennaio 1562, per dissipare i so-spetti, fatti circolare sul suo conto, di avere fatto distruggere alcune immagini sacre nel proprio palazzo�0�. In quella circostanza il patrizio lucchese asserì come, in casa sua, non solo si trovassero le immagini che vi erano già da trenta o quaranta anni, ma «anchora delle altre mis-sovi di nuovo», e venne scagionato anche questa volta�0�. Infine il 30 luglio 1568 Michele Diodati, a nome di Alessandro Buonvisi�0�, e dei loro comuni interessi si presentò, insieme con Francesco Arnolfini�04, davanti all’«Offizio sopra i beni degli eretici», come longe maior pars dei creditori di Giuliano e Benedetto Calandrini, a cui l’Offizio aveva confiscato il palazzo di famiglia�0�. Giuliano, che aveva aderito da tem-po al calvinismo e risiedeva allora prevalentemente in Francia, aveva provveduto infatti, tramite il fratello Benedetto, a alienare per tempo i beni di famiglia�06. Una transazione che era potuta andare in porto, non
99 Tommasi, Sommario della storia, p. 451. Si veda inoltre nota 70.100 BSLu, ms. 837, sec. XVI [Nicolao Sergiusti], Frammenti di cronache lucchesi,
c. 20. S. Adorni-Braccesi, Giuliano da Dezza caciaiuolo: nuove prospettive sull’eresia a Lucca nel XVI secolo, «Actum Luce. Rivista di studi lucchesi», 1980, pp. 89-138: 91-2.
101 Berengo, Nobili e mercanti, pp. 447-8. Ragagli, Il mercante come inquisitore, p. 153.
102 Berengo, Nobili e mercanti, p. 448.103 Alessandro Buonvisi, figlio di Ludovico e Caterina Diodati, rimasto orfano, era
stato avviato alla mercatura sotto la guida dello zio Michele (M. Luzzati, s.v. Buonvisi, Alessandro, in Dizionario Biografico degli Italiani, I5, Roma 1978, pp. 289-95).
104 Sembra trattarsi di Francesco di Girolamo Arnolfini (G. Miani, s.v. Arnolfini, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, 4, Roma 1962, pp. 260-1).
105 S. Adorni-Braccesi, I palazzi degli eretici, in I. Belli Barsali (ed.), I palazzi dei mercanti nella libera Lucca del Cinquecento. Immagine di una città-Stato al tempo dei Medici, Catalogo della mostra, Lucca 1980, pp. 459-67: 462-3.
106 F. Luzzati Laganà, Giuliano Calandrini, in Dizionario Biografico degli Italiani,
��4 Simonetta Adorni-Braccesi
solo con la piena consapevolezza dei soci e congiunti dei Calandrini, fra i quali il Diodati, ma anche grazie alla loro autentica solidarietà. Nel frattempo il terzogenito di Michele e Anna di Martino Buonvisi, Carlo, che aveva lasciato da qualche tempo Lucca per Ginevra, era stato di-chiarato eretico e ribelle dal Consiglio il 3 marzo 1568 e quindi bandito da Lucca�0�.
5. L’Inquisizione, il vescovo, e i domenicani
Le carte superstiti del processo Diodati ci informano non meno, come si è premesso, intorno a procedure inquisitoriali finora sconosciute per la città di Lucca, in particolare sul fatto che alcuni religiosi del convento di San Romano vennero incaricati di assistere il vescovo, o il suo vica-rio nell’esame dei testimoni a favore dell’imputato. Il tentativo da parte dell’Inquisizione, e, in particolare del cardinale Gian Pietro Carafa, di fare breccia a Lucca, tramite i domenicani, risaliva addirittura al set-tembre 1549�0�. Allora era stata data «commissione» per inquisire nella città in particolare al priore, il pistoiese Giovan Battista Bracciolini�0�, e al lucchese fra Paolino Bernardini��0, il primo dei quali era nominato commissario straordinario del Sant’Uffizio���. Le pressioni del governo, ma soprattutto l’intervento dello stesso Bartolomeo Guidiccioni, fecero sì che il provvedimento venisse ritirato: cardinale dell’Inquisizione cer-to, ma non meno cittadino lucchese, il Guidiccioni vedeva infatti con sospetto l’ingerenza di religiosi che provenivano da uno Stato, quello fiorentino, potenzialmente ostile alla Repubblica���. I procedimenti in-quisitoriali dell’estate 1559, finora sconosciuti, contribuiscono a spiega-re meglio i sospetti nutriti allora e in seguito dalle autorità cittadine nei
16, Roma 1973, pp. 455-7.107 Turchetti, Diodati, Carlo, p. 171.108 Adorni-Braccesi, «Una città infetta», pp. 321-6.109 Verde, Corsi (edd.), La «Cronaca», pp. 32 e 251-4.110 G. Tognetti, s.v., Bernardini, Paolino, in Dizionario Biografico degli Italiani, 9,
Roma 1967, pp. 192-5, e Verde, Corsi (edd.), La «Cronaca», pp. 80-1, 308-1.111 Adorni-Braccesi, «Una città infetta», pp. 321-2.112 Ibid., pp. 322-3.
��� Le carte lucchesi del processo inquisitoriale di Michele di Alessandro Diodati
confronti dei religiosi del convento di San Romano, intravisti sempre come una quinta colonna dell’«aborrita» Inquisizione romana���.
Dal costituto di Alessandro Guidiccioni, una fra le carte più dense di informazioni dell’intero processo Diodati, emergono inoltre dettagli inediti e significativi sulle conseguenze esercitate sulla vita religiosa cit-tadina dal breve emanato da Paolo IV il 30 agosto 1555. Questa dispo-sizione pontificia, nel concedere al vescovo di potere udire da solo, in segreto e in forza della sua autorità ordinaria, per la durata di tre mesi, le confessioni delle colpe ereticali, aveva chiuso per allora una trattativa iniziata fra la Repubblica e l’Inquisizione nel marzo dello stesso anno, ancora sotto il pontificato di Giulio III��4. Come ricordava Alessandro Guidiccioni nella sua deposizione,
quod de anno 1555 tempore quo plures iverunt ad abiurandum heresim et ad deferendum��� eorum complices in manibus ipsius testis ut certam gra-tiam a sanctissimo domino nostro Paulo papa quarto emanatam conseque-rentur numquam aliquis fuit qui ipsum dominum Michaellem articulatum detulisset vel nominasset uti hereticum vel de heresi suspectum pro ut ex scripturis et processu propterea tentis et descriptis per ipsum testem videri potest��6,
il nome di Michele Diodati non era mai stato menzionato fra quelli de-gli eretici o dei sospetti, denunciati da numerosi concittadini i quali, nel corso del 1555, si erano recati da lui per abiurare in segreto le proprie opinioni e procurarsi così il perdono elargito dal pontefice.
6. ConclusioniAl termine del capitolo dedicato a La vita religiosa, nella Lucca del
Cinquecento, Marino Berengo deplorava «il quasi completo silenzio delle fonti, che ha cancellato –affermava – tanta parte della storia del
113 Si veda Ead., La Repubblica di Lucca e l’«aborrita» Inquisizione: istituzioni e socie-tà, in L’Inquisizione romana in Italia nell’Età moderna. Archivi, problemi di metodo, e nuove ricerche, Atti del seminario internazionale, Roma, 1991, pp. 233-62: 233, 244.
114 Ead., «Una città infetta», p. 340.115 «Coram episcopo testi» cancellato nel testo (AsdLu, TE, FC, Processo Diodati, 83,
p. 213).116 Ibid.
��6 Simonetta Adorni-Braccesi
movimento riformatore lucchese»���. Grazie soprattutto all’apertura progressiva degli archivi ecclesiastici, i documenti rinvenuti restitui-scono progressivamente la parola ai protagonisti del dissenso religioso lucchese del Cinquecento. In particolare le carte superstiti del processo Diodati si prestano, come abbiamo visto, a due livelli di ricerca. Il primo verte sulle circostanze, del tutto inconsuete, con le quali un laico, citta-dino di una libera repubblica, incarcerato dal Sant’Uffizio sotto l’accusa di eresia, poté non solo mettere in atto una ben documentata procedura difensiva, ma, come sembra, uscire indenne dal processo intentatogli. Il secondo deve far luce piuttosto sulle radici lucchesi dello stesso, ovvero le rivalse sociali, gli odi familiari, e, non meno, le accese rivalità che spaccavano allora la Chiesa cittadina���. Insieme con la fama di eresia, queste ultime minacciavano la stabilità interna della Repubblica, pro-vocando – come scrive Marino Berengo – «il progressivo alienarsi dello spirito pubblico lucchese dal clero, anche da quella parte di esso che gli era sempre stata più vicina e congeniale»���.
117 Berengo, Nobili e mercanti, pp. 357-454, in part. p. 442.118 Si veda ibid. pp. 387-90; Adorni-Braccesi, «Una città infetta», pp. 227-8. 119 Berengo, Nobili e mercanti, pp. 389-90.
Finito di stampare nel mese di febbraio 2010 in Pisa dalle
Edizioni ETSPiazza Carrara, 16-19, i-56126 Pisa