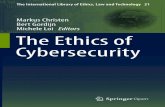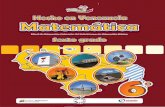Marco Giovenale e Michele Zaffarano: una matematica della realtà
Transcript of Marco Giovenale e Michele Zaffarano: una matematica della realtà
Antonio Loreto
Marco Giovenale e Michele Zaffarano:una matematica della realtà
If number, measure and weighingbe taken away from any art,
that which remains will not be much.(Louis Zukofsky, Anew)
Marco Giovenale e Michele Zaffarano sono autori certamente diver-si tra loro, ma le cui scritture mostrano di avere vaste aree di sovrappo-nibilità, almeno per quel che riguarda alcune strategie di oggettivazione.
Vi è anzitutto l’aspetto delle tecniche di produzione dei testi: proce-dimenti quali il cut-up o il googlism, di cui i nostri si avvalgono larga-mente, bastano forse a indirizzare l’opera verso qualche forma di ogget-tivismo, attribuendole istanze di desoggettivazione importantissime. Bi-sogna però fare attenzione su questo punto, in particolare sull’utilizzo della macchina: come dirò in un saggio allo studio, cui posso qui solo accennare, è da scongiurare il rischio di affidarsi, per simili procedimen-ti, a una immediata e lineare lettura oggettivista, poiché essi comporta-no sì una riduzione del ruolo del soggetto, ma anche, dialetticamente implicata, l’impronta del suo atto fondativo. Decisiva per orientare la riflessione risulterà la lezione sulla riproducibilità impartita da Paolo Virno in Convenzione e materialismo, laddove si mette in evidenza, sulla scorta di un passaggio della Fenomenologia dello spirito di Hegel, come l’esperimento (e qui stiamo parlando di ‘poesia sperimentale,’ o, come si preferisce oggi, di ‘scrittura di ricerca’) si fondi su di una ipotesi teo-rica piuttosto che sul fenomeno empirico-sensibile, e insomma come esso dia luogo a una costruzione dell’esperienza più che a una registra-zione del dato empirico.1 Questo accade anche nel caso in cui l’esperi-
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 249Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 249 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
250
mento non abbia il fine scientifico dell’individuazione di leggi, bensì, com’è per la letteratura sperimentale, la loro infrazione: perché ciò che si produce è in ogni caso un paradigma teorico-operativo, tanto più re-plicabile in quanto lo strumento utilizzato, il software, consiste in un “linguaggio arbitrario e puramente sintattico, privo di referente empiri-co, inabile a rispecchiare qualsivoglia ‘stato di cose’ reale, comprensivo unicamente della possibilità di ‘stati di cose’ ancora da determinare, sem-pre revocabile e sostituibile.”2
La riflessione accennata non vale evidentemente solo per Giovenale e Zaffarano, ma può essere utile a chiarire da subito la natura contrad-dittoria, o come si diceva dialettica, della qualità oggettivista di un’ope-ra come la loro. La quale opera si distingue in particolare, venendo dal metodo ai testi, che del metodo recano evidenti i segni, per una cifra precisa: quella della quantificazione, della numerazione, della misura-zione.
Non si tratta per loro di descrivere (come avviene ad esempio in Fran-cis Ponge), ma proprio di numerare, misurare, quantificare, sotto gli ob-blighi di una sorta di coazione a contare (direbbe Gian Pio Torricelli)3 che sembra riportare la scrittura alla sua origine contabile e mercantile. Giovenale e Zaffarano hanno in effetti dedicato due testi, concomitan-temente ma separatamente, alla nascita/invenzione della scrittura, all’e-poca in cui si poneva in un rapporto 1:1 con le cose ed era anzi fatta di cose essa stessa. Ne riporto due passaggi significativi:
ci sono persone che scambiano delle merci. cibo, bestiame, manufatti, tes-suti.
le merci scambiate vengono significate da oggetti che le riproducono, in scala. animali, vasellame, cose, oggetti vari: hanno le loro riproduzioni in scala. in piccoli tokens.
si chiamano così. sono piccole sfere, cilindri, parallelepipedi, signa conven-zionali.
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 250Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 250 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
251
questi – in numero corrispondente alla vendita – vengono chiusi in una bulla sigillata. memoria e testimonianza della transazione.
per prendere atto di cosa la bulla contiene, per tradurre quali tokens ha in-camerato, si inizia poi a tracciare segni su di essa.
si inizia così a riprodurre all’esterno, cioè sulla superficie della bulla (su ciò che già di suo è una sorta di segno-ventre o pellicola) segni stilizzati che ri-dicono e ripetono gli oggettini chiusi nella bulla. (che a loro volta erano se-gni – appunto tokens).
col tempo, questa moltiplicazione di segni diventa ridondante. o meglio: viene (finalmente) percepita come tale. perché segnare e ri-segnare tante volte? perché token+bulla+segno?
tutto si semplifica (alle spalle di una attestata complessità tuttavia).
tutti i segni si appiattiscono nella tavoletta. si incide su un piano orizzon-tale, dunque in astratto. scompare la bulla. ironia: è scoppiata la bolla. nasce la scrittura.4
con l’invenzione della scrittura inizia la comunicazionesincronica e la comunicazione diacronicadella civiltà umana prima della scritturapossiamo solo fare congetturepartire dai dati archeologici l’invenzione della scritturadiede inizio alla storia l’invenzione della scritturaè legata a esigenze di amministrazione è legataa esigenze di contabilità l’invenzione della scritturaè legata a esigenze di comunicazionenel quarto millennio nacque la scritturanel quarto millennio presso un popolo di originesconosciuta immigrato nella bassa mesopotamia5
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 251Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 251 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
252
Date queste premesse si potrebbe pensare che se il reale è numerabi-le, quantificabile, misurabile allora è un reale oggettivo, nel senso che è fatto di oggetti concreti, oppure nel senso che in maggioranza possiamo essere d’accordo intorno alle sue proprietà. Per Giovenale e Zaffarano le cose non stanno esattamente così, come vedremo.
Per ora vediamo a quali livelli il numero ha un ruolo nella loro scrit-tura. Innanzitutto si rileva un uso massiccio di percentuali e misurazio-ni nel corpo del testo, come in A New House, in Venus & Mars, o in Sca-vate buche nello spazio di Zaffarano,6 o come, nel caso di Giovenale, in Quasi tutti o in Giornale del viaggio in Italia (all’interno del quale tro-viamo un brano intitolato “attività economiche e classi di cose,” e un altro è dedicato alle “pratiche amministrative”).7
In secondo luogo si nota una particolare numerazione di singoli versi, proposizioni, paragrafi, brani. Un esempio significativo – secon-do un uso che fu già di Zukofsky, che numerava ordinatamente i ver-si del suo “Poem beginning ‘The’,” fedele allora ad una linearità che oggi è del tutto saltata – è negli pseudo-sonetti che Giovenale presen-ta in Quasi tutti (nella sezione esordiale intitolata “Piccoli suoni”), co-stituiti di una sequenza, un elenco (forma dall’uso tipicamente com-merciale) di 14 estratti, 14 stringhe di testo numerate giusto dall’1 al 14 (con qualche eccezione)8 in modo che l’allusione al sonetto sia del tutto palese.9
In generale ci troviamo di fronte a opere articolate per false progres-sioni, per numerazioni incongrue, incognite e variabili (nel senso che i numeri sono sostituiti da una x)10 o arrestate su una costante (n).11 Ad esempio Giovenale, in Shelter e in CDK,12 blocca la numerazione delle sezioni e dei paragrafi sul numero 1: un blocco assoluto – per l’Husserl di Filosofia dell’aritmetica ‘uno’ è concetto derivabile senza la necessità di contare13 – che qui serve a indicare una paralisi, l’impossibilità del mutamento, sia di quello che vorrebbe dire guarigione (“la malattia non viene curata, sì numerata,” è scritto in Quasi tutti;14 e in Shelter è cen-trale il motivo della clinica),15 sia di quello che in maniera opposta si dà unicamente come processo di decadimento, di corruzione, di rottura, di
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 252Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 252 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
253
degradazione, di prosciugamento, come in clausola a CDK (dove allora trova spazio qualche tipo di sanità, se non di salvezza):
1la comparsa di chiazze necrotiche può essere usata per monitorare la rottu-ra delle catene molecolari. la manifestation même de
1usa buone lenti, collassa, prosciùgati16
In Zaffarano abbiamo rifiuto del mutamento: “Detesto i mutamen-ti di qualsiasi tipo” scrive in Wunderkammer, dove poco indietro si leg-geva: “ecco una fisicità, mi dico, un senso del tempo che è passato so-prattutto nella mia prosa […]. Ti sei concessa, poi ti sei ammalata, ti sei morta.”17 Quest’ultimo è un passaggio che introduce perfettamen-te alla particolare e del tutto coerente concezione del tempo che so-vrintende alle opere in oggetto: si tratta per loro di ricondurre la mor-te a qualcosa come uno spostamento; così Giovenale: “i nostri vecchi amici dovrebbero essere morti, o spostati, pensammo, mentre per un attimo esitavamo.”18 Il tempo in definitiva si perde nello spazio, come avviene in Numeri primi: “Resti di spazio continuano a picchiare nei resti di tempo”; “Poi sono passati diversi spazi di tempo,”19 dove un’e-spressione metaforica tutto sommato corrente qual è ‘spazio di tempo’ assume un valore del tutto specifico, e mette in evidenza la lettera del testo, anche perché collocata in un brano che insiste sulla dimensione spaziale, nel senso più rigoroso possibile: “assonometrie,” “carta milli-metrata,” misure “80x80.”
È vero che le misurazioni, le quantificazioni, riguardano in qual-che caso il tempo stesso; tuttavia queste interessano perlopiù inter-valli minimi, attimi, istanti (e non per nulla la storia di Giovenale si riduce a “storia dei minuti,” minuti che il corpo del testo traduce infatti come “minimi”).20 Del resto la scrittura – così abbiamo visto parlarne Giovenale e Zaffarano, perlomeno – nasce proprio per fis-
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 253Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 253 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
254
sare uno stato di cose, per tradurre in segni uno stato di cose in un preciso istante, uno stato che deve rimanere stabile, prevenendo la mutazione (fraudolenta, magari) dei contenuti di una transazione commerciale.
Emerge in sostanza una predilezione per la misurazione spaziale, sbilanciando le coordinate spazio-temporali, sottraendo il cronos, con il risultato dell’ormai classico appiattimento della storia sul presente. Insomma la realtà di Giovenale e Zaffarano è una realtà fatta di cose in un modo o nell’altro posizionate (dava giusta rilevanza al concetto di spazio già Cecilia Bello Minciacchi nella postfazione a Criterio dei vetri, citando il Michel Foucault di Naissanse de la clinique).21 Per quan-to riguarda Zaffarano, è suggerito con un breve elenco quale statuto egli attribuisca al tempo: “Cose alle quali io tengo molto: gli anni, gli uomini, gli oggetti, gli animali,”22 dove il tempo è incluso in una clas-se formata da sottoclassi di esistenti, di individuabili. E di nuovo Gio-venale, in modo non dissimile, o assimilabile, in Storia dei minuti scri-ve: “Elica, mietitura, forgia, benna, tornio, rete: | sono cose. Storia: avercele stampate.”23
Gli spazi (foglio di carta a parte) sono questi, preferibilmente: una casa, una camera, una stanza di una clinica. Ma la casa è esposta, in un titolo di Giovenale, oppure aperta (e “ci nevicherà dentro”).24 E la ca-mera è la camera di Dürer,25 una wunderkammer dunque, anche qui, dove la chiusura, la compattezza dello spazio è messa in crisi eccedendo nella ricerca della totalità, ammettendovi una quantità di cose tale da causare l’esplosione dello spazio stesso. Non diversamente vanno le cose in Zaffarano: A New House è comprensiva di un apparato fotografico26 che ritrae angoli di una casa in locazione o in vendita, vuota e niente af-fatto nuova bensì segnata gravemente da decenni di vita domestica or-mai spostatasi altrove, o estintasi (a verificare la sostanziale equivalenza di Giovenale tra morte e spostamento):
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 254Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 254 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
255
Spazi chiusi ma che si aprono (“la casa è chiusa sul campo,” qui di seguito), e spazi vuoti o che si vanno svuotando, che in qualche modo perdono una loro componente, quella storica, vitale, come in generale nella Casa esposta o come in alcuni luoghi di Shelter:
Acqua, luce, quando è morto,e la casa è chiusa sul campoe corpo, e allora può essere il suo –vuole che queste due cose ci siano.
Se non ci sono è perché le mura
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 255Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 255 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
256
sono state rivendute tante volte– allora lui non ha più quella(ma qualsiasi) casa dove puòfare la rivolta della polvererivolgersi a polvere, smetteredi essere e di esserescritto come fanno27
E all’opposto volumi pieni, colmi, zeppi, eccessivamente ingombri di tutto. Allora si tratta di contare le cose, misurare una stanza, uno spa-zio. Non misurare il tempo, però, o almeno abbiamo visto in quali ter-mini sia possibile farlo, perché il tempo è un contenitore eccessivamen-te esatto, perché contiene tutto, possiamo dire evocando lo spirito argu-to di W.V. Quine, il quale, per cominciare a delineare la propria teoria della relatività ontologica, si chiedeva e rispondeva: “Che cosa c’è?” “Tut-to.”28
Bene, non è così semplice per Giovenale e Zaffarano, che respingono la perfetta totalità del reale: essi abitano uno spazio in cui c’è sempre una carenza o al contrario un eccesso. Dal loro personale orizzonte ontolo-gico manca sempre qualcosa, o c’è qualcosa di troppo. Certo è difficile contraddire Quine, e dobbiamo dire che effettivamente tutto c’è. Solo che una parte grande o piccola di quel tutto è nel posto sbagliato. Gio-venale insiste sul termine, in Numeri primi (e altrove),29 e scrive mi-schiando tedesco e italiano, il che rende se possibile l’espressione più ri-levata: “Falsch nella stanza,”30 dove falsch vale falso, sbagliato appunto. C’è poi quel passaggio che induce a ritenere che per Giovenale morire e spostarsi siano la stessa cosa, lo abbiamo visto; che dice che il tempo ce-de il ruolo di fattore di mutazione (per quanto possibile) allo spazio. Ec-co, dovremmo dire che per i nostri autori tutto c’è, ma di quel tutto qualcosa è stato spostato, o a quel tutto qualcosa è stato persino aggiun-to.
Una stanza, dicevo, è un contenitore più opportuno rispetto al tem-po: permette di avere un rapporto a misura di braccia, diretto, 1:1, con
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 256Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 256 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
257
le cose che vi si trovano (o che vi si stipano dentro), anche se a guardar bene essa può facilmente (e magari dolorosamente)31 trasformarsi in una Wunderkammer, col suo spazio eccessivo, iperbolico. Nella Wunder-kammer la innumerabilità o la incommensurabilità sono il segno, ine-luttabile, di un mondo che non si lascia dominare nella sua totalità, né comprendere fino in fondo.
Partendo da qui, da questo ennesimo dato comune, è necessario ri-leggere tutti gli spazi di Giovenale e di Zaffarano, e tutta la loro realtà. Esiste sempre una maglia che non tiene, che per eccesso o per difetto rompe l’esattezza: questa condizione può essere espressa introducendo lacune nelle numerazioni (Numeri primi non comprende nella sua serie il più primo dei numeri, cioè 1 – che del resto ha per Giovenale una funzione e una natura specifica di cui si è detto); vengono poi introdot-ti paradossi matematici (“3 scienziati giapponesi travestiti da 4 scienzia-ti cinesi,” in Quasi tutti)32 e paradossali statistiche (“La somma delle cal-ze nere è la più alta,” di nuovo in Quasi tutti;33 ma lo specialista è Zaf-farano: “scavare buche in altri, 11,5%, scavare buche in giardino, 8,3%, saltare addosso agli aborigeni, 54,8%,”34 “Il 39% sbircia nell’armadietto del bagno del padrone di casa”).35
Bisognerà tornare sul concetto di esattezza e su quello di totalità. Zaf-farano e Giovenale esprimono ancora più efficacemente il concetto di fallacia dell’esattezza proprio quando hanno a che fare con la totalità, che è la sua condizione più perfetta, e che può essere rifiutata al modo in cui viene rifiutato il più perfetto dei numeri primi. Giovenale dice “quasi tutti,”36 “tutte le porte si aprono tranne una,” parla di qualcosa che “solo se si sdoppia è uno,”37 significando la problematicità del rap-porto della totalità con le sue parti; come fa anche Zaffarano quando dice che è impossibile non scavare una buca intera, che è “impossibile scavare mezzo buco.”38 Abbiamo a che fare in questo senso anche con il contrario dell’intero, con il nullo, il vuoto. Non mancano i vuoti messi in pagina, per cui sotto ad un titolo di Zaffarano la pagina resta bian-ca39; non manca per Giovenale il richiamo ad un passaggio di Tanizaki in cui l’esposizione di un oggetto nella casa vale ad aggiungere una di-
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 257Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 257 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
258
mensione cava, e non manca l’invenzione di un doppio vuoto dato da “scodelle di antimateria.”40 Dal punto di vista delle immagini Giovena-le condivide con Zaffarano l’impiego ricorrente della buca, dello scavo di una buca più precisamente (volentieri operato da un cane) .41 È un’im-magine che rende bene il motivo dello spostamento, del vuoto, del vuo-to creato per spostamento.
Ed è un’immagine che del resto rimanda più o meno direttamente a due istanze intellettuali precise: una poetica (se così si può dire), e il ri-ferimento è Jean-Marie Gleize con i suoi cani neri della prosa42 (che sca-vano buche – che ‘cercano il loro spazio,’ certo, ma che letteralmente ‘scavano la loro buca,’ e con Gleize è necessario essere letterali). L’altra istanza è di natura economica, e chiama in causa, dagli stessi anni Tren-ta del gruppo oggettivista, J.M. Keynes43 (Zaffarano vi allude in manie-ra scoperta: “era solo un paradosso, far scavare buche, farle riempire ai disoccupati”),44 che attraverso il paradosso dello scavo di una buca illu-strava una politica economica di cui oggi si torna a parlare ma per (è il caso di dirlo) seppellirla definitivamente – anche ad opera dell’ideologia della valutazione (valutazione finanziaria, valutazione della ricerca, per dire di due aspetti soltanto), che tenta di sottoporre la collettività a cri-teri apparentemente oggettivi ma evidentemente dipendenti per i più da principi del tutto soggettivi, e del resto riconducibili a soggetti che ap-paiono sempre così poco materiali e individuabili (in senso nominalisti-co).
Per concludere si dovrà dire che la matematica di Giovenale e Zaffa-rano, paradossale anche questa, getta un’ombra di dubbio sulla nostra capacità non solo di percepire la qualità e la quantità delle cose – che pure ci fa continuamente e concretamente percepire – ma soprattutto getta un’ombra sull’apparente trasparenza e oggettività dei numeri. Si può provare a risolvere l’interrogazione del reale contando – “Sono rea-li. Non sono reali. Sono reali. Una due”45 – tuttavia il fallimento è già nella natura metalinguistica delle parole, dei numeri che si usano. Nu-meri che comunque permeano ogni aspetto della realtà, forzando resi-stenze e ragioni critiche, e oggi sono incongruo strumento di controllo
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 258Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 258 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
259
per noi: per noi non in quanto soggetti bensì in quanto oggetti. Questo è il valore politico – che in una poetica oggettivista è verosimilmente della massima rilevanza, come lo è stato in quegli anni Trenta – di una scrittura che parla di cose, di spazi, e sembrerebbe a prima vista dire po-co dell’uomo e della sua vita tra gli uomini.
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 259Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 259 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
260
Note
1 Cfr. Paolo Virno, Convenzione e materialismo. L’unicità senza aura (Roma-Napo-li: Theoria, 1986), p. 15. Per Hegel si veda Fenomenologia dello spirito, trad. Enrico De Negri (Firenze: La Nuova Italia, 1973), vol. I, p. 212. Si veda anche, declinando il di-scorso in termini aderenti per un altro verso alla strategia poetica qui presa in esame, la posizione secondo cui la matematica è “un atto di creazione, non di conoscenza” com’è suggerito ad esempio in Gabriele Lolli, Filosofia della matematica: l’eredità del Novecento (Bologna: il Mulino, 2002), p. 41.
2 Virno, Convenzione e materialismo, cit., p. 54.3 Gian Pio Torricelli, Coazione a contare (Roma: Lerici, 1968).4 Marco Giovenale, (come) nasce la scrittura (http://www.nazioneindiana.
com/2010/11/11/la-nascita-della-scrittura-i/, 2010).5 Michele Zaffarano, l’invenzione della scrittura. 13 analitical sought poems + 1
(http://www.nazioneindiana.com/2010/11/15/la-nascita-della-scrittura-ii/, 2010); già in Il libro dell’Immagine. La Camera Verde, vol. VIII (Roma: La Camera Verde, 2010).
6 Michele Zaffarano, A New House (Roma: La Camera Verde, 2008), opera com-posta di cartoline sparse recanti sul verso un testo numerato; Michele Zaffarano Sca-vate buche nello spazio, pubblicazione parziale in il verri, N. 50 (2012): 110-14, e integrale in lingua inglese – con il titolo Dig Holes in Space – in Or, N. 9 (2012): 28-30.
7 Marco Giovenale, Quasi tutti. Prose in prosa nuove e non nuove, postfazione di Pa-olo Zublena (Roma: Edizioni Polimata, 2010); Marco Giovenale, Giornale del viaggio in Italia (Prosa in prosa, introd. Paolo Giovannetti, note di lettura di Antonio Loreto [Firenze: Le Lettere, 2009], pp. 101-27).
8 Il terzultimo sonetto della sezione è composto di 17 versi per via di una numera-zione che riprende da capo dopo il verso 3, producendo un’escrescenza che mima, sep-pure rovesciata, la forma del sonetto caudato. Il sonetto tradizionale (si fa per dire) è comunque finalmente ristabilito dal verso 14, il cui testo è appunto “14” (Giovenale, Quasi tutti, cit., p. 23).
9 Allusione che incorpora forse un omaggio a Nanni Balestrini, Ipocalisse. 49 sonet-ti. Provenza 1980-1983 (Milano: Scheiwiller, 1986), i cui testi sono composti di 14 versi brevissimi a formare 49 “iposonetti.”
10 Si veda Giovenale, Quasi tutti, cit., alla sezione “Excesses (nel voletto),” pp. 29-33.
11 “Clinica (n)” è il titolo di un testo (p. 83) di Marco Giovenale, Shelter (Roma: Donzelli, 2010).
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 260Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 260 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
261
12 Marco Giovenale, CDK, il verri, N. 48 (2012): 94-9 (già in lingua inglese in Or, N. 1 [2008] e poi Bainbridge Island: Tir aux Pigeons, 2009).
13 Cfr. Edmund Husserl, Filosofia dell’aritmetica [1891], trad. e cura di Giovanni Leghissa (Milano: Bompiani, 2001), p. 122: “La molteplicità in generale […] non è altro che questo: un qualcosa qualsiasi e un qualcosa qualsiasi e un qualcosa qualsiasi, e così via; oppure: una cosa qualsiasi e una cosa qualsiasi e una cosa qualsiasi, e così via; oppure, ancor più brevemente: uno e uno e uno, ecc.” (corsivo dell’originale).
14 Giovenale, Quasi tutti, cit., p. 115.15 La nota d’autore specifica: “In una serie di spazi o reclusorii numerati tutti in-
variabilmente istericamente ‘1’, ‘clinica 1’, sempre all’inizio, re iniziando, si dà discor-so o flusso […]; un flusso stabilmente interrotto. Sospeso, ripreso. […] Forward e rewind sono nello stesso tasto, libro. | Piccoli malati e piccoli prigionieri e battuti e illusi sono fitti e finiti nelle pagine, qui nell’andirivieni. Bloccati, narranti, riportati a mutismo” (Giovenale, Shelter, cit., p. 115).
16 Giovenale, CDK, cit., p. 99.17 Michele Zaffarano, Wunderkammer (Prosa in prosa, cit.), p. 144 e p. 136, rispet-
tivamente.18 Giovenale, CDK, cit., p. 97.19 Marco Giovenale, Numeri primi. 23 piccoli preludi, 1995-2005 (Milano: Arci-
pelago, 2006), p. 9 e p. 28 rispettivamente.20 Marco Giovenale, Storia dei minuti (casa. clinica) (Massa: Transeuropa, 2010).21 Cfr. Cecilia Bello Minciacchi, Postfazione a Marco Giovenale, Criterio dei vetri
(Salerno-Milano: Oèdipus, 2007), p. 81.22 Zaffarano, Wunderkammer, cit., p. 146.23 Giovenale, Storia dei minuti, cit., p. 23.24 Giovenale, Numeri primi, cit., p. 10.25 Cfr. Marco Giovenale, In rebus (Civitella in Val di Chiana: Zona, 2012), plaquet-
te chiusa dalla sezione “Camera di Albrecht.”26 L’immagine proposta di seguito è legata al testo n. 8 di Zaffarano, A New House,
cit.27 Giovenale, Shelter, cit., p. 110.28 Willard Van Orman Quine, Che cosa c’è [1948], trad. di Paolo Valore in Orman
Quine, Da un punto di vista logico. Saggi logico-filosofici (Milano: Cortina, 2004), pp. 13-33.
29 Cfr. Giovenale, Shelter, cit., p. 107.30 Giovenale, Numeri primi, cit., p. 14. Cfr. anche, ibidem, p. 21.31 Si veda il testo dal titolo “(o.t. | objet…),” in Giovenale, Shelter, cit., p. 19: “Sec-
chi in terra, specchi, un polverìo | che si nasconde sotto; l’urto | di lancette, segnato il
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 261Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 261 23/10/13 15:1623/10/13 15:16
262
tempo: troppe | cose sono in casa, avverte, la | più ferita è nominarle,” dove peraltro è da notare il participio ‘segnato’ che blocca il tempo indicato dall’orologio in un attimo senza prospettiva di divenire.
32 Giovenale, Quasi tutti, cit., p. 32.33 Ibidem, p. 23.34 Zaffarano, Scavate buche nello spazio, cit., p. 111.35 Zaffarano, A New House, cit., testo n. 4.36 Cfr. in particolare Giovenale, Quasi tutti, cit., p. 46.37 Ibidem, p. 47.38 Zaffarano, Scavate buche nello spazio, cit., p. 112.39 Michele Zaffarano, E l’amore fiorirà splendidamente ovunque (Roma: La Camera
Verde, 2007), p. 12.40 Giovenale, Quasi tutti, cit., p. 32.41 Cfr. ad esempio Giovenale, In rebus, cit., p. 16; Giovenale, Numeri primi, cit.,
p. 28; oltre a Zaffarano, Scavate buche nello spazio, cit., passim. 42 Jean-Marie Gleize, Les Chiens noirs de la prose (Paris: Seuil, 1999): “Apprendre à
écrire comme un chien fait son trou.”43 Cfr. John Maynard Keynes, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della
moneta [1936], ed. Alberto Campolongo (Torino: Utet, 1971), III, 10, p. vi.44 Zaffarano, Scavate buche nello spazio, cit., p. 114.45 Giovenale, Shelter, cit., p. 60.
Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 262Nuovi oggettivisti_5bozza.indd 262 23/10/13 15:1623/10/13 15:16