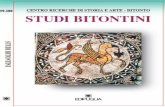SAN GREGORIO MAGNO: UN TEMPIO CORINZIO TRASFORMATO IN CHIESA
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of SAN GREGORIO MAGNO: UN TEMPIO CORINZIO TRASFORMATO IN CHIESA
La chiesa di San Gregorio Magno sorge a ridosso del Colledell’Annunziata nell’area retrostante alla Piazza Arringo, sulla direttricedella via Tornasacco, che eredita il percorso di una strada romana.L’area della Piazza Arringo, divenuta sede del complesso episcopale, acco-glieva già in antico uno spazio pubblico su cui prospettavano alcuni edi-fici monumentali, il cui ruolo di rappresentanza viene riaffermato dallaCattedrale, dal Battistero e dal Palazzo dell’Arengo, e in modo analogo lachiesa di San Gregorio si presenta costituita dalle strutture perfettamen-te leggibili di un tempio corinzio.La struttura templare è databile tra la tarda età repubblicana e la primaetà augustea (I sec. a. C. – I sec. d. C.), ossia all’epoca in cui la città anti-ca, assunta la qualifica di colonia, venne completamente ricostruita.La cella, ossia l’area chiusa in cui si conservavano l’ara e la statua delladivinità, mostra le pareti in opus quasi reticulatum, alle quali si addentel-la una nicchia absidata in opus latericium, pertinente anch’essa al tempioantico. All’interno la nicchia mostra un basamento che faceva forse dasupporto alla statua venerata.Le pareti si conservano fino al piano del coronamento, dove correva una tra-beazione ritmata da doccioni figurati che fungevano da scarico dell’acqua
�Veduta dellafacciata e dellatorre campanariacon scorcio delfianco sinistro
The façade and thebelfry seen fromthe left side of thechurch
�Particolare deicapitelli dellecolonne romanecon tratto diarchitrave anticoconglobate infacciata
Details of theRoman columnscapitals with a partof the oldarchitrave re-inserted on thefaçade
92 I LE CHIESE I SAN GREGORIO MAGNO
SAN GREGORIO MAGNO: UN TEMPIOCORINZIO TRASFORMATO IN CHIESA
piovana. Alcuni elementi superstiti diquesta cornice sono attualmente inmostra nel corridoio di fianco alla chiesa.In corrispondenza del semipilastro scanalatoche si osserva sul fianco stesso, la cella siinterrompeva per dare luogo al portico fron-tale (il pronao), costituito su due file da duecolonne laterali e da quattro colonne in fac-ciata, poste come di consueto a sostegno diun timpano. L’area del pronao è stata assor-bita dalle attuali strutture della chiesa, masul fronte si osservano due splendide colon-ne residue con il relativo architrave (privodelle lastre decorate che vi dovevano esseremontate in origine). Le colonne, situateesattamente dove erano state collocate in etàromana, sono conglobate nella facciata inmodo da apparire “fuse” con la paretemedievale in cui sono inserite. Grazie all’a-bile tessitura della superficie muraria, esseappaiono perfettamente in tono sia con la
levigata squadratura dei conci (alcuni dei quali di reimpiego), sia con il lieverisalto delle membrature che disegnano le cornici marcapiano e i portali. Ilportale secondario, in particolare, è ingegnosamente incassato tra le duecolonne con un architrave che “ripete” l’architrave delle colonne stesse.L’elemento è arricchito in stile “antico” dalla geometrica tessitura delle corni-ci e dalla piattabanda, che si rifà al portale su piazza del Battistero.I ganci di pietra e la cornice in aggetto sono in relazione ad un ballatoioin legno che poteva essere allestito durante le festività.Le strutture in opus quasi reticulatum si osservano anche all’interno.L’impianto romano mostra la sola aggiunta dei pilastri su cui si impostanogli ampi archi trasversali (detti anche archi-diaframma) che sostengono aloro volta le travature del tetto. Naturalmente è mutato l’assetto ambienta-le. Le pareti, oggi a facciavista, erano già intonacate e almeno in parte rive-stite in affresco nel sec. XII, e nella situazione antica erano rivestite di lastredi marmo di colore alternato. Il pavimento, a quota più bassa di quelloattuale, era in origine formato da piastrelle quadrate di marmo di due colo-ri alternati, giallo e grigio, a formare un disegno a linee diagonali.Proprio su questo pavimento nel 1939 furono individuate quattro basi dicolonna infisse “in rottura” sul marmo romano, agli angoli di un rettangoloideale, in corrispondenza dell’altar maggiore della chiesa. Si trattava senzadubbio dei resti di un arredo presbiteriale. A questo riguardo, nella stessaoccasione fu rinvenuto il frammento di una lastra istoriata che era in origine
�Vedutadall’angolosudorientale con illato posteriore, ilfianco sinistro e latorre campanaria
View of the backside, the left sideand the belfryseen from thesouth easterncorner
�Vedutadell’interno
The inside of thechurch
94 I LE CHIESE I SAN GREGORIO MAGNO
96 I LE CHIESE I SAN GREGORIO MAGNO
pertinente ad un ciborio del sec. IX. Lequattro colonne che corrispondevanoalle basi rinvenute erano probabilmentepertinenti proprio a questo ciborio, ed ècosì possibile asserire che già nel sec. IXil tempio era stato adattato al culto cri-stiano, senza ricevere alcuna modificastrutturale, tant’è che l’antico pavimentopoté essere mantenuto in funzione.La ricostruzione della parte frontale,forse dovuta ad un cedimento dell’an-tico pronao, e il nuovo tetto impostatosugli archi trasversali, risalgono aglianni 1250-1270. La torre campanaria,che sostituisce il precedente campani-letto a vela, è stata aggiunta nei primidecenni del sec. XIV.Il motivo dell’estremo interesse suscitatodalla chiesa di San Gregorio Magno diAscoli ha una doppia valenza, locale e“universale”. Sul piano della realtà asco-lana, San Gregorio esempla in modostraordinario quel rapporto di continui-tà con l’antico che costituisce l’essenza ditutta la vicenda urbanistica e culturaledella città nell’arco di cinquecento anni,dal sec. IX al Duecento. Sul piano del-l’architettura religiosa europea costitui-sce un esempio “da manuale” di ricon-versione al culto cristiano di un tempioantico, grazie all’entità e alla leggibilitàdelle componenti romane ancora in fun-zione, e grazie anche al “dosaggio” eall’attenzione degli inserimenti medieva-li. Simili situazioni si evidenziano, perquel che riguarda le realtà vicine, aSant’Ansano di Spoleto (Perugia) e a SanPietro di Alba Fucens (L’Aquila).L’esempio più illustre della casistica è aSiracusa, dove la cattedrale è sorta dallatrasformazione del tempio magnogrecodi Atena. Gli edifici di culto antichi tra-sformati in chiesa senza perdere la loro
SAN GREGORIO MAGNO I LE CHIESE I 97
immagine originaria si riassumono poi in due monumenti-simbolo: il Partenone, trasformato nel sec. VI nella cattedra-
le di Atene (una basilica a tre navate), e il Pantheon, dedi-cato nel 609 alla Vergine e a tutti i martiri. Si inserisce bene
a questo punto la dedica stessa della chiesa ascolana a quelgrande pontefice, Gregorio Magno (590 ca. - 604), che pro-pugnava la conversione degli edifici di culto pagano al culto
cristiano contro la diffusa demonizzazione e quindi ladistruzione o l’abbandono dei templi stessi. Sarà propriograzie al suo esempio che si avrà la storica conversione del
Pantheon (ed è grazie alla conversione al culto cristiano chequesto tempio è giunto a noi intatto).Completa il quadro della chiesa ascolana un intrigante reper-
torio di dipinti murali, purtroppo spesso pervenuti in stato frammentario.Sull’abside si nota innanzitutto quanto rimane di un corteo di Apostoli che sisviluppava al di sopra di un finto velario. L’alta qualità tecnica del disegno e laresa plastica delle vesti rimandano al raffinato stile “tardocomneno” (così dettodalla dinastia dei Comneni imperante a Bisanzio tra il 1081 e il 1185), diffu-so in Sicilia dai mosaicisti d’Oriente attivi nella cattedrale normanna diMonreale (1172-1189). Questo stile si diffuse a largo raggio grazie a bot-teghe di artisti locali attive in taluni luoghi-cardine, ad esempio a Spoleto(Perugia), come attestano il Crocifisso di Alberto (1187) e il mosaico diSolsterno sulla facciata del Duomo (1207). L’affresco ascolano è databileintorno a questi anni. Doveva essere completato, al centro dell’abside, daun Cristo benedicente o da una Madonna in trono col Bambino.Gli altri dipinti sono di carattere votivo, e sono cioè legati a singole ini-ziative di committenti privati che gestiscono gli spazi disponibili senzaun piano decorativo organico. Come si vede spesso nelle chiese ascola-ne, si registrano a San Gregorio due “ondate” sovrapposte di pitturavotiva, la prima che interessa gli anni 1250-1270, la seconda databileagli anni 1290-1330. A questo riguardo, sulla seconda campata dellaparete destra, un San Giovanni Battista della seconda fase si sovrapponead una più antica Salita di Gesù al Calvario di cui si ammira in partico-lare la figura di San Giovanni Evangelista. Il repertorio formale bizanti-no (evidente nelle pieghe classicheggianti della veste, sottolineate dadense pennellate scure), ispirato ai dipinti locali più antichi, convive conun concetto “teatrale” della figura: lo sgomento che l’Evangelista provadavanti ai tormenti del Cristo si esprime attraverso un “balzo” che proiet-ta il Santo in direzione opposta. Il dolore della Madonna si evidenzia al con-trario nella posa contratta e nelle mani giunte davanti al petto. Accanto a leisi nota la cotta di maglia di uno dei soldati romani che scortano Gesù. Si evi-denzia bene un concetto “drammatico” della scena che si rifà ai Vangeli apo-crifi della Passione, e che si ricollega alla pratica delle sacre rappresentazioni.
�Pagina a fianco:Frammento didecorazione adaffresco concorteo di Apostolisulla fascia basaledell’abside
Opposite:Fragment of frescoshowing a court ofApostles on theapse lower band
�Affrescoframmentario dellaSalita di Gesù alCalvario sullaparete destra
Fragmentaryfresco of TheAscent of Christ tothe Calvary on theright wall
Sul secondo pilastro della paretesinistra si ammira, ben conservato,un San Francesco che predica agliuccelli, con la raffigurazione dell’of-ferente ai piedi. L’episodio, ambien-tato a Bevagna, in Umbria, vennenarrato nel 1228-29 dall’agiografoTommaso da Celano nel capitoloche precede il resoconto della venu-ta del Poverello nella stessa città diAscoli (l’evento è datato al 1215).Alla figura dolce e imponente delSanto, con il saio, l’aureola e il voltoreclino, fanno rimando le vivaci rap-presentazioni di quattro uccelli, cheevocano la povertà e la purezza dispirito propugnate dal messaggioevangelico. Sono rivolti tutti a SanFrancesco, tre di loro aprono ilbecco, uno spiega le ali e spicca ilvolo, per avvicinarsi il più possibilealle sue mani e al suo volto. La collocazione e il soggetto del
SAN GREGORIO MAGNO I LE CHIESE I 101
�Pagina a fianco:(A sinistra) Affrescocon San Francescoche predica agliuccelli(A destra) Affrescocon San GiovanniBattista a fianco dellaMadonna in trono colBambino
Opposite: (On the left) Frescorepresenting SaintFrancesco Preachingto the Birds(On the right) Frescorepresenting SaintJohn the Baptist andthe Madonna on theThrone with the Child
dipinto rimandano alle fortunate tavole con la raffigurazione di SanFrancesco benedicente dipinte da Margarito d’Arezzo proprio in funzionedelle esigenze votive, secondo un formato costante regolato sullo spaziodisponibile dei pilastri. Il maestro aretino, attivo fino al 1280 circa, avevauna bottega che ha poi proseguito a diffondere questi modelli. L’affrescoascolano è databile intorno al 1290.Alla base della torre l’attuale sagrestia era in origine una cappella affrescatache custodiva forse il fonte battesimale, in genere ubicato presso la contro-facciata. All’esterno della cappella, sul pilastro d’angolo, si nota SanGiovanni Battista e la Madonna in trono col Bambino. Si tratta di una rap-presentazione votiva molto diffusa in Ascoli, grazie all’attenzione per ilculto del Precursore di Cristo: così è detto il Battista nei Vangeli, essendol’ultimo profeta e il primo martire della Rivelazione. Proprio nella sua vestedi profeta è richiamato nel dipinto, riconoscendo nel Bambino l’Agnellodi Dio. Il filatterio di pergamena che regge in mano propone infatti la for-mula liturgica ancora in uso: “Ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati delmondo”. Il dipinto risale ai primi decenni del sec. XIV.Va infine segnalato sulla parete destra dell’aula, presso l’ingresso secondario,l’affresco frammentario con San Gregorio Magno ispirato da un Angelo. IlSanto dedicatario della chiesa, intento a scrivere i Dialoghi alla presenza delsuo interlocutore, il diacono Pietro, riceve l’ispirazione grazie ad un Angeloche gli porge un filatterio. Il dipinto, opera della stessa bottega che ha rea-lizzato la Salita di Gesù al Calvario, è databile agli anni 1250-1270.
�Affrescoframmentario conAngelo che porgeun filatterio a sanGregorio Magno
Fragmentary frescoof An Angel offeringSaint Gregory aPhilattery
ering from the top. Its cen-tral column is unfortunatelymissing. The archlets areinscribed within a uniqueblock of stone enriched bythree bowls which probablycontained ceramic basins. On the left side of thechurch, at ground level, onecan notice a reused Romaninscription. It is a tomb slabmentioning a “liberta” (awoman freed from slavery)named Ventidia Arescusa.This woman had taken onthe name of a renownedgeneral from Ascoli whosename was Publio VendidioBasso. He had won a battleagainst the Parthians in 38BC and was a secondarycharacter in Shakespeare’sAnthony and Cleopatra. The right side of the churchonce faced the monastery,which is now completelydestroyed. Its basement iscomposed of reutilised ashlarblocks. Above it there was adecorative strip, which is nowfragmentary, made up ofalternating layers of bricksand travertine ashlar blockswhich form a scheme charac-terised by diagonal lines. Thispattern imitates the Romangrid work used in building.
The church of San GregorioMagno is located next to Colledell’Annunziata in the areabehind Piazza Arringo, in thedirections of Via Tornasacco,an ancient Roman road.Some of the monumentalbuildings had already beenplanned during ancient timesin the public area aroundPiazza Arringo, which hadbecome the seat of theEpiscopalian complex. Theirrepresentative roles can beasserted by the Cathedral, theBaptistery and Palazzodell’Arengo, and, in the sameway, the Church of SanGregorio is clearly structuredlike a Corinthian temple.This templar structure datesback to between the lateRepublican age and the early
Augustan age (I century A.C. -I century D. C.). During thisperiod, the ancient town,which had been classified acolony, was totally rebuilt.The cella, that is, the innerroom where the altar andthe divinity statue were con-served, displays the walls inopus quasi reticulatum, towhich is connected an apsi-dal alcove in opus latericiumalso pertaining to ancienttimes. The interior of thealcove includes a basewhere the venerated statuemight have rested.The walls went up to theupper panel on which wasattached an entablature full ofgargoyles used as a drain forrain water. A few of theremaining parts of this frameare presently displayed in thehall on the side of the church.In correspondence to thegrooved half-pillar located onthe side of the cella, there isan interruption in the cellagiving place to the front porti-co (the pronaos), which con-sists in two rows of two later-al columns and four frontalcolumns, customarily posi-tioned to hold up a tympa-num. The area of this pronaoswas taken up by the currentstructures of the church, butin the front, two splendidremaining columns with theircorresponding architraves(devoid of the decorated slabswhich originally were sup-posed to be mounted onthem) can still be observed.
THE CHURCHES I ENGLISH TEXT I 173
SAN GREGORIO MAGNO:A CORINTHIAN TEMPLE
TRANSFORMEDINTO A CHURCH
The columns, situated exactlywhere they had been placed inRoman times, are incorporat-ed into the façade in such away that they seem perfectly“fused” into the Medieval wallin which they are inserted.Thanks to the skilled weavingof their masonry, they seemto be perfectly in tone bothwith the even squaring of theashlars (some of which werereutilised), and with the slightrelief of the structures whichoutline the string-courseframes and the portals.The stone hooks and theframe in projection are con-nected to the wooden gallerywhich could be decoratedduring the feasts.The structures in opus quasireticulatum can also beobserved internally. TheRoman instalment is onlydemonstrated with the addi-tion of the pillars on which arepositioned the wide transver-sal arches (also called arch-diaphragm) that hold up thebeams of the roof. Naturallythe environmental order waschanged. The walls were onceplastered and at least partiallycovered with frescoes in theXII century, and in ancienttimes they had been coveredby marble slabs which alter-nated in colour. The floor,slightly lower than the presentone, was originally formed bysquare marble tiles in twoalternating colours, yellowand grey, which resulted in adiagonal line design.
Four column bases insertedinto the Roman marble werefound on this exact floor in1939. The four columns cor-responding to these basesprobably pertained to a tab-ernacle of the early MiddleAges. It can therefore beasserted that already in theIX century the temple hadbeen adapted to the Christiancult, without going throughany structural transforma-tions, as can be seen withthe antique pavement whichwas still in existence.The reconstruction of thefacade, perhaps due to a set-tling of the antique pronaos,and of the new roof posi-tioned on the transversalarches date back to 1250-1270. The bell tower, whichsubstituted the previous smalldomical bell tower, was addedon in the first few decades ofthe XIV century. The reason for the great inter-est in the Church of SanGregorio Magno in Ascoli hasa double value, a local oneand a “universal” one. In ref-erence to Ascoli, SanGregorio is an extraordinaryexample of the continuousrelationship with antiquitywhich makes up the essenceof the whole urban and cultur-al vicissitude of the townthroughout five hundredyears, from the IX century tothe 1200s. On the level of reli-gious architecture in Europe,it is a copybook example ofthe reconversion of an ancient
temple into the Christian cult,thanks to the extent and clear-ness of the Roman compo-nents still in function, andthanks also to the “dosage”and the attention of theMedieval insertions. An intriguing collection ofpainted murals, unfortunatelyoften attained in a fragmen-tary state, completes thestructure of the church. Aboveall, the remains of a proces-sion of Apostles expandingabove a fake curtain can benoted on the apse. The hightechnical quality of the draw-ing and the plastic presenta-tion of the garments referback to the refined “lateComneni” style (called afterthe Comneni Dynasty reigningin Byzantium between 1081and 1185), diffused in Sicilyby the mosaicists from theeast who worked on theNorman Cathedral ofMonreale (1172-1189)The other paintings werevotive, and so they were com-missioned by private singleindividuals who handled theavailable spaces without anorganised decorative plan. Ascan often be seen in thechurches in Ascoli, even SanGregorio has two overlapping“movements” of votive paint-ing, the first one during theyears 1250-1270, and thesecond dates back to theyears 1290-1330. An exampleof this can be seen on thesecond span of the right wall:a Saint John the Baptist of the
174 I ENGLISH TEXT I THE CHURCHES
second phase overlaps withan older The Ascent of Christto the Calvary where it is pos-sible to admire in particularthe figure of Saint John theBaptist. The formal Byzantinerepertoire (evident in the clas-sic folds of the garments,underlined by dark densebrushstrokes), inspired by themore ancient local paintings,coexist with a “theatrical”concept of the figure: thedismay which the Evangelistfelt in front of Christ’s agonyis expressed by a “leap”which projects the Saint intothe opposite direction. Onthe contrary, the pain of theMadonna is evidenced in hercontracted pose and withclasped her hands on herwomb. A coat of mailbelonging to one of theRoman soldiers who escort-ed Jesus lied next to her.On the second pillar of theleft wall, a well-conservedSaint Francesco Preachingto the Birds, depicting thecommissioner at his feet,can be admired. Thisepisode, set in Bevagna, inUmbria, was narrated in1228-29 by hagiographerTommaso da Celano in thechapter before the accountof Poverello’s arrival to thetown of Ascoli (this event isdated 1215). The frescodates back to about 1290.At the base of the tower, thecurrent sacristy was originallya frescoed chapel, perhapscontaining the baptismal font,
which was normally locatedon the opposite side. SaintJohn the Baptist and theMadonna on the throne withthe Child can be noticed onthe corner pillar outside thechapel. It deals with a votivefiguration which is very wide-spread in Ascoli thanks to theattention drawn towards thecult of Christ’s Precursor: asthe Baptist is called in theGospels, being the lastprophet and the first martyr ofthe Revelation. The paintingdates back to the firstdecades of the XIV century.Finally, the fragmentary frescowith San Gregorio MagnoInspired by an Angel can beadmired on the right wall ofthe room near the secondaryentranceway. The Saint, whothe church was named after,is engrossed in writing theDialoghi in the presence of hisinterlocutor, the deaconPietro. He gets his inspirationfrom an Angel who hands hima phylactery. The painting,work of the same artist’sworkshop which executed theAscent of Christ to theCalvary, dates back to theyears 1250-1270.
The church of San Vittorewas erected in an area oftown which had been scarce-ly urbanised before the end ofWorld War II. Until the 1800sthe area was mainly occupiedby vegetable gardens whichsurrounded this building oneach side. There was a roadrunning to its right near theMalatesta Fort and theRoman bridge named Cecco’sBridge, which crosses theCastellano torrent.The parish of San Vittorewas confirmed to the cler-gymen of the Cathedral inan official document (diplo-ma) by Otto III (996) whichis now preserved in theCapitulary Archives ofAscoli. The church of SanVittore, as we now see it, isthe result of reconstructionworks which began duringthe mid XIIIth century, inline with numerous other
THE CHURCHES I ENGLISH TEXT I 175
THE CHURCH OFSAN VITTORE: A SHRINEOF VOTIVE PAINTINGS