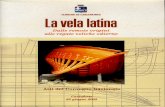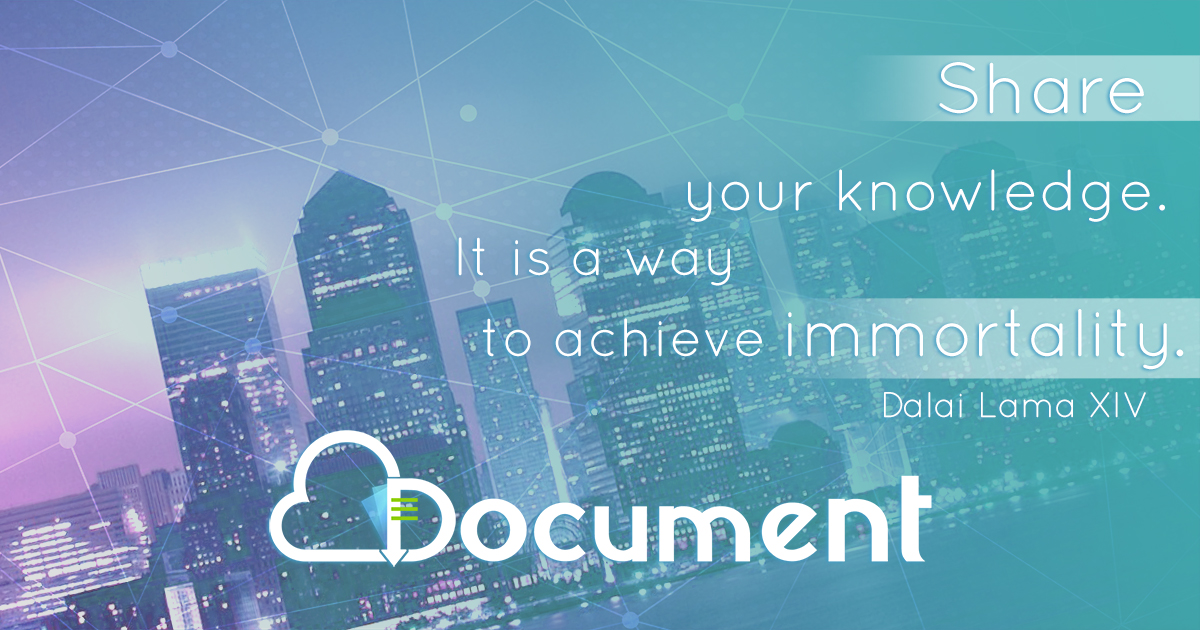Le chiese a pianta centrale: diffusione del nuovo “tempio cristiano”
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Le chiese a pianta centrale: diffusione del nuovo “tempio cristiano”
La tipologia planimetrica delle chiese cristiane prerinascimentali è general-mente costituita da un’evoluzione dell’impianto basilicale, in cui un corpolongitudinale a navate è intersecato trasversalmente dal transetto, a formareuna croce latina, chiaramente allusiva alla passione di Cristo. L’utilizzo dellapianta centralizzata risulta, invece, limitato ai battisteri e ai martyria (santuaridedicati ai martiri), nei quali era necessario che l’oggetto della venerazione(il fonte battesimale o il luogo santo) fosse visibile ai numerosi fedeli chefluivano nel circostante deambulatorio.Nel quarantennio a cavallo tra XV e XVI secolo, invece, si assiste a una pro-gressiva diffusione di chiese a pianta centrale, le cui motivazioni possono es-sere ricondotte essenzialmente a due categorie di considerazioni: in primoluogo il valore linguistico derivante dalla riscoperta dei testi classici e delleforme edilizie dell’antichità, e in secondo luogo il contenuto simbolico con-nesso al pensiero neoplatonico.L’uso di piante circolari, poligonali e a croce greca, inoltre, si adatta alleconcezioni prospettiche del Rinascimento, in quanto consente, all’interno,di individuare univocamente il fulcro simbolico dell’aula sacra (ove vienecollocato l’altare) e, all’esterno, di qualificare le diverse parti dell’organismoedilizio. La ricerca formale condotta in pianta, infatti, si estende anche aglialzati, polarizzando l’interesse degli architetti sulla complessità dei volumi
4 Le chiese a pianta centraleDiffusione del nuovo “tempio cristiano”
95
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 95
come testimoniano, per esempio, i numerosi studi leonardeschi, in cui figu-rano tutte le possibili varianti sul tema della pianta centrale con cappelle, edove i rapporti volumetrici tra il corpo principale e quelli secondari (spessotutti cupolati) sono risolti con grande varietà.La pianta centrale, peraltro, viene utilizzata non solo negli edifici religiosi,ma anche per i palazzi (si ricordi palazzo Farnese a Caprarola, a pianta penta-gonale) e le ville (prima tra tutte la palladiana villa Almerico Capra, detta LaRotonda), le cui esigenze funzionali avrebbero richiesto originariamente so-luzioni diversificate.Tutte queste fabbriche, sia religiose che civili, realizzateo semplicemente disegnate, si presentano all’esterno come forme perfetta-mente compiute, cui nulla può essere tolto o aggiunto senza compromet-terne l’armonia complessiva, e costituiscono pertanto una metafora dell’or-dine universale e divino, ovvero dell’harmonia mundi, basata sulla concezio-ne geo-antropocentrica dell’universo.
Memorie archeologiche brunelleschianeLe radici archeologiche della cultura rinascimentale emergono chiaramentedagli esempi canonici di architettura che Antonio di Tuccio Manetti sceglieper celebrare l’opera di Filippo Brunelleschi, nella sua biografia di poco suc-cessiva alla morte dell’architetto fiorentino: la cosiddetta “rotonda” di SantaMaria degli Angioli e Santo Spirito, entrambe a Firenze.
Il Rinascimento96
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 96
Brunelleschi si reca più volte a Roma nel corso della propria vita, spesso ac-compagnato dall’amico Donatello, per studiare le antichità classiche con unapassione che ha tutto il sapore della scoperta, e il cui esito immediato è pro-prio l’incompiuta Santa Maria degli Angioli (1434), considerata la prima chie-sa a pianta centrale del Rinascimento. L’edificio, nella ricostruzione più accre-ditata, presenta un interno ottagonale cui corrisponde, all’esterno, un prisma asedici facce riquadrate da cornici che delimitano profonde nicchie, forse alter-nate a finestre centinate; il tutto sormontato da una cupola a padiglione otta-gonale, probabilmente contraffortata con volute e conclusa da un lanternino.Gli stretti passaggi di comunicazione tra le otto cappelle radiali a pianta qua-drata sembrano alludere a un sottaciuto deambulatorio, che qualificherebbe lafabbrica brunelleschiana virtualmente ricostruita quale nuova versione delmartyrium classico, o meglio ancora paleocristiano, sul modello della romanaSanta Costanza, che nel Rinascimento era ritenuta l’antico tempio di Bacco.I lavori per la sua costruzione furono interrotti nel 1437, quando l’edificioraggiungeva l’altezza di circa 7 metri, ma nel 1444, a pochi isolati di distanza,inizia a prendere forma la ben più ampia tribuna della Santissima Annunziata,
Le chiese a pianta centrale 97
Alla pagina 94:Antonio da Sangalloil Vecchio, Chiesadella Madonna di San Biagio,1518-1534,Montepulciano,Siena.
FilippoBrunelleschi,Disegno della piantadi Santa Maria degliAngioli, 1434,Firenze.
Santa Costanza,IV secolo, Roma.
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 97
per la quale Michelozzo di Bartolomeo progetta un am-biente circolare con sette grandi nicchie disposte lungo ilperimetro, ispirandosi verosimilmente alla “rotonda” bru-nelleschiana anche per la presenza di un assai probabiledeambulatorio su pilastri o colonne. Esso, però, scomparenel progetto di completamento di Leon Battista Albertiche, nel 1470, la porta a compimento superando un’acce-sa ostilità per l’impianto centrale. Il risultato finale, quin-di, mostra la tribuna circolare semplicemente giustappo-sta al corpo longitudinale a navata unica della chiesa, elu-dendo ogni possibile tentativo di una difficile sintesi.La sequenza di absidi estradossate che, secondo recentistudi, avrebbe dovuto correre lungo i lati esterni (com-presa la facciata) di Santo Spirito (1436) potrebbe essereispirata, invece, alla corona di analoghe nicchie che sca-vano la solida massa muraria del tempio di Minerva Me-dica; esse, sommandosi alla teoria di cappelle cubicheche circonda la navata centrale, avrebbero concluso la se-rie di tre croci latine concentriche di questo organismoeterodosso, ipoteticamente immaginato da Brunelleschiquale sintesi tra la centralità della basilica civile romana eil simbolo della croce, facendone, in tal senso, uno degli
anelli più interessanti e spregiudicati dellalunga catena di piante centrali al cui
termine si trova il progetto diBramante per la nuova basilica
di San Pietro (si veda Dentroil capolavoro alle pagine100-101).I modelli “antichi” citatida Brunelleschi testimo-niano che il recuperodel linguaggio classicodell’architettura rinasci-mentale, non sostenuto
da una rigorosa conoscen-za archeologica, tende ad
annoverare, quali exempla daimitare, anche numerosi edifici
paleocristiani reputati templi ro-
Il Rinascimento
CristoforoCaradosso Foppa,Medagliacommemorativa dellafondazione di SanPietro per papaGiulio II, 1506,Londra, BritishMuseum.
98
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 98
mani adattati a chiese cristiane, come Santo Stefano Rotondo, il battisteroottagonale del Laterano, o addirittura il suo analogo fiorentino, fabbrica cheper Coluccio Salutati “non era né greca né etrusca ma certamente romana”.Non deve stupire, quindi, la palese analogia tra il mausoleo di Galla Placidiae San Sebastiano a Mantova, con il quale Leon Battista Alberti inaugura lalunga teoria di piante a croce greca che percorre tutto il Cinquecento. L’es-senziale stereotomia dell’edificio è impostata su un cubo di 15 metri di latosormontato da una cupola emisferica, che si espande in tre cappelle rettan-golari absidate (gli albertiani tribunalia) e un quarto braccio parzialmentemodificato per formare il vestibolo.
Il simbolismo neoplatonico per il “tempio cristiano” di AlbertiLo spazio nitidamente definito e al tempo stesso solenne della semplice cro-ciera mantovana appare perfettamente coerente con il compiuto programmaper l’edificazione dalla chiesa ideale secondo i nuovi principi umanistici, e-sposto da Alberti nel proprio trattato, che costituisce il principale punto diriferimento per gli architetti, almeno fino alla Controriforma.Nel VII libro del De Re Aedificatoria (1485), dedicato alla costruzione degli e-difici sacri, egli mostra apprezzamento per la tipologia basilicale, ma escludeche essa possa assurgere alla dignità del tempio in quanto contaminata dal-l’originaria funzione di tribunale, e propone, in alternativa, un proprio mo-dello di ‘tempio cristiano’, ubicato in posizione rialzata e impostato su piantarettangolare o centrica, quest’ultima suddivisibile nei due generi degli edificicircolari o poligonali.Un accorato panegirico del cerchio, però, tradisce la netta predilezione diAlberti per la seconda tipologia planimetrica, anche in considerazione delfatto che la Natura (ovvero Dio stesso) ha scelto le forme tondeggianti intutte le strutture dell’universo, da quelle macroscopiche (il globo, i cieli, gliastri) a quelle microscopiche (i nidi degli uccelli, le celle degli alveari). Eglisi innesta, così, su una tradizione che risale al Timeo platonico (il dialogo chetratta della fabbricazione del mondo secondo i canoni della geometria e del-l’armonia), ove il cerchio è considerato figura geometrica perfetta in quantoqualsiasi punto della sua circonferenza risulta equidistante dal centro; un’os-servazione portata alle estreme conseguenze da Niccolò Cusano, il quale ag-giunge che nell’infinito cerchio o nella sfera infinita, centro, diametro e cir-conferenza sono sostanzialmente coincidenti. Subito dopo il cerchio, la figu-ra geometrica più apprezzata è il quadrato, sia per la regolare geometria deisuoi quattro lati uguali (che consente di inscriverlo in una circonferenza), siain quanto simbolo della solidità della terra (la casa dell’uomo), forse a causadell’implicito riferimento ai quattro punti cardinali.
Le chiese a pianta centrale 99
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 99
Basilica di San Pietro
Modello della basilica di San Pietro, su progettodi Antonio da Sangallo,1483-1546,Città del Vaticano,basilica di San Pietro.
L’interminabile edificazione della nuovabasilica di San Pietro è scandita da unaricorrente alternanza nella scelta tra lamonumentalità neoplatonica delle soluzioni a pianta centrale e la praticità degli impianti acroce latina, che consentivano di ottimizzaregli spazi liturgici e accogliere un maggiornumero di fedeli.
L’imponente modello ligneo che fa realizzare rivela la frammentarietàdel trattamento parietale esterno e non sortisce l’effetto di vincolare i
suoi successori. Michelangelo, infatti, definendolo con disprezzo“tritume di membri”, presenta il suo progetto (5) come un ritorno alla
pianta centrale di Bramante, ma ne sacrifica completamente leelaborate articolazioni planovolumetriche, riducendo lo schema a unacroce greca cupolata, intersecata da un grande anello quadrato. CarloMaderno, infine, prolunga il braccio orientale, facendo assumere alla
basilica l’attuale impianto a croce latina.
Dentro il capolavoro
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 100
Raffaello (2) mantiene la crociera bramantesca ma vi giustapponeun corpo a navate segnando un effimero ritorno alla tipologialongitudinale, Antonio da Sangallo il Giovane (4) tenta una sintesi(più formale che sostanziale) tra i due modelli planimetrici,anteponendo alla croce greca un vestibolo (la loggia dellebenedizioni) fiancheggiato da due svettanti campanili e legato al corpo principale mediante un portico aperto.
Schema con piante e progetti
per San Pietro.
In pianta la crocegreca è riprodotta
per gemmazione neiquattro angoli delquadrato in cui è
inscritta (sistema aquincunx), e conclusa,talvolta, da ambulacriterminali. In alzato ilcrescendo dei volumiculmina nella grande
e luminosa cupolacentrale, definendocosì un complesso
spaziale cheBramante avrebbeimmaginato come
spregiudicatomontaggio del
Pantheon sopra labasilica di Massenzio.
Accantonata la vasta, ma arcaica, tribuna delRossellino, Bramante (1) elabora vari progetti
accomunati da una logica progettuale in cuicellule spaziali simili, pur mantenendo la propria
autonomia formale, sono aggregate secondoleggi razionali in un organismo gerarchizzato.
1
3
2
4 5
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 101
Cerchio e quadrato, poi, appaiono significativamente riuniti nell’immaginevitruviana, nota soprattutto nella versione leonardesca, in cui un uomo dalcorpo armonioso è inscritto perfettamente nelle due figure geometriche i-deali, a dimostrazione della corrispondenza matematica tra macrocosmo di-vino e microcosmo terreno ove l’uomo, immagine di Dio, racchiude in sél’armonia dell’universo.Diretta conseguenza di questa visione cosmologica dell’architettura è la de-duzione di rapporti dimensionali dal corpo umano che determina un solidosistema proporzionale in cui tutte le parti, raccomanda Alberti, devono cor-rispondersi fino al punto che sia possibile risalire alle dimensioni generalidalla misura di ogni singola parte, per quanto minuta.
Il Rinascimento102
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 102
Il germe formale della nuova grande basilica:San Pietro in MontorioLe teorie albertiane, quindi, si sommano al diffuso desiderio di ricongiungersi conla grande tradizione costruttiva classica, e gli architetti si convincono progressi-vamente che la tipologia templare tipica dell’antichità avesse un impianto cen-trico coperto da una cupola, come attestato dall’autorevole esempio del Pantheon,a quei tempi considerato il più prestigioso e meglio conservato edificio dell’an-tichità, che presenta, appunto, un corpo cilindrico sovrastato da una cupola ce-mentizia dalle dimensioni straordinarie. Proprio per questo motivo appare sin-golare il numero assai esiguo di chiese rinascimentali a pianta circolare, tra le qua-li meritano menzione la tarda Madonna di Campagna (1559) di Sanmicheli a Ve-rona, e soprattutto il tempietto di San Pietro in Montorio (1502-1510).Il piccolo edificio romano sorge, su un alto podio di sapore albertiano, nelluogo dove si riteneva fosse stato crocifisso l’apostolo Pietro, pertanto fin
Le chiese a pianta centrale
Madonnadell’Umiltà, cupola,Pistoia.
Leonardo daVinci, Manoscritto B,studi di fortificazionie pianta centrale perun edificioecclesiastico,1487-1490, Parigi,Institut de France,biblioteca.Emblemadell’aspirazione alla perfezione divina e segno del mutatosentimento religioso,la pianta centraleriflette la concezioneantropocentricadell’universo. Formeclassiche e proporzionigeometriche vengonoapplicate a edificireligiosi e civili senzaalcuna gerarchia fra ledue distinte funzioni.
103
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 103
dall’inizio viene concepito da Bramante come un martyrium (o martyrion) eprogettato sull’esempio dei templi peripteri circolari, come quello di Hercu-les victor presso il Tevere e quello della Sibilla a Tivoli. Una peristasi di colon-ne avvolge il corpo cilindrico della cella, che non si arresta alla trabeazione,ma emerge oltre la balaustra, scandito da paraste e nicchie e coronato da unacupola emisferica. Semplici rapporti proporzionali governano tutte le di-mensioni, come per esempio il diametro di base che è uguale all’altezzacomplessiva esclusa la cupola, mentre le metope del fregio esterno, sull’e-sempio di quello del tempio di Vespasiano, recano in bassorilievo le chiavi diSan Pietro e altri simboli liturgici.Una tavola del trattato di Sebastiano Serlio (Libro III) raffigura il presunto pro-getto originale, in cui un secondo peristilio di colonne circonda il tempietto
Il Rinascimento104
Sebastiano Serlio,Pianta del tempiettodi San Pietro inMontorio, XVI secolo,Milano, BibliotecaAmbrosiana.
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 104
all’interno di una corte quadrata che nei quattro angoli è ulteriormente arti-colata in altrettante piccole cappelle triconche. Bramante, quindi, avrebbeconcepito un organismo architettonico complesso e inedito, dove la pianta cir-colare della cella si sarebbe dovuta estendere anche allo spazio circostante,moltiplicandosi alle varie scale per gemmazione.Questa caratteristica, insieme al rigoroso uso degli elementi classici nonché alvalore plastico dei volumi, qualifica il piccolo edificio non tanto come versionemoderna dei templi rotondi o di altri prototipi classici, bensì quale chiave perla comprensione dei progetti bramanteschi destinati alla nuova basilica di SanPietro, a metà tra il manifesto programmatico e l’esperimento in scala ridotta.La tormentata vicenda della basilica Vaticana, purtroppo, non consentirà algerme formale di San Pietro in Montorio di svilupparsi in un complesso si-stema di spazi centrali gerarchizzati come Bramante aveva immaginato.
Il culto mariano e l’exploit cinquecentescoSe il piccolo sacello bramantesco viene edificato nel luogo del martirio diSan Pietro, il principale tempio della Cristianità, che sorge sopra la tombadell’apostolo, deve essere inteso anche quale gigantesco martyrium, una ca-ratteristica che favorisce l’adozione della pianta centrale per entrambi gli e-difici, come si è già avuto modo di evidenziare. Ma c’è un’altra particolaritàche accomuna le chiese a pianta centrale del Rinascimento: molto spesso sitratta di santuari legati a eventi miracolosi prodotti da un’effigie della Ma-donna o da una sua apparizione.La precoce rotonda brunelleschiana e l’attardato cilindro di Sanmicheli, in-fatti, costituiscono i limiti cronologici entro i quali è possibile annoverareSanta Maria delle Carceri a Prato (1485), Santa Maria della Consolazione aTodi (1508), la Madonna di San Biagio a Montepulciano (1518), il Santuariodella Madonna di Macereto presso Visso (1528) e altre ancora, le quali, pe-raltro, si distinguono anche per l’impiego della pianta a croce latina nelle suepiù svariate declinazioni.La semplice crociera pratese di Giuliano Giamberti da Sangallo denota unachiarezza spaziale che il progetto albertiano per San Sebastiano non avevaraggiunto, in quanto le figure elementari e perfette del cerchio e del qua-drato definiscono rapporti proporzionali quanto mai evidenti come, per e-sempio, nelle pareti di fondo aventi larghezza e altezza identiche, o nellacupola emisferica, distaccata e quasi sospesa sulle centine degli archi. Al-l’interno, infatti, un grigio scheletro strutturale in pietra serena si con-trappone al candido intonaco delle pareti, esaltando la limpidezza delloschema geometrico con liberi ma diretti e colti riferimenti al linguaggioformale dell’antichità.
Le chiese a pianta centrale 105
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 105
Circa un trentennio dopo il fratello di Giuliano, Antonio il Vecchio, sviluppa aMontepulciano (nella chiesa della Madonna di San Biagio) un analogo temaprogettuale segnando un punto d’incontro tra la tradizione fiorentina e lamonumentalità bramantesca, in cui certe soluzioni (per esempio l’abside se-micircolare priva di un catino che la raccordi alla cupola) determinano uncomplesso incastro di volumi squadrati, reso potentemente rude dal traverti-no dorato dal tempo. La coppia di campanili che inquadrano la facciata (unosolo dei quali ultimato), sembra anticipare il criticato modello ligneo per SanPietro di suo nipote,Antonio il Giovane, e denota una consolidata conoscenzadel lessico formale classico nella puntuale sovrapposizione degli ordini.Interessanti gli sviluppi della croce greca negli ultimi due esempi. Nellachiesa di Todi, Cola da Caprarola riduce i bracci a grandi corpi absidali (trepoligonali e una semicircolare), sviluppando un’architettura interamente im-
Le chiese a pianta centrale 107
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 107
postata sulle curve. A Macereto, invece, Giovan Battista da Lugano avvolge lacrociera absidata in un prisma ottagonale con tre avancorpi, che successiva-mente viene raccordato ai resti di un crollato campanile assumendo sul retroun profilo a poligono irregolare.
Il tempio civico del RinascimentoLa croce greca, come testimoniato dalla sua ampia diffusione, è certamentela più gradita tra le planimetrie centriche agli occhi dei teologi integralisti,in quanto l’implicito riferimento simbolico al martirio di Cristo (che la ac-comuna alla raccomandata croce latina), riesce a fondersi splendidamentecon i principi di geometria e armonia propri della cultura rinascimentale.Ciononostante, la controversia controriformista sulle virtù delle planimetriecentrali o longitudinali riesce a influenzare l’architettura religiosa in genera-le e quella di San Pietro in particolare, in quanto la pianta centrale, oltre aderivare da modelli pagani, interferirebbe con la liturgia cristiana e la cor-retta ubicazione dell’altare, cosicché il cardinale Francesco Gonzaga, un an-no dopo la morte di Alberti, manifesta ancora serie perplessità sul San Seba-stiano, chiedendosi “se l’haver reussire in chiesa o moschea o sinagoga”.La scelta di una planimetria centralizzata, quindi, si carica di un nuovo signi-ficato, correlato alla volontà delle comunità locali di instaurare un culto daicaratteri eminentemente civici, in autonomia rispetto al clero secolare,quando non in aperto contrasto con esso. Lorenzo il Magnifico, per esem-pio, per Santa Maria delle Carceri, sceglie l’evoluta crociera sangallesca, inluogo dell’ottagono proposto da Giuliano da Maiano, una figura geometricapiù tradizionale, raccomandata da padri della Chiesa quali Sant’Agostino oSant’Ambrogio, e ottenuta con la sovrapposizione di due quadrati (non a ca-so!) ruotati reciprocamente di 45°.
Le trasformazioni avvenute nella società rinascimentaleavrebbero fatto emergere l’esigenza di un culto ben distinto(anche sotto il profilo formale dell’edificio) da quelloistituzionale della chiesa locale, in considerazione, peraltro,dei conseguenti vantaggi (economici o di prestigio cittadino)derivanti dal prevedibile flusso di pellegrini e fedeli.
Sintomo di questa aspirazione sarebbe proprio il frequente ricorso alla piantacentrale nel culto mariano o in quello legato a miracoli o altra manifestazionedella divinità in un determinato luogo. In altri contesti emergerebbe, invece,l’istanza del signore locale di manifestare il proprio prestigio attraverso larealizzazione di una chiesa-mausoleo. Una larga parte della critica tradizionale
Il Rinascimento108
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 108
ritiene, invece, che la diffusione della pianta centralizzatasia da attribuire principalmente al piacere di un’alta eser-citazione formale, basata sulle regole matematiche e geo-metriche, ai limiti della speculazione intellettuale. In taleipotesi l’architettura rinascimentale è considerata, infatti,come trionfo della pura forma, scevra da connotazionireligiose, anzi per certi versi assolutamente profana, qua-le conseguenza della sostituzione di una concezione an-tropocentrica dell’universo alla spiritualità medievale.Al-la luce di questa lettura critica, quindi, l’apparato di for-me classiche e di proporzioni geometriche si applichereb-be indifferentemente a edifici civili o religiosi senza alcu-na gerarchia tra le due distinte funzioni.È indubbio, comunque, che questa laboriosa attività pro-gettuale consente alla figura dell’architetto di affrancarsidal ruolo essenzialmente esecutivo di colui che “sa fare”,accreditandolo quale creatore, in grado di padroneggiarecon l’attività intellettuale tutti i problemi della costru-zione, ed elevando il suo lavoro dalle arti meccaniche alquadrivium di quelle liberali.
Le chiese a pianta centrale 109
Alla pagina 106:Santa Maria dellaConsolazione,1508,Todi.L’armoniosa complessitàdelle forme e lacombinazionevolumetrica tra corpoprincipale e quellisecondari riflettono lavarietà delle soluzionicui conduce la ricercaformale condotta sullapianta centrale.
Alla pagina 107:Antonio da Sangalloil Vecchio, Chiesadella Madonnadi San Biagio,cupola, 1518-1534,Montepulciano, Siena.Il passaggio dalle chiesemedievali in modumcrucis a quellecosmologicamentecentralizzate può essereletto come cambiamentodall’immagine delChristus patiens al Pantocrator.
Giuliano daSangallo, Pianta diSanta Maria delleCarceri,fine XV secolo,Prato, Siena,Biblioteca Comunale.
09.04_094_109 29-01-2007 14:45 Pagina 109