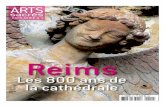I brevetti Deneux per il c.a. e le loro applicazioni nella ricostruzione delle chiese di Reims...
Transcript of I brevetti Deneux per il c.a. e le loro applicazioni nella ricostruzione delle chiese di Reims...
ATTI DEL III CONVEGNO DI STORIA DELL’INGEGNERIA
INDICE DEI CONTRIBUTI Tomo primo Prefazione SALVATORE D’AGOSTINO x
STORIA E SCIENZA DELL’INGEGNERIA
Un manoscritto ritrovato e altri eventi per riscrivere la storia del radar italiano MARIO CALAMIA, GIORGIO FRANCESCHETTI, ALESSANDRO MORI 7 Studio della forma dell’automobile: l’esperienza Pininfarina RICCARDO MAJOCCHI 17 Matematica e Ingegneria nei primi decenni di vita del Politecnico di Milano ANDREA SILVESTRI 29 Il Vajont. I primi interventi dopo il disastro GIOVANNI TRAVAGLINI 45 Dalle storie di dighe ad una storia dell’ingegneria delle dighe in Italia RUGGIERO JAPPELLI 57 I Provveditorati alle OO.PP.: la loro storia, il loro ruolo nel controllo e nella infrastrutturazione del territorio italiano DONATO CARLEA 69 Scienza, tecnologia, progresso nella visione degli ingegneri scrittori VITO CARDONE 91
Dalle Scuole di Applicazione al futuro: quale cultura per l’Ingegneria? SALVATORE D’AGOSTINO 107 La gestione di grandi progetti alla frontiera della conoscenza: la lezione del Manhattan Project BARRY SHORE, GIUSEPPE ZOLLO 117 L’ingegneria nucleare e l’atomica: un percorso etico MASSIMO ZUCCHETTI 129 Crisi energetiche ed esaurimento delle risorse: minacce recenti? MASSIMO GUARNIERI 141 Terremoti, case e sicurezza abitativa. Qualche osservazione dal punto di vista storico sull’Italia precontemporanea EMANUELA GUIDOBONI 151 Scienza e tecnica nel Magistero della Chiesa.«L’autonomia della ricerca scientifica» nei documenti del Concilio Vaticano II BRUNO BISCEGLIA 169 I problemi di Routing da Eulero ai nostri giorni GIUSEPPE BRUNO, ANDREA GENOVESE, GENNARO IMPROTA 175 L’infomobilità in Italia e l’esperienza innovativa della Campania ANTONIO COPPOLA 193 La nascita del tetto con le tegole e la formazione dei sistemi decorativi: qualche riflessione GIOVANNA GRECO 207 Strumenti greco-romani per la misura delle distanze
MICHELA CIGOLA, FLAVIO RUSSO, CESARE ROSSI, MARCO CECCARELLLI 219 Il cemento romano: un precursore dei cementi belitici? RICCARDO SERSALE 229 Alcune riflessioni sulla storia del disegno in ambito industriale EMILIO CHIRONE, EDOARDO ROVIDA 239 La siderurgia rinascimentale: l’impianto estense in Garfagnana WALTER NICODEMI, SILVIA BARELLA, CARLO MAPELLI 249 Invarianti e dinamiche della professione nel Mezzogiorno tra Cinque e Settecento ALFREDO BUCCARO 261 Histoire du froid DIDIER COULOMB 271 La rivoluzione chimica di Lavoisier FRANCESCO BRANDA 281 Breve storia della reologia GIUSEPPE MARRUCCI 291 Origine e sviluppo delle discipline chimiche applicate nelle Scuole di Ingegneria CARMINE COLELLA, DANIELA PISCOPO 301 La statica grafica nell’ingegneria civile di fine Ottocento DANILO CAPECCHI, GIUSEPPE RUTA 313 L’evoluzione del percorso ergonomico in ingegneria PAOLA CENNI, FRANCESCA ROMANA D’AMBROSIO ALFANO 323 Itinerari storici nell’ingegneria geotecnica italiana ALESSANDRO FLORA, RUGGIERO JAPPELLI, CARLO VIGGIANI 339
Ingegneria e sottosuolo: il caso Napoli CARLO VIGGIANI 349 La modellazione strutturale nel Novecento. Ragioni e diffusione dell’induttivismo sperimentale in Italia e all’estero MARIO ALBERTO CHIORINO, GABRIELE NERI 367 Qualche cenno sulla nascita, sugli sviluppi e su alcune attuali applicazioni dell’Ingegneria del Traffico RAFFAELE MAURO 377
EVOLUZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Come costruire una cupola e vivere sereni EUGENIO GALDIERI 387 La “macchina” delle terme romane; architettura e funzioni GIUSEPPE MARIA MONTUONO 399 Proprietà dei materiali da costruzione: antichi e moderni metodi di analisi ROSA OSCURATO, FERDINANDO TORALDO, MICHELE BRIGANTE 411 Geometria pratica e geometria teorica MAURA BOFFITO 421 Storia della Fulminologia AMEDEO ANDREOTTI, DARIO ASSANTE, LUIGI VEROLINO 429 L’illuminazione pubblica ad olio nella Napoli del Settecento. Origini ed esperimenti ANDREA LIZZA 439 Committenti, maestranze e tecnici nella costruzione rurale dell’agro ericino tra il XVIII ed il XIX secolo GIUSEPPE COSTA 447
L’acustica nell’architettura teatrale al principio del XIX secolo: dal National Theater allo Schauspielhaus di Berlino ANDREA MAGLIO 459 Ordonnance e solidité: un problema di architettura tra décadence e scienza del costruire all’inizio del XIX secolo BIANCA GIOIA MARINO 469 Progetti ottocenteschi di potenziamento della rete carrabile della Costiera Amalfitana MARIA RUSSO 483 El sistema polonçeau en el Puente Isabel II (puente de Triana, Sevilla, España) AMPARO GRACIANI GARCÌA 493 Gli ingegneri e la manualistica per l’edilizia razionale ed economica all’inizio del XX secolo CLAUDIO MAZZANTI 505 L’edilizia rurale: architetti e ingegneri a confronto nel primo Novecento GABRIELLA MUSTO 515 I brevetti Deneux per il c.a. e le loro applicazioni nella ricostruzione delle chiese di Reims (1919-1938) MARIA ROSARIA VITALE 529 Edilizia scolastica a Salerno tra le due guerre: evoluzione dei modi del costruire tra tradizione e modernità FEDERICA RIBERA, PASQUALE DOLGETTA 543 La struttura dell’arco nell’architettura italiana moderna STEFANIA PALAORO, ENZO SIVIERO 557 L’alta velocità ferroviaria. Un’occasione perduta EMILIO MARAINI 567
La costruzione metallica per sistemi edilizi antisismici: l’Istituto dei concorsi in Italia RENATO MORGANTI, ALESSANDRA TOSONE 579 Innesti di strutture in c.a. in edifici in muratura: ricadute sulla analisi di vulnerabilità MICHELE BRIGANTE 591 Il Museo dell’Industria a Brescia EMILIO CHIRONE, PIER PAOLO POGGIO 601 L’importanza delle spiagge urbane e del loro equilibrio EDOARDO BENASSAI 611 Le tecnologie FRP e FRCM. Evoluzione in ambito edilizio MARIANGELA BELLOMO 623 La relazione tra forma e struttura nella storia della leggerezza in architettura: le tensostrutture a membrana ALESSANDRA ZINGONE 633
Tomo secondo
ORIGINI E FORMAZIONE DELL’INGEGNERE
Ingegneria militare borbonica. La formazione nel Settecento dalla lettura delle “Reali Ordinanze” MARIA GABRIELLA PEZONE 643 Le ricerche scientifiche in Campania di Charles Babbage, l’inventore della macchina alle differenze ANDREA VILLA 657 La nascente cultura ingegneristica e il tema della cupola nella Sicilia dell’Ottocento BRUNO BILLECI 663 Alle radici delle discipline: l’Architettura nelle Scuole di Applicazione fra Otto e Novecento MARIA BEATRICE BETTAZZI. PIER GIORGIO MASSARETTI, GIOVANNI MOCHI, GIORGIA PREDARI 675 L’influenza dell’École des Ponts et Chaussées nella formazione professionale degli ingegneri Civili del Corpo Reale del Genio degli Stati Sardi CRISTINA BOIDO 687 Architetti e ingegneri nelle trasformazioni della città di Napoli agli inizi del XX secolo ALDO AVETA 697 I modelli, geometrici e grafici, come strumenti nella formazione e nella pratica dell’ingegnere LIA MARIA PAPA 711 La Facoltà d’Ingegneria a Pisa dalla nascita (1913) all’immediato dopoguerra (1950) ENRICO MARIA LATROFA 723 La storia dell’ingegneria e la formazione degli ingegneri FRANCESCO ROSA, EDOARDO ROVIDA 735
OPERE E PROTAGONISTI TRA ANTICO E MODERNO La storia, il percorso e le opere dell’acquedotto Augusteo di Serino GIOVANNI DE FEO, SABINO DE GISI 745 Roma, Terme di Caracalla, volte a concrezione MARIA LETIZIA CONFORTO, SILVIA NICOLUCCI 755 Sulla costruzione e sulla statica della cupola di Brunelleschi MARIO COMO 769 Il Ponte del Carmine a Bitonto. Precetti strutturali e proposizioni palladiane TOMMASO MARIA MASSARELLI 779 L’ingegneria militare del XVI secolo: Cristòbal de Rojas e i trattatisti italiani NINA MARIA MARGIOTTA 787 Il ruolo della meccanica ne Le fortificazioni di Buonaiuto Lorini RAFFAELE PISANO, DANILO CAPECCHI 797 Il castello di Baùso e il sistema fortificatorio dei Peloritani MARIO MANGANARO 809 L’edilizia universitaria federiciana: dal progetto di Giulio Cesare Fontana a quello di Michio Sugawara ANNA NATALE 819 Francesco Lana, scienziato e tecnico EMILIO CHIRONE, PIER LUIGI PIZZAMIGLIO 829 Le “fabbriche di rinforzo” del Braccio nuovo del Real Palazzo di Napoli: aspetti della cultura tecnica napoletana alla fine del XVIII secolo ANTONIO FRIELLO 839 Architetture del lavoro in area casertana tra Sette e Ottocento: “architetti ingegneri” alla scuola di cantiere di Luigi Vanvitelli
FRANCESCA CAPANO 857 El puerto pesquero de Marbella (Màlaga-España): historia y transformacion de un espacio portuario DIEGO ANGUÌS CLIMENT 869 La costruzione di un’opera pubblica nell’800 borbonico fra rispetto della proprietà privata e difesa dell’interesse collettivo FELICITA DE NEGRI 879 Il carcere borbonico di Avellino e le “nuove” tendenze culturali europee sulla detenzione PIERFRANCESCO FIORE 891 La rivoluzione stradale di John Loudon McAdam PAOLO FERRARI 901 La gestione del territorio e delle infrastrutture nello stato sabaudo di Vittorio Amedeo II BEATRICE MARIA FRACCHIA 913 Le conferenze e le lezioni sul calcestruzzo armato di Camillo Guidi e l’insegnamento della tecnica delle costruzioni alla Scuola di Applicazione d’Artiglieria e Genio di Torino AULO GUAGNINI 923 L’architettura sanitaria. Sperimentazioni e applicazioni tra Ottocento e Novecento GIOVANNI FATTA, TIZIANA CAMPISI, CALOGERO VINCI 933 L’ingegnere Giustino Fiocca: le opere tra tradizione e innovazione MARIA LIPPIELLO, LUCIA BOVE, LIANA DODARO 945 Una città tra due fiumi. Ponti a Torino MARIA PAOLA MARABOTTO, NADIA FABRIS 957 Il ponte sul Tagliamento tra Pinzano e Ragogna nella storia dell’ingegneria italiana TULLIA IORI, MICHELE RICCI 967 Ingegneri e irredentismo in una regione di confine: il caso Panzarasa
STEFANO MOROSINI 979 Elettrificazione delle funicolari a Napoli. La funicolare Centrale GIOVANNI FRESA 991 Nuove fonti archivistiche sull’opera di Risanamento e Ampliamento di Napoli MARIA ROSARIA DELL’AMICO 1003 Per una storia della Società degli Ingegneri e Architetti italiani: l’attività di Gustavo Giovannoni nel sodalizio, 1896-1924 ANDREA PANE 1015 La copertura della “gran sala” della Biblioteca Nazionale di Napoli: i progetti di restauro di Adolfo Avena CLAUDIA AVETA 1029 Emma Strada, ingegnere dal 1908. La vita della prima donna ingegnere attraverso le fonti archivistiche istituzionali e private MARGHERITA BONGIOVANNI, NICOLETTA FIORIO PLÀ 1037 Emma Strada. Temi, forme e maestri della formazione politecnica, progetti, disegni e opere della professione di progettista PINA NOVELLO, ELENA MARCHIS 1047 L’opera dell’ingegnere Arturo Boccassini a Barletta CARLOS ALBERTO CACCIAVILLANI 1057 Architetture per la città e disegno urbano a Napoli nell’opera degli ingegneri De Simone, Piccinato e Cosenza ANGELA D’AGOSTINO 1067 Roberto Siano: un ingegnere napoletano della Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna della Campania RAFFAELE AMORE 1079 Il palazzo Olivetti a Milano di G.A. Bernasconi, A. Fiocchi e M. Nizzoli LAURA GRECO 1089 L’Hangar per dirigibili di Antonio Garboli ad Augusta MARIELLA MUTI, GAETANO PETRACCA, ENRICA RASIMELLI 1099
Il magistero di P.L. Nervi nella stazione ferroviaria di Vaglio Lise a Cosenza STEFANIA MORNATI 1109 Pier Luigi Nervi: rapporti statunitensi inesplorati. 1952-1979 ALBERTO BOLOGNA 1119 I modelli strutturali di Pier Luigi Nervi per la Cattedrale di San Francisco GABRIELE NERI 1131 Strutture e infrastrutture per le Olimpiadi di Roma del 1960: analisi di un macroprogetto attraverso la lettura dei disegni di Pier Luigi Nervi CHIARA VERNIZZI 1141 Committenza pubblica nel Veneto fascita: le opere dell’ingegnere Pietro Motta CAROLINA PUPO 1151 Storia ed evoluzione dei sistemi di difesa dalle valanghe di neve BERNARDINO CHIAIA, BARBARA FRIGO 1163 La cupola della chiesa del Gesù a Palermo: un intervento di ricostruzione in cemento armato MATTEO ACCARDI, SIMONA BERTOROTTA, LIDIA LA MENDOLA, GIOVANNA VELLA 1173 Il professore Gaetano Latmiral nel ricordo di un suo allievo GIORGIO FRANCESCHETTI 1183 Gaetano Latmiral, sottovoce MARIO CALAMIA 1189 Il professore Gaetano Latmiral e l’Istituto Universitario Navale di Napoli PAOLO CORONA 1191 Ricordando Tani Latmiral e vivendo ancora oggi il suo insegnamento ANTONIO SASSO 1195 Un ingegnere soprintendente: l’opera di Pietro Lojacono nel restauro dei monumenti della Sicilia orientale (1954-1963)
MARIA ROSARIA VITALE, VINCENZA TAFARO 1203 Ingegneria, architettura e arte nelle opere pubbliche: gli esiti della legge del 2% a Napoli FRANCESCO VIOLA 1217 Il contributo della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II durante l’emergenza sismica del 1980/81 SALVATORE D’AGOSTINO 1227
MARIA ROSARIA VITALE
I brevetti Deneux per il c.a. e le loro applicazioni nella ricostruzione delle chiese di Reims (1919-1938)
Introduzione
Le ricerche che Henri Deneux con-duce nel corso della sua carriera sulle coperture lignee della Francia setten-trionale sono alla base del brevetto per elementi in cemento armato assemblati e smontabili che egli registra fra il 1919 ed il 1921.
La ricerca sulle charpentes viene avviata a partire dal 1892, negli anni dell’apprendistato, durante i quali Deneux studia le coperture della catte-drale di Reims, proseguendo con una serie di edifici della stessa città e giun-gendo, infine, a costituire un corpus documentario di rilievi comprendente circa cinquecento coperture distribuite nel nord della Francia e in alcune aree del Belgio, al fine di proporne un si-stema di classificazione e datazione.
Formatosi alla scuola di Anatole de Baudot, Deneux ha modo di travasare il patrimonio di conoscenze acquisito attraverso lo studio delle grandi struttu-re lignee nella ricerca di nuove possibi-lità applicative, mediante l’utilizzo della tecnologia del cemento armato. Le distruzioni della prima guerra mon-diale costituiranno, per lui, l’occasione di introdurre i sistemi costruttivi bre-vettati nel campo del restauro monu-mentale.
Le tappe di questa sperimentazione, che viene via via verificata attraverso prove di carico ed applicata nella co-
struzione di hangar d’aereo, sono scandite da altrettanti interventi su fabbriche della città di Reims, nelle chiese di Saint-Jacques e di Saint-Remi e nella stessa cattedrale, le cui copertu-re erano andate perdute a causa degli incendi provocati dai bombardamenti.
Nel primo Novecento la città di Reims, forse non a caso, è sede di importanti esperienze ingegneristiche e costituisce un terreno fertile per la ricerca.
L’attività di Deneux si colloca all’interno di una stagione ricca di esperimenti che sancisce, in Francia, la transizione dalla fase dei “brevetti” e dei “sistemi” – segnata dalla contrap-posizione fra Cottancin ed Hennebi-que – al momento di definitiva consa-crazione del cemento armato come “materiale” della nuova architettura1.
Seguendo l’indirizzo dettato da de Baudot, Deneux segue da vicino il sistema Cottancin che, alla fine, uscirà perdente dalla competizione.
Le sue realizzazioni, l’uso etero-dosso del cemento armato, contestato nella sua concezione monolitica, l’ottimo stato di conservazione delle sue strutture a distanza di un secolo, confermano la statura ed il respiro della sua ricerca e la capacità di perve-nire a nuove sintesi attraverso l’uso di forme antiche e materiali nuovi, senza mai “mentire” ai mezzi impiegati2.
MARIA ROSARIA VITALE
530
La lezione dell’antico A partire dal 1892, Henri Deneux
inizia a rilevare la cattedrale di Reims ed avvia la sua ricerca sulle coperture lignee della Francia del nord. La rico-gnizione procede negli anni e si arric-chisce soprattutto grazie all’incarico che egli, divenuto nel 1905 architecte en chef, riceve dalla Commissione dei Monumenti storici e che lo porta in missione dal settembre 1917 al marzo 1918, in compagnia di Camille Enlart, per rilevare le charpentes di Etampes, Orléans, Blois, Tours e Angers3. Le informazioni desunte attraverso le campagne fotografiche e di rilievo vengono verificate attraverso la restitu-zione grafica e la realizzazione di mo-delli lignei tridimensionali.
L’utilizzo incrociato del disegno, della fotografia e dei modelli rappre-senta sicuramente la cifra caratteristica del modo con cui Deneux conduce le proprie analisi non soltanto in fase di studio, ma anche durante l’elaborazio-ne dei progetti e, benché i materiali prodotti abbiano avuto un largo utiliz-zo a scopo didattico, sembra opportuno ribadire la loro finalizzazione alla ricerca ed il loro ruolo nella costruzio-ne di un vero e proprio “metodo” di approccio alla costruzione storica.
Le ricerche di Deneux vedranno la luce nel 1927, con la pubblicazione dello studio su L’évolution des char-pentes du XIe au XVIIIe siècle. Il sag-gio, che ha costituito a lungo un riferi-mento obbligato per gli studiosi, racco-glie solo parzialmente i risultati di una ricognizione che egli proseguirà ancora negli anni, con interesse costante.
Fig. 1 – Maquette della charpente della nave maggiore nella cattedrale di Reims
Nel testo – volto ad elaborare, at-
traverso il confronto delle soluzioni costruttive, un sistema di classificazio-ne e datazione per le strutture lignee – Deneux individua diverse grandi “fa-miglie” di charpentes: da quelle “à chevrons portant fermes”, “à pannes”, “par étages successifs”, fino alle cosid-dette charpentes “à la Philibert Delor-me”. Queste ultime (e, in particolare, quella della cupola della cappella Sain-te-Croix nel Cimetière du Nord a Reims) sono state individuate come il modello di riferimento per il brevetto di Deneux sul cemento armato.
Il sistema che Delorme sperimenta nel 1555 e pubblica nel 15614 sostitui-sce i lunghi e pesanti componenti delle coperture tradizionali con elementi di ridotte dimensioni, facilmente traspor-tabili, disposti di coltello e collegati
I brevetti Deneux per il c.a. e le loro applicazioni nella ricostruzione delle chiese di Reims (1919-1938)
531
con cunei, spine e chiavi di legno più duro. In effetti, l’assemblaggio degli elementi nei brevetti Deneux riprende in modo esplicito il sistema “à petits bois”, ma il travaso di esperienze dallo studio delle charpentes ai brevetti per il cemento armato e, quindi, ai cantieri di restauro di Reims è decisamene più ampio ed articolato.
Le relazioni costruttive fra gli ele-menti delle coperture, la loro compar-tecipazione alla resistenza del sistema, le soluzioni di dettaglio sui sistemi di mensole che riducono le luci, riportan-do in basso i carichi, gli studi sulle varie ricostruzioni nel tempo, sono tutti spunti di riflessione che verranno am-piamente utilizzati in occasione dei restauri, concorrendo a delinearne le soluzioni progettuali.
Lo stesso sistema costruttivo bre-vettato da Deneux non si comprende, nella specificità della sua concezione strutturale, al di fuori di questo insieme di riferimenti e indipendentemente dalla linea di continuità che lo lega alla ricerca sulle charpentes. Una semplice verifica attraverso le date consente di confermare la continua intersezione fra le diverse ricerche: non si tratta, dun-que, di una derivazione a cascata, ma di un percorso fitto di reciproci rimandi ed interscambi, in cui gli studi e le applicazioni nei diversi ambiti proce-dono contestualmente e si arricchisco-no a vicenda. I brevetti e il sistema Deneux
Fra il 1919 ed il 1921 Deneux de-posita due brevetti relativi a “un procé-dé de construction en ciment armé”
che assembla elementi prefabbricati di ridotte dimensioni, per realizzare “po-teaux, solives, poutres, ponts et passe-relles, escaliers, pans de ciment armé et charpentes de toutes formes”5.
Il sistema prevede planches in c.a. di sezione 4x20 cm, di lunghezza va-riabile da 2 a 3 metri, assemblate me-diante altri elementi passanti più corti, serrati da clavettes in legno di quercia o da altri tipi di cunei6. Tutti gli ele-menti, curvi o rettilinei, sono realizzati attraverso un sistema di modellazione in casseforme lignee, costituite da semplici cornici, all’interno delle quali sono posizionati dei tasselli di legno per realizzare i fori di assemblaggio.
Secondo quanto si legge ancora nel-la descrizione del brevetto, “le scelle-ment de certains assemblages permet d’obtenir des ouvrages ayant toutes les propriétés du monolithe et, d’autre part, la libre dilatation de l’ouvrage est assuré par d’autres assemblages laissés libres, sans scellement”.
Fig. 2 – Varianti di nodi e di assemblaggi
MARIA ROSARIA VITALE
532
I pezzi sono realizzati con una mal-ta di cemento Portland dosato a 350 Kg e sabbia vagliata della Mosella, armati con tondini d’acciaio lisci del diametro di 12 mm, con staffe di collegamento e di rinforzo in corrispondenza delle mortase e degli intagli predisposti per il montaggio. Il getto avviene in due riprese, intervallate dalla costipazione della malta cementizia e dalla succes-siva posa delle armature, ed il disarmo dalle casseforme avviene in modo quasi immediato, dopo la pressatura finale, senza attendere la presa dell’impasto. La perfetta sformatura degli elementi rappresenta già un pri-mo “collaudo” ed esige buona qualità e vaglio attento dei materiali, dosaggio minimo dell’acqua ed estrema cura nella lavorazione.
I vantaggi che Deneux attribuisce al suo sistema sono molteplici e sono riscontrabili tanto nella conduzione del cantiere, quanto nella realizzazione finale. Il sistema è concepito per rea-lizzare a piè d’opera tutti gli elementi e, quindi, il vantaggio in termini di economia di tempi e materiali è evi-dente. Le condizioni meteorologiche non condizionano più il regolare an-damento dei lavori sia perché la confe-zione degli elementi può essere avveni-re al chiuso, sia perché i pezzi nella fase di presa non sono esposti alle intemperie. Si realizza, inoltre, una notevole economia di legno perché non sono più necessarie grandi impalcature, ma solo piccoli ponteggi per il mon-taggio in opera e le casseforme sono riutilizzate subito dopo la sformatura.
Le ridotte dimensioni degli elemen-
ti ne consentono una facile movimen-tazione in cantiere da parte di uno o due operai, anche ad altezze conside-revoli. Lo spessore contenuto consente una grande precisione nel posiziona-mento delle armature, che non rischia-no di essere spostate durante l’ope-razione di costipazione del getto. La prefabbricazione, oltre a ciò, assicura grande regolarità e precisione esecutiva e garantisce che i nodi di connessione fra gli elementi siano punti di forza della struttura. Leggerezza e versatilità sono, infine, caratteristiche precipue del sistema che, assemblato a secco, risulta perfettamente smontabile e riutilizzabile per altri scopi. La cultura coeva del cemento armato
L’analisi del “sistema Deneux” ri-vela, con tutta evidenza, una serie di riferimenti, quando non nessi espliciti, nei confronti della sperimentazione precedente e, come anticipato, si collo-ca in un filone preciso delle ricerche riconducibile ai brevetti sul cemento armato di Paul Cottancin. Anch’egli originario di Reims, l’ingegnere che lega il suo nome ad una serie di brevet-ti per “travaux en ciment avec ossature métallique” concepisce le sue strutture come piastre sottili innervate da tralicci di épines-contreforts. Il sistema si basa sul ciment armé, preferito al béton armé, ed utilizza ferri di piccolo dia-metro orditi come una tela all’interno del getto di malta cementizia. Orizzon-tamenti e coperture in cemento armato si associano alla muratura di mattoni armata utilizzata per gli elevati e ad essa si interconnettono mediante il
I brevetti Deneux per il c.a. e le loro applicazioni nella ricostruzione delle chiese di Reims (1919-1938)
533
sistema delle nervature. Un sistema “ibrido”7, dunque, le cui
prerogative vengono esplicitamente richiamate nella pubblicistica tecnica con la quale la ditta promuove i propri prodotti: “Seuls les systèmes P. Cot-tancin résolvent complètement le be-soin qui se fait sentir de créer un nou-veau mode de construction pouvant avoir, avec la légèreté et l’élasticité de la construction métallique, la durée et la stabilité de la maçonnerie”8. Non sfugge, al proposito, la perfetta rispon-denza con le affermazioni di Anatole de Baudot: “Il faut réserver l’emploi absolu du ciment armé pour les plan-chers, les combles et certains travaux de détails, tels que balcons, balustra-des, etc. S’il s’agit de piles et de murs, voire même d’épines, il est préférable de recourir à la brique enfilée, voir en raison des facilités d’exécution, des motifs d’économie et, par le fait même que le ciment armé travaille à la fois à la compression et à la traction, il sera d’un emploi plus rationnel horizonta-lement que verticalement”9.
Non vi è dubbio che siamo decisa-mente distanti dai contenuti della spe-rimentazione di Hennebique, contras-segnata da una concezione “monoliti-ca” della struttura. Come è stato oppor-tunamente osservato, la questione della monoliticità è “argument plus com-mercial qu’architectural”10, ma costi-tuisce la via primaria alla definizione del béton armé come sistema costrutti-vo basato sulla precisa distinzione costruttiva (e di qui, poi, estetica) fra ossatura e riempimento.
I motivi per i quali Anatole de Bau-
dot sente di sposare le ragioni del si-stema Cottancin contro il più fortunato brevetto Hennebique sono stati effica-cemente esplorati11. All’allievo di Viollet-le-Duc, maggiore sostenitore e più convinto “interprete” del sistema, si devono non soltanto la promozione e la diffusione del brevetto (mediante la progettazione, l’insegnamento e la pubblicistica), ma anche alcune impor-tanti innovazioni costruttive, in coe-renza con il verbo del “razionalismo strutturale” che egli persegue12.
Il sodalizio con Cottancin – a parti-re dal 1892 e fino all’esperienza para-digmatica di St-Jean a Montmartre – si fonda sulla comune concezione del cemento armato come sistema basato su grande perizia tecnica ed esecutiva e su un ragionamento strutturale che ripropone, nel nuovo materiale, i tradi-zionali procedimenti empirici ed intui-tivi che sono stati ricavati dalla lezione costruttiva dei maestri del Medioevo.
Fig. 3 – Interno di St-Jean-de-Montmartre
Vale tuttavia la pena di sottolineare come, a dispetto dei detrattori che gli rimproverano l’incapacità di modellare le sue strutture e di fornirne un efficace algoritmo di calcolo, Cottancin prefi-
MARIA ROSARIA VITALE
534
guri una strada non in concorrenza, ma totalmente alternativa a quella di Hen-nebique, che solo le ricerche sulle strutture sottili saranno in grado di portare a compimento.
Nel 1906, sarà lo scientismo buro-cratico della ministeriale sul cemento armato a mettere definitivamente in crisi il mondo dei brevetti e dei siste-mi: la diffusione di norme sulla realiz-zazione delle opere in cemento armato consentirà da una parte la diffusione ed il controllo tecnico-scientifico del sapere, dall’altra, aprirà definitivamen-te la strada alla autonoma affermazione del “materiale” rispetto alle singolarità dei procedimenti costruttivi13: nono-stante la difesa d’ufficio molte volte assunta da de Baudot a favore del ce-mento armato di Cottancin, la mancan-za di un efficace controllo numerico “l’avrebbe allontanato molto rapida-mente da un ambiente professionale popolato da ingegneri civili più sensi-bili alle bellezze matematiche che all’intuizione creativa”14.
In questa sede merita solo osservare come la progressiva uscita di scena del sistema dal mondo della nuova costru-zione non ne ostacola, tuttavia, il per-manente utilizzo nel campo del restau-ro monumentale. Le ragioni sono di-verse: la classe degli allievi di de Bau-dot è prevalentemente confluita nei ruoli dell’amministrazione dei monu-menti storici; il problema dell’incalco-labilità del sistema, che ne determina in larga misura l’abbandono nel campo della produzione del nuovo, non trova evidentemente riscontro nel cantiere di restauro; in ultimo, la natura “artigia-
nale” del sistema Cottancin, contrap-posta alla vocazione nettamente indu-striale del concorrente Hennebique, incontra in misura maggiore le esigen-ze dei restauratori.
Il debito che Deneux contrae nei suoi confronti passa, con tutta eviden-za, proprio per il tramite di Anatole de Baudot, le cui lezioni al Trocadero egli ha potuto seguire dopo il trasferimento a Parigi nel 1898. Deneux stesso, come molti architetti della cerchia razionali-sta, utilizza il cemento armato di Cot-tancin per la nuova architettura e firma con questo sistema la costruzione, fra il 1911 ed il 1913, della propria abitazio-ne in rue Belliard a Parigi.
Fig. 4 – Facciata di casa Deneux a Parigi
Coerentemente con la linea soste-nuta dal suo maestro, egli denuncia all’esterno la snella struttura, ricopren-do le murature di mattoni armati con un rivestimento ceramico dal disegno geometrico ripetitivo: il modello è
I brevetti Deneux per il c.a. e le loro applicazioni nella ricostruzione delle chiese di Reims (1919-1938)
535
senza dubbio l’architettura di de Bau-dot, ma il risultato è nettamente più asciutto ed essenziale.
Il primo conflitto mondiale metterà fine a queste esperienze ed aprirà il campo alla progressiva “normalizza-zione” del cemento armato ed alla ricerca di nuove modalità espressive. Ma, se già nel primo decennio del nuovo secolo l’esperienza dei “siste-mi” può dirsi conclusa, che ruolo oc-cupa la sperimentazione di Deneux? E può effettivamente qualificarsi come sperimentazione oppure la si deve considerare come un prodotto interes-sante, ma tardivo di una fase ormai trascorsa?
I brevetti Deneux, nel loro diretto collegamento con il sistema Cottancin, ne ereditano in diversa misura pregi e virtù. Sotto il profilo esecutivo, la precisione e l’accuratezza del confe-zionamento degli elementi progettati da Deneux sono totalmente in linea con le esperienze nate dalla ricerca congiunta di Cottancin e de Baudot. Non a caso, quest’ultimo si dimostra sempre fiero avversario del beton armé e del sistema Hennebique proprio in ragione della sua “grossolanità” rispet-to alle finezze realizzative del ciment armé15.
Nel sistema brevettato da Deneux, inoltre, le armature sono già stabilite a priori e non c’è alcuna traccia di studi per un più preciso dimensionamento ed anche in questo aspetto l’architecte en chef continua a seguire un indirizzo di progettazione strutturale decisamente poco incline al calcolo matematico degli elementi. La sperimentazione
viene supportata piuttosto dalla model-lazione in scala e al vero: le maquettes che da sempre accompagnano gli studi di Deneux sulle charpentes antiche vengono ora utilizzate per verificare il progetto e si associano alla realizza-zione di prototipi da sottoporre a prove di carico: l’architetto stesso riferisce di aver realizzato “des expériences de charges” e di aver “etudié une ferme de 52 m. de portée pour un hangar d’avions”16.
Anche sotto il profilo costruttivo, il sistema messo a punto da Deneux si presta per usi “ibridi”, per esempio in associazione, sostegno o completamen-to di strutture murarie. Inoltre, se si analizza meglio il contenuto descrittivo del brevetto, si può vedere come le applicazioni riguardino elementi isolati (poteaux, solives, poutres), strutture particolari (ponts, passerelles, esca-liers) che, proprio in virtù delle caratte-ristiche del sistema, potremmo definire “di servizio”, ed infine vere e proprie parti della costruzione (pans de ciment armé, charpentes) che, tuttavia, sem-brano mantenere una propria autono-mia rispetto all’insieme.
L’elenco esemplificativo proposto da Deneux rivela l’indirizzo del brevet-to a specifici lavori di architettura e tradisce anche la sua concezione strut-turale della costruzione come “assem-blaggio” di parti differenti, ciascuna contrassegnata da funzioni (strutturali, ma anche costruttive) diverse e, quindi, da materiali diversi. Tuttavia, proprio questa caratteristica costituisce, da una parte, l’elaborazione conclusiva di un percorso che sintetizza spunti molte-
MARIA ROSARIA VITALE
536
plici (legame fra antichi e nuovi mate-riali, prefabbricazione degli elementi, economia di tempi e materiali) che possono farsi risalire già ad alcune lungimiranti considerazioni di Viollet-le-Duc17; dall’altra parte, in una forma di “compatibilità” ante litteram, si mostra particolarmente efficace nel connubio con le strutture murarie ed in questo, ancora oggi, possiamo rintrac-ciare il suo carattere di assoluta origi-nalità di concezione ed applicazione. Le applicazioni nel restauro
“La perfection des procédés actuels a fait ses preuves au cours des restaura-tions entreprises dans les régions dé-vastées qui utilisent les ressources de la technique moderne tout en conservant intact l’esprit même du Moyen Age”18. Un bilancio positivo quello che Paul Léon propone alla Conferenza di Atene del 1931 riguardo all’utilizzo delle nuove tecniche nella ricostruzione monumentale dopo la Grande Guerra.
La disamina dei fatti e dei cantieri rivela, tuttavia, un panorama decisa-mente più sfumato e contraddittorio. Come è stato opportunamente rilevato, “au départ, on put envisager la possibi-lité de non-restaurer des églises dévas-tées comme témoignage de la barbarie. Mais cette diatribe s’estompa relative-ment vite. La difficulté intellectuelle d’admettre la reproductibilité d’œuvres déclarées comme majeures, les cathé-drales, fut soulagée par l’élaboration abstraite d’une sorte de protocole de la reproduction respectueuse”19.
Avendo richiesto ed ottenuto, all’indomani del conflitto, di potersi
dedicare ai restauri della sola città di Reims, Deneux inizia a cimentarsi con i cantieri delle chiese di St-Jacques, di St-Remi e della Cattedrale che diven-tano altrettante tappe della sperimenta-zione del proprio sistema per la rico-struzione delle coperture20. L’architetto ha già alle spalle diverse esperienze di utilizzo del cemento armato nel restau-ro di edifici monumentali, prevalente-mente riferibili a rifacimenti di coper-ture con lastre sottili armate con una maglia di ferri da 5 mm: si tratta di soluzioni decisamente più convenzio-nali, riprese direttamente dalla lezione di Cottancin21, che verranno adoperate per la realizzazione della copertura provvisoria della cattedrale di Reims.
Fig. 5 – Veduta della charpente della nave maggiore di Saint-Jacques a Reims
Di tutt’altro segno l’esperienza che
inizia nel 1920 con la ricostruzione della copertura di St-Jacques. La solu-zione adottata prevede un sistema di arbalétriers accoppiati a costituire l’orditura primaria, collegamenti longi-tudinali costituiti da pannes situate a metà della loro luce, che portano a loro volta gli chevrons secondari. Come
I brevetti Deneux per il c.a. e le loro applicazioni nella ricostruzione delle chiese di Reims (1919-1938)
537
nota opportunamente Deneux, il siste-ma degli assemblaggi fa sì che tutto il sistema sia complanare e l’utilizzo di elementi di sezione ridotta obbliga ogni componente a contribuire alla resistenza di tutto l’insieme, come avveniva nelle charpentes medievali.
Fig. 6 – Progetto delle charpentes della navate laterali nella cattedrale di Reims
Le coperture delle navate laterali
della cattedrale, realizzate fra il 1923 ed il 1924, seguono da vicino questo modello: l’incatenamento trasversale viene soppresso e la spinta laterale viene raccolta alla base dalle sablières (lunghe travi longitudinali disposte sul colmo dei muri d’ambito) e trasferita ai piloni da cui spiccano gli archi ram-panti; superiormente la copertura ha un vincolo di semplice appoggio su men-sole in cemento incastrate sul muro del triforio ed è, quindi, libera di dilatarsi.
A metà del 1924, grazie alla dona-zione Rockefeller, è possibile avviare la ricostruzione delle coperture della navata centrale della cattedrale, sull’esempio della quale verranno restituite quelle del transetto e del coro. La soluzione progettuale presenta delle importanti innovazioni rispetto ai can-
tieri precedenti, ma, ancora una volta, i croquis conservati forniscono interes-santi spunti di riflessione per compren-dere la genesi del progetto. Il corpus dei rilievi di Deneux comprende, infat-ti, una cospicua documentazione ri-guardante la nuova copertura della cattedrale di Chartres, ricostruita in ferro e ghisa da Edouard Baron fra il 1837 ed il 1839 ed individuata come principale esempio di riferimento per il progetto della copertura della nave maggiore nella cattedrale di Reims22.
Fig. 7 – Progetto di ricostruzione della charpente della cattedrale di Chartres
In entrambi i casi la struttura si ca-
ratterizza per l’adozione di un doppio sistema di arbalétriers (l’inferiore ad andamento curvo ed il superiore rettili-neo), con duplice appoggio sulla ter-minazione dei muri della navata e su un sistema di mensole. Tanto l’utiliz-zo di multipli arbalétriers, quanto la ricerca di un piano di imposta coadiu-
MARIA ROSARIA VITALE
538
vato da mensole laterali è ampiamente attestato nella tradizione costruttiva, ma la soluzione di Baron libera lo spazio centrale dalla foresta di incaval-lature della charpente tradizionale.
Fig. 8 – Progetto di ricostruzione della charpente della cattedrale di Reims
A Reims tali suggerimenti sono utiliz-zati allo scopo di riportare in basso parte dei carichi della copertura, facen-doli confluire sulle mensole lapidee inserite in corrispondenza dell’arrivo degli archi rampanti. Lo spunto (for-male e costruttivo) di un sistema reti-colare ad intradosso curvo ed estrados-so retto, ricavato da Chartres, nella soluzione di Deneux si estende anche al sistema dell’incatenamento trasver-sale: lo spazio dell’“immense vaisse-au”23 realizzato dalla nuova copertura diventa percorribile grazie al solaio
gettato fra le incavallature inferiori.
Le applicazioni del cemento armato a St-Remi costituiscono la tappa con-clusiva della sperimentazione e riguar-dano tanto il consolidamento e la rico-struzione delle volte, quanto il rifaci-mento della copertura. Nella ricostru-zione delle volte il cemento armato viene utilizzato per realizzare dei “cor-sets” che, come pinze, imprigionano all’estradosso gli arc-doubleaux della nave maggiore ed impediscono loro di deformarsi sotto la spinta degli archi rampanti esterni, erroneamente appli-cati ben al di sopra dell’imposta delle crociere. L’intervento permette a De-neux di risolvere il problema struttura-le, senza correggere il “disordine” costruttivo riscontrato.
Fig. 9 – Maquette della charpente della nave maggiore di St-Remi
La copertura utilizza l’ormai col-laudato sistema ad elementi assemblati e, pur in una soluzione strutturale sem-plificata, sviluppa alcune degli spunti della charpente della cattedrale.
I brevetti Deneux per il c.a. e le loro applicazioni nella ricostruzione delle chiese di Reims (1919-1938)
539
Il sistema del doppio arbalétrier ad intradosso curvo ed estradosso retto viene riproposto, ma i due elementi confluiscono in basso su un’unica terminazione, a sezione progressiva-mente crescente verso l’appoggio sui muri laterali: la soluzione al piede della struttura e la centinatura a pieno centro dell’intradosso riprendono molto più da vicino le soluzioni del sistema De-lorme che, tuttavia, potrebbero non essere le sole fonti di ispirazione.
La maquette di un progetto non rea-lizzato per St-Remi24 mostra un intra-dosso ad ogiva, in cui sono ancora evidenti i riferimenti alla charpente della cattedrale, e la presenza di una catena al piede della struttura, molto simile a quella di Chartres. Questa fase preliminare di studio, oltre ad attestare i reciproci rimandi fra i cantieri, per un verso accredita ulteriormente il debito di Deneux nei confronti di Baron, per un altro ne attesta il superamento a favore di suggerimenti diversi.
Fig. 10 – Il cantiere delle Halles du Boulingrin fotografato da Deneux
Al proposito non possono trala-sciarsi le affinità fra lo spazio al di sotto della copertura di St-Remi e quello delle Halles du Boulingrin che Emile Maigrot ed Eugène Freyssinet costruiscono fra il 1927 ed il 1929: un cantiere spesso scrutato con curiosità dall’oc-chio fotografico di Deneux25 che ne coglie tutto l’interesse in termi-ni di sperimentazione sulla normaliz-zazione del cantiere e sulla riutilizza-zione delle carpenterie.
Conclusioni
Concepito come “sistema” costrut-tivo atto ad essere impiegato in modo versatile, il brevetto Deneux non ap-porta sostanziali novità sul piano di quella transizione alla diffusione e normalizzazione del “materiale” ce-mento armato, ma si rivela assoluta-mente inusuale nella concezione del cantiere che egli dimostra di conoscere e padroneggiare bene nelle modalità di organizzazione.
La possibilità del preconfeziona-mento degli elementi e la facilità di movimentazione all’interno di cantieri complessi come quelli di Reims (situa-ti, peraltro, ad altezze considerevoli) permettono di risolvere agevolmente i problemi della messa in sicurezza e della successiva ricostruzione degli edifici monumentali di cui Deneux si occupa nell’arco di un ventennio. L’esperienza è tuttavia destinata a non avere seguito.
Nel 1997, in occasione della mostra su L’art de l’ingénieur, viene avanzata l’ipotesi che, nella concezione della copertura della cattedrale di Reims, si
MARIA ROSARIA VITALE
540
possa affiancare al nome di Deneux quello del giovane ingegnere Bernard Laffaille26. La tesi, confortata da alcu-ne testimonianze verbali, si fonda sul confronto delle soluzioni tecniche adottate nei vari esempi, rilevando le significative innovazioni introdotte in questo cantiere da Deneux.
“La complexité d’un telle structure a obligatoirement nécessité d’une étude technique poussée, voire des essais sur maquettes, modèles et autres prototypes. C’est sans aucun doute à ce niveau que Laffaille est intervenu”27.
In verità, come si è potuto verifica-re, tutti questi studi (prove, modelli, prototipi) fanno parte a pieno titolo non soltanto della strumentazione di cui Deneux si serve nel corso dei cantieri della ricostruzione, ma anche della sua personale metodologia di studio e di analisi dell’architettura e delle char-pentes, a partire dai primi studi giova-nili.
D’altro canto, la soluzione tecnica e costruttiva della copertura della catte-drale trova riferimenti e spunti proprio “all’interno” del percorso formativo e degli interessi specifici dell’architecte en chef.
Ciò che, invece, continua a mancare è l’apporto specifico della cultura in-gegneristica che Laffaille avrebbe dovuto rappresentare: la modellazione numerica attraverso il calcolo rimane assente anche nel più emblematico dei cantieri di Reims, né era lecito atten-derselo da un giovane ingegnere appe-na uscito dall’Ecole Centrale.
Naturalmente non si discute di una mera questione attribuizionistica, per-
ché proprio in questo mancato passag-gio, in questo irrimediabile confina-mento entro il modo dei “sistemi” costruttivi consiste paradossalmente la più innovativa lezione del brevetto Deneux.
Gli elementi in cemento armato prefabbricati e smontabili trasferiscono nella nuova tecnologia un ragionamen-to costruttivo che continua a concepire la struttura in termini tradizionali, come sistema “assemblato” e non “mo-nolitico”, attraverso un’analisi preva-lentemente qualitativa delle sue carat-teristiche tecnologiche e costruttive.
Quando le certezze matematiche del mondo dell’ingegneria entreranno prepotentemente in scena nel cantiere di restauro, totalmente disgiunte da una autentica comprensione critica del comportamento delle strutture murarie, queste dovranno rassegnare al nuovo “materiale” cemento armato le proprie funzioni strutturali.
I brevetti Deneux per il c.a. e le loro applicazioni nella ricostruzione delle chiese di Reims (1919-1938)
541
Questo contributo prosegue un percorso di ricerca su H. Deneux, avviato da chi scrive nel 2006 e tuttora in corso di svolgimento. Un particolare ringraziamento va a Yann Harlaut per la sua disponibilità e a Franca Malservisi per le sue sempre attente puntualizzazioni critiche. 1 G. DELHUMEAU, L’invention du Béton Armé, Hennebique 1890-1914, Paris, Norma, 1999. 2 Il riferimento è alle considerazioni del XII Entretien di E.E. VIOLLET-LE-DUC (Entretiens sur l’architecture, Paris, A. Morel, 1863-72) riportate in P.M. AUZAS, Eugène Viollet-le-Duc 1814-1879, Paris, Caisse National des monu- ments historiques et des sites, 1979, p. 139. “Je ne saurai trop le répéter: pur nous, architectes du XIX e siècle, le nouveau ne peut consister que dans l’emploi de moyens inusités avant nous à des formes déjà trouvées, mais sans mentir à ces moyens”. 3 J. MEYER, Henri Deneux (1874-1969). Un précurseur, in Les charpentes du XIe au XVIIIe siècle. Typologie et évolution en France du Nord et en Belgique, a cura di P. Hoffsummer, Paris, Editions du Patrimoine, 2002, pp. 25-31. 4 P. DE L’ORME, Nouvelles inventions pour bien bastir et à petits fraiz, Paris, Frédéric Morel, 1561, ora in Traités d’architecture, Paris, Laget, 1988. Sul sistema Delorme cfr. J.M. PEROUSE
DE MONTCLOS, La charpente à la Philibert de l’Orme, réflexions sur la fortune des techniques en architecture, in Les chantiers de la Renais-sance, Actes des colloques (Tours 1983-1984), a cura di J. Guillaume, Paris, Picard, 1991, pp. 27-50. 5 Presso l’Institut National de la Propriété Industrielle sono depositati il primo brevetto n. 506.789 del 29 novembre 1919 ed il secondo n. 506.789 25519 del 24 ottobre 1921. 6 H. DENEUX, La nouvelle charpente de la Cathédrale de Reims, en éléments de ciment armé assemblés et démontables, “La Technique des Travaux”, 1926, 7, (estr.) pp. 1-11. 7 C. SIMONNET, Le béton. Histoire d’un maté-riau. Economie, technique, architecture, Mar-seille, Parenthèses, 2005, p. 133 e sgg. 8 P. COTTANCIN, Les travaux en ciment avec
ossature métallique, “Bulletin de l’Union syn-dicale des architectes français, 1895, 8-9, p. 213. 9 A. de Baudot, L’architecture et le ciment armé, “L’union des architectes”, 1905, 8, p. 9. 10 C. SIMONNET, Le béton, cit., p. 134. 11 F. BOUDON, Recherches sur la pensée et l’œuvre d'Anatole de Baudot (1834-1915), “Architecture, mouvement, continuité”, 1973, 28, pp. 1-66 e, sulla questione specifica, M.J. DUMONT, La pietra filosofale: Anatole de Baudot e i razionalisti francesi, “Rassegna” 1992, 49, pp. 36-43. 12 È la tesi di F. BOUDON, Recherches, cit. 13 A proposito delle prime regolamentazioni sul c.a. scrive G. DELHUMEAU (L’invention, cit., p. 26): “Elles opèrent une sorte de déplacement du champ de la pratique, celle des constructeurs, à celui de la science qui s’impose come le cadre institutionnel du débat. [Le] processus de nor-malisation associé à l’essor du béton armé […] n’est autre chose, au fond, que le passage pro-gressif de l’état de «système» à celui de «maté-riau»”. 14 M.J. DUMONT, Fortuna di un precursore, in Anatole de Baudot (1834-1915), “Rassegna”, 1996, 68, pp. 8-9. 15 C. SIMONNET, Le béton, cit., p. 134. 16 H. DENEUX., La nouvelle charpente, cit., pp. 2 e 10. Presso gli Archives photographiques di Fort de Saint-Cyr si conserva l’immagine, datata 1926, di una maquette per un hangar d’aerei che potrebbe essere quello citato. 17 “Le perfectionnements dans l’art de la cons-truction doivent consister à épargner le temps, la place, le main-d’œuvre superflue, comme celle affectée au montage sur le tas de matières dont une partie seulement devra entrer dans la struc-ture”. E.E. VIOLLET-LE-DUC, Entretiens, cit., p. 138. 18 P. Léon, La restauration des monuments en France, in La conservation des monuments d’art et d’histoire, Conclusions de la conférence d’Athènes, Paris, Institut de coopération intel-lectuelle, 1933, pp. 57-58. 19 F. MALSERVISI, La restauration architectu-rale en France: deux siècles de pratique ordi-naire, Thèse de doctorat en Histoire de l’architecture, directeur Prof. F. Loyer, Univer-
MARIA ROSARIA VITALE
542
sité de Versailles, 2005, p. 170. Sulla questione cfr. anche F. BERCE, La doctrine de la restaura-tion face aux reconstructions après les guerres, in De la guerre réglée à la guerre totale, Actes du 119e Congrès national des sociétés histori-ques et scientifiques (Amiens, octobre 1994), a cura di A. Corvisier, J. Jacquart, Paris, CTHS, 1997, pp. 131-146 e S. GARNERO, Conserva-zione e restauro in Francia. 1919-1939: i lavori della Commission des monuments historiques, Firenze, Alinea, 2006. 20 Sulla vicenda della cattedrale di Reims cfr. Y. HARLAUT, La cathédrale de Reims du 4 septem-bre 1914 au 10 juillet 1938. Idéologies, contro-verses et pragmatisme, Thèse de doctorat en Histoire, directeur Prof. M.C. Genet-Delacroix, Université de Reims, 2006. 21 J.L. SONNIER, Henri Deneux. L’utilisation du ciment armé dans la construction et la restaura-tion au début du XXe siècle, Ecole d’architecture de Paris-Belleville, 1984, dattiloscritto. 22 Sulla filiazione della soluzione di Reims da Chartres cfr. Hommage à Henri Deneux. Les charpentes de la cathédrale de Reims, Reims, Société des amis du vieux Reims, 1988. 23 L’espressione è in P. LEON, La vie des mo-numents français. Destruction, restauration, Paris, Picard, 1951, p. 494. 24 L’immagine è riportata in J.L. SONNIER, Henri Deneux, cit. 25 F. GABORIT, La collection Deneux. Un fonds régional à découvrir, in Rebâtir Reims, La collection photographique Henri Deneux, 1870-1938, a cura di I. Balsamo, Châlons sur Marne, Direction régionale des affaires culturelles, 1988, pp. 11-20. 26 L’art de l’ingénieur. Constructeur, entrepre-neur, inventeur, a cura di A. Picon, Paris, Cen-tre Georges Pompidou, 1999, p. 569. 27 La tesi è di N. NOGUE, Bernard Laffaille (1900-1955) ingénieur, Thèse de doctorat en Histoire de l’art, Université de Paris, directeur Prof. M. Gérard-Monnier, 2001, p. 60, cit. p. 63.



























![Saillance visuelle des maillages 3D par patches locaux adaptatifs [Anass Nouri - Christophe Charrier - Olivier Lézoray] (Conférence Reims-Image, 2014, France)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632364ad48d448ffa006a732/saillance-visuelle-des-maillages-3d-par-patches-locaux-adaptatifs-anass-nouri-.jpg)