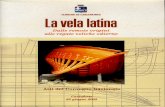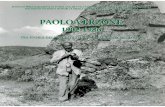voce Conservazione, in Enciclopedia dell'Architettura - 2008
Le maestranze antelamiche nella Liguria di ponente. Diffusione dell'Opus Quadratum tra XII e XIII...
Transcript of Le maestranze antelamiche nella Liguria di ponente. Diffusione dell'Opus Quadratum tra XII e XIII...
XVI
II 20
13A
rch
eo
log
ia d
ell’
Arc
hite
ttu
ra
include gli Atti del Seminario “TECNICHE COSTRUTTIVE E CICLI EDILIZI TRA VI E IX SECOLO, FRA ORIENTE E OCCIDENTE”
Numerose sono le tecniche costruttive di età romana. In questo numero ne discutono alcuni specifici aspetti tre contributi nella sezione “casi studio”: relativamente alla città di Argentomagus, alle mura di Populonia, all’opus africanus e alle tecniche a telaio litico in Etruria e Campania. Nella prima parte del volume vengono invece pub-blicati gli atti di un seminario che si è tenuto a Padova il 25 ottobre del 2013, dedicato a “Tecniche costruttive e cicli edilizi tra VI e IX secolo”. Le relazioni riguardano tre aree geografiche chiave nel dibattito storiografico: alcune regioni del Medio Oriente, dove è accertata una continuità, in età bizantina ed islamica, della tecnica mu-raria in opera quadrata; la Penisola iberica, per la quale si raffrontano due posizioni antitetiche tra chi la ritiene sviluppata già in epoca visigota e con un’influenza bizantina e chi la collega invece all’arrivo degli Arabi nell’VIII secolo; la Francia, dove le opere in pietra di cava sono assai rare e di datazione controversa; infine l’Italia, dove il confronto è tra i territori bizantini, in particolare Roma e la Sardegna, e quelli longobardi del Nord Italia dove l’opera quadrata non compare che con il Romanico. Il quadro che ne emerge è assai variegato e ancora aperto, il che richiede ulteriori ricerche sia su casi di studio specifici, come quelli qui presentati delle cripte delle basiliche patriarcali di Aquileia e di Venezia o sul San Michele Arcangelo di Perugia, sia per sintesi regionali in aree geo-grafiche, come le coste mediterranee dell’Africa, non considerate in questa sede. E per quanto riguarda l’opera quadrata, l’attenzione è sulla sua ripresa in epoca romanica, argomento di cui si è discusso nel seminario pubblicato nel n. XVII della rivista e che viene ora riproposto in un articolo sulla Liguria di Ponente tra XII e XIII secolo.
Archeologia XVIII 2013
dell’Architettura
€ 40,00
ISSN 1126-6236ISBN 978-88-7814-628-0
e-ISBN 978-88-7814-632-7
ARCHEOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
Supplemento di «Archeologia Medievale»diretta da Gian Pietro Brogiolo e Sauro Gelichi (responsabile)
Comitato di direzione:
GIAN PIETRO BROGIOLOFRANCESCO DOGLIONIROBERTO PARENTIGIANFRANCO PERTOT
Redazione:
GIOVANNA BIANCHIANNA BOATOAURORA CAGNANASTEFANO CAMPOREALEANNA DECRIPAOLO FACCIOFABIO GABBRIELLIPRISCA GIOVANNINIALESSANDRA QUENDOLOGIAN PAOLO TRECCANIRITA VECCHIATTINI
Coordinamento di redazione:
Giovanna Bianchi – [email protected] Boato – [email protected] Quendolo – [email protected]
Segreteria di redazione:
Tommaso Arianic/o Edizioni All’Insegna del Giglio s.a.s.e-mail [email protected]
Edizione e distribuzione:
ALL’INSEGNA DEL GIGLIO s.a.s.via del Termine, 36; 50019 Sesto Fiorentino (FI) tel. +39.055.8450.216; fax +39.055.8453.188 e-mail [email protected] sito web www.insegnadelgiglio.it
Abbonamenti:
http://www.insegnadelgiglio.it/categoria-prodotto/periodici/archeologia-dell-architettura/«Archeologia dell’Architettura» XIX, 2014:– carta € 33,00; – carta + ebook € 40,00; – ebook su range IP € 70,00; – carta + ebook su range IP € 100,00; – ebook arretrati su range IP € 250,00. Per gli invii in contrassegno o all’estero saranno addebitate le spese postali.
ISSN 1126-6236ISBN 978-88-7814-628-0e-ISBN 978-88-7814-632-7 © 2014 All’Insegna del Giglio s.a.s. via del Termine, 36; 50019 Sesto Fiorentino (FI) tel. +39 055 8450 216; fax +39 055 8453 188 e-mail [email protected] sito web www.insegnadelgiglio.itStampato a Firenze nel dicembre 2014 Tecnografica Rossi
Per le annate XV-XVII la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti referee
Belardi PaoloBenente FabrizioBernardi PhilippeBessac Jean-ClaudeCaballero Zoreda LuisCagnana AuroraCantini FedericoCausarano Marie-Ange
Chavarría Arnau AlexandraCoden FabioDeLaine JanetDella Torre StefanoFiorani DonatellaMusso Stefano FrancescoPetrella GiovannaPizzo Antonio
Quirós Castillo Juan AntonioReveyron NicolasVannini GuidoVaquero ManuelWard Perkins BrianZanetto Serena
Indice
I. TECNICHE COSTRUTTIVE E CICLI EDILIZI TRA VI E IX SECOLO, FRA ORIENTE E OCCIDENTE Atti del Seminario (Padova, 25 ottobre 2013) a cura di Gian Pietro Brogiolo
9 J.-C. Bessac, Techniques classiques de construction et de décor architectural en pierre de taille entre Orient et Occident (VIe-IXe siècle): abandon ou perte?
24 P. Gilento, R. Parenti, Modelli edilizi e tecniche costruttive tra Tardoantico ed Età islamica in area siro-giordana
45 G.P. Brogiolo, Architetture di qualità tra VI e IX secolo in Italia settentrionale
60 S. Zanetto, Le cripte delle basiliche patriarcali di Aquileia e di Venezia: IX o XI secolo?
80 D. Esposito, Il cantiere e le opere murarie in Roma fra Tardoantico e alto Medioevo
88 P. Vitti, Tradizione romana e tradizione bizantina nelle tecniche costruttive delle volte fra V e VI secolo: il caso delle Mura Aureliane
114 S. Borghini, Murature giustinianee in Italia centrale: il caso perugino del San Michele Arcangelo
127 L. Caballero Zoreda, M. de los Ángeles Utrero Agudo, El ciclo constructivo de la alta Edad Media hispánica. Siglos VIII-X
147 J. Sarabia Bautista, El ciclo edilicio en la arquitectura tardoantigua y altomedieval del sureste de Hispania: los casos de Valentia, Eio y Carthago Spartaria
II. CASI DI STUDIO
173 A. Chartrain, P. Flotté, E. Henry, Tempo, tecniche, approvvigionamenti: un tentativo di analisi archeologica dell’uso dei materiali lapidei nella cittadina gallo-romana di Argentomagus (Francia)
192 S. Camporeale, Opus africanum e tecniche a telaio litico in Etruria e Campania (VII a.C.-VI d.C.)
210 C. Mascione, Le mura dell’acropoli di Populonia. Tecnica costruttiva e organizzazione del cantiere
229 F. Zoni, Le maestranze antelamiche nella Liguria di ponente. Diffusione dell’opus quadratum tra XII e XIII secolo
Federico Zoni
Le maestranze antelamiche nella Liguria di ponente. Diffusione dell’opus quadratum tra XII e XIII secolo
Archeologia dell’ArchitetturaXVIII 2013, pp. 229-244
Introduzione 1
L’obiettivo del presente contributo è indagare il rap-porto tra le maestranze antelamiche e il Comune genovese durante la fase di espansione territoriale nella Liguria di ponente. I limiti geografici della ricerca sono le circoscri-zioni storiche maggiori del territorio: la marca Albingane e il comitatus Vintimili, principali interlocutori o oppositori del potere comunale in espansione (fig. 1). La metodologia seguita ha avuto carattere interdisciplinare, tra fonti scritte e fonti materiali. Le prime sono rappresentate dai cartulari notarili editi e dagli statuti dei centri liguri principali, studiati allo scopo di analizzare l’eventuale presenza di maestranze specializzate nella lavorazione della pietra.
Le campagne di ricognizione archeologica si sono concentrate su insediamenti e manufatti architettonici con fasi cronologicamente comprese tra l’XI e il XIII secolo. Nella maggior parte dei casi si è cercato di agganciare le cronologie “relative” a dati di scavo, determinando una datazione tanto più sicura quanto meno stilistica (Man-noni 1997). I campioni murari sono stati rilevati tramite documentazione fotografica finalizzata alla rielaborazione fotogrammetrica. Sulle ortofotografie è stato realizzato il rilievo in ambiente CAD, finalizzato allo studio dell’appa-recchiatura muraria rispetto a litotipo, lavorazioni e finitu-re, posa in opera, peculiarità dei giunti e dei letti di posa.
Attraverso questa metodologia si è tentato di andare oltre un’indagine puntiforme, per delineare una «storia estensiva dell’architettura» che lavora su «grandi unità territoriali, senza necessariamente ricorrere alle etichette stilistiche, ma che verifica sul campo la diffusione diacro-nica di soluzioni costruttive, di modelli decorativi e di tecniche edilizie» (Tosco 2003, pp. 129-130).
1. La definizione del Districtus Ianue e i magistri antelami nelle fonti scritte
I mutamenti sociali avvenuti tra XII e XIII secolo, quando il controllo territoriale di Genova sulla Liguria occidentale andava definendosi, possono essere indagati grazie ai numerosi cartulari notarili, corpi statutari e fonti cronachistiche a noi pervenuti e in buona parte editi 2.
1 Si ringraziano la prof.ssa Paola Galetti e la dott.ssa Aurora Cagnana per la gentile supervisione al presente contributo. Inoltre si ringraziano per i consigli e le ulteriori segnalazioni i proff. Giuseppe Palmero e Fulvio Cervini, esperti conoscitori della Liguria di ponente.
2 In questa sede si intende dare una panoramica storica riassuntiva della creazione di uno stato territoriale da parte di Genova, finalizzata alla contestua-lizzazione della documentazione analizzata. Per maggiori approfondimenti vd. Pavoni 1992; Guglielmotti 2005.
Una supremazia politica sui centri mercantili costieri e sui poteri locali delle signorie territoriali si rese necessaria al fine di escludere una potenziale concorrenza economica o politico-militare. Il successo di centri come Albenga, Savona o Noli, nasceva dagli stessi riconoscimenti che aveva avuto Genova in seguito alla partecipazione alla prima crociata: esenzione dai dazi doganali e possedimenti diretti in oriente 3.
Ad Albenga, una magistratura consolare cittadina è attestata dal 1127; per tutto il XII secolo vi furono rapporti distesi con il capoluogo, tanto che gli uomini di questa città furono coinvolti negli scontri con Pisa e fu riconosciuta loro notevole libertà d’iniziativa economica.
Diversa era la situazione a Ventimiglia, dove i conti continuarono a mantenere solide basi di potere in città e nel contado per tutto il XII secolo, portando avanti politiche espansionistiche a danno dei residui poteri dei discendenti del marchesato di Albenga e avanzando pretese sui beni che l’episcopio genovese possedeva in Taggia e San-remo 4. Già nel 1140 si concretizzarono le prime operazioni militari nel Ponente: i marchesi del Vasto, grazie all’alle-anza genovese, riconquistarono i territori loro sottratti; Genova impose che la metà dei possedimenti restituiti ai marchesi fossero dati in feudo al genovese Giovanni Barca. A Ventimiglia, nello stesso anno, il conte Oberto dovette giurare fedeltà alla compagna communis e rinunciare ai beni in città e nel contado (Imperiale di Santangelo 1936, doc. 106, pp. 126-127; doc. 162, pp. 201-202). Il potere di Genova sul territorio occupato fu riconosciuto formalmente da Federico I, nel 1162; nello stesso anno Alessandro III confermò l’elevazione ad arcidiocesi della città, che ottenne la suffraganeità del vescovo di Albenga 5 (ibid., doc. 308, pp. 395-404; doc. 305, pp. 387-391).
In seguito a questi eventi, dal 1217 (con la svolta verso il sistema di governo podestarile), Genova impostò un controllo capillare su tutto il territorio. Dalle convenzioni variamente stabilite con i poteri locali del Ponente, nel XIII secolo, emerge una centralità più vigorosa del capoluogo ligure attraverso l’imposizione della propria politica mi-litare e finanziaria; ciò portò molti centri a essere ceduti
3 Sono noti, ad esempio, i diritti su Antiochia, estesi agli uomini di Savona e Noli (Imperiale di Santangelo 1936, I, doc. 12, pp. 16-18), o le concessioni da parte di Baldovino di Gerusalemme e Bertrand di St. Gilles, estese agli albenganesi (ibid., doc. 15, pp. 20-22; doc. 24, pp. 32-33). Sullo sviluppo mercantile e commerciale di Genova cfr. Balard 1982; Basso 2010.
4 Già dall’XI secolo il vescovo di Genova aveva iniziato a consolidare un organico dominio signorile in questi territori. Sulla natura delle istituzioni ecclesiastiche del ponente ligure nell’XI secolo, cfr. Embriaco 2007.
5 Per un approfondimento sulla chiesa albenganese tra XI e XIII secolo vd. Embriaco 2004.
230 F. ZONI
fig. 1 – Carta della Liguria di ponente con indicazione delle località indagate.
fig. 2 – Stralcio di tabella con elenco dei magistri antelami citati nei cartulari genovesi di XIII secolo.
o venduti al Comune. Gli ultimi tentativi di resistenza si verificarono durante gli anni d’impero di Federico II, nelle alterne vicende tra questi e Genova, ma la definitiva subordinazione avvenne attorno alla metà del XIII; da questo momento tutte le maggiori cariche cittadine dei centri del Ponente vennero tenute da una quota sempre maggiore di genovesi.
A Genova i magistri antelami emergono in modo molto evidente, come è già stato mostrato da vari studi precedenti, in particolare quelli di Aurora Cagnana (Ca-gnana 2004, 2005a, 2005b, 2008; Cagnana, Mussardo
2012). L’origine di queste maestranze fu inizialmente trattata, collateralmente all’indagine sulle maestranze altomedievali, da Ugo Monneret de Villard (Monneret De Villard 1919), successivamente ripreso e ampliato da Bognetti (Bognetti 1938). Rispetto a questi primi approc-ci, Aurora Cagnana ha potuto avvantaggiarsi delle edizioni critiche dei cartulari notarili di XII secolo 6. Si sono definiti
6 Per il programma editoriale della pubblicazione, che, partendo dal 1938, si è prolungata in nove volumi fino al 1974, cfr. Moresco, Bognetti 1938. Le pubblicazioni sono ricomiciate nel 2004 a cura della Società Ligure di Storia Patria con la pubblicazione di altri cinque cartolari notarili.
LE MAESTRANZE ANTELAMICHE NELLA LIGURIA DI PONENTE. DIFFUSIONE DELL’OPUS QUADRATUM TRA XII E XIII SECOLO 231
i caratteri del lavoro di questa maestranza, specializzata nella realizzazione di muri, volte, pilastri, scale, fondazioni, nella lavorazione della pietra e nella preparazione delle calci (Cagnana 2004, pp. 91-92). Inoltre, si sono individuate le zone principali d’insediamento cittadino degli Antelami, attestati soprattutto in relazione ad ambiti di collegamento consortile con le maggiori famiglie della nobiltà genovese (ibid., p. 94).
Non da meno, l’individuazione dei manufatti ar-chitettonici ricollegabili alle maestranze intelviesi ha consentito la definizione dei caratteri del primo esempio di opus quadratum a Genova: «rifilatura a scalpello dei bordi, spianatura delle facce, alternanza fra conci lisciati e a bugnato, ecc» (Cagnana 2005b, p. 35).
Le considerazioni sul ruolo sociale di questa mae-stranza, nel XII secolo, possono essere estese senza solu-zione di continuità anche al XIII secolo. Lo spoglio dei cartulari dei notai Lanfranco (Krueger, Reynolds 1953) e Giovanni di Guiberto (Hall-Cole et al. 1940), non ancora considerati nei precedenti lavori, ha permesso di individuare nove magistri antelami operanti in Genova tra il 1200 e il 1226 (fig. 2). Le carte in cui sono coinvolti hanno nature differenti, che testimoniano la trasversalità e l’inserimento sociale di questo gruppo. Concessioni e cessioni (Krueger, Reynolds 1953, doc. 129, pp. 61-62; Hall-Cole et al. 1940, doc. 309, p. 154), affitti (Krue-ger, Reynolds 1953, doc. 130, p. 62), quietanze (ibid., doc. 160, p. 76), richieste di mutui (Krueger, Reynolds 1953, doc. 822, pp. 363-364; Hall-Cole et al. 1940, doc. 203, pp. 108-109), doti (Krueger, Reynolds 1953, doc. 1394, p. 201), compravendite (ibid., doc. 1481, pp. 236-237), accomendaciones (ibid., docc. 1198, 1199, 1200, pp. 120-121), costituzioni di società (Hall-Cole et al. 1940, doc. 438, p. 209) vedono attivi i soggetti interessati nei ruoli più vari: da attori a testimoni. Un caso interessante è quello di Guibertus magistri de Antelamo, che compare come proprietario della casa nella quale fu rogato un atto nel 1201 (ibid., doc. 309, p. 154). È altrettanto significativo l’esempio di Albertus calegario, il quale, in una concessione di un mutuo a Otto e Baiamuns filii olim Rubaldi Binelli, per definirsi, fa ricorso non al patronimico, ma al nome e alla qualifica professionale dello zio: Albertus calegario nepos Lafraci magistro de Antelamo (ibid., doc. 203, p. 109). Il dato, letto nel suo contesto, potrebbe far pensare a una notevole capacità economica derivante dalla professione di magister Antelami. Lo stesso si può dire per quanto già rilevato da Aurora Cagnana nel caso della societas contratta nel 1154 tra Iterius e Guido, entrambi magistri de antelamo. I due, per cinque anni, s’impegnarono a fare calcionarias bona fide sine fraude (Cagnana 2004, pp. 93-94). La produzione di leganti è stata considerata come propria degli Antelami perché indotta dall’economia di un cantiere edilizio. Tuttavia, non è da escludere che questo investimento, diverso dalla pratica di una profes-sione specializzata, fosse dovuta più che altro alle notevoli capacità economiche degli Antelami stessi. Oltre ad altre società costituite al fine di produrre calci 7, non mancano
7 Si veda, ad esempio, Guido magister e la costituzione di una società nel 1206, nella quale lui stesso e altri promittunt inter se vivissimo et conveniunt
casi di altri investimenti slegati da cicli produttivi edilizi. Il 29 settembre 1216, Guiscardo magister Antelami, in una accomendacio con Stephanus Resta, finanzia il commercio in oltremare di quest’ultimo con dieci libbre di genovini (Krueger, Reynolds 1953, doc. 1198, p. 120). Potrebbe trattarsi di casi d’investimento finalizzati a una diversifi-cazione del rischio economico 8.
Il lavoro degli intelviesi fu compreso nel generale ordinamento delle maestranze edili nei primi statuti citta-dini (di XIII secolo: De Simoni, Belgrano 1901) e in un capitolo apposito in quelli successivi di XV (De Simoni 1866, cap. XXXVII, De magistris antelami).
La situazione documentaria del Ponente ligure è no-tevolmente più complicata rispetto a quella genovese. La lacunosità delle edizioni dei notai costringe a una selezione forzata di limiti geografici e cronologici. Tra XII e XIII secolo, per l’arco di costa compreso tra Genova e Venti-miglia, sono noti cinque cartulari: il cartulare di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato 9 (Savona, dal 1178 al 1188), il cartulare del notaio Martino 10 (Savona, tra il 1203 e il 1206), Il cartolare di Uberto (Savona, dal 1213 al 1215) 11 e i due cartulari contenenti gli Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio 12 (Ventimiglia, dal 1256 al 1258; Ventimiglia e Rapallo dal 1258 al 1264). Nessun cartolare notarile è ancora edito per quanto riguarda Albenga.
La raccolta degli atti di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato è la più antica di tutta la Liguria, dopo quella del genovese Giovanni scriba 13. Ai fini di questa ricerca costituisce solo un dato ex silentio; nei più di mille atti non compaiono, infatti, menzioni o riferimenti a magistri Antelami operanti a Savona. Le 25 citazioni di magistri sono sempre riferite a un notaio, a un canonico o a un medico. Le professionalità legate a cicli edilizi compaiono solo attraverso il termine murator, come nei casi di Iohannes bonus murator, Otto murator, Gisulfus murator e Obertus murator 14, ma nessuna delle attestazioni fa riferimento a processi edilizi complessi. A Genova è già stato notato come la presenza degli Antelami non escludesse quella di muratori che, verosimilmente, dovevano far parte delle maestranze locali alle quali erano commissionate costru-zioni di opere minori, soprattutto su iniziative private. Un caso esemplare è quello di Vivaldus de Costa, Aimericus de Costa e Wuillelmus de Bruna che, nel 1190 s’impegnarono con Adalaxia a costruire una domum de muro (Cagnana 2005a, pp. 38-39). Oltre a precisare le dimensioni e il rivestimento della futura casa, gli artefici specificano anche il materiale, che sarebbe stata semplice petras ruptas locale fornita dalla committente 15.
facere calcinairam unam vel plures si eis placebit usque ad duos annos proximos (Hall-Cole et al. 1940, doc. 1864, pp. 371-372).
8 Per un confronto con altre maestranze italiane del XIII secolo, nello specifico quella dei falegnami bolognesi, vd. Erioli c.s.
9 Balletto et al. 1978.10 Puncuh 1974.11 Castiglia 2009; Rovere 2013.12 Rispettivamente, in ordine cronologico, Balletto 1993 e 1985.13 Chiaudano, Moresco 1935.14 Balletto et al. 1978, docc. 76, 509 (Iohannes bonus); 88, 501, 509,
528 (Otto); 596 (Gisulfus); 962 (Obertus).15 Chiaudano, Morozzo della Rocca 1938, doc. 290, p. 115: promit-
timus tibi Adalaxie uxor olim Enrici Galine quod elevabimus tibi domum unam de muro in loco tuo supra eclesia Sancti Celsi et erit murus ante et retro longitudinis canellarum quattuor et ab utroque fronte canelle .II. anell muro de retro et erit
232 F. ZONI
fig. 3 – Stralcio di tabella con elenco dei magistri antelami citati nel cartulare ventimigliese di Giovanni di Amandolesio.
Neppure nei cartulari dei notai Martino e Uberto, del XIII secolo, si trovano menzioni di magistri Antelami. Abbiamo però, ugualmente al caso precedente, un Otto magister murator, costruttore di un muro che suscitò una lite di vicinato tra Alberti Beliaminis e tal Trucus (Puncuh 1974, doc. 372, pp. 125-127). Siamo sempre di fronte a committenze private di non particolare prestigio. Nei car-tolari di Uberto si trovano svariate attestazioni di muratores, tutti solitamente ricordati come semplici testimoni.
Questa situazione emerge anche attraverso gli Statuti cittadini savonesi, nei quali, tra le varie attività normate, due capitoli sono dedicati ai muratores 16. Altre attività attestate sono i produttori di mattoni o di calce e la defi-nizione delle unità di misura e dei prezzi di quest’ultima (Calleri 1997, rispettivamente, cap. CLXXVIII, cap. CLXVI, cap. CLXXVII).
Il caso di Albenga, della quale sono editi gli statuti di fine XIII secolo, è analogo: anche qui un capitolo è dedicato al pagamento dei muratori (Costa Restagno 1995, De muratoribus, cap. XLIII), ma mai compaiono riferimenti a cicli di cantieri edilizi più complessi o a pro-
altitudinis ante et retro cumpensante uno cum alio unius anella et ab utroque fronde usque ad tectum et erit largus trium palmorum et cunvenientis malte et imbucabimus intus et foris, et posito in convenienti fundamento et facere unum necessarium et fenestras .IIII. et archerios .II. et hec omnia faciemus tibi pro lb. .VII. et s .VIII. et minis .CCC. arene ibi traere et petras ruptas dabis nobis infra locum predictum.
16 Il primo è l’obbligo di giuramento di onestà nei confronti del co-mune, in particolare riguardo al non restringimento delle strade pubbliche (Calleri 1997, cap. CXLIIII). Il secondo è la regolarizzazione dei pagamenti dei muratori in base al periodo dell’anno in cui è richiesta la loro prestazione (ibid., cap. CCVI).
fessionalità legate alla lavorazione della pietra. In questo caso, il paragone con Genova è ancor più indicativo, se si considerano i rapporti politici che ben traspaiono dal primo capitolo degli statuti, dove si riporta la convenzio-ne tra le due città (ibid., De conventione inter Ianuam et Albingana edita firmanda tenenda, cap. I).
La situazione documentaria di Ventimiglia permette maggiori considerazioni attraverso la lettura di uno dei due cartolari di Giovanni di Amandolesio 17. Dai 656 atti che lo compongono, emerge uno spaccato della società ventimigliese di XIII secolo. Si trovano 33 menzioni di magistri. Tra queste, vi sono 10 attestazioni di magistri Antelami, tutte riferite a due personaggi: Bertramus de Cumis magister antelami e Balduinus de Vaure magister antelami (fig. 3). Una lettura incrociata dei documenti ha permesso di ampliare le attestazioni a 16 casi, mettendo in relazione testimoni e luogo di redazione degli atti 18. È importante notare che tutti gli atti che riconducono alla presenza di magistri antelami sono stati redatti nei castelli di Ventimiglia, dove si trovavano le sedi dei presidi geno-vesi: il castrum Collis (dove risiedeva magister Bertramus), il castrum Apii e il castrum Roche (dove risiedeva magister
17 Si tratta del cartulare 57 dell’archivio di Stato di Genova, edito in Bal-letto 1985. Il cartulare 56 (Balletto 1993) non è risultato significativo ai fini di questo studio. Parte dei risultati qui esposti sono già stati presentati in Zoni 2013.
18 Balletto 1985, docc. 247, pp. 238-239; 276, pp. 260-261; 318, p. 301; 349, p. 330; 366, pp. 344-345; 379, pp. 357-358; 401, pp. 375-376; 405, pp. 380-381; 407, pp. 382; 435, pp. 406-407; 447, pp. 416-417; 449, p. 418; 469, pp. 434-435; 470, pp. 435-436; 485, p. 448; 486, pp. 448-489. Alcune pri-me considerazioni sulla presenza degli Antelami a Ventimiglia in Cervini 1996.
LE MAESTRANZE ANTELAMICHE NELLA LIGURIA DI PONENTE. DIFFUSIONE DELL’OPUS QUADRATUM TRA XII E XIII SECOLO 233
Balduinus) 19. I negozi giuridici che li coinvolgono sono esclusivamente affidamenti di procura fatti dagli uomini dei vari castelli a un personaggio – variabile di volta in volta – al quale è richiesto di riscuotere il compenso loro dovuto dal Comune per il servizio prestato a guardia del castello. I partecipanti sono attestati come conestabiles o servientes e hanno qualificazioni tra le più varie come notai, magistri assiae, medici, arcieri, taliatores, balestrieri, tintores, ferraris, calegariis, giudici, un murator, un bancherius, porterii e due magistri antelami. Spesso i nomi che ritornano tra i vari atti sono gli stessi. Si evince, così, una presenza stabile di questi personaggi, attestati mediamente in 30 unita per il castello del Colle, 25 per quello della Rocca e 18 per il castel d’Appio. Ad oggi queste sono le uniche attestazioni di maestranze Intelviesi nella Liguria di ponente. Anche qui la loro particolarità emerge dal collegamento diretto con Genova. Gli Antelami compaiono esclusivamente in contesti legati alla Dominante e al suo controllo politico e militare sul territorio; i loro rapporti economici si svi-luppano solo in questa direzione 20.
Non è da escludere che la loro presenza esclusiva in questo tipo di documenti, fosse dovuta alla particolare figura del notaio Giovanni di Amandolesio, anch’egli attestato in due casi tra i servientes del castello della Rocca (Balletto 1985, doc. 485, p. 448; doc. 556, p. 516). Tra le prerogative che Genova si arrogava nei trattati con le città sottomesse, vi era la nomina del podestà, del giudice e del notaio, che dovevano essere di estrazione genovese (Piergiovanni 1995). La base del controllo territoriale era l’esportazione di un modello politico proposto in termini di emancipazione dall’egemonia signorile. A Ventimiglia tale politica era perseguita nel XIII secolo, a danno delle residue rivendicazioni da parte del potere comitale che manteneva ancora solide basi nel contado. Per questo, sembra di poter vedere un ruolo particolarmente attivo di Genova a differenza delle altre città del Ponente. Tale presenza forte si attesta in ben tre castelli, uno dentro la città e due nelle prossime vicinanze.
L’attività dei magistri antelami, in questo contesto, non era evidentemente parte della vita sociale cittadina ma, piuttosto, funzionale al mantenimento delle strutture militari (cfr. Balletto 1985, p. 50).
È interessante notare, infine, come tra gli uomini del presidio genovese vi fossero diversi membri dell’aristocrazia cittadina del capoluogo, tra i quali proprio i della Volta, i cui rapporti clientelari con le maestranze antelamiche sono già stati evidenziati.
2. Le tecniche edilizie del Ponente tra XII e XIII secolo. Ricognizione delle testimonianze archeologiche
2.1 Opere a corsi di elementi sbozzatiGuardando al patrimonio architettonico della Ligu-
ria di ponente, è possibile notare un buon repertorio di
19 Sulla topografia urbana di Ventimiglia nel XIII secolo cfr. Palmero 1994.
20 L’unico caso in cui un magister antelami compare fuori da uno dei presidi genovesi è quello del testamento di Guirardus magister assie, dove Ber-tramus magister presenzia come testimone (Balletto 1985, doc. 401, p. 410).
murature ascrivibili a cronologie comprese tra il XII e il XIII secolo, utili per lo studio dell’evoluzione delle tecni-che edilizie in relazione all’avanzata dell’influenza politica genovese sul territorio 21.
La cattedrale di Albenga (SV), che oggi si presen-ta nella sua faccia tardo gotica ripristinata dai restauri compiuti tra 1964 e 1967 durante i quali si svolsero gli scavi archeologici diretti da Nino Lamboglia 22, presenta stratificazioni dell’elevato comprese tra i secoli XI-XII e XIX 23 (fig. 4).
L’edificio presentava, nella sua pianta più antica, un impianto a tre navate che fu ridimensionato in età alto-medievale a un edificio di culto a navata unica, le cui fasi si conservano solo in parte dell’elevato dell’attuale facciata (Lamboglia 1970, pp. 90-91). La tecnica edilizia relativa a questa fase (CM 1, fig. 5) è caratterizzata da blocchetti di arenaria di piccole e medie dimensioni (con rara presenza di laterizio di reimpiego), di larghezze comprese tra 10 e 30 cm, ottenuti da strati di roccia di altezze omogenee, privi di rifiniture, messi in opera in corsi orizzontali paralleli ottenuti mediante la selezione di elementi con altezze si-mili, comprese tra 10 e 20 cm. Lo spessore dei giunti e dei letti di posa è variabile e irregolare, probabilmente dovuto alla mancanza di lavorazione delle facce di contatto. La datazione del campione è certa grazie al rapporto con la cronologia derivante dallo scavo archeologico.
È già stato notato come questa tecnica abbia avuto un’ampia diffusione cronologica, con attestazioni fino al XIV secolo (Brogiolo, Cagnana 2012, p. 157; Cagnana 2000, p. 448). Un caso analogo di tecnica edilizia si trova nel Palatium del castello di Andora (SV). Le prime ricer-che sul sito cominciarono nel 1988 contestualmente allo studio sui villaggi abbandonati, che in Liguria dimostrò una notevole precocità partendo già negli anni ’70. Sette campagne di scavo archeologico furono condotte fino al 1994, succedute da altre due tra 2010 e 2011, portando a una periodizzazione del complesso compresa tra XII-XIII e XVIII secolo 24. Nel 1221 il palazzo del castello era residenza stabile dei marchesi: qui fu fatto redigere, inter caminatam castelli Andorie, il testamento dello stesso mar-chese Bonifacio. Come altri centri del Ponente, tra cui i comuni di Albenga e Savona, anche Andora partecipò alla lega che tra 1226 e 1227 tentò di emanciparsi dal giogo politico genovese. In questa fase vi fu la riedificazione del castello e di parte delle sue strutture, tra le quali il muro di cinta in pietra (Ramella 2006). Come nella fase di XI-XII secolo della cattedrale di Albenga, la tecnica edilizia presenta un paramento in elementi sbozzati di medie e piccole dimensioni, tra 14 e 45 cm di larghezzza, disposti in corsi sub-orizzontali paralleli di altezze comprese tra 14 e 24 cm. Anche qui, la regolarità del paramento sembre-rebbe ottenuta mediante l’impiego di pietra proveniente da strati di arenaria locale di altezze omogenee. Non si
21 Un repertorio utile si ha in Lamboglia 1970. Per lo studio delle tipologie architettoniche castrensi cfr. Cagnana, Gardini, Vignola 2010.
22 Lamboglia 1964, 1965, 1966.23 Un ultimo studio del monumento in Costa Restagno 2007.24 Varaldo et al. 2003. Da ultimo, sulle strutture esterne al palatium,
vd. Bulgarelli et al. 2013.
234 F. ZONI
fig. 4 – Facciata della chiesa cattedrale di S. Michele Arcangelo ad Albenga (SV). Fasi edilizie.
notano particolari tracce di segni lavorazione o finiture (CM 6, fig. 5).
Un altro possedimento dei marchesi di Clavesana, il castrum Diani (attuale Diano Castello, IM), presenta delle architetture con fasi di XII-XIII secolo. La chiesa di S. Giovanni Battista ha pianta rettangolare allungata a navata unica, con orientamento canonico e abside circolare (fig. 6). Le aperture, tanto dell’abside quanto dei perime-trali, sono strombate, con archetto monolitico a tutto sesto. Lungo il perimetrale sud è annesso il basamento di quello che fu il campanile della chiesa, crollato in seguito al terremoto del 1887, che oggi si presenta come corpo di
fabbrica, anch’esso absidato, annesso all’edificio princi-pale. Il terremoto rese necessari una serie di interventi di restauro, tra il 1892 e l’inizio del secolo successivo, condotti da Alfredo d’Andrade. Indagini archeologiche sono state condotte all’interno della chiesa a partire dal 2006, met-tendo il luce tre impianti per la fusione di campane: due moderni di XVIII secolo che sostituirono uno precedente le cui fasi iniziali risalgono alla prima fondazione dell’edi-ficio di XII-XIII secolo (Gandolfi 2009, pp. 79-90). La tecnica edilizia presenta delle bozzette arenarie tra 10 e 45 cm di larghezze, ottenute dallo spacco di strati di roccia con altezze omogenee, prive di rifiniture, messe in opera
LE MAESTRANZE ANTELAMICHE NELLA LIGURIA DI PONENTE. DIFFUSIONE DELL’OPUS QUADRATUM TRA XII E XIII SECOLO 235
fig. 5 – Tavola con campioni murari di opere a corsi di elementi sbozzati.
in corsi orizzontali paralleli di altezze comprese tra 9 e 24 cm. Lo spessore dei giunti e dei letti di posa è variabile e irregolare, probabilmente a causa della mancanza di lavo-razione delle facce di contatto (CM 8, fig. 5).
Continuando verso est, ancora nei territori dei mar-chesi di Clavesana, in quelle zone già ricordate come oggetto di contesa tra questi e i conti di Ventimiglia, altri esempi di muri in elementi sbozzati messi in opera in corsi orizzontali paralleli, si trovano a Taggia (IM), il cui destino fu simile a quello del castello di Andora. Anche Taggia fu ceduta definitivamente nel 1227 dopo lo scioglimento delle ultime resistenze contrarie all’influenza genovese. La chiesa di S. Maria del Canneto, situata immediatamente a nord dell’abitato medievale, è stata oggetto di recenti scavi
(Gandolfi et al. 2003, pp. 29-54) che hanno portato a una cronologia dell’attuale elevato di XII-XIII secolo. Pure questo edificio presenta degli elementi sbozzati di arenaria locale, di dimensioni comprese tra 10 e 46 cm, ottenuti dallo spacco di sedimenti geologici omogenei, messi in opera in corsi orizzontali paralleli di altezze tra 9 e 20 cm, con giunti e letti di posa variabili e irregolari (CM 10, fig. 5).
Questo tipo di tecnica si può trovare in altri svariati esempi del territorio ligure. Oltre che nei possedimenti dei Clavesana, muri a bozzette compaiono anche a Venti-miglia, come, ad esempio, nelle murature del complesso episcopale: nella chiesa cattedrale di S. Maria Assunta (CM 12, fig. 5) e nel suo battistero (CM 13, fig. 5). L’aspetto
236 F. ZONI
fig. 6 – Pianta della chiesa di S. Giovanni Battista a Diano Ca-stello (IM). In grigio, i limiti del saggio di scavo (rielaborata da Gandolfi 2009, p. 79).
fig. 7 – Particolare di affioramento di formazione di S. Bartolomeo con tracce di cava a spacco, località S. Gregorio (Baiardo, IM).
attuale è frutto dei lavori di restauro compiuti tra gli anni ’50 e ’60 durante i quali si svolsero anche i lavori di scavo archeologico diretti da Nino Lamboglia (Lamboglia 1961). Oltre a una prima fase altomedievale di VIII-IX secolo, emerge chiaramente una fase ascrivibile ai secoli XI-XII
nella facciata della cattedrale, nel suo perimetrale sud e nella muratura esterna del battistero, realizzata in bozzette di arenaria (con rara presenza di laterizio di reimpiego) non lavorate, con dimensioni comprese tra 9 e 39 cm (cattedrale) e 5 e 59 cm (battistero), ottenute a spacco da strati di altezze omogenee del sedimento geologico, messe in opera in corsi orizzontali paralleli con altezze variabili tra i 6 e i 16 cm (cattedrale) e tra i 5 e i 15 cm (battistero).
Nell’entroterra si trovano ancora per tutta l’età basso medievale murature ottenute dallo spacco di strati sottili, giustificati dalla facilità di reperimento in loco di materiale da costruzione. È il caso, ad esempio, della chiesa di S. Gregorio (fraz. S. Gregorio, Baiardo, IM), costruita su un affioramento della formazione di S. Bartolomeo della quale utilizza gli stessi strati, semplicemente spaccati, per la messa in opera e la cui cava è tuttora visibile in situ (fig. 7).
2.2 Opere a conci squadratiCon il XIII secolo, e la graduale imposizione del
Comune genovese su tutto il territorio della Liguria di ponente, si diffuse nei cantieri più importanti l’utilizzo di una tecnica edilizia differente, caratterizzata da elementi squadrati o riquadrati, con dimensioni maggiori, frutto di estrazione da cava a taglio, messi in opera in corsi paralleli e orizzontali, sempre disposti mediante l’utilizzo del filo a piombo e con evidenti tracce di lavorazione.
Un esempio è la già citata cattedrale di Albenga: nella fase di ampliamento di XIII secolo, che riportò l’edificio alle dimensioni della chiesa paleocristiana, si passò dalla tecnica in elementi sbozzati a una in conci riquadrati di grandi dimensioni (l 20-50 cm; h 26-33 cm) di calcare compatto, ottenuti mediante un sistematica coltivazione di cava, sui quali si notano tracce di lavorazione con rifilatura a scalpello (1,5-3 cm) e spianatura a punta fine (CM 2, fig. 8). Sulle murature perimetrali (CM 3, fig. 8), la tecnica edilizia è coerente con la fase di XIII secolo, relativa all’ampliamento dell’edificio di culto riscontrato sulla facciata, ma presenta caratteri distintivi come sdop-piamento dei filari, lavorazione geometrica di alcuni conci,
LE MAESTRANZE ANTELAMICHE NELLA LIGURIA DI PONENTE. DIFFUSIONE DELL’OPUS QUADRATUM TRA XII E XIII SECOLO 237
con conseguenti giunti a “L”, e buche pontaie realizzate nello spessore tra i conci anziché dal loro taglio. Il ciclo produttivo è lo stesso, si potrebbe trattare soltanto di una sotto differenziazione giustificata da una posizione di mi-nor peso rappresentativo (la facciata rappresenta l’edificio nel suo complesso).
Un caso analogo, di stacco tecnologico notevole tra tecniche edilizie ravvicinate cronologicamente e geografi-camente, si trova anche nel castello di Andora. Quando, nel 1252, il castello dovette essere ceduto completamente e definitivamente con tutte le sue pertinenze a Genova, il palatium divenne sede della guarnigione e, nel panorama politicamente stabile garantito dalla Repubblica, l’abitato si dilatò conseguentemente all’aumento della popolazione (Varaldo et al. 2003, p. 192). Con la committenza co-munale genovese, Andora visse una seconda fase edilizia monumentale, con la costruzione della chiesa dedicata ai Santi Giacomo e Filippo e della porta torre dell’accesso nord al castello (fig. 9). Come per la sequenza di XIII secolo della cattedrale Ingauna, anche qui si nota, nell’architettura genovese, una ricerca di un litotipo differente, passando da arenaria locale a calcare della formazione geologica c.d. di Capo Mele. Anche la tecnica edilizia è notevolmente differente: la posa in opera è in conci riquadrati di grandi dimensioni (l 20-40 cm; h 20-22 cm) disposti in corsi orizzontali paralleli mediante l’utilizzo di filo a piombo. Gli elementi del paramento presentano tracce di lavora-zione di rifinitura a scalpello (1,5-2,5 cm) e di spianatura delle facce a vista con punta fine (CM 4, fig. 8). Le stesse caratteristiche che si sono riscontrate nelle differenze tra facciata e prospetti laterali ad Albenga, si notano anche nella chiesa dei Ss. Giacomo e Filippo.
Anche la porta torre, che ancora in studi recenti si pensava di committenza clavesanica, presenta una tecnica edilizia che presupponeva lo stesso ciclo produttivo della chiesa (CM 5, fig. 8), senza considerare i caratteri formali della muratura ma solo quelli tecnici ed economici, la torre può essere ascritta alla fase di riedificazione genovese del castello. Anche qui, grandi conci squadrati (l 22-45 cm; h 10-30 cm) e parallelepipedi messi in opera in corsi orizzontali mediante l’utilizzo del plumbinum, presup-pongono un ciclo di cantiere di alta committenza che i residui di potere marchionale non potevano garantire. La lavorazione geometrica di alcuni conci, e i relativi giunti a “L”, lasciano ipotizzare una lavorazione a piè di muro.
La stessa tecnica di lavorazione della facciata della chiesa dei Ss. Giacomo e Filippo di Andora si ritrova nella chiesa di S. Pietro a Lingueglietta (Cipressa, IM), inse-diamento anch’esso parte dell’organizzazione territoriale del marchesato dei Clavesana ma legato a Genova già dal 1199 (Imperiale di Santangelo 1936, III, doc. 62, pp. 159-164). I feudatari locali, i de Vinguilia, giurarono presto fedeltà al Comune di Genova ottenendo la conferma dei diritti signorili che prima ottenevano dai discendenti del marchesato del Vasto 25. Recenti lavori di restauro hanno reso necessari interventi di scavo archeologico, conclusi nel 2004, con i quali è stato possibile datare la prima fase
25 Sull’organizzazione e la discendenza delle dinastie marchionali tra Piemonte e Liguria cfr. Sergi 1988; Bordone 1988.
della chiesa al XIII secolo (Gambaro 2005; Cagnana 2005c; Gambaro, Reffelini, Amoretti 2006). L’edi-ficio, oggi sconsacrato e adibito a sala conferenze, è di modeste dimensioni, a navata unica con sviluppo longi-tudinale, orientato canonicamente est-ovest e con abside semicircolare internamente ed esternamente. L’architettura della chiesa presenta evidenti stratificazioni dovute alle diverse destinazioni d’uso che l’edificio ha assolto nel corso del tempo (fig. 10): da edificio di culto venne trasformato in fortezza durante il periodo di organizzazione delle difese costiere contro le incursioni “turco-barbaresche” (per la stratigrafia delle murature cfr. Cagnana 2005c, pp. 38-42). Anche qui il litotipo è un calcare marnoso, tagliato in grandi conci frutto di estrazione da cava (l 25-75 cm), con evidenti segni di rifilatura a scalpello di c.a. 2,5-3,5 cm e di spianatura a punta fine. La posa in opera è in corsi perfettamente orizzontali di altezze comprese tra 23 e 30 cm e la sottigliezza dei giunti e dei letti di posa lascia presupporre la lavorazione delle facce non in vista (CM 9, fig. 8).
È una lavorazione molto simile a quella che ritroviamo nella chiesa concattedrale di S. Siro a Sanremo: grandi conci di calcare marnoso, con dimensioni comprese tra 25 e 47 cm, riquadrati con rifilatura a scalpello di spessore tra 2 e 3 cm e spianatura a punta fine, messi in opera in corsi orizzontali paralleli, di altezze comprese tra 17 e 27 cm, mediante l’utilizzo del filo a piombo e con giunti e letti di posa sottili e regolari (CM 11, fig. 8). Il caso della cattedrale di Sanremo, inoltre, è particolarmente rappresentativo in quanto un documento del 1254 attesta esplicitamente la presenza di un Blancus de Molzano magister antelami, il quale lasciò procura al fine di riscuotere quanto a lui do-vuto in occasione laborerii et magisterii quod fecit in operi ecclesie Sancti Romuli 26. Un altro manufatto, la canonica di S. Siro, presenta lavorazione, finiture e messa in opera simili: tuttavia le facce a vista, anziché essere spianate, presentano una lavorazione a “bugnato rustico” che sem-brerebbe rimandare ai primi esempi di opus quadratum del capoluogo ligure di XII secolo.
Un’ultima considerazione merita di essere fatta intor-no a due campioni di murature rilevati a Ventimiglia: le torri campanarie delle chiese di S. Maria Assunta e di S. Michele Arcangelo. Nel panorama che vede la comparsa di opere ascrivibili alle maestranze antelamiche genovesi soltanto dal Duecento, i due esempi sopra citati mostrano particolarità ascrivibili all’opera quadrata di XII secolo.
26 Si ringrazia per la segnalazione il prof. Fulvio Cervini. Il documento, un atto notarile conservato all’Archivio di Stato di Genova (ASG, cartulare 52, notaio Guido di San Ambrogio), è una procura che Blancus de Molzano fa nei confronti di Raimundum de Buzana e fratrem Wilielmum Bonaventure. Cito per intero: Ego Blancus de Molzano, magister antelami, facio et constituo Raimundum de Buzana et fratrem Wilielmum Bonaventure absentes et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis non sit melioris condicione, meos certos nuncios, procurators et loco mei petendum, recipiendum et exigendum Omnia et singular debita que mihi debenture a quacumque persona de Sancto Romulo et a comuni et universitate Sancti Romuli occasione laborerii et magisterii quod fecit in operi ecclesie Sancti Romuli vel aliqua alia occasione et ad agendum, opponendum, respondendum, excepiendum, replicandum, paciscendum suam et suas audiendum et appellandum si necesse fuerit. Actum Ianue ante apothecam predictam die XXIII aprilis intra terciam et nonam, MCCLIII, indictione XI. Il documento è pubblicato parzialmente in Calvini 1996, p. 162. Anche qui, inoltre, si nota come il lavoro e la presenza di un magister antelami fosse legato a delle commesse particolari e come questi non risiedesse nel centro cittadino di Sanremo.
LE MAESTRANZE ANTELAMICHE NELLA LIGURIA DI PONENTE. DIFFUSIONE DELL’OPUS QUADRATUM TRA XII E XIII SECOLO 239
fig. 9 – Vista generale della facciata della chiesa dei Ss. Giacomo e Filippo e della porta torre dell’accesso nord, castello di Andora (SV) (foto http://www.cnandora.org/monumenti.html).
fig. 10 – Lettura stratigrafica degli alzati della chiesa di S. Pietro, Lingueglietta (Cipressa, IM).
Anche in questi le differenze tecniche e litotipiche lasciano presupporre la presenza di committenti diversi rispetto alle opere murarie coeve. Entrambi gli edifici mostrano una ricerca di materiale frutto di cava, trasportato e lavorato in conci parallelepipedi di grandi dimensioni, rifiliati a scalpello e messo in opera in corsi orizzontali paralleli (CM 12, CM 13, fig. 8). La pietra, una roccia sedimentaria conglomeratica a matrice carbonatica, proviene da una formazione geologica riconducibile ai conglomerati di Monte Villa (fig. 11).
Entrambi i manufatti sono attribuiti ad una fase di ampliamento delle rispettive chiese di XII secolo. In particolare, la torre campanaria della cattedrale di S. Ma-ria Assunta mostra nelle facce delle superfici a vista una lavorazione a “bugnato rustico” e rifilatura a scalpello che sembra paragonabile per caratteristiche tecniche alla prima facies dell’opera quadrata antelamica, propria delle costru-zioni genovesi di XII secolo (Cagnana, Mussardo 2012).
Lo stesso litotipo si ritrova anche in quel che rimane dei castelli d’Appio (fig. 12) e della Rocca (fig. 13), nei quali (come nel caso di Sanremo) è attestata la presenza di magistri antelami 27. Anche questi presentano una tecnica edilizia simile ai casi precedentemente visti, realizzata in conci di grandi e medie dimensioni estratti dal conglome-rato di Monte Villa. È interessante notare come la ricerca di una materia prima utile all’apertura di cave finalizzate alla realizzazione di conci fosse calibrata sulla realtà geolo-
27 Vd. Supra, nota 17.
240 F. ZONI
fig. 11 – Carta geologica d’Italia, F. 91, Sanremo, scala 1:100.000. Particolare con Ventimiglia e, retinato, affiora-mento geologico del conglomerato di Monte Villa (scala 1:200.000).
fig. 12 – Castel d’Appio, Ventimiglia (IM).Vista generale e particolare della muratura in conci di roccia conglomeratica squadrati (foto A. Cagnana).
gica locale. Nel caso di Ventimiglia, non erano disponibili affioramenti di calcare a distanze potenzialmente utili dalla città e i più vicini erano situati oltre il Roja, confine politico del Districtus.
Conclusioni
Dall’indagine territoriale, emergono diversi casi in cui differenze di lavorazione ed evoluzioni tecniche compaiono in contesti cronologicamente e geograficamente vicini. La motivazione è da ricercare nei committenti delle opere, una delle tre variabili del cantiere edilizio (Bianchi 2010a, riprendendo Quirós Castillo 2005).
Murature in conci di grandi dimensioni, ottenuti da materiale frutto di una ricerca dell’affioramento geologico
più consono (anche se più lontano dal sito), con tracce di rifilatura a scalpello e spianatura delle facce a vista con strumenti a punta fine e messa in opera in corsi orizzontali paralleli, sono diffuse nella Liguria di ponente in contesti e cronologie che rimandano sempre alla presenza genovese sul territorio. Prima di questa non compaiono mai esempi di opus quadratum.
Contestualmente allo sviluppo e al successo econo-mico e politico di Genova si assiste a una delle prime riaperture sistematiche di cave nell’occidente medievale.
È così possibile attestare, a livello archeologico, la pre-senza delle maestranze antelamiche là dove le fonti scritte hanno delineato un panorama più incerto. L’uniformità delle caratteristiche tecniche, della lavorazione e della messa in opera di queste murature lascia presupporre la
LE MAESTRANZE ANTELAMICHE NELLA LIGURIA DI PONENTE. DIFFUSIONE DELL’OPUS QUADRATUM TRA XII E XIII SECOLO 241
fig. 13 – Castello della Rocca, Ventimiglia (IM). Lacerto di paramento in conci di roccia conglo-meratica squadrati (foto A. Cagnana).
presenza di una cultura costruttiva omogenea che venne ad operare con regolarità nella Liguria di ponente a partire dal XIII secolo.
Si nota la tendenza alla diffusione con un leggero ritardo di murature in opera da scalpellino. Rispetto a Genova, dove le evidenze cominciano a essere frequenti dal XII, nei territori di Albenga e di Ventimiglia ciò sembra avvenire nella prima metà del secolo successivo (fig. 14).
Il paragone con le tecniche precedenti fa emergere un’evoluzione tecnologica notevole, evidente nel passaggio da apparati con cicli produttivi meno complessi, formati da estrazione in cava a strati di elementi sbozzati e messi in opera da muratori 28, a cicli produttivi molto complessi, che richiedevano una seriale coltivazione di cave da taglio, un trasporto di prefabbricati (o semilavorati) pesanti, una rifinitura in cantiere e, probabilmente, un sollevamento dei blocchi per mezzo di apposite machinae (Brogiolo, Cagnana 2012, pp. 162-163).
Diversi casi di murature in bozzette lavorate a spacco, ottenute da cava di strati di roccia sedimentaria, presentano datazioni certe che le pongono in rapporto di contemporaneità con altre di grande apparato 29. Questo dato dimostra come la motivazione delle differenze nelle tecniche edilizie sia da ricercare a monte del processo edilizio: ovvero nelle capacità economiche e negli impulsi simbolici che portarono alla costruzione di un edificio. Ciò che realmente cambiò, con l’utilizzo dell’opus qua-dratum, fu la committenza genovese, che portò capacità economiche sconosciute nel territorio ligure occidentale prima del Duecento.
È significativo notare che la fase di ricostruzione di XIII secolo della cattedrale di Albenga sia avvenuta durante l’episcopato del vescovo Lanfranco di Negro, un genovese. Altrettanto indicativa è la chiesa dei Ss. Giacomo e Filippo ad Andora dove la tecnica costruttiva genovese, la cui finezza dei giunti e dei letti di posa da l’impressione
28 Si possono citare, tra i vari esempi con datazione certa grazie a docu-mentazione di scavo, la chiesa di S. Giovanni a Diano Castello (IM, XII-XIII secc.), le fasi romaniche della cattedrale di Ventimiglia (IM, XI-XII secc.), del battistero di Ventimiglia (XI-XII secc.), della chiesa di S. Maria a Taggia (IM, XII-XIII secc.), del palatium del castello di Andora (SV, XIII sec.), e altri ancora.
29 Si veda il caso sopra citato del castello di Andora.
di una messa in opera quasi a secco, emerge in un netto contrasto con l’ultima fase clavesanica.
Anche la differenza di litotipo utilizzato è una costante che separa i cantieri antelamici del ponente dal resto del panorama edilizio. Le murature in bozzette sono, perlopiù, ottenute con lo spacco di strati di depositi rocciosi sedi-mentari sottili, di 10-20 cm, caratteristici degli affioramenti della formazione geologica più diffusa nel Ponente: il flysch di Sanremo. L’utilizzo di un litotipo diverso nelle murature in opus quadratum (in genere calcare marnoso) implica la ricerca di affioramenti di altre litofacies con banchi di spes-sore maggiori finalizzati alla cava da taglio (fig. 15). Sempre nel caso di Andora, si passa dalla muratura del castrum in bozzette di arenaria locale a pietra calcarea cavata dal membro di Capo Mele, situato a più di due chilometri dal cantiere, caratterizzato da strati con banchi spessi tra i 10 e i 30 m (Giammarino et al. 2010). Questo dato è forse uno dei più indicativi nel testimoniare le capacità economiche della committenza, in quanto la ricerca di una pietra adatta implica un aumento del costo di cantiere direttamente proporzionale alla distanza tra questo e la cava.
Non a caso l’impiego di un’opera così costosa non si diffuse indiscriminatamente, ma interessò solo determinate zone e cantieri particolarmente importanti. È un’opera il cui utilizzo era esclusivo in edifici di particolare valore strategico o simbolico. Un utilizzo apertamente politico dei cantieri edilizi, in un panorama che vede Genova im-pegnata a ribadire la propria autorità e la propria presenza anche da un punto di vista materiale, proprio nel momento in cui l’egemonia e la giurisdizione sul territorio compreso tra Portovenere e Monaco era stata messa in discussione. Dopo il XII secolo, caratterizzato da un rapporto pressoché pacifico con le città costiere e con le signorie territoriali del ponente comprese nella giurisdizione politica riconosciuta da Federico I, nel XIII avvenne un mutamento radicale nel rapporto tra il capoluogo genovese e il Ponente. Le ultime rivendicazioni d’indipendenza durante l’impero di Federico II portarono a un investimento costruttivo in edifici di rappresentanza molto maggiore 30.
30 Un caso analogo è la Toscana degli Aldobrandeschi studiata da G. Bianchi: vd. Bianchi, Fichera, Paris 2009; Bianchi 2010a, 2010b.
242 F. ZONI
fig. 15 – Tabella dimensionale degli elementi messi in opera nei diversi campioni.
fig. 14 – Tabella con distribuzione cronotipologica delle tecniche murarie del Ponente ligure tra X e XIV secolo.
Gli ultimi esempi citati, le torri campanarie di S. Mi-chele e S. Maria Assunta a Ventimiglia e della canonica di S. Siro a Sanremo confermano che la diffusione dell’opus quadratum nel Ponente ligure ha seguito le tappe della dominazione di Genova sul territorio. La committenza genovese, in questi luoghi, può essere anticipata, coerente-mente con la datazione di questi edifici, date le particolari vicende storiche dei due centri. Ventimiglia, come primo centro ligure che subì un intervento militare diretto a scopo di occupazione nel 1146 (nel quale si ricorda anche la co-struzione di una “fortezza” per il primo presidio genovese, distrutta poco dopo dagli abitanti). Sanremo poiché centro di antica rivendicazione da parte del vescovo di Genova, che vi detenne beni a vario titolo almeno dal X secolo e che, dal 1143, troviamo attestato col titolo dominus et comes (Belgrano 1862, p. 122).
In conclusione, emerge come il ritardo nella diffusione dell’opera antelamica nel Ponente ligure sembri pienamen-te riconducibile allo sviluppo dell’espansione genovese che portò alla creazione della base territoriale della futura Repubblica. Questo dato, coerente con le vicende stori-
che liguri che videro l’imposizione di Genova nella costa occidentale affermarsi con un ritardo di circa un secolo rispetto alla Liguria di levante per la presenza di centri forti come Savona, Albenga e Ventimiglia, sottolinea e mostra con chiarezza il legame particolare che legò le maestranze intelviesi alla Dominante. Emerge un utilizzo apertamente politico dell’architettura realizzata in grande apparato, che porta l’opus quadratum dei magistri Antelami su un piano d’importanza simbolico oltre che qualitativo.
Questo è quanto riferisce Caffaro parlando delle costruzioni in novum opus che avrebbero suscitato grande gioia nel cuore degli amici atterrendo al contempo quello dei nemici 31.
31 Preterea castra, videlicet Vultabilii, Flaconis, Palodii, Rivarolii et Por-tusveneris, que extra civitatem de vetere opere erant edificata, tante fortitudinis tanteque pulcritudinis novum opus desuper et circa consules edificare fecerunt, quod intuitu transeuntium inde cetera cordis opiniones pro pulchritudine novi operis ab eis removeat: unde enim non solum amicis copia est leticie, verum etiam inimicis inmensam formidinem fortitudo novi operis tribuit audientibus. Belgrano, Imperiale di Santangelo 1890, p. 62.
LE MAESTRANZE ANTELAMICHE NELLA LIGURIA DI PONENTE. DIFFUSIONE DELL’OPUS QUADRATUM TRA XII E XIII SECOLO 243
BibliografiaBalard M., 1982, Per una storia dell’insediamento genovese nel Me-
diterraneo medievale, in Genova e la Liguria nel Mediterraneo. Insediamenti e culture urbane, a cura di P. Stringa, Genova, pp. 9-15.
Balletto L., 1985, Atti Rogati a Ventimiglia da Giovanni di Aman-dolesio dal 1258 al 1264, Collana storica di fonti e studi. 44 e Collana storicoarcheologica della Liguria occidentale. XXIII, Genova-Bordighera.
Balletto L., 1993, Atti Rogati a Ventimiglia da Giovanni di Aman-dolesio dal 1256 al 1258, Collana storico-archeologica della Liguria occidentale. XXVI, Bordighera.
Balletto et al. 1978 = Balletto L., Cencetti G., Orlandelli G., Pisoni Agnoli B.M., Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona 1178-1188), Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI, Roma.
Basso E., 2010, Naissance d’un empire: le reseau commercial génois du Levant à l’Atlantique, XIIe-XIVe siècle, in Réseaux marchands er réseaux de commerce. Concepts récente, réalités historique du Moyen Age au XIXe siècle, a cura di D. Coulon, Strasbourg, pp. 67-86.
Belgrano L.T., 1862, Il Registro della Curia arcivescovile di Genova, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II.
Belgrano L.T., Imperiale di Santangelo C., 1890, Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, Fonti per la Storia d’Italia, 11, Roma.
Bianchi G., 2010a, Archeologia dell’Architettura e indicatori materiali di storia sociale: il caso toscano tra IX e XII secolo, «Archeologia dell’Architettura», XV, pp. 205-210.
Bianchi G., 2010b, Dominare e gestire un territorio. Ascesa e sviluppo delle ‘sgnorie forti’ nella Maremma toscana centrosettentrionale tra X e metà XII secolo, «Archeologia Medievale», XXXVII, pp. 93-103.
Bianchi G., Fichera G., Paris F., 2009, Rappresentazione ed eser-cizio dei poteri signorili di XII secolo nella Toscana meridionale attraverso le evidenze archeologiche, in V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Foggia-Manfredonia 2009), a cura di G. Volpe, P. Favia, Firenze, pp. 412-416.
Bognetti G.P., 1938, I magistri Antelami e la valle d’Intelvi, «Perio-dico Storico Comense», II, pp. 17-54.
Bordone R., 1988, Affermazione personale e sviluppi dinastici del gruppo parentale aleramico: il marchese Bonifacio “Del Vasto” (sec. XI-XIII), in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico, Atti del primo Convegno (Pisa, 10-11 maggio 1983), Roma, pp. 29-44.
Brogiolo G.P., Cagnana A., 2012, Archeologia dell’architettura. Metodi e Interpretazioni, Firenze.
Bulgarelli et al. 2013 = Bulgarelli F., Roascio S., Dellù E., Ciurlo A., Vignola M., Grassi E., Interventi archeologici a Borgo Castello di Andora (SV). Dalla stratigrafia archeologica all’analisi degli elevati, «Archeologia Medievale», XL, pp. 205-232.
Cagnana A., 2000, La transazione al Medioevo attraverso la storia delle tecniche murarie: dall’analisi di un territorio a un problema sovraregionale, in I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Pisa 1997), a cura di S. Gelichi, Firenze, pp. 445-448.
Cagnana A., 2004, La ricerca sui magistri antelami da Monneret de Villard ad oggi, in L’eredità di Monneret de Villard a Milano, Atti del convegno (2002), a cura di M.G. Sandri, Milano, pp. 89-98.
Cagnana A., 2005a, Le tecniche murarie prima del romanico: evidenze archeologiche, fonti scritte, ipotesi interpretative, in Alle origini del romanico. Monasteri, edifici religiosi, committenza tra storia e archeologia (Italia settentrionale, secoli IX-X), a cura di R. Salvarani, G. Andenna, G.P. Brogiolo, Milano, pp. 93-122.
Cagnana A., 2005b, L’introduzione dell’opera quadrata medievale a Genova: aspetti tecnologici e contesto sociale, «Arqueología de la Arquitectura», 4, pp. 23-45.
Cagnana A., 2005c, Analisi stratigrafica delle murature in elevato, in Lingueglietta. Are, storia e tradizioni di un borgo del Ponente ligure, a cura di A. Sista, Imperia, pp. 38-42.
Cagnana A., 2008, Maestranze e opere murarie nell’alto Medioevo: tradizioni locali, magistri itineranti, importazione di tecniche, «Archeologia Medievale», XXXV, pp. 39-53.
Cagnana A., Gardini A., Vignola M., 2010, Castelli e territorio nella Repubblica di Genova (secoli X-XIII): un confronto tra fonti scritte e strutture materiali, «Archeologia Medievale», XXXXVII, pp. 29-46.
Cagnana A., Mussardo R., 2012, “Opus novum”. Murature a bugnato del XII secolo a Genova: caratteri tipologici, significato politico, legami con l’architettura crociata, in VI Congresso Na-zionale di Archeologia Medievale (L’Aquila 2012), a cura di F. Redi, A. Forgione, Firenze, pp. 87-92.
Calleri M., 1997, I più antichi statuti di Savona, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVII/II.
Calvini N., 1996, Un cinquantennio di attività per la storia del Ponente Ligure, I, Imperia.
Castiglia M., 2009, Il cartolare di ‘Uberto’, II. Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215), Società ligure di storia patria, Genova.
Cervini F., 1996, La “resistenza al gotico” nella Liguria Duecentesca. Il portale della cattedrale di Ventimiglia, «Intemelion», 2, pp. 19-46.
Chiaudano M., Moresco M., 1935, Il cartolare di Giovanni Scriba, Genova.
Chiaudano M., Morozzo Della Rocca R., 1938, Oberto scriba de mercato (1190), Genova.
Costa Restagno J., 1995, Gli statuti di Albenga del 1288, Fonti per la storia della Liguria, III – Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII, Bordighera-Genova.
Costa Restagno J., 2007, La cattedrale di Albenga, Albenga.De Simoni C., 1866, Statuto dei Padri del Comune della Repubblica
genovese, Genova.De Simoni C., Belgrano L.T., 1901, Leges Genuenses, HPM,
XVIII, Torino.Embriaco P.G., 2004, Vescovi e signori. La chiesa albenganese dal
declino dell’autorità regia all’egemonia genovese (secoli XI-XIII), Bordighera-Albenga.
Embriaco P.G., 2007, Enti ecclesiastici e organizzazione della cura d’anime: l’esempio del Ponente ligure, in L’organizzazione ecclesia-stica nel tempo di san Guido. Istituzioni e territorio nel secolo XI, Atti del Convegno (Acqui Terme, 17-18 settembre 2004), a cura di S. Balossino, G.B. Garbarino, Acqui Terme, pp. 219-240.
Erioli E., c.s., I falegnami in città. Lavoro, bottega e patrimonio tra fine Duecento e inizio Trecento, in Artigiani a Bologna (titolo provvisorio), a cura di R. Rinaldi, M.G. Muzzarelli, Bologna.
Gambaro L., 2005, La chiesa di S. Pietro a Lingueglietta. Indagini archeologiche, in Lingueglietta. Are, storia e tradizioni di un borgo del Ponente ligure, a cura di A. Sista, Imperia, pp. 29-34.
Gambaro L., Reffelini C., Amoretti V., 2006, Lingueglietta di Cipressa (IM). Indagini archeologiche nella chiesa di S. Pietro e presso la chiesa parrocchiale, «Ligures», 4, pp. 15-30.
Gandolfi D., 2009, La scoperta di impianti per la fusione di cam-pane nella chiesa di S. Giovanni Battista a Diano Castello (IM), «Ligures», 7, pp. 79-90.
Gandolfi et al. 2003 = Gandolfi D., Ansaldo L., Maggiolo L., Zambelli D., Cervini F., Taggia (IM), Chiesa di Santa Maria del Canneto. Nuovi studi e ricerche, «Ligures», 1, pp. 29-54.
Giammarino et al. 2010 = Giammarino S., Fanucci F., Orezzi S., Rosti D., Morelli D., Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, foglio 258-271, Sanremo, Roma.
Guglielmotti P., 2005, Ricerche sull’organizzazione del territorio nella Liguria medievale, Firenze.
Hall-Cole et al. 1940 = Hall-Cole M.W., Krueger H., Reinert R.G., Reynolds R.L., Giovanni de Guiberto (1200-1211), Torino.
Krueger H.C., Reynolds R.L., 1953, Lanfranco (1202-1226), Torino.
Imperiale di Santangelo C., 1936, Codice diplomatico della Re-pubblica di Genova, I-II-III, Fonti per la storia d’Italia 77, 79, 89, Roma.
Lamboglia N., 1961, Il restauro esterno della cattedrale di Ventimiglia, «Rivista Ingauna e Intemelia», 16, pp. 81-98.
244 F. ZONI
Lamboglia N., 1964, L’inizio del restauro interno della cattedrale di Albenga, «Rivista Ingauna e Intemelia», 19, pp. 71-81.
Lamboglia N., 1965, La seconda fase dei lavori per il restauro della cattedrale di Albenga, «Rivista Ingauna e Intemelia», 29, pp. 85-92.
Lamboglia N., 1966, Lo scavo e il restauro della cattedrale, «Bollettino Lingustico», 18, pp. 3-22.
Lamboglia N., 1970, I monumenti medioevali della Liguria di Ponente, Torino.
Mannoni T., 1997, Il problema complesso delle murature storiche in pietra 1. Cultura materiale e cronotiplogia, «Archeologia dell’Ar-chitettura», II, pp. 15-24.
Monneret De Villard U., 1919, L’organizzazione industriale nel-l’Italia Longobarda durante l’alto Medioevo, «Archivio Storico Lombardo», XLVI, pp. 1-83.
Moresco M., Bognetti G.P., 1938, Per l’edizione dei notai liguri del sec. XII, Torino.
Palmero G., 1994, Ventimiglia medievale: topografia ed insediamento urbano, Genova.
Pavoni R., 1992, Liguria medievale, Genova.Piergiovanni V., 1995, L’organizzazione dell’autonomia cittadina.
Gli statuti di Albenga del 1288, in Costa Restagno 1995, pp. IX-XXXIV.
Puncuh D., 1974, Il cartulario del notaio Martino: Savona, 1203-1206, Genova.
Quirós Castillo J.A., 2005, Técnicas constructivas altomedievales en la ciudad de Pisa y en la Toscana nordoccidental en la Alta Edad Media, «Arqueología de la Arquitectura», 4, pp. 81-109.
Ramella D., 2006, Analisi stratigrafica delle strutture: il caso del castello di Andora, «Ligures», 4, pp. 31-49.
Rovere A., 2013, Il cartolare di ‘Uberto’, I. Atti del notaio Giovanni, Savona (1213-1214), Società ligure di storia patria, Genova.
Sergi G., 1988, Anscarici, Arduinici, Aleramici: elementi per una com-parazione fra dinastie marchionali, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico, a cura di A. Spicciani, Atti del primo Convegno (Pisa, 10-11 maggio 1983), Roma, pp. 11-28.
Tosco C., 2003, Il castello, la casa, la chiesa: architettura e società nel medioevo, Torino.
Varaldo et al. 2003 = Varaldo C., Lavagna R., Benente F., Ramagli P., Ventura D., Il castello di Andora (SV): dalle tracce di frequen-tazione romana al castello signorile, in III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Salerno 2003), a cura di R. Fiorillo, P. Peduto, Firenze, pp. 191-200.
Zoni F., 2013, Magistri antelami tra Genova, Liguria di ponente e Ven-timiglia. Attestazioni documentarie e alcune considerazioni (secoli XII-XIII), «Intemelion», 19, pp. 1-18.
SummaryThe Magistri Antelami in western Liguria and the Spread of Opus Quadratum in the 12th-13th Centuries.The paper aims to describe the relation between the municipality of Genoa and medieval specialized stonemasons/stone-cutters during the political expansion in western Liguria. These workers are known in historical literature as magistri antelami and they started to organize as a real guild in the second half of the 12th century. Their work was characterized by a particular building technique, known as opus quadratum that appeared in western Liguria around the middle of the 13th century. In fact, this building technique (the most expensive in medieval constructions) appears only in contexts under direct control by Genoa due to an explicit political use of architecture, an aspect which is clearly demonstrated by both written and archeological sources. The construction of monumental build-ings in the landscape took place in response to the last attempts to gain autonomy by the coastal towns and by the local powers during the reign of Frederick II.Key words: opus quadratum, medieval building techniques, magistri antelami, Republic of Genoa, Western Liguria.
RiassuntoIl contributo analizza il rapporto tra il Comune di Genova e le ma-estranze specializzate di costruttori e lavoratori della pietra durante la fase di maggiore espansione territoriale nella Liguria occidentale. Questi ultimi, noti nella storiografia col nome di magistri antelami, già sul finire del XII secolo iniziano a mostrare le prime organizza-zioni del lavoro tipiche della futura associazione corporativistica. I tratti caratteristici del loro lavoro (murature in opus quadratum, pro-duzione di conci ben lavorati e spianati, con tracce di strumenti per la lavorazione omogenee in tutto il territorio) iniziano a comparire in modo significativo nel Ponente ligure solo a partire dal Duecento, circa un secolo dopo rispetto al capoluogo o ai centri della Liguria di levante ed esclusivamente in contesti legati a un dominio diretto genovese. La motivazione di tale fenomeno è riconducibile ad un uso apertamente politico dell’architettura monumentale da parte del Comune che emerge in modo incrociato sia dalle fonti scritte che dalle fonti archeologiche. La monumentalizzazione del paesaggio avviene contestualmente e in risposta alle ultime rivendicazioni di autonomia da parte dei centri cittadini e delle signorie locali durante gli anni di regno di Federico II.Parole chiave: opus quadratum, tecniche di costruzione medievali, magistri antelami, Repubblica di Genova, Liguria di ponente.