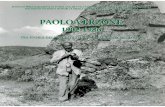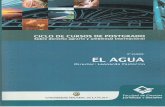voce Conservazione, in Enciclopedia dell'Architettura - 2008
Fabio Mariano, - Pratica dell'Architettura e del restauro dei materiali costruttivi storici....
Transcript of Fabio Mariano, - Pratica dell'Architettura e del restauro dei materiali costruttivi storici....
La “pratica” dell’architettura dei
materiali storici in uso consoli-
dato, in un territorio specifico e
ben caratterizzato (come nel
caso delle Marche), può costitui-re un ottimo sussidio non soloall’attività professionale nelleoperazioni di restauro/conser-vazione ma anche una validapropedeutica formativa ad usodi un corso a livello universita-rio di Restauro Architettonicomirato alla qualificazione delprogettista restauratore, intesoquest’ultimo come figura tecnicain grado di conoscere e com-prendere un bene architettonicoe ambientale nei suoi aspettistorico-evolutivi, nelle sue com-ponenti culturali, strutturali,materiche.
Per inciso, col termine “restau-ro” intendo qui identificare ogniintervento di conservazioneindirizzato a tutelare ed a tra-smettere integralmente al futuroun manufatto storico-artisticoe/o ambientale, facilitandone lalettura delle sue parti evolutesinel tempo, ponendo in sicurez-za in modo reversibile le suestrutture e le sue superfici,garantendone la durata e la suatrasmissibilità nel tempo.Sorvolando in questa sede suldibattito sui pur sottesi aspetti econtenuti etici e sociali dell’ope-razione “restauro/conservazio-ne”, ritengo che essa costituiscaevidentemente e comunque un“atto critico”, la cui attendibilità
si accresce in funzione dellaconoscenza analitica del manu-fatto, su basi scientifiche e cultu-rali; gli aspetti conoscitivi delmonumento (storia documenta-ria, rilievo architettonico, rico-noscimento dei materiali storici,analisi diagnostiche, ecc.) vannoquindi identificati come basesostanziale ed imprescindibiledi ogni corretto intervento. Le
Pratica dell’architetturae del restauro deimaterial i costruttivistorici . Introduzione alcaso delle MarcheFFaabbiioo MMAARRIIAANNOO
1
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc ii
RRoommaa �� VViittttoorriiaannoo�� ppaarrttii��ccoollaarree ddeellllaa ccoommpplleessssaaccoorrnniiccee ddeell ccoorroonnaammeennttooddeeii pprrooppiilleeii�� pprrooggeettttaattaaiinniizziiaallmmeennttee iinn TTrraavveerrttiinnoorroommaannoo ddaall SSaaccccoonnii mmaappooii rreeaalliizzzzaattaa iinn BBoottttiicciinnoobbrreesscciiaannoo�� ccoommppoorrttaannddoo iillrriiddiisseeggnnoo iinn ddeettttaagglliioo ddeeiippaarrttiiccoollaarrii aarrcchhiitteettttoonniiccii
AArrttiiggiiaannoo llaappiicciiddaa aall llaavvoorroo nneeii pprriimmiirreessttaauurrii ddeell PPaallaazzzzoo ddeellllaa SSiiggnnoorriiaa ddiiJJeessii�� ((�������� ccaa))
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:43 Pagina 1
eterogenee ed articolate infor-mazioni raccolte a supporto diquesta base conoscitiva devonoessere poi analizzate criticamen-te nei loro valori specifici edapplicativi ai fini del progettooperativo di restauro/conserva-zione, nell’ambito dell’evoluzio-ne delle normative tecnico-amministrative vigenti, che nonsempre concorrono, purtroppo -
a causa spesso di una carenzaculturale in materia da parte dellegislatore - alla migliore riuscitadell’intervento.Come ha sottolineato lucida-mente Giovanni Carbonara: “Ilrestauro, infatti, guarda al futuroe non al passato, neppure èriservato al godimento di pochieletti cultori dell’antico. Esso hafunzioni educative e di memo-ria, per le future generazioni,per i giovani; riguarda, in fondo,non il compiacimento per glistudi in sé ma la formazione d’o-gni cittadino e la sua qualità divita, intesa nel senso spirituale emateriale più esteso”.
In una regione come le Marche -nella quale il plurale del nome(l’unico oramai in Italia) coinci-de di fatto con una sedimenta-zione di storie sovrapposte eparallele, e di pratiche costrutti-ve conseguentemente articolate- l’aspetto del riconoscimentodei materiali costruttivi localicostituisce quindi una delle ope-razioni basilari propedeutiche alprogetto di restauro/conserva-zione, aspetto che gioca unruolo quanto meno pariteticocon le altre indagini storicodocumentarie ed archivistichenecessarie a definire la faciesevolutiva del monumento inesame ed a caratterizzarne le
fasi della sua stratificazione.In questo senso uno sguardod’insieme alle caratteristiche deimateriali costruttivi storici legatitradizionalmente ad uno specifi-co territorio può contribuire adindividuare le peculiarità delmonumento, la sua collocazionecronologica, i suoi possibili pro-gettisti ed esecutori e finanche il
2
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc iiBBrraacc ((BBrraazzzzàà))�� CCrrooaazziiaa�� ggiioovvaanneeaapppprreennddiissttaa llaappiicciiddaa aallllaa llooccaallee
SSccuuoollaa ppeerr llaa llaavvoorraazziioonnee ddeellllaa ppiieettrraa dd’’IIssttrriiaa
BBrraacc ((BBrraazzzzàà))�� CCrrooaazziiaa�� lleeaannttiicchhee ccaavvee ddii ppiieettrraadd’’IIssttrriiaa rriissaalleennttiiaall XXVV sseeccoolloo
AAnnccoonnaa �� LLooggggiiaa ddeeiiMMeerrccaannttii�� ffaacccciiaattaa iinn ppiiee��ttrraa dd’’IIssttrriiaa ddii GGiioorrggiioo ddiiMMaatttteeoo ddaa SSeebbeenniiccoo��((��������))
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:43 Pagina 2
3
ruolo svolto dai suoi committen-ti. Valga in merito l’esempionoto del Vittoriano di GiuseppeSacconi: progettato inizialmentedall’architetto marchigiano peruna esecuzione in poroso tra-vertino romano (od ascolano,data l’origine picena dell’archi-tetto), ne venne poi indiretta-mente imposta, influentemente,l’esecuzione in compatto bottici-no bresciano dall’allora Ministrodi Giustizia, il brescianoGiuseppe Zanardelli (1887-1891) - che aveva emanato ilRegio Decreto per la costruzio-ne del monumento - con l’in-combenza soverchiamenteimpegnativa per il Sacconi didover completamente ridisegna-re il dettaglio delle decorazionipreviste, a causa della notevol-mente diversa resa, finezza econsistenza materica delle duepietre, con i conseguenti enormiritardi esecutivi e la non secon-daria influenza anche sull’imma-gine finale del monumento,dovuta alla diversa reazione fisi-co-chimica agli agenti deltempo. Non basta inoltre alla conoscen-za del monumento la pur indi-spensabile ricerca archivistica(ché da sola può esser peraltrotalvolta contraddetta dai fattievolutivi del cantiere) se non sihanno rilievi rigorosi e finalizza-
ti ai vari interventi di conserva-zione e restauro sui diversimateriali storici, se non si“assaggia” fisicamente la mura-tura e i materiali, e li si indaghicon occhio esperto per discer-nerne le verità palesi e nascoste.Questo responsabile ed accura-to procedere comparativo com-porta quindi, se applicato cor-rettamente, tempi ed impegnonotevoli: un procedere necessa-riamente continuativo e collabo-rativo, interdisciplinare e,soprattutto, esperto della mate-ria.
Il tema delicato dell’esperienzacostruttiva - così strettamentelegato, specie in Italia, ad unalungimirante salvaguardia etutela delle consolidate tradizio-ni artigianali - sembra vada peròimmediatamente a confliggerecon la politica di superficialedisattenzione perseguita nelnostro paese nei confronti delprezioso retaggio culturale dellatradizione manuale nel settoredelle costruzioni. Nella Carta delRestauro del 1987, ad esempio -col definire il compito delrestauro nell’interpretazione delmanufatto storico-artistico, indi-viduandone la leggibilità dellasequenza storica degli interven-ti, oltreché garantirgli un ade-guato e controllabile migliora-
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc iiPPeessaarroo�� PPaallaazzzzoo DDuuccaallee�� ffiinneessttrraallaatteerraallee iinn ppiieettrraa dd’’IIssttrriiaa ddii MMaatttteeooddii AAnnttoonniioo ddaa AAnnccoonnaa�� ((sseeccoonnddaammeettàà ddeell XXVV sseeccoolloo))
TToolleennttiinnoo �� BBaassiilliiccaa ddii SSaannNNiiccoollaa�� ppoorrttaallee iinn ppiieettrraadd’’IIssttrriiaa ddii NNaannnnii ddiiBBaarrttoolloo�� ((������������))
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:43 Pagina 3
mento funzionale con mezzicompatibili e reversibili - siauspicava abbastanza esplicita-mente l’adozione, o meglio ilrecupero, delle antiche tecnicheartigianali. Tuttavia, dichiaran-dosi favorevole al recuperodelle tecniche tradizionali, iltesto metteva anche opportuna-mente in guardia sul loro pro-blema esecutivo, sottolineandoquanto il loro recupero non siadi per sé condizione sufficiente,poiché tali tecniche è necessariosoprattutto conoscerle e poterleattuare, in quanto la formazionedi nuove maestranze qualificatedovrebbe costituire parte inte-grante delle attività di salvaguar-dia e conservazione del patri-monio architettonico.
L’adozione talvolta sconsideratadi tecnologie e materiali cosid-detti “innovativi” nel campo delrestauro, promosse nei passatidecenni più o meno scoperta-mente dalle ditte operanti nelsettore della chimica inorganica,ha contribuito ad una talvoltairreversibile scomparsa delsaper fare tradizionale, spessoproditoriamente giudicato obso-leto o addirittura superato odinadatto. Un fenomeno seguitopoi dalla corrente “moda” edalla “riscoperta” dell’architet-tura ecocompatibile, formula
utile talora solo a sollecitarenuovi bisogni consumistici inquanto tali tecniche erano giàampiamente note alla consuetu-dine ed alla metodica della tra-dizione costruttiva storica (leelementari nozioni sui materialinaturali e sulla loro compatibi-lità, l’orientamento e l’insolazio-ne degli edifici, i presidi delrisparmio energetico, il valoredella massa muraria, ecc.). Larivitalizzazione del fare artigia-nale, auspicata da quella Cartadel Restauro, avrebbe dovutonelle intenzioni passare per lacreazione - o rifondazione - dibenemerite scuole edili, centristudi, corsi universitari specializ-zati…ma allora - ci si potrebbechiedere - perché si è lasciatomorire l’artigianato sopravvissu-to - e soprattutto gli artigiani -senza invece curarne in tempola tutela? Perché non si è inter-venuti tempestivamente e con-cretamente a salvaguardia delledelicate strutture operative giàesistenti nel cantiere di restauro(già in crisi obiettiva indotta daun mercantilismo superficiale
ed esasperato al ribasso) e suisuoi tradizionali vincoli e pro-blematiche operative?Sopravvivenza delle botteghe,equo canone, incentivi e facilita-zioni finanziarie e fiscali sull’ap-prendistato dei giovani, oculatistrumenti legislativi di tuteladelle antiche professionalità,ecc. erano a tutta evidenza leprime tematiche cui prestareuna intelligente e dovuta atten-zione. Nazioni meno ricche e
4
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc ii
JJeessii �� PPaallaazzzzoo ddeellllaaSSiiggnnoorriiaa�� eeddiiccoollaa aarraallddiiccaa��ffiinneessttrree ee ddeeccoorrii iinn ppiieettrraadd’’IIssttrriiaa ddii MMiicchheellee ddiiGGiioovvaannnnii eedd AAllvviissee ddaaMMiillaannoo ssuu ddiisseeggnnoo ddiiFFrraanncceessccoo ddii GGiioorrggiioo��((������������))
AAnnccoonnaa �� LLaazzzzaarreettttoo�� ppoorrttaallee iinn ppiiee��ttrraa dd’’IIssttrriiaa�� LLuuiiggii VVaannvviitteellllii�� ((������������))
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:43 Pagina 4
5
sviluppate di noi hanno avuto inmerito una previdente politicaformativa e di tutela delle anti-che professionalità artigiane, efaccio solo l’esempio della vici-na e prospiciente Croazia, con lesue scuole per giovani lapicidi.Si tratta, evidentemente, di untipico caso di schizofrenia ende-
mica nella politica programma-toria italiana. La vigente leggesugli appalti (la famigerata“Merloni” nelle sua varie versio-ni ed integrazioni) è stata estesaprobabilmente con poca nozio-ne scientifica nel merito specifi-co dei lavori di restauro, affastel-lando nello stesso calderonenormative spesso incompatibili,tra edilizia generica e restaurodei beni monumentali, comehanno dimostrato alcuni degliinterventi nei casi specifici, tal-volta particolarmente dolenti,per il terremoto Marche-Umbriadel 1997. Le opere pubbliche eprivate storiche non ricadentisotto il vincolo e la committenzadiretta delle Soprintendenzevengono tuttora appaltate sottonormative che poco si discosta-no da quelle adottate per lepalazzine di periferia o per icentri commerciali. Non è possi-bile in tal modo avvalersi seletti-vamente e proficuamente dell’o-pera diretta di artigiani restaura-tori di provata e consumataesperienza, e del credito da loroaccumulato e conquistato colloro sapiente lavoro. I progettistirestauratori devono sovente farevoti affinché l’impresa ediliziaaggiudicatrice delle gare (sele-zionata quasi sempre al soloribasso d’asta e con scarsi vinco-li prestazionali) accetti poi di
subappaltare i lavori più delicatisui materiali e le superfici stori-che a restauratori documentata-mente qualificati nei settori spe-cifici; fatto che non avvienemolto spesso a causa della ten-denza al subappalto a prezzistracciati per consentire i debitiricarichi degli appaltatori edili,con conseguente esclusione deimigliori artigiani restauratori, iquali oltretutto si rifiutano spes-so, e giustamente, di iscriversiagli Albi dei Costruttori e trasfor-marsi in mere imprese edilizie.Tornando al tema della cono-scenza dei materiali storici, ilcaso delle Marche si presenta,nello specifico, particolarmentesignificativo.
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc iiAAnnccoonnaa �� cchhiieessaa ddii SSaann DDoommeenniiccoo��ffaacccciiaattaa iinn ppiieettrraa dd’’IIssttrriiaa ddii CCaarrllooMMaarrcchhiioonnnnii�� ((������������))
AAnnccoonnaa �� MMoonnuummeennttoo aaii CCaadduuttii�� iinnppiieettrraa dd’’IIssttrriiaa�� aarrcchhiitteettttoo GGuuiiddooCCiirriillllii�� ������
AAnnccoonnaa �� AArrccoo ddii TTrraaiiaannoo�� iinn mmaarrmmooddeellll’’IImmeettttoo ddii AAtteennee�� ((������ dd CC ))
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:44 Pagina 5
L’orogenesi delle Marche ha unaetà relativamente recente equasi completamente marina, icui sedimenti costituiscono leformazioni stratificate più anti-che, prevalentemente di tipomarnoso. Generalmente laregione è caratterizzata daforme sedimentarie che vannodal Lias Inferiore (i calcari piùantichi) fino all’Era Cenozoica;gli affioramenti più antichi, che
interessano le zone montagno-se, sono formati da calcare mas-siccio, dalla corniola e da calca-ri marnosi, con affioramenti dirosso ammonitico; si nota la pre-senza di calcari selciferi (scisti),di formazioni di maiolica, di sci-sti “a fucoidi” e di scaglia rosata(Monte Nerone), abbastanza dif-fusa nella regione; quindi dellerocce giurassiche di originemarina, del Furlo, ecc.. Tali resi-dui geologici appenninici inte-ressano il massiccio calcareo ele falesie del Conero, i massiccicalcarei di Cingoli, del Catria,del San Vicino. L’abbondanzadei sedimenti del Cenozoico edel Terziario hanno da semprefornito alle Marche abbondantemateriale calcareo da costruzio-ne e decorazione architettonicadi diverso tipo. Le diverse zonedi provenienza ne hanno deter-minato le diverse caratteristichegeomorfologiche e la denomi-nazione locale.
Tra i migliori calcari si citano quiquelli del Monte Conero (traAncona e Sirolo), che per lachiarezza cromatica e la consi-stenza materica potevano talvol-ta competere con la più prezio-sa e prospiciente pietra dalmata(Pietra d’Istria, di Orsera, diBrazzà, di Rovigno, ecc.). Il cal-care del Conero veniva infatti
spesso preferito alla pietrad’Istria per la facilità della suaestrazione direttamente daimassi trovanti, prodotti dallericorrenti frane costiere del mas-siccio cumerico, e per l’econo-micità del suo costo di trasporto(bastasìa, nei contratti antichi)rispetto a quello ben più onero-so via mare dalla Dalmazia.Spesso quello si trova benmescolato con questo neimonumenti più significativi diAncona tra Medioevo eRinascimento (mura duecente-sche, S. Maria della Piazza,Loggia dei Mercanti, S.Francesco delle Scale, S.Agostino, Palazzo del Governo,ecc.).La presenza costante di architet-ti, scultori e lapicidi dalmati intutte le Marche del Rinascimento- i quali, oltre all’attività artistica,svolgevano con consuetudinequella di fornitori di pietra dalle
6
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc iiFFaannoo �� AArrccoo ddii AAuugguussttoo�� ccoossttrruuiittoo
ssuull ppuunnttoo iinn ccuuii llaa vviiaa FFllaammiinniiaass’’iinnnneessttaa ssuull ddeeccuummaannoo mmaassssiimmoo
ddeellllaa cciittttàà�� rreeaalliizzzzaattoo iinn bblloocccchhii ttuuffaacceeii ee rriivveessttiittoo
iinn ppiieettrraa dd’’IIssttrriiaa�� ((aannttee iill �� dd CC ))
UUnnaa ccaavvaa aa ggrraaddoonnii ddii ssccaagglliiaa rroossssaanneellllee MMaarrcchhee cceennttrraallii
UUnnaa ccaavvaa aa ffoossssaa ddii ttrraavveerrttiinnoo�� ccoonnttaagglliioo vveerrttiiccaallee ee rriibbaallttaammeennttoo ddeeiibblloocccchhii ssuull ppiiaazzzzaallee�� nneellll''AAssccoollaannoo
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:44 Pagina 6
7
loro terre d’origine, dove posse-devano spesso concessioni di“petrere”, (ovvero di cave) -rende diffuso tale materiale
architettonico e scultoreo sututto il territorio regionale. Siveda a Fermo lo zaratino Andreadi Giorgio che lavora, fra il 1404ed il 1410, per il locale conventodegli Agostiniani, mentre nellacattedrale fermana opera dal1469 il sebenicense GiovanniHreljic, ed anche un Giacomo diGiorgio slavo è qui l’artefice delportale in gotico fiammeggiantedell’ ex Ospedale dellaCongregazione della Carità;quindi l’istriano LucianoLaurana nelle sue opere lapideenella Rocca di Pesaro e diSenigallia. Sempre in Ancona,alcune parti della Loggia deiMercanti verranno lavorate efornite direttamente da Giorgiodi Matteo da Sebenico e dall’al-banese Andrea Alessi; nellaChiesa di S. Francesco delleScale la pietra d’Istria verrà for-nita e lavorata da GiovanniPribislavic da Sebenico. Di con-tro, artisti marchigiani userannola pietra d’Istria nella propriaregione: come Matteo diAntonio da Ancona nelle fine-stre laterali del Palazzo Ducaledi Pesaro; il fiorentino Giulianoda Maiano ne farà ampio uso nelportico del Palazzo del cardinalVenieri a Recanati, come faràanche il suo concittadino Nannidi Bartolo nel portale della chie-sa di S. Nicola a Tolentino. Altri
troveranno più economico affi-darsi alle numerose varianti cal-caree presenti in regione: comeMarino di Marco Cedrino, archi-tetto e scultore veneziano di ori-gine riminese, ad Amandola,Ancona, Fano, S. Angelo inVado, Fermo e forse aCivitanova. Così farà il Laurananel Palazzo Ducale di Urbino e,sempre qui, il senese Francescodi Giorgio nel portale dellaChiesa francescana di S.Bernardino (con la pietra dellaCesana). Su disegno del senese,Michele di Giovanni da Milanoed il figlio Alvise realizzerannola splendida edicola e le finestrea croce immissa di pietra d’Istriadel Palazzo della Signoria a Jesi,mentre sempre qui Giovanni diGabriele da Como scolpirà lalaterale Porta Salara dello stessopalazzo e le colonnine coi capi-telli del secondo ordine dellasua corte interna, su disegno diAndrea Sansovino.
Va detto che, anche nei secolisuccessivi, nei monumenti dicommittenza più ricca ed in pre-senza di architetti camerali pre-stigiosi ed influenti, l’uso direttodella pietra d’Istria veniva impo-sto sovente, essendo questa benpiù resistente del calcare locale,specialmente all’aggressione deiventi salsi marini.
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc iiUUrrbbiinnoo �� PPaallaazzzzoo DDuuccaallee�� ccoorrttee��aarrcchhiitteettttuurraa ddii LLuucciiaannoo LLaauurraannaa��ccaappiitteellllii�� ccoolloonnnnee ee ppaarraassttee iinnccaallccaarree ddeettttoo ““ttrraavveerrttiinnooddii PPiioobbbbiiccoo””
AAssccoollii PPiicceennoo �� PPoorrttaa GGeemmiinnaa ssuullllaaVViiaa SSaallaarriiaa�� ((II°° sseeccoolloo aa CC ))
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:44 Pagina 7
E’ il caso delle opere marittimeed urbane di Luigi Vanvitelli inAncona (1732-39): come nelLazzaretto, nel MoloClementino, nell’ArcoClementino, nella Chiesa delGesù, ecc.; ma anche nellaChiesa della Maddalena aPesaro e nell’addizione al porti-co bramantesco della Basilica diLoreto. Come anche farà, nellafacciata della Chiesa di S.Domenico in Ancona, il romanoCarlo Marchionni (1761-88), onelle fontane di Piazza del Papal’architetto anconitano PietroZara di Camerata, nel 1817, sinoall’utilizzo contemporaneo fat-tone dall’architetto Guido Cirillinel suo elegante tempietto delMonumento ai Caduti alPassetto (1932).E’ appena il caso qui di sottoli-neare che da tali metodichevada espunta la precedentevasta pratica costruttiva romanasul territorio, diffusa in numero-
si importanti monumenti edinfrastrutture pubbliche, che -con concretezza pratica e grandimezzi tecnici ed organizzativi -tendeva dove necessario ad uti-lizzare indifferentemente siapietre locali (arenarie, pietra“grigna”, calcare bianco e giallo,corniola, pietra del Furlo, traver-tino ascolano, ecc.) come anchemateriali d’importazione piùidonei alla funzione (la trachitelaziale od euganea per i bàsolistradali), o, più raramente, i pre-ziosi marmi esteri nel contestodi opere insigni di committenzaimperiale; vedi il raro caso delmarmo greco dell’Imetto atenie-se usato nell’Arco di Traiano inAncona (115 d.C.). Ciò avvennealmeno a partire dall’intensifi-carsi dei traffici tra Roma e leMarche, con l’apertura dellaprima consolare Flaminia(attorno al 220 a.C.) e dei suoidiverticoli: arteria fondamentalepassante per Fano (FanumFortunae) e verso Rimini(Ariminum). A Fano sorgel’Arco di Augusto, costruito -forse dall’architetto MarcoVitruvio Pollione - intorno al 9d.C. sul punto in cui la viaFlaminia s’innestava sul decu-mano massimo della città, rea-lizzato in blocchi tufacei e rive-stito in pietra d’Istria.Numerose sono le varianti della
pietra calcarea presenti nelleMarche, utilizzate come materia-li costruttivi o per produrrecalce; tra di esse - oltre alla cita-ta pietra del Conero - si ricorda-no: quelle di Cingoli, SanSeverino, Matelica,Serrapetrona, Serra S. Quirico(cave della Rossa), Cagli (dalMonte Petrano), pietra del Furlo(Monte di Pietralata,Acqualagna, nelle versioni bian-che e rosate), la delicata e vetro-sa pietra della Cesana (nelMontefeltro), il cosiddetto “tra-vertino di Piobbico” (dal MonteNerone e dal Catria), famosoquesto per aver dato forma aicapitelli ed alle colonne monoli-tiche del cortile del PalazzoDucale di Urbino del Laurana,ecc.; ed infine anche una formadi alabastro è presente nellerocce di Genga.Ma, soprattutto, va evidenziatoqui il travertino ascolano (Lapisasculanus): ottimo e rinomatomateriale costruttivo sin dall’e-
8
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc iiAAssccoollii PPiicceennoo �� cchhiieessaa ddii
SS FFrraanncceessccoo ddii PPaaoollaa�� iinngg IIggnnaazziiooCCaannttaallaammeessssaa�� ((��������������))
SSaann LLeeoo �� llaa ccaatttteeddrraallee rroommaanniiccaa ddiiSSaann LLeeoonnee�� rreeaalliizzzzaattoo iinn bblloocccchheettttiiddii aarreennaarriiaa ttuuffaacceeaa ddaa mmaaeessttrraannzzeelloommbbaarrddee�� ((������))
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:44 Pagina 8
9
poca classica. La sua facile lavo-rabilità, durabilità e la sua resi-stenza a compressione ne decre-tarono la fortuna d’uso, anchegrazie alla sua comoda reperibi-lità nelle cave limitrofe all’im-portante capoluogo piceno (siricordano quelle del Colle SanMarco, di Rosara, di CastelTrosino, di Acquasanta). Questaottima pietra da costruzione,dalla pregevole e calda tonalitàbionda conferitale dal tempo, sidiffuse nella Asculum romana apartire dall’89 a.C., con la con-quista dell’importante centro,posto sul tracciato trasversale trai due mari della divenuta strate-gica via Salaria, da parte diGneo Pompeo Strabone al ter-mine della Guerra Sociale.Il travertino ascolano - subito
individuato dai Romani comevalido succedaneo di quello diTivoli (Lapis tiburtinus), già aloro ben noto - divenne da allo-ra e ben presto il leit motivmaterico e cromatico unificante,per duemila anni e senza solu-zione di continuità, dei principa-li monumenti storici di AscoliPiceno e del suo territorio(ponti, fortificazioni, pavimenta-zioni, templi, porte, teatri edanfiteatri, terme, palazzi, portalie ville), usato e riusato per seco-li, dall’età classica e sino adoggi, senza limitazioni odimpacci stilistici: dalla romanaPorta Gemina, passando per ilRomanico ed il Rinascimento,sino alle opere della modernità.
Un materiale, questo, a tutt’oggioggetto di produzione locale(23.000 mc ca. annui) e di profi-cua esportazione in tutto ilmondo, al punto da giustificaree motivare anche una praticaattualmente in corso per il suoinserimento come “bene cultu-rale” nel patrimonio mondialedell’Unesco.Un altro materiale da costruzio-ne molto diffuso nella regione èsenz’altro l’arenaria, e le varieforme del “tufo”; la cui qualità eporosità è determinata propor-zionalmente dalla profonditàdegli strati della sua estrazione;
quella più scadente, il cosiddet-to “cappellaccio”, corrispondesolitamente agli strati più super-ficiali. Data la sua economicità ela sua non eccezionale resisten-za agli agenti atmosferici, l’are-naria si trova ricorrentemente,usata a blocchetti o “tufelli”,nella realizzazione delle massic-ce cinte murarie urbiche delMedioevo e nelle tessiture miste(con ciottoli fluviali, laterizi epietre di recupero, ecc.) di edifi-ci di epoche poco faconde. Unparadigma significativo e preco-ce è costituito, ad esempio, dallacattedrale di San Leone a SanLeo, datata al 1173.La sua diffusione regionale è
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc iiSSaann SSeevveerriinnoo�� SSaannttuuaarriioo ddii SS MMaarriiaaddeell GGlloorriioossoo�� RRooccccoo ddii TToommmmaassoo ddaaVViicceennzzaa�� ((����������))
DDeettttaagglliioo ccoossttrruuttttiivvoo ddii uunn aatttteerrrraattoo
AAtttteerrrraattoo pprreessssoo CCoorrrriiddoonniiaa
AAtttteerrrraattoo pprreessssoo PPoolllleennzzaa
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:44 Pagina 9
molto estesa; si ricorda qui sol-tanto la specialità denominata“pietra di S. Ippolito”, in quantoquesta località dell’alta Valle delMetauro produsse anche unacollegata e rinomata scuola discalpellini molto attiva tra XVI eXIX secolo.Un materiale “di nicchia” inambito architettonico e decorati-vo è rappresentato nella regionedal gesso Balatino: una sorta diritmite gessosa costituita dall’al-ternanza di sottili lamine di stra-tificazione carbonatiche micro-cristalline, spesso fissili, di colo-re screziato biancastro cereo,talora grigio o verdastro, brunoo violaceo, di origine miocenica,che ha subito una prima sedi-mentazione con l’abbassamentodi livello del Mediterraneo, poiuna erosione ed infine una suc-cessiva sedimentazione in ban-chi profondi.
Il gesso Balatino è molto diffusoin Sicilia, in Romagna orientale(Cesena), ed anche nelleMarche. Qui le cave più antiche,oggi non più attive, si rinvengo-no nei territori di S. Severino e diCingoli, ma affioramenti sonopresenti anche nel bacino geo-logico di Pietrarubbia-Peglio.Esso è documentato in uso sindai primi del XVI secolo: si vedail significativo esempio del
Santuario del Glorioso (opera diRocco di Tommaso da Vicenza,1519-21) nella periferia di S.Severino, dove lo ritroviamoadoperato in modo diffuso sianelle murature portanti sia nellescure colonne e nei capitelli cheritmano l’austera aula ecclesialedel tempio, grazie anche alla suabuona resistenza a compressio-ne. L’antica cava, oggi ricoperta,è ancora identificabile a pochecentinaia di metri dal Santuario.Successivamente esso vennemolto usato nei diffusi rinnovidei palazzi marchigiani nelXVIII secolo, specie nei gradinie nei balaustri, o nelle scornicia-ture degli scaloni monumentali.La sua caratteristica facilità dilucidatura “a spoltiglio” e confinitura a grafite - che lo rendevaassimilabile ad un marmo - lofaceva preferire ai più costosimarmi d’importazione per le sueottime caratteristiche estetiche;ciò purché lo si utilizzasse esclu-sivamente all’interno in quantoestremamente attaccabile e sca-gliabile dagli agenti atmosfericie gelivi. A causa della sua faciledeperibilità superficiale, dovutaal calpestio, esso viene oggimalauguratamente sostituito nei“restauri” con pietre grigie d’im-portazione (quali la pietraSerena od il Peperino) che nullahanno a che fare con la storia
geologica ed architettonica delleMarche, rimanendo questi litoti-pi di origine vulcanica pertinen-ti maggiormente alle aree tosca-ne e del nord del Lazio.A tutt’oggi le cave di materialelapideo attualmente attive sul ter-ritorio marchigiano, impiegatonelle varie attività edilizie, sono175 mentre ben 1041 sono quel-le storiche ed oggi dismesse.Un cenno va infine concesso adun materiale - o meglio ad unatecnica costruttiva - che risultacaratteristica della regione: sitratta della muratura in terracruda: una sorta di “pisè” o“adobe”, ancora molto diffusatra le popolazioni primitivedell’Africa e dell’AmericaCentrale ma utilizzata da tempoimmemore in tutto ilMediterraneo.
Nelle Marche essa è nota colnome di “atterrato” (adterratumnell’antichità), che si distinguesostanzialmente dai due terminisuindicati (in francese e spagno-lo) in quanto realizzata non conmattoni d’argilla preformati incasseforme di legno bensì conmappe informi di argilla umidamista a paglia o pula, allineate esovrapposte, poi compattatepigiandole direttamente inopera coi piedi sui muri stessi invia di elevazione.
10
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc ii
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:44 Pagina 10
11
Dell’uso di tale tecnica si hanozione nella regione sin dall’al-to Medioevo, e con maggiorefrequenza dal XIII secolo; tutta-via la sua espansione avvennedopo la crisi demografica edagricola del XIV e XV secoloquando, agli inizi del XVI seco-lo, col ripopolamento dellecampagne e la conseguenterinascita agricola, con l’estensio-ne del potere papale unificatosul territorio marchigiano, vienea definirsi anche la gestione deipossedimenti agricoli, che sispecializza in due forme con-trattuali privatistiche prevalenti:l’affitto e la mezzadria. Mentrequest’ultima fruiva, per sua stes-sa natura, di insediamenti fami-liari collaborativi e stabili, conconseguente creazione di abita-zioni più solide e durature, laprecarietà del contratto di affittoe la condizione di “casanolanti”delle masse contadine più pove-re sembra identificare la propriacondizione gerarchicamentedepressa nell’uso stesso dellacasa in atterrato. La sua diffusio-ne sembra corrispondere, anchenella frequenza geografica, atale stato di indigenza economi-
ca. I documenti storiograficiindividuano infatti tali aree nellezone del Maceratese (soprattut-to), del Fermano edell’Ascolano: aree tradizional-mente depresse economica-mente, almeno sino all’Unitàd’Italia.
La struttura del contratto mezza-drile era imperniata su di unaunità produttiva frammentaria,basata sul nucleo familiare e sudi un podere colonico benmisurato e solitamente piccolo,sia nel numero delle braccia sianelle attrezzature sia negli ani-mali da lavoro; conseguente-mente il suo schema insediativoseguiva tali dimensionamentiprevalenti. La mano d’opera ineccesso veniva inesorabilmenteespulsa da tale miope sistemaproduttivo, primitivo e nonindustrializzato, per affollare lemasse diseredate del cosiddettobracciantato agricolo, dei “gior-nalieri”: proprietari di nulla ecostretti ad affittare sia i terrenicoltivi sia gli strumenti per illoro lavoro, sia talvolta la pro-pria stessa residenza. La loro eraquindi, di fatto, una residenza
precaria, realizzata temporanea-mente ad hoc con le propriestesse braccia non specializzate,e con materiali di bassissimo onullo costo trovati direttamentesul posto: la terra e la paglia,appunto. La povertà costruttivae l’opera di progressiva sostitu-zione con case in laterizio o pie-tra arenaria, non appena ilmiglioramento delle condizioniesistenziali lo consentivano, hadecretato la pressoché totalescomparsa di tali tipologie archi-tettoniche nella regione. I pochiesempi superstiti, quasi tutti nonanteriori al XIX secolo (esempi a
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc ii
MMiissuurree rroommaannee ssuullll’’AArrccoo ddii TTrraaiiaannooiinn AAnnccoonnaa
MMiissuurree eeddiilliizziiee ssuullllaa LLooggggiiaa ddeeiiMMeerrccaannttii iinn AAssccoollii PPiicceennoo ((��������))
AAnnccoonnaa�� iill ccaannttiieerree ddeellLLaazzzzaarreettttoo ee llee ffoorrnnaaccii ddiiPPoossaattoorraa�� iinn uunn ddiisseeggnnoo ddiiLL VVaannvviitteellllii ((������))
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:44 Pagina 11
Corridonia, Borgo Ficana aMacerata, Cupramontana,Pollenza, Treia, Montelupone,Ripaberarda, Ostra Vetere, ecc.),hanno recentemente consentitoil rilevamento e la tutela dellecaratteristiche tipologiche, men-sorie e costruttive di questa anti-chissima e popolare forma
costruttiva ed insediativa.I sedimenti prevalenti delle areecollinari, appartenenti al tardoTerziario e al Quaternario, sononelle Marche a composizioneargillosa, arenacea e in alcunicasi sabbiosa o ghiaiosa, dovespesso si rintracciano le sedi-mentazioni alluvionali deinumerosi corsi d’acqua fluvialiparalleli, posti trasversalmenteagli Appennini ed alla costa.Dalle caratteristiche strutturalidei minerali argillosi dipendonole proprietà complessive delleargille stesse, in particolare leloro caratteristiche proprie,quali la plasticità per assorbi-mento d’acqua e le capacità diindurimento per cottura ad altetemperature, sfruttate appuntoper la produzione di laterizipieni da costruzione. Il rangecromatico dei laterizi varia quidal giallo paglierino al rossovivo, in funzione sia del tipo diargilla utilizzata sia della tempe-ratura raggiunta nella fase dicottura dell’impasto.
L’argilla si ritrova correntementeed abbondante sia in zone colli-nari che litoranee; non c’è quin-di da meravigliarsi se l’ediliziastorica nella regione presentiuna netta prevalenza dell’usodel laterizio in tutte le epoche.Dal Montefeltro al Piceno era
infatti prassi consolidata apriredelle fornaci in diretta vicinanzadei cantieri edilizi, anche di pic-cola dimensione, poiché eraverosimilmente più convenientesfruttare le limitrofe disponibi-lità di argilla per la fattura deimattoni che affrontare i costi ditrasporto di materiali prodottialtrove. Non esistevano infattidepositi di laterizi prefabbricatiprima della fine del XIX secolo:le piccole fornaci venivano crea-te appositamente per il cantieree poi subito demolite.
Dell’uso precoce di tale praticaedilizia si ha testimonianza negliantichi reperti di fornaci laterizieromane individuati presso i cen-tri di Aesis, Forum Sempronii,Septempeda, UrvinumMataurense, ed anche aPiobbico nel Montefeltro.E’ significativo l’osservare glistupendi disegni di cantiere diun grande architetto ed espertis-simo costruttore qual’era LuigiVanvitelli il quale, nei suoi vastiinterventi nel porto di Anconaper Clemente XII (1732-39), illu-stra sullo sfondo del complessocantiere del Lazzaretto numero-se fornaci attive e fumanti, da luiappositamente impiantate tra lelame caduche delle pendici diCapodimonte e nei vasti e mobi-li giacimenti argillosi delle colli-
12
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc ii
VVeedduuttaa aaeerreeaa ddeellllaa cciittttàà ddii CCoorriinnaallddoo:: ppaarraaddiiggmmaa ddeellll’’iimmmmaaggiinnee ““llaatteerriizziiaa””ddiiffffuussaa ddeeii cceennttrrii ssttoorriiccii mmaarrcchhiiggiiaannii
OOssiimmoo�� SSaannttuuaarriioo ddeellllaa BB VV ddii CCaammppooccaavvaalllloo�� iinngg CC CCoossttaannttiinnii�� ((��������������))
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:44 Pagina 12
SSeerrrraa ddeeii CCoonnttii�� llaa ssuuppeerrssttiitteeFFoorrnnaaccee HHooffffmmaann ddeell ���������� ooggggii
rreessttaauurraattaa ccoommee rreeppeerrttoo ddii aarrcchheeoo��llooggiiaa iinndduussttrriiaallee
13
ne di Posatora (attuale area dellaFrana Barducci).Il laterizio era essenzialmenteusato cotto, in piccole fornaci diterra occasionali e realizzato astampo in forme precostituite.La sua dimensione - specie nellospessore - risulta variabile neltempo, ma soprattutto in funzio-ne della disponibilità economicadella committenza. Le architet-ture civili ed ecclesiali di mag-gior prestigio presentano infattimattoni di minor dimensioni inspessore, mentre quelle militario di committenza più poverapresentano spessori maggiori,fin oltre i 9-11 cm. Ciò consenti-va un maggior risparmio neitempi della posa in opera: mag-gior spessore equivaleva aminor numero di positure deiricorsi. A ciò si aggiungeva unmaggior spessore delle maltenelle strutture più economiche,nelle quali la malta faceva aggiosul numero dei mattoni, conconseguente risparmio econo-mico ma con minor robustezzastatica delle murature. Dalperiodo medievale - e soprattut-to in condizioni di economiasfavorevole - tale modalità ese-cutiva, tesa al risparmio deimateriali, appare più evidentesia con l’uso di giunti orizzonta-li di malta più spessi, sia colriuso diffuso di mattoni di recu-
pero, frutto di demolizioni diprecedenti edifici, mattoni chevenivano poi “sagramati” incorso d’opera per accompagnar-ne le differenti porosità presentinelle coste a vista del paramen-to: una tecnica antica ma diffusaspecialmente in età barocca,attuata sfregando un mattoneduro su un impasto di calce vivabagnata che, diminuendone leasperità ne aumentava l’idrore-pellenza. Tale operazione ten-deva inoltre a correggere i difet-ti di posa, dovuti alla scarsa pro-fessionalità della mano d’opera,che risultavano particolarmenteevidenti nella mancanza dell’ap-piombo verticale dei muri. Varicordato in proposito che lamanodopera adibita alle struttu-re murarie primarie veniva con-tingentata spesso a forza tra lastessa popolazione rurale, loca-le od immigrata (qui special-mente dalla Padania o dallaDalmazia); popolazione nonnecessariamente specializzata intali lavori. Questa consuetudine,particolarmente evidente nellegrandi opere pubbliche di inte-resse collettivo (cinte murarie edarchitettura militare in genere,grandi edifici religiosi, ecc.),perdurerà per tutto il medioevoe sino oltre la metà delQuattrocento. Naturalmente perle murature di ampio spessore,
come quelle delle fortificazioni,
veniva utilizzata la tecnica del
muro a sacco, con riempimenti
di spezzature di vari materiali
eterogenei non più utilizzabili
per i paramenti, poi rifiniti e
sagomati esternamente con cor-
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc ii
OOssiimmoo�� SSaannttuuaarriioo ddeellllaaBB VV ddii CCaammppooccaavvaalllloo�� iinngg CC CCoossttaannttiinnii�� ((��������������))��ppaarrttiiccoollaarree ddeell ccoorrnniicciioonneeiinn ccoottttoo
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:44 Pagina 13
tine di mattoni, in funzione di“cassaforma”, che non supera-vano le tre teste. Anche se - ed ilrecente terremoto del 1997 lo hapurtroppo dimostrato - non erararo l’uso di tale tecnica poveraanche in edifici civili privati conmurature portanti di soli 40-50cm. di spessore. Inoltre, l’infil-trazione meteorica dall’alto deimuri a sacco - quando mal pro-tetti e/o non manutenuti - porta-va allo svuotamento progressivoed invisibile del legante del pez-zame interno, con conseguenticrolli improvvisi ed imprevistidell’apparecchio murario, spes-so in concomitanza di non infre-
quenti scosse telluriche.A partire dalla metà del XV seco-lo le amministrazioni comunalitenderanno, qui come altrove, acontrollare ed a legiferare sul-l’attività edilizia al fine di garan-tire un minimo di uniformità tracosti e qualità realizzativa dellemurature. Compariranno allora -incastonati sulle stesse facciateprincipali dei palazzi comunalimarchigiani - le prime forme emisure standardizzate dei prin-cipali elementi costruttivi: il mat-tone standard da muro, la pia-nella, il mazzocco, la canna ed ilbraccio di misura, il coppo unifi-cato, ecc. Alcune misure stan-dard pubbliche sono ancoravisibili, ad esempio, sul Palazzodella Signoria di Jesi, in quelloComunale ad Osimo, nellaLoggia dei Mercanti ad AscoliPiceno, sull’Arco di Traiano inAncona, ecc.
Tra XVII e XVIII secolo si nota-no tuttavia apparecchi murarimolto eleganti e ben allineati,che fanno riferimento a realizza-zioni coeve romane, special-mente negli edifici di commit-tenza dei facondi ordini religiosiriformati ed inurbati in epocabarocca (Gesuiti, Filippini,Barnabiti, Carmelitani, ecc.); ciòera favorito anche dai loro rap-porti con le ricche case-madri
romane, cui le congregazionimarchigiane facevano costanteriferimento, sia per le magistra-ture sia per la scelta dei presti-giosi progettisti: spesso architet-ti di gran fama ed esperienzaarchitettonica, catapultati suqueste terre dall’istituto pontifi-cio dell’“Architetto camerale”,questo almeno sino alla fine delXVIII secolo ed all’invasionenapoleonica. Il salto di profes-sionalità nell’architettura mar-chigiana in epoca tardo baroccae neoclassica è infatti evidente eben rilevabile dalla qualità dellerealizzazioni ecclesiali, dovenon è infrequente riscontrareperfetti paramenti laterizi “a cor-tina” dai giunti invisibili, degnidei capolavori dei maggioriarchitetti della Roma barocca.
Più in generale, il laterizio - apartire dalla prima metà delXVIII secolo - viene qui impie-gato sempre più diffusamentesia per la tessitura delle paretidegli edifici sia - per ragioni eco-nomiche ed in sostituzione dellevarie pietre - anche per la realiz-zazione dell’apparato decorati-vo architettonico: cornici di fine-stre e portali, marcapiani, corni-cioni abilmente sagomati, para-ste e lesene, ecc.. L’immagineurbana delle città marchigianeassumerà così, a partire dal
14
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc ii
AAnnccoonnaa�� cchhiieessaa ddeell GGeessùù�� ddii LLuuiiggiiVVaannvviitteellllii ((������))�� mmooddeelllloo nneelllleeMMaarrcchhee ddeell nnuuoovvoo lliinngguuaaggggiioo aarrcchhii��tteettttoonniiccoo ““rraazziioonnaalliissttaa”” bbaassaattoo ssuull��ll’’uussoo ddiiffffuussoo ddeell llaatteerriizziioo
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:44 Pagina 14
15
XVIII secolo, le caratteristichemateriche e cromatiche del late-rizio, che ne contraddistingue atutt’oggi la facies prevalente,soprattutto nell’edilizia minore;immagine che andrebbe preser-vata e tutelata, anche con unaapposita regolamentazionecomunale.
Negli edifici della fine del XVIIIsino a tutto il XIX secolo si notaun disegno progettuale piùaccurato e una ricerca di mag-giore qualità architettonica: ledifferenti pezzature dei laterizitendono a diminuire e ad unifor-marsi, significando tra la finedell’Ottocento e gli inizi delNovecento una progressivastandardizzazione ed industria-lizzazione del processo edilizio.Ciò avvenne anche con il diffon-dersi nella regione delle fornacicon la tecnologia produttivamessa a punto dall’ingegneretedesco Friedrich Hoffman (dal1857), in cui, come noto, la zonadi combustione si sposta oriz-zontalmente mentre la carica delmateriale rimane ferma, conparziale e profittevole recuperodel calore. Molte di queste carat-teristiche officine edilizie dell’e-poca della prima industrializza-zione, a pianta ellittica con altaciminiera centrale, sussistonoancora qua e là sul territorio e
costituiscono un interessantereperto di archeologia industria-le oggi da salvaguardare.Nello scorcio del secolo XIX sisperimenta anche la produzionedi pezzi laterizi decorati, conmodanature a stampo in stileneoromanico e neogotico, insintonia col gusto eclettico pre-valente di quel periodo, edanche l’uso diffuso di scialbarein opera il mattone cotto in poli-cromie, nelle scale dei rossi, perevidenziarne le differenti parti-zioni, specchiature ed incorni-ciature laterizie. L’esperienzadell’ing. Costantino Costantini diOsimo, progettista ed al con-tempo industriale dei laterizi, èparticolarmente significativa edesemplificativa nelle sue realiz-zazioni osimane, come ad esem-pio nel suo imponente santuarioneoromanico di Campocavallo(1893-98).
Possiamo quindi considerare lafacies prevalente dell’architettu-ra marchigiana post-classicacaratterizzata dall’uso diffusodel laterizio, sia in fase costrutti-va che in fase decorativa. Quelloche altrove ho definito lo “spar-tiacque vanvitelliano” costitui-sce forse l’esempio più eclatan-te, in termini qualitativi, dell’usodiffuso del laterizio come “lin-guaggio” architettonico, caratte-
rizzante e qualitativo nella
regione per i secoli a venire.
L’idea progettuale sottesa all'ar-
chitettura importata nelle
Marche dal Vanvitelli - specie
col modello della Chiesa del
Gesù in Ancona (1738) - con-
tempera ambedue le istanze
della scenografia barocca e della
razionalità costruttiva, caratteri-
stiche che potevano solo coagu-
larsi nella sua particolare storia
personale di raffinato disegnato-
re e di sapiente costruttore. Nel
suo creare edifici di alta qualità
compositiva e di costo contenu-
to, col solo uso del paramento
laterizio a faccia vista accostato
a pochi rilievi e sottolineature
cromatiche in bianca pietra cal-
carea, il Vanvitelli aprì ad una
vera e propria scuola di stile per
gli di architetti che ne prosegui-
rono e divulgarono l’intuizione
architettonica sino all’Unità
d’Italia, introducendo nelle
Marche il linguaggio compositi-
vo, ma anche materico, della
modernità europea.
AA rr cc hh ii tt ee tt tt oo nn ii cc ii
F. Mariano imp. 3.3.09 Lu 20-03-2009 17:44 Pagina 15