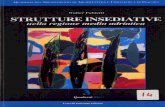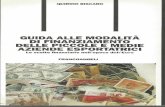Pasquale Favia, Scelte insediative, architettoniche e funzionali per le sedi del potere nella Puglia...
Transcript of Pasquale Favia, Scelte insediative, architettoniche e funzionali per le sedi del potere nella Puglia...
128
scelTe insediaTive, archiTeTToniche e funzionali Per le sedi del PoTere
nella Puglia seTTenTrionale in eTà medievale
diPasquale Favia
Nel medioevo, come più volte è stato sottolineato, le sedi del potere, ovvero le residenze signorili, nelle loro varianti e declinazioni (palazzi residenziali, rocche fortificate, centri amministrativi o soluzioni plurifunzionali, che assommavano cioè in un luogo fisico una molteplicità di mansioni e attività connesse ad un esercizio di autorità), furono portatrici, anche attraverso le loro manifestazioni edilizie, di una pluralità di valenze, significati e ragioni che investivano sfere e ambiti sfaccettati e diversi. Le funzionalità architettoniche rispondenti primieramente alle esigenze militari e residenziali si prestarono peraltro a dare riscontro e riflesso anche ai progetti di dominio territoriale e di possesso fondiario, all’affermarsi di prerogative istituzionali ed economiche, alla costruzione di reti e relazioni sociali, ai disegni di controllo sulle comunità, alla trasmissione di messaggi simbolici e modelli ideologici.
Nel medioevo dell’Italia meridionale, questo mosaico di segni materiali e immateriali si riconfigurò continuamente e progressivamente essendo intimamente interrelato ai processi di trasformazione dei paesaggi rurali e urbani, alla mutazione degli scenari umani e sociali, all’evoluzione delle forme di do-minio e conduzione terriera, ai cambiamenti istituzionali, alle differenziate condizioni giuridiche e proprietarie in cui queste stesse strutture si trovarono nel corso del tempo, alle variegate figure detentrici o comunque usufruttuarie di tali residenze (sovrani, alta aristocrazia, signorie locali, funzionari politici e amministrativi, entità religiose), portatrici di diverse istanze, concezioni, progetti, oltre che di risorse e disponibilità finan-ziarie. In altre parole, le sedi del potere risultano intensamente sensibili tanto alle vicende di medio e lungo periodo quanto ad accadimenti bellici e socio-politici di più rapida realizzazione.
Non diversamente da altri distretti del mezzogiorno d’I-talia, la Puglia settentrionale appare comprensorio progressi-vamente coperto da una fittissima trama di residenze signorili, variamente configuratasi e modellatasi nel corso del medioevo. recenti scavi e nuove operazioni di lettura stratigrafica degli elevati storici (in particolare per quanto riguarda il periodo fra XI e XIv sec.), integrati da un riesame dei risultati di indagine più datati, hanno fornito rinnovati contributi all’interpreta-zione archeologica dei caratteri delle dimore aristocratiche nella regione e dei significati sottesi alle loro architetture. tali contributi, per inciso, possono inoltre assumere un valore e interesse specifico di tutela e valorizzazione in considerazione del fatto che gli episodi edilizi castrensi e signorili dell’età di mezzo di capitanata giunti fino a nostri giorni, in alzati più o meno conservati e imponenti, sono organismi che spesso hanno perpetuato una loro significativa funzione insediativa e sociale nel corso del tempo, trasformandosi di conseguenza assai nettamente rispetto alle facies architettoniche originarie; le possibilità di ricomposizione e lettura delle fasi medievali sono state tenute in considerazione in modo assai diseguale nella stagione di restauro e recupero alla fruizione pubblica che pure recentemente queste stesse strutture hanno vissuto e che ne ha ulteriormente ritoccato le sembianze e la perce-zione visiva.
dal punto di vista strettamente archeologico, allo stato attuale, per epoca altomedievale si dispone di riscontri ancora solo sporadici o assai limitati per individuare eventuali spazi architettonici specificatamente deputati ad accogliere i detentori del potere e a marcare differenziazioni e gerarchie sociali, in un territorio in cui inoltre le zone di controllo politico da parte rispettivamente di Longobardi e Bizantini furono lungamente cangianti e mobili.
Nel dettaglio, per i territori gravitanti nell’orbita longo-barda, il patrimonio documentario lumeggia, attraverso una serie di menzioni, una trama di castra, castella ed oppida (per una rapida sintesi di queste citazioni si veda Licinio 1994, pp. 13-31; martin 1993, pp. 213-225) di una qualche consistenza, cui inoltre si aggiungono le curtes (sulla possibilità di indivi-duare archeologicamente tracce di una presenza dirigenziale all’interno di aziende agricole altomedievali daunie, si vedano le prime ipotesi per il sito di Faragola in volpe et al. c.s.); appare complicato nell’attuale status della ricerca archeologica trovare riflessi di specifici e autonomi spazi destinati alla dimora dei ceti dominanti, pure difficili da cogliere negli stessi documenti scritti, interni ai processi di fortificazione militari dei nuclei demici urbani e rurali.
Una fonte narra che nel 740 a Siponto il duca Gottschalk soggiornava in palatio (cSS III, 9); l’uso di questo termine de-linea dunque, verosimilmente, l’esistenza di una costruzione di tipo residenziale nel quadro delle strutture connesse alla difesa, in qualche maniera capace di marcare il ruolo del potere ducale nel tessuto urbano di questo centro costiero. Una carta datata quasi esattamente tre secoli dopo quella appena citata (intorno al 1045: cdtremiti II, doc. n. 35 pp. 111-116), tratteggia una stabile presenza del longobardo conte di Lesina tesselgardo nel castellum di Serracapriola, situato sulla riva sinistra del Forto-re, ovvero sulla linea di frontiera con i territori apuli soggetti all’impero d’oriente (lo stesso conte da questo castello si rese protagonista di un appello alla lotta contra Apulos vel Graecos, intrecciando dunque la sua presenza anche a ragioni di stretta natura politica e militare; si veda Fuiano 1972, pp. 14-15). Il piccolo centro di Serracapriola, conserva a tutt’oggi un com-patto edificio castrale a planimetria quadrangolare (de vita 1974, p. 65; si veda anche Fuiano 1978, pp. 30-31), dotato di tre torri cilindriche e una poligonale (quest’ultima realizzata in laterizi), che si presenta come una complessa stratificazione architettonica, che pure potrebbe avere trovato origine fra fine X e XI sec. (ipotesi che necessiterebbe però di una verifica di scavo o di analisi approfondita degli elevati).
Queste fugaci suggestioni documentarie, distribuite su una parabola cronologica di lungo spettro, possono dunque ispirare l’ipotesi che negli ambiti cittadini più rilevanti della Puglia settentrionale si sia sviluppata un’architettura di tipo palaziale, legata all’aristocrazia e al ceto dirigente longobardo, capace di qualificarne ruolo e presenza, mentre nei piccoli insediamenti fortificati (in particolare se più esposti lungo gli assi confinari) l’eventuale spazio residenziale e di soggiorno di figure esercitanti il potere si sia configurato come polo protetto e difeso, con-nesso e contestuale all’intero meccanismo di fortificazione del sito. La valutazione archeologica di questo percorso di ricerca peraltro manca ancora di elementi significativamente probanti: del resto, gli scavi e le ricerche che hanno interessato aree di popolamento coinvolte, a vario titolo e in tempi diversi, nelle forme di controllo longobardo (si possono citare i casi monte S. Giovanni, monterotaro, la stessa canne), hanno offerto contributi limitati in tal senso rispetto alle conoscenze offerte per le fasi bassomedievali.
Anche per i quadri insediativi in cui agirono, pure in questo caso in tempi differenziati, meccanismi istituzionali e consue-tudini costruttive di stampo più accentuatamente bizantini, si dispone di menzioni del termine palatium: a Lucera appunto una costruzione così definita viene citata nel 998; tale palazzo è stato considerato sede dei funzionari imperiali e, come tale, non necessariamente fortificato (von Falkhenhausen 1973, p. 402).
Lo scavo effettuato a vaccarizza (cirelli, Noyé 2003), in-sediamento subappenninico, non lontano da troia, che compa-re nelle fonti alla fine del X sec. e che viene talora appellato come città (martin 1990, p. 181), ha porto un significativo sussidio archeologico alla conoscenza delle residenze e delle architetture del potere in contesto bizantino. All’interno del perimetro del sito, a un vertice dello sviluppo insediativo fortificato, si è rin-tracciato l’andamento irregolarmente poligonale di un recinto chiuso, realizzato in muratura. Il carattere costruttivamente
129
solido e la fisionomia protetta del complesso hanno spinto ad avanzare una ipotesi di classificazione tipologica della struttu-ra come una cittadella munita, quasi una sorta di praitôrion, distinto in un settore produttivo e in uno residenziale. In realtà questo termine indica generalmente edifici residenziali dell’alto notabilato, quale la sede catepanale a Bari o quello dello stratega di tema come a reggio calabria (un praitôrion era forse presente anche a catanzaro: sintesi delle menzioni in von Falkenhausen 1978, p. 151). L’ipotesi di identificazione di un solido nucleo protetto e fortificato, accostabile a entità di natura pretorile all’interno di una realtà insediativa oscillante fra la condizione di città secondaria e di stanziamento castrale come vaccarizza, prefigura di fatto la possibilità che un’aristo-crazia di funzionari e di notabili bizantino possa avere avviato fra X e XI sec. tentativi di acquisizione di autonomi spazi di potere, di cui l’edificazione di cittadelle fortificate potrebbe aver costituito una concretizzazione (questo processo viene supposto in cirelli, Noyé 2003, p. 484; Noyé 1998 p. 115; ancora nel 1174 il termine pretorium viene adoperato per iden-tificare un corpo di fabbrica, forse il castello, di Sannicandro Graganico: cdtremiti 116). Per quanto riguarda altri siti di fondazione o frequentazione bizantina indagati nella regione, non si dispone di indizi chiari rispetto a questa dinamica (che non è stata accertata a Fiorentino ed ancora in fase di verifica per montecorvino).
Lo stesso scavo di vaccarizza documenta inoltre il passaggio dall’edilizia di potere bizantina alla struttura castrale di epoca normanna. Questo processo si realizzò attraverso la quasi totale obliterazione della prima (conservata solo nella funzione di sostruzione per nuove edificazioni) e la messa in opera di un apprestamento in terra dai caratteri rispondenti ai tratti della tipologia motte and bailey; sull’imponente rialzo artificiale (ai piedi del quale si estendeva il polo demico), circondato da un fossato, fu eretta una torre in legno, poi trasformata in pietra (cirelli, Noyé 2003, pp. 484-485, fig. 5).
La dinamica innescatasi in questo sito del Subappennino daunio appare sufficientemente espressiva dell’allargamento di orizzonti realizzatosi fra tardo XI e XII sec., nella gamma delle realizzazioni castrali ed anche nelle modalità di presenza sul territorio delle classi dirigenti (ben al di là delle prefigurazioni elaborate in epoca bizantina); in questa piega cronologica la formazione di un nuovo dominio signorile, territoriale e fondia-rio, dettò anche l’urgenza della protezione militare degli stessi signori, del loro controllo sulla popolazione e i centri demici, della formazione di spazi residenziali ad essi deputati. Per un analisi archeologica di questi movimenti sono significative le numerose tracce aerofotografiche di stanziamenti, ora scomparsi, ubicati nella pianura del tavoliere e sui monti della daunia (talora ancora in parte leggibili anche ad un esame ricognitivo di superficie) che denunciano l’esistenza di settori distinti rispetto all’intero sviluppo topografico dell’insediamento, verosimilmen-te di status gerarchicamente superiori agli altri settori abitativi del borgo, dai quali risultano distinti anche fisicamente, per il tramite di un proprio autonomo sistema di difesa, costituito da un fossato e terrapieno, integrati eventualmente da una cinta muraria che si collegava generalmente al più ampio perimetro fortificato del polo insediativo. La cronologia di frequentazione di questi siti e della formazione del nucleo castrense è spesso difficilmente individuabile su base esclusivamente diagnostica; in alcuni casi essa potrebbe risalire anche al X – inizi XI sec e dunque inquadrare qualche episodio di queste modellazioni topografiche già in ambito bizantino, mentre per la maggior parte di essi, verosimilmente realizzati fra fine XI e XII sec., pure andrebbero verificati caso per caso i tempi di formazione dei settori castrensi rispetto a quelli abitativi, ovvero i rapporti di contemporaneità, antecedenza o successione intercorrenti fra il nucleo militare-signorile e il polo demico (su questi temi si rimanda a Favia, maruotti c.s.). In ogni caso, la costellazione di insediamenti urbani e rurali muniti di rocche, castra, palatia (il termine palatium viene utilizzato ancora nei casi di monte S. Angelo e Lesina, rispettivamente nel 1083 e 1141, forse per indi-care i castelli dei due centri: martin 1993, p. 275. A S. Lorenzo,
lo stesso termine identifica verosimilmente, fra XIII e XIv sec., una residenza di proprietà vescovile: martin, Noyé 1987, p. 67, note 49-50) che fra fine XI e prima metà del XII sec. si forma nel paesaggio daunia pare rappresentare la ricaduta insediativa della combinazione fra il compimento dello stanziamento militare dei Normanni nella regione e l’elaborazione di nuove forme di gestione del territorio e di controllo sociale e dell’intersecazione fra la formazione dei poteri signorili fortemente agenti su ambiti locali e tentativi di governo accentrato da parte della monarchia. I caratteri di questo tessuto castrense furono declinati nella Puglia settentrionale in varianti topografiche e costruttive determinate da diversi fattori, quali l’orografia dei siti di installazione, il peso della signoria promotrice o detentrice, la natura e ampiezza dei territori di pertinenza.
Lo studio delle tracce materiali delle residenze coinvolte in questo disegno di distribuzione dei poteri nella capitanata può essere intrapreso sia attraverso l’analisi dei lacerti strutturali e delle stratigrafie verticali ancora leggibili nei complessi ca-stellari a lungo periodo di uso e frequentazione sia attraverso occasioni di scavo che analizzino corpi di fabbrica rientranti in questa tipologia. oltre al citato caso di vaccarizza, disponiamo delle informazioni relative all’insediamento di Fiorentino, sulle primissime pendici dei monti della daunia. Questo abitato fortificato si connota per una topografia estesa su un pianoro, ad un vertice del quale si ubica, in posizione sopraelevata, un imponente edificio, protetto da un fossato e da terrapieno, eretto in età sveva verosimilmente su un preesistente impianto normanno, dalle caratteristiche però solo parzialmente ricom-ponibili: in questo caso dunque il processo di creazione di un polo di stanziamento del nucleo dirigente dello stanziamento, protetto e difeso.
Lo scavo attualmente in corso sul sito di montecorvino (Favia et al. 2009), dalle condizioni orografiche e insediative non dissimili da quelle della vicina Fiorentino, può fornire qualche altro suggerimento sui tratti residenziali, militari, simbolici assunti dai luoghi di presenza e soggiorno di figure detentrici di ruoli potere nei contesti cronologici e culturali di XII-XIII sec. nella Puglia settentrionale. Anche in questo esempio, ad una estremità del terrazzo sommitale di una lieve altura, si erge una rocca, distinta dal borgo per il tramite di un fossato e innalzata su un poggio che le prime analisi di scavo paiono qualificare di natura artificiale (figg. 1-2). Su questo rialzo di terreno si stanno ricomponendo stratigraficamente i resti e i contorni di un organismo castrense, sottoposto ov-viamente nel corso del tempo a dinamiche di trasformazione dei suoi caratteri costruttivi e delle sue stesse forme e valenze d’uso. La ricerca archeologica ha delineato le prime tracce di un recinto murario (forse quadrangolare, verosimilmente lungo in senso N-S intorno ai 28 m. circa e in senso E-o non meno di 25). Al vertice sud-orientale di questo perimetro murario si ubicano le imponenti vestigia di una torre di planimetria quasi quadrata (lati di 12 e 11 m), alta non meno di 24 m., articolata verosimilmente su quattro livelli (figg. 1A-2A). Una seconda torre si situa sul ciglio settentrionale del poggio; essa presenta forma pentagonale (9×8 m) con puntone rivolto a oriente con muri assai robusti, spessi circa 2,5 m, che riducono lo spazio interno utilizzabile a un quadrato di lato di 3 m (figg. 1B-2B).
La posizione e il pronunciato sviluppo in altezza delineano con evidenza il ruolo cruciale della torre meridionale nel di-spositivo militare castrense; tuttavia l’articolazione in quattro piani, una certa cura adottata in alcuni particolari architettonici (cornici degli accesi e delle finestre, gli stessi cantonali), portano a non escludere (anzi, forse, suggeriscono) la possibilità che questa fabbrica unisse alla natura difensiva una destinazione residenziale per un signore e la sua famiglia, o la sua cerchia di dipendenti. La struttura turrita settentrionale ha invece spessori murari e misure degli spazi interni che ne denunciano una funzione difensiva e di servizio (il piano inferiore è costituito da una cisterna voltata, profonda circa 3,5 m), incompatibile con una di tipo abitativo. Le prime tracce stratigrafiche e l’analisi degli elevati della torre meridionale (Giuliani, Favia 2007, pp. 138-148) inducono verso una possibile datazione dell’impianto
130
castrale ad un’avanzata epoca normanna, cui fecero seguito vari apprezzabili interventi di modifica e aggiustamento; la struttura pentagonale della torre settentrionale trova del resto compara-zione in area garganica, nel castello di monte S. Angelo, le cui fortificazioni sono dotate apunto di una torre irregolarmente pentagonale (lunga sino a 10,60 m e larga 6,20 m, con spessori di 3,70 m), ipoteticamente attribuita al secondo quarto del XII sec. (de vita 1974, pp. 58-59, fig. 42).
L’analisi archeologica, seppure in fieri, del sito di montecor-vino suggerisce dunque l’emersione in capitanata nel corso del XII sec. di una tipologia delle sedi signorili decisamente con-notata in senso militare, come palesa il recinto murato dotato di torri, situato marginale rispetto all’estensione dell’abitato e diviso da esso da un fossato. Questo diaframma fra rocca e polo demico manifesta come il sistema difensivo contemplasse tanto elementi apprestati contro le minacce provenienti dall’esterno quanto soluzioni mirate a uno stretto controllo sullo stesso abitato (Giuliani, Favia 2007, p. 148; Favia 2010, pp. 23-
224; Favia, maruotti c.s., ma già martin, Noyé 1988, p. 522); le stesse finestre a feritoia che guardano verso il borgo paiono sottolineare la sovrapposizione della preoccupazione per l’ordine sociale interno alle cautele rispetto alle minacce provenienti dall’esterno. Uno schema di questo genere sembra ritrovarsi sostanzialmente anche nel vicino centro di Pietra (ora Pietramontercorvino), il cui recinto murario originario è corredato da un’alta torre cui si contrappone un più basso corpo di fabbrica rettangolare (alle cui spalle inoltre si ubica una chiesa; Giuliani et al. 2009, pp. 779-780, fig. 1). Le torri dunque e i corpi di fabbrica interni ai recinti fortificati pure paiono avere riservato spazi residenziali e domestici per una presenza stabile o soggiorni prolungati della famiglia signorile o comunque di un nucleo di notabili (esse inoltre potevano essere caricate anche di una valenza simbolica: sul ruolo delle motte a questo proposito si veda martin, Noyé 1988, p. 522).
Questo modello tipologico e insediativo trova echi anche in alcune realtà cittadine di maggiore importanza e in vari castra
fig. 1 – Planimetria dell’area castrense del sito di Montecorvino (FG) (a cura di E. Battiante, O. Pastore, F. Stoico, F. Monaco).
131
del tavoliere, ma naturalmente è affiancata da altre soluzioni nel territorio apulo che variamente privilegiano il carattere militare o quello abitativo; numerose torri di una certa imponenza in effetti punteggiano il paesaggio di capitanata, peraltro collocan-dosi variamente sul piano cronologico e talora assumendo più decisamente un carattere difensivo o semaforico (a vaccarizza, p. es., la torre è affiancata da un’aula, distinguendo forse net-tamente ambienti residenziali e spazi difensivi; cirelli, Noyé 2003, p. 485). Lo schema dunque sembra essersi originato in età normanna, in stretto rapporto con i mutamenti di orizzonte e prospettiva delle forme di dominio territoriale, di potere fondiario e di prelievo e sfruttamento economico delle risorse naturali e ambientali che dalla fine dell’XI sec. si realizzarono in larga parte dell’Italia meridionale e nello specifico nella Puglia settentrionale. Esso inoltre si perpetuò in certa misura nel XIII sec. in ambito svevo e angioino; un esempio di questo svilup-
fig. 2 – Fotografia aerea dell’area castrense del sito di Montecorvino (FG) (a cura di M. Campese, M. Maruotti).
fig. 3 – Planimetria della domus di Fiorentino (FG) (da Beck 1998, p. 149, fig. 2).
po proviene ancora dagli scavi di montecorvino, che hanno individuato (in una fase ancora da verificare nel dettaglio ma appunto collocabile verosimilmente nel corso del XIII sec.) l’edificazione di una chiesetta, mononave e monoabsidata, cui si accedeva esclusivamente da un fianco, ovvero dal lato a quasi diretto contatto con la torre meridionale (figg. 1c-2c). La fondazione una cappella interna al recinto signorile, una sorta di ecclesia palatina (cui si affianca inoltre un ambiente che accoglie un silos granario), pare un forte segno della volontà di accentuare il carattere di residenza aristocratica della rocca di montecorvino, dotandola di un attributo di forte connotazione dal punto di vista dello status sociale.
In questo processo di continua traduzione architettonica delle esigenze, delle scelte e dei caratteri dei poteri insediatisi nella regione daunia, si innestò l’esperienza legata all’azione dell’imperatore Federico II. Nella geografia delle decisioni po-litiche del sovrano nel regno ebbe, come noto, una posizione rilevantissima la capitanata, mentre fu certamente centrale nella sua strategia la scelta del diretto intervento della corte sulla regolazione e amministrazione della rete dei castelli; essi furono utilizzati in senso oltre che strumentale anche simbolico, come concreta manifestazione di una cultura della sovranità e come modalità cruciale della trasmissione pubblica dell’ideologia, dell’esercizio e degli attributi del potere. A proposito di questa trama di castelli, domus e palatia, gli studi hanno analizzato il suo inquadramento dal punto di vista insediativo e amministra-tivo (il «sistema castellare svevo»: Licinio 1994, pp. 117-194), sul piano dei nessi fra topografia e cornice politico-istituzionale (martin 1985), nell’ottica delle opzioni costruttive, tipologiche e della cultura architettonica (Willemsen 1979; cadei 1994), nella visuale delle manifestazioni artistiche e simboliche della concezione sveva della regalità (marino Guidoni 1980; calò mariani 1994; 1995). Sul versante archeologico, in capitanata si dispone di due riscontri di scavo inerenti residenze erette o radicalmente ristrutturate da Federico II e spesso citate nelle fonti con l’appellativo di domus.
Lo scavo di Fiorentino, come si è già accennato, ha esa-minato i resti di una costruzione di età sveva che si innesta su una preesistenza verosimilmente di epoca normanna; essa si dislocava, secondo la griglia topografica precedentemente descritta, ad un vertice dello sviluppo del sito, protetto da un fossato. La ricomposizione del corpo di fabbrica (Beck et al. 1989, pp. 667-678, tavv. vII-XI; Beck 1989; Id. 1998) raffi-gura una planimetria articolata in due ambienti rettangolari (su una misura complessiva di 29×17 m), allungati e giustapposti, seppure leggermente sfalsati (figg. 3-4). Questi ampi vani erano scanditi da arconi che ne ritmavano la spazialità e la volumetria (solo più tardi furono innalzati dei tramezzi, in corrispondenza degli arconi stessi), con tutta probabilità privi di finestre, ma dotati di camini e di pavimentazione in laterizi; essi si confi-gurano dunque, verosimilmente, quali vaste sale di accoglienza e di riunione, legate alle necessità e alla logistica delle corte regia. La stratigrafia dei depositi di crollo lascia immaginare l’esistenza di un piano superiore, munito di aperture per la luce e impreziosito da arredi architettonici; il livello superiore appare dunque riservato agli spazi privati del sovrano. L’edificio dunque denuncia un’accurata attenzione alla qualità costruttiva e artistica e ad un habitat confortevole, mentre le accortezze di tipo protettivo paiono limitate alla solidità delle strutture e alla salvaguardia degli ingressi, riparati e alcuni modellati in forma di chicane, oltre che allo sfruttamento dei fossati e dei terrapieni creati in precedenza, verosimilmente in fase normanna, e della cinta murata urbana.
Uno schema in qualche misura rapportabile a quello di Fio-rentino si ritrova a ordona, castrum situato nel pieno tavoliere. Anche in questo caso la domus sveva fu installata nella zona più elevata dell’insediamento medievale, al suo vertice nord-occidentale, sfruttando una preesistenza; in questo esempio peraltro, la peculiare e radicale opzione architettonica adottata fu (secondo la ricostruzione proposta dagli autori dello scavo: mertens 1985 a-b; Id. 1998) quella della trasformazione in chiave residenziale di una chiesa. La planimetria trinave della
132
fig. 4 – La domus di Fiorentino (vista da Sud-Est).
fig. 5 – La domus di Ordona (1. struttura ecclesiale originaria; 2. Tra-sformazione in domus; 3. Ulteriori modifiche (da mertens 1995, p. 357, fig. 359).
costruzione religiosa fu modificata per realizzare un ampia sala longitudinale centrale (nuovamente cadenzata da archi) fiancheggiata da due vani più stretti (fig. 5).
All’interno della articolate, complesse e differenziate scelte architettoniche in campo castrale e palaziale effettuate dall’impe-ratore Federico II, la ricerca archeologica dunque ha consentito di documentare in capitanata due esempi materiali di residenze del sovrano svevo: esse ineriscono a una tipologia che pare mo-dellata per rispondere primieramente alle necessità di garantire soggiorni confortevoli al sovrano e alla corte; la difesa di queste fabbriche appare affidata oltre che all’eventuale presenza armati, al fossato e al terrapieno che recingevano l’area, piuttosto che a loro dotazioni edilizie. Questi due episodi dauni costituiscono un riflesso e una conferma della predilezione nelle architetture di committenza sveva per planimetrie composte da sale di forma rettangolare allungata, scandite da arconi, soluzione che trova eco in Sicilia, in altre costruzioni attribuite ad epoca federiciana e ipoteticamente identificate come residenze reali, come il palazzo di milazzo, il “castelluccio” di Gela e quello di “Lombardia” di Enna (maurici 1997, pp. 323-326, 332-346, figg. 78-79; Bruschi, miarelli, mariani 1975, pp. 158-161, 179-182: si vedano anche le ampie sale dei castelli di Gravina e Lagopesole: Willemsen 1979, p. 20, fig. 1; Peduto 2000, pp. 21-24).
La capitanata risulta la regione dell’Italia meridionale a più alta densità di castelli sotto il controllo del sovrano: essi si contraddistinguono peculiarmente per la varietà tipologica e morfologica ed anche per la diffusione geografica e insediativa. Il sistema si diramava infatti nei contesti urbani principali o emergenti (p. es. i palazzi di Foggia e Lucera), nei centri demici secondari o nei borghi murati (abbiamo visto o casi di Fiorentino e ordona), e inoltre in episodi più isolati nel territorio e immersi nel paesaggio (si pensi a Belvedere sul Gargano o all’Incoronata nel tavoliere), ovvero domus che rispondevano anche al soddisfacimento di alcuni interessi e attività tipicamente rientranti nei requisiti e negli attributi dei poteri medievali (solacia, rapporto con la natura, esercizio della caccia), qualificandosi spesso per particolare pregio architetto-nico e ambientale. La rete residenziale in realtà toccava anche le aziende rurali del sistema produttivo di controllo demaniale in capitanata, ovvero le masserie regie, che punteggiavano la regione; emblematico appare il caso di Sala, per il quale le fonti scritte narrano di un palacium soleratum cum camera, inserito in un complesso di edifici legati però ad attività agricole e di allevamento (Quaternus, pp. 51, 62-63, 71).
di questa situazione si può forse cogliere un riverbero ar-cheologico nello scavo effettuato nei pressi di Foggia, in località Pantano (Favia et al. c.s.), toponimo che rievoca una delle più celebrate e sontuose residenze volute da Federico II, una soluzio-ne insediativa che sposava costruito e architettura del paesaggio. Le indagini hanno in effetti esaminato due aree ravvicinate: in quella più orientale si sono riscontate tracce di tipo mobile (frammenti architettonici e scultorei) verosimilmente riferibili appunto alla domus Pantani (di cui non sono però state ritrovati elementi strutturali), mentre in quella più occidentale si sono analizzati resti di imponenti corpi di fabbrica in pietra, verosi-milmente inerenti a una funzionalità di immagazzinamento e conservazione di beni agricoli o stabulari, abbinati a una fitta serie di vestigia di recinti e ambienti realizzati in legno, ovvero in materiale deperibile (una masseria regia è in effetti attestata in questa zona, almeno da età angioina).
L’esempio di Pantano conferma la varietà dei dati storici e archeologici disponibili per il tema di studio dei caratteri delle sedi del potere in capitanata in età sveva; le residenze regie paiono essersi articolate in una casistica sfaccettata, in cui ad episodi rispondenti ad una logica di affermazione dell’esclusività, separatezza e distacco rispetto alla comunità e alle collettività civiche, si affiancavano realtà che, ubicandosi fisicamente sin nelle pieghe degli insediamenti rurali e del paesaggio daunio (si pensi al succitato fenomeno delle domus presso le masserie), trasmettevano un segnale di immanenza, pervasività, capacità di controllo capillare dello stesso potere, sul popolamento, sul territorio e sulle sue risorse, suggerendo
inoltre, attraverso le strutture materiali castrensi, la percezione pubblica di questa presenza. Questa pluralità di ruoli, valenze e significati si risolveva di conseguenza in opzioni costruttive diverse e duttili, sia dal punto di vista dell’accentuazione dei caratteri militari piuttosto che di quelli residenziali, sia nella qualità tecnica e architettonica delle fabbriche che nel loro rapporto con l’ambiente circostante.
Il quadro proposto dalle indagini archeologiche sulla ca-pitanata medievale qualifica questo comprensorio come uno spazio geografico ben espressivo della complessità, pluralità e densità di valenze, di trasformazioni e di relazioni che le archi-tetture del potere (castelli, palazzi, etc.) hanno assunto nel corso
133
del medioevo stesso. Questa molteplicità di senso e di portati storici ci pare infine confermare la necessità che un approccio di studio a queste entità e a questi temi scientifici debba muo-versi nella consapevolezza di tale pluralità, senza privilegiare a priori solo una parte di questo sfaccettato insieme di significati materiali, sociali, economici, politici, ideologici, simbolici.
Bibliografia
Beck P. 1989, Archeologia di un complesso castrale: Fiorentino, «Arche-ologia medievale», 16, pp. 137-154.
Beck P. 1998, La domus imperiale di Fiorentino, in c.d. Fonseca (a cura di), castra ipsunt possent et debent reparari. Indagini cono-scitive e metodologie di restauro delle strutture castellane normanno-sveve, 2 voll., roma, I, pp. 144-152.
Beck et al. 1989 = Beck P., calò mariani m.S., Laganara Fabiano c., martin J.-m., Piponnier F., Cinq ans de recherches archéo-logiques à Fiorentino, «mélanges de l’Ecole française de rome. moyen Age-tempes modernes», 101, pp. 641-699, tavv. I-Xv.
Bruschi A., miarelli mariani G. (a cura di) 1975, Architettura sveva nell’Italia meridionale. Repertorio dei castelli federiciani. catalogo della mostra (Prato, Palazzo Pretorio, maggio-settembre 1975), Firenze.
cadei A. 1994, I castelli federiciani: concezione architettonica e realiz-zazione tecnica, in P. toubert, A. Parravicini Bagliani (a cura di), Federico II e le scienze, Palermo, pp. 253-271.
calò mariani m. S. 1994, L’arte al servizio del potere, in P. toubert, A. Parravicini Bagliani (a cura di), Federico II e le scienze, Palermo, pp. 123-145.
calò mariani m. S. 1995, Lo spazio dell’ozio e della festa, in m. calò mariani, r. cassano (a cura di), Federico II. Immagine e potere. catalogo della mostra (Bari, 4 febbraio-17 aprile 1995), venezia, pp. 357-363.
cdtremiti = Codice Diplomatico del monastero benedettino di Tremiti (1005-1237), a cura di A. Petrucci, 3 voll (FSI 98) roma 1960.
cirelli E, Noyé Gh 2003, La cittadella bizantina e la motta castrale di Vaccarizza (scavi 1999-2002), in r. Fiorillo, P. Peduto (a cura di), III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Salerno, 2-5 ottobre 2003), 2 voll, Firenze, I, pp. 481-486.
cSS = chronicon Sanctae Sophiae: (cod Vat. Lat. 4939), a cura di J.-m. martin, 2 voll., Fondi per la Storia dell’Italia medievale 3, roma 2000.
de vita r. (a cura di) 1974, Castelli, torri ed opere fortificate in Puglia, Bari.
Favia P. 2010, Dalla frontiera del Catepanato alla “Magna Capitana”: evoluzione dei poteri e modellazione dei quadri insediativi e rurali nel paesaggio della Puglia settentrionale fra X e XIII sec., «Archeologia medievale», XXXvII, pp. 197-214.
Favia P. et al. 2009 = Favia P., Giuliani r., mangialardi N. m., Stoico F. 2009, Indagine archeologica sul sito di Montecorvino nel Subappennino daunio: primi scavi della cattedrale e dell’area castrense, in G. volpe, P. Favia (a cura di), V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Foggia-manfredonia, 30 settembre-1 ottobre 2009), Firenze, pp. 373-381.
Favia P., maruotii m., c.s., Valutazioni di superficie e casi di scavo per la definizione dei caratteri insediativi delle recinzioni e fortificazioni di terra nella Capitanata medievale, in Fortificazioni di terra in Italia: motte, tumuli, tumbe, recinti, Atti del convegno Internazionale di Studi (Scarlino [Gr], 14-16 aprile 2011).
Fuiano m. 1972, Città e borghi in Puglia nel Medio Evo I, Napoli.Fuiano m. 1978, Castelli in Puglia nei secoli X-XIII, «Archivio Storico
Pugliese», XXXI, pp. 25-45.Giuliani 2009 et al. = Giuliani r., caracuta v., Fiorentino G.,
Pignatelli o., Prime ricerche nella torre medievale di Pietramon-tecorvino (FG): un approccio integrato tra esame archeologico delle architetture e analisi paleocologiche, in G. volpe, P. Favia (a cura di), V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Foggia-man-fredonia, 30 settembre-1 ottobre 2009), Firenze, pp. 789-794.
Giuliani r., Favia P. 2007, La “sedia del diavolo”. Analisi preliminare delle architetture del sito medievale di Montecorvino di Capitanata, «Archeologia dell’Architettura», XII, pp. 133-159.
Licinio r. 1994 Castelli medievali. Puglia e Basilicata: dai Normanni a Federico II e Carlo D’Angio, Bari (2010).
marino Guidoni A. 1980, Architettura, paesaggio e territorio dell’I-talia meridionale nella cultura federiciana, in A.m. romanini (a cura di), Federico II e l’arte del Duecento italiano, Atti della III Settimana di Studi di Storia dell’Arte medievale dell’Università di roma (roma 15-20 maggio 1978), 2 voll., Galatina, I, pp. 75-98.
martin J.-m. 1985, Pouvoir, géographie de l’habitat et topographie urbaine en Pouille sous le regne de Fréderic II, «Archivio Storico Pugliese», XXXvIII, pp. 61-89.
martin J.-m. 1990, Troia e son territoire ai XIe siècle, «vetera chri-stianorum», 27, pp. 175-201.
martin J.-m. 1993, La Pouille du VIe XIIe siècle, Paris-rome.martin J.-m., Noyé Gh. 1987, L’evolution d’un habitat de plaine
jusq’au XIV siècle: l’exemple de San Lorenzo in carminiano, in Fiorentino. Campagne di scavo 1984-1985, Galatina, pp. 63-78, tavv. LXXXIX-Xc.
martin J.-m., Noyé Gh. 1988, Habitats et systèmes fortifiés en Capi-tanate. Première confrontation des données textuelles et archéologi-ques, in Gh. Noyé (a cura di), castrum 2. Structures de l’habitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens. Les méthodes et l’apport de l’archeologie extensive, Actes de la rencontre organisée par l’Ecole française de rome (Paris, 12-15 novembre 1984), rome-madrid 1988, pp. 501-526.
maurici F. 1997, Federico II e la Sicilia. I castelli dell’Imperatore, catania.
mertens J. 1995, Il Medioevo, in J. mertens (a cura di), herdonia. Scoperta di una città, Bari, pp. 353-369.
mertens J. 1995, Il «castellum» di Ordona, in m.S. calò mariani, r. cassano (a cura di), Federico II. Immagine e potere. catalogo della mostra (Bari, castello Svevo 4 febbraio, 17 aprile 1995), venezia, pp. 197-205.
mertens J. 1998, Il Castello di Ordona: domus solaciorum di Federico II?, in c.d. Fonseca (a cura di), castra ipsunt possent et debent reparari. Indagini conoscitive e metodologie di restauro delle strutture castellane normanno-sveve, 2 voll., roma, I, pp. 153-174.
Noyé Gh. 1998, La Calabre entre Byzantine, sarrasins et Normands, in J.-m. martin, E. cuozzo (a cura di), Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull’Italia normanna in memoria di Léon-Robert Menager, roma-Bari, pp. 90-116.
Peduto P. 2000, Lo scavo archeologico, in A. Giovannucci, P. Peduto (a cura di), Il castello di Lagopesole da castrum a dimora reale. Visita al castello e guida alla mostra, Salerno.
Quaternus = Quaternus de excadenciis et revocatis Capitinatae de man-dato imperialis maiestatis Friderici secondi, a cura di A.m. Amelli, montecassino 1903.
von Falkenhausen v. 1973, Zur byzantinischen Verwaltung Luceras am Ende des 10. Jahrundert, «Quellen und Forschungen aus ita-lienischen Archiven und Biblioteken», 53, pp. 395-406.
von Falkenhausen v. 1978, La dominazione bizantina in Italia me-ridionale dal IX all’XI secolo, Bari (traduz. ital. dall’orig. tedesco: Untersuchungen über die Byzantinische Herrschaft in SüdItalien von 9 bis 11 Jahrundert, in Schriften zur Geistegeschichte des östlichen Europa, Wiesbaden 1967).
Willemsen c.A. 1979, I castelli di Federico II nell’Italia meridionale, Napoli (traduz. Ital. dall’orig. tedesco: Die bauten Kaiser Friedrichs II in Süditalien, Stuttgart 1977).
volpe et al. c.s. = volpe G., turchiano m., de venuto G., Goffredo r., L’insediamento altomedievale di Faragola. dinamiche insediative, assetti economici e cultura materiale tra VII e IX secolo d.C., in La trasformazione del mondo romano e le grandi migrazioni: nuovi popoli dall’Europa settentrionale e centro-orientale alle coste del Mediterraneo, Atti del convegno (cimitile-Santa maria capua vetere, 16 giugno 2011).