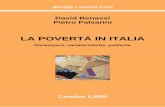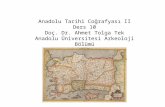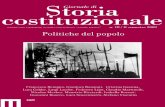Cristianizzazione e scelte politiche : il caso della Caria (Lecture)
-
Upload
pontificalorientalinstitute -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Cristianizzazione e scelte politiche : il caso della Caria (Lecture)
Cristianizzazione e scelte politiche: il caso della Caria
Ebbi modo lo scorso anno di parlare su "Possanza ed ambiguità a Bisanzio: la legge, la chiesa";
non ripeterò quanto detto in quella occasione. Eviterò, inoltre, un orizzonte molto ampio - impero bizantino
- per non cadere in facili generalizzazioni; mi fermerò ad un vasto territorio, la Caria, che da parte sua
documenta processi e sintomi riscontrabili in gran parte dei territori dell'Asia Minore. Escludo, per ovvie
ragioni, tutti і dati relativi all'evangelizzazione in Asia Minore, iniziando da S. Paolo per terminare coi
martirologi e synassario.
Nell'editto di Tessalonica (Cunctos populos: C.Thoed. XVI,1,2 del 380) il legislatore pone la
religio (termine giuridico) che l'apostolo Pietro ha trasmesso ai Romani (termine giuridico) come lex per
tutto il popolo a lui sottomesso. La istituzionalizzazione della Christiana religio esige una separazione fra la
"buona novella" (εναγγέλιον), intesa come annunzio gratuito, e la lex, che, per sua natura, obbliga; e questo
sia detto pur se nell'editto, per esplicare il nuovo Dio, trino ed unico, il legislatore fa appello alla apostolica
disciplina et euangelica doctrina, cioè all'enunciato dogmatico di Nicea I. Da aggiungere a proposito che
Teodosio nel suo editto prende vescovi isolati come referenti per la Christiana religio; bisogna aspettare
Marciano e poi Giustiniano per avere il concilio ecumenico come punto di riferimento. Si tratta allora di
scelte politiche - legislative - che hanno causato la cristianizzazione, e non viceversa.
Status quaestionis in Caria
V'è qualche chiarimento da illustrare prima di inoltrarci nel territorio. La presenza di vescovi
carii nei due concili ecumenici di Nicea (325) e Costantinopoli (381), se testimonia da una parte la presenza
ufficiale della chiesa, non forza un processo di cristianizzazione che è a venire. Ancora, l'attenta analisi fatta
tempo addietro sul ruolo che il vescovo ebbe vis-à-vis con il tempio pagano resta di grande pregio, pur se è
doveroso ricordare che і decreti citati da vari studiosi, spesso ignari del jus imperiale, diventano diritto
vigente (Іleges generales) per tutto l'impero solo dopo la pubblicazione del Theodosianus all'inizio del 439.
Da quanto sappiamo sulla Caria, come si dirà, riterrei che la "cristianizzazione" di aree già sacre, e creazioni
1
di nuove - cioè una nuova urbanistica - vede la luce generalmente dopo il 435. E tuttavia non ci è lecito
ritenere che questo processo di conversione, il cambio di status, sia stato veloce, né tanto meno generale e
capillare.
Il C.Iust. I, XI, rubricato De paganis sacrificiìs et templis (rievocando il C.Theod.), riporta una
costituzione di Valentiniano e Marciano (C.Iust. I, XI, 7 del 451) che vieta non solo di recarsi nei templi che
sono stati una volta chiusi, ma anche di accendere fuochi sugli altari profani, bruciare incenso, ammazzare
le vittime (libagioni), appendere ghirlande; il fenomeno persiste, come si vede e non si ferma. Nello stesso
titolo vi sono altre due costituzioni giustinianee, non datate, che toccano elementi nuovi e d'una certa
importanza (C.Iust. I, XI, 9 e 11). Nella prima l'imperatore, oltre a confermare la legislazione passata
relativa al paganesimo, interdice qualsiasi forma di liberalità che tocchi "l'empietà dell'ellenismo". La
seconda costituzione (I, XI, 11) si potrebbe tentativamente datare al 529 e riconosce la persistenza dei
pagani (Elleni) nell'impero. V'è un enunciato in questa costituzione di un certo interesse per quanto qui si
dice. Giustiniano proibisce qualsiasi insegnamento condotto da malati del sacrilego ellenismo (par. 2). Una
misura analoga è intravista anche nella costituzione I, V, 18, 4 che, come la precedente, nega l'annona al
retore pagano (anno 529). In questo anno, al dire di Malaias, vi fu una considerevole "persecuzione" dei
pagani da parte di Giustiniano, che inoltre emanò un decreto inviato ad Atene col quale si annullava anche
l'insegnamento della retorica e della legge.
- La Caria: і centri urbani
Il territorio interno montagnoso e la costa frastagliata e spesso montagnosa evidenziano la
"lontananza" - mi riferisco ovviamente al periodo cristiano - dai plessi urbani; і lunghi promontori,
montagnosi, di Halicarnassus e soprattutto quello di Loryma sono ardui nell'attraversamento e difficili da
controllare. Considerando che il Golfo Ceramico e quello di Simi erano intensamente puntellati da
insediamenti e villaggi (molti di origine ellenistica) avvicinabili soprattutto via mare, il significato di
"lontananza" implica una indeterminazione di tempo ed anche di modalità nello sviluppo della
cristianizzazione. Ben si sa come inizialmente la Caria fosse legata alla Frigia; Aphrodisias divenne la
capitale della Caria (fra il 301-305) quando vi fu il distacco dalla Frigia. Mi sembra doveroso infine
2
sottolineare, in un contesto geografico come il nostro, la distanza della metropoli dalla fascia urbana
mediterranea considerando la modalità esecutiva d'una legge (la sua effettiva messa in opera), sia essa a
carattere civile о ecclesiastico, all'interno dei territori appartenenti all'estreme città sud-occidentali.
Giustamente si disse che la cristianizzazione era formalmente un processo mentale. I Cari erano
inizialmente abitanti delle alture, e la natura aspra e montagnosa della regione ha evidenziato
archeologicamente questa caratteristica. Questa linea interpretativa ha trovato riscontro nella permanenza di
abitanti in piccole borgate e la continuità dei culti indigeni; questi ultimi creavano una dinamica di influenze
e sincretismi molto originali. Il lavoro archeologico di queste ultime decadi ha obiettivamente trasmesso una
miriade di insediamenti, molti ellenistici, di gran lunga superiore in numero a quanto di bizantino si può
rinvenire nello stesso ristretto territorio. A questa considerazione se ne aggiunga un'altra: il periodo
cristiano vede in genere scendere gli insediamenti a valle о presso le città - si abbandonano le alture - a
meno che eccezionalmente si vada a rivisitare un luogo sacralizzato da un santuario.
Ritengo che vi sia poco da aggiungere all'analisi fatta sulle iscrizioni relative ad Asclepiodotus
di Aphrodisias. Coadiuvate dalla Vita di Isidoro e da quella di Severo, patriarca di Antiochia,
rispettivamente scritte da Damaselo e Zaccharia Scolastico, le iscrizioni, individuano, contestualizzandolo,
Asclepiodotus, cittadino di Aphrodisias. V'era, così, una fucina di filosofia pagana sostenuta anche da un
certo Asclepiodotus di Alessandria. Se, dunque, si accerta la persistenza d'un pensiero filosofico di matrice
pagana in questa città verso la fine del V secolo (Palmatus 2), mi sembra prematuro, al momento
certamente imprudente, estendere una tale situazione a tutte le altre città carie. Che Asclepiodotus di
Aphrodisias abbia avuto una propensione filosofica è desumibile dalle iscrizioni e indirizza in questo modo,
con l'ausilio dell'omonimo alessandrino, a pensare ad una scuola in città. Un frammento di Damaselo
illustra la città come sede centrifuga di pratiche religiose, il che sta a dire che studenti di altre città si
volgevano ad Aphrodisias per attingere un'antica saggezza. Le informazioni desunte dalle due fonti ed
incrociate con l'evidenza epigrafica in loco hanno allargato il milieu culturale della città; l'epigrafia
racconta la cura e і benefici che Asclepiodotus ha versato sulla città. Se è da pensare ovviamente ad una
coesistenza di pagani e cristiani, e questo va ben oltre la fine del V sec., quanto mi preme sottolineare è
3
l'attitudine ancora viva di benefattori della città in questo periodo pregiustinianeo. A parte Asclepiodotus,
un buon numero di altri cittadini, tra cui il vir illustrìs Pytheas, quasi certamente pagano, sono intervenuti
per l'abbellimento monumentale della città (nuovi interventi e/o restauri).
Non simile certo ad Aphrodisias, ma un analogo milieu culturale rinvenuto a Keramos,
Stratonikeia e Mylasa lascia vedere uno sviluppo nel processo di cristianizzazione che naturalmente anche al
tempo di Asclepiodotus si concretizzava nella metropoli. Due interessanti e colte iscrizioni sono state
rinvenute a Keramos e relative ad un solo personaggio Philagrios [DIA 3]; cinque, invece, sono le eleganti e
auliche iscrizioni rinvenute a Stratonikeia, relative a Máximos (DIA 4) e Apollinarios (una). Tutte queste
iscrizioni hanno varie caratteristiche in comune. La cronologia le pone nella seconda metà-fine V secolo.
Tutte le iscrizioni sono celebrative usando un linguaggio elegante, aulico (Máximos è indicato come
πενταρχήσαντα [n. 1357], Apollinarios è un pater civitatis) e le scritte sono pubblicamente esposte. Tutte si
riferiscono ad una forma di filantropia sociale (condutture idriche per Apollinarios), ad un impegno per
coprire le tasse per і poveri (χρυσάργυρον, auri lustralis collatio, abolita poi da Anastasio) per Máximos,
alla costruzione di una αϊθονσσα (struttura porticata per Philagrios) per stranieri e locali in tempo invernale
- il che ci dice che questo mecenatismo è volto alla città e ai suoi abitanti, piuttosto che alla chiesa. Ancora,
tutte le iscrizioni sono relative ad aree urbane periferiche (presso la porta nord a Stratonikeia
accompagnando le relative statue, presso la porta a sud a Keramos), là ove, se non vado errato, si pone il
complesso cattedrale. A Stratonikeia un'iscrizione pone le statue "davanti alla casa del divino Cristo"[DIA
5]; Philagrios accosta da nord il complesso cattedrale che s'addossava alla porta sud. Queste considerazioni
portano a riconoscere come l'intervanto monumentale о meno di questa élite non interferisce con l'antica
parcellizzazione urbana; l'area centrale delle città conserva ancora una tessitura antica pur se le chiese
esistevano, in un'area ancora non centrale e senza insistere su una precedente area templare. Anche
l'episcopato agisce con gli stessi moduli epigrafici, esposti ma decentrati, pur se relativi a fondazioni
ecclesiastiche (casi a Keramos e Bargylia DIA 6 e 7].
È opportuno citare il caso di Mylasa. L'editto del 480 del prefetto Dionysios era affisso al podio
del tempio di Augusto e Roma a Mylasa [DIA 8]; non sappiamo dove fosse il luogo dell'affissione a
4
Keramos e a Stratonikeia. Nella seconda metà di V sec. si snoda la Vita Xenae seu Eusebiae, scritta nei
primi decenni del VI sec.; il luogo è Myl asa. Sappiamo dalla Vita che il tempio (ιερόν) - identificato come
quello di Augusto e Roma, era ancora lì, certo non in uso, ma non distrutto, visto l'affissione dell'editto.
Inoltre Xena compra una casa in un'area privata, vicina al complesso cattedrale e allo hier on, il che lascia
pensare che, benché il tempio non fosse ancora stato distrutto, si cominciava a creare una nuova
parcellizzazione a carattere ecclesiastico. Sul tempio, tuttavia si venne a costruire una chiesa, di S. Nicola,
stando all'informazione desumibile da Ciriaco di Ancona dell'inverno del 1446. Credo che la
trasformazione effettiva del tempio in chiesa possa essere accaduta in periodo giustinianeo considerando il
tono teologico della Vita Xenae di manifattura monofisita. Sappiamo che anche il tempio extraurbano di
Keramos, a Kurşunluyapı venne trasformato in chiesa in periodo giustinianeo; a Bargylia si è ipoteticamente
pensato che una chiesa sia stata costruita su una struttura templare d'epoca ellenistica; una possibile
identificazione è stata proposta anche per la basilica sull'acropolis di lasos; un'impresa analoga venne
intrapresa anche a Didyma.
Si sa della presenza di una chiesa nel grande adyton del tempio [DIA 9], a sua volta rimpiazzata
da un'altra più tarda. Dalle iscrizioni reperite si ebbe l'inizio d'un editto giustinianeo, purtroppo mutilo e la
ricostruzione della chiesa in epoca medievale. Per Mileto ν'è poco da aggiungere a quanto in genere può
dirsi di Aphrodisias. La città, anche nel VI sec. conservò la sua monumentalità consistente non solo nella
conservazione di antichi monumenti (il propylon della Grande Chiesa, l'Heroon III presso la chiesa di S.
Michele, il ninfeo e le terme di Faustina), ma anche nella nuova politica di costruzioni ecclesiastiche che
ben si intonarono al sistema viario precedente. V'era la personalità di Hesychius Illustrius, nella Mileto di
VI sec. che conservava fra l'altro le antiche credenze elleniche ed usi; v'era ancora l'area della Grande
Chiesa che nella seconda metà di VI sec. va ad occupare l'area lasciata vuota d'un monumento dedicato al
culto imperiale, come la primitiva chiesa di S. Michele costruita nella cella del tempio di Dionysios.
L'epigrafia e l'archeologia dei centri urbani, dove scavati, offrono un quadro culturale delle città
che s'incrementa ancora dell'apporto dell'elite pagana e di quella cristiana. Ambedue le correnti sono
presenti nell'ultimo scorcio del V secolo e buona parte della metà del VI a rendere ancora dinamica l'antica
5
polis che, da parte sua, non presenta in genere una conflittualità che nuoce al tessuto sociale. Pur vero che le
testimonianze epigrafiche e monumentali di Aphrodisias e di Mileto non trovano un ragguaglio similare
nelle altre città, ma se di conflitto si deve parlare, nelle città carie anche nella prima metà di VI secolo, ciò
non riguarda quello fra pagani e cristiani, quanto piuttosto d'una polemica intestina alla stessa chiesa
(ortodossia calcedoniense e monofisismo).
A scrutinare le varie costituzioni imperiali del C.Theod. XVI, 10 che riguardano la politica
religiosa, sacrale e monumentale dei templi, fino alla Novella 4 di Maiorano (458), si nota un sinuoso
andamento della politica imperiale, un elastico e ad quid pronunciamento (penso alla forma di rescritto) che
ben s'allinea alla coesistenza delle due diverse élites urbane. La cristianizzazione in ambito urbano in Caria
non ha avuto sconvolgimenti traumatici quali tramandati a proposito di alcune città meridionali; le fonti
scritte non hanno riportato eventi drammatici in Caria e l'archeologia ha iniziato a constatare le mutazioni
del parcellario urbano e monumentale ma molto lento e prodottesi a cavallo del V - inizio VI secolo.
Gli insediamenti periferici
La periferia resta per il nostro soggetto un orizzonte difficilmente districabile. Se l'epigrafia
classica ha individuato vari siti in seguito abitati dai bizantini, l'archeologia ha testimoniato certamente la
stabilitas loci del sacro, ma come essa si sia evoluta, e quando, per gran parte resta ancora da investigare.
Inoltre, il dato archeologico non sempre è lineare nella sua lettura, di quale monumento о area sacra si
trattasse. Accanto al fenomeno della "permanenza dell'area sacra" - costituito nei casi che seguiranno dalla
erezione di una chiesa - si deve porre un insieme di altri fattori che hanno influito in questa continuità
abitativa divenuta cristiana. All'interno della geografia montagnosa e aspra dei grandi promontori mi
sembra altamente significativo il fatto che la continuità abitativa si è avvalsa della presenza di terra
produttiva, di campi sparsi nelle vallate, di approdi riparati posti su rotte commerciali (si pensi al caso di
Loryma), pur se spesso v'era carenza d'acqua (dunque, ricorso a cisterne) in molti siti. La totalità dei siti
bizantini, usualmente ellenistici in origine e con iscrizioni dedicatorie, resta muta circa la dedicazione
cristiana; non è possibile trarre nessuna comparazione fra l'antico e il nuovo culto. Il processo di
6
cristianizzazione del sito, ancora, resta monco sul soggetto che l'ha intrapreso; non sappiamo se sia opera
monastica о episcopale, considerando che spessissimo la chiesa sul tempio о sull'altare restava solitaria
nell'area, di rado accompagnata da qualche cisterna, approdo о strutture di piccole dimensioni. Se si può
pensare all'influenza episcopale per і casi di Lagina, Panamara, Sinuri, Labranda, Koraza, Kindya, gli altri
restano insoluti о è da pensare a piccole comunità monastiche. La cronologia di questa conversione
monumentale e religiosa si aggira fondamentalmente durante il VI sec., forse qualche caso attorno all'anno
500, ma tutti і siti investigati in Caria, a carattere rurale о marittimo, mostrano una stessa muratura e una
lineare semplice planimetria. Insistere sull'area templare о leggermente discostato da essa è un segno a mio
avviso che il monumento antico non ha subito una violenza distruttrice da parte dei cristiani. Credo che la
patina del tempo aveva già attaccato l'edificio antico prima di questa "conversione di religiosità", e questa
testimonianza archeologica dà luce a quanto prima si diceva della sinuosa, elastica politica a questo riguardo
nel C.Theod. XVI, 10.
Emblematico per la sua ricchezza archeologica è il tricorno montagnoso dei promontori, di cui
due (quello di Myndos, con due città bizantine, e quello di Cnidos) aventi città, mentre quello di Loryma è
carente di centri urbani. Da questo non si evince solamente la lontananza dai centri municipali, ma la
effettiva difficoltà di attraversamento del territorio. La Perea Rodia, inoltre, mi sembra costituisca un
unicum circa la sopravvivenza di chiese su strutture antiche, un'area ricca di religiosità antica e poi cristiana.
In questo contesto, più che altrove, probabilmente trova senso affrontare qualche principio metodologico
che può aiutare a comprendere il fenomeno del cambio di status e la giustificazione di tanti casi. Gli
orizzonti che si pongono innanzi sono: la veneratio-stabilìtas loci, l'inquadramento legale del sacrum,
l'entrata cristiana. In breve, il primo orizzonte ermeneutico si basa sulla continuazione (stabìlìtas) d'un sito
che è stato da tempo ritenuto sacro (venerado). Questo binomio ha creato la frequentazione, particolarmente
in una società rurale, d'un fanum conosciuto da tutti componenti della contrada e da essi ritenuto un punto
focale della loro esistenza. Questa stabìlìtas del luogo venerato, e questo è il secondo orizzonte
interpretativo, è ancorato all'antico diritto romano che mai ha diviso jus e religio. Giustiniano definisce
nelle Instìtutìones (II, 1, 7-8) in modo chiaro ed apodittico un materiale giuridico di lunga storia: le res
7
sacrae et religiösae et sanctae sono di diritto divino. Per quanto concerne le cose sacre (res sacrae) esse
diventano tali quando ritualmente e per mezzo dei vescovi sono consacrate a Dio, come gli edifici sacri e і
doni che ancora ritualmente sono dedicati al ministero divino; tutto questo non è alienabile, fatta eccezione
per il riscatto di prigionieri. La inalienabilità e la immutabilità dell'area, che resta sacra anche se l'edificio
dovesse crollare, sono categorie che appartengono al diritto divino e che la chiesa gestisce per il culto
divino. In effetti quando il testo legislativo giustinianeo ritorna su rite (ritualmente), quasi certamente si
riferisce all'ormai stabilito rito di consacrazione e dedicazione per una chiesa che nella formulazione
ufficiale trasmessa richiama l'epoca giustinianea, a dire che il processo di creazione di questa cerimonia si
colloca nel V secolo.
Andando a ritroso, l'ultima costituzione del titolo XVI, 10 è relativa alla "distruzione e
riabilitazione" dei "fana templa delubra, si qua etiam nunc restant integra, praecepto magistratum destrui
(la mano militare all'opera) collocationeque uenerandae christianae religionis signi expiari (la mano
episcopale in azione con l'erezione della croce)". A me sembra che quanto la legge ha fatto passare sotto
silenzio è la conservazione della natura della res sacra, in questo contesto il topos templare: esso
apparteneva al dio in quanto propriamente consacrato. Quanto dunque Cod.Theod. XVI, 10, 25 prevede è la
demolizione dell'edificio - e l'archeologia mostra che non tutto l'edificio viene distrutto. In modo
particolare è la cella che viene demolita, e si ripropone la riattivazione cultuale dell'edificio in veste
cristiana attuata certamente dal vescovo poiché al magistrato spettava solo il compito della distruzione. In
altre parole si potrebbe vedere qui un "impasse legislativo" in quanto il luogo non cessa mai di restare sacro;
il passaggio da un culto ad un altro non ha richiesto una normativa per la desacralizzazione - normativa
contraria al ius divinum - quanto una riformulazione consacratoria per mano episcopale. Questa
circumventio legale credo abbia trovato origine in una prassi già da tempo stabilita per salvaguardare la
sacratio del luogo. Lasciate che vi citi l'incertezza di Teodosio II e della sua cancelleria a questo proposito.
La costituzione CTh IX, 45, 4 emessa a Costantinopoli il 23 III 431 legifera sul diritto di asilo, iniziando con
"Che і templi (=le chiese) di Dio Altissimo siano aperti a tutti coloro che lo temono." Fra gli atti del concilio
di Efeso si rinviene un editto, pubblicato ad Alessandria il 7 IV 431, sul quale, mi sembra, si basa la
8
formazione codificata nel Theodosianus . Ebbene, in questa versione alessandrina l'editto presenta un lungo
preambolo che ben conosce il jus sacrum del tempio, delle statue imperiali {ad statuas confugere),
completamente eraso nella versione costantinopolitana.
V'è, infine, un ultimo parametro ermeneutico, quello ludico, che ritengo sia intervenuto in questo
processo culturale della tarda antichità, e particolarmente nelle campagne. C.Theod. XVI, 10, 17 del 399
viene ripresa da C.Iust. I, 11, 4: riaffermando la proibizione dei "riti profani", il legislatore acconsente che
vi siano le riunioni festive dei cittadini e una comune letizia per tutti. Si acconsente così che siano offerti
divertimenti (voluptates) secondo l'antico costume e che si tengano feste conviviali allorquando і voti
pubblici {publica vota) lo esigano.
Volgendo brevemente l'attenzione al culto celebrato nel santuario di Zeus Panamaros presso
Startonikeia - siamo edotti dalle iscrizioni sui misteri celebrativi e sulla permanenza della funzione sacrale
del sito, certamente fino agli inizi del IV sec. Le lettere invitatorie dei sacerdoti in carica per le celebrazioni
fanno menzione della "tavola del dio" e di εύωχία e εύφροσύνη; la gente accorsa in effetti, non solo
partecipava alla processione, ma aveva in seguito un tempo di diletto conviviale e letizia. L'area dove si
svolgeva il banchetto è sempre all'interno del períbolo del santuario; ad Amyzon, L. Robert l'individuò su
una terrazza parallela a quella del tempio. Su quest'area, inoltre, si ergevano tende di fogliame (σκηναί) per
un miglior conforto. Qualcosa di molto simile è stato riscontrato nella zona montagnosa di Myra, in Licia. È
il ben noto tour sacrificale e conviviale capeggiato da Nicola di Sion, dove il testo usa θύω (per l'uccisione
dei buoi) e per la gioia del popolo si ha εύωχία e εύφρανθέντες; ancora sintomatico è l'uso di στιβάδια
(stuoia di giunchi о di fogliame da stendere a terra per sedersi durante il pranzo) e la costante di "invito a
tutto il popolo" del villaggio a partecipare.
Siffatte costumi sociali e religiosi sono stati credo in Caria, come altrove in Asia Minore,
soprattutto in ambiti rurali, il medium culturale per un passaggio "senza colpo ferire" verso la
cristianizzazione. Va da sé che resta da chiedersi "che tipo di cristianizzazione" qui si tratti. Il sottofondo a
tutte le preghiere "rurali" presenti negli antichi eucologi lasciano chiaramente trasparire il tono esoreistico
nella petizione. Se si considera che le prime formulazioni orazionali, presenti sia nei testi eucologici e
9
agiografici, vanno a porsi dall'inizio del VI sec., si evince come il quadro culturale e religioso vada
lentamente cambiando con l'includere una evidente percentuale di sincretismo. E questa ricerca
interdisciplinare è ancora del tutto sconosciuta in questo Istituto.
E d'uopo citare la ben nota missione di Giovanni d'Efeso, commissionata da Giustiniano,
relativa alle zone rurali, autentiche sacche di prassi religiose antiche (adorazione degli idoli, sacrifici,
rovesciare і templi, gli altari, distruggere gli alberi). Stando al racconto si piantarono allora le croci,
s'eressero chiese, soprattutto, e monasteri. Ebbi modo, anni addietro, di imbattermi in due chiese che ritenni
appartenenti a questa missione
Linee conclusive.
La religio, che nella cultura classica innervava la sfera socio-politica della città creando nel
cittadino quello stile chiamato pietas, diventa nel mondo cristiano materia cogente nell'esercizio del jus
principale. Nel tit. I del libro XVI del C.Theod, il de fide catholica asserisce quale sia la religio del popolo
romano e questa sola è la religione di stato. Come inciso, mi vien da chiedere - a proposito della
cristianizzazione e scelte politiche della Georgia e dell'Armenia cosi magistralmente schizzate nei mesi
scorsi - quale sia stata la legge vigente in quelle contrade esattamente nella seconda metà del V secolo.
Riterrei che una siffatta domanda possa arrecare nuova intelligenza al fenomeno della cristianizzazione del
Caucaso. Senza aggiungere ulteriori parole su questa fondamentale variazione di rotta nell'esercizio del
potere imperiale nell'impero, come nella sua recezione all'interno dell'accostumata vita sociale, vorrei
indicare altri due fattori che, pur se non citati precedentemente, e certamente in bisogno d'essere
ulteriormente scrutinati, hanno interagito con gli eventi e mutamenti accennati precedentemente e databili
dopo la pubblicazione del Theodosianus. Nella sfera di competenza del principe l'unità della chiesa era un
dovere e un obiettivo da perseguire costantemente sì da consolidare l'unità e stabilità dell'ecumene; molte
leggi del codice esplicitamente fanno menzione di ciò. Quanto però accadde inizialmente ad Efeso ed
esploso a Calcedonia - parlo della lotta intestina alla chiesa relativa al monofisismo - sconquassò la fragile
unità creando lacerazioni che interessarono le provincie, e la stessa Caria denunziò questa scissione.
Aphrodisias e altre città carie vissero l'esperienza dell'episcopato monofisita e la polemica ecclesiastica
10
indebolì, credo, la forza politica e l'intervento pastorale dell'episcopato sul territorio. L'altro fattore che può
aver pesato nella storia politica e religiosa dell'impero e della Caria fu l'ascesa al trono di Anastasio nel
491. Se il patriarca Eufemio ha creato il precedente per una confessione scritta di ortodossia per
l'incoronazione, l'imperatore non cambiò tuttavia la sua politica religiosa. Se le fonti attestano una buona
percentuale di vescovi monofisiti in Caria nel 518 (due decadi più tardi circa parte la missione di Giovanni
d'Efeso), d'altra parte il mecenatismo civico è stato documentato dalle iscrizioni sulla fine di V sec. Non
vedrei male l'erezione della chiesa sul tempio ad Aphrodisias in questo periodo anastasiano, così come
decoroso restano le città in questo periodo. Il cambio di status, questo travaso dall'antica alla nuova religio
non è stato traumatico nelle contrade carie e in Anatolia; vi fu quanto vorrei chiamare un cambio, una
progressiva metamorfosi generazionale, come indiziata a Roma nella famiglia dei Ceionii a cavallo fra il IV
e V sec. Il mondo rurale, da parte sua, segue di li a poco, soprattutto in tempo giustinianeo, il cambiamento
che non comportò, anche in quelle remote aree, una schizofrenia sociale. Se nell'emergente mondo culturale
cristiano la retorica, l'omiletica, l'innografia, la storiografia risentono e rispondono ai requisiti ecclesiastici
con gli stessi dettami letterari, fenomeno soprattutto metropolitano, bisogna assolutamente volgersi ad una
differente e popolare letteratura, cioè all'agiografia, al genere erotakriseìs, ali'eucologio per ritrovare sotto
mentite spoglie quanto s'era pensato d'essersi lasciato alle spalle e che la legislazione imperiale riteneva
d'aver eradicato. Un'analisi strutturale di questi testi lascerà trasparire come sotto diversa foggia sia
sopravvissuta l'antica cultura.
V. Ruggieri
11