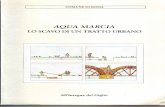Le pari opportunità nelle carriere politiche in Italia. Il punto di vista delle Consigliere...
Transcript of Le pari opportunità nelle carriere politiche in Italia. Il punto di vista delle Consigliere...
1
Le pari opportunità nella carriere politiche in Ita lia. Indagine nazionale sulle consigliere comunali1.
Domenico Carbone*, [email protected] Leonardo Catena**, [email protected]
e Fatima Farina**, [email protected]
«Diventa allora necessario indicare in quali termini una presenza più consistente delle donne in politica possa “fare” la differenza e far prevalere una diversa “progettualità” politica su temi spesso rimossi o marginalizzati, che riguardano in particolare le relazioni di genere e i rapporti inter-generazionali. Ma sono solo le donne a doversene occupare?» (Lorella Cedroni 2011, p.5).
Abstract L’obiettivo del contributo è indagare il tema delle pari opportunità in un ambito sociale particolarmente rilevante: quello della rappresentanza politica a livello locale in Italia. La sfasatura tra il formale godimento dei diritti politici e una bassa partecipazione alla politica attiva, pur accomunando le diverse democrazie occidentali, è in Italia particolarmente evidente. La presenza delle donne sulla scena politica italiana tende ad aumentare inversamente alla centralità delle istituzioni, dal livello nazionale a quello locale (regionale, provinciale, comunale). E’ proprio la rappresentanza a livello locale che si intende qui approfondire attraverso i risultati di un'indagine sulle Consigliere elette nei Comuni italiani. La rilevazione è stata effettuata con metodo CAWI su un campione nazionale, rappresentativo a livello territoriale, di Consigliere comunali, con lo scopo di cogliere il sistema delle pari opportunità nelle rappresentazioni, opinioni e pratiche politiche locali che le Consigliere incarnano nei rispettivi territori, quali la rilevanza attribuita alla parità tra donne e uomini, come e se fanno parte delle agende politiche locali, oltre che nei diversi ambiti dell'esperienza sociale. La relazione tra percezione/definizione delle pari opportunità e la definizione della politica, del ruolo di rappresentanza ricoperto, l'esistenza o non di aspettative di carriera politica sono altresì aspetti considerati nelle analisi dei risultati. A partire dall’ipotesi di una non necessaria, tantomeno univoca, relazione tra appartenenza di genere e ruolo di rappresentanza politica, si intende qui riflettere sull'agire politico delle donne elette nei diversi territori e su come il tema della parità tra i generi solleciti o non, anche in termini di risposte fornite, il loro ruolo istituzionale. * Dipartimento di Giurisprudenza Scienze Politiche Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale ** Dipartimento di Economica Società Politica dell’Università di Urbino
1 Questo lavoro è frutto di un progetto di ricerca nato dall'incontro con Lorella Cedroni, al suo ricordo è dedicato il nostro lavoro.
2
1. Il punto della questione Nei contesti in cui la divisione del lavoro affievolisce il carattere sessuato, la partecipazione delle donne in politica tende ad elevarsi (Formengo, Guadagnini, 1999). Come riconosce Stevens, è il circolo virtuoso partecipativo economico e sociale ad aver rappresentato negli ultimi decenni il fattore di propulsione incrementale e migliorativo delle condizioni femminili nei paesi Ocse: «i cambiamenti politici mettono le donne in grado di migliorare le proprie condizioni economiche e sociali, mentre lo sviluppo sociale ed economico alimenta l'ambizione delle donne di migliorare il proprio status politico» (Stevens 2007, p. 39).
Di qui, un altrettanto semplice riflessione intorno alla relativamente recente riscoperta del tema rappresentanza politica femminile2, spesso portata ad evidenza di una in-compiuta democrazia, «forma massima di realizzazione di uno Stato democratico» (Deffenu, 2001, p. 460) nella sua configurazione paritaria. «Si ritiene, infatti, che in una democrazia compiuta tutti i cittadini debbano avere paritariamente la stessa opportunità di votare e di essere eletti. Il gender gap in politica (così come in altri ambiti sociali ed economici) viene dunque inteso come un elemento di disparità, se non di discriminazione, che indica la mancata presenza di una parte della popolazione in cariche legislative e governative» (Cedroni 2011, p. 1). La questione della rappresentanza, quando e se declinata al femminile, diviene sinonimo di sottorappresentanza che di per sé implica un divario di genere, un dato acquisito piuttosto che un problema da analizzare, descrivere ed eventualmente interpretare. E' così che mentre il cahier de doleances3 risulta copioso, la questione della rappresentanza femminile è spesso ferma alla conta numerica, continuando a latitare studi integrati sulla differenza di genere come fattore propulsivo dei processi politici, specie per quanto riguarda la partecipazione legata all’affermazione di nuovi partiti e movimenti politici (Cedroni 2011), e il valore più o meno aggiunto da una rappresentanza di maggiore equilibrio dal punto di vista della composizione di genere.
É evidente che il raggiungimento dell'obiettivo di paritarie opportunità si correla ad una spesso implicita assunzione di una rappresentanza numerica che, quasi necessariamente, sostanzia una istanza, variamente espressa, di equità:
«La mera “presenza” (fisica) delle donne in politica non esaurisce il problema della rappresentanza […] La rappresentanza politica viene generalmente intesa come l’atto di “rendere presente qualcuno o qualcosa e, in particolare, di dare voce e presenza a cittadini che non posso essere fisicamente partecipi nei luoghi decisionali. Il rappresentante assume quindi un ruolo vicario che si presta a ulteriori questioni: è un delegato che rappresenta solo gli interessi dei suoi elettori, oppure è un fiduciario che, una volta ottenuta la carica, può fare scelte a favore di un più ampio numero di cittadini? Cosa può significare tale questione per le elettrici e le elette, da un punto di vista di genere?» (Cedroni 2011, p. 4).
Inoltre, cosa può rappresentare per il sistema politico e per la comunità che ne dà mandato?
La rappresentanza include l'agire nel senso della stessa, rimanda ad interessi, soggetti e istanze rappresentate e ovviamente agli obiettivi (politici) tutt’altro che predeterminati a partire dal genere. Quale dunque l'agire politico rappresentato dalle donne, quali i presupposti, i percorsi e gli obiettivi, i legami che connotano le “carriere politiche” come pure la formulazione delle agende, le relazioni con i rappresentati e le rappresentate? Partire da tali quesiti significa mettere in discussione l'assunto della rappresentanza politica in funzione di un'autorappresentanza delle istanze del mondo
2 Fa notare inoltre Bellé che «ricerche prettamente sociologiche che prendano in esame la costruzione del genere in politica e nei partiti, coinvolgendo sia uomini, sia donne, sono pressoché inesistenti in Italia» (2010, p. 13). 3 Hughes parla di «culture of complaint» (1993) intorno e delle minoranze sociali.
3
femminile, che si radica in un'inossidabile divisione sessuata dei ruoli, riconfermando altresì le logiche di consolidamento della maschilità egemone (Connell 2005), nonostante l'esserci delle donne. Se la presenza femminile è funzionale principalmente all'autorappresentazione, diviene possibile ma non necessaria, eventualmente attuata o negata4 . Qui la premessa ad una rappresentanza plurale che non contempla la diversità, piuttosto la omologa al parametro dominante, in forza di quel dominio maschile che individua nei fattori pre-politici le ragioni dell'esclusione (Bourdieu 1998), che rimandano alla costruzione della cittadinanza in assenza di donne dalla sfera pubblica (Saraceno 2008), universale nella misura in cui si forgia sulla uniforme differenza maschile (Sarlo, Zajczick 2012). Le donne dunque rappresentano l'alterità subalterna, omogenea e univoca portatrice di interessi5, sussidiaria o eventualmente salvifica del sistema maschile, opposto per definizione al femminile, non un reale competitor del gruppo dominante nella misura in cui non afferma un'autonomia decisionale in quanto soggetto politico e non collettivo. Le donne presunte in virtù del loro genere comprese e conosciute nel ruolo, risultano invisibili socialmente, per una difficile acquisizione di status.
Dunque gli interrogativi e gli scenari che si aprono sono incentrati sull'agire politico delle donne, oltre che degli uomini, sul valore non presupposto ma verificato dai fatti e dall'esperienza, di una differenza percepita e agita allo stesso tempo. Un agire tutt'altro che predeterminato verso le questioni che le riguardano o di loro competenza. Delle donne si occupano solo le donne. Dentro la rigidità della divisione dei ruoli vi è una indiretta legittimazione dell'assenza delle donne, ma anche della relazione di genere, nell'agenda politica. Il rovescio della medaglia è l’enfatizzazione del ruolo femminile come elemento di rottura, di miglioramento del sistema esistente maschile. L’enfatizzazione della femminilità è variamente introdotta dalla stessa letteratura come marcatore della differenza dal maschile, giustificazione degli ostacoli esistenti alla realizzazione di migliori equilibri, nonché auspicio per porre riparo alle crisi ed impasse del mondo politico, come di quello del lavoro ed economico6.
Sono gli stereotipi che spesso colmano il vuoto dell'esperienza fatta ed osservata cui sfuggono la complessità delle scelte, degli orientamenti e comportamenti7. Gli stereotipi positivi enfatizzano il contributo possibile o persino reale delle donne in quanto tali, in continuità con il polo opposto dell’oscillazione, quello degli stereotipi negativi, dove la politica rimane un mondo più facilmente per uomini e i percorsi delle donne, rimanendo entro una minoranza numerica e simbolica, sono costellati da ostacoli che rendono l’accesso e la partecipazione più debole, ma anche gravosa. Tra il troppo e il troppo poco, il mezzo virtuoso del genere detto e fatto (West, Zimmerman 1987) in politica è ancora oggi poco sviluppato nell’attività di ricerca.
4 Tale concezione si basa sulla convinzione che le donne, per essere meglio rappresentate, debbano “autorappresentarsi” ovvero votare non per un candidato che rappresenti in maniera neutra issues di tipo generale, ma gestire quindi in prima persona la rappresentanza, magari attraverso la fondazione di partiti ad hoc (Cedroni 2011). 5 Scrive al proposito Brunelli «le donne non sono un gruppo di interesse (è davvero problematica l'individuazione di un interesse comune delle donne) e che l'idea di una rappresentanza dei gruppi (donne, minoranze etniche o religiose) almeno in parte commisurata alla loro consistenza in seno alla società, non è altro che la riproposizione, del tutto anacronistica, di una concezione postmoderna della rappresentanza politica» (Brunelli 2006, p.18). 6 È questo per esempio il caso della teoria della Womenomics o del fattore D come propellente di sviluppo ad un sistema imbrigliato, stagnante e profondamente in crisi. Senza che la maschilità in questo caso venga messa in discussione, si guarda alle donne per individuare la via virtuosa dentro un sistema che non muta comunque le sue coordinate neppure nella sua lettura ed interpretazione, a cui si affida il ruolo di manodopera di riserva rispetto della centrale risorsa maschile (Farina 2012a). 7 La riduzione stereotipata della lettura delle scelte politiche delle donne non dà conto di ciò che di fatto esprimono, delle priorità variamente espresse nella formulazione dell'agenda politica (Duflo 2010).
4
Prendendo dunque le distanze dall'univocità della relazione tra appartenenza di genere e ruolo di rappresentanza politica, si intende qui riflettere sull'agire politico delle donne elette nei Comuni delle diverse regioni italiane e su come il tema delle pari opportunità, le questioni dell'eguaglianza e disuguaglianza di genere sollecitino o non, anche in termini di risposte fornite, il ruolo istituzionale ricoperto. Le problematiche che si pongono non sono solo quelle di un'urgenza riequilibrativa, ma il significato, attribuito e praticato, di un'equa e plurale rappresentanza a partire dall'esistente. Senza dare per scontato una partecipazione politica delle donne indirizzata verso obiettivi paritari, si tratta di comprendere se effettivamente questi rientrino nell'esperienza politica, quale è la percezione e i significati attribuiti alla differenza, negli orientamenti ideologici e valoriali della rappresentanza agita, se questa è percepita come un impegno in direzione paritaria oppure prende forma di autorappresentanza, totalmente svincolata da intenti di rivendicazione antidiscriminatoria e comunque orientati ad una percezione delle pari opportunità a tutto tondo. 2. La ricerca e il suo percorso L'indagine, di cui si presentano qui i primi risultati, riguarda un campione di Consigliere comunali in tutto il territorio nazionale. Le Consigliere rappresentano il maggior numero di donne nelle cariche elettive tra gli enti locali. Di fatti, i dati mostrano con chiara evidenza che la presenza delle donne tende ad aumentare inversamente all'ampiezza del Comune e passando dalle Amministrazioni Regionali a quelle Comunali8 . Pertanto i Comuni rappresentano un luogo privilegiato di osservazione della partecipazione politica femminile. Di qui la rilevanza di un'indagine sulle Consigliere che sono una parte cospicua del totale della rappresentanza politica del nostro paese, pur con diversa distribuzione tra le diverse aree geografiche. L'obiettivo che ci si è proposti è di considerare la relazione tra il genere e il ruolo elettivo di consigliere, nelle sue specificità rispetto agli obiettivi politici, le agende locali, gli orientamenti a valori e le pratiche di azione politica. Sebbene l'indagine sia più ampia, ci si soffermerà qui in particolare sulla questione delle pari opportunità, sul se e come questa è percepita dalle Consigliere nell'esercizio del loro ruolo . L'indagine è stata svolta con il metodo dell’inchiesta campionaria tramite CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)9. Si è optato per un campione rappresentativo di Comuni italiani seguendo un disegno di campionamento casuale stratificato per area geografica e dimensione della popolazione del comune. Dalla lista di campionamento costituita da circa 270 comuni, è stato quindi costruito un database di circa 1200 indirizzi email delle consigliere comunali, elette in questi comuni, a cui è stata inviata, per posta elettronica, la richiesta di partecipazione all’indagine corredata da una lettera di accompagnamento che spiegava le finalità della ricerca e le modalità di compilazione del questionario. Nel complesso il tasso di risposta è stato piuttosto elevato, considerando lo strumento di rilevazione adottato, attestandosi intorno al 45% dei contatti. Sono state, infatti, 540 le consigliere comunali che hanno compilato il questionario. Sebbene il processo di auto-selezione delle rispondenti sia stato influenzato dal livello di conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici, si può comunque affermare che l’indagine sia stata accolta con interesse dalle consigliere comunali contattate. Ciò è testimoniato anche dal fatto che nonostante che la
8 Oltre a mantenere una significativa concentrazione delle cariche di maggiore potere e visibilità nelle mani di rappresentanti di genere maschile (Sartori 2009). 9 Si tratta della somministrazione per via telematica di un questionario da compilare autonomamente online. Tale metodo presenta vantaggi di tipo economico e organizzativo, sia di accorciamento dei tempi di rilevazione, sia di una pseudo-impersonalità e minore intrusività della comunicazione che sembra persino agevolare l’autenticità delle risposte (Ricolfi, 1996; Bruschi, 2005; Gabbiadini, Mari, Volpato, 2011).
5
compilazione richiedesse circa 25 minuti, la percentuale di questionari incompleti si attesta intorno al 7%. Il questionario utilizzato nella rilevazione è articolato in 4 sezioni10, prevedendo domande chiuse (a risposta singola e multipla) e alcune domande aperte inserite al fine di indagare più in profondità alcuni aspetti che sono stati ritenuti particolarmente rilevanti ai fini della ricerca. In questo contributo l’analisi riguarderà, come detto, solo una parte dei risultati dell’indagine, quella relativa alla questione delle pari opportunità e il suo legame con la rappresentanza politica delle Consigliere intervistate. A partire dal punto di vista delle protagoniste si tenta qui di comprendere come si sostanzia la relazione tra l'essere donne e ricoprire la carica elettiva di Consigliera sul piano delle istanze più o meno paritarie, del valore e significato della differenza e su come ciò entra negli orientamenti, nelle azioni e nelle agende politiche pensate per i territori di appartenenza. 3. L'analisi dei risultati Iniziamo l’analisi dei risultati emersi nella nostra indagine con alcuni dati utili a definire il “peso istituzionale” che il tema delle pari opportunità assume nei vari contesti territoriali. Le figure 1 e 2 illustrano, l'incidenza, differenziata per ampiezza del comune e per area geografica, di due organi istituzionali dedicati: Delega Assessorile e Commissione pari opportunità. Come si può osservare, i comuni in cui è presente la Delega Assessorile o la Commissione sono più diffusi al Centro-Nord e nelle città di maggiori dimensioni (oltre i 50.000 abitanti). È qui, che troviamo le più elevate percentuali di casi in cui, nella stessa amministrazione comunale, è presente sia la Commissione sia l'Assessorato. Viceversa, nei comuni più piccoli e nelle regioni meridionali sono più frequentemente assenti.
10 La prima sezione è dedicata ai dati personali, la seconda al lavoro, la terza all’attività politica, la quarta e ultima parte alle pari opportunità.
6
In generale, come si evince dalla figura 3, nella metà dei casi la questione pari opportunità, però, trova una scarsa rappresentatività all’interno dei Consigli comunali e, a quanto afferma la metà delle nostre intervistate, il problema è affrontato raramente o mai.
Nella tabella 1 la frequenza con cui il problema è analizzato, nel comune delle consigliere intervistate, è messa in relazione con l’ampiezza del comune stesso, la posizione geografica, e la presenza di una Commissione e/o Assessorato alle pari opportunità. I risultati mostrano, ancora una volta, l’importanza della dimensione del comune. Anche in questo caso, infatti, sono soprattutto le consigliere dei comuni di piccole o piccolissime dimensioni ad affermare che il problema delle pari opportunità è affrontato raramente o mai. È, tuttavia, interessante notare come una discriminante importante, e statisticamente molto significativa, sia rappresentata dalla presenza di organi istituzionali delegati a questa funzione. Nei comuni in cui più sono presenti gli organi istituzionali dedicati, infatti, la questione delle pari opportunità trova più frequentemente spazio in Consiglio
7
comunale. Non emergono, in questo caso, differenze statisticamente significative rispetto all’area geografica. Tab. 1: Frequenza con cui la questione pari opportunità è affrontata per ampiezza del comune, area geografica, e presenza di commissione e assessorato alle pari opportunità spessissimo/molto spesso abbastanza spesso raramente/mai Totale
Ampiezza comune* Meno di 5000 11,8 34,1 54,1 100,0
5001-20000 14,0 29,4 56,6 100,0 20001-50000 24,5 28,2 47,3 100,0
500001-100000 16,7 38,9 44,4 100,0 Più di 100000 28,5 41,3 30,2 100,0
Area geografica Nord 18,9 34,1 47,0 100,0
Centro 13,4 33,5 53,1 100,0 Sud e Isole 23,9 25,0 51,1 100,0
Presenza Commissione/Assessorato** Entrambi 35,1 39,5 25,4 100,0 Nessuno 5,7 24,2 70,1 100,0
Solo commissione 20,8 31,1 48,1 100,0 Solo assessorato 15,1 36,7 48,2 100,0
Totale 17,6 32,3 50,1 100,0 N 89 163 253 505
*p<0.05; ** p<0,001 Abbiamo poi messo in relazione le risposte date rispetto all’importanza attribuita alla realizzazione delle pari opportunità nell’ambito lavorativo, nello studio, in politica e in famiglia, con alcune caratteristiche personali delle intervistate e del comune in cui operano11. Complessivamente appare chiaro come in tutti gli ambiti la realizzazione delle pari opportunità sia ritenuta molto importante. Su una scala da 1 a 5, infatti, i punteggi medi sono vicini al massimo in tutti gli aspetti considerati. L’ambito in cui, comunque, il problema delle pari opportunità risulta essere più importante è quello del lavoro, seguito da quello familiare, poi quello politico e infine quello dello studio. A partire da questa evidenza è, comunque, possibile analizzare in dettaglio le risposte fornite dalla consigliere comunali. Dai dati di tabella 2 emerge, anzitutto, la non significatività delle differenze, su nessuno dei quattro aspetti, rispetto alle diverse classi di età. Le opinioni delle consigliere risultano quindi trasversali alle diverse generazioni, riconoscendo un grado molto elevato di importanza a tutti gli aspetti considerati. Anche considerando il livello d'istruzione, non emergono differenze significative intorno all’importanza delle pari opportunità nel lavoro, in politica e in famiglia, a differenza dello studio in cui sono le più istruite ad attribuire una maggiore importanza al problema. Le differenze tra le intervistate emergono più chiaramente, però, quando prendiamo in considerazione le caratteristiche relazionali e familiari. L’avere o meno dei figli sembra incidere
11 L’importanza attribuita ai diversi aspetti delle pari opportunità è stato registrata su una scala “tipo Likert” con 5 gradi di accordo (1 per niente, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo). Nella presentazione dei risultati si è deciso di confrontare il punteggio medio, piuttosto che le frequenze di risposta dei singoli gradi d’accordo, per mettere maggiormente in evidenza le differenze rispetto alle diverse caratteristiche personali delle consigliere. La significatività di queste differenze è stata calcolata tramite ANOVA.
8
nella differente importanza attribuita alle pari opportunità nel lavoro, nello studio e in politica, mentre non c’è significatività per quanto riguarda la sfera familiare. In dettaglio, come era lecito attendersi, coloro che hanno dei figli si mostrano più sensibili ai problemi relativi alle pari opportunità. Per quanto riguarda lo stato civile, i livelli più bassi di importanza attribuita al problema nell’ambito lavorativo, in quello formativo e in quello politico, si registrano tra le consigliere single. Viceversa coloro che sono coniugate o conviventi, ma soprattutto, coloro che hanno interrotto una relazione coniugale ritengono il problema più importante, anche in questo caso, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. La collocazione politica risulta essere un’altra variabile “discriminante”. In questo caso, infatti, con la sola eccezione dello studio, in tutti gli altri aspetti analizzati le consigliere di centro sinistra ritengono più importante realizzare le pari opportunità, soprattutto in famiglia, poi nel lavoro e in politica. Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche del comune in cui ricoprono il loro ruolo, la tabella 2 mostra come le differenze geografiche siano significative soltanto in riferimento alla realizzazione delle pari opportunità in famiglia. Sono soprattutto le consigliere delle regioni meridionali ad attribuirvi maggiore importanza. Differentemente da quanto rilevato in precedenza sull'incidenza della questione, la presenza di deleghe assessorili e commissioni pari opportunità e le dimensioni del comune non sembrano discriminare le opinioni delle consigliere in merito all'importanza che siano realizzate le pari opportunità nei diversi ambiti esperienziali, che risultano trasversali rispetto a questi parametri di confronto. In sintesi, quindi, l'importanza di realizzare pari opportunità sembra principalmente legata a fattori soggettivi individuali, oltre all'orientamento politico delle intervistate, piuttosto che di contesto. Con un’altra batteria di domande si chiedeva alle intervistate di esprimere il loro parere in merito all’esistenza di discriminazioni tra uomini e donne in diversi ambiti della vita sociale12. Questo con lo scopo di comprendere la percezione delle discriminazioni nei vari ambiti di vita. Osservando nella tabella 3 anzitutto il dato relativo all’intero campione nell’ultima riga, si può notare come il grado di discriminazione percepita, emerga con pareri più differenziati rispetto alle opinioni sull’importanza di realizzare misure per le pari opportunità. L’ambito lavorativo resta quello in cui si riconosce il livello più alto di discriminazione di genere, seguito dall’ambito familiare, da quello politico e infine da quello dello studio. Non emergono differenze significative relativamente alle classi di età delle intervistate. Rispetto al titolo di studio, invece, sono le consigliere con percorsi di studio più brevi a ritenere l'ambito dello studio maggiormente discriminante per le donne. La presenza di figli e lo stato civile mostrano, invece, una relazione significativa con le differenze in ambito politico. Anche in questo caso sono le consigliere con figli e quelle che hanno interrotto una relazione coniugale ad sostenere l’esistenza di un più alto gap di genere. La collocazione politica risulta piuttosto rilevante per comprendere le differenze rispetto a queste problematiche. Come si può osservare, infatti, le consigliere di centro sinistra affermano in maniera più netta l’esistenza di discriminazioni nei confronti delle donne nel lavoro e nella famiglia.
12 Anche in questo caso il livello di discriminazione percepita è stato registrata su una scala “tipo Likert” con 5 gradi di accordo (1 per niente, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo). Come per l’analisi dell’importanza delle pari opportunità nei diversi ambii, i risultati sono presentati attraverso il confronto con. La significatività di queste differenze è stata calcolata tramite ANOVA.
9
Tab.2: Importanza di realizzare pari opportunità (valori medi e deviazione standard) nel lavoro nello studio in politica in famiglia Classi di età
Fino a 35 4,62 (0,62)
4,49 (0,74)
4,48 (0,77)
4,60 (0,63)
36-45 4,59 (0,60)
440 (0,79)
4,54 (0,71)
4,48 (0,82)
46-55 4,70 (0,49)
4,55 (0,70)
4,57 (0,63)
4,61 (0,63)
Più di 56 4,61 (0,68)
4,48 (0,80)
4,60 (0,65)
4,62 (0,65)
Titolo di studio Fino al diploma 4,59
(0,57) 4,38* (0,75)
4,49 (0,67)
4,52 (0,68)
Laurea e post-laurea 4,66 (0,60)
4,52* (0,76)
4,57 (0,70)
4,59 (0,70)
Ha dei figli Si 4,68*
(0,52) 4,53* (0,70)
4,59* (0,64)
4,60 (0,69)
No 4,58* (0,67)
4,40* (0,84)
4,48* (0,76)
4,53 (0,70)
Stato civile Nubile 4,50**
(0,74) 4,32* (0,88)
4,41* (0,81)
4,48 (0,76)
Coniugata/convivente 4,67** (0,53)
4,51* (0,73)
4,57* (0,66)
4,59 (0,68)
Separata/divorziata 4,80** (0,40)
4,66* (0,52)
4,54* (0,70)
4,54 (0,70)
Collocazione politica Centro sinistra 4,69*
(0,5) 4,53
(0,74) 4,61* (0,65)
4,65** (0,62)
Centro destra 4,57* (0,63)
4,40 (0,75)
4,45* (0,72)
4,43** (0,80)
Area geografica Nord 4,63
(0,57) 4,49
(0,72) 4,52
(0,70) 4,52* (0,69)
Centro 4,63 (0,62)
4,45 (0,77)
4,57 (0,61)
4,58* (0,71)
Sud e Isole 4,73 (0,53)
4,55 (0,81)
4,62 (0,74)
4,75* (0,59)
Ampiezza del comune Meno di 5000 4,63
(0,59 4,43
(0.76) 4,53
(0,74) 4,57
(0,67) 5001-20000 4,63
(0,58) 4,54
(0,65) 4,52
(0,65) 4,58
(0,62) 20001-50000 4,65
(0,62) 4,44
(0,94) 4,59
(0,65) 4,63
(0,68) 500001-100000 4,75
(0,50) 4,56
(0,60) 4,72
(0,56) 4,61
(0,80) Più di 100000 4,68
(0,56) 4,60
(0,66) 4,57
(0,75) 4,52
(0,78) Presenza assessorato/commissione pari opportunità
Entrambi 4,72 (0.50)
4,59 (0,66)
4,66 (0,57)
4,64 (0,69)
Nessuno 4,57 (0,53)
4,43 (0,61)
4,48 (0,59)
4,51 (0,60)
Solo commissione 4,71 (0,55)
4,50 (0,68)
4,51 (0,64)
4,58 (0,50)
Solo assessorato 4,64 (0,65)
4,43 (0,58)
4,63 (0,72)
4,63 (0,69)
Totale 4,65
(0,58) 4,49
(0,68) 4,56
(0,49) 4,58
(0,69)
10
Tab.3: Livello di discriminazione delle donne rispetto agli uomini (valori medi e deviazione standard) nel lavoro nello studio in politica in famiglia Classi di età
Fino a 35 3,87 (0,85)
2,24 (0,92)
3,61 (0,93)
2,81 (1,11)
36-45 3,86 (0,89)
2,25 (0,89)
3,80 (0,97)
3,06 (1,02)
46-55 3,74 (0,85)
2,32 (0,97)
3,83 (0,98)
2,90 (0,99)
Più di 56 3,65 (0,93)
2,29 (0,87)
3,94 (1,04)
2,94 (0,97)
Titolo di studio Fino al diploma 3,83
(0,88) 2,48** (0,85)
3,79 (0,96)
2,93 (1,02)
Laurea e post-laurea 3,79 (0,89)
2,18** (0,92)
3,78 (1,01)
2,92 (1,03)
Ha dei figli Si 3,77
(0,88) 2,29
(0,89) 3,85* (0,98)
2,93 (0,99)
No 3,86 (0,87)
2,26 (0,94)
3,68* (1,01)
2,92 (1,09)
Stato civile Nubile 3,83
(0,87) 2,18
(0,91) 3,60* (1,02)
2,89 (1,01)
Coniugata/convivente 3,80 (0,87)
2,28 (0,88)
3,83* (0,99)
2,91 (1,08)
Separata/divorziata 3,75 (1,10)
2,44 (1,05)
3,98* (0,87)
2,93 (0,97)
Collocazione politica Centro sinistra 3,88**
(0,81) 2,28
(0,90) 3,86
(0,97) 3,04** (1,03)
Centro destra 3,57** (1,00)
2,27 (0,94)
3,68 (1,03)
2,59** (0,92)
Area geografica Nord 3,76
(0,92) 2,26
(0,87) 3,76
(0,96) 2,94* (0,94)
Centro 3,90 (0,77)
2,28 (0,89)
3,78 (1,01)
3,03* (1,04)
Sud e Isole 3,71 (0,90)
2,34 (1,07)
3,93 (1,01)
2,68* (1,19)
Ampiezza del comune Meno di 5000 3,83
(0,84) 2,40
(0,98) 3,79
(1,03) 2,76
(1,01) 5001-20000 3,72
(0,93) 2,30
(0,93) 3,82
(0,95) 2,99
(1,06) 20001-50000 3,84
(0,80) 2,22
(0,87) 3,76
(0,99) 3,06
(1,01) 500001-100000 3,72
(0,94) 2,36
(0,76) 4,00
(0,71) 2,72
(0,97) Più di 100000 3,89
(0,90) 2,10
(0,91) 3,79
(1,09) 3,03
(0,96) Presenza assessorato/commissione pari opportunità
Entrambi 3,82 (0,82)
2,24 (0,85)
3,96* (0,96)
2,93* (0,94)
Nessuno 3,75 (0,82)
2,24 (0,90)
3,70* (0,96)
2,81* (1,04)
Solo commissione 3,73 (0,98)
2,32 (0,96)
3,73* (1,00)
2,83* (1,03)
Solo assessorato 3,95 (0,97)
2,40 (0,97)
3,99* (0,96)
3,21* (1,11)
Totale 3,80
(0,87) 2,28
(0,91) 3,82
(0,97) 2,91
(1,03)
11
Rispetto alle variabili di contesto, le differenze non risultano, in nessun ambito, significative relativamente all’ampiezza del comune. L’area geografica denota, invece, una differenziazione per quanto riguarda l’ambito familiare. Sono soprattutto le consigliere del Centro, e a seguire quelle del Nord, ad affermare che le donne subiscono una maggiore discriminazione in famiglia. Infine, nei comuni dove non ci sono organismi istituzionali delegati alle pari opportunità c’è un minore livello di percezione delle discriminazioni di genere in politica e in famiglia. Il riconoscimento delle discriminazioni è dunque l'aspetto che più appare come ideologicamente connotato, mentre l'importanza delle pari opportunità si mostra maggiormente trasversale in quanto valore acquisito al di là delle distinzioni di orientamento. Tab. 4 Nella sua esperienza di consigliera, le opportunità delle donne rispetto a quelle degli uomini sono? (val. %)
le stesse/quasi le stesse minori/nulle Totale Classi di età*
Fino a 35 61,3 38,7 100,0 36-45 52,5 47,5 100,0 46-55 59,0 41,0 100,0
Più di 56 40,4 59,6 100,0 Titolo di studio
Fino al diploma 52,8 47,2 100,0 Laurea e post-laurea 55,2 44,8 100,0
Ha dei figli* Si 50,7 49,3 100,0
No 40,7 59,3 100,0 Stato civile*
Nubile 61,5 38,5 100,0 Coniugata/convivente 54,1 45,9 100,0
Separata/divorziata 40,9 59,1 100,0 Collocazione politica
Centro sinistra 54,8 45,2 100,0 Centro destra 49,6 50,4 100,0
Area di residenza Nord 56,2 43,8 100,0
Centro 52,0 48,0 100,0 Sud e Isole 50,0 50,0 100,0
Ampiezza del comune* Meno di 5000 58,5 41,5 100,0
5001-20000 59,0 41,0 100,0 20001-50000 50,9 49,1 100,0
500001-100000 38,9 61,1 100,0 Più di 100000 44,4 55,6 100,0
Presenza assessorato/commissione pari opportunità Entrambi 51,5 48,5 100,0 Nessuno 54,6 45,4 100,0
Solo commissione 53,2 46,8 100,0 Solo assessorato 51,9 48,1 100,0
Totale 53,1 46,9 100,0
N 270 238 508 *p<0,05 Passando poi alle opportunità in politica con una domanda specifica si chiedeva alle intervistate di esprimere sulla base della personale esperienza di rappresentanti le opportunità delle donne rispetto a quelle degli uomini. Come si può osservare in tabella 4, complessivamente poco più della metà
12
(53,1%) delle intervistate ritiene che le opportunità di uomini e donne siano le stesse o quasi le stesse. Le consigliere più anziane risultano, però, meno d’accordo con tale opinione. Al crescere della classe di età, infatti, aumenta considerevolmente anche la percentuale di coloro che dichiarano che nella loro esperienza politica le opportunità delle donne rispetto agli uomini sono minori o nulle. Qui c'è dunque da considerare il percorso formativo con buona probabilità più lungo ed anche un bilancio tra esperienza ed aspettative. Nuovamente la presenza di figli e lo stato civile acquistano significatività. Sono le consigliere senza figli e, anche in questo caso, le single a giudicare maggiormente egualitario l'ambito di azione politica esperito. Viceversa le consigliere con figli e coloro che hanno interrotto una relazione coniugale, ritengono vi sia un più ampio gap di opportunità tra uomini e donne. Le altre caratteristiche personali delle consigliere, titolo di studio e collocazione politica, non risultano significative nelle differenti risposte fornite a questa domanda. Relativamente alle caratteristiche del comune nel quale operano le nostre intervistate, differenze significative emergono soltanto in riferimento alla dimensione del comune. Le consigliere delle città più grandi affermano l’esistenza di un maggiore gap nelle opportunità tra uomini e donne nell’esperienza politica. Non emergono, invece, differenze significative rispetto all’area di residenza e alla presenza di organi istituzionali delegati alla questione delle pari opportunità. Per verificare quanto il tema delle pari opportunità infine sia al centro dell’agenda politica indicata personalmente dalle consigliere intervistate, abbiamo calcolato le volte in cui la questione è stata posta ai primi tre posti di una ideale agenda politica13. Come si può notare dalla figura 3, le pari opportunità non sembrano rappresentare una questione particolarmente urgente per le consigliere intervistate. Soltanto una consigliere su dieci, infatti, ha posto il problema ai primi tre posti della propria ideale agenda politica. Non sono emerse, inoltre, differenze significative rispetto alle caratteristiche personali e a quelle del comune.
13Il testo della domanda era il seguente: “Pensando ad una ideale agenda politica per l'Italia... potendo scegliere liberamente quali sono le tre questioni più importanti che vorrebbe poter affrontare?” Le opzioni di risposta erano: La riduzione del debito pubblico, Il lavoro per i giovani, Le pari opportunità tra donne e uomini, Una nuova legge elettorale, Il rilancio del sistema di istruzione pubblico, Il rilancio del sistema di istruzione privato, Il riordino degli enti locali, Investimenti e incentivi a favore delle energie rinnovabili, Miglioramento del sistema sanitario pubblico, Miglioramento del sistema sanitario privato, Politiche di agevolazione per l'acquisto/affitto della casa, La riduzione del numero di parlamentari, La riduzione dei costi della politica, Il riordino degli enti di governo locale.
13
È questo certamente un dato importante emerso nella ricerca perché evidenzia l’esistenza di uno scarto tra l’elevata importanza attribuita alle pari opportunità e la sua scarsa collocazione nell'agenda politica. È per approfondire ulteriormente questo aspetto si è deciso di prendere in considerazione, oltre ai dati standardizzati delle domande chiuse, i commenti che le consigliere intervistate hanno fatto utilizzando alcune domande aperte. 3.1 I commenti delle intervistate e note a margine della rilevazione In questo paragrafo si presentano alcune analisi preliminari dei commenti liberi delle intervistate relative ad alcune domande aperte previste nel questionario. Rispetto alla domanda “Quali sono state le principali motivazioni che l'hanno spinta verso il suo impegno politico?”, ad una prima semplice conta delle risposte si può osservare che i riferimenti alla dimensione di genere, alle pari opportunità sono eccezioni piuttosto che la norma. Quante individuano nell'equità di genere il fine principale del proprio impegno in politica, sottolineano come si tratti di un impegno marginale nella politica italiana e addirittura controcorrente: “Cercare di portare avanti politiche di genere, molto sottovalutate nel nostro Paese” (PD); “La passione e la convinzione di fornire un servizio alla cittadinanza in un periodo storico in cui si metteva in discussione l'impegno femminile rispetto all'impegno politico” (PD); ma comunque necessario per offrire punti di riferimento per altre donne: “La necessità, come donna, di dare un forte segnale di presenza, partecipazione e proposta. La volontà di essere un esempio, per mia figlia prima di tutto e per le donne della mia città in generale…” (PD). Anzi, alcune addirittura vedono nella partecipazione politica delle donne un atto rivendicativo in sé, di rottura e cambiamento: “Per le donne la scelta di occuparsi di politica è quasi sempre dettata dal bisogno di operare un cambiamento…” (Centro-Sinistra). Appare questo un orientamento residuale e autopercepito come tale, in continuità con un passato che si conosce ma non si esperisce al presente. Altre rispondenti sottolineano invece il valore di utilità sociale del loro impegno politico, interpretando le pari opportunità in maniera indifferenziata, inclusiva di tutte le differenze, ma ancor meglio di tutti gli svantaggi: “Mettermi in gioco e impegnarmi per il benessere del nostro paese, in particolar modo farmi portatrice delle esigenze dei giovani e delle donne” (Lista civica). Se il senso e il significato dell'agire politico fa emergere un'eterogeneità negli orientamenti, maggiore convergenza vi è nel riconoscere alle donne in politica un diverso atteggiamento rispetto ai colleghi uomini. Alla domanda “Secondo lei le donne impegnate in politica hanno un atteggiamento diverso dagli uomini?” corrispondono risposte differenziate sulla base
14
dell'orientamento politico-partitico delle intervistate. Le rispondenti di centro-destra tendono infatti a mettere la diversità di genere in relazione con le caratteristiche ascritte (o supposte tali) al genere femminile, restituendo al contempo una rappresentazione pressoché omogenea della femminilità trasposta in politica e delle sue correlate istanze. Caratteristiche biologiche da una parte e divisione tradizionale dei ruoli vengono richiamate così dalle intervistate: “La natura delle donne è quella di generare e gestire la propria prole, hanno una capacità maggiore rispetto all'uomo di sopportare il dolore, proprio perché gestiscono il ménage familiare possono riuscire in diversi campi anche prettamente maschili” (PdL)”; “Agevolare le donne che lavorano ma che vogliono anche fare figli” (Lega Nord). La rappresentazione del femminile è piuttosto tradizionale e circoscritta entro rappresentazioni stereotipe del femminile come del maschile. Le donne finiscono per rappresentare quell’alterità subalterna e omogenea piuttosto che un autonomo soggetto politico. Il richiamo ai concetti di capacità di mediazione, pragmatismo, coerenza, onestà, sensibilità, la propensione ai compiti di cura, al dialogo, ad una minore competitività e conflittualità si definiscono in alternativa alle caratteristiche “proprie” del genere maschile e per differenza rispetto alla loro positività presunta e ascritta: “La donna porta in politica l'universo femminile, fatto di sensibilità , problematiche, attenzione, moralità, pragmatismo assolutamente diverse dal mondo maschile…” (Lista Civica); “In genere sono più concrete, meno predisposte alle speculazioni politiche, ai panegirici, ai ‘balletti’, ai calcoli di partito; le donne in genere vanno diritte alla soluzione dei problemi, hanno più capacità di ascolto e di mediazione” (Movimento 5 Stelle); “Le donne sono dotate di grande senso pratico, sono molto più concrete e in genere senza pregiudiziali ideologiche. Inoltre sono secondo me capaci di negoziare e di mediare, molto più degli uomini. Sono più razionali e anche affidabili” (Lega Nord). Le potenzialità riconosciute alle donne emergono come importanti ma in qualche misura accessorie, non indispensabili al sistema politico che si riproduce normalmente e per inerzia al maschile. La femminilità è un valore aggiunto eventuale, ma non necessario. Al di là di ciò le differenze di genere sono piuttosto negate nella loro autonomia, sotto il segno della complementarietà quale fattore di arricchimento dell'azione politica e dello status quo: “Non credo che un impegno politico ‘al femminile’ sia migliore, semplicemente diverso e quindi complementare a quello maschile. Spesso il confronto tra persone di sesso opposto produce idee brillanti e strategie operative interessanti…” (Lista Civica); “Perché per ogni cosa ed in ogni situazione il modo di ragionare e di vedere le cose al femminile è spesso differente da quello maschile; ambedue i punti di vista potrebbero trovare un’ottima sintesi, se sinergici” (PdL); “Si perché ritengo che siano diversi i talenti del genere femminile da quello maschile. Offrono un punto di vista diverso indispensabile nel problem solving…” (Lista Civica); “La differenza di genere si ripercuote anche nella modalità di affrontare certi temi e problematiche. Vedo comunque in questo un’arricchente esperienza e occasione di crescita sia per i consiglieri donne che per i consiglieri uomini” (Lista Civica). La complementarietà è la metafora dell'assenza di differenze che si traducono in diseguaglianze. A ben guardare infatti non emerge una problematizzazione delle condizioni diseguali per genere, neppure c'è una messa in relazione con i modelli di ruolo, le costruzioni e le pratiche sociali di
15
attribuzione di ruoli adatti alla maschilità ed alla femminilità (Bellè, 2009). Si disconosce il genere come elemento costitutivo del rapporto sociale (Cedroni, 2012). Le differenze vengono semmai ricollegate a caratteristiche soggettive individuali: “È un luogo comune immaginare le donne impegnate ontologicamente diverse dagli uomini. Gli atteggiamenti positivi e quelli negativi sono equamente distribuiti e vanno di pari passo con il carattere inimitabile di ciascuna persona” (PD); “Non credo che si possa generalizzare. Gli atteggiamenti in politica sono frutto di una molteplicità di elementi che non si riducono alle differenze di genere” (SEL); “In proporzione le donne che scelgono di fare politica sono di meno degli uomini. se si guardano in proporzione gli uomini e le donne, secondo me, non vi è molta differenza! io non ne farei una questione di genere, la politica non è di genere...” (Lista Civica). La dominanza maschile non è dunque problematizzata in termini di produzione di diseguaglianza ma indirettamente essa diventa assimilazione sul piano comportamentale delle donne attive in politica. Alla logica dell’esclusione si sostituisce spesso quella dell’omologazione, per cui si partecipa accettando di agire come uomini (Cedroni, 2012): “Le donne che "decidono" di far carriera politica sono quelle che hanno lo stesso atteggiamento della maggior parte degli uomini che fanno politica, aggressivo e prevaricatore” (Pdci); “Purtroppo molte delle donne che decidono di fare politica anche a livello locale assumono comportamenti maschili (organizzazione dei tempi del lavoro politico ma anche dinamiche di potere) annullando le differenze di genere…” (Lista Civica); “Quando ricoprono incarichi importanti si comportano esattamente come gli uomini” (PD). La politica rappresenta ancora un terreno in cui la maschilità si rivela largamente e particolarmente egemone (Bellè, 2009), nelle parole delle intervistate il riconoscimento di uno stato delle cose, un tratto immutabile: “Proprio perché sono poche non possono concedersi il lusso di comportarsi da donne. Ritengo che le donne in politica simulino il comportamento maschile” (Lista Civica); “Credo che il sistema politico dominato dal genere maschile abbia creato meccanismi più o meno evidenti che hanno portato molto spesso le donne ad agire la politica ed in politica secondo il genere dominante” (ns14). Comportarsi da donne dunque, per usare le parole della nostra intervistata è un “lusso”, mentre più agevole è l'emulazione di ruoli maschili. La consapevolezza degli ostacoli non rivela tuttavia una exit strategy da parte delle consigliere ma piuttosto un affanno delle donne nel sopravvivere nei meandri della vita politica anche locale: “La maggior parte delle donne che fa politica si trova a dover combattere contro pregiudizio e un sistema di valori che impongono maggior serietà e professionalità che generalmente non vengono richieste si colleghi di sesso maschile…”(Lista Civica).
14 Leggi non specificato.
16
Essere sotto esame, dar prova di sé è l'esperienza testimoniata dalle intervistate che si collocano esse stesse in una minoranza riconosciuta: “Le donne che scelgono di impegnarsi in politica hanno sempre l'onere di dover dimostrare di essere all'altezza dei propri colleghi di genere opposto …” (Lista Civica); “È richiesto un maggior livello di professionalità nel comportamento e un più elevato livello di competenza per ottenere fiducia e rispetto dai soggetti interlocutori (cittadini, altri consiglieri, ecc.)” (ns). La rarefazione della femminilità, nella loro esperienza politica, è rimarcata attraverso la mancanza di coesione, l'assenza di una massa critica nel sistema politico. Tuttavia, anche in questo caso, l'interpretazione che le rispondenti ne danno non chiama in causa i fattori strutturali ma le singole donne: “Le donne mostrano aspetti positivi come la cura e la concretezza delle azioni politiche, ma il loro punto debole è divisione fra di esse” (Lista Civica); “Hanno la concretezza e la capacità di risolvere i problemi senza perdersi in inutili chiacchiere anche se non riescono quasi mai a fare squadra” (PdL). Il non riuscire a fare squadra testimoniato dalle rispondenti è l'evidenza di una mancata rielaborazione collettiva dell'esperienza politica al femminile, neppure percepita autonomamente, ma pensata dentro l'ordine gerarchico maschile dato. La prospettiva di genere non è introdotta e tantomeno emerge un orientamento rivendicativo delle disparità che pure vengono chiaramente esperite e dette. 4. Conclusioni Riprende corpo in questi giorni la riflessione sulle opportunità delle donne nell'attuale riforma del sistema di voto. La legge elettorale proposta, ha per l'ennesima volta riaperto uno scenario piuttosto noto. Le parlamentari hanno replicato alla mancata introduzione di misure riequilibratrici definendola una “grave disattenzione”15 nei confronti delle donne, senza risalire né ai rapporti, né alla struttura di potere, l'assenza degli squilibri di genere vengono additati, pur polemicamente, come “disattenzione” per quanto grave. L'assenza di dialettica tra i generi è una caratteristica trasversale, il rapporto tra i sessi appare “pacificato”, proprio mentre le disparità vengono riconosciute, ma non lette attraverso il genere, né tantomeno incorporate nell'agenda politica. Altrettanto, la disgiunzione tra rappresentanza politica e genere appare ad oggi compiuta. Per quanto emerge nella nostra ricerca è evidente che la dimensione di genere non ha particolare rilievo come chiave di lettura, né come strumento di decostruzione degli stereotipi sessuati (Bellè, 2009).
Le rappresentazioni della maschilità e della femminilità non vengono lette come prodotto di dinamiche di potere, di pratiche sociali, di trasformazioni culturali soggette a mutamento in quanto condizioni storico-sociali, piuttosto prevale il senso comune di un agire diverso di donne e uomini in quanto essenzialmente diversi (Connell, 1996). Resta, invece, un pregiudizio originario che continua a perpetuare la collocazione delle donne e del femminile entro un universo non politico (Cedroni, 2012).
15 V. comunicato delle parlamentari al sito www.donneuropa.it.
17
La ricerca propone un rovesciamento di prospettiva, dunque non a partire dalla sistema politico ma dalle donne per arrivare al sistema. Domandandosi in sostanza a cosa siano interessate le donne, si propone altresì una riflessione sulle stesse categorie interpretative da cui solitamente prende le mosse la stessa ricerca che, interrogandosi e descrivendo gli ostacoli alla partecipazione delle donne (e non degli uomini), rischia di riprodurre l'esistenza senza produrre nuovi interrogative e possibilità interpretative. Il caso analizzato trova la sua significatività proprio nella dimensione in cui la rappresentanza politica elettiva delle donne è considerata, vale a dire quella del comune, in cui il rapporto tra elette e cittadinanza è più stretto e le dinamiche di potere agiscono in una direzione meno discriminante in termini di oggettiva partecipazione, stando alle proporzioni numeriche. Se dunque l'ente locale è quello che con maggiore probabilità accoglie la rappresentanza politica delle donne, da quanto emerge dai risultati della ricerca questo non si traduce necessariamente in un'agenda politica locale orientata ad azioni riequilibratrici del sistema di genere. Non è tanto la presenza delle donne, ma le caratteristiche del contesto, a mettere a fuoco l'obiettivo in sé propriamente politico delle pari opportunità, anche attraverso un'articolazione istituzionale interna che stabilmente le contempla tra le sue azioni e impegni. La significatività delle dimensioni del comune positivamente correlata con un'agenda, per così dire, maggiormente paritaria, fa pensare che laddove le risorse sono minori le priorità si allontanano da tali questione che invece tendono ad essere ricomprese nei comuni di più ampie dimensioni, dunque con maggiori risorse e anche con buona probabilità competenze e sensibilità plurali. Dal punto di vista delle intervistate d'altro canto si nota un'acquisita sensibilità trasversale verso le disparità di genere, quale effetto di quella diffusione nel dibattito pubblico delle originarie istanze femministe, che tuttavia hanno perso il carattere rivendicativo e dialettico in virtù di un vero e proprio shift valoriale, da cui risulta la parità tra i sessi come scontata e in ogni caso già data. Uno shift che non ha invece perso una sua specificità ideologica, giacché, da quanto emerge, l'orientamento politico delle intervistate va di pari passo con una maggiore rilevanza attribuita alle questioni paritarie e alla loro realizzazione tra donne e uomini, ma che in ogni caso appare residuale. Le pari opportunità mantengono, possiamo dire, una connotazione ideologica, un legame con riferimenti a valori, dall'altra sono significativamente condizionate dalle caratteristiche strutturali e dai percorsi esperienziali delle intervistate. Dunque, da una parte l'orientamento politico, dall'altra l'individuo. La collocazione politica appare più significativa in termini di riconoscimento delle discriminazioni nei vari ambiti esperienziali e nell'attribuire importanza alle pari opportunità. Avendo incentrato le analisi del paper sulla questione delle pari opportunità tra donne e uomini dal punto di vista delle elette, l'aspetto più interessante che sembra emergere è lo scarto tra l'importanza attribuita alle pari opportunità nei diversi ambiti dell'agire sociale e la sua collocazione nell'agenda politica. Come emerge dai risultati vi è l'evidenza di un'eterogeneità del ruolo di Consigliere anche nell'individuare le priorità verso cui agire e intervenire politicamente. Le Consigliere non percepiscono il loro ruolo di rappresentanti in quanto donne, ma soprattutto in quanto singole. Le pari opportunità tra donne e uomini sono ben lontane dall'essere rivendicate da un omogeneo gruppo di interesse di cui sopra. Piuttosto è l'eterogeneità ad emergere tout court nelle agende formulate per i territori che le intervistate rappresentano, in cui le pari opportunità non emergono come un obiettivo politico, anche se invece sono un valore riconosciuto, a diverso titolo importante, e le discriminazioni sono ben lontane dal non essere riconosciute. Manca il collegamento tra la condizione delle donne e l'azione politica; l'agire politico non è orientato verso il ripianamento di squilibri di genere. In ciò vi è una certa coerenza anche con la direzione delle politiche pubbliche degli ultimi tempi. Ciò appare quasi un paradosso considerando il comune, quale ente locale, il luogo dove di fatto la proporzione numerica rende conto di una più elevata concentrazione di donne, ma certamente non una sorpresa
18
giacché è proprio l'assenza di dialettica a rappresentare l'impasse tra il dire e il fare il genere nei contesti di appartenenza. Se dunque le disparità sono un reale problema, uno tra i principali, il loro superamento è un obiettivo politico che non risulta raggiunto né perseguito da una maggiore presenza quantitativa delle donne in politica, piuttosto richiederebbe una presenza qualitativa di donne e uomini nella consapevolezza di una di una “emergenza” sociale, economica e culturale, che come tale andrebbe affrontata (Cedroni, 2011). Bibliografia Aa.Vv., 2010, Le donne e la rappresentanza. Una lettura di genere nelle amministrazioni comunali, Cittaitalia Fondazione Anci Ricerche; Bellé E. (2010), Genere della politica, politica del genere, CIVIS s.n.c/Scriptaweb.eu. Biffignandi S., Pratesi M.(2003), Tempestività e qualità: aspetti concettuali e comportamenti di risposta nelle indagini via Internet. Un’applicazione ad un’indagine regionale sulle imprese, estratto da S. Biffignandi, G. Gozzi (a cura di), Qualità e Informazione Statistico Economica Territoriale: Aspetti del Processo di Formazione dei Dati e delle Metodologie di Analisi, Angeli, Milano. Bimbi F., Del Re A. (1997) (a cura di), Genere e democrazia. La cittadinanza delle donne a cinquant’anni dal voto, Rosenberg & Sellier, Torino. Boccia Maria Luisa (2002), La differenza politica, Il Saggiatore, Milano. Brunelli G. (2010), Donne e politica, Il Mulino, Bologna. Bruschi A. (2005), Metodologia della ricerca sociale, Laterza, Bari. Camillo F., Girotti C. (2007), L’impatto dell’integrazione di tecniche multiple di rilevazione nell’indagine sulla condizione occupazionale ALMALAUREA: una misura di propensity score in spazi condizionati multivariati, in: IX Profilo dei laureati italiani. La riforma allo specchio, Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA (a cura del), Il Mulino, Bologna. Cimini C., Gasperoni G., Girotti C. (2009), Le determinanti della buona riuscita di un’indagine via web, Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA. Cedroni L. (2011), Le donne nelle istituzioni rappresentative in Italia e in Europa, Intervento al ciclo di seminari Chiacchierate sul genere, Università degli Studi di Urbino, 19 maggio. Cedroni L. (2012), Rappresentanza, potere, quote. Una questione ancora aperta, in Sessismo democratico. L’uso strumentale delle donne nel neo-liberismo, a cura di A. Simone, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, pp. 177-193. Cittaitalia (2013), La rappresentanza di genere nelle amministrazioni comunali italiane, Cittaitalia Fondazione Anci Ricerche. Connell Robert W., Messerschmidt., J.W. (2005), “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept”, Gender and Society, vol. 19, n. 6, pp. 829-859. Corbetta P., 1999, Metodologia e tecniche della ricerca sociali, Il Mulino, Bologna Crisci M.T., (1999), “Internet e la ricerca”, Micro & Macro Marketing, n. 2/1999, Il Mulino, pp. 323-334. Deffenu A., La parità dei sessi nella legislazione elettorale di alcuni paesi europei, in «Diritto pubblico», 2001. Del Re A. (1989) (a cura di), Stato e rapporti sociali di sesso, Angeli, Milano. Re A. (1999) (a cura di), Donne in politica. Un’indagine sulle candidature femminili nel Veneto, Angeli, Milano. Del Re A. (2000) (a cura di), A scuola di politica. Reti di donne e costruzione dello spazio pubblico, Angeli, Milano. Del Re A. (2004), Quando le donne governano le città, Angeli, Milano.
19
Duflo E. (2010), Alle donne non basta lo sviluppo, «Il Sole 24 Ore», 29 giugno. Fatima Farina (2012a), La complessa tessitura di Penelope. Donne vita e lavoro: teoria e pratica sul territorio. Indagine sulle donne dell'entroterra pesarese, Liguori editore, Napoli. Fatima Farina (2012b), “Ruby und die anderen: die italienische politik in den zeiten der ver-marktung” , L'Homme. Europäische zeitschrift für feministische geschichtswissenschaft, vol.1, p. 127-133. Formengo G., Guadagnini M. (1999), Un soffitto di cristallo? Le donne nelle posizioni decisionali in Europa, Fondazione Olivetti, Torino. Gabbiadini A., Mari S., Volpato C., 2011, “Internet come strumento di ricerca. Linee guida per la creazione di web survey”, Psicologia sociale, n. 2/2011, pp. 237-258; Hughes R. (1993), Culture of complaint: the traying of America, Oxford University Press. Limuti S., 2009, “Un’applicazione per l’ottimizzazione dei sistemi di rilevazione Cati e Cawi”, Micro & Macro Marketing n. 3/2009, Il Mulino, pp. 477-483; Mancina C. (2002), Oltre il femminismo. Le donne nella società pluralista, Il Mulino, Bologna. Reis H. T., Gosling S. D. (2010), Social psychological methods outside the laboratory. In S.T. Fiske, D. T. Gilbert e G. Lindzey (eds.), Handbook of Social Psychology (5th ed.), New York: McGraw-Hill, pp. 82-114. Ricolfi L., 1996, Incertezza e verità. Un confronto fra tecniche telematiche di sondaggio, in F. Di Spirito, P. Ortoleva, C. Ottaviano, Lo strabismo telematico. Contraddizioni e tendenze della società dell'informazione, UTET, Torino. Rossi Doria A. (1990) (a cura di), La libertà delle donne. Voci della tradizione politica suffragista, Torino, Rosenberg & Sellier. Saraceno C. (2008), Tra uguaglianza e differenza: il dilemma irrisolto della cittadinanza delle donne, lezione alla Lettura annuale Ermanno Gorrieri, Modena. Sarlo A., Zajczyk F. (2012), Dove batte il cuore delle donne?, Laterza, Bari. Sartori F. (2009), Differenze e disuguaglianze di genere, Bologna, Il Mulino. Stevens A. (2007), Donne potere politica, Il Mulino, Bologna. Van Selm M., Jankowski N. W., 2006, “Conducting on line surveys”, Quality & Quantity, 40, pp. 435-456.