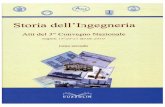A questão da autoria masculina e feminina e Orgulho e Preconceito e Senhora
Ingegneri e territorio nel regno di Napoli tra età francese e Restaurazione: reclutamento,...
Transcript of Ingegneri e territorio nel regno di Napoli tra età francese e Restaurazione: reclutamento,...
Giuseppe Foscari
Tngegneri e territorio nel Regno di Napoli
ffa età francese e Restaurazione:reclutamento, forma zione e carriere
L- Cinque anni furono sufficienti { go"trno napoleonico per€mettere
ml-i à".t.ti che modificarono radicalment e Ia precaÀa organizzazione
**J;.1regno di Napoli. Gli atti più_significativi.furono varati nel
roOS-g, q,r"nào venne istituito il Corpo di ingegneri di Ponti e Strade' e
d 13f 1; con l'apertura della Scuola di Applicazione "
il referente piimario sul piano politico-normativo non poteva che
e$s€re la Francia, e, con il sosiegno del ministro Francesco Ricciardi' -
uun recchio ma tenace riformiita che {irmò i decreti e che costituì il
fu-d-'uoionfra il processo innovativo awiato da Giuseppe Bonaparte e
;*li;;;.;orro dil suo successore Gioacchino Murat2 - pr€se corpo
ú;;; dei lavori pubblici. Non fu solo un normale e fisiologico
ffi|;*[ n.ll'org"ni, zazíone degli uffici, ma una pagina del tutto
mnmra per una r..r. ii ragioni che mèritano di essere approfondite'-î*"*aosi
di una rifórma di tipo amministrativo oltre che squisita-
Íffinre tecnica non può essere .ott'idttutu avulsa dal più generale conte-
*"-dt modernizzazione dell'ordinamento amministrativo e finanziario
.d R.g"" d.i Napoli, pertanto f-u Parte integrante di quel.progetto di
*rU-iùi""rione d.l r.gi-. napoleónico che si affídava alla proprietà
lf"*ai-i^ ed al serviziJai Stutà per reclutare la nuova élite sociale' Con
x* ,lior-" tecnica anche il lavoro degli ingegneri diventava infatti un
ncrrizio di Stato.ilcentraiismo,pfesuppostoimprescindibiledellamonarchiaammrnr-
r*.d;;;;;""" "ppti.r*
anche i,.l rumo tecnico' per cui prevalse I'in-
ffi;;; diretto .à il.o'trollo dello Stato sulle ópere pubbliche3' In
e"-ti"" if gorr.r.ro napoleonico affidò ad un proprio organo burocratico'
mmn orgamzzato ln fr.rrul"nzu ton p""otàle iecnico' la gestione del
*trlrio nei suoi lnterventi più iÀpegnativi sul piano finanzíario e
fr[*À4.. Tutto il Regno rr.ttr" riordinato in tre divisioni, e ciascuna
-"*.f,1 qrr"li in un certo ,irr-.ro di dipartimenti; un riassetto geografico
,*fl doveva tenere conto dell'orcgiaÍía e della n firra dei <<travaglb>,
280 Giuseppe Foscari
ossia delle opere pubbliche da attivare. Una suddivisione squisitamenrctecnica che ricalcava sul piano ideologico la ben nota ripartizione errrni*nistrativa in organi comunali, disffettuali e provinciali con i qnnli frfigoverno francese rcalizzò un più efficace controllo sulla società locaie"Non si ffattava quindi di un'analogia, ma di un progetto politicamenremirato, per ottenere la corretta funzionahtà del servizio di ponri estrade.
Veniva avviato, pur con tutte le limitazioni culturali, un lenro o**consistente processo di riqualificazione del Mezzogiorno, iniziando crsopportuni interventi infras*utturùí (riattazione e costruzione di srra-de, bonifiche, nuovi porti, ponti,lazzarctti, ristrutturazione di veccruedifici per ospitare i nuovi organi amministrativi e giudiziari), e pone!-do le basi per quel salto di qualità che poteva essere ottenuto medianreuna generale mzíonalizzazione delle opere pubbliche in tutto il Regno.
Acquisì pieno rilievo laformazione civile degli ingegneri in alternatrva a quella dei militari, 'passaggio' che preludeva al riconoscimenro diuna diversità di interessi fra le esigenze difensive dello Stato, che eramdi pertinenza dei militari, e le opere pubbliche destinate a vivi{icare iltessuto commerciale e produttivo del Regno, per le quali la responsabr-lità ricadde su un gruppo di specialisti appositamente istruiti.
Si spalancarono in tal modo le porte della burocrazía agld ingegne:-che ricevettero finalmente un inquadramento professionale ben definirne una suddivisione otganíca delle mansionia; ciò consentì loro di supe-rare quella precarietà del lavoro che ne aveva condizionato sino ad allc,rnl' operato 5 . Va posto in evidenza come I' af{er mazione dell' orientamenrctecnocratico fu anche g î^ntita scindendo le competenze tecniche d,squelle contabili, rispettando in pratica la formazione scientifi62 d.llnnuova figura professionale. Infatti, negli organi tecnici di fine Setteceirto gli ingegneri erano rimasti frequentemente invischiati in comple.sseoperazioni di ripartizione dei fondi fra i comuni per costruire o riatrarele strade, perdendo di vista le loro più specifiche mansioni e diventandcin qualche occasione il capro espiatore delle ben note superficialiùcontabili che si registravano nelle amministrazioni locali.
Giova anche sottolineare che, mediante I'esercizio di una funzionepubblica, come si prefigurava l'attività degli ingegneri coordinata d*una Direzione Generale, nacque e si consolidò un nuovo gruppo socia.lecapace di porsi al7'attenzione come una élite tecnica ed in grado drincidere sul territorio e di infrangere vecchie e consolidate prassi che srestendevano a macchia d'olio soprattutto nelle zone decentrate deiRegno.
Una vasta produzione di studi più o meno recenti ha inteso coglieregli aspetti più significativi di questo collegamento fra I'ufficio e I'ascesasociale di quanti lo gestivano6. L'istituzione di nuovi organi ammini-
Ingegneri e territorio nel Regno di Napoli 281,
i::a:ivi statali o anche l'adeguamento degli stessi alle mutate esigenze
:._a società o dei governi ha agevolato in effetti, in modo diretto o per
,:-::zía, fenomeni di mobilità e di promozione sociale. Un esempio che
::,;rgrafa bene questo processo è il sistema della venalità degli uffici in
.-, Àod.rna, ma, in genere, dalla gestione di un ufficio pubblico aveva-
:,,: iratto beneficio varie figure professionali.,\,11a base di questi meccanismi vi è stata la costante esigenza di
::r--curare al governo un consenso che solo una burocrazia per certi
n..etti più feàele e che meglio si conciliasse con gli obiettivi politici
-, :.ebbe potuto assicurare. Va ribadito che le stesse riforme napoleoni-
;:,e. che pure si muovevano su ben allo terreno, non sfuggivano alla
:".-o1a di creare, per quanto possibile, dei 'luoghi' pubblici che una
:.:ghesia di nuova formazione, più sensibile agli effetti del 'carrieri-
i:lo.-', avrebbe potuto occupare in modo proficuo pel un costante miglio-
-- .i:rento del proprio s tatus sociale.\el teritorio meridionale della penisola gli organi tecnici erano stati
:-:r5re esclusi da questi processi, e, fatta eccezione per p-oche figure che
,-.-.,.uno tratto benefici individuali dalla gestione di uffici con compe-
:::ze tecnicheT, non si può parlaîe per il Settecento né di un'élite
:-:irica sviluppatasi mercé I'esercizio della professione di architetto o di
-,::egnere8, ne di on gruppo socio-professionale capace diindirizzare
- :::ervento Pubblico.Frno all'inizio del XIX secolo, insomma, l'ingegnere non aveva mai
,,e ,:ito l'abito del pubblico funzionario. Si comprenderà come, aldilà
:;l'a metaforu, qrr"ita nuova figura di ingegnere-dipendente dello Stato
:.3'ría costituito realisticamente un fatto nuovo e di grande impatto per
,: 'ocietà.Occorre naturalmente tenere presente che le condizioni lavorative
:e:li ingegneri avevano risentito ancoîa nella seconda metà del Sette-
:.:ro della pesante îngercnza feudale e della scarsa conoscenza tecnica
:r .magistrati> ed altri <nobili personaggil> che avevano gestito i lavori
:::blici nelle realtà localie. In assenza di norme che consentissero agli
-::gegneri-architetti di accedere al mercato del lavoro in condizioni di
r..ofuta parità, era prevalso un sistema arbitraúo e clientelare nella
.e-ezione dei tecnici. In questo modo, piuttosto che premiare solo i più
::eritevoli, si era dato anche spazio a quegli ingegneri più accomodanti e
:!e avevano meglio tutelato gli interessi del ceto dominante feudal-
.i:istocratico.Sono note le venature polemiche di vari studiosi ed intellettuali
_reridionali che, ancora nei primi decenni dell'Ottocento, ponevano
- arrenzione sulla inadeg vatezza dell'organiz zazione tecnica tatdo sette-
;e:lresca, fornendo elementi di raffronto proprio fra questa esperienza e
-e innovazioni del secolo seguente. Trale numeîose memorie e i discorsi
282 Giuseppe Foscari
coevi pubblicati o le relazioni manoscritte, merita una particolare cnursiderazione il lavoro dato alle stampe da un intellettualé napoletano chqpur non esercitando la professione tecnica, si rivela un esperto conosc[-tore delle tematiche tecnico-amministrative del Regno' Nel novemb'rt1820 inf.attí, I'awocato Gennaro Grossi, nel presentare al Parlamen cNazionale peî conto della Commissione di amministrazione provincinlpe comunale di Napoli unaMemoria, con annesso un progetto di legge pela istituzione di un <(corpo Nazionale dei pubblici lavori>>, stronio gú[
uffici tecnici operanti alla Íine del XVil secolo. Le tre Giunte cbeerano state istituite avevano subito, a suo giudizio, la ingombrante epreponderante ptesenza dei baroni, pronti a tutelare esclusivamente ipropri 'affari'cercando di dirottare le strade nei loro possedimenri perevidente comodità ma anche per farne lievitare il valore fondiario"
Quindi non erano prevalse le cognizioni tecniche e l'analisi delle carm-teristiche orografiche nella 'traccia' della via di comunicazione da c+struire. Gli ingegneri in più occasioni erano stati chiamati a legittimaretecnicamente queste richieste senza porre ostacoli di sorta.
Questa, unitamente all'incapacità di un approfondito esame per eîri-denti lacune nelle conoscenze tecniche, era una delle cause per crril'esecuzione delle opere previste (in particolar modo la costruzione deilestrade per la Puglia e per gli Abrtzzi, considerate di importanza nevral-gica per I'economia meridionale), aveva richiesto tempi lunghi e prodor-to non sempre giustificati rallentamenti. Infatti, <de Giunte, - si leggenelTa Memoria del Gtossi - si awalsero d'ingegneri e sovrastanti scioc-chi di loro dipendenza, ed i lavori si abbondarono agli avidi imprendi-tori. Quindi ne nacquero que' tanti disordini nella direzione de' lavori enell'economia delle speser, 10.
Né minori addebiti faceval'awocato Grossi alla Soprintendenza cheaveva sostituito le Giunte negli ultimi anni del secolo. <I difetti diquesta nuova amministrazione furono innumerevoli e tutti da per sestessi manifesti. L'incarico si era affidato ad un nobile per le sue suppo-.ste cognizioni di arte, e il suo amor proprio lo lusingava a credere dipossederle effettivamente. Sdegnò quindi di consultarne gli artisti [ov-vero gli ingegneril. Si awalse di essi (senzafissarli sulle opere) solamen-te consultandoli nei casi disperati, ma senza eseguire i consigli, menoc-ché nei rinconri, che fossero stati uniformi al suo modo di pensare. Gliappaltatori furono i direttori delle strade e questi più delle volte impe-riti; ma sempre ingordi delle sostanze del pubblico. Gl'ingegneri veni-vano impiegati solamente per riveder le misure e i prezzi de' lavori,senz'aver veduto giarnmai i progressi delle opere; cosicché senza leregolari cognizioni, gl'ingegneri doveano erare e 'l danaio pubblimveniva bamttato colla dovizia degl'imprenditori, e senz'alcun vantaggiodei pubblici lavoril>11. Dunque, appaúvachiaro che gli ingegneri aveva-
Ingegneri e territorio nel Regno di Napoli 283
M)cs,sîiruito solo un supporto saltuatio per i lavori pubblici, e non già il
frmrmm di riferimento primafio per la pîogettazione e I'esecuzione delle
LW€r€.Ad arricchire con nuove ossefvazioni una gestione tecnica che aveva
rmtrbe conosciuto polemiche sull'appfopriato uso del danaro pubblico e*rilfiflm moralità di qrranti erano stati direttamente impegnati nell'ediliziar,{ffirmn,rnziata dallo Stato, concorse l'analisi di un tecnico, e dunque di un'rddetro ai lavori', le cui lucide osservazioni, pur se condizionate in.nnl ,'ch€ misura dalla necessità di evidenziate i benefici delle riforme
,mutnc.nresche, restano di indubbio interesse.f"ingegnere Antonio Maiuri, inf.atti, diede alle stampe un prezioso
,rnmurne nél '1836, nelquale sostenne, tra I'alro, che gli stessi ingegneti,s$mrtonl.r'rati a progettare le opere pubbliche a Napoli cinquant'anni prima
mm gîessero le necessarie acquisizioni tecniche, <<non potevano essel
ucrsnri né punto né poco nelle scienze loro necessarie - scrive il Maiuri
- Der ^
ir n ^diiibri
attenenti ad Architet1ota>>t2. A suo giudizio vi
urur-Cunque una limitata circolazione nella capitale del Regno napoletano*{'flllb conoscenze scientifiche, in pafticolare della geometria pura, del-
ffimchirettura statica e della idraulica, i cui testi avevano invece ampia
dfii,wuJgazione in Francia ed in molte parti d'Italia. <<Ed ecco perché
rm*r.=hi" bonificazioni restarono imperfette e tanti pofti distrutti; ecco
il"*ùé molte strade allora fatte si vedono condotte, senza ragione, su
nd dorto d'inaccessibili montagne o pef mezzo a sprofondate valli, con
fu*6 notabile del traffico e de' viandanti>> concludeva ancora I'inge-
gwe lfaiurils. Dunque, sul banco_degli imputati nel dibattito culturale
foilil'r"r..to settecentesco figurava l'isffuzione dei tecnici, la quale cosa
slmnjÀ come un implicito riconoscimento 4 postetiori della Scuola di
Ap_nùicazione, che aveva preceduto di circa trent'anni la pubblicazione
dC volume del Maiuri, ma che aÍrcotanecessitava di essere sostenuta pef
ffi rttacchi più o meno reiterati che subìva in sede politica.
Questa premessa rende probabilmente maggiore meîito al salto di
W*mi.A assilurato dai riformatori di ispirazione francese, anche se il
Ufr-*fu ùidealizzazione e di attenzione verso questa figura professionale
du perre della società napoletana rimasero ben al di sotto del modello
umnmsaXpino, come testimoniato dal prestigio che l'ingegnere di Ponts et
Cffiiur.irées acquisì nel tessuto sociale e dall'interesse suscitato nell'ambi-rmm della letteratura coeva.
t\[a anche nel settore tecnico non può passare sotto silenzio il ruolo
ofuf riiormatori illuministi napoletani. Genovesi, Filangieri, Galanti,
Gofliani, Palmieri, Delfico, Longano, cuoco, avevano individuato i limi-
mi dell'azione di governo nella precaria gestione del territorio e proposto
mlnzioni estremamente concîete. Essi prestarono attenzione alla conti-
@mie manutenzione delle sffade per favorire le attività commerciali, alla
284 Giuseppe Foscari
centralità della dialettica uomo-territorio incentrata sulla salvaguardirdelle aree situate in declivio e di quelle ad esse sottoposte, - le coúmodernità è fuori discussione -, ed espîessero I'esigenza di una buro-craziapiù funzionale che affidasse ad uno specifico organo l'inten'entnbasato sulla regolarità e la competenzala. Orientamenti. e sollecitaMassimilati completamente dai finzionaú del Corpo di Ponti e Smade cche costituitono il fulcro dell'analisi dei maggiori intellettuali napoleta-ni nella prima metà del XIX secolo.
2. La Scuola di Applicazione pose alla base della professione I'i.nse"'gnamento sistematico, in un corso di cinque mesi, da novembre amaÍill.di sei ore giornaliete per cinque giorni la settimana (erano esclusi ilgiovedì e la domenica) ed avente dtrata triennale, al quale partecipava-no dodici alunni per ciascun anno. A conti fatti, nei primi anni difunzionamento della Scuola, a pieno regime, ossia con il completa-entodel primo triennio di corso, si registrò una presenza globale di trentaseialunni, dei quali dodici in procinto di lasciare la Scuola stessa. In reakànon mancò qualche anomalia che fece aumentare il numero, e d'altreparte il legislatore si aspettava una possibile impennata negli iscrinilasciando intendere nel decreto del marzo 1811 che gli alunni potessenoaumentare per eventuali esigenze.
A capo della struttura scolastica venne posto naturalmente il diretto-re generale di ponti e strade, ma, per gli impegni notevoli che questofunzionario aveva, in seno all'istituto fu assegnato l'incarico di diremoread un ispettore o ad un ingegnere in capo, che doveva verificare il grdodi preparazione degli alunni.
Trovò larga applicazione I'adozione del metodo sperimentale tt, hquanto fu collegata alTateotia l'attività in attrezzati laboratori di chimi-ca e fisica e fu prevista, a pafiíre dalla conclusione del corso in m^îzr:',l':utiltazazione degli alunni in un lavoro rimesmale al seguito di uningegnere ordinario del Cotpoló. Questa esperienza diretta poteva an-che durare qualche settimana o mesi in più e non mancano casi ditermini di concorsi per I'ammissione al Corpo di ingegneri prorogati perconsentire ad alunni meritevoli di poter concludere il lavoro al seguito diun ingegnere ordinario e di parteciparc alla selezione.
E chiaro che con le riforme il reclutamento degli ingegneri non erepiù affidato a criteri soggettivi ed arbitrari, ma veniva stabilito sullabase di regole definite a priori ed impersonali, con un'acclrrat^ selezionedei tecnici sulla base di un concorso pubblico. E owio che vi furonodelle anomalie all'inizio dell'esperienza, - ad esempio la cooptazionenel Corpo di 'vecchi' ingegneri-architetti, ua i quali vanno menzionariingegneri del calibro di Bartolomeo Grasso, Luigi Malesci e Giuliano deFazioLT - ma vanno considerati fatti fisiologici, in attesa cioè che la
Ingegneri e territorio nel Regno di Napoli 285
Scuola di Appkcazione cominciasse a Ticenziarc i primi alunni.I-ln elemento decisivo per il consolidamento della Scuola fu rappre-
Mrtato, senza dubbio, dallo sbocco occupazionale che essa garantiva aipriu meritevoli. In pratica, anno per anno, a seconda dei posti disponibfimtrl'organico del Corpo di ingegneri, la parte migliore degli alunniùscritti alla Scuola transitava nei ranghi dello Stato.
11 concorso diventava dunque decisivo per accedere alla Scuola, e,mtrh stesso Istituto, vi era I'obbligo di un esame al termine di ciascunrumo di corso ed un esame finale, decisivo per l'inserimento dell'allievoilÍ:r gli ingegneri del Corpo. E solo mediante concorso, infine, era possi-hffie l'ascesa a qualifiche superiori all'interno del Corpo di ingegneriffisso, in ossequio al sistema meritocratico che dovevagatantire concre-dE opporrunità di carriera ai tecnici più qualificati.
Cerro, soprattutto nei primi anni, le resistenze a7|'adozione del mo-ddfr,o concorsuale lasciano pensare quanto radicata fosse nella culturamidionale la snada del favoritismo e della benevolenza conquistataguer crpacità non propriamente tecniche da parte degli ingegneri. Cito ill " abbastanza eloquente, delf ing. aspfuante Teodoto Paolott| ched| *i''f,ra tn Calabúa. Invitato a partecipate al concorso per I' ampliamen-m 'fl.1l'organico del I8LI, battagliò con i direttori generali di Ponti e:fude che si susseguirono tra il 1811 ed il L812, Campredon e Colletta,, ur'r+*ndendo di essere promosso alla qralitica di ingegnere ordinarioffi m r{asse in virtù dei titoli maturati e come tacito riconoscimentoffih sua quaiità senza sottoporsi alla valutazione di una commissione,ffcsm.i 18.
lft *o"trto che il Paolotti rimase alquanto isolato in questa richiestaúilm4ne $€. rrattandosi di un ingegnere che aveva già dato prova dicapa-
'olhlù c uslento, riuscì a trovare una collocazione più rispondente alle sue,dhm[ snctoponendosi ad un concorso pubblico.
Sc si collegano a questa protesta insinuazioni sulla moralità dei com-
otoì,"i'esistenza di atteggiamenti conservatori e di un boicottaggío,dhi[mnurrn-i meccanismi di accesso e di promozione all'interno degli organir@ùú
MMs i[ rovescio della medaglia fu rappresentato dalTa corretta applica-&ùifu di questi srumenti moderni di valutazione, dei quali nel tempoilhuncfficínrono i migliori ingegneri, anche quelli che avevano lanciatommi Cubbi sull'integrità morale dei membri delle commissioni. È,
W@; il. caso dell'ing. Alessandro Villacci. Il suo curuiculum parlardllfll&nnútÌr: assgnto per chiamata ditettanel 1810, prima cioè che comincias-rruffimnnzionare la Scuola; nel 1813 diventò ingegnere di III classe; nelmnru4 h si ritrova ing. di II classe e assegnato al Dipartimento dellaMdi$miocireriore; nelI826 ingegnere ordinario di I classe con la respon-
286 Giuseppe Foscari
sabilità operativa nella provin cia abrazzese2o .
Non si può naturalmente asserire che il meccanismo concors.:,c,,.e
mettesse al riparo del tutto da favoritismi, tanto più che non mancarc.rrul
protezioni politiche per agevolar ela carcie:a di qualche ingegnere, conrÉ
irovato dil fatto.È "nlh.
il ministro dell'Interno Zurlo si diede c,e
?ur. p., proreggere degli ingegneri, ma si trattò di_sporadici casi.l"e.
nella- sosian r^, ].,'on poJtoro f ui mutare giudizio sulla proficua applic,n-
zione dei requisiti aititudinali e conoscitivi.La concorre nzaftagli alunni veniva incentivata di continuo e non e.&
casuale che nelle circolari dei direttori generali campredon e De vi;r
Piscicelli, si richiamaval'attenzione alla emulazione come stimolo pe
ottenere ia massima dedizione allo studio o al lavoro pratico da parte d,ei
tecnici. Per questa ragione, i concorsi annuaii nella Scuola erano accorb
p^gîatida premi, ché si potevano esibire con orgoglio ai compagni de:
.olro, trattàndosi di libri o slumenti per esercitare la professione, sr:
quali venivano incisi il nome dell'alunno e I'occasione dèl premio2t.'
o..orr. anche ribadire che dopo la Restaurazione, questa linea c
riforma francese finì solo pef un breve tempo nel dimenticatoio e che f:
ripristinata in tutta ftetta, unitamente al recupero del Corpo e dells
scuola, soppressi più per ansia di sminuire le precedenti riforme che per
reale esigenza di cambiamento.Dopo il Decennio le carriere subirono tuttavia un rallentamento
,.nribî., causato sopfattutto dalle ristrettezze delTapíanta organica. E
naturale che una struttura gerarchica piramidale che non congedasse i
tecnici in avanzataetà, maihe attendeva in pratica la morte dell'inge-
gnere per liberare un posto, è naturale, si diceva, che questo sistema
It orr^to a lungo andaie creasse disillusione, amaîezz e scarso rispettc
per l,istituzionà e, e{fetto non secondario, non permetteva un rinnova-
mento dell'élite tecnica.Il tentativo più consistente per porre argine alle conseguenze di
carriere bloccatà ai hvelli bassi ed intermedi fu attuato durante il De-
cennio, ma ancofa più in età borbonica. Furono ass€gnate inf"atti a taltrni
ingegneri mansionì e compiti superiori alla qualifica, cercando soprat-
t.ittJ ai arginare l^ rnan anzu di àirettori in provincia pef non correre il
rischio di Èloccare le opere pubbliche per assenza di responsabili. Veni-
vano in qualche -odo "g.uolati
ingegneri meritevoli madatempo bloc-
cati a livelli intermedi di qualifica. Solo che, seguendo le caliere, si ha la
conferma che non tutti questi ingegneri riuscivano nel tempo a trasfor-
marclamansione superióre in un più gratif.icante profilo professionale.
Comunque, a preicindere dalle speranze o dalle illusioni della ca*ie-
ra, un datoìa posto ancoîa una volta in particolare evidenza.Il Corpo e
la Scuola nap;letana riuscirono u g^r^niirc a fasce sociali identificabfi
nella borghesia della Capitale e delle province un'aha strada da seguire
Ingegneti e temitorio nel Regno di Napoli 287
:::1e propúe aspirazioni di ascesa e di consolidamento sociale. Si-: ,:raya, però, di una borghesia medio-alt a, in gtado di accedere ad un- ' ,:-zato livello di istruzione, (visto che bisognava conoscere I'italiano,: ratematiche, il francese), un grado di conoscenza che si poteva: :-seguire studiando nei licei e privatamente presso esperti ingegneti.::-r::o i figli di ingegneri, architetti, docenti di materie tecniche, avvo--,:r. quelli che entravano nella Scuola e nel Corpo di ingegneri.
l',Íancarono nel Regno i famosi conducteurs francesi, che provenivanor:r reti con umili origini e davano una chance alternativa alla borghesia,:--::ciando in qualche modo i giovani che provenivano da ambienti: ---.''legiati e che studiav^no nella Scuola Politecnica. Nel regno di
.!cfi non fu accolta la figva del conducteur e I pîopositi di rivalsa. . -':ale di una certa parte della borghesia non furono assecondati, la-:-;:do dei seri dubbi sulla capacità delle riforme napoleoniche di coin-- -:ere nel meccanismo di promozione sociale anche strati della società
- -e tradizionalmente esclusi per mancan za di mezzi economici e della: : : :ssaria istruzione.
l'-é aristocrazia né ceti umili; questo può considerarsi lo slogan dei' : ,::ratori. Il progetto doveva ganntke spazio agli strati intermedi che' :.: meglio potevano assicurare adesione e fedeltà al regime napoleo-: : - . e che erano fermamente decisi a raggiungere la solidità economica.
-,-r ulteriore e significativo elemento innovativo fu la legittimazione::;-- organi tecnici collegiali. Il Consiglio dei lavori pubblici fu operati-, ,::: dal 1807 in virtù di un decreto di Giuseppe Bonaparte; esso era
- -:osto da sette membri e aveva lo specifico impegno di esaminare ed: : I riner€ un parere tecnico motivato su quei progetti che il ministro:=- -rterno riteneva necessari inviargli e riguardanti le strade, i <regii.;--,, e i canali. Inoltre eru incaricato di verificate I'esecuzione delle--,.:- approvate, sia per I'uso dei materiali che per la solidità delle:,t:-. nonché per la esatta rispondenza al progetto esecutivo22. Esso fu
,::r.acato due anni dopo dal Consiglío Generale di Ponti e Strade,. : :.:csto da tre ispettori, dal direttore generale e da alfti cinque tecnici,, : ::lí venivano sottoposti i progetti delle opere dal direttore generale,: :: -:r'analisi dei lavori e deiprezzi e per tutti i contenziosi2r.
-- iibattito anche animato sulle caratteristiche dell'opera pubblica'-:-,'a i presupposti per una crescita ulteriore del nucleo di ingegneri
. ",- .iierivano agli organi collegiali, ma permetteva anche una circola-: : -.. del dibattito agli akri ingegneri abllitati a seguire i lavori se di: ,,;,:gio nella Capitale. Pur avendo funzioni consultive, questi Consi-,:,. .,.;iavano traccia di sé in quanto erano tenuti a vetbalizzarc Ie: ' ::ie sedute ed a rimettere le deliberazioni al massimo funzionario di: r.:: e strade. Questo lascia presupporre che si andasse ben oltre la:,:, iunzione consultiva e che quei deliberati fossero delle vere e
288 GiusePPe Foscari
proprie assunzioni di responsabitità che avevano un peso rilevante e ''qnul. tott si poteva rinunciare tanto facilmente'
3. Il modulo tecnico-amministrativo che fu pfoposto ed adottato da:
rif ormatori all' inizio dell' Ot tocento postulava dunque la piena subor & -
nazioneall'autorità centrale. Era compito dello Stato valutare la neces-
sit à ed improrogabilit à di un' opera pubblic a e finanziarne la t ealizz az'-c -
ne, affidando il compito ai suoi tecnici che aveva provrreduto ad. istruhe
e ad inquadrare in una corpofazione. E toccava agli Intendenti, ternì-
nali buÀcratici della macchina statale ma anche preposti alla trasmissic-
ne al governo delle ístanze e delle esigenze locali, il puntuale. rispetri
nelle irovince degli input governativi in.materia di lavori pubblici. L:
compiro ,ror, ,.-ili.e, né agevolato probabilmente dagli stessi funzic-
nari dello Stato. Se da un lato essi erano parte integrante del progettc
centralista e quindi tenuti al rispetto della normativa, dall'altra gradiva-
no poco l, p..t"r" degli ingegnèri di essere I'unico punto di riferimentc
per controilare le opeie pubbliche e subivano la pressione_degli impren-
àitori locali, per i quali i'ingegneîe era quasi un intruso' L'opposizione
ed il disagio'Àe g[intendeÀticostruirono attorno ai tecnici governati\-i
fu tanto;iù forie perché non si trattav,. di obbedire ad un superiore
organo pó1iti.o, b"nrt "d
una istituzione con competenze tecnjche, che.
pei giunta, efa poco accreditatain sedepolitica. Una con6addizione che
i"ró rror,,frrggirra a quanti avatío titolo operavano nel settor€ edilizio'
euesta poririot. dì contrapposizione era naturalmente spalleggiata c
ispiìata dai notabili locali. Oi6e che perdere una fetta consistente del
proprio potere, questi temevano che l'intervento di un organo tecnico
,t^iul. pàtesse in qualche modo intaccare i_propri beni patrimoniali con
vincoliii varia naiura, senza tener conto dei loro specifici interessi.
Tutti questi ostacoli frapposti alla rcalizzazione completa del proget-
to central'ista nello specifió settore tecnico costrinsero lo Stato borbo-
nico che subentrò dopo la Restaurazione a ricercare una mediazione con
la periferia p., ,.-oibidire in qualche modo le resistenze nei confronti
d.ll'amminismazione statale. L'obiettivo era evitare che quelle resisten-
ze si Úasformassefo in un atto di sfiducia verso il govefno e ne compro-
mettessero la stabilità.A oartire dal 1817 si cercò di rísolvere il problema promuovendo una
suddivisione tra lavori pubblici di conto regio, ossia regolati totalmente
dall,ente pubblico e quindi mediante i suoi uf{ici tecnici ed i suoi
ingegneri, e quelle di conto prouinciale e comunale, nelle quali I'ammini-
stiaiione dei?ondi elavigîlanza per I'esecuzione dei lavori fu sottoposta
al vincolo decisionale d"!|i tttt.ttdenti e di specifici organi, controllati
dallo stesso funzionario'a . L. deputazioni delle opere pubbliche prouin-
ciali e cornunali, commissioni composte da membri del decurionato,
Ingegneri e territorio nel Regno di Napoli 289
::::; Cei consigli comunali, o da consiglieri provinciali, avevano specifi-:.-,= :riribuzioni di verifica tecnico-contabile e di controllo qualitativo:: :pera pubblica eseguita. Si ftattava, in effetti, di istituzioni perife-:-::-; che eîano espressione del potere economico e politico locale25. il::;:::re borbonico quindi sceglieva una soluzione mista di controllo:::,-ralizzato e di apertura alle istanze della periferia.
'equivoco di fondo non stava tanto nel fatto che vi fossero opere.":-i:-ziate dallo Stato e da organismi provinciali e comunali, in quà.rto;', :.'.'a trattarsi anche di una suddivisione più funzion ale e razionale, ma:..-:, sdoppiamento delle responsabilità tecniche e del livello di respon-:-i:''irà politica, nella confusione tra le attribuzioni degli ingegneri del- -
-o di Ponti e Stade, - i veri esperri in materia -, elapossibilità di
,---jacare sull'opera da eseguirsi che era propria delle deputazioni delle-:e:e pubbliche.
\on a caso, una delle più dure battaglie del già richiamato direttore;":erale Carlo Afàn de Rivera, per trent'anni circa responsabile della::: *:rura tecnica, fino al 1852, fu appunto volta a far passare il concetto,:e: ,ui basilare, di un'unica direzione tecnica per tutte le opere pubbii::È. senza alcuna distinzione fra lavori promossi e diretti dallo Stato e:,r i organi provinciali, condizione per lui assolutamente irrinunciabile:':: eÌaborare un piano nazionale di interventi sul territorio. Egli poneval:-;he l'attenzione sul fatto che la dicotomia fra ingegnere regio e inge-;:-"re provinciale avesse ricadute sullo sviluppo delle carriere e creasse-' e-fi economici differenziati che mettevano seriamente in discussione: ::mpattezza dell'intero corpo di ingegneri. Alla base di tutto, natu-: ,,i:ente, vi era un giudizio di fondo negativo sulla classe dirigente e su:; :ne forze imprenditoriali locali, sui funzionari periferici (gli Inten-:"r;r), cui de Rivera atribuiva gravi responsabilità nella dilagante cor-::.ione in materia di appalti pubblici e connivenze con <<gli ingordii::altatori>. Il pregiudizio antllocalistico di Afàn de Rivera prendeva: :::o dall'idea che vi fossero troppi appaltatori comotti e speculatori in-:::-','ità nel Regno; ma anch'egli, in altri ambiti che pure erano di sua: -:-petenza, come la gestione del patrimonio boschivo, dovette ricono-,,.:.re che lo Stato non aveva sempre gli strumenti e le persone adatre per:.-- rispettare i vincoli e che il privato e la società locale porevanoi .,rcorrerlo in modo appropúato26.
Il confronto su questa tematica restò alquanto serrato e coinvolse vari---:ellettuali napoletani con posizioni contrastanti rispetto alla possibi-':; o meno di conciliare I'interesse locale con quello dello Stato. proba-:''r:ente le 'aperture' verso gli organi provinciali e comunali e la media-:::re alla quale si è fatto riferimento, meriterebbero una lettura più
"::omentata e senza preclusioni interpretative che sovente hanno por-:-::o a prediligere nel dibattito storiografico I'opzione statalista e centra-
290 GiusePPe Foscari
lista ed a sminuire, se non addirittura a demonizzare le obiezioni a qud
modello sollevate in sede peri{erica'
NOTE
, La sequenza normativa comincia, invero, con il 31 marzo L806, quando fu isdruiro
".f r.g"" t ù"pofi f fvfi"ist.ro J.itír.tno Jh. urrttr. anche la responsabilità polirim
;;iffi; a.it"uori p.bbili;;;*c,ripoi.ot i de*eti 18 agosto^1807 (istituzione dd
ó;;h"al i""".ip"uuii.ii, is io.,,.,,,br. 1808_e 21 gennaio 1809 (s.tabilimento dd
è;;6;i i"g.g"..i di ponJ. strade), 4 matzo,1811 (stabilimento di una Scuole d[
Àpp'ff.*i*. ,U'internó del Corpo di ingegneri di ponti e strade)', Su Francesco Ricciardi cfr. F. NrcorrNr, Nicola Nicolini e gli studi giundici bfu
prini ietà del secoloXlX, Napoli, 1907, inroduzione' p' XLI[', Sulla monarchia amminisffativa si veda R. FrolA, Dall'Illuminisno alla Resuttw-
zione. Donato Tommasi e Ia lcgislazione dellc sicilie, Napoli, 1987 (ristampa).
a Nell,organico previsto con il dedeto del 1809 gli ingegneri erano suddivisi in
ispettori (l unità), irrg.gn"ri in capo (6), ingegneri o*.ai""ii ai prima classe (4) e di
seconda classe t+1, irg.gr.rì ,g;i"",i tOi, infin-e,"sottoingegneri di prima (7) e di secondr
classe (8) e 5 aspiranti. ai;;i;;; "'g;;;to pel corpo d4tlngegneri di ponti e sfi^de' 21
gennaio 1809).5 cfr. N. Osrr.rNr, Le comanicazioni strudali nel'700 metidionale, Napoli, 1991' nel
ouale emerqono i t.rrturiui di irrrroi^rion del settore viario. Per I'Ottocento si vedano
i.tr"ii^r""lc)Jr'Ài; dr-nj;*" e it corpo di,ponti e studc, Latina, te% e G,
Foscenr, Dall,arte ,tU pliil"it, f:iogrgorrr'*eridionalc tra Sette e Ottocento, Napoli
1995.u Per non appesantire l'apparato delle note si richiama I'attenzione sugli autori cbe
hanno scitto più saggi ;;;íril t; questo tema' è il caso di A' Musi' G' Muto' P'L-
n"ti., G. G"lurro,F. Macy, R' Pilàti, R' Aiello' R' Mantelli' V' I' Comparato'
, Si può citare in proposito Giuseppe Valva, marchese di Valva, Soprintendente dle
"r"a.l'.in.gi" a N"p"r, p., *,"à'""i
^ partire d^l 1798, personaggig molto chiac-
;il;Gi: ".r.raii.rpi*rUrfiti
i..tiche ed amminislative che ebbe, e che tu al
;;;;if;ip.i.*i"ft"ifr. riguardarono proprio la sua capacità di funzionario e di
amminis*ator. a.f a*"." p"f-ifi.o. Sul suo Jonto, si veda il già citato volume di
Osruxr.s È chiara la complementarietà dei termini di architetto e ingegnefe ancora all'inizio
dell'Ottocento.e Si veda in proposito Ancnrvro DI SrAro or Nepolr (ASN), Archiuio Botbone,b'
857 ,,,Ossenazlonl detO,liettore Generalc diPonti e Struile sutprogetto di riordinamexto dcl
sensizio coffipilato aA pr"ii*'ni genet/c el -\2" , relazione di Ó' Atrt De RrveRA del
ie;i, n. M'.,ro, D;il";i;* polbbhrb, net Regno di Napoti e degl'ingegneri pteposti a
costruirle, NaPoli, 1836.10 Cfr. G. Gnossr, Menoria salla storia dette snadz dclRegno e su i rsizi dell'ammin'i'
strazione di esse, s.d. (ma Napoli, t82O), p' 1'
ltilu.
tJl
t]111
lll
Ingegneri e territorio nel Regno di Napoli 291
-: : ) . , p. 6.
. :,.. A Merunr, Delle opere pubbliche nel Regno di Napoli, cit., p. 1.2.
. : : ì . . o. IJ --
-:: 1n proposito B.. Vtccnro, II bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell'età"-: : , : , , ' ; : : i i . Torino, 1974.
' -e materie_ di insegnamento,attribuite ai quatffo docentí della Scuola erano: Ia':-::::::ia appllcata aI taglio delle pietre e deilegnami, Ia pratica d.li. _rtr,_,r;orri
:- : : ' : edidraul iche)peri lpr imodocente;l 'architetturacivi lèeiIdisegnorelat ivoai le-:_::::i per iJ secondo; la.,meccanica applicata per il terzo; la fisica íp..iÀàntA., t,' - _:: : -a mineralogia per il quarro (Regiknentò delk scuok a;
"ipiiíii*r- de, ponti
;: ;:: : :natzo '1,811,).
- : : i
'- ::: anomalie sono state individuate da F. Ds Metrre - F. Dn Nrcnr, It corpo di: ':: : :-tde dal decennio francese aila rifonna der 1g26, in A. Messernìilirru ail, izt :::: ::,,ro preunitario. Economia, società e istituzioni, Bari, 19gg, pp. 4a9_46g.' ,r- ! \ . Ponti e Srade, I I Serie, fs. 117. 1g11.
:, ':'s\. Ponti e strade II_Serie,.[s.,136, inc. r, "IstruTioni" derdirettore genera-
'r: I :-:: lollerra, 17 ottobre 1812, inolte il Regolamento della Scuola i-n^rzo if'|^,
i . - , :
' -'-: Decreto con cui si stabilisce un consiglio dei kuori pubblici e se ne assegnano re" i ' : : : ' : - : agostO 1807.
-:: I più volte citato decreto del 21 gennaio 1g09.rrir- i:1: :cteva anche convocafe un <<comitato> ristretto. . ' . i - : :enerale di ponti e strade.
- - :=--reto regio 20 settembre 1g16 stabilì infarti che a decorrera dal ro gennaio' : :::re pubbliche regie e provinciari dovessero costituire a*."-i..p".Jri, ::..::?nto
di organizzazione e d.i senizio d.ella direzione di ponti ) strad.e, II
" -:-- ia proposito G. Foscenr, Ir patrintonio boschi,o ner cilento borbonico, inr..-.: r :-enrani", anno II, n. 1, 1990, pp.25_3g.
Se necessario, il direttoredi tecnici appartenenti al
tii
1t
lllI
i
l
Ill