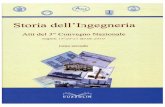Il Corpo degli ingegneri pontifici dalla formazione al controllo dei lavori pubblici nei territori...
Transcript of Il Corpo degli ingegneri pontifici dalla formazione al controllo dei lavori pubblici nei territori...
a partire dal 1809 anno di annessione dei territoridello Stato Pontificio alla Francia di Napoleone e finoal 1814, la Consulta Straordinaria degli Stati romanicon il decreto del 9 dicembre 1809 riorganizzò l’am-ministrazione dei lavori pubblici introducendo neiterritori dello Stato Pontificio il Bureau des Ponts, ar-ges et travaux publics1. Un organo esecutivo, questo,preposto all’amministrazione delle Strade, acque eFabbriche di roma e dello Stato, alle dirette dipen-denze della prefettura, la quale assumeva le compe-tenze della Presidenza delle Strade e della Congre-gazione del Buon Governo2.Sulla rilevanza assunta dai lavori pubblici a scala ter-
ritoriale, in particolare quelli idraulici e stradali, e sul-l’attività di riorganizzazione del settore messa a pun-to dai francesi nell’ambito dei territori annessi al-l’impero3, e tra questi lo Stato Pontificio, esiste unanutrita e circostanziata pubblicistica. Studi che, purverificando l’irrilevanza delle opere concretamenteeseguite e, anzi, riscontrando il progressivo degradodel sistema viario sottoposto al ripetuto passaggiodelle truppe francesi4, hanno sottolineato l’influen-za determinante del modello amministrativo delladirezione generale di Ponts et Chaussées nella riorga-nizzazione degli uffici tecnici condotta successiva-mente, negli anni della restaurazione, attraverso il
motu proprio del 6 luglio 1816 e il successivo motu pro-prio sul regolamento dei lavori pubblici di acque e strade del23 ottobre 18175.Con tali atti, infatti, Pio Vii varò una riforma am-
ministrativa e una specifica ristrutturazione del set-tore delle acque e strade dello Stato Pontificio al qua-le aggiunse, con il regolamento del 7 luglio 1818, ilsettore delle fabbriche camerali6. L’ideatore di tale ra-dicale riorganizzazione fu il segretario di stato car-dinale ercole Consalvi, il quale si avvalse della Con-gregazione economica, istituita da Benedetto XiV il18 aprile 1746, per istruire la riforma dell’intero set-tore dei lavori pubblici.La ripresa della compattezza e della compagine bu-
rocratica del modello francese nella nuova legge diConsalvi del 1817, si riscontra, in particolare, nei trefattori strutturali sui quali essa si incardina. Fattoriche consistono, il primo, nella distinzione in classidelle strade statali, ossia nazionali, provinciali e co-munali; il secondo, nel più vigile controllo sia del-l’aggiudicazione degli appalti, sia del rispetto delleclausole contrattuali; il terzo, nell’immissione nel-l’organigramma di ingegneri di accertata formazio-ne ed esperienza tecnica. Proprio a tale ultimo e so-stanziale aspetto, ossia Istituzione e regolamento del Cor-po degl’Ingegneri Pontifici di acque e strade, il motu proprio
iL COrPO deGLi iNGeGNeri PONtiFiCi daLLa FOrmaziONe aLCONtrOLLO dei LaVOri PUBBLiCi Nei territOri deLLO StatO
PONtiFiCiO. GLi iNGeGNeri GiUSePPe e LUiGi CaStaGNOLa
Simonetta Ciranna
1 Sull’attività della Consulta romana vedi, tra gli altri, gli studi diCarla Nardi e tra questi, da ultimo e per la ricca bibliografia C.Nardi, Napoleone e Roma. Dalla Consulta romana al ritorno di PioVII 1811-1814, roma 2005, Gangemi.
2 Cfr. O. Verdi, L’istituzione del Corpo degli ingegneri pontifici di ac-que e strade (1809-1817), in a. L. BONeLLa, a. POmPeO, m. i.VeNzO, a cura di, Roma fra la restaurazione e l’elezione di Pio IX.Amministrazione, economia, società e cultura, roma-Freiburg-Wien1997, Herder, pp. 191-220. della stessa autrice si veda ancheead., Vie di comunicazione nel territorio di Campagna in epoca napo-leonica, in r. SaNtOrO (a cura di), Viabilità e territorio nel Laziomeridionale, Frosinone 1992, pp. 19-47.
3 Vedi G. BiGatti, Il Corpo di acque e strade tra età napoleonica e re-staurazione (1806-1848). Reclutamento, selezione e carriere degli inge-
gneri, in “Società e storia”, XV, 56, apr.-giu. 1992, pp. 267-297.
4 Cfr. G. Friz, Le strade dello Stato pontificio nel XIX secolo, archi-vio economico dell’Unificazione italiana, s. i, vol. XVi, f. i,roma 1967; G. SimONCiNi, La viabilità nelle città italiane del perio-do napoleonico. Le fonti delle Archives Nationales di Parigi, in “StoriaUrbana”, 1982, n. 19, pp. 139-156.
5 Motu proprio della Santità di N.S. Papa Pio VII in data 23 ottobre1817 sul regolamento dei lavori pubblici di acque e strade, VincenzoPoggioli stampatore della reverenda Camera apostolica, roma1818.
6 r. SaNtOrO, L’amministrazione dei lavori pubblici nello Stato ponti-ficio dalla prima restaurazione a Pio IX, in “rassegna degli archividi Stato”, a. XLiX, n. 1, gennaio-aprile 1989, pp. 45-94.
OPUS 12 2012
SimONetta CiraNNa
dell’ottobre del 1817 riservò l’intera terza parte in cuiesso risulta suddiviso7, regolando, nel titolo Vi, Istru-zione e scuole, la creazione di una struttura scolasticaper la preparazione degli ingegneri pontifici. Unascuola il cui modello corrispondeva all’École des Pontset Chaussées, fondata a Parigi nel 1747 a opera di Char-les trudaine e di Jean Perronet, e prima in europa aessere preposta alla formazione di ingegneri da in-gaggiare nell’ambito degli uffici tecnici dell’ammini-strazione statale. anche gli allievi diplomati nell’ambito del nuovo
istituto pontificio, originariamente attivo nelle sedidi Ferrara e di roma ma, dal 1820, presente solo nel-la capitale, avevano l’opportunità di accedere al Cor-po degli ingegneri, quantunque con il grado più bas-so, ossia di aspirante. agli aspiranti o sopranumera-ri era assegnato il compito di assistenti ai lavori; essicostituivano l’ultimo livello di una gerarchia anch’essaereditata dal Bureau napoleonico. Un ordinamentoorganizzato in tre gradi: 1°) gli ispettori8, incaricatidell’esame dei progetti e della sorveglianza ai lavori;2°) i sotto-ispettori e gli ingegneri in capo provincialideputati alla direzione attiva dei lavori, e assegnati ri-spettivamente, i primi agli uffici centrali e, i secondi,alle legazioni o delegazioni provinciali; 3°) gli inge-gneri ordinari (suddivisi in prima e seconda classe)alle dipendenze dei precedenti, incaricati delle ope-
razioni di campagna o anche destinati a province diminore importanza.Per provvedere all’iniziale reclutamento si proce-
dette, invece, attraverso un concorso per ottantatreingegneri, notificato dal cardinale Consalvi il 24 ot-tobre 18179. il bando chiedeva agli ingegneri già inservizio presso gli organi dello stato e a tutti coloroin possesso dei requisiti previsti, di inviare, entro iltermine di quindici giorni, i propri titoli alle autoritàdelegate10.Le domande degli aspiranti al nuovo Corpo di in-
gegneri Pontifici furono trecentoquarantacinque. icurricula vennero sottoposti a una puntuale verifica ea un confronto, come emerge dall’impostazione deiquattro quaderni predisposti dal Consiglio d’istru-zione, oggi conservati presso l’archivio di Stato diroma11.il 31 gennaio 1818 il cardinale ettore Consalvi fir-
mò un primo Elenco degli Ingegneri Pontifici di Acque, eStrade distribuiti per ciascun servizio, a cui si trovano desti-nati, e loro rispettive attribuzioni, ma soltanto due annidopo, il primo gennaio del 1820 egli inviò a VivianoOrsini, Presidente delle strade, la definitiva Pianta delPersonale di Servizio di Acque, Strade e Fabbriche con inomi degli ingegneri prescelti e i ruoli e le sedi loroassegnati12. L’elevato numero di partecipanti al concorso resti-
7 Cfr. L. PePe, La formazione degli ingegneri a Roma dalla Scuola po-litecnica centrale alla Scuola degli ingegneri pontifici, in L. BLaNCO (acura di), Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Ita-lia tra Sette e Ottocento, atti del convegno “ingegneri, pubblicaamministrazione e istruzione tecnico-scientifica in italia dall’e-tà napoleonica all’unificazione nazionale”, trento 24-25 no-vembre 1995, Bologna 2000, il mulino, pp. 301-319.
8 tre ispettori, ossia ingegneri di primo grado, componevano ilConsiglio d’arte, residente in roma, il quale insieme al Consi-glio amministrativo e al Presidente delle strade costituivano ladirezione centrale dei lavori delle strade nazionali; tra questi in-gegneri erano distribuite le competenze sulle strade di roma esu quelle nazionali e provinciali (per alcune province).
9 Notificazione in esecuzione dell’art. 444 del Motu-Proprio di Nostro Si-gnore dei 23 Ottobre 1817, Vincenzo Poggioli Stampatore Came-rale, roma 24 ottobre 1817.
10 Più esattamente, le domande di ammissione alla selezione do-vevano riportare: la patria; l’età; il possesso eventuale di una pa-tente di pubblico “Perito ingegnere Civile”; i luoghi e la tipolo-gia degli incarichi compiuti come responsabile o come collabo-ratore, riconducibili, in particolare, a opere pubbliche di strade,ponti, fiumi, canali e, più generalmente, idrauliche; i progettiideati anche fino alla scala esecutiva. Oltre a ciò, i candidati do-vevano segnalare loro eventuali pubblicazioni inerenti “l’artedell’ingegnere”, e, anche, lo svolgimento di attività didattica nelsettore dell’istruzione pubblica.i tecnici già in servizio doveva-
no specificare con esattezza cronologica quanto di più signifi-cativo svolto nell’ambito delle proprie competenze. i giovani,invece, “che otterranno all’impiego di aspirante dovranno esi-bire la Patente ottenuta d’ingegnere Civile se saranno di queiPaesi nei quali si suole accordare per l’esercizio di questa pro-fessione, previo il corso dei relativi studi e la pratica, o se sonodi altri Paesi, nei quali non siano in vigore tali prescrizioni, fa-ranno costare di aver fatto il corso degli Studi Fisici, e matema-tici in qualcuna delle Università dello Stato avendone ottenutoil grado corrispondente, di avere appreso i principi del disegno,e di essersi esercitati nella pratica delle operazioni riguardantil’arte dell’ingegnere”. Ibidem.
11 archivio di Stato di roma (aSr), Consiglio d’Arte, b. 1. Vedi O.Verdi, L’istituzione ... cit., pp. 214-215. i quaderni sono impo-stati sulla doppia pagina divisa per colonne intestate secondo irequisiti richiesti dal bando. dopo il nome, la patria e l’età, laterza e la quarta colonna riportano, rispettivamente, gli “Studjed abilitazione di teoria” e gli “Studj ed abilitazione di pratica”,la quinta e la sesta i “Servizj presso il Governo” e i “Servizj pres-so Consorzj o privati”, la settima e ultima le “Osservazioni”.
12 aSr, Buon Governo, serie i, b. 9 bis. Sul documento del 1820vedi anche quanto riportato in F. di marCO, Organizzazione e le-gislazione dei lavori pubblici nello Stato pontificio nell’ultimo decennio delpontificato di Pio VII (1814-1823), in G. riCCi e G. d’amia (a curadi), La cultura architettonica nell’età della Restaurazione, atti del con-vegno, Politecnico di milano ottobre 2001, milano 2002, pp.137-142, in particolare p. 141 n. 6.
iL COrPO deGLi iNGeGNeri PONtiFiCi. GLi iNGeGNeri GiUSePPe e LUiGi CaStaGNOLa
Fig. 1 – Giuseppe Castagnola, 1778, “macchina detta cassone” per il prolungamento dei moli (Archivio Storico del Comune di Ge-nova, Padri del Comune. Pratiche pubbliche, Filza 244, doc. 126)
Fig. 2 – Giuseppe Castagnola, 1772, Nuova pianta del Porto di Ancona (ASR, Buon Governo, serie XIV, collezione di piante,mappe e disegni, n. 107)
SimONetta CiraNNa
tuisce, attraverso l’analisi dei loro curricula, un qua-dro minuzioso sulla formazione e sull’attività pro-fessionale svolta dai tecnici sul territorio dello StatoPontificio nei decenni a cavallo dei secoli XViii eXiX. Circa la prima emerge l’importanza sia del pra-ticantato13, specialmente per i più anziani e i romani,sia degli studi teorici, condotti anche privatamente,presso personalità del mondo della cultura scientifi-ca, quali, a esempio: i matematici François Jacquier(1711-1788)14, Gioacchino Pessuti (1743-1814), Giu-seppe Calandrelli (1749-1827)15, andrea Conti (1777-1840)16, Giuseppe Oddi (1759-1840)17, esperto anchedi meccanica e di idraulica, e il fisico-chimico Feli-ciano Scarpellini (1762-1840)18, ai cui esperimenti ave-va assistito nel 1797 Gaspard monge19. relativamente all’attività professionale, tra tutti i
partecipanti si delinea una sostanziale preminenzadei romani nell’accesso a cariche dell’amministra-zione statale e nella captazione di incarichi dalla ge-rarchia curiale20. relativamente alle esperienze matu-rate a fianco di professionisti di indiscussa fama, sonomolti i candidati che dichiarano di aver assistito l’in-gegnere idraulico andrea Vici (1743-1817), la cui de-cennale attività come esperto di acquedotti e navi-gabilità dei fiumi venne pure riconosciuta dal gover-no francese. Negli anni dell’occupazione napoleoni-ca, infatti, egli occupò la carica di ingegnere in capoper i lavori di strade, ponti, navigazione, porti, dei
due dipartimenti del tevere e del trasimeno. Non meno rimarchevoli si mostrano, poi, i profili
formativi e professionali maturati dai concorrenti al-l’interno dei corpi militari. in tal senso, un esempiosignificativo di una prestigiosa carriera svolta nel-l’ambito della marina pontificia si riscontra nel rag-guardevole curriculum presentato al concorso del 1817dal settantunenne tenente colonnello Giuseppe Ca-stagnola21.
Gli ingegneri Giuseppe e Luigi CastagnolaNella ricostruzione del percorso formativo e pro-
fessionale seguito da Castagnola, docente di idro-grafia dal 1767, la commissione concorsuale registròcon particolare attenzione le imprese da lui condot-te durante la sua continuativa attività nei porti delloStato pontificio, ossia di ancona, Civitavecchia, an-zio e Fiumicino. Già nel 1778, poco più che trentenne, la perizia e
l’inventiva nel risolvere i problemi connessi alla re-golarizzazione dei fondali, doveva essergli ricono-sciuta anche fuori i confini pontifici. in quell’anno,infatti, egli ideò e fece pervenire a Genova, sua cittànatale, la descrizione corredata da un disegno di una“macchina detta cassone”, la quale, secondo le pa-role dello stesso progettista, rappresentava il “modopiù utile e vantaggioso per costruire, riattare e pro-lungare la formazione de’ moli nei porti artefatti”22
13 Sulla formazione professionale fondata sostanzialmente su unpraticantato di natura privata, vedi anche quanto sottolineato daGiorgio Bigatti circa il reclutamento degli ingegneri nel regnod’italia nel 1806, cfr. G. BiGatti, cit., p. 274.
14 tra i suo studi si ricordano F. JaCqUier, Elementi di perspettivasecondo li principii di Brook Taylor con varie aggiunte spettanti all’ottica,e alla geometria, roma 1755, Generoso Salomoni; id., Institutionesphilosophicae ad studia theologica potissimum accomodatae, tomi 1-6, Ve-nezia 1764, Simone Occhi; id., Elementa arithmeticae, algebrae, etgeometriae institutionibus physicis praemittenda auctore Francisco Jacquierex Minimorum familia primariarum per Europam academiarum socio,roma, marco Pagliarini, 1777.
15 a. LOmBardi, Elogj del Prof. Giuseppe Calandrelli e del matematicoFerroni, modena 1838.
16 Sulla figura di andrea Conti vedi Biografia di Andrea Conti scrit-ta da don Baldassarre Boncompagni de’ principi di Piombino, in “Gior-nale arcadico di Scienze, Lettere ed arti”,, t. LXXXV, Ottobre-Novembre-dicembre 1840, roma 1840, tipografia delle Bellearti, pp. 12-20.
17 Un profilo sintetico sulla figura e l’attività di Oddi venne pub-blicato, a pochi mesi dalla sua morte, negli “annali Universali distatistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio”, v. 67,1841, p. 384 a firma di i. C. Negli anni del concorso Oddi inse-gnava meccanica e idraulica presso l’Università di roma, nell’a-bito della quale pochi anni dopo scrisse due opere: Elementi di
calcolo differenziale e di Calcolo integrale ad uso dell’Università Romana,roma 1825 e Schiarimento alla Meccanica e Idraulica del prof. Ventu-roli, roma 1827. Cfr., inoltre, F. m. reNazzi, Storia dell’Universi-tà degli studj di Roma detta comunemente la Sapienza, 4 vv., roma, Pa-gliarini, 1803-1806 (rist. anast. Bologna, Forni, 1971).
18 S. PrOJa, Don Feliciano Scarpellini, in “L’album giornale lettera-rio e di Belle arti”, Vii, 43, dicembre 1840, pp. 337-340.
19 Nel 1797 il matematico Gaspard monge era a roma per dareesecuzione al trattato di tolentino, con l’incarico del prelievo dicinquecento manoscritti dalla Biblioteca Vaticana, cfr. L. PePe,La formazione... cit., pp. 302-303.
20 Cfr. S. CiraNNa, La città e il territorio nella formazione e nella pro-fessione degli Ingegneri Pontifici (XVIII-XIX secolo), in C. rOBOtti (acura di), Città Castelli Paesaggi euromediterranei. Storie rappresenta-zioni progetti, atti del Sesto Colloquio internazionale di Studi, 1-2 dicembre 2006, Castello di Carlo V Capua, Lecce, edizioni delGrifo, 2009, pp. 362-371.
21 il suo curriculum è riportato in aSr, Consiglio d’Arte, b. 1, f. 2,n. 105. a questo sostanzialmente rinvia F. PUCa, Castagnola Giu-seppe, in e. deBeNedetti (a cura di), Architetti e ingegneri a con-fronto, I l’immagine di Roma fra Clemente XIII e Pio VII, (Studi sulSettecento romano), roma 2007, pp. 222-224.
22 archivio Storico del Comune di Genova, Padri del Comune. Pra-tiche pubbliche, Filza 244, doc. 126. La descrizione porta la data
iL COrPO deGLi iNGeGNeri PONtiFiCi. GLi iNGeGNeri GiUSePPe e LUiGi CaStaGNOLa
(fig. 1). La soluzione adottata per il prolungamento del molo
di Genova era forse già maturata nei primi anni set-tanta, quando Castagnola ricevette l’incarico da deBlacas Carros di eseguire la nuova pianta del portodi ancona. il rilievo fu effettuato nella primavera del1772 con l’ausilio della tavola pretoriana e attraversoun “generale scandaglio delle profondità dell’acquemisurate a palmi romani d’architetto con la giusta di-rezione del banco di rocche o scogli di Santa Lucia”23
(fig. 2). Circa venti anni dopo, Castagnola, allora mae-stro di Nautica e primo capitano delle Barche Ponti-ficie, aveva affrontato l’insabbiamento del porto diancona su incarico di monsignore Fabrizio dionigiruffo, tesoriere generale dal 1786 al 179124, duranteil pontificato di Pio Vi (1775-1799). L’espediente escogitato per risolvere tale problema
appare raffigurato da Castagnola nella Pianta del Vec-chio e Nuovo Braccio del Porto di Ancona25 (fig. 3); essoconsisteva nel praticare alcuni “fori o siano apertureper rendere libero il corso alla naturale inclinazionedella corrente del mare, affinché possa la medesimacorrente condur seco le materie molli e fangose chetanto angustiano il detto Porto”, da cui il nome di‘Foro Castagnola’. Un’idea che probabilmente ri-prendeva la proposta dall’esperto idraulico olandeseConelius meyer avanzata nel 1685 e mai realizzata26.Le aperture vennero praticate nel nuovo braccio, o
molo Clementino, prolungato nel mare oltre l’arcodi traiano da Luigi Vanvitelli come parte integrantedel progetto voluto da Clemente Xii (1730-1740) nelquale rientra la realizzazione dell’imponente lazza-retto pentagonale. il progetto vanvitelliano, iniziatonei primi anni trenta del Settecento, venne continua-
to nel 1746 con la creazione della scogliera circolarein corrispondenza del lazzaretto e lentamente ulti-mato sotto la direzione dell’architetto Carlo mar-chionni e di suo figlio Filippo durante il pontificatodi Clemente XiV (1769-1774)27. La cospicua documentazione che accompagna la
lunga attività condotta da Castagnola relativamentealla manutenzione e al buon funzionamento dei duepiù importanti porti dello Stato Pontificio, Civita-vecchia e ancona, completamente trasformati dopole distruzioni causate dai bombardamenti della se-conda guerra mondiale, conferma ripetutamente ildiffuso apprezzamento per le competenze dell’espertod’idraulica.Sempre per volere del tesoriere monsignor ruffo,
nel marzo del 1792 una commissione di specialisti fuchiamata a esprimersi sul sistema più sicuro e sem-plice di proseguimento della “già incominciata nuo-va scogliera fuori dell’antemurale del Porto di Civi-tavecchia”28. L’analisi dello stato di fatto e i provve-dimenti da assumersi vennero elaborati dall’allora Ca-pitano Castagnola il quale evidenziò tra i problemiall’interno del bacino la presenza di massi di piccolae media grandezza29. tali blocchi erano stati prece-dentemente utilizzati per la formazione della sco-gliera, ma, specialmente quelli gettati isolati e a spez-zoni erano stati rimossi dalle mareggiate dell’ultimoinverno e si muovevano sul fondale con grave peri-colo per i bastimenti. Per evitare ulteriori dannosispostamenti, Castagnola propose un “altro stile” nelcontinuare la formazione della scogliera, ossia l’usodi “grossi scogli” sia per bloccare i piccoli massi spar-si, sia per realizzare una cordonata addossata all’an-temurale; la soluzione descritta nel dettaglio era an-
del 1778 ma, probabilmente, Castagnola era stato convocato nel-la città ligure già nel 1771, cfr. aSr, Consiglio d’Arte, b. 1, f. 2, n.105. ringrazio la dott.ssa raffaella Ponte, direttore dell’archi-vio Storico del Comune di Genova, per la cortesia con la qualeha contribuito al ritrovamento della documentazione qui citatae pubblicata.
23 aSr, Buon Governo, serie XiV, collezione di piante, mappe edisegni, n. 107.
24 Nei porti dello Stato Pontificio operavano due diverse ammi-nistrazioni marittime, la Capitaneria di porto e gli Uffici di sani-tà, entrambe dipendevano amministrativamente dal tesorieregenerale.
25 in aSr, Disegni e Piante, coll. i, cart. 2, n. 60.
26 C. meyer, Dell’innalzamento de i fondi che seguono nel Porto d’An-cona e del rimedio per sgravarlo dalli riempimenti, allegato alla parte pri-ma di L’arte di restituire a Roma la tralasciata navigazione del suo Te-
vere, roma, Lazzari Varese, 1685, citato in G. SimONCiNi, Porti epolitica portuale dello Stato Pontificio dal XV al XIX secolo, in G. Si-mONCiNi (a cura di), Sopra i porti di mare IV Lo stato Pontificio, Fi-renze 1994, pp. 9-79, in particolare pp. 39-41.
27 F. PUGNaLONi, Note sull’architettura e sulla forma del porto di An-cona, in C. mezzetti, G. BUCCiareLLi, F. PUGNaLONi, Il lazza-retto di Ancona: un’opera dimenticata, ancona, Cassa di risparmiodi ancona, 1978, pp. 244-339. il porto ebbe ulteriori modifichenegli anni successivi; tra queste, nel 1791 venne realizzata unascogliera circolare lunga circa m. 600 innestata a quella costrui-ta nel 1746 lasciando per l’accesso al porto un’apertura di m.600, ivi.
28 in aSr, Disegni e Piante, coll. i, cart. 19, n. 277.
29 Sullo formazione e sullo stato del porto di Civitavecchia cheprecede gli interventi di Giuseppe Castagnola vedi G. CUrCiO eP. zamPa, Il porto di Civitavecchia dal XV e XVIII secolo, in G. Si-mONCiNi (a cura di), Sopra i porti di mare... cit., pp. 159-232.
SimONetta CiraNNa
che presentata graficamente da una planimetria e dauno spaccato (fig. 4). La formazione di tale scogliera a protezione del-
l’antemurale era stata decretata già nel 1788 e le cri-tiche mosse nel 1792 da Castagnola, sull’uso di mas-si di piccola dimensione, vennero da lui ribadite nuo-vamente in un dettagliato promemoria redatto mol-ti anni dopo, durante l’occupazione napoleonica30. inquesti anni, infatti, il maggiore Castagnola venne no-minato ingegnere Ordinario di 1a Classe e destina-to, per continuità e per la riconosciuta competenza31,ai Porti dello Stato romano di Civitavecchia, Fiumi-cino e anzio32. il promemoria sullo stato del portodi Civitavecchia e sulle misure di manutenzione daintraprendere risponde all’incarico affidatogli dallaConsulta Straordinaria degli Stati romani con decre-to del 19 luglio 1809. in tale documento, al quale era unita una pianta ri-
levata nell’agosto del 1809, Castagnola oltre a spie-gare le caratteristiche del porto descrisse alcune mi-sure da lui intraprese negli anni precedenti per mi-gliorarne la funzionalità. Per distruggere alcuni ban-chi di rocce vive che danneggiavano le gomene deipiccoli e grandi bastimenti ormeggiati, egli aveva uti-lizzato per tre stagioni consecutive la tecnica inno-vativa dell’uso di mine sott’acqua33. Un sistema che,secondo il maggiore, doveva essere ripreso “per di-struggere li altri Banchi vivi che sonosi residuati”.Oltre a questo, non meno necessario secondo l’in-gegnere era attivare lo “spurgo del Fango, ed arenacoll’opera delle Bette, e Puntoni, e delle tenaglie edaltri ordegni” per rimuovere dal fondo le “pietre mo-vibili”; gli attrezzi erano tutti presenti al porto di Ci-vitavecchia. alla manutenzione interna doveva poi affiancarsi
quella fondamentale dell’antimurale, o mole traia-na, “la bell’isola artificiosamente fatta (...) che fa fron-te ed impedisce l’ingresso nel Porto alle grosse ma-reggiate prodotte dell’impetuosi venti di traversiadella costa”, e, quindi, della scogliera posta nel suofianco esterno34. La costruzione di tale scogliera conmassi non inferiori a 400 palmi cubi, indicata da Ca-stagnola nel 1792 e presumibilmente adottata in quel-lo stesso anno, aveva portato a una sua stabilità, marestavano ancora sparsi i piccoli massi precedente-mente adoperati35. Castagnola suggeriva sia di ri-muovere dalle due punte dell’antimurale tali picco-li e pericolosi spezzoni, sia di rafforzare ulteriormentela stabilità della scogliera e dell’antimurale con lacreazione di due speroni e l’uso di un “buon mate-riale”, forse un legante, per unire i grossi macigni. Lacava da cui erano stati estratti negli anni precedentii grandi blocchi, secondo l’ingegnere, ormai ne pro-duceva di meno sicuri “piuttosto mal sinceri, venatie facili a spezzarsi”, egli quindi proponeva di servir-si di un’altra cava sita al monte argentale. Nel chiu-dere la sua relazione il maggiore indicava la necessi-tà di altri specifici restauri, e tra questi di ‘rinfresca-re’ la scogliera al molo del Bicchiere “che pone il pie-de sotto la fortezza colla direzione circolare versoPonente in estensione di palmi 1220 in retta linea”,e di riattivare immediatamente la lanterna del faro,per poi, in estate, potenziarne la luce “per renderlapiù da lontano visibile ai Bastimenti”. i lavori elencati nel promemoria erano poi esami-
nati nel dettaglio in una circostanziata descrizione diopere, strumenti, maestranze e costi, datata 18 otto-bre 1809. Nella stessa occasione l’ingegnere, sempreal fine di incrementare il commercio della città di Ci-vitavecchia, presentò alla Consulta il progetto per la
30 aSr, Buon Governo, serie iii, b. 218, f. Carte riguardanti il portodi Civitavecchia.
31 Limitatamente al porto di Civitavecchia Giuseppe Castagno-la eseguì scandagli: nel giugno 1798, in qualità di capitano, ri-prodotto nella splendida “Pianta esatta del Porto e darsena diCivitavecchia che si umilia a sua eccellenza r.ma monsignorLitta arcivescovo di tebe e tesoriere Generale di Nostro Si-gnore” conservata in aSr, Disegni e piante, coll. i, cart. 19, n. 278;nell’aprile del 1805, in qualità di maggiore, riportato nella “Pian-ta del Porto e darsena di Civitavecchia...” in aSr, Disegni e pian-te, coll. i, cart. 20, n. 294.
32 dallo “Stato nominativo degli impiegati nell’amministrazio-ne dei Fiumi, Ponti e Strade per il dipartimento del tevere, eser-cizio dell’anno 1810” vistato nel mese di gennaio dall’ingegne-re in Capo andrea Vici, in aSr, Miscellanea Governo Pontificio, An-tichità e Belle Arti, 88bis, cass. 31, f. 34.
33 Secondo Castagnola tali banchi si erano formati nel corso dei
secoli dopo la costruzione del porto, come dimostrava la pre-senza sia al loro interno “di pezzi di cocciami e dei chiodi”, siadi un fondale di fango su cui essi poggiavano. Castagnola ave-va individuato lo strato fangoso “con il trapano di ferro, allor-ché facevansi li buchi per uso delle mine dentro delli banchi me-desimi, mentre arrivato il trapano alla profondità di sette in ottopalmi, cadeva uno, o due altri palmi ad un tratto da per se stes-so, immergendosi nel fango, che esisteva di sotto”, in aSr, BuonGoverno, serie iii, b. 218, f. Carte riguardanti il porto di Civitavecchia.
34 Per la realizzazione di questa scogliera, come detto decisa nel1788, Giuseppe Castagnola aveva individuata una cava non mol-to lontana dal porto.
35 tali piccoli scogli “con il loro continuo rotolare hanno ridot-to se stessi in tante piccole breccie che formano un letto mobi-le e mal sicuro, si perché col sovrapporvi in seguito li novi sco-gli dell’indicata grossezza di palmi quattrocento cubi, si trova-no anch’essi instabili dal rotolamento inferiore delle sopraddet-te breccia”, Ibidem.
iL COrPO deGLi iNGeGNeri PONtiFiCi. GLi iNGeGNeri GiUSePPe e LUiGi CaStaGNOLa
Fig. 3 – Giuseppe Castagnola, 1786-1791, Pianta del Vecchio e Nuovo Braccio del Porto di Ancona (ASR, Disegni e Piante, coll.I, cart. 2, n. 60)
Fig. 4 – Giuseppe Castagnola, 1792, Pianta esatta dell’Antemurale di Civitavecchia (ASR, Disegni e Piante, coll. I, cart. 19, n.277)
SimONetta CiraNNa
costruzione di un lazzaretto e di un suo porto per“ricevere li Bastimenti in contumacia ed altri per licarichi e discarichi”. il sito scelto era denominato S.Gordiano ed era posto presso la punta detta del Pe-coraro a circa un miglio e mezzo a est di Civitavec-chia36.a testimoniare l’intensità del lavoro svolto da Ca-
stagnola e la richiesta della sua personale presenzasono i sopralluoghi condotti lungo le coste dello Sta-to Pontificio37. Nel marzo del 1810, a esempio, con-temporaneamente ai lavori di manutenzione dellemacchine necessarie allo spurgo del porto di Civita-vecchia38, Castagnola ricevette l’incarico da Josephmarie de Gerardo, membro della Consulta Straor-dinaria e ministro dell’interno, di ispezionare il por-to a canale di Fiumicino “cioè quel tratto di Canaledel Fiume tevere, che resta fra lo Spalmadore39, e la
Foce di detto Fiumicino”40. il porto a canale presen-tava lungo tale percorso ingenti danni alle palizzatelaterali, guasti determinati sia dalle mareggiate in-vernali sia dagli straripamenti del fiume. Nonostan-te l’ingegnere attestasse l’intervento dell’appaltatoredei lavori di manutenzione, Pietro Poggioli41, per ilrifacimento delle palizzate rovinate, egli riconobbenecessario migliorare tale manutenzione mediantel’aumento della lunghezza delle ‘passonate’ della spon-da sinistra, ossia di portare l’altezza dei pali da 55 a70 palmi42.ripristinato il Governo Pontificio, nell’estate del
1815 il maggiore eseguì con successo due fondazio-ni all’antemurale di Civitavecchia43; lavori descritti inalcune sue perizie redatte già nell’autunno-invernodel 181444 e raffigurati sia nella Pianta esatta dell’Ante-murale del Porto di Civitavecchia con suo corrispondente Pro-
36 Ibidem. anche questo promemoria era corredato da una pla-nimetria. Nel testo di V. aNNOVazzi, Storia di Civitavecchia dallasua origine fino all’anno 1848, roma, tipografia Ferretti, 1853, l’au-tore a p. 478 scrive “L’ingegnere Civitavecchiese sig. Luigi Ca-stagnola redasse un bel tipo e scandaglio per la costruzione delLazzaretto in discorso, e sul commendato lavoro del Castagno-la la nostra Camera di Commercio ha presentato al Governo nel1843 un progetto utilissimo sott’ogni rapporto, che speriamopotrà effettuarsi non appena lo permetteranno le circostanzemeno angustiose del pubblico erario”. Non è chiaro se il ri-chiamo a Luigi Castagnola, figlio di Giuseppe, sia un errore del-lo scrivente o se, più probabilmente, questi avesse portato avan-ti il progetto paterno. La pianta del lazzaretto è pubblicata in B.BLaSi, Della strada ferrata pia Cassia e del porto neroniano in Anzio,roma, Contedini, 1846, p. 49.
37 da un promemoria del 21 febbraio 1810 inviato da Castagnolaal prefetto del tevere, si apprende che egli dimorava con la suanumerosa famiglia in Civitavecchia nel palazzo della signora mar-chesa Patrizi, in aSr, Buon Governo, serie iii, b. 218, f. Carte ri-guardanti il Porto di Civitavecchia.
38 Ivi, f. Porto di Civitavecchia, documento firmato da Castagnola il16 marzo 1810. in questo resoconto l’ingegnere chiede che levenga affiancato come ingegnere aspirante suo figlio Giovanni,allora ventiquattrenne, e come conduttore Luigi ravenna, “di35 anni circa che ha servito per lungo tempo in qualità di Pilo-ta nella marina del passato governo”. L’attenzione sul porto diCivitavecchia era sostanzialmente motivata dall’interesse di svi-luppare i rapporti commerciali, consentendo un più sicuro ac-cesso e ancoraggio ai “grossi bastimenti francesi”.
39 questo era senz’altro il luogo dove avveniva l’operazione dispalmare le carene delle navi con lo ‘spalmo’, pattume di sego,pece, olio di pesce o simili.
40 Ibidem. La relazione datata roma 9 marzo 1810 porta la firmadel maggiore Giuseppe Castagnola in qualità di ingegnere deiPorti dello Stato romano e il visto e l’approvazione dell’inge-gnere in Capo andrea Vici. Nel 1810 Castagnola aveva anchericevuto l’incarico di eseguire una perizia sullo stato del portodi anzio, ivi, b. 218, carte sciolte, da una lettera inviata il 22 no-
vembre 1810 da andrea Vici al barone Camille de tournon, Udi-tore al Consiglio di Stato e Prefetto del dipartimento del teve-re.
41 Poggioli aveva avuto l’incarico nel 1809, sotto il governo pon-tificio, per la durata di 18 anni e per una somma di scudi 4500.a scriverlo è l’ingegnere in capo andrea Vici in una lettera dell’11marzo 1810 inviata a Camille de tournon. Ibidem.
42 relativamente alle passonate della riva destra, queste presen-tavano problemi connessi allo scolo delle acque penetrate at-traverso rotture degli argini del fiume “da Ponte Galera fino allaVignola. acque che portavano “dentro lo stesso Porto molteterrosità, che fanno sempre più diminuire li fondi innanzi al-l’imboccatura di esso Porto, che è il principal male del medesi-mo perché rende difficile l’entrata ai Bastimenti”.
43 aSr, Consiglio d’Arte, b. 1, f. 2, n. 105.
44 aSr, Computisteria generale, div. Viii, Soldatesche e marina, b. 1. idanni riguardavano anche gli edifici posti sull’antemurale, tra iquali, due magazzini che presentavano danni ai tetti. La conti-nuità dei lavori di manutenzione negli anni del governo napo-leonico è ulteriormente documentata da un rapporto firmato daCastagnola il 27 maggio 1811 nel quale l’ingegnere precisò i dis-sesti presenti nella mole traiana detta antemurale del Porto diCivitavecchia. Più esattamente, egli scrisse: “il predetto ante-murale si trova in uno stato molto malmenato dall’impeto del-le onde, ed in specie nelle due punte di esso, le quali restandoallo scoperto, ed esposte più che ogni altra parte alli reiterati col-pi di mare, ne derivò particolarmente nella punta di Levante cheriguarda il mezzogiorno uno sgrottamento di palmi diecisette,che produsse il distacco di un grosso pezzo di essa mole, conevidente pericolo di restare rovinata la Lanterna, mentre restaindebolito con il rilasso di detto macigno l’angolo del Bastioneche si trova di sopra e che consente colla stessa Lanterna”. Ca-stagnola segnalò anche altri danni e distacchi di massi, solleci-tando il restauro prima di un prevedibile peggioramento, e in-dicò come necessario “di proseguirsi la costruzione della nuo-va scogliera a similitudine di ciò che è stato fatto in una porzio-ne dalla parte di Levante di detto antemurale”, in aSr, BuonGoverno, serie iii, b. 218, f. Carte riguardanti il Porto di Civitavecchia.
iL COrPO deGLi iNGeGNeri PONtiFiCi. GLi iNGeGNeri GiUSePPe e LUiGi CaStaGNOLa
Fig. 5 – Giuseppe Castagnola, 1816, Pianta e profili del molo nel Porto di Ancona detto la Graticola (ASR, Disegni e piante, coll.I, cart. 2, n. 81)
SimONetta CiraNNa
filo, il tutto delineato dell’ottobre del 181545, sia, due annidopo, nella Pianta esatta della Mole Trajana del Porto diCivitavecchia.questo secondo disegno46 probabilmente affianca-
va la perizia sui lavori necessari alle fondazioni almazzocco elaborata da Castagnola nel giugno del181747. Nella pianta appaiono ben evidenziati gli‘sgrottamenti’ dell’antemurale causati dalle mareg-giate dell’inverno del 1816. il rafforzamento di tali fondazioni doveva costitui-
re un’opera di particolare difficoltà, come traspareda un lato dal ‘provocatorio’ invito di Castagnola aun sopralluogo dell’architetto raffaele Stern, dall’al-tro dalla sua richiesta di personale qualificato. Circaquest’ultimo, l’ingegnere chiese esplicitamente l’in-vio sia del “forzato tommaso riccioli detto il Paron,che si ritrova in Castel S. angelo, essendo marinaro,ed insieme buon sangozzatore”, sia del capo mastrod’ascia Bartolomeo Vignola, allora in ancona, poi-ché a Civitavecchia mancavano operai altrettanto ca-paci48. Nello scambio di epistole che accompagnò tale im-
presa emerge, più volte, l’interesse di Giuseppe Ca-stagnola a promuovere suo figlio Luigi, già ufficialedi marina, di cui egli chiese il momentaneo trasferi-mento a Civitavecchia dal porto di ancona dove sta-va operando in veste di suo coadiutore49.La presenza di Luigi ad ancona nel 1817, è docu-
mentata, anche, dal suo rilievo della zona portualeestesa dalla Portella Panunzi al Palazzo dell’appan-naggio50.L’anno precedente, invece, a ispezionare il porto di
ancona, era andato Giuseppe Castagnola, elevatoproprio nel 1816 a tenente colonnello. Nel mese disettembre, egli sollecitò ulteriori finanziamenti siaper lo spurgo del porto, sia per il restauro che stavaeseguendo alla fondazione del molo detto della Gra-ticola51. tali risarcimenti appaiono rappresentati nel-la pianta e nei profili dello stato del molo preceden-te e successivo ai lavori compiuti nei giorni 10 e 11del settembre del 181652 (fig. 5); opere che venneroanche riportate, esattamente alla lettera “k”, nella det-taglia pianta del porto anch’essa delineata, nello stes-so anno, dal tenente colonnello Castagnola53 (fig. 6).
45 in aSr, Disegni e piante, coll. i, cart. 19, n. 280, “Pianta esattadell’antemurale del Porto di Civitavecchia con suo corrispon-dente Profilo, il tutto delineato in Ottobre dell’anno 1815, cioèdopo eseguite le Fondazioni che per ordine di Sua eccellenzareverendissima monsignor ercolani tesoriere Generale di No-stro Signore Papa Pio Vii furono in detto anno fatte al nuovoScalo ed alla Punta di mezzogiorno, la quale viene dettagliatanei due piccoli annessi disegni fatti in dupla Scala, indicanti l’u-no lo stato di detta punta prima della Fondazione, e l’altro dopodi essere stata questa effettuata” segue la legenda. La tavola èfirmata da Giuseppe maggiore Castagnola ingegnere dei Portidello Stato Pontificio e maestro di Nautica.
46 il disegno, eseguito da Giuseppe Castagnola presumibilmen-te nella primavera-estate del 1817, evidenzia sia i restauri al-l’antimurale condotti nel 1815, sia i danni da esso subiti dallemareggiate del 1816, in aSr, Disegni e piante, coll. i, cart. 19, n.281, “Pianta esatta della mole trajana del Porto di Civitavecchiacomunemente detta antemurale coll’indicazione ove esistono ivisibili sgrottamenti di essa mole, e delineazione delle loro ri-spettive concavità”.
47 “Perizia di una fondazione da farsi nel presente anno 1817avanti il mazzocco dell’antemurale del Porto di Civitavecchia eprecisamente nel sito accennato in Pianta dalle Lett.e X.y.z. perla quale si stima occorrere come segue …”, in aSr, Computiste-ria generale, div. Viii, Soldatesche e marina, b. 1. il 20 gennaio del1817 Castagnola aveva già preso visione e approvato la periziadel capo mastro muratore Clemente mollica sul “ lavoro da far-si per ora nella Controcalata del molo del Bicchiere nel Porto diCivitavecchia, affine non rovini nel Porto parte di detta contro-calata, conforme positivamente viene minacciata dalle conside-rabili crepature manifestate giorni sono all’occasione di una gros-sa seguita mareggiata”, ibidem.
48 Ibidem, lettere del 14 e del 18 luglio 1817.
49 Luigi appare come capitano del Porto di Civitavecchia nell’a-prile del 1810, in aSr, Buon Governo, serie iii, b. 218, f. Porto diCivitavecchia. da una “Nota di tutti i subalterni che nei rispettiviloro rami si sono distinti con attività e con zelo nelle due fon-dazioni eseguite in Civitavecchia nei mesi di agosto e Settem-bre 1817” si evince, invece, la presenza del figlio Giovanni Ca-stagnola “giovane di aspettazione, di cognizioni, di zelo, e di at-tività, non si è mai mosso né di giorno né di notte dai Ponti del-la fondazione tanto in tempo che si è eseguita, quanto nella co-struzione delle Paratie insistendo e dirigendo i mastri sé d’ascia,che ca(...?) e muratori…”, oltreché di un antonio e di un Nic-cola Castagnola. in particolare, Niccola ha perfetta “cognizio-ne dei Legnami atti alla Costruzione essendo egli medesimo Co-struttore e Perito in tal ramo”, in aSr, Computisteria generale, div.Viii, Soldatesche e marina, b. 1.
50 il disegno acquerellato è stato esposto alla mostra tenutasi adancona nel 2007, vedi m. POLVerari, a cura di, Ancona nel pri-mo Ottocento (1800-1830), catalogo mostra 25 marzo - 10 giugno2007 Pinacoteca Comunale di ancona, ancona 2007, p. 24.
51 archivio di Stato di ancona (aSan), Prefettura del Metauro e de-legazione di Ancona, titolo XVi, rubrica 3, b. 1046. documentodel 5 settembre 1816 inviato da Giuseppe Castagnola a monsi-gnor Ludovico Gazzoli delegato apostolico in ancona e presi-dente della Commissione di Sanità. Giuseppe il 26 ottobre del-lo stesso anno inoltrò un’ulteriore richiesta di finanziamenti, giàsollecitati dal figlio Luigi, per il pagamento degli operai impe-gnati nei lavori del porto, ibid.
52 aSr, Disegni e piante, coll. i, cart. 2, n. 81.
53 aSr, Disegni e piante, coll. i, cart. 2, n. 65.
54 esattamente il 6 aprile 1816 con lettera inviata da Castagno-la a monsignor Gazzoli, in aSan, Prefettura del Metauro e delega-
iL COrPO deGLi iNGeGNeri PONtiFiCi. GLi iNGeGNeri GiUSePPe e LUiGi CaStaGNOLa
Pochi mesi prima, Giuseppe aveva accettato l’inca-rico di effettuare un sopralluogo al porto-canale diSenigallia al fine di stimare le riparazioni necessarieal suo funzionamento54. i lavori vennero condotti tral’aprile e il luglio del 1816 e previdero l’utilizzo sia dimacchine per lo spurgo sia di forzati come mano d’o-pera, trasferiti da Castagnola da ancona a Senigal-lia55.L’assenza di Giuseppe Castagnola dalla lista degli
ingegneri prescelti tra i concorrenti del 1817 fu do-vuta esclusivamente alla sua morte; tuttavia il suo pre-stigio dovette assumere un peso non secondario nel-l’accoglimento della domanda del figlio Luigi. É que-sto, infatti, ad apparire, nel 1818, nell’Elenco degli In-gegneri Pontifici di Acque e Strade come ingegnere ordi-nario di 2a classe “per i lavori del Porto di Civita-vecchia”, e, nel gennaio 1820, nella Pianta del Perso-nale come ingegnere, con lo stesso grado, della dele-gazione di Civitavecchia. a partire dal 1820, quindi,Luigi, insieme all’ingegnere aspirante antonio de ro-manis, assunse la responsabilità dei lavori delle stra-de, delle acque e delle fabbriche camerali della dele-gazione di Civitavecchia, nonché lo specifico com-pito “della esecuzione de’ lavori del Porto colla sub-ordinazione in questa parte all’ingegnere in Capo de’lavori idraulici Camerali”, ossia del cavaliere Ludo-vico Linotte56.il sintetico profilo di Luigi Castagnola, tracciato dal
Consiglio d’istruzione sulla base degli attestati pre-sentati al concorso del 1817, oltre a confermare lasua formazione presso il padre ricostruisce la carrie-ra militare dell’allora quarantenne aspirante ingegne-
re. esattamente: “nel 1784 fù patentato alfiere so-prannumero di marina. Nel 1797 fù appoggiato alCorpo del Genio militare in Civita Vecchia. Nel 1804col grado di tenente ebbe il comando di una canno-niera57. Nel 1806 gli fù conferita dal monsignore San-te tesoriere la Patente di ingegnere idraulico Co-adiutore a suo padre per la ispezione de’ lavori ne’Porti dello Stato, al quale servizio fu prestato anchein tempo di disarmo. Nel 1809 fù nominato Capita-no del Porto di Civita Vecchia coll’incarico generaledi sanità di detto Porto e del Littorale romano. Nel-l’ispezione de’ lavori de Porti serve senza alcuno sti-pendio”58.in continuità con l’attività paterna, quindi, la ma-
nutenzione del porto di Civitavecchia passò a LuigiCastagnola il quale, infatti, figura come esecutore de-gli scandagli di tale scalo laziale a partire dal 1818 ealmeno fino ai primi anni del decennio successivo59.dal gennaio del 1820, inoltre, la sua mansione in-
cluse anche la manutenzione delle strade provincialidella delegazione di Civitavecchia, come attesta, tral’altro, la visita con relativo verbale condotta sopral-luogo nell’agosto di quell’anno insieme all’ispettoreGiambattista martinetti, membro del Consiglio d’ar-te incaricato di verificare la conformità dei lavori ese-guiti60.a tale ispezione partecipò anche l’ingegnere aspi-
rante Odoardo Poggi, il quale aveva sostituito anto-nio de romanis probabilmente già nel febbraio del182061. anche Poggi tuttavia fu presto trasferito e, al-meno dal settembre del 1821 ad affiancare Luigi Ca-stagnola venne inviato l’ingegnere aspirante dome-
zione di Ancona, titolo XVi, rubrica 3, b. 1046.
55 Ibidem. tali disposizioni sono comunicate da Castagnola a Gaz-zoli nella lettera del 21 aprile 1816.
56 Precisamente: “elenco degli ingegneri Pontifici di acque, eStrade distribuiti per ciascun servizio, a cui si trovano destinati,e loro rispettive attribuzioni” redatto il 31 gennaio 1818 e fir-mato dal cardinale ettore Consalvi, e “Pianta del Personale delServizio di acque, Strade, e Fabbriche da adottarsi al Primo Gen-naro 1820” firmata dal cardinale ettore Consalvi dalla Segrete-ria di Stato il 25 dicembre 1819, in aSr, Buon Governo, serie i, b.9 bis.
57 Luigi compare con il grado di sottotenente nella lista di soldodegli equipaggi di legni da guerra del dicembre del 1807 citata in C.CaLiSSe, Storia di Civitavecchia, Firenze, S.a.G. Barbera, 1936, p.619 n. 1. Lo stesso autore lo riporta come capitano del porto diCivitavecchia, ivi, p. 626 n. 3.58 aSr, Consiglio d’Arte, b. 1, f. 2, n. 106. Luigi chiedeva di esse-re inserito nel Corpo degli ingegneri con “la carica di sotto ispet-tore mobile de’ lavori idraulici Nazionali giusta l’art. 154 § 5 e
l’art. 396 del motu Proprio”.
59 aSr, Disegni e piante, coll. i, cart. 20, nn. 295, 296 e 297. que-st’ultima, datata 1824, riporta anche i lavori eseguiti alla scoglie-ra, “Pianta del Porto e darsena di Civitavecchia col generaleScandaglio de’ fondi rilevati in misura metrica e distinti con nu-meri in Negro i fondali ch’esistevano nell’anno 1823, ed in ros-so quelli ritrovati in decembre 1824 nei siti ove ha travagliato lamachina del Puntone a Vite. La scogliera fatta nell’esercizio su-detto e distinta dal colore rosso con le rispettive Sezioni alle let-tera a,b”.
60 “Verbale e rilievi fatti dall’ispettore martinetti membro delConsiglio d’arte nelle Strade Provinciali nelle delegazioni di Ci-vitavecchia nel anno 1820”, in aSr, Buon Governo, serie i, Stra-de e Acque 1801-1831, b. 9 bis. Sull’attività di Luigi Castagnola neiprimi anni venti vedi anche aSr, Delegazione di Civitavecchia (1807-70), Acque – Strade – Fabbriche Camerali – Edifici militari, b. 69 (1820)e b. 89 (1822).
61 Cfr. d. LOdiCO, De Romanis Antonio, in e. deBeNedetti, acura di, Architetti e ingegneri a confronto.. , cit., pp. 255-257.
SimONetta CiraNNa
nico teoli62. Nonostante il romano teoli fosse coetaneo di Lui-
gi, nel resoconto della sua carriera predisposto per ilconcorso del 1817 appaiono riportati unicamente i“premi in Ornato, Storia e mitologia, Costumi, edanatomia”, ottenuti nell’accademia di San Luca, egli studi teorici condotti con alcuni tra i più noti pro-fessori del Collegio romano63. in particolare, teoliaveva studiato le matematiche Sublimi con Giusep-pe Calandrelli e andrea Conti e la Fisico-Chimicacon Feliciano Scarpellini. Nella sua mansione di in-gegnere aspirante fu teoli a firmare, in vece di Lui-gi Castagnola, nel 1823 e nel 1824, alcuni interventidi manutenzione nelle fabbriche camerali. in parti-colare, in quei due anni, egli seguì le trasformazionidei locali destinati a carcere all’interno del duecente-sco palazzo comunale di Corneto, l’odierna tarqui-nia64, e anche piccole opere di restauro e di manu-
tenzione sia al “Bagnetto detto della macina” delladarsena di Civitavecchia sia al palazzo apostolico del-la stessa città65. Già nei primi mesi del 1825 è nuovamente Luigi,
forse tornato da un incarico maggiore, a seguire i la-vori di manutenzione delle carceri sia di Civitavec-chia sia di quelle collocate nella fortezza di Palo66.La specifica cognizione della manutenzione degli
scali marittimi probabilmente determinò il suo in-tervento al porto-canale di Fano, dove nel 1830 in-sieme all’ingegnere Pancaldi egli delineò una piantaper la sistemazione dell’imboccatura del porto chegià nel 1807 risultava ridotta da un grosso banco disabbia67. Su tale non realizzato progetto si continuòa lavorare negli anni successivi68 e ancora nel giugno1840 Luigi Castagnola firmò il disegno titolato “Por-to di Fano”69. agli stessi anni trenta va pure ricon-dotta la Memoria del fiume Aniene scritta da Luigi in
62 Nel 1823 Poggi venne trasferimento dalla delegazione di ma-cerata alla Bonifica Pontina, in aSr, Buon Governo, serie i, Stra-de e Acque 1801-1831, b. 9 bis. il distaccamento di teoli a Civi-tavecchia risale invece al 26 settembre del 1821, in aSr, Com-putisteria generale, div. i, b. 92, f. 11 Roma Consiglio d’Arte Corri-spondenza per il personale degli ingegneri Competenze.
63 aSr, Consiglio d’Arte, b. 1, f. 2, n. 97.
64 il “Piano di esecuzione dei lavori occorrenti al pubblico car-cere di Corneto” fu redatto da teoli il 26 febbraio 1823, in aSr,Computisteria generale, div. i, bb. 30 e 31. Sulle trasformazioni delpalazzo comunale di tarquinia nel corso dei secoli vedi m. a.L. meNGaLi, Il Palazzo comunale di Tarquinia. Studio storico e lineeguida per un intervento, quaderni di architettura e restauro, 3,roma 2001.
65 i lavori al ‘bagnetto’ vennero seguiti da teoli nel luglio del1824, mentre in data 31 maggio 1824 egli aveva redatto la peri-zia dei lavori da condursi al Palazzo apostolico di Civitavecchia,in aSr, Computisteria generale, div. i, b. 31.
66 Ibidem. Nell’ambito dei lavori alle fabbriche camerali, l’operadi manutenzione o di adeguamento a carceri di edifici di diver-sa destinazione costituisce una delle attività ricorrenti per gli in-gegneri responsabili delle diverse delegazioni dello Stato ponti-ficio.
67 Si tratta, certamente, del bolognese Pietro Pancaldi che avevaa lungo lavorato nelle commissioni sul reno e che venne no-minato ispettore nella Legazione di Bologna. Per il suo curricu-lum vedi in aSr, Consiglio d’Arte, b. 1, f. 1. il progetto, conser-vato presso la Biblioteca Federiciana di Fano, Progetti e disegni delporto di Fano, è riprodotto in P. Sorcinelli, Vicende tecniche del por-to di Fano in epoca moderna, in “Fano”, supplemento al n. 5, 1974,del “Notiziario di informazione sui problemi cittadini”, pp. 83-102, la figura è a p. 99. Lo stesso autore cita, inoltre, un proget-to Castagnola datato 4 aprile 1804 accompagnato da una rela-zione dell’ingegnere Bracci “che illustra i vantaggi che il portodi Fano poteva apportare ai paesi limitrofi e alla stessa roma”,
ivi, p. 92. anche se questa più antica soluzione è probabilmen-te da attribuire a Giuseppe Castagnola, certamente Luigi dove-va conoscerla.
68 in aSr, Disegni e Piante, coll. i, cart. 26, n. 29, la cartella con-tiene 4 tavole numerate: la “tav. 1a - Pianta del Canale detto laLiscia dal Ponte storto al suo sbocco in mare costituente il Por-to a Canale di Fano colla indicazione in rosso dei lavori ideati,e in piccola parte eseguiti per la restaurazione del Porto mede-simo” non datata; la “tav. 2a - Pianta Prospetti, e Sezioni deltratto di nuovo molo destro eseguito negli anni 1832, e 1833come parte dei Lavori di radicale restaurazione del Porto a Ca-nale di Fano”; la “tav. 3a – Pianta Profilo e Sezioni del piccoloGuardiano, e Penello costrutto a Levante del nuovo molo de-stro, quantunque non designato nel primitivo Progetto dei Si-gnori ingegneri Pancaldi e Castagnola” non datata; la “tavola4a - Profilo del Canale detto la Liscia dal Ponte storto all’estre-mità dei moli ossia Palate di Legno costituenti la Bocca attualedel Porto di Fano, e quindi per metri 212 protratto in mare indirezione dell’asse dell’ultimo tronco del Canale” non datata.i disegni non sono firmati e il riferimento nella tavola 3 al pro-getto Pancaldi-Castagnola non consente di attribuire agli stessiingegneri anche questa proposta. inoltre, è probabile che fac-ciano parte di questa serie anche le due tavole rilegate insieme,senza data e firma, numerate “tavola 5a” di cui solo la prima hal’intestazione “Sezioni del Canale del Porto di Fano al terminedel muro circolare sotto la Liscia, allo sbocco in mare”, in aSr,Disegni e Piante, coll. i, cart. 26, n. 30. alcune notizie sui lavoriPancaldi-Castagnola al porto di Fano si ritrovano annotate neldiario del fanese tommaso massarini al giorno 3 agosto 1833.in queste righe l’autore traccia una quadro negativo del Corpodegli ingegneri Pontifici – che definisce “infame”. Un giudizioche però non riguarda i due tecnici, cfr. G. BOiaNi tOmBari, acura di, Cronaca fanestre o siano memorie delle cose più notabili occorsein questi tempi nella città di Fano. Notate per mio piacere da me TommasoMassarini Fanese, Nuovi Studi Fanesi, quaderno n. 6, Fano, Bi-blioteca Comunale Federiciana, 2001, pp. 174-175.
69 Si tratta di una tavola comprensiva di una pianta, sezioni e unprofilo conservata in aSr, Disegni e Piante, coll. i, cart. 26, n. 30.
iL COrPO deGLi iNGeGNeri PONtiFiCi. GLi iNGeGNeri GiUSePPe e LUiGi CaStaGNOLa
Fig. 6 - Giuseppe Castagnola, 1816, Pianta esatta del Porto di Ancona (ASR, Disegni e Piante, coll. I, cart. 2, n. 65)
Fig. 7 - Giuseppe Della Gatta, 29 ottobre 1820, Porto di Ancona. Nuova Macchina da istituirsi per estrarre le materie indurite nelfondo del Porto al ridosso delle Portelle e Molette (ASR, Disegni e Piante, coll. I, cart. 128, n. 40)
SimONetta CiraNNa
merito ai problemi connessi al corso di questo im-petuoso corso d’acqua70. Fra il 1832 e il 1835, infat-ti, per volontà del pontefice Gregorio XVi, l’archi-tetto e archeologo romano Clemente Folchi, nel 1820ingegnere in capo nel Corpo degli ingegneri ponti-fici, eseguì il traforo del monte Catillo per l’inalvea-zione del fiume aniene, con la creazione della ca-scata e della villa Gregoriana di tivoli.La formazione e le prime esperienze professionali
di Luigi Castagnola, selezionato tra i candidati delconcorso del 1817 e inquadrato nel Corpo pontifi-
cio con la qualifica di ingegnere ordinario di 2a clas-se, costituiscono un esempio di una preparazioneprofessionale acquisita interamente nell’ambito del-la marina militare.al Corpo tuttavia ebbero accesso anche figure dal
profilo formativo diverso, come quella del romanoGiuseppe della Gatta, di un anno più giovane di Lui-gi, che assunse nel 1818 e poi nel 1820 la gestionedella delegazione di ancona, affiancato dall’ingegnereaspirante Luigi Orioli e con lo stesso speciale man-dato della manutenzione del porto71.
70 Memoria del fiume Aniene di Luigi Castagnola ingegnere idraulico, inBiblioteca Nazionale di roma, mss. Vittorio emanuele, ms. 699,Oddi Giuseppe, Carpi Pietro, Folchi Clemente, Diamilla Gaetano, Rap-porto e discarico completo della Commissione dell’Aniene, il testo è ri-portato alle cc. 9-12.
71 quest’ultima, come per Luigi Castagnola, subordinata all’in-gegnere in Capo dei lavori idraulici Camerali, Ludovico Linot-te Vedi i già citati: Elenco degli Ingegneri Pontifici di Acque, e Strade
del 1818 e la Pianta del Personale del 1820 firmati dal cardinaleConsalvi , in aSr, Buon Governo, serie i, b. 9bis. Sull’attività diGiuseppe della Gatta cfr. S. CiraNNa, Practice, Empiricism andScience inside the Corpo degli Ingegneri Pontifici. The Activity of GiuseppeDella Gatta in the District of Ancona (1817-1836), in K. e. KUr-rer, W. LOreNz, V. WetzK (a cura di), Proceeding of Third Inter-national Congress on Construction History, Brandenburg Universityof technology Cottbus (Germany) 20-24 may 2009, Branden-burg University of technology Cottbus 2009, 1, pp. 377-384.