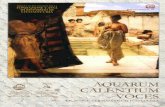El comerç d'art japonès a Barcelona, 1887-1915 (Locus Amoenus, 10, 2009-2010, pp. 259-277)
La circolazione monetaria a Verona in età romana: i dati dei lavori d'Adige (1887-1894)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La circolazione monetaria a Verona in età romana: i dati dei lavori d'Adige (1887-1894)
in collaborazione con
con il contributo di
S.A.V. onlus - cinque per mille 2011 (redditi 2010) cinque per mille 2012 (redditi 2011)
Iniziativa editoriale promossa e realizzata da
SOCIETÀARCHEOLOGICA VENETAONLUS
FondazioneCassa di Risparmiodi Padova e Rovigo
ISSN 0392-9876
ARCHEOLOGIA VENETAXXXVI – 2013
Miscellanea di studi
SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ONLUS - PADOVA
Comitato scientifico:
SIMONETTA BONOMIGIAN PIETRO BROGIOLOGIANPAOLO CANDIANI
FRANCESCO COZZA - direttore responsabileGIOVANNI GORINI
MICHELANGELO MUNARINIELENA PETTENÒMARISA RIGONI
ANGELA RUTA SERAFINIGIOVANNA TOSI
PAOLA ZANOVELLO
© 2014 - Società Archelogica Veneta Onlus - Padova, Corso Garibaldi, 41; c.f. 80009900285Casella postale n. 722 - 35122 Padova, tel. 347.9179129
E-mail: [email protected] web: www.archeovenetaonlus.it
Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675
Registri delle Organizzazioni di Volontariato:Regione del Veneto n. PD 0514
Provincia di Padova n. 226/dComune di Padova n. 699
Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell’8.2.1978
La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della S.A.V. in regola con la quota sociale.
Progetto grafico e impaginazione: Francesco CozzaRealizzazione grafica al computer: Giuseppe Manfrin
Stampa: Nuova Grafotecnica snc - 35020 Casalserugo, via L. Da Vinci, 8 - tel. 049.643195
INDICE
Ai margini dell’urbanesimo. Le comunità montane dell’Italia settentrionale in un’età di cambiamenti
Mara Migliavacca
Insediamenti romani tra Berici ed Euganei lungo il tracciato dell’autostrada A31 - Valdastico sud
Alberto Balasso, Marco Cagnoni, Paolo Cattaneo, Vincenzo Gobbo, Isabel Llacer,Francesca Meloni, Cristiano Miele, Cinzia Rossignoli
La circolazione monetaria a Verona in età romana: i dati dei lavori d’Adige (1887-1894)
Antonella Arzone, Federico Biondani
Palazzo Chiericati a Vicenza. Sviluppo urbano dalla romanità a PalladioStefania Bonato, Silvia Cipriano, Mariolina Gamba, Michele De Michelis,
Marco Marchesini, Silvia Marvelli, Stefania Mazzocchin
Portus de Gruario: il frate, il mercante, il fabbro del quartiere settentrionaleGuido Andrea Anese, Andrea Battiston, Vincenzo Gobbo, Elena Natali, Elena Pettenò,
Alessandra Benedetta Piccolo, Maria Teresa Ret, Federica Rinaldi
Sondaggi archeologici nel sito del castello vescovile di Castelgomberto (Vicenza)Cristiano Miele
Nuovi dati per l’archeologia di Jesolo (Venezia) attraverso l’aerofotointerpretazione
Graziano Serra
“Bestiario ceramico” Gli animali simbolici sulle ceramiche graffite rinascimentali dalla struttura esagolane
del distrutto monastero di Santa Chiara de Cella Nuova di Padova: il castoroVincenzo Gobbo
Annotazioni su Alcune notizie sulle mura di PadovaGianpaolo Candiani
Una trapanazione cranica risalente all’epoca di Girolamo Fabrizio d’Acquapendente dall’ex convento di San Francesco a Conegliano (Treviso)
Alessandro Canci, Marina Zago
8
24
82
124
164
206
224
304
314
318
82
fig. 1. Siti che hanno restituito monete antiche (i numeri corrispondono a quelli dell’elenco di tab. 1); la carta utilizzata data al periodo immediatamente precedente ai lavori: Mappa dei Fabbricati del Comune Censuario della città di Verona. Distretto I. Provincia di Verona aggiornata all’anno 1875 (Verona, Archivio di Stato).
3
70
66?65
7
2830 29
4-6
75-79
80-81
19-22
16-18
831-2
82
31
37
38
23
86
6053
87?
57
84
85
58 59
32-36
39-46
47-49
50-52
54-56
67-698-13
14-15
24-27
71-74
61-64
83
Parte I: i lavori d’Adige e i ritrovamenti numismatici (aspetti distributivi)
I lavori e le scoperte archeologiche
Negli stessi anni in cui a Roma, da poco capitale del nuovo regno d’Italia, si interven-ne per regolarizzare il corso del Tevere con rettifiche dell’alveo e la costruzione di mura-glioni (1877-1890) dopo la grande alluvione del 18702, anche a Verona, per ragioni ana-loghe, imponenti lavori riguardarono il corso dell’Adige.
L’intervento fu determinato dalla disastro-sa esondazione che a partire dalla notte del 15 settembre 1882 aveva interessato per più giorni gran parte del centro di Verona e che aveva provocato crolli e danni ai ponti e a decine di abitazioni. Pochi giorni dopo l’allu-vione la Giunta Comunale, guidata dal sinda-co Camuzzoni, decise di indire un pubblico concorso per un progetto di protezione del-la città dalle piene del fiume. Fra i numerosi elaborati che furono presentati, quattro ven-nero premiati e su di essi si discusse fino alla stesura del progetto definitivo presentato in Giunta il 31 maggio 1885. Questo progetto, che prevedeva la regolarizzazione dell’alveo urbano e la sua arginatura con muraglioni, comportava fra l’altro l’eliminazione dell’Iso-lo Bonomi e della Sabbionara, l’interramento del Canale dell’Acqua Morta e modifiche alla rete fognaria. I lavori furono suddivisi in cin-que tronchi:1. da porta Catena a Castelvecchio (riva de-
stra);
2. da Castelvecchio al Bastione San Fran-cesco (riva destra);
3. dalla fornace Righetti al ponte Pietra (riva sinistra);
4. dal ponte Pietra alla presa Giuliari (riva si-nistra);
5. arginatura e taglio a San Pancrazio.I lavori fra porta Catena e Castelvecchio
(tronco I) si svolsero fra 1887 e 1889, ma per questo tratto non si ha notizia di ritrovamenti archeologici. Nel 1889 invece ebbero inizio i lavori a valle di Castelvecchio (tronco II e tron-co IV), che si protrassero sino a maggio 1894. L’inaugurazione ufficiale dei nuovi muraglio-ni avvenne il 6 giugno 1895 alla presenza del principe ereditario Vittorio Emanuele3. Per l’occasione fu anche programmata un’espo-sizione suddivisa in quattro sezioni: “tecnica”, “storica ed artistica”, “archeologica” e “fisica e naturale”; del sottocomitato per la sezione archeologica presidente effettivo fu nomina-to Luigi Adriano Milani, all’epoca direttore del Museo archeologico di Firenze, ma veronese di origine. In questa sezione, come risulta dal programma, accanto a materiale restituito dall’Adige in periodi più antichi e a materiale di provenienza non veronese legato comun-que al fiume, doveva trovare posto quanto si era rinvenuto negli scavi più recenti, fra cui “molte e diverse monete Repubblicane e Imperiali, di argento e di bronzo e qualche medaglia” e monete medievali e moderne4.
Lo spostamento e in alcuni punti l’allarga-mento del letto dell’Adige e la costruzione dei muraglioni con relativi Lungadige, oltre all’interramento del ramo minore del fiume,
La circolazione monetaria a Verona in età romana: i dati dei lavori d’Adige (1887-1894)1
84
comportarono la demolizione di decine di case e palazzi, anche di rilievo storico-arti-stico (basti pensare a palazzo Da Lisca con i suoi pregevoli affreschi), posti lungo l’alveo del fiume (molti peraltro erano già crollati o erano stati danneggiati a seguito della piena del 1882), la scomparsa di intere strade, come via Beccheria delle Vacche e via Binastrova, la scomparsa dei vo’, i vicoli che dalle vie citta-dine immettevano direttamente sul fiume a pelo d’acqua, e lo spostamento verso sud di ponte Nuovo (cfr. figg. 1-2).
Le opere di sistemazione fluviale furo-no poi accompagnate da lavori collaterali come quello del grande collettore in destra Adige realizzato nel 1890, che interessò via Cadrega, via Sole, via Garibaldi, Stradone del Duomo (oggi via Arcidiacono Pacifico), piazza Duomo, via Duomo, via Liceo (oggi
via Massalongo), piazza S. Anastasia, piazza Chiavica e via Trota.
Gli scavi furono l’occasione per il ritrova-mento di numeroso materiale archeologico, per il cui recupero e per la cui localizzazione topografica largo merito va ascritto all’ing. Tullio Donatelli (1849-1913), capo dell’Uffi-cio tecnico comunale e direttore dei lavori, la cui competenza e diligenza archeologi quali Luigi Adriano Milani5, Edoardo Brizio6 e Serafino Ricci7 non mancano di sottolineare8. Poco incisivi in questa occasione furono inve-ce gli organi all’epoca preposti alla tutela, in particolare la locale Commissione Consultiva di Belle Arti e Antichità9.
Anche le monete, come ricorda Milani, al quale furono consegnate per una prima clas-sificazione, furono raccolte “con scrupolosa cura nei lavori di sterro e debitamente corre-date dalle indicazioni di provenienza”10.
Gli studi
Dei ritrovamenti compiuti nel 1890 (spe-cialmente nell’area del Duomo), durante gli scavi per il grande collettore in destra Adige, una prima segnalazione fu data nelle “Notizie degli Scavi” dell’agosto 1890.
Su questi ritrovamenti nella stessa rivista, l’anno successivo, comparve un articolo con le firme dell’ing. Tullio Donatelli, direttore
fig. 2. L’Adige a Verona dopo i lavori: Mappa dei Fabbricati del Co-mune Censuario della città di Verona. Distretto I. Provincia di Verona ag-giornata all’anno 1875. Allegati (Verona, Archi-vio di Stato).
85
dei lavori, e di Paolo Orsi: il primo informava brevemente circa i ritrovamenti archeolo-gici compiuti, lo studioso trentino illustrava invece l’iscrizione di Prassitele, le sculture e gli elementi architettonici rinvenuti in piazza Duomo. Per quanto riguarda i ritrovamenti monetali si segnalava genericamente la sco-perta di “alcune monete” in Piazza Duomo11.
Sui ritrovamenti compiuti nell’area del Duomo intervennero anche Gherardo Ghirardini e Luigi Adriano Milani: il primo con un articolo sull’iscrizione di Prassitele e sulle sculture12; il secondo con una rela-zione indirizzata in forma di lettera all’avv. Augusto Caperle, assessore ai lavori pubblici di Verona13, nella quale era contenuta un’illu-strazione delle sculture in marmo rinvenute in piazza Duomo, ma anche un’Appendice con la sintetica descrizione dei ritrovamen-ti numismatici sia antichi sia medievali e moderni14. L’elenco del Milani corrisponde sostanzialmente alle monete attualmente conservate, anche se per qualche esemplare l’esame autoptico ha portato ad attribuzioni diverse rispetto a quelle dell’archeologo ve-ronese, il quale forse vide le monete di fret-ta e più incrostate di quanto non lo siano attualmente. Milani riprese questa relazione in un articolo che comparve sul “Bullettino dell’imperiale Istituto archeologico germani-co”, incentrato però quasi esclusivamente sui ritrovamenti scultorei15.
Delle scoperte compiute durante le de-molizioni e gli scavi per la costruzione dei muraglioni, specialmente delle scoperte epigrafiche, troviamo notizia in tre articoli comparsi sulle “Notizie degli scavi” del 1891: nel primo non firmato16 si segnalano alcune iscrizioni; negli altri due, a firma di Edoardo Brizio, ci si sofferma sui ritrovamenti effettua-
ti dietro la chiesa di S. Anastasia in corrispon-denza dell’antico ponte Postumio, la zona che aveva restituito il maggior numero di testimonianze antiche, e su quelli compiuti a seguito della demolizione del muro medie-vale realizzato presso stradone S. Tommaso in prossimità di casa Moltini17. Considerando i rinvenimenti dietro Sant’Anastasia, l’archeo-logo torinese non manca di segnalare il co-pioso materiale numismatico: fra le monete qui recuperate, “per la maggior parte coperte ed anche corrose dall’ossido”, egli si limitò ad esaminare quelle meglio conservate, stabi-lendo che tutte erano imperiali, soprattutto del basso impero. Esclude che esse facessero parte di un ripostiglio, a differenza di quel-le d’argento trovate fra i ruderi del ponte Postumio, sulla riva sinistra. Di queste ultime, parimenti, egli esaminò le meglio conserva-te (”ché anche molte di esse hanno sofferto e sono coperte dall’ossido”), constatando la prevalenza degli imperatori che regnarono tra la fine del I e la fine del II secolo d.C. e l’assenza di imperatori di III secolo (in realtà dall’esame autoptico compiuto dopo il re-stauro risultano anche monete di III secolo).
Dei ritrovamenti effettuati fra il 1891 e il 1892, numerosi specialmente nell’area di ponte Navi, dell’Isolo di San Tommaso e dell’Isolo Bonomi, riferisce Serafino Ricci in un articolo che compare nelle “Notizie degli scavi” del 189318. Ricci si sofferma in parti-colare sulla documentazione epigrafica, ma nel suo articolo troviamo anche un elenco dei rinvenimenti numismatici, dei fram-menti marmorei e fittili (sculture, elementi architettonici ed anfore) e degli oggetti in metallo. Le monete, per la cui classificazione Ricci segnala la cooperazione di Milani, sono elencate in ordine cronologico distinte in:
86
1) repubblicane e imperiali; 2) medioevali e incerte; 3) moderne e incerte. L’indicazione del modulo della moneta (secondo le con-suetudini dell’epoca per quella di bronzo si usano i termini: “piccolo”, “medio” e “grande”) e dell’autorità emittente è seguita dalla data e dal luogo del rinvenimento. Questo elenco ha permesso di riconoscere, nella massima parte, le monete pubblicate succintamente da Ricci fra quelle presenti oggi in Museo. Non tutte le monete recuperate furono però prese in considerazione, inoltre le identifi-cazioni proposte da Ricci non sempre corri-spondono ai riconoscimenti attuali19.
Sui ritrovamenti monetali compiuti in prossimità dei ruderi del ponte Postumio ri-torna Carlo Cipolla in un lavoro nel quale si illustrano le vicende di questo ponte. Cipolla riporta un sintetico elenco in ordine cronolo-gico delle monete rinvenute, per la cui clas-sificazione si era fatto aiutare da Alessandro Bolognini, per arrivare alla conclusione che esiste una coincidenza fra la datazione delle monete recuperate, riferibili principalmen-te al I-III sec. d.C., e l’epoca di maggiore fre-quentazione del ponte. L’assenza di monete posteriori a Costantino, secondo lo storico veronese, sarebbe dovuta non solo alla scar-sezza della produzione monetaria ma anche al fatto che fra III e IV secolo il ponte avrebbe subito “qualche guasto”20.
In seguito, dei ritrovamenti d’Adige tor-nano ad occuparsi in particolare Lanfranco Franzoni, cui si deve una carta archeologica della città con riferimenti inediti a queste scoperte21, e Margherita Bolla in relazione agli oggetti di bronzo22. Dei rinvenimenti nu-mismatici, dopo Milani e Ricci non si occupò più nessuno, tanto che ad oggi si possono considerare sostanzialmente inediti23.
I ritrovamenti numismatici
I numerosi oggetti rinvenuti nel corso dei lavori (sia quelli romani sia quelli post-classici), oggetto probabilmente di una preliminare selezione24, furono consegnati all’allora Museo Civico e oggi sono distribu-iti fra il Museo archeologico e il Museo di Castelvecchio: nel primo sono conservati i materiali antichi escluse le monete, nel se-condo i materiali medievali e moderni e le monete (sia antiche sia post-classiche).
Dei ritrovamenti pervenuti al Museo fu re-datto un registro manoscritto (AMC, Lavori), nel quale i materiali consegnati al Museo nel corso dei lavori sono suddivisi cronologica-mente in base alle date del rinvenimento. I ritrovamenti monetali di norma sono distinti rispetto a quelli di altri oggetti; tuttavia non manca qualche moneta, inizialmente non ri-conosciuta come tale, confluita fra materiali diversi, così come fra le monete troviamo grumi di bronzo, bottoni ed altri tondelli me-tallici non monetiformi.
In questo elenco, in corrispondenza di ciascun ritrovamento (comprendente singoli oggetti o gruppi di oggetti), compaiono le seguenti voci:- numero progressivo (da 1 a 727);- data del rinvenimento (in ordine cronolo-
gico dal 7 maggio 1890 al 20 luglio 1893);- data della consegna al Museo (da agosto
1890 a dicembre 1893);- località del rinvenimento;- oggetto (con breve descrizione dei mate-
riali rinvenuti);- osservazioni (qui talvolta si trovano indica-
zioni con una grafia diversa rispetto a quel-la originale).Fisicamente le monete furono conserva-
87
te in sacchetti di carta con l’indicazione del numero progressivo; solo in occasione di questa catalogazione sono state sistemate in appositi vassoi e inventariate.
Nel corso degli anni non sono manca-ti dei controlli, come testimonia una nota del 3 febbraio 1960, nella quale si indicano come “monete varie da catalogare” un totale di 2274 pezzi comprendenti: “Bronzo 1657. Argento 559. Rame 16. Pezzi vari 20. Piombo 1. tessere 1. medaglie 9. fermagli 2. Bottoni 9”.
In base al riscontro compiuto per que-sto lavoro si può dire che nella gran parte dei casi il numero delle monete conservate corrisponde a quello scritto nell’elenco; tut-tavia non mancano discrepanze: in genere le monete sono di meno, ma in qualche caso il loro numero è anche maggiore, segno che nel corso degli oltre 100 anni trascorsi dal momento del recupero ci sono state alcune perdite e dei rimescolamenti.
In totale le monete attualmente conserva-te sono all’incirca 2600; quelle antiche sono all’incirca 2000. Si tratta di un numero eleva-to, ma, considerata l’estensione e la mole dei lavori, non altissimo. In proposito si segnala che Arturo Stenico calcolava in “qualche mi-gliaio” le monete trovate nel fiume Ticino a Pavia nella sola area dove fu costruita la spal-la settentrionale del nuovo ponte sul fiume25. Stenico in questo numero comprendeva an-che le monete in mano privata; che anche a Verona, come a Pavia, delle monete trovate in occasione dei lavori possano essere passa-te in mano privata è possibile, ma in merito non risulta alcuna testimonianza.
Si ricorda inoltre che oltre 2000 monete antiche furono trovate nel 1967 nell’alveo del fiume Liri, in un stretta fascia attigua alla riva destra in prossimità delle mura di Minturnae
e del probabile ponte su cui passava la via Appia: in questo caso tuttavia si trattava di una vera e propria ricerca archeologica su-bacquea26.
Circa 50.000 invece furono le monete tro-vate a Roma nel Tevere in occasione della costruzione dei muraglioni fra 1877 e 189027; in questo caso vanno però considerate l’am-piezza dei lavori e le eccezionali dimensioni della capitale dell’impero.
I materiali veronesi, al momento dell’at-tuale studio, erano in parte restaurati, anche con interventi piuttosto radicali che aveva-no tolto completamente la patina antica, ma in gran parte non restaurati, spesso ri-coperti da incrostazioni calcaree che ave-vano intaccato il tondello metallico28. Fra questi ultimi un gruppo è stato sottoposto a restauro29, mentre per altri esemplari si è provveduto ad una pulizia meccanica, la quale in alcuni casi ha migliorato la leggi-bilità, portando a qualche attribuzione più precisa. Sicuramente una lettura migliore per gli esemplari più incrostati sarebbe pos-sibile con un intervento professionale più accurato, tuttavia si ritiene che anche nuovi restauri non porterebbero risultati signifi-cativi, visto che la lettura è resa problema-tica soprattutto dalla fortissima corrosione; peraltro, anche dopo gli interventi di cui si è detto, solo in pochi casi è stata possibile una più precisa attribuzione.
La distribuzione dei ritrovamenti
Per quanto riguarda l’ubicazione dei ritro-vamenti monetali si possono distinguere:1. ritrovamenti effettuati nell’alveo o lungo
l’alveo del fiume;2. ritrovamenti effettuati nell’area cittadina
88
legati alla realizzazione di opere collatera-li (in particolare il canale fognario fra via Cadrega e via Trota).
1. Ritrovamenti nell’alveo e lungo il fiume
a. Tratto da Porta Catena e ponte della Vit-toria (riva destra)
Nessuna moneta è segnalata lungo que-sto tratto di fiume, nei cui pressi si collocava il suburbio occidentale della città, costituito da zone residenziali diventate funerarie in epoca tardoantica (lungo la Postumia da porta Iovia all’Arco dei Gavi) e, nella parte più esterna, da zone funerarie (lungo la via “Gallica”, all’incirca fino all’altezza di ponte Catena)30.
b. Tratto da ponte della Vittoria a ponte Pietra (riva destra e sinistra)
In questo tratto l’Adige, con un corso ana-logo a quello attuale31, segnava il confine nord-occidentale della città romana. I ritro-vamenti sono stati pochi: la maggior parte di essi avvenne nell’area dell’Isolo Bonomi, una zona occupata da segherie di fronte a via Dietro S. Eufemia, la quale a seguito dei lavori fu completamente eliminata. Qualche moneta fu inoltre trovata presso l’attuale piazza Broilo poco a monte di ponte Pietra. Nessun ritrovamento è segnalato in corri-spondenza del supposto ponte romano che sarebbe stato realizzato nel sito dell’attuale ponte Garibaldi32. Non sono segnalati ritro-vamenti neppure lungo la riva sinistra, an-che nell’area immediatamente ad occiden-te di ponte Pietra, che era compresa entro le mura.
Le poche monete trovate in questo tratto, che rientrano tutte fra i rinvenimenti isolati, datano dall’età augustea a tutto il IV secolo.
c. Tratto da ponte Pietra a ponte Navi (riva destra e sinistra)
Sull’esatto percorso del fiume fra pon-te Pietra e ponte Navi in età romana non vi è concordanza di vedute. Secondo alcuni studiosi, fra i quali Vittorio Galliazzo, l’Adige, dopo ponte Pietra, non volgeva immedia-tamente a sud come oggi, ma formava un arco più ampio seguendo un tracciato coin-cidente sostanzialmente con il vecchio alveo del Canale dell’Acqua Morta; la città romana quindi si sarebbe estesa anche in corrispon-denza dell’attuale corso atesino fino all’I-solo33. Invece, secondo altri studiosi, fra cui Giuliana Cavalieri Manasse, il corso del fiume non doveva essere sostanzialmente diverso da quello antecedente i lavori d’Adige: dopo il ponte Postumio l’alveo si sarebbe biforca-to in due rami che si sarebbero riuniti poco a monte dell’attuale ponte Navi. A soste-gno di questa ipotesi è il ritrovamento in via Sottoriva di un muro parallelo all’alveo attua-le, interpretabile come un apprestamento spondale romano34; inoltre pare attribuibile ad un argine sinistro del fiume il “muro roma-no” (in realtà altomedievale, ma realizzato in larga misura con materiale di spoglio roma-no) trovato presso Stradone San Tommaso nel 1891, durante i lavori per l’allargamento del letto del fiume35.
Il tratto atesino fra ponte Pietra e ponte Postumio era compreso all’interno della cit-tà romana che in sinistra Adige si estendeva fino alla porta situata immediatamente ad oriente del ponte Postumio; più a sud fin quasi a ponte Navi, l’Adige segnava il confine orientale della città; sulla sinistra del fiume si collocavano invece delle aree funerarie ma anche degli impianti produttivi.
Questo tratto, lungo il quale si concentra-
89
rono i maggiori interventi, è anche quello che ha restituito quasi tutto il materiale numisma-tico recuperato durante i lavori (sia antico sia post-classico) ed anche la massima parte di quello non numismatico.
Qualche ritrovamento fu compiuto presso ponte Pietra, l’unico ponte della città romana che con vari rifacimenti è rimasto in uso fino ai nostri giorni36.
Più a sud, sia lungo la riva destra sia lungo la riva sinistra, i ritrovamenti si concentrano fra ponte Pietra e il ponte Postumio, vale a dire lungo il tratto che scorreva all’interno delle mura cittadine; particolarmente nu-merosi furono le scoperte in prossimità del ponte Postumio; questo ponte, realizzato probabilmente nella piena età augustea, costituiva il proseguimento del decumano massimo cittadino ed era senza dubbio il più utilizzato della città; non sappiamo quando esattamente sia avvenuto il suo crollo, certa-mente anteriore al 905, anno in cui comincia ad essere chiamato pons fractus37.
La grande quantità di monete qui rinvenu-te si deve certo alla sua intensa frequentazio-ne (sicuramente questo ponte era più traffi-cato di ponte Pietra), ma soprattutto al fatto che mentre in corrispondenza di ponte Pietra la struttura tufacea del colle di San Pietro scende, quasi affiorante, fin verso la metà del letto del fiume tanto che le pile di sinistra insistono sul fondale roccioso38, in corrispon-denza invece del ponte Postumio il letto del fiume è formato da uno spesso strato alluvio-nale. Si può quindi ritenere che le eventuali monete cadute in prossimità di ponte Pietra siano fluitate a valle, fermandosi poco più a sud dove la corrente del fiume rallenta, cioè in corrispondenza del ponte Postumio39. Può essere inoltre che materiali pesanti come i
metalli venissero spinti verso le testate del ponte e qui restassero bloccati40.
In proposito si segnala che con modalità analoghe, secondo Stenico, si formò il depo-sito archeologico trovato nel 1949 nel Ticino a Pavia in corrispondenza della spalla del nuovo ponte realizzato al posto del distrut-to ponte Vecchio. Questo deposito com-prendeva oggetti prevalentemente metallici (comprese molte monete) ma anche cerami-ci, vitrei e lapidei di funzione molto eteroge-nea, compresi fra l’età augustea (ma le mo-nete datavano anche all’età repubblicana) e il VII secolo41. Questi oggetti, finiti nel fiume in vario modo, si sarebbero accumulati in questo luogo risucchiati a seguito dell’azione di un forte gorgo provocato da un ostacolo notevole che non poteva che essere il pilo-ne di un ponte; Stenico osserva altresì che la cronologia dei materiali sarebbe indicativa della vita di questo ponte42.
La grande quantità di materiali trovata lun-go la riva destra in corrispondenza di Regaste Orto, dietro la chiesa di Sant’Anastasia (fra essi arnesi di vario tipo, un bronzo a forma di prora di nave e una tavoletta bronzea con la menzione di un negotiator), la scoperta di una muratura formata da mattoni roma-ni (alla quota attuale del livello dell’alveo: m 51.00) 43, unitamente alla posizione riparata rispetto alla corrente e a considerazioni di ca-rattere topografico, come la vicinanza con il decumano massimo, principale arteria citta-dina, hanno fatto pensare a Franzoni che qui, immediatamente a sud del ponte Postumio, si collocasse il porto fluviale della città44; ad un porto fluviale in questa zona pensa an-che Galliazzo, il quale, come si è detto, ri-tiene che qui l’Adige formasse un’ansa più ampia45. Di diverso avviso è invece Giuliana
90
Cavalieri Manasse, la quale sottolinea come la gran parte degli oggetti rinvenuti descritti da Brizio (elementi di statue, oggetti di or-namento personale, appliques ecc.) sia poco attinente con impianti commerciali o por-tuali e come la loro associazione in questo punto sia probabilmente dovuta alle ragioni meccaniche sopra indicate; riguardo al muro messo in luce si segnala come non sia chia-ro se esso fosse a sud o a nord del ponte. In ogni caso, in considerazione principalmente della posizione del sito, non si esclude la pre-senza di un approdo a cui potrebbe essere riconducibile la gradinata scoperta presso la riva destra del fiume fra ponte Pietra e ponte Postumio, quella che aveva fatto pensare ad una sorta di “controteatro”46.
Per quanto riguarda il contesto di rinveni-mento delle monete recuperate in quest’a-rea (in totale quelle antiche sono all’incirca 1000) qualche notizia è fornita dal Brizio. Le monete da lui viste (che assommavano a cir-ca 600 ed erano quasi tutte di bronzo, “per la maggior parte coperte ed anche corrose dall’ossido”) erano state raccolte a piccoli gruppi “ad altezza e distanza varia fra loro, la quale si può calcolare di un quindici metri di lungo per due di largo, aderenti, mischiate anzi talvolta con altri oggetti minuti di bron-zo e di ferro, di modo che resta esclusa l’ipo-tesi che trattisi di un ripostiglio, quantunque non sia facile dare ragione della presenza di sì gran numero di monete in quel tratto dell’alveo dell’Adige”47.
Pur tenendo conto delle considerazioni del Brizio, non si può escludere che almeno tre gruppi di monete, ciascuno dei quali tro-vato nello stesso punto e nello stesso giorno, possano aver fatto parte di ripostigli: ad av-valorare questa ipotesi, oltre alla posizione e
alla grande quantità di numerario, è anche, almeno in due casi, la relativa omogeneità cronologica.
Un grande numero di monete fu recu-perato anche nell’area dove sorgeva il pon-te Postumio in prossimità della riva sinistra. Su questi rinvenimenti si sofferma sempre il Brizio, secondo il quale “spettano senza dub-bio ad un ripostiglio 577 monete quasi tutte di argento, raccolte fra i ruderi del medesimo ponte Postumio, sulla riva sinistra e riunite in una superficie di circa 10 metri quadra-ti”, Il Brizio scrive anche: “sembra che queste monete fossero originariamente racchiuse dentro un cofanetto di bronzo del quale si raccolsero eziandio alcuni frammenti in vici-nanza delle monete stesse”48. Oggi le mone-te d’argento che si conservano, provenienti da quest’area, sono 475, di cui 471 imperiali e quattro di età precedente, mentre le mone-te di bronzo sono 28. Sembra plausibile che solo le monete d’argento facessero parte del ripostiglio e che quelle di bronzo siano finite casualmente nella stessa area49.
A sud del ponte Postumio sulla riva destra un gruppo consistente di monete fu trova-to durante la costruzione del muraglione Sottoriva e un esemplare presso il vo’ San Gaetano; sulla riva sinistra vari rinvenimen-ti sono segnalati lungo via Beccheria delle Vacche (corrispondente oggi, grosso modo, a Lungadige Re Teodorico), nella zona di San Tommaso, un’area dove furono abbattute varie abitazioni poste lungo il fiume. Di qui proviene anche l’unico ritrovamento che potrebbe essere in connessione con una sepoltura: si tratta di un follis di Costantino I trovato sotto la casa Lassotovich (n. 40), dove furono trovate anche tre anfore con resti di ossa. Alcuni esemplari infine furono recupe-
91
rati in prossimità di ponte Navi, dove è pro-babile l’esistenza di un ponte romano poco più a monte dell‘attuale manufatto50.
In generale questo tratto, l’unico in cui, accanto a vari ritrovamenti isolati, si sia rinve-nuto un gruzzolo (e non è da escludere che costituissero dei ripostigli anche altri gruppi di monete), ha restituito monete che vanno dal periodo repubblicano fino ad epoca tar-doantica.
Non sembra casuale che proprio dalla zona ponte Pietra/ponte Postumio, dove si collocava l’oppidum repubblicano (in si-nistra Adige) e dove dal 148 a.C. passava la Postumia, provengano l’unica dramma pa-dana di imitazione massaliota e quasi tutte le monete repubblicane.
d. Tratto da ponte Navi al ponte della Fer-rovia
Lungo questo tratto, sulla riva destra del fiume, si estendeva il suburbio meridiona-le della città attraversato dalla via Claudia Augusta “padana” che da Verona portava ad Hostilia sul Po: questa zona era occupata da aree funerarie, ma anche da strutture di va-rio tipo come quella individuata presso l’ex Campo Fiera, dove sono state accertate ope-re di innalzamento spondale attraverso ban-chi di anfore e la costruzione di un impianto per il quale si è ipotizzata l’identificazione con degli horrea o più probabilmente con il campus/ludus publicus veronese51. Inoltre du-rante la costruzione del ponte della Ferrovia nel 1851 furono scoperte le fondamenta di un edificio rettangolare, che, in ragione di una base di statua con dedica alla Fortuna qui rinvenuta, è stato interpretato come un tempio dedicato a questa divinità 52.
In quest’area, a differenza che nel subur-
bio nord-occidentale, vari siti sia sulla riva destra sia sulla riva sinistra del fiume hanno restituito reperti numismatici, sia pure in quantità molto ridotta. Monete romane furo-no recuperate in via Filippini, via Macello, in corrispondenza del Bastione San Francesco e nella zona del ponte della Ferrovia lungo la riva destra del fiume e in lungadige Porta Vittoria presso il Museo, dove fu trovato an-che “un deposito” di anfore53, e nella zona del ponte della Ferrovia lungo la riva sinistra. Gli esemplari rinvenuti sono tutti di età imperia-le, compresi fra l’età augustea e il IV secolo; al periodo repubblicano data solamente un asse da Lungadige Porta Vittoria.
2. Ritrovamenti all’interno dell’area cittadinaI lavori compiuti nell’area cittadina, in oc-
casione della costruzione dei muraglioni, re-stituirono anch’essi vario materiale archeolo-gico, fra cui diverse monete. I rinvenimenti più significativi furono compiuti nel 1890 a seguito della realizzazione di un grande collettore in destra Adige, che interessò la zona centro-settentrionale della città ro-mana.
I lavori di scavo riguardarono strade at-tuali, come via Duomo e via Massalongo, corrispondenti a cardini e decumani della città antica. Si tratta di monete rinvenute isolatatamente o in piccoli gruppi (la pre-senza di gruzzoli non è ipotizzabile), che in parte furono rinvenute sul piano stradale antico (posto all’incirca a 2 metri di profon-dità rispetto a quello attuale), in parte al di sotto di esso, come si può desumere dalle quote. In alcuni casi in AMC, Lavori si dice espressamente che il materiale fu recupe-rato nel canale fognario che si trovava al di sotto del selciato.
92
Le monete trovate in questa zona copro-no un lungo arco di tempo che va dall’età repubblicana a quella gota: molto poche sono quelle repubblicane, poche sono quelle della prima età imperiale, più nu-merose sono quelle di III e soprattutto di IV secolo. Significativamente l’unica moneta gota di fine VI secolo proviene dalla zona del Duomo, un’area che, per la presenza della chiesa cattedrale, anche nell’alto medioevo doveva essere intensamente frequentata.
In destra Adige altri ritrovamenti isolati di monete di età imperiale furono compiuti sia all’interno della città romana (via Dietro Sant’Eufemia) sia nel suburbio meridionale (via Ponte Rofiolo e via Pallone). Interessante è la scoperta di via Ponte Rofiolo dove gli scavi intercettarono la galleria di scolo che dall’asse maggiore dell’anfiteatro prosegui-va verso SE fino all’Adige, già indagata da Bartolomeo Giuliari negli anni 1818-1819 e da Alessandro Perez nel 188054. In sinistra Adige una moneta di età imperiale è segnala-ta in via San Vitale; si tratta di un’area extraur-bana occupata nelle vicinanze da necropoli, ma su questo rinvenimento mancano dati di contesto.
Considerazioni conclusive
Per le monete trovate nei fiumi si pongo-no varie questioni come la posizione origina-ria, i motivi per i quali sono finite nel letto del fiume e l’epoca di deposizione.
Per quanto riguarda la posizione origina-ria, nel caso dei ritrovamenti veronesi, fermo restando che è difficile stabilire se e in che misura queste monete si siano spostate ri-spetto al luogo originario di deposizione, qualche considerazione si può tentare sulla
base della distribuzione dei ritrovamenti e delle caratteristiche del fiume, mentre scar-samente significative sono le indicazioni che provengono dagli altri materiali recuperati, frutto fra l’altro di una probabile selezione che ha privilegiato la raccolta di bronzi e marmi55. Il fatto che le aree più ricche di ri-trovamenti corrispondano a quelle maggior-mente frequentate in antico sembra sugge-rire una non eccessiva fluitazione di questi reperti; qualche spostamento, legato alla minore o maggiore intensità della corrente, pare comunque esservi stato; come si è già sottolineato l’alta concentrazione di mone-te all’altezza del ponte Postumio rispetto a quella riscontrabile all’altezza di ponte Pietra sembra essere dovuta, oltre che alla maggio-re o minore frequentazione dei due ponti, anche alla corrente e alle caratteristiche del letto fluviale: l’Adige infatti in corrispondenza di ponte Pietra, dove si notano affioramenti tufacei, presenta una forte corrente, la quale può avere trascinato le monete più a valle, dove l’acqua del fiume rallenta il suo corso, consentendo la formazione di uno spesso deposito alluvionale dove le monete posso-no essersi fermate. Inoltre può essere signifi-cativo il fatto che dalla zona a monte esterna alla città non provenga nessun ritrovamento e che invece qualche moneta sia stata trova-ta nella zona più a valle.
Riguardo alle ragioni della presenza di mo-nete nel fiume va considerata la possibilità che almeno una parte del materiale rinvenu-to, in particolare quello trovato in prossimità dei ponti, sia stato gettato volontariamente nel fiume come offerta, per ragioni cultuali. Si tratta di una consuetudine già protostori-ca, che è documentata anche in età romana: lasciare un’offerta alla divinità in prossimità
93
di un passaggio, come un guado fluviale56. L’ipotesi di un getto rituale è stata avanzata, per esempio, per le monete trovate a Pavia nel Ticino57 e per le monete trovate nel fiume Liri a Minturnae, le quali sono più numerose in prossimità del presunto ponte della via Appia e sono state accompagnate dal ritro-vamento di terrecotte votive58.
Nel caso di Verona, tuttavia, considerando anche gli altri ritrovamenti effettuati, manca-no elementi che avvalorino questa ipotesi; inoltre, anche tenendo conto delle conside-razioni sopra esposte circa la corrente, stu-pisce, in quest’ottica, la scarsa presenza di monete (in particolare di monete delle fasi più antiche) o di altri oggetti che potrebbero avere una valenza votiva in corrispondenza del guado di ponte Pietra, per dove sicura-mente passava una pista protostorica poi ri-presa dalla via Postumia.
Sembra quindi più facile pensare ad altri motivi: se non vi sono gettate volontaria-mente, le monete, come sottolinea Stenico, possono finire in un fiume a seguito di ca-dute fortuite dalle sponde o dai ponti o da barche, trascinate da piene, scaricate dal si-stema fognario, gettate per sbaglio con altro
materiale di rifiuto oppure potevano anche appartenere a persone per varie ragioni ca-dute nel fiume59. In una città come Verona, pare plausibile pensare specialmente agli scarichi fognari e a piene che possono aver trascinato nel fiume oggetti che si trovavano nelle abitazioni.
Per quanto riguarda il momento in cui le monete caddero nel fiume e quindi il tempo trascorso fra la data di emissione e quella di deposizione, mancano elementi certi. I ma-teriali recuperati nei medesimi siti (per i quali peraltro manca uno studio analitico), anche quando siano stati trovati alle medesime quote delle monete, non possono fornire dati sicuri, in quanto l’associazione può esse-re del tutto casuale; per esempio, vari sono i siti in cui sono testimoniate sia monete anti-che sia monete post-classiche. Riguardo allo stato di usura al momento della deposizione, in molti casi non è determinabile per la forte corrosione dovuta alle condizioni di giacitu-ra; comunque laddove non siano intervenu-te forti alterazioni post-deposizionali, sembra trattarsi di esemplari in generale piuttosto consunti, oggetto quindi di una lunga circo-lazione60.
Tabella 1 - Elenco dei siti che restituirono monete antiche nel corso dei lavori d’Adige. Il numero della prima colonna corrisponde a quello della fig. 1; il numero (o i numeri) della seconda colonna corrisponde a quello presente in AMC, Lavori.* Si segnala che le monete dei siti con i numeri 320 e 410 in AMC, Lavori si trovavano nella stessa scatola ed erano divise fra monete romane e monete medievali e moderne: le prime che assommano a 358 paiono ricon-ducibili al sito n. 320 che secondo AMC, Lavori avrebbe restituito 366 monete di bronzo; le seconde che assom-mano a 226 potrebbe essere ascritte, almeno nella gran parte, al sito n. 410 che, secondo AMC, Lavori, avrebbe restituito 217 monete di bronzo.I gruppi di 356, 167 e 220 monete non si esclude potessero far parte di ripostigli.** Nello stesso sito si rinvennero tre anfore con resti di ossa.*** Il ritrovamento è segnalato di seguito a quelli di via Cadrega, però sotto questo numero la via non è indicata.**** Si ritiene si tratti del Cimitero monumentale; però nel Registro l’indicazione “cimitero” non è accompagnata da nessuna ulteriore precisazione.
94
n. n. sito nome sito monete antichequantità
datazione monete postclassiche
quantità
1 494 Isolo Bonomi. Sez. 35 1 2ª metà I
2 514, 638, 643, 647, 649, 652, 657, 660
Isolo Bonomi. Nuovo alveo.
29 fine I a.C./I d.C.-fine IV/inizi V
50
3 715 Casa Castelli/Asili Aportiani (=Piazza Broilo)
5 I-1ª metà IV 4
4 635, 639-640 Ponte Pietra 8 fine I a.C./I d.C.-IV 83
5 655 Ponte Pietra. Arco ds 1 1ª metà IV 4
6 659 Ponte Pietra. Pila ds 3 I-1ª metà IV 17
7 662 Muraglione. Spalla ds ponte Pietra
3 fine I a.C.-1ª metà I d.C.
8 661 Muraglione. Ponte Pietra 1 1ª metà II 18
9 227 Muraglione a valle di ponte Pietra (riva ds)
2 fine I a.C.-I d.C.
10 303 Muraglione ponte Pietra. Sez. 92-93
6 fine III/1ª metà II a.C.-1ª metà IV
6
11 259, 261, 264-265 Muraglione a valle di ponte Pietra. Sez. 93 (riva ds)
13 I-IV 33
12 293, 406 Muraglione ponte Pietra. Sez. 93-94
7 I-III 9
13 285 Muraglione ponte Pietra. Sez. 94 (riva ds)
1 2ª metà IV 5
14 256 Muraglione Bra Molinari 1 I sec.
15 274 Muraglione Bra Molinari. Sez. 93-94
3 1ª metà I 5
16*
266, 269, 272-273, 280, 283-284, 288, 291, 314, 320-326
Muraglione Regaste Orto. Sez. 103-104
356 +167 +220 +217
fine III/1ª metà II a.C.-IV
38 (+3 inc.)
17 411 Muraglione Regaste Orto. Fondazioni. Sez. 103-104
56 I/II-IV/V 4
95
18 658 Muraglione Regaste Orto. Fondazioni
16 fine III/1ª metà II a.C.-IV
19 260, 279, 286 Muraglione Sottoriva. Sez. 109-110
45 I a.C.-IV 22
20 257 Muraglione Sottoriva. Sez. 110
75 II a.C.-IV 10
21 255 Muraglione Sottoriva. Sez. 112
1 2ª metà III
22 195 Muraglione Sottoriva. Casa Vianini
1 IV 3
23 697 Muraglione. Vo’ S. Gaetano 1 1ª metà IV
24 182, 206-207, 211, 237
Muraglione Redentore 7 I-III 8
25 246 Muraglione Redentore. Sez. 7-8
10 fine I a.C.-III
26 663 Regaste Redentore. Archi sporgenti sull’Adige
1 1ª metà IV
27 664, 678 Regaste Redentore. Scaletta
2 2ª metà IV 3
28 205, 208-209, 222, 232
Muraglione Redentore. Casa Spitz
16 II a.C.-IV 3
29 667 Vo’ S. Faustino. Casa Spitz 3 III-IV
30 204, 212, 216, 220, 223-226, 231, 234-236, 238-239, 243, 245
Ponte Postumio (ruderi) (verso riva s.)
475 (AR) +28
2ª metà IV/III a.C.-1ª metà III
3
31 417, 420 Via Beccheria delle Vacche. Vicolo Isolo
5 I-IV
32 427 Via Beccheria delle Vacche. Casa Laschi
3 fine I a.C.-II
33 428 Via Beccheria delle Vacche. Casa Arrighi
1 2ª metà III
34 507 Via Beccheria delle Vacche. Casa “dell’Ospitale di Padova”
1 2ª metà IV
96
35 413 Via Beccheria delle Vacche. Casa Zini-Bragantini
1 2ª metà III
36 496 Via Beccheria delle Vacche. Casa Da Lisca/casa Zini-Bragantini
3 IV-fine IV/inizi V
37 481, 486, 679 Via Beccheria delle Vacche. Casa Da Lisca
3 II-IV
38 595, 610, 625 Via Sammicheli. Ex Caserma della Questura
4 II-III
39 439 S. Tomaso. “Muro romano” 1 2ª metà III
40**
506 S. Tomaso. “Muro romano”. Casa Lassotovich [=Stradone S. Tomaso 21]
1 1ª metà IV
41 300, 305-306 Muraglione S. Tomaso. Casa Moltini
3 2ª metà III-IV/V 3
42 600 Muraglione S. Tomaso. Casa Castellani
1 fine I a.C.
43 437 Alveo S. Tomaso. Casa Moltini
1 2ª metà II
44 419 S. Tomaso. Casa Lugo [= Stradone S. Tomaso]
1 2ª metà I
45 616 (=600?) Casa Savelli Castellani 2 2ª metà III-1ª metà IV 1
46 614 S. Tomaso. Nuovo alveo. Località diverse
5 I-III
47 435 Muraglione S. Tommaso. Casa Fraccarolli-Buja
2 2ª metà III-1ª metà IV
48 431 Muraglione ponte Navi. Casa Fraccarolli-Buja
1 2ª metà III 1
49 617, 626 Casa Fraccaroli. Pila del ponte
4 I-2ª metà III 1
50 251 Ponte Navi 1 1ª metà I
51 695 Ponte Navi. Pila ds 1 2ª metà II
52 612, 634 Ponte Navi. Spalla s. 4 I-IV 1
53 438 Muraglione sotto ponte Navi
1 1ª metà IV
97
54 418 Via Filippini. Muro romano. Casa comunale
1 1ª metà IV
55 421, 423 Via Filippini. Muro romano 2 IV
56 665 Via Filippini. Galleria 1 2ª metà IV
57 434 Via Macello. Scuole Normali Maschili
2 IV
58 408 Bastione S. Francesco. Mura di cinta
1 2ª metà IV
59 275 Galleria Bastione S. Francesco
1 1ª metà I
60 184 Muraglione. Lungadige Porta Vittoria. Museo
1 fine III-II a.C.
61 440 Ponte della Ferrovia (riva ds)
1 2ª metà I
62 422 Ponte Ferrovia (riva s.) 2 2ª metà IV
63 426 Ponte Ferrovia. Orto Scandolara
1 1ª metà IV
64 429 Ponte della Ferrovia. Orto Scandolara (termine)
5 fine I a.C./1ª metà I d.C.-1ª metà IV
65 6 Via Cadrega 3 I-IV
66***
8 Casa Benciolini [zona via Cadrega?]
1 IV
67 88 Piazza Duomo 1 1ª metà VI
68 32 Piazza Duomo. Gradinata 1 1ª metà III
69 34 Piazza Duomo. Casa Piccoli 1 1ª metà IV
70 169 Via Pietà Vecchia 4 fine I a.C.-1ª metà IV
71 126, 134 Via Duomo. Strada romana 3 2ª metà I-IV
72 122, 136, 140-141, 143
Via Duomo 7 II a.C.-1ª metà IV 1
73 137 Via Duomo (tra via Pigna e via Liceo)
1 2ª metà I
98
74 144-145 Via Duomo (“galleria romana”)
4 I-1ª metà IV
75 18, 22, 121 Via Liceo (= via Massalongo)
5 fine I a.C.-IV 1
76 56 Via Liceo 3 (= via Massalongo)
1 1ª metà IV
77 57 Via Liceo 5 (= via Massalongo)
1 II
78 74-75, 77-78 Via Liceo (= via Massalongo). Euripo
9 2ª metà III-IV 3
79 102 Via Liceo (= via Massalongo). Casa Guzzeri
4 fine I a.C.-IV
80 87 Via Liceo (= via Massalongo)/incrocio corso Sant’Anastasia
1 2ª metà III
81 113 Piazza Sant’Anastasia. Caffè Vidi
2 2ª metà III
82 511-513 Via Trota 4 I/II-IV
83 153 Via Dietro Sant’Eufemia 2 fine I a.C.-II
84 485 Via Ponte Rofiolo 1 1ª metà IV
85 508 Via Pallone 1 1ª metà I
86 717 Via S. Vitale. Vicolo Fondachetto
1 I sec.
87****
46 Cimitero 1 1ª metà IV
88 270 Loc. ignota 1 fine II-inizi III
89 139 Varie località non id. 5 II a.C-III d.C. 9
99
Parte II: Aspetti della circolazione mone-taria a Verona
Le monete di età romana ritrovate nel corso dei lavori d’Adige ammontano quindi complessivamente a circa 2000 unità. Si trat-ta prevalentemente di numerario di bronzo di piccolo taglio, cioè degli spiccioli smarriti durante la vita quotidiana e rimasti nella ter-ra oppure finiti nell’alveo del fiume dove la corrente li ha spostati per depositarli magari poco più a valle in mezzo alle sabbie e alle ghiaie (vedi infra). Un gruppo di circa 500 pezzi per omogeneità del nominale, tutte monete d’argento, per prossimità del rin-venimento e per il recupero di alcuni fram-menti di un cofanetto di bronzo può essere invece ritenuto un tesoretto disperso. Per la maggior parte si tratta quindi di reperti decontestualizzati dai quali è possibile solo parzialmente trarre informazioni sulla circo-lazione monetaria veronese nelle sue diverse fasi, ma utili, anche in ragione della rilevante quantità, ad essere confrontati con le mone-te recuperate nelle indagini archeologiche condotte dalla Soprintendenza Archeologi-ca in siti corrispondenti ad aree pubbliche o residenziali di cui si sono definite le fasi di occupazione e di frequentazione.
L’età romana repubblicana
Dopo un lungo periodo di scambi basati sul baratto e su un sistema convenzionale in cui il metallo a peso doveva avere un ruolo preminente61, le prime monete vere e pro-prie circolanti nel territorio veronese sono le imitazioni padane della dracma ridotta di Massalia. La più antica forma di monetazione nella Cisalpina si fonda sull’uso dell’argento
che veniva anche tesaurizzato e posto nelle sepolture, rappresentando soprattutto un bene di prestigio. Con l’avanzare della roma-nizzazione, alle dracme si aggiungono le mo-nete romane in argento e quelle di bronzo, che divengono prevalenti fino a sostituirle del tutto62. L’utilizzo di numerario di valore intrinseco molto inferiore all’argento è sinto-mo di un cambiamento culturale che si ma-nifesta anche nel rituale funebre: il significato dell’offerta si sposta infatti dal piano dell’o-stentazione della ricchezza e della dotazio-ne materiale del defunto al piano simbolico poiché, con l’avanzare della romanizzazione, nelle tombe vengono deposti quasi esclusi-vamente assi. La disponibilità di nominali di
1. Dracma, Insubri, IV-III sec. a.C., dal sito n. 380 (inv. n. 66659)
2. Quinario anonimo, 81 a.C., Roma, dal sito n. 324 (inv. n. 67916)
3. Denario serrato di L. ROSCI FABATI, 64 a.C., Roma, dal sito n. 283 (inv. n. 67102)
100
bronzo è indicativa di un sistema di scambi basati sul mezzo monetario anche al livello delle transazioni più basse ed è stata inter-pretata come un indicatore della maggiore o minore resistenza alla romanizzazione, nel senso che si è notato come nei centri dell’a-rea indigena prealpina vi sia una quantità percentualmente più significativa di moneta d’argento rispetto ai centri romanizzati della pianura, meno legati alla tradizione di una valuta solo argentea63.
Le monete databili al periodo preaugu-steo recuperate da contesti nel territorio ve-ronese ammontano nel conteggio attuale a 970 unità, comprendenti numerario greco, celtico-padano, romano in argento e romano in bronzo. Nel computo sono stati conside-rati i ritrovamenti avvenuti nella provincia e pubblicati nei due volumi della collana Ri-trovamenti Monetali di Età Romana nel Vene-to a cura di Federico Biondani e di Marcella Giulia Pavoni e le monete ancora inedite re-cuperate nell’ambito del Comune di Verona. Dal calcolo sono stati esclusi i ripostigli64, ma sono state considerate le necropoli perché, anche se la deposizione in corredo funerario presuppone meccanismi specifici di selezio-ne, il numerario era comunque sottratto alla circolazione locale65. L’apporto di moneta di età preaugustea dai Rinvenimenti d’Adige è piuttosto ridotto: si tratta complessivamente di 24 unità. La cifra non comprende i quattro pezzi d’argento - una dracma celtica di imi-tazione massaliota, un quinario e due denari - considerati parte del ripostiglio di III seco-lo scoperto nei pressi del ponte Postumio e testimonianza della consuetudine di accan-tonare la moneta d’argento come riserva di valore sulla base del contenuto metallico. Si spiegherebbe così la presenza della dracma
celtica, cronologicamente uno tra i più antichi esemplari di imitazione massaliota trovato nel territorio veronese. La moneta è stata trovata nel fiume alle pendici della collina dove si era sviluppato l’oppidum per cui potrebbe essere invece ricondotta alla circolazione monetaria della fase preromana. La dracma è ben con-servata pur avendo un certo grado di con-sunzione (peso g 2.60): la testa femminile al dritto, un po’ rigida nelle linee, mantiene una resa plastica del volto, mentre il leone al rove-scio è stato disegnato in modo naturalistico e la leggenda MAΣΣA, anche se non comple-tamente leggibile, conserva regolari caratteri greci66. Sembra di poterla classificare come appartenente al gruppo ‘massa β’ di Pautasso, corrispondente al gruppo ‘V’ di Arslan, cioè ad un’emissione, ancora vicina al prototipo massaliota, coniata forse dagli Insubri, popo-lo che tra il IV e il III secolo a.C. svolgeva una funzione egemone tra i clan celtici lateniani di più recente immigrazione67. I 24 esemplari dei rinvenimenti isolati dei lavori d’Adige, cor-rispondenti al 2,4% del complesso delle mo-nete preaugustee trovate nel veronese, sono costituiti unicamente da moneta romana e sono articolati nel modo seguente: 4 denari, 6 quinari, 7 assi, 2 semissi e 5 assi dimezzati. Il numerario d’argento è concentrato nella zona di Regaste Orto, riva destra, in partico-lare è stato recuperato nel sito indicato in AMC, Lavori con il numero 324. A Regaste Orto (nn. 320, 324, 326) si concentrano 744 monete, quantità molto superiore a quella di altre zone di rinvenimento per cui vi è una maggiore probabilità che tra tante monete vi siano anche quelle di età repubblicana e di metallo nobile. Non si può escludere che questa concentrazione sia legata alla posizio-ne del sito, collocato vicino all’oppidum e al
101
passaggio della Postumia. I denari sono del 131, del 64 e del 58 a.C.68; i quinari apparten-gono alle emissioni degli anni 89-81 a.C., uno è più tardo, del 39 a.C. Il quinario è il nominale che a partire dalla fine del II secolo a.C. (lex Clodia, 101 a.C.) soddisfaceva la necessità di disporre di un sottomultiplo del denario, so-stituendo i vittoriati ormai consunti e ripren-dendone l’iconografia, la percentuale di fino e il peso leggero. I quinari vennero battuti in ampie emissioni tra il 101 e il 97 a.C. e poi ancora intensivamente in altre emissioni tra il 90 e l’87 a.C. Nel territorio veronese, 1361 quinari dei primi vent’anni del I sec. a.C. era-no nel ripostiglio di Casaleone-Sustinenza69, due in quello di Cologna Veneta70; mentre ve ne sono alcuni da ritrovamento sporadico in città e da contesto abitativo, ad esempio due dall’impianto rustico di Ronchetrin71; uno da una villa rustica a Oppeano72; uno dal territo-rio di Gazzo Veronese73; uno dall’area vicino al ponte romano individuato a San Bonifacio, Villanova74. La cronologia di questi esempla-ri è compresa tra il 90 e l’87 a.C. I quinari dei Ritrovamenti d’Adige sono a nome di M.CATO coniati nell’89 a.C.75 (tre esemplari); a nome di L.RVBRI DOSSENI dell’87 a.C.76 (un esempla-re); uno anonimo dell’81 a.C.77; uno a nome di C.CAESAR IMP, M.ANTONIVS IMP del 39 a.C.78.
Per quello che riguarda il bronzo repub-blicano, il campione è piuttosto ridotto es-sendo costituito da 12 assi, di cui 5 dimezzati intenzionalmente, e da due semissi. Questi ultimi, come altri trovati nel territorio verone-se, hanno peso molto basso, sarebbero quin-di stati coniati con lo standard semiunciale che venne introdotto con la lex Papiria de as-sis pondere, datata al 93/90 a.C.79 oppure al 91 a.C.80 o ritenuta anche più bassa81. Sappiamo, però, che a partire all’incirca dalla metà del II
sec. a.C. la monetazione bronzea si basa, di fatto, su livelli di peso ben al di sotto di quello unciale82 e che i semissi di standard semiun-ciale o anche inferiore sembrano abbastanza diffusi sia in abitato83 sia in necropoli84 nel territorio veronese, dove si trovano in tombe databili al LT C2-D1 e LT D1 in associazione ad assi e a dramme padane della prima metà (o poco dopo) del II sec. a.C. Una parte di questi potrebbero essere imitazioni tollerate dalle autorità, riconoscibili per anomalie nel tipo. Il Crawford ipotizza un’emissione nei primi tre quarti del I a.C., ma, anche in base ai dati for-niti dai corredi delle sepolture del territorio di Verona, la cronologia sarebbe da anticipare85. Le emissioni non ufficiali sembrano riguarda-re i nominali minori dell’asse e denotano il bisogno di circolante spicciolo, forse carente nelle aree periferiche dove l’arrivo in quantità consistenti di moneta romana era avvenuto quando la moneta divisionale di taglio infe-riore non veniva più coniata. La penuria di circolante dovette accentuarsi nel periodo tardo repubblicano a causa della cessazione della coniazione del bronzo dopo il 79 a.C., proprio in un momento in cui cresceva la domanda di moneta. Questo diede luogo sia all’utilizzo di specie monetarie estranee al si-stema romano, sia al fenomeno molto diffuso del dimezzamento di assi unciali e semiun-ciali che, con l’espediente del taglio, vennero mantenuti nella circolazione, adeguandosi al valore della moneta riformata da Augusto.
La pratica della divisione del numerario di bronzo sembra essere stata autorizzata ufficialmente in due principali momenti: attorno al 20 a.C., in concomitanza con la riforma augustea, e attorno al 30 d.C., quan-do gli assi augustei vennero ridotti a semis-si86. L’operazione, attestata soprattutto sul
102
limes in età tiberiana, si contrasse a partire dal regno di Caligola e cessò quasi del tutto nel regno di Nerone, pur con riprese di una certa consistenza nel II secolo d.C. All’epoca dell’introduzione della riforma augustea87, lo scopo del dimezzamento è stato riconosciu-to nell’esigenza di provvedere rapidamente al rifornimento di moneta minuta a fronte dell’abbondanza di assi repubblicani ancora in circolazione; si considerò evidentemente più conveniente tagliare almeno una parte delle monete precedenti piuttosto che riti-rarle, rifonderle e riconiarle. Non vi sarebbe stata alcuna forma di demonetizzazione uf-ficiale; ormai gli assi avevano circolato così a lungo da uscire spontaneamente dal merca-to. Lo Stato garantiva e imponeva il valore di cambio attribuito alle monete spezzate.
La prima età imperiale
Con il rifornimento di monete dei magi-strati monetali di Augusto finisce il periodo di carenza di numerario divisionale e di di-sordine della circolazione che aveva caratte-rizzato il tardo periodo repubblicano. I nuovi assi devono essere arrivati prontamente e in quantità a Verona, come è testimoniato dai casi in cui è possibile avere un puntuale ri-scontro dall’associazione di reperti datanti nella stratigrafia88. Essi estromisero dal mer-cato i precedenti assi repubblicani che, infat-ti, si trovano nei corredi delle sepolture delle necropoli che iniziano in età augustea di nor-ma dimezzati. Rispetto alla massa piuttosto significativa del bronzo tresvirale, l’argen-to è quasi assente: tra le monete rinvenute nell’Adige è stato rinvenuto solo un quinario emesso da Augusto; il dato concorda con i ritrovamenti dagli scavi cittadini che hanno
restituito al momento solo un altro denario e un quinario di Augusto. È attestata poi la moneta coloniale occidentale di Nemausus e quella imperiale coniata nella zecca di Lugdunum. I tre esemplari rinvenuti appar-tengono alle serie di maggiore diffusione, quella dei dupondi/assi di Nemausus coniata tra il 20 e il 10 a.C., con leggenda al rovescio COL NEM e tipo raffigurante un ramo di pal-ma, un coccodrillo e una corona (RIC 154-157) e quella degli assi di Lugdunum con la raffigurazione dell’altare eretto nella città per il culto di Roma e Augusto e dedicato dallo stesso imperatore nel 10 a.C. (RIC 230). Il nu-mero delle attestazioni è in linea con i ritro-vamenti della città e del territorio da cui ven-gono due assi di Nemausus89 e cinque assi di Lugdunum90. Mancano invece tra le monete dei Rinvenimenti d’Adige le emissioni della zecca di Vienna, Colonia Iulia Viennensis.
Tra le emissioni di Augusto a nome dei tresviri monetali vi sono assi, pochi quadranti e un solo sesterzio. Non vi è una particolare concentrazione degli esemplari di un colle-gio triumvirale, come si è notato invece tra le monete degli scavi cittadini tra le quali vi è una maggiore incidenza di quelle del colle-gio del 7 a.C. di P. Lurius Agrippa, M. Maecilius Tullus e M. Salvius Otho.
4. Asse di Claudio, 50(?+)-54, Roma, dal sito n. 322 (inv. n. 67827)
103
9. Denario di Marco Aurelio con Lucio Vero, restituzio-ne di un denario di Marco Antonio, 161-169 d.C., Roma, dal ripostiglio del ponte Postumio (inv. n. 66417)
10. Dupondio di Antonino Pio, 157-158 d.C., Roma, dal sito n. 433 (inv. n. 68405)
11. Sesterzio di Antonino Pio, 158-159 d.C., Roma, dal sito n. 322 (inv. n. 67831)
12. Imitazione di un sesterzio di Commodo, 180-192 d.C., dal sito n. 322 (inv. n. 67851)
13. Denario di Commodo per il Divo Marco Aurelio, post 180 d.C., Roma, dal ripostiglio del ponte Postu-mio (n. inv. 66401)
5. Denario di Vitellio, 69 d.C., Roma, dal sito n. 440 (inv. n. 68415)
6. Denario di Domiziano, 93-94 d.C., Roma, dal riposti-glio del ponte Postumio (inv. n. 66643)
7. Denario di Antonino Pio per Marco Aurelio, 140-144 d.C., Roma, dal sito n. 283 (n. inv. 67104)
8. Denario di Antonino Pio, 138-161 d.C., Cesarea in Cappadocia, dal ripostiglio del ponte Postumio (inv. n. 66573)
104
Complessivamente le monete databili al I secolo d.C. sono più del doppio di quelle di età augustea e di quelle assegnabili al II secolo d.C. I nominali sono in grande mag-gioranza assi e tali sono anche gli esemplari troppo consunti o corrosi per essere ricon-dotti all’autorità emittente, ma attribuibili, sulla base della forma del tondello, al I secolo d.C. Aumenta il numero dei sesterzi rispetto al periodo di Augusto, mentre i quadranti sono solo due. Si segnalano due denari, uno dei quali, particolarmente ben conservato, fu trovato in un punto imprecisato presso il ponte della ferrovia, zona dove in età im-periale si trovava un tempio extraurbano91. Casualmente gli unici due denari del I secolo d.C., rinvenuti in siti diversi, sono di impera-tori, Galba e Vitellio, che per la breve durata dei loro regni sono poco frequenti tra i ritro-vamenti sporadici. Il denario di Vitellio ripro-duce al rovescio le teste affrontate del figlio e della figlia dell’imperatore con leggenda LIBERI IMP GERMAN AVG (RIC 79). La moneta appartiene ad un’emissione nei due metalli, oro e argento, in cui si enfatizza l’intenzione di Vitellio di creare una nuova dinastia ed è singolare che anche la figlia femmina sia in-clusa in tale progetto.
A partire dal II secolo aumenta la quantità dei sesterzi che iniziano, se pur raramente, ad essere presenti all’interno delle tombe e che sono più frequenti tra il materiale smarrito92. Questo è un segnale che indica una progres-siva caduta del potere di acquisto di questo nominale che nella prima metà del III secolo finirà per soppiantare l’asse, prima di cessare di essere coniato nella zecca di Roma duran-te il regno di Gallieno. Appartiene a questa fase un dupondio/asse provinciale, forse di zecca orientale, conservato troppo male per
essere classificato ma probabilmente conia-to a nome di Adriano93; un po’ successivo è un bronzo della zecca di Mylasa in Caria, coniato da Settimio Severo per Geta94. Lo smarrimento di monete di tale provenienza si spiegherebbe con contatti commerciali e politici con il mondo orientale all’interno del generale fenomeno di incremento di nume-rario bronzeo provinciale nelle città venete per supplire alla carenza di quello romano verificatasi con la crisi dell’età di Commodo95. Alla stessa esigenza di integrazione della cir-colazione si dovrebbe attribuire un sesterzio di Commodo con caratteristiche irregolari96.
L’età dei Severi e il secolo dell’antoniniano
Nella prima metà del III secolo d.C. si re-gistra a Verona un incremento di denari nei ritrovamenti isolati. Tra i rinvenimenti d’Adi-ge vi è un esemplare di Settimio Severo per Giulia Domna97 e uno a nome di Elagabalo98. Cresce anche il numero dei sesterzi rispet-to agli assi. Questo nominale, tra la fine del II e gli inizi del III secolo, recuperò un ruolo primario negli scambi prima della definitiva cessazione della sua produzione con il con-seguente ritiro dal mercato da parte dello Stato e la rifusione del vecchio numerario bronzeo99. Dalla fine del II secolo, la crisi po-litica inizia ad interessare l’Impero, a comin-ciare dai sanguinosi conflitti del 193 d.C. che
14. Denario di Settimio Severo, 202-210 d.C., Roma, dal ripostiglio del ponte Postumio (inv. n. 66783)
106
quelli svalutati. Nonostante molti tesori siano posteriori alla riforma di Caracalla, gli anto-niniani vengono esclusi dall’occultamento a causa del loro valore intrinseco inferiore al denario, in aderenza ai principi generali della legge di Gresham.
Riguardo al ripostiglio del ponte Postumio, si sono già ricordate le circostanze e la po-sizione del rinvenimento dei denari. A ciò si può aggiungere che il numero iniziale di 577, ridotto oggi a 475 perché gli esemplari migliori sono stati probabilmente inclusi nel-la serie degli altri denari della collezione del Museo di Castelvecchio, rappresenta solo ciò che è sopravvissuto ed è giunto ai nostri gior-ni, essendo impossibile accertare la quantità iniziale di monete. La composizione del teso-retto dell’Adige ricalca la struttura di altri ripo-stigli di denari che si chiudono tra la fine del II e la prima metà del III secolo: tipicamente sono quasi assenti le emissioni di età giulio-claudia e la serie inizia con i Flavi per avere un picco con gli imperatori antonini e poi calare fino all’epoca di chiusura. I denari repubbli-cani e di età giulio-claudia non si trovano nei ripostigli chiusi nel II e III secolo non solo per la naturale fuoriuscita dalla circolazione a causa della vetustà, ma perché furono in-tenzionalmente ritirati dall’amministrazione dello Stato. Infatti, dal momento in cui l’im-peratore Nerone abbassò con la riforma del 63-64 il peso del denario e introdusse una percentuale di rame106, divenne conveniente per lo Stato ritirare dalla circolazione le mo-nete precedenti con un più alto contenuto argenteo in modo da ricavare un profitto dal-la fusione e riconiazione. Questo processo è documentato appunto dall’improvvisa spari-zione dai tesoretti dei denari repubblicani e giulio-claudi che furono commemorati dagli
imperatori flavi con alcune emissioni di resti-tuzione. Anche Traiano, probabilmente nel 107 d.C., fece coniare un’ampia serie di au-rei e di denari caratterizzati da una leggenda al rovescio che permette di attribuirli a tale imperatore, mentre per il resto replicano leg-gende e iconografia di monete repubblica-ne e imperiali con il fine di ricordare eventi e personaggi significativi della storia romana. Successivamente, durante il regno di Marco Aurelio e Lucio Vero vennero ‘restituiti’ i denari legionari di Marco Antonio i quali sa-rebbero sopravvissuti perché il loro basso contenuto argenteo avrebbe offerto uno scarso profitto alla zecca nel lavoro di fusio-ne e di riconiazione del metallo. Uno di que-sti si trova anche tra i denari dell’Adige (RIC 443)107. I denari precedenti i Flavi sono solo quattro – due di Nerone, molto consunti, e due di Vitellio – mentre sono più consistenti le monete della dinastia flavia che, evidente-mente, circolavano ancora un secolo e mez-zo dopo la loro coniazione: ci sono monete di Vespasiano, di Vespasiano per Tito, di Tito per il Divo Vespasiano, di Tito per Domiziano, di Domiziano. Seguono le monete di Nerva e di Traiano tra le quali si possono notare due esemplari del tipo RIC 291 con al dritto IMP. TRAIANO AVG.GER.DAC.P. M.TR.P. COS.VI P. P., busto drappeggiato, testa laureata a destra e al rovescio S.P.Q.R., Traiano su cavallo, a si-nistra, con lancia e vittoria108. Tra le monete di Adriano sono ben rappresentati i tipi del-le province con l’Africa (RIC 299d)109, l’Egitto con la raffigurazione del Nilo (RIC 310d)110, la Spagna (RIC 305a)111 e sono numerosi i dena-ri coniati in onore di Sabina.
Nell’età di Antonino Pio si tocca la per-centuale più alta di esemplari con emissioni a nome ed effige dell’Imperatore stesso, a
107
nome della moglie Faustina maggiore, sia da viva che da morta ed assunta tra le divinità, a nome del figlio adottivo Marco Aurelio in qualità di Cesare e della figlia Faustina mino-re, moglie di Marco Aurelio. Interessante è la presenza di una moneta romano-provinciale, a nome di Antonino Pio, coniata a Caesarea in Cappadocia. La descrizione è la seguente: D/ ΑΥΤΟΚΡ ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ, busto di Antonino Pio a d., drappeggiato con testa nuda; R/ ΠΡΟΝΟΙΑ, Pronoia, stante a s., tiene un lungo scettro e tende la mano d. verso un globo ai suoi piedi112.
Seguono le monete di Marco Aurelio come Augusto, il quale a sua volta celebra membri della sua famiglia, dalla moglie Fau-stina minore al padre adottivo divinizzato. Vi sono sette monete che appartengono all’e-missione che commemora la consacrazio-ne del Divus Antoninus con i tipi dell’aquila, della pira funeraria, dell’imperatore stesso con i simboli dello scettro e del ramoscello a nome di Marco Aurelio e Lucio Vero. Ad un’al-tra principessa della casa imperiale, Lucilla, moglie di Lucio Vero e figlia di Marco Aurelio, appartengono sei monete.
Con il regno di Commodo le monete ini-ziano a diminuire sensibilmente nel riposti-glio secondo un andamento che coincide con quello di altri ripostigli chiusi nella stessa epoca.
Tra le monete di età severiana, in partico-lare, va segnalato il secondo esemplare che non proviene dalla zecca di Roma. Si tratta di un denario a nome di Settimio Severo co-niato probabilmente nella zecca di Emesa in Siria113, nel 194-195: D/ IMP C[AE L SPE SEV PERT AVG]COS II, testa laureata a destra; R/ M[ONETA], la personificazione della Moneta, in piedi rivolta verso sinistra, regge con la de-
stra una bilancia e con la sinistra una cornu-copia114. Il riferimento è all’amministrazione finanziaria collegata alla produzione mone-tale attivata per sostenere in loco le spese della guerra contro Pescennio Nigro. La pre-senza di qualche esemplare severiano prove-niente da zecca orientale è stata riscontrata in altri ripostigli occidentali chiusi nella stes-sa epoca. Dal punto di vista iconografico è suggestiva la moneta con la dea di Cartagine Caelestis battuta a Roma nel 204, anno del-la celebrazione dei Ludi Saeculares (RIC, 266 o 267). L’emissione ricorda probabilmente i particolari favori concessi da Settimio Severo alla città. La raffigurazione del rovescio, con leggenda INDVLGENTIA AVGG IN CARTH, rappresenta la dea Caelestis che cavalca un leone, tenendo un fulmine o un tambu-ro, mentre nella parte inferiore del campo si vede l’acqua che scaturisce dalle rocce. L’imperatrice Giulia Domna è ricordata sia in emissioni di Settimio Severo che di Caracalla. Tra gli ultimi denari superstiti del ripostiglio ci sono quelli di Caracalla con TR.P.XX, anno 217, e quelli in onore della madre assimila-ta a Cibele come madre degli Augusti, ma-dre del Senato e madre della patria, D/ IVLIA [PIA FELIX] busto drappeggiato a destra; R/ MAT.AVGG.MAT.SEN.M.PATR., Giulia Domna, in piedi rivolta a sinistra, con ramoscello e scettro (RIC 380). La moneta più recente del ripostiglio è di Gordiano III dell’anno 240 (RIC 81)115.
La fase critica dell’Impero si acuisce nel-la seconda metà del secolo, quando an-che l’antoniniano subisce un progressivo svilimento del metallo, che conduce, già all’epoca di Gallieno, all’emissione di grandi quantità di moneta di mistura, la quale va di fatto a soppiantare nel mercato il numerario
108
bronzeo che proprio intorno al 260 d.C. cessa di essere battuto. Lo svilimento dell’antoni-niano provoca la tesaurizzazione anche di questo nuovo nominale, un fenomeno che nel veronese trova riscontro in due clamo-rosi rinvenimenti che hanno fatto pensare alle casse militari trasportate dalle truppe116: il ripostiglio di Ceraino, contenente 12.000 pezzi, interrato intorno al 264 d.C.117 e il te-soro della Venèra, di oltre 45.000 antoniniani da Gordiano III a Diocleziano, interrato nel 287118. In questa fase il quadro economico è aggravato dall’instabilità politica dell’Impero che deve fronteggiare l’ondata di invasioni di popolazioni provenienti dall’Europa centro-orientale, proprio in concomitanza con l’ucci-sione di Valeriano ad opera dei Parti. Durante il regno di Gallieno, la Venetia orientale è tra le regioni maggiormente esposte agli attac-chi esterni, a causa della vicinanza con il con-fine settentrionale: per reagire alla pressione degli Alamanni e degli Jutungi le truppe vengono spostate lungo la via da Milano ad Aquileia e Verona si prepara ancora una volta all’eventualità di un assedio. Tra l’aprile e il di-cembre del 265 d.C., Gallieno fa restaurare e rinforzare con torrette e postierle le mura cit-tadine di età repubblicana, ormai cadute in disuso, e recinge l’Anfiteatro con una nuova appendice muraria, costruita con l’impiego di materiali di recupero. La cospicua massa di antoniniani di mistura immessa nel mercato a partire da questa fase, alla cui coniazione si sopperisce anche con l’apertura di nuove zecche imperiali, trova pieno riscontro tra i pezzi smarriti accidentalmente negli edifici della città e anche nell’Adige, anche se la leg-gerezza, le modeste dimensioni e lo scarso valore nominale di questo numerario può di certo avere influito sul fatto che, una vol-
ta perduto, esso venisse recuperato meno facilmente, e con minore interesse, rispetto ai nominali di modulo maggiore dei secoli precedenti. Per la monetazione di Gallieno, di Claudio II e a nome del Divo Claudio fu la bassissima lega a favorirne una diffusio-ne capillare. In particolare sono frequenti gli antoniniani battuti a nome del Divo Claudio con l’iconografia dell’altare e dell’aquila al rovescio, con una prevalenza del primo ri-spetto al secondo tipo. La coniazione appare spesso approssimativa per il decentramento dell’impronta del conio rispetto al tondello e la scarsa cura dei dettagli rispetto ai proto-tipi più accuratamente incisi. La consistenza nel campione di antoniniani posteriori alla riforma monetale di Aureliano sembra, però, anche avvalorare l’ipotesi di un’economia condizionata dalla presenza militare, ben giustificata a Verona dal ruolo di piazzafor-te assunto dalla città119. Le testimonianze si riducono rispetto alle quantità battute tra il 260 e il 270, ma tutti gli imperatori sono rap-presentati: Aureliano, Tacito, Floriano, Probo, Caro, Carino, Massimiano e Diocleziano. Più numerosi sono i pezzi di Aureliano e Probo, probabilmente per la maggior durata dei loro regni. Nonostante l’intensa tesaurizza-zione di questa fase, il numerario doveva es-sere così capillarmente diffuso da giustificare il frequente smarrimento. La circolazione di queste monete dovette continuare fino al IV - VI sec. d.C., data anche la facile assimilazio-ne ponderale con il numerario in rame di IV secolo, come è dimostrato dal frequente re-cupero in strati la cui cronologia è altrimenti accertabile. Un lungo corso ebbero anche gli antoniniani prodotti dai diversi usurpatori del cosiddetto Impero gallico, le cui monete nei Rinvenimenti d’Adige sono soprattutto dei
109
Tetrici, mentre i pezzi di Vittorino sono solo due. Questo elemento, in linea con i ritrova-menti dell’Italia settentrionale, rivela un qua-dro di contatti con i territori gallici, già emer-so fin dall’età augustea, ma ora molto più spiccato. Affini a questi esemplari per l’ap-prossimazione della tecnica di coniazione, ma distinguibili per il peso basso e per l’in-comprensione dei modelli, sono alcuni casi di imitazione locale120. Nonostante il valore intrinseco praticamente nullo, le emissioni galliche dovevano essere accettate almeno a titolo nominale, circolando insieme al nume-rario migliore, fino ad essere perfino tesau-rizzate, come dimostra il ristretto nucleo pre-sente all’interno del ripostiglio della Venèra.
Nel corso del III secolo alla zecca di Roma se ne erano affiancate altre, dislocate in varie zone dell’impero, che avevano iniziato a co-niare monete contrassegnandole fin dall’e-poca del regno di Gallieno con una sigla all’esergo. Il loro numero aumentò durante il regno di Aureliano che ne riorganizzò il siste-ma sia riducendo il numero delle officine per la produzione delle monete in mistura del-la zecca di Roma, sia potenziando le zecche
nelle province così che potessero operare in modo continuativo e non saltuario come av-veniva in precedenza. Le monete di III secolo dei Rinvenimenti d’Adige spesso non consen-tono, a causa del cattivo stato di conserva-zione, di identificare la sigla di zecca; si sono costruiti comunque due grafici con una pe-riodizzazione a maglie larghe che restituisce le tendenze su lungo periodo sulla base de-gli esemplari leggibili. Il primo arco cronolo-gico considerato va dall’apertura della zecca di Milano da parte di Gallieno nel 255 d.C. alla riforma monetaria di Diocleziano. Nel grafico la colonna delle monete di provenienza in-determinata è la più alta, segue la zecca di Roma che è decisamente superiore alle altre zecche il cui apporto è molto modesto. Tale indicazione concorda con quella dei ritrova-menti monetali provenienti dagli scavi ar-cheologici della città. L’apporto delle zecche asiatiche in questa fase è inesistente, mentre quello delle zecche galliche è relativo al pe-riodo 271-274 d.C., quando esse coniavano per conto degli usurpatori Tetrico I e II; più si-gnificativo il contributo della zecca balcanica di Siscia. L’apertura di Ticinum, attiva dal 274
Grafico 1: l’istogramma sintetizza le attestazioni delle zecche imperiali nel III secolo d.C. L’alternativa di più zecche deriva dalla impossibilità di leggere la sigla in esergo, mentre lo stesso tipo è stato coniato in più sedi.
num
ero
mon
ete
zecche
110
d.C., in sostituzione di Milano, determina un cambiamento rilevante nell’approvvigiona-mento di moneta bronzea in Verona. Già una parte degli antoniniani di Aureliano e di Caro e i suoi figli vengono da tale zecca, ma l’af-flusso si intensifica tra il 299 e il 306 soprat-tutto con le frazioni laureate della serie votxx.
L’età tardo antica
L’età dei Tetrarchi è numericamente rap-presentata da 41 esemplari: prevalgono le frazioni laureate (laureati piccoli) che furono emesse per lo più nella zecca di Ticinum tra il 295 e il 299 d.C. e che appartengono alla se-rie dei Vota. Si ricorda che il territorio verone-se fu direttamente coinvolto nel conflitto che condusse all’ascesa al potere di Costantino a scapito di Massenzio sia con l’occupazione della città da parte dei soldati di quest’ultimo, sia con l’assedio delle truppe di Costantino fino alla battaglia campale del 312121. Le atte-
21. Follis di Costantino I, 317-318 d.C., Ticinum, dal sito n. 320 (inv. n. 67283)
20. Follis di Massimiano Erculeo, 301 d.C., Aquileia, dal sito n. 421 (inv. n. 68392)
22. Follis di Costantino I per Costantino II, 330-335 d.C., Antiochia, dal sito n. 320 (inv. n. 67298)
23. Follis di Costante, 347-348 d.C., Treviri, dal sito n. 324 (inv. n. 67943)
24. AE3 di Costanzo II a nome di Costanzo Gallo, 351-354 d.C., Siscia, dal sito n. 320 (n. inv. 67335)
25. AE3 di Giuliano, 361-363 d.C., Antiochia, dal sito n. 320 (n. inv. 67349)
26. AE2, Magno Massimo, 383-388 d.C., Arles, dal sito n. 323 (inv. n. 67895)
111
stazioni monetarie sono però da connettere a fenomeni economici e tra questi il più im-portante di quegli anni fu la netta riduzione della moneta bronzea tra il 307 e il 309 d.C., fatto che provocò la sottrazione dal mercato dei nominali più pesanti della fase preceden-te. Dei grossi bronzi rimangono sporadiche testimonianze, sia di quelli di peso pieno co-niati dai Tetrarchi, sia di quelli di peso ridot-to, coniati in particolare da Massenzio nelle zecche di Roma e di Aquileia. Le monete di questo imperatore appartengono alla serie con leggenda conserv urb suae, recante il tipo della statua di Roma seduta frontalmente en-tro un tempio esastilo.
A cominciare dal 313 d.C. ha inizio l’ab-bondante produzione di bronzi di taglio medio-piccolo, proseguita per tutta la dura-ta del regno di Costantino e poi continuata dai figli. Il nominale è ancora il nummus il cui peso oscilla attorno ai 3 g; le serie più rappre-sentate sono quelle di soli invicto comiti, iovi conservatori e victoriae laetae princ perp, ma sono frequenti anche i pezzi della serie ce-lebrativa dei vota XX e XXX del dn constantini max aug, emessi tra il 320 e il 325.
Una vera impennata di attestazioni si ha dal 330 d.C. con la serie gloria exercitus.2, fa-vorita da una diminuzione ponderale, sia con la seguente gloria exercitus.3, distinta dalla precedente dal dettaglio iconografico di una sola insegna tra i soldati. L’introduzione di questa seconda serie è accompagnata da un’ulteriore diminuzione di peso avvenuta nel 335 che porta ad emissioni con valore teorico di 1,70 g e modulo più piccolo. Tra il 347 e il 348 venne prodotta la serie victoriae dd auggq nn. Queste emissioni, con quelle ri-dotte di fel temp reparatio, falling horseman, sono immancabilmente presenti in tutti i
contesti tardo-antichi della città122. Altre serie costantemente attestate sono quelle anoni-me prodotte per commemorare l’Urbe e per celebrare la fondazione di Costantinopoli, coniate tra il 330 e la morte di Costantino.
Il numerario della seconda metà del IV secolo è il più rappresentato in tutti i rin-venimenti. Tra il 348 e il 350, l’imperatore Costanzo II avviò una riforma con la quale i nominali di bronzo vennero diversificati: quelli di modulo più largo coniati secondo due diversi standard ponderali e con modu-lo leggermente diverso e quelli più piccoli di peso attorno a 2,50 g con poche tracce d’argento nel metallo utilizzato. Negli anni successivi il cambiamento più significativo, riguardante la moneta di metallo vile, è la perdita della percentuale di argento nella lega così che le monete venivano battute in rame. Nella massa di 628 pezzi appartenenti alla circolazione del IV secolo una parte con-sistente sono gli AE2 (72 pezzi), ma il gros-so è suddiviso tra AE3 e AE4. Sono assenti le monete in metallo prezioso che, invece, sono sporadicamente attestate tra le mo-nete recuperate nelle indagini archeologi-che. Infatti un solido di Valentiniano I della zecca di Treviri viene dal palazzo delle Poste e un altro di Arcadio, battuto nella zecca di Milano, viene da Monte dei Pegni. L’argento è più raro: è nota un’unica frazione di siliqua dal Campidoglio. Tra i Rinvenimenti d’Adige vi sono anche cinque monete di Magnenzio e di Magnenzio per Decenzio nei nominali AE1 e AE2. Il dato è significativo se si tiene conto che dopo la caduta degli usurpatori vennero prese misure di confisca del loro numerario, il quale fu ritirato o tesaurizzato per il buon peso dei nominali. Il fatto che ne sopravvi-vano diversi può far supporre che in pochi
112
anni queste emissioni circolassero molto123. Dell’imperatore Giuliano è sopravvissuto nei ritrovamenti d’Adige solo un AE1 con la raffigurazione di un toro sormontato da due stelle e contraddistinto dalla leggenda SECVRITAS REIPVB, iconografia forse connes-sa al culto del dio Mitra, mentre vi sono altri nove AE3 e AE4124.
L’arco cronologico che va dal 348 al 361 è dominato dalla presenza delle diffusissi-me emissioni della serie fel temp reparatio in tutte le sue varianti. Prevalente all’interno di questo gruppo è il tipo del cavaliere che incombe su un soldato caduto a terra (fal-ling horseman); in particolare sono attestati gli esemplari della riduzione ponderale che ferma il peso medio attorno a g 2,50 e so-prattutto quelli appartenenti alla riduzione successiva, battuti tra il 355 e il 361. In una minima percentuale sono state riconosciute delle imitazioni prodotte per sopperire a una richiesta di numerario superiore alla capacità di approvvigionamento. Nel periodo di go-verno congiunto dei Valentiniani, tra il 364 e il 378, la circolazione del bronzo è sostenuta prevalentemente dall’emissione di AE3 delle serie securitas reipublicae e gloria romano-rum.8, diffusa in modo capillare a Verona e frequente anche nel recupero dal fiume. Nel periodo successivo, compreso tra il 378 e il 388, ritornano però le monete di modulo maggiore, gli AE2 con il tipo di reparatio rei-pub. con l’Imperatore che rialza una donna con corona murale inginocchiata, tenendo la Vittoria sul globo. La serie è ben rappre-sentata a Verona da 46 casi solo dal Teatro e più di 50 dagli altri siti, comprendendo sia i Ritrovamenti d’Adige, sia gli scavi archeologi-ci125. Il dato è in linea con quanto è emerso dai ritrovamenti in Lombardia e nel Veneto
orientale: dopo una abbondante immissio-ne sul mercato di tale numerario, negli anni 383-388 ci sarebbe stato il picco della sua dif-fusione nella circolazione. Successivamente, un provvedimento di Teodosio I portò al ritiro dal mercato dei nominali maggiori la-sciando in circolazione solo i piccoli AE4126. Le emissioni di Magno Massimo e Flavio Vittore sono documentate sia nel nominale maggiore con il tipo della reparatio reipub, sia nel nominale minore con la serie di spes ro-manorum. Nell’ultimo ventennio del secolo il numerario, al livello più basso degli scambi, è costituito soprattutto da AE4. Questi nomi-nali tra i Rinvenimenti d’Adige presentano di-versi problemi per una puntuale classificazio-ne a causa del cattivo stato di conservazione, dovuto alla corrosione della lega di scadente qualità. Si sono riconosciuti alcuni esemplari della serie salus reipublicae.2, ma la maggior parte ha perduto ogni impronta di conio. Il peso si aggira attorno al grammo, sembre-rebbero quindi appartenere alle emissioni della fine del IV secolo mentre non vi sono i cosiddetti minimi, imitazioni o moneta sussi-diaria, di peso inferiore al grammo, diametro al di sotto dei 10 mm e tondello molto sottile rinvenuti con una certa frequenza a Verona nella stratigrafia relativa al momento di deca-denza, di abbandono e poi di distruzione de-gli edifici della città romana. La loro assenza è facilmente giustificabile per le dimensioni ridotte che possono averli resi invisibili. Una moneta molto piccola è stata però vista e raccolta in piazza Duomo; si tratta di un pez-zo interessante perché è una frazione di sili-qua d’argento coniata dagli Ostrogoti127. La moneta è molto consunta ma è ugualmente possibile distinguere un monogramma così da attribuirla all’emissione coniata a nome
113
di Giustiniano con sigla di Teodorico al rove-scio. Poiché il re ostrogoto morì prima che Giustiniano salisse al trono, le monete devo-no essere state battute nel corso del regno di uno dei suoi successori: Teodato (534-535) oppure Vitige (536-538)128. Un esemplare ana-logo, ma di cronologia anteriore, è stato tro-vato a Montorio in località Mattarana in data e circostanze non ricostruibili129. I ritrovamenti in città di moneta gota ammontano comples-sivamente a 18 pezzi130. Nella tabella 1 è possi-bile vedere l’articolazione nei diversi nominali.Per quello che riguarda le zecche, la possibi-lità di leggere il marchio all’esergo a partire dalle emissioni di III secolo consente di rico-struire lo stato della circolazione monetaria durante il periodo in cui l’apertura delle nuo-ve zecche imperiali comporta una diffusione
del numerario secondo circuiti diversificati. Nel periodo che va dalla metà del III secolo all’affermazione di Costantino, pur potendosi distinguere solo su una minoranza di pezzi l’esergo, prevale la zecca romana, seguita da Siscia e da Ticinum, attiva dal 274 d.C. in so-stituzione di Mediolanum. Nella prima metà del IV secolo, fino alla riforma monetale di Costanzo II, l’incidenza della zecca ticinese sembra condizionare quella di tutte le al-tre zecche attestate in città, anche quella
di Roma, la quale, mantiene comunque il primato, affiancata da Aquileia la cui produ-zione aumenta dopo il 334/335. Dalla metà del secolo diventa più consistente l’apporto delle zecche del comprensorio balcanico in conseguenza degli spostamenti di truppe in questi decenni; all’interno del gruppo il ruolo predominante spetta a Siscia. Roma mantie-ne il livello di rifornimento del periodo pre-cedente. Nella seconda metà del secolo le monete che arrivavano a Verona e nella Venetia erano prodotte principalmente in tre zecche: Roma, Aquileia e Siscia. Questo indica che, pur man-tenendosi contatti frequenti con il centro Italia, vi era anche una propensione verso i territori orientali di confine. La componente emessa dalle zecche nord-occidentali, Are-
late e Lugdunum, è legata soprattutto a mo-menti particolari della vita politica e militare, come quello dell’usurpatore Magnenzio. Le testimonianze orientali sono equamente di-stribuite con pochi pezzi (da 2 a 6) per ogni zecca; un po’ più consistente il contributo della zecca traco-macedone di Thessalonica. Negli ultimi decenni del IV e agli inizi del V secolo, la circolazione monetale del bronzo è alimentata soprattutto da Aquileia per cui essa assume un carattere tipicamente locale.
n. esemplari nominale autorità emittente cronologia rif. catalogo
1 quarto di siliqua Teodorico a nome di Giustino I 518-526 COI 55
1 quarto di siliqua Vitige a nome di Giustiniano 536-538 COI 64
1 20 nummi Atalarico 526-534 COI 83 a
1 20 nummi Atalarico 526-534 COI 84 a
6 10 nummi Teodorico 493-518 COI 77
8 10 nummi Teodorico 493-518 COI 78 a-bTabella 1: Riepilogo dei ritrovamenti di moneta ostrogota a Verona.
114
Grafico 2: l’istogramma sintetizza le attestazioni delle zecche imperiali nel IV secolo. La cattiva conservazione delle monete in molti casi pregiudica il riconoscimento della loro provenienza.
Grafico 3: l’istogramma permette di visualizzare come le monete si concentrino nel I, III e IV secolo. Si sono con-siderati i soli rinvenimenti isolati.
Grafico 4 : l’istogramma permette di visualizzare quali siano i nominali più frequenti tra le monete dei Rinveni-menti d’Adige. Sono stati esclusi i denari del ripostiglio.
115
In conclusione, per quanto sia indispensabile approfondire entro scansioni cronologiche più ravvicinate il contributo delle diverse zec-che, sembra possibile ipotizzare che Verona nel IV secolo rientrasse in circuiti moneta-ri meno condizionati dalla circolazione del comprensorio nord-orientale della penisola e maggiormente ricettivi nei confronti dell’en-troterra italico rispetto agli altri centri veneti (114 attestazioni per le zecche peninsulari; 58 per le zecche orientali; 51 per le zecche occi-
dentali). Tale constatazione, coincidente con quanto osservato per i rinvenimenti monetali dal Teatro romano e dal Capitolium, potrebbe suggerire che la città avesse avuto contatti più diretti con la capitale a causa del ruolo di spicco politico ed economico ancora rivesti-to tra il III e il IV sec. d.C. nell’ambito dell’Italia settentrionale nel quadro generale di crisi e decadenza urbana.
Antonella ArzoneFederico Biondani
Note
1 Del testo del presente articolo si deve a Federico Biondani la parte I e ad Antonella Arzone la parte II.Si ringrazia Giacomo Faggionato per la rielaborazione grafica delle mappe di Verona; le foto sono di Stefano Sacco-
mani. Per migliorare la leggibilità la dimensione della foto, a volte, è superiore a quella reale della moneta.Le immagini delle figg. 1-2 sono state autorizzate dall’Archivio di Stato di Verona, concessione 22/13 del 22/7/2013.2 Sui lavori compiuti a Roma cfr. MOCCHEGGIANI CARPANO 1984, p. 67 ss.3 Sulla piena del 1882 e sui lavori che seguirono cfr. fra gli altri GAZZOLA 1963, pp. 87-96; MAGAGNATO 1977
(con approfondimento sui cambiamenti di carattere urbanistico); MILANI 1995, pp. 7-22; ZALIN 2003, pp. 393-399. I lavori furono seguiti attentamente dalla stampa cittadina (cfr. In difesa d’Adige 2007, alla sezione bibliografia, pp. n.n.). Relazioni tecniche compaiono nei “Resoconti delle sedute del Consiglio comunale di Verona” degli anni 1889-1892 (cfr. ancora In difesa d’Adige 2007). Su questi lavori esiste inoltre una ricca documentazione fotografica; in particolare va segnalato l’album “Lavori di difesa d’Adige in Verona” realizzato da Giuseppe Bertucci per conto della ditta Laschi, appaltatrice dei lavori (In difesa d’Adige 2007).
4 Feste inaugurali 1895, passim.5 A proposito dei lavori del 1890 per la costruzione del collettore in destra Adige, Milani, lodando l’accuratezza del
lavoro dell’ing. Donatelli, sottolinea come “ogni rudere, ogni avanzo di antichità, ogni più minuto frammento uscito da quegli scavi è stato raccolto, registrato e riportato sulla pianta planimetrica” (MILANI 1891a, p. 4).
6 A proposito del Ponte Postumio, Brizio ricorda che l’ufficio tecnico diretto da Donatelli “con grande cura ha mi-surato e rilevato tutti i blocchi scoperti, riproducendoli poscia in tanti solidi, di piccole dimensioni, con i quali sarà possibile ricostruire in seguito un modello esatto di quel ponte” (BRIZIO 1891a, pp. 101-102).
7 Ricci, nell’introdurre la sua relazione del 1893, rende “pubblica e meritata lode al ch. cav. Ing. Tullio Donatelli, di-
RiassuntoA seguito dei lavori che si tennero a Verona negli anni 1887-1894 per la rettifica del corso dell’Adige e la costruzione dei muraglioni fu recuperato numeroso materiale archeologico, fra cui circa 2000 monete antiche. Queste monete sono state studiate dagli scriventi e sono in corso di pubblicazione nell’ambito della collana Ritrovamenti monetali del Veneto. I ritrovamenti si distribuiscono soprattutto nel tratto fluviale fra ponte Pietra e ponte Navi, in particolare nell’area dell’antico ponte Postumio, nei cui pressi è stato recuperato un ripostiglio. Riguardo alla posizione origina-ria dei reperti monetali si ritiene che la fluitazione sia stata limitata; si ritiene inoltre che le monete siano finite nel fiume a seguito di eventi alluvionali o per ragioni accidentali. L’arco cronologico dei reperti numismatici è compreso tra il III secolo a.C. e il IV secolo d.C. con una particolare concentrazione in età tardo antica. Si tratta prevalentemen-te di numerario di bronzo di piccolo taglio, cioè degli spiccioli smarriti durante la vita quotidiana.
116
rettore dell’Ufficio Tecnico municipale di Verona, il quale, con singolare perizia ed amore nelle ricerche archeologiche, tiene nota in apposito elenco di ogni ritrovamento negli scavi urbani, specialmente dell’Adige, e così ne rende pos-sibile lo studio ulteriore” (RICCI 1893, pp. 3-4). Apprezzamenti per Donatelli furono espressi anche dallo storico Carlo Cipolla (FRANZONI 1994, pp. 309-310).
8 Donatelli curò anche la redazione di planimetrie e relazioni di accompagnamento. Queste sarebbero di grande aiuto per l’esatta ubicazione dei luoghi di ritrovamento; purtroppo, nonostante le ricerche compiute in vari archivi (Musei Civici di Verona, Comune di Verona, Archivio di Stato di Verona, Ufficio del Genio Civile di Verona), non sono state reperite. Un frammento di questa documentazione è costituito dai rilievi relativi al ponte Postumio inviati dal Co-mune di Verona a Carlo Cipolla nel 1896 (ora all’Archivio di Stato di Verona), nei quali sono documentati i ritrovamenti del 1891 durante i lavori d’Adige e quelli del 1896 dovuti ad una eccezionale magra del fiume (cfr. BRUGNOLI 2001). Cipolla utilizzò questa documentazione per il suo lavoro sul ponte Postumio, legato alla datazione dell’Iconografia Rateriana (CIPOLLA 1901).
9 Cfr. BRUGNOLI 2001, pp. 42-43.10 MILANI 1891a, p. 16.11 DONATELLI, ORSI 1891, p. 4.12 GHIRARDINI 1891.13 MILANI 1891a.14 Le monete sono elencate secondo l’ordine di AMC, Lavori fino al numero 146. Un riscontro della consegna a
Milani di queste monete si trova in AMC, Lavori al n. 145, dove, fra le osservazioni, è scritto: “Le monete tutte registrate fino al n. 145 vennero consegnate al Sig. Prof. L.A. Milani”.
15 MILANI 1891b.16 FIORELLI 1891.17 BRIZIO 1891a; BRIZIO 1891b18 RICCI 1893.19 In particolare, nell’elenco di Ricci, ci sono due monete le quali, a meno di non ammettere una qualche confu-
sione nella numerazione dei siti, risultano moderne. Si tratta di “1 p. br. di Aureliano” trovato il “25 febbraio 1892” (però probabilmente è marzo) a San Tomaso “di fronte alla casa ex Brentel-Bargonti” (equivalente al sito n. 650 di AMC, Lavori) a cui corrisponde attualmente una moneta veneziana e di un “p. br. del II secolo (irriconoscibile)” trovato il 22 febbraio 1892 nello scavo dell’alveo del fiume in via Beccheria (equivalente al sito n. 633 di AMC, Lavori) a cui corrisponde at-tualmente una moneta che dopo una sommaria pulizia dalle incrostazioni è risultata di Napoleone.
20 CIPOLLA 1901, pp. 11-13. Le monete da lui prese in esame sono quelle che “occupano i sacchetti 204, 205, 212, 216, 220, 223, 224, 225, 226, 231, 236, 238, 239, 243, 245”.
21 FRANZONI 1965, passim e FRANZONI 1975, passim.22 BOLLA 1999, pp. 220-237; BOLLA 2000, pp. 42-55.23 Un catalogo completo del materiale numismatico è stato realizzato dagli scriventi ed è di prossima pubblicazio-
ne nel volume dedicato a Verona città, nell’ambito della collana Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto, curata dal Prof. Giovanni Gorini.
24 Stupisce infatti, scorrendo l’elenco degli oggetti recuperati (AMC, Lavori), che il materiale ceramico sia costituito quasi unicamente da anfore da trasporto; molto poco è anche il materiale vitreo. Assai numerosi invece, oltre alle monete, sono i bronzi e i materiali lapidei, fra cui molte epigrafi.
25 STENICO 1953, p. 66. Altre monete nella medesima area furono trovate negli anni successivi: cfr. VISMARA 1992, pp. XVII-XVIII (ivi bibl.).
26 FRIER, PARKER 1970, pp. 89-91. Le monete trovate nel Garigliano durante le varie campagne assommano a circa 5000 (VISMARA 1998, p. 9); inoltre dalla foce di questo fiume provengono altre 2665 monete antiche trovate a seguito di scavi clandestini, che sono state oggetto di sequestro: GIOVE 1996, p. 113.
27 www.uniroma2.it/eventi/monete/n-tev-3.28 In proposito si segnala che anche le monete trovate nel 1949 a Pavia nel fiume Ticino, sia quelle d’argento sia
quelle di bronzo, erano in genere “assai sciupate e, molte, profondamente corrose”: STENICO 1953, p. 43.29 Un centinaio è stato affidato a Giordano Passarella; un altro centinaio è stato restaurato nel 2009 presso il Labo-
ratorio di restauro dell’Università di Padova a cura del dott. Michele Asolati.
117
30 Cfr. CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 48, 50. Lungo questo tratto, la presenza di un ponte romano in corrisponden-za del ponte di Castelvecchio è stata ipotizzata, fra gli altri, dal Galliazzo (cfr. GALLIAZZO 1973, p. 37); mancano però solidi indizi a riguardo (cfr. FRANZONI 1975, p. 63, n. 38).
31 Che fra ponte della Vittoria e ponte Pietra l’Adige non abbia avuto modificazioni di corso rispetto all’età romana è attestato dalla scoperta di una strada e di resti di muraglioni d’argine romani paralleli all’alveo attuale: cfr. FRANZONI 1975, p. 121, n. 151; CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 6-7 (ivi bibl.). Questi elementi smentiscono l’ipotesi, rimasta peral-tro isolata, di Richmond e Holford, secondo i quali l’ansa del fiume a nord-ovest della città sarebbe stata più ampia dell’attuale (RICHMOND, HOLFORD 1935, p. 71, fig. 1).
32 L’esistenza di un ponte romano è ipotizzata da vari studiosi fra cui il Galliazzo (GALLIAZZO 1973, p. 37; GALLIAZZO 1994, II, p. 223, n. 454), ma è ritenuta molto dubbia sia dal Franzoni (FRANZONI 1975, p. 62, n. 37) sia dalla Cavalieri Manasse (CAVALIERI MANASSE 1987, p. 6).
33 GALLIAZZO 1973, pp. 45-46. Sulla questione cfr. inoltre FRANZONI 1986, pp. 349-351 e CAVALIERI MANASSE 1987, p. 50 e p. 57, nota 320. A sostegno di questa ipotesi potrebbe essere il fatto che i ritrovamenti relativi al ponte Postu-mio compiuti nel 1896 a circa 20-30 m dalla riva destra sarebbero da riferire non tanto ad una pila, bensì alla spalla destra (cfr. relazione del 1896 riportata in BRUGNOLI 2001, p. 51); mancano però dati di scavo precisi.
34 CAVALIERI MANASSE 1987, p. 7 (ivi bibl.).35 FRANZONI 1975, pp. 50-51, n. 13; FRANZONI 1986, pp. 350-351.36 Questo ponte, dopo una probabile prima realizzazione lignea, fu poi costruito in pietra verso la metà del I sec.
a.C.: cfr. fra gli altri FRANZONI 1975, pp. 56-58, n. 27; GALLIAZZO 1969-1970; GALLIAZZO 1994, II, pp. 223-226 (ivi altra bibl.).
37 La denominazione “Postumio” è moderna e si deve al fatto che su questo ponte, i cui resti furono rinvenuti pro-prio in occasione dei lavori d’Adige, doveva passare l’antica via Postumia. Su questo ponte cfr. fra gli altri FRANZONI 1975, pp. 56-57, n. 26; CAVALIERI MANASSE 1987, p. 12; GALLIAZZO 1994, II, p. 226, n. 457; sulla documentazione me-dievale cfr. CAPPIOTTI, VARANINI 2012, p. 114 ss.
38 In questo punto, sottolinea Gazzola, il fiume “non scava né interra” (GAZZOLA 1963, p. 33).39 Motivi analoghi (destinazione d’uso e topografia del luogo ma anche tratto più tranquillo dopo l’ansa) sono stati
addotti per spiegare l’alta concentrazione di monete individuata a Roma nel Tevere in corrispondenza dell’edificio del San Michele, di fronte all’impianto portuale del Testaccio, in confronto ad altri tratti urbani del fiume: SERAFIN, DE PACE, NICOLAI 2005, p. 599.
40 CAVALIERI MANASSE 1998, p. 119, nota 57; BOLLA 1999, p. 195.41 Mentre gli oggetti metallici e le monete vennero conservati, gli oggetti di altro materiale (vetro, ceramica, legno,
osso e forse marmo) vennero ributtati nel fiume: STENICO 1953, pp. 42-43.42 STENICO 1953, pp. 69-73.43 Per un sintetico quadro dei ritrovamenti: FRANZONI 1965, pp. 135-139, n. 145; FRANZONI 1975, pp. 116-117, n.
143.44 FRANZONI 1975, p. 117.45 GALLIAZZO 1973, pp. 45-46.46 CAVALIERI MANASSE 1987, p. 50 e p. 57, nota 320; CAVALIERI MANASSE 1998a, p. 119, nota 57. Sulle varie ipotesi
avanzate in passato intorno alla funzione della gradinata cfr. BESCHI 1960, pp. 455-456.47 BRIZIO 1891a, pp. 107-108.48 BRIZIO 1891a, pp. 107-108. Il rinvenimento del presunto contenitore delle monete è segnalato in AMC, Lavori n.
250: il 26 febbraio 1891 “tra i ruderi del ponte Postumio (riva sinistra)” furono trovati “tre frammenti di bronzo, che si suppone appartenessero alla cassetta contenente le monete” (data di consegna al Museo 30 giugno 1891).
49 Sui ritrovamenti compiuti presso il ponte Postumio cfr. in generale FRANZONI 1965, pp. 38-39, n. 26; FRANZONI 1975, pp. 56-57, n. 26 (ivi altra bibl.); riguardo al ripostiglio cfr. ARZONE 2001.
50 Cfr. FRANZONI 1975, pp. 54-55, n. 23; CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 52-53, nota 38 (ivi bibl.); GALLIAZZO 1994, II, p. 223, n. 455.
51 CAVALIERI MANASSE 1998b, pp. 186-192. Priva di concreti riscontri è l’ipotesi del Canobbio circa la presenza di un ponte romano in corrispondenza dell’attuale ponte Aleardi (cfr. FRANZONI 1975, p. 54, n. 22).
52 FRANZONI 1975, pp. 30-31, n. 1.
118
53 CAVALIERI MANASSE 1998b, p. 185: ivi bibl.54 GIULIARI 1818; GIULIARI 1821; PEREZ 1881.55 Sulle problematiche relative al luogo di deposizione originario dei materiali archeologici trovati nei fiumi (com-
presi quelli monetali) in relazione ad un ritrovamento entro il fiume Brenta presso Padova cfr. LEONARDI 1992.56 Le offerte lungo il corso dei fiumi sembrano rispondere a ragioni differenti rispetto a quelle in sorgenti o piccoli
specchi d’acqua. Su queste ultime e sui loro possibili significati (simbolo di un patto fra uomini e dei finalizzato soprat-tutto al recupero della salute; tributo per onorare gli dei; ringraziamento o pagamento per attività oracolari; significato magico) cfr. FACCHINETTI 2003 e FACCHINETTI 2004.
57 Cfr. VISMARA 1992, pp. XIII-XIV.58 FRIER, PARKER 1970, pp. 90-91. Dopo la realizzazione della città, il traffico di transito si sarebbe spostato all’ester-
no, mentre il ponte sul Garigliano di collegamento fra il decumano massimo e i quartieri sorti sulla sponda sinistra del fiume sarebbe rimasto ligneo con un utilizzo solo locale e “con un carattere che può anche essere sacrale” (BELLINI 1998, p. 13). Va tenuto presente comunque che a Minturnae lungo il fiume si svolgevano intense attività portuali e commerciali che potrebbero anch’esse rendere ragione di questa ampia presenza monetale (cfr. VISMARA 1998, pp. 11-12). Per altri esempi di ritrovamenti monetali da fiume di età romana che potrebbero essere legati ad offerte dei viaggiatori cfr. FRIER, PARKER 1970, pp. 90-91; VISMARA 1998, pp. 10-11.
59 Cfr. STENICO 1953, p. 70.60 In proposito va ricordato che le monete di IV secolo circolarono a lungo fino al pieno VI secolo: cfr. SERAFIN, DE
PACE, NICOLAI 2005, p. 601: ivi bibl.61 Ci si riferisce ai diversi ritrovamenti nel territorio di aes rude (S. Pietro in Cariano, Archi di Castelrotto: RMRVe III/3
31/3/1; S. Giorgio in Valpolicella, Casaletti: RMRVe III/3 32/5/1; Oppeano: RMRVe III/2 21/1(1)/1-4 e 21/5(1)/1-?) e di aes signatum (S. Giorgio in Valpolicella: RMRVe III/3 32/5/2 e 32/6/1). Un ripostiglio di pani di metallo e di utensili bronzei è venuto alla luce a Campo Paraiso (Breonio) in Lessinia: SALZANI 1979, pp. 588-590.
62 GORINI 1987, pp. 234-235.63 ARSLAN 2007, pp. 310-313.64 Il territorio veronese ha restituito quattro ripostigli di età repubblicana la cui data presunta di chiusura è scalata
a distanza di dieci anni nella seconda metà del I secolo a.C.: Albaredo (1240 denari e quinari); Cologna Veneta (108 denari e quinari); Sustinenza-Casaleone (2151 denari e quinari); Montorio (38 denari).
65 Diversamente GORINI 2008, p. 477 (il confronto è limitato alle sole necropoli celtico-romane).66 La moneta sembra vicina anche al gruppo 8A di Pautasso che inserisce in questo sottotipo le monete con «testa
al dritto di stile classico, simile al prototipo massaliota; leone al rovescio poco deformato e di buone proporzioni». La differenza sembra essere nella mancanza di deformazione del leone al rovescio. Secondo Saccocci le monete di que-sto sottotipo, che definisce di ‘bello stile’, sarebbero le prime emissioni monetali in area veneta, prototipo per tutta la successiva monetazione di tipo locale. Sarebbero opera di incisori non locali, ma provenienti da aree dove la moneta era ben conosciuta e si daterebbero all’ultimo quarto del III a.C., in coincidenza dello scontro di Roma con i Galli. SAC-COCCI 1994, pp. 107-115, in particolare alle pp. 109-110.
67 PAUTASSO 1966, pp. 1-162, in particolare pp. 19-20 e p. 104; ARSLAN 1991-1992, XC-XCI, pp. 9-33, in particolare p. 17.
68 RRC 253/1 (MVR 67912); RRC 412/1 (MVR 67102); RRC 422/1b (MVR 67917).69 RMRVe, III/4. Il ripostiglio si chiude nell’anno 50 a.C.; il suo seppellimento e mancato recupero sono in genere
collegati alle vicende delle guerre civili. I quinari datati tra l’anno 99 e l’anno 81 sono 1361 su un totale di 2151 monete; soltanto 15 quinari appartengono ad un’emissione del 62 a.C.
70 RMRVe, III/2, 10/8 (1)/27-28 (RRC 341/3, 343/2a, 90 e 89 a.C.).71 Monete inedite: RRC 341/3 (90 a.C.); RRC 343/2 (89 a.C.).72 RMRVe, III/2 21/4/1 (RRC 348/4, 87 a.C.).73 RMRVe, III/2 13/17(4)/4 (RRC 343/2b, 89 a.C.).74 Di età successiva: RMRVe, III/3 29/1(2) (RRC 480/25, 44 a.C.).75 RRC 343/2 a-b.76 RRC 348/4.77 RRC 373/1b.
119
78 RRC 529/4b.79 CRAWFORD 1985, p. 183.80 MARTINI 2001, p. 49.81 ARSLAN 2007, p. 318.82 RRC, p. 596.83 Oltre a un semisse trovato a Colognola ai Colli, peso g 5,50, rinvenuto in uno strato databile alla prima metà del I
sec. a.C. (RMRVe III/3 11/1/4; SALZANI 1983, p. 82); un altro rinvenuto a Castel Sottosengia (Fumane) (RMRVe III/3 14/4/3 SALZANI 1981, p. 101: peso g 4,395) si ricordano quelli di Montorio raccolti in superficie: BIONDANI 2000, pp. 61-77, e quelli da Verona.
84 Oltre che a Isola Rizza (BIONDANI 1998, pp 127-142 sono documentati a Valeggio sul Mincio (BIONDANI et alii 1995, p. 78) e a S. Maria di Zevio (BIONDANI 1996, p. 208).
85 BIONDANI 1998, pp. 127-142.86 Una sintesi delle questioni relative alle monete dimezzate augustee in MARTINI 2001, pp. 419-424.87 La data di introduzione della riforma è il 19 a.C. per il Sutherland (RIC I), invece Rodolfo Martini propone il 23-22
a.C., in concomitanza con la nomina di Augusto a tribuno della plebe, e un’inversione della scansione cronologica dei primi quattro collegi di monetieri. MARTINI 2001, pp. 111-114.
88 Ci si riferisce ad esempio al caso di via Redentore 9 dove vi è una stretta concordanza tra la cronologia dei reperti ceramici e le monete che documenta la circolazione del numerario dei tresviri a Verona negli ultimi due decenni del I secolo a.C.
89 Brentino-Belluno: RMRVe III/3 5/2 (2b) 1; S. Giorgio in Valpolicella: RMRVe III/3 32/4(3)/5 (esemplare dimezzato).90 Villabartolomea loc. Stanghelletti RMRVe III/2 35/6(2)/1; Santa Maria di Zevio (Rivalunga) RMRVe III/2 36/5(a)/2-3;
Povegliano, località Dossetto RMRVe III/2 22/4/6 (esemplare dimezzato).91 RIC I, 79; MVR 68415. BOLLA 2009, p. 11.92 GORINI 2002, p. 184.93 MVR 68304. G 12,31; mm 24. D/ [-]G[-] Testa a d.; R/ [-] Figura stante. L’esemplare è ritenuto provinciale per il
modulo e il peso e inoltre per le caratteristiche del ritratto del dritto (forse attribuibile ad Adriano). Un altro bronzo provinciale proviene dagli scavi del cortile del Seminario. Si tratta di una moneta di Marco Aurelio della zecca di Nysa ad Meandrum in Lydia (cfr. SNG Cop., Lydia, 317 oppure RPC IV, scheda temporanea on line n.1473).
94 MVR 67850: SNG Cop., Caria, 437.95 Prevale in questa fase il numerario proveniente dalle province orientali (comprensorio balcanico e Moesia) e Asia
Minore (Pergamo, Laodicea, Antiochia), con diverse testimonianze provenienti dalla Bitinia e da Alessandria d’Egitto. Per il Veneto: GORINI 2002, pp. 185-186; per le attestazioni in area lombarda: ARSLAN 2007 p. 329; per il Trentino: GORINI 2000, p. 252.
96 MVR 67851: BMC 729. L’esemplare è pubblicato in BMC, compreso fra “various irregular issues” e presenta al dritto la leggenda: COMMO-DVS AVGV.
97 MVR 67002: RIC 577.98 MVR 68736: RIC 161.99 GORINI 2002, pp. 184-185.100 SARTORI 1960, pp. 247-248.101 MORATI 1870, pp. 58-61.102 Il tesoro era composto da due bracciali in oro, una collana in oro e smeraldi, tre anelli con gemme incise oltre a
parecchie monete che iniziavano con Elagabalo e terminavano con Traiano Decio. BOLLA 2002, p. 102.103 Nel corso di ricerche di superficie effettuate da un gruppo archeologico locale sul sito di una probabile villa
rustica sono stati recuperati 27 denari, da Vespasiano a Settimio Severo. L’omogeneità dei nominali e la coerenza della cronologia, oltre al ritrovamento in un’area ristretta li hanno fatti ritenere un gruzzolo disperso. RMRVe III/2, 22/7.
104 Solo nel ripostiglio di Paulmana le ultime monete appartenevano a Traiano Decio e solo questo tesoro ha chia-ramente le caratteristiche del nascondimento in condizioni di emergenza, ma gli altri tre ripostigli ci sono pervenuti in condizioni di incompletezza e la classificazione di quello di Villabona, prima della sua dispersione, è molto appros-simativa, per cui non si può escludere che i gruzzoli contenessero anche monete di Traiano Decio.
105 La questione del valore facciale attribuito al radiato al momento della sua introduzione rimane controversa. La
120
posizione classica è quella espressa da H. Mattingly (BMCRE, V, Introduction, p. xviii) per cui il radiato equivarrebbe a due denari. Secondo Lo Cascio l’antoniniano avrebbe avuto il valore di un denario e un quarto, LO CASCIO 1984, pp. 133-201.
106 Un temporaneo miglioramento avvenne durante il regno di Domiziano e in quello di Nerva.107 MVR 66417.108 MVR 66604, 66605.109 MVR 66576.110 MVR 66521; 66740.111 MVR 66387.112 MVR 66573. METCALF 1996, n. 117.113 Nei primi anni del suo regno, Settimio Severo avrebbe utilizzato alcune zecche situate nelle zone teatro di guer-
ra tra le quali anche la città di Emesa della quale era originaria Giulia Domna. L’ipotesi di attribuire una serie di monete a Emesa è basata sullo stile e sull’articolazione della leggenda. BMCRE, Introduction, pp. cxviii-cxix; RIC IV, pp. 81-82.
114 BMCRE, pp. 96-97, nn. 383 oppure 384 o 386.115 Prima del restauro si riteneva che le ultime monete fossero di Caracalla e si era perciò fissata al 217 la data di
chiusura del ripostiglio. Dopo il recente restauro di una parte del tesoretto è stato possibile leggere alcuni esemplari prima indeterminati e tra questi quello di Gordiano.
116 GORINI 1987, p. 263; Venera I, p. 5.117 GORINI 1987, p. 263.117 GRICOURT 2000, p. 15.119 ARSLAN 2004, p. 68; ARSLAN 2007, pp. 331-332.120 ARZONE 2008, p. 537.121 SARTORI 1960, pp. 252-254.122 Sulle presenze monetali nel Veneto dopo la riforma di Costanzo II: GORINI 2002, p. 189.123 CALLEGHER 1998, pp. 36-38; ARSLAN 2007, p. 335 e nota 265 con un’ampia registrazione dei rinvenimenti. I dati
veronesi correggono l’impressione di Arslan di una particolare concentrazione delle monete di Magnenzio e Decen-zio nelle province di Bergamo, Brescia e Trento; il fenomeno coinvolge l’intero territorio padano.
124 L’impressione di una rarità nelle attestazioni nell’area occidentale sembra debba essere corretto a fronte dei dati veronesi: sono noti dai ritrovamenti veronesi complessivamente 4 esemplari di AE1 e 27 tra AE3 e AE4. Rare effettiva-mente, invece, le monete di Gioviano di cui c’è un solo rinvenimento. CALLEGHER 1998, p. 144.
125 Corte Farina (1), Corso Cavour 21 (2), ritrovamenti d’Adige-Regaste Orto (20), ritrovamenti d’Adige-Muraglioni (3), via Liceo (1), Montorio, loc. Gavagnin (3), San Felice Extra (1), Palazzi Giudiziari (10), Palazzo Forti (1), Corte Sgarzarie (2), Monte dei Pegni (2), Corte Sgarzarie 2003 (1); corso Santa Anastasia (7). Il calcolo non è completo ed è approssi-mato per difetto.
126 ARSLAN 2005, p. 207.127 Nell’Elenco generale è segnalato che il 15 agosto 1891 fu trovata “una piccola moneta d’argento” (AMC Elenco n.
88 ) ; Luigi Milani la ritenne un sesterzio repubblicano, identificazione da escludere perché nonostante la consunzione è distinguibile un monogramma. MILANI 1891a, p. 6 e p. 28; cfr. anche MILANI 1891b, p. 287.
128 MVR 66200. GRIERSON, BLACKBURN 1986, p. 37. Per la definizione tipologica: MEC 138 oppure COI 64.129 Quarto di siliqua coniato da Teodorico a nome di Giustino I, COI 55. La moneta è dispersa ed è nota solo da una
fotografia.130 Monete gote: 4 esemplari dall’area dei Palazzi Giudiziari dove è documentata la continuità dell’uso abitativo
dell’insula nel corso di tutto l’altomedioevo; 4 dall’area del Capitolium; 2 dal Teatro romano; 1 da piazza Vescovado da un impianto termale ripristinato in età gota; 1 da via Duomo in una tomba longobarda; 1 da piazza Corrubbio; 2 da corso Sant’Anastasia; 1 in piazza Duomo; 1 a Montorio, loc. Mattarana.
121
FONTI ARCHIVISTICHE
AMC, Lavori = Archivio del Museo di Castelvecchio, Lavori d’Adige 1890-93 Verona. Di questo registro presso la Biblioteca di Castelvecchio esiste anche una copia dattiloscritta con il titolo Elenco generale degli oggetti d’arte rinvenuti nella esecuzione dei lavori d’Adige.
BIBLIOGRAFIA
ARSLAN E.A. 1991-1992, Le monete padane preromane a Budapest, in “Numizmatikai Koezloeny”, XC-XCI, pp. 9-33.ARSLAN E.A. 2004, Le monete di Manerba, in La necropoli romana di Campo Olivello. Dagli scavi ottocenteschi di G.B. Marchesini
ai recenti rirovamenti di Manerba del Garda, a cura di B. Portulano e S. Amigoni, Mantova, pp. 62-89.ARSLAN E.A. 2005, Monete, in Indagini archeologiche a Como. Lo scavo nei pressi di Porta Pretoria, a cura di I. Nobile, Como,
pp. 206-228.ARSLAN E.A. 2007, Le vicende della circolazione monetaria, in Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni. Dalla
preistoria al Medioevo, a cura di M. Fortunati e R. Poggiani Keller, I, Bergamo, pp. 307-363.ARZONE A. 2001, Un ripostiglio di denari dall’alveo dell’Adige, in Inspecto nummo. Scritti di numismatica, medaglistica e sfragi-
stica offerti dagli allievi a Giovanni Gorini, a cura di A. Saccocci, Padova, pp. 37-62.ARZONE A. 2008, Le monete, in L’area del Capitolium di Verona. Ricerche storiche e archeologiche, a cura di G. Cavalieri Manas-
se, Verona, pp. 531-582.BELLINI M.T. 1998, Introduzione, in Minturnae. Antiquarium. Monete dal Garigliano, III. La città ed il porto (296-44 a.C.). Monete
romane repubblicane (fino alla morte di Cesare), a cura di G.R. Bellini, Milano (Materiali Studi Ricerche, 12), pp. 7-29.BESCHI L. 1960, Verona romana. I monumenti, in Verona e il suo territorio, I, Verona, pp. 367-552.BIONDANI F. 1995, Le monete, in La necropoli gallica di Valeggio sul Mincio, a cura di L. Salzani, Mantova, pp. 77-84, tavv.
XVII-XXI.BIONDANI F. 1996, Necropoli di località Mirandola. Le monete, in La necropoli gallica e romana di S. Maria di Zevio (Verona), a
cura di L. Salzani, Mantova, pp. 207-218.BIONDANI F. 1998, La necropoli gallica di Casalandri a Isola Rizza (Verona), a cura di L. Salzani, Mantova, pp. 127-142, tavv.
LIII-LX.BIONDANI F., CORRENT G., SALZANI L., MARINETTI A. 2000, Montorio (Verona). Ricerche di superficie sul Colle del Castello, in
“Quaderni di Archeologia del Veneto”, XVI, pp. 61-77.BIONDANI F. 2007, Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto. III/2, Provincia di Verona: Legnago, Padova (= RMRVe, III/2).BOLLA M. 1999, Bronzetti figurati romani del territorio veronese, in “Rassegna di studi del Civico Museo archeologico e del
Civico Gabinetto numismatico di Milano”, LXIII-LXIV, pp. 193-260.BOLLA M. 2000, Statuaria e cornici di bronzo di epoca romana nel Museo archeologico di Verona, in “Rassegna di studi del
Civico Museo archeologico e del Civico Gabinetto numismatico di Milano”, LXV-LXVI, pp. 25-71.BOLLA M. 2002, Militari e militaria nel territorio veronese e gardesano (III-inizi V sec. d.C.), in Miles Romanus dal Po al Danubio
nel Tardoantico, Atti del Convegno internazionale Pordenone-Concordia Sagittaria 17-19 marzo 2000, a cura di M. Buora, Pordenone, pp. 99-135.
BOLLA M. 2009, Testimonianze archeologiche di culti a Verona e nel territorio in età romana, in Verona storico-religiosa: testimo-nianze di una storia millenaria, a cura di P.A. Carozzi, Verona, pp. 11-31.
BRIZIO E. 1891a, Verona – Scoperte archeologiche fatte in Verona nell’alveo dell’Adige, in “Notizie degli scavi”, pp. 101-108.BRIZIO E. 1891b, Verona – Nuove epigrafi latine scoperte nei lavori per la sistemazione del corso urbano dell’Adige, in “Notizie
degli scavi”, pp. 215-216.BRUGNOLI A. 2001, Il rinvenimento del ponte Postumio nel 1891. Contributo alla ricerca archivistica delle fonti archeologiche, in
“Atti della Accademia roveretana degli Agiati”, CCLI (ser. VIII, vol. I, A), pp. 41-58.CALLEGHER B. 1998, Trento-Teatro sociale: scavi 1990-1992. Le monete repubblicane, imperiali e medievali: analisi critica e cata-
logo del complesso numismatico, in Materiali per la storia urbana di Tridentum.II. Ritrovamenti monetali, Trento, pp. 7-341.
CAPPIOTTI F., VARANINI G.M. 2012, Il pons marmoreus e gli edifici ai piedi del castrum, in La più antica veduta di Verona. L’i-conografia rateriana. L’archetipo e l’immagine tramandata. Atti del Seminario di studi 6 maggio 2011 Museo di Castelvecchio, a cura di A. Arzone e E. Napione, Caselle di Sommacampagna (Verona), pp. 109-132.
122
CAVALIERI MANASSE G. 1987, Verona, in Il Veneto nell’età romana, II, Verona, pp. 1-57.CAVALIERI MANASSE G. 1998a, La Via Postumia a Verona, una strada urbana e suburbana, in Optima Via. Postumia. Storia e ar-
cheologia di una grande strada romana alle radici dell’Europa. Atti del Convegno internazionale di studi. Cremona 13-15 giugno 1996, Cremona, pp. 111-143.
CAVALIERI MANASSE G. 1998b, Banchi d’anfore romane a Verona: nota topografica, in Bonifiche e drenaggi con anfore in epoca romana: aspetti tecnici e topografici. Atti del Seminario di studi Padova 19-20 ottobre 1995, a cura di S. Pesavento Mattioli, Modena, pp. 185-196.
CIPOLLA C. 1901, L’antichissima iconografia di Verona secondo una copia inedita, in “Reale Accademia dei Lincei. Memorie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche”, s. V, vol. VIII, a. CCXCVIII (estratto).
CRAWFORD M.H. 1974, Roman republican coinage, voll. I-II, Cambridge (= RRC).CRAWFORD M.H. 1985, Coinage and money under the Roman Republic, London.DONATELLI T., ORSI P. 1891, Verona – Avanzi di costruzioni romane, sculture ed oggetti recuperati nei lavori pel grande collettore
sulla destra dell’Adige, in “Notizie degli scavi”, pp. 3-18.FACCHINETTI G. 2003, Iactae stipes: l’offerta di monete nelle acque nella penisola italiana, in “Rivista italiana di numismatica”,
CIV, pp. 13-55.FACCHINETTI G. 2004, L’offerta di monete nelle acque in età romana e tardoantica: alcune riflessioni, in Acque per l’utilitas, per la
salubritas, per l’amoenitas, a cura di M. Antico Gallina, Milano, pp. 273-298.Feste 1985, Feste inaugurali dell’Adige. Programma della Esposizione dell’Adige 5-6 giugno 1895, Verona.[FIORELLI G.] 1891, Verona – Nuove scoperte epigrafiche, in “Notizie degli scavi”, pp. 43-44.FRANZONI L. 1965, Verona. Testimonianze archeologiche, Verona.FRANZONI L. 1975, Edizione archeologica della carta d’Italia al 100.000. Foglio 49. Verona, Firenze.FRANZONI L. 1986, Immagine di Verona romana, in “Antichità altoadriatiche”, XXVIII, pp. 345-373.FRANZONI L. 1994, Carlo Cipolla e l’antichità fra tutela e ricerca, in Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento.
Atti del Convegno di studio. Verona 23-24 novembre 1991, a cura di G.M. Varanini, Verona 1994, pp. 303-314.FRIER B.W, PARKER A. 1970, Roman coins from the river Liri, in “The numismatic chronicle”, pp. 89-109.GALLIAZZO V. 1969-1970, Il ponte della Pietra di Verona. Problemi archeologici e storici, in “Atti e memorie della Accademia di
agricoltura scienze e lettere di Verona”, s. VI, XXI (LXLVI), pp. 533-570.GALLIAZZO V. 1973, Nuove considerazioni sull’idrografia e sull’urbanistica di Verona romana, in Il territorio veronese in età roma-
na. Convegno del 22-23-24 ottobre 1971. Atti, Verona, pp. 33-60.GALLIAZZO V. 1994, I ponti romani, I-II, Treviso.GAZZOLA P. 1963, Ponte Pietra a Verona, Firenze.GHIRARDINI G. 1891, L’iscrizione di Prassitele e le statue antiche scoperte in Verona, in “Nuova antologia”, s. III, v. XXXII, pp. 667-
688.GIOVE T. 1996, Monete dal fiume Garigliano, in Minturnae. Antiquarium. Monete dal Garigliano, I. Guida alla Mostra. Catalogo
delle monete, a cura di G.R. Bellini, Milano (Materiali Studi Ricerche, 8), p. 113.GIULIARI B. 1818, Relazione degli escavamenti fatti nell’anfiteatro di Verona l’anno MDCCCXVIII, Verona.GIULIARI B. 1821, Relazione sugli scavi fatti nell’anfiteatro di Verona l’anno 1819, Verona.GORINI G. 1987, Apetti monetali: emissione, circolazione e tesaurizzazione, in Il Veneto in età romana, I, Verona, pp. 227-286.GORINI G. 2000, Presenze monetali e tesaurizzazione, in Storia del Trentino, II, L’età romana, a cura di E. Buchi, Bologna, pp.
241-285.GORINI G. 2002, Problematiche e metodi di indagine nell’economia monetaria della X regio, in Ritrovamenti monetali nel mondo
antico. Problemi e metodi, Atti del congresso internazionale (Padova 31 marzo – 2 aprile 2000), a cura di G. Gorini, Padova, pp. 177-191.
GORINI G. 2008, Alcuni aspetti della romanizzazione nel veronese attraverso le monete, in Est enim ille flos Italiae…Vita econo-mica e sociale nella Cisalpina romana, Atti delle giornate di studi in onore di Ezio Buchi, a cura di P. Basso, Verona, pp. 475-484.
GRICOURT D. 2000, Ripostiglio della Venèra. Nuovo Catalogo Illustrato. Caro-Diocleziano, IV, Verona.GRIERSON P.- BLACKBURN M. 1986, Medieval European Coinage, I, The Early Middle Ages (5th-10th centuries), Cambridge (=
MEC).
123
In difesa d’Adige 2007, In difesa d’Adige. La campagna fotografica di Giuseppe Bertucci 1890-1894, a cura di E. Lievore, A. Prandi, Verona.
LEONARDI G. 1993 (a cura di), Un complesso votivo a nord di Padova, in “Quaderni di archeologia del Veneto”, IX, pp. 130-147.LO CASCIO E. 1984, Dall’antoniniano al ‘laureato grande‘: l’evoluzione monetaria del III secolo alla luce della nuova documenta-
zione di età dioclezionea, in “Opus”, III, pp. 133-201.MAGAGNATO L. 1977, La piena del 1882, la regolazione dell’Adige in città e le sue implicazioni urbanistiche, in Una città e il suo
fiume. Verona e l’Adige, a cura di G. Borelli, II, Verona, pp. 799-867.MARTINI R. 2001, Caesar Augustus: collezione Veronelli di monete di bronzo. Catalogo critico, Milano.MATTINGLY H. 2005 (1a ed. 1950), Coins of the Roman Empire in the British Museum, V. Pertinax to Elagabalus, London
(= BMCRE)METCALF W.E. 1996, The silver Coinage of Cappadocia, Vespasian-Commodus, American Numismatic Society, New York.METLICH M.A. 2004, The coinage of Ostrogothic Italy, London (= COI).MILANI L.A. 1891a, Le recenti scoperte di antichità in Verona, Verona.MILANI L.A. 1891b, Le recenti scoperte di antichità in Verona, in “Bollettino dell’imperiale Istituto archeologico germanico”, vol.
VI, fasc. 3, pp. 285-301, 307-331 (estratto).MILANI G. 1995, La Verona fluviale. Dalla grande alluvione alla costruzione dei muraglioni 1882-1895, Vago di Lavagno (Vero-
na).MOCCHEGGIANI CARPANO C. 1984, Il Tevere: archeologia e commercio, in “Bollettino di numismatica”, nn. 2-3, pp. 21-81.MODONESI D. 2001, Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto, III/4, Provincia di Verona: Casaleone/ Sustinenza, a cura
di D. Modonesi, Padova (= RMRVe, III/4)MORATI F. 1871, Informazione sopra alcuni ripostigli di monete, in «Periodico di Numismatica e sfragistica per la storia d’Ita-
lia», pp. 58-69.PAUTASSO A. 1966, Le monete preromane dell’Italia settentrionale, in “Sibrium”, VII, 1962-63 (1966), pp. 1-162.PAVONI M.G. 2005, Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto, III/3, Provincia di Verona: Peschiera del Garda, a cura di M.G.
Pavoni, Padova (= RMRVe, III/3)PEREZ A. 1881, L’acquedotto dell’anfiteatro (lavori del 1880), in “Archivio storico veronese”, VIII, fasc. XXIII, pp. 177-194.RICCI S. 1893, Verona – Recenti scoperte epigrafiche e archeologiche, in “Notizie degli scavi”, pp. 3-23.RICHMOND I.A., HOLFORD W.G. 1935, Roman Verona: the archaeology of its town-plan, in “Papers of the British School at
Rome”, XIII, pp. 69-76.SACCOCCI A. 1994, Alcune considerazioni sulle monete di tipo venetico, in Numismatica e Archeologia del celtismo padano, Atti
del Convegno Internazionale Saint-Vincent 8-9 settembre 1989, Aosta, pp. 107-115.SALZANI L. 1979, Il ripostiglio di campo Paraiso (Breonio), in “Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona”, 6, pp.
501-597.SALZANI L. 1981, Preistoria della Valpolicella, Verona.SALZANI L. 1983, Colognola ai Colli. Indagini archeologiche, Vago di Lavagno.SARTORI F. 1960, Verona romana. Storia politica, economica, amministrativa, in Verona e il suo territorio, I, Verona, pp. 161-259.SERAFIN P., DE PACE S., NICOLAI R.M. 2005, Il Tevere e il Lazio. Analisi della circolazione monetale e le scienze ausiliarie, in XIII
Congreso Internacional de Numismatica. Madrid - 2003. Actas, editado por C. Alfaro, C. Marcos y P. Otero, Madrid, pp. 599-609 [www.mcu.es/museos/docs/MC/ActasNumis].
STENICO A. 1953, Relazione definitiva sui ritrovamenti archeologici nell’alveo del Ticino a Pavia, in “Bollettino della Società pavese di storia patria”, n.s. V, 1, pp. 37-80.
SUTHERLAND C.H.V. 1984 (1a ed. 1923), The Roman imperial coinage. From 31 BC to AD 69, London (= RIC)Sylloge Nummorum Graecorum. The Royal collection of coins and medals. Danish national museum, Ionia, Caria, Lydia, Cope-
naghen, 1946-1947 (= SNG Cop.).VISMARA N. 1992, Monetazione repubblicana, Pavia (Cataloghi dei Civici Musei di Pavia, II).VISMARA N. 1998, Monete greche e provinciali dal Garigliano: introduzione critica, in Minturnae. Antiquarium. Monete dal Ga-
rigliano, II. Monete greche, provinciali romane e tessere romane (di bronzo e di piombo), a cura di G.R. Bellini, Milano (Materiali Studi Ricerche, 11), pp. 7-38.
ZALIN G. 2003, Il territorio veronese tra l’annessione e i moti del 1898, in Verona e il suo territorio, VI/2. Verona nell’Otto/Novecen-to, Verona, pp. 303-426.
Finito di stamparemaggio 2014
Nuova GrafotecnicaCasalserugo (Padova)
Tel. 049 [email protected] - www.grafotecnica.it