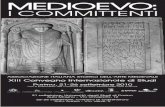Arte, ambiente e paesaggio nell’attività parlamentare di Carlo Levi e nei lavori per la...
Transcript of Arte, ambiente e paesaggio nell’attività parlamentare di Carlo Levi e nei lavori per la...
1 | 2012 NAZIONE
Fra idealismo e cultura materiale
Nella “Commissione Franceschini”1 viene a giusta ragione indivi-
duato lo spartiacque fra due contrapposte stagioni culturali. Da
un lato si colloca la concezione idealistica, estetizzante che pone
l’attenzione sulle singole rarità e bellezze artistiche e naturali; dall’altro
quella antropologica intitolata al “bene culturale”, inteso come “ogni testi-
monianza materiale avente valore di civiltà”, e ai “beni ambientali”.
In questo senso la Commissione rappresenta certamente uno snodo
cruciale per il modo di intendere il patrimonio storico artistico e i valori
che di esso meritano di essere conservati e comunicati. Ma forse sarebbe
meglio dire che la Commissione Franceschini è lo specchio fra i più effica-
ci, per quanto vi è di organicamente concepito e per quanto di contraddit-
torio e di irrisolto si riscontra nelle sue risultanze, di quel periodo che det-
te luogo forse non ad una transizione fra idealismo e cultura materiale,
quanto, piuttosto, ad una compresenza per lo più conflittuale fra queste
due concezioni di cultura. Periodo che spiega quelle proposte di radicale
revisione degli stessi statuti disciplinari delle scienze storiche, fra cui anche
l’archeologia e la storia dell’arte, e il conseguente insorgere di paradigmi
metodologici che, accettati da molti e da molti altri rifiutati, hanno comun-
que preso uno spazio imprescindibile nell’esercizio delle nostre discipline.
Se si deve giudicare dalle molte novità verificatesi a partire dal 1967,
quando vennero pubblicati gli atti della Commissione, la innovativa visio-
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
154
1. Fu istituita con la l. 26-4-1964, n. 310, Costituzione di una commissione d’indagine per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio. Concluse i lavori con la
pubblicazione dei tre volumi Per la salvezza dei Beni culturali in Italia. Atti e documenti della Com-
missione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del
paesaggio, Colombo, Roma 1967.
Arte, ambiente e paesaggio nell’attività parlamentare di
Carlo Levi e nei lavori per la Commissione Franceschini
di PATRIZIA DRAGONI
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
1 | 2012NAZIONE
ne legata alla nozione di “bene culturale” parrebbe essersi definitivamente
e totalmente affermata. Fra tanto altro, infatti, è stato costituito un apposi-
to ministero ed ufficialmente intitolato ai “beni culturali” e “ambientali”,
invece che alle cose di straordinario interesse artistico o storico e alle bel-
lezze naturali, la cura delle quali era uno dei molteplici compiti prima spet-
tanti al ministero della Pubblica Istruzione. Negli anni settanta il direttore
dell’Istituto Centrale per il Restauro, Giovanni Urbani, ha prospettato il
superamento della tecnica tradizionale del restauro, per dare attuazione ad
un’attività di prevenzione del danno con misure di conservazione pro-
grammata rivolte all’ambiente prima che ai singoli beni. Recentemente è
stato adottato addirittura un Codice intitolato ai beni culturali e al paesag-
gio. Il museo, proprio ad opera del Codice, è stato riconosciuto come pub-
blico servizio e non più solo come universitas rerum e posto in relazione
con il territorio dal D.M. del 10 maggio 20012. La valorizzazione è stata
costituzionalmente prevista come funzione distinta dalla tutela. Addirittu-
ra è stata sottoscritta una Convenzione Europea del Paesaggio, che ogni
Stato membro è tenuto a recepire nelle proprie leggi, con la quale, nel 2000,
è stata sancita la doverosa salvaguardia sia dei “paesaggi che possono esse-
re considerati eccezionali, sia dei paesaggi della vita quotidiana” e perfino
dei “paesaggi degradati”, i quali ugualmente cooperano “all’elaborazione
delle culture locali” e rappresentano “una componente fondamentale del
patrimonio culturale e naturale”3.
In apparenza, dunque, si è compiuta una trasformazione anche più
profonda di quella richiesta dai membri della Franceschini. In realtà la
situazione rimane parecchio complessa e irrisolta tanto sotto il profilo giu-
ridico, amministrativo e tecnico, quanto sul piano culturale. Lo dimostra
emblematicamente il riproporsi negli ultimi decenni di “una rappresenta-
zione prosopopeica, monumentale e selettiva, delle cose d’interesse artisti-
co e storico” e di un linguaggio usato per descriverle che inclina di nuovo
“volentieri alla metafora: lontano da ogni accezione pragmatica, da qua-
155
2. Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei.3. Convenzione europea del Paesaggio, Firenze 20 ottobre 2000, art. 2.
1 | 2012 NAZIONE
lunque interesse per la lettura tecnica dei rapporti spaziali e temporali rife-
riti dagli oggetti d’arte come dal paesaggio intero”4. Inoltre la definizione di
“bene culturale” è prepotentemente entrata nell’uso, ma senza troppo
preoccuparsi di rispettarne il significato5, al punto che viene ormai sempre
più spesso collegata a “esemplarità squisitamente museali”6.
Di fatto l’origine di questa distonia era insita nella Commissione stessa.
L’omogeneità dei risultati ai quali essa pervenne è molte volte piuttosto appa-
rente. Dietro l’effetto unificante di alcune enunciazioni, prima fra tutte l’e-
spressione stessa “beni culturali”, e di qualche parola d’ordine di forte impe-
gno sociale, emerge spesso fra le molto differenti figure di studiosi che vi pre-
sero parte una eterogeneità di accenti e non raramente una aperta contraddit-
torietà di impostazioni che ritraggono fedelmente la complessità di quella sta-
gione anche sotto il profilo della ideologia politica7. Dunque di essa occorre
avere puntuale consapevolezza, per poter comprendere le ragioni delle discor-
danze oggi perduranti circa l’individuazione stessa degli oggetti ritenuti meri-
tevoli di studio e di tutela giuridico-amministrativa, nonché circa i fini e i
metodi dell’attività di salvaguardia del patrimonio storico artistico e del pae-
saggio e, pertanto, circa l’esercizio della storia dell’arte come di altre finitime
discipline di studio, circa la pratica del restauro e le possibilità della conserva-
zione preventiva e circa l’ordinamento e la conduzione degli istituti museali.
Il nostro fondamentale interesse è comprensibilmente rivolto allo specifi-
co tema dei beni storici e artistici e, in particolare, al momento in cui vengo-
no visti come “beni culturali” e riferiti anche alla dimensione del paesaggio e
al conseguente emergere dell’intenzione di trasformare il museo da “congre-
gazione di opere «a funzionamento estetico»” a “centro vitale di attività
didattica e di ricerca e punto nodale di riferimento indispensabile anche per
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
156
4. B. Toscano, Il territorio come campo di ricerca storico-artistica, oggi, in AA.VV., Pittura del ‘600 e del ‘700.
Ricerche in Umbria. 3. La Teverina umbra e laziale, Canova, Treviso 2000, pp. 19-29, pagg. 20-21.5. Si veda M. Montella, Valore culturale, in G.M. Golinelli (a cura di), Patrimonio culturale e creazione
di valore, CEDAM, Padova 2012, pp. 3-70.6. Toscano, Il territorio come campo di ricerca storico-artistica, oggi, cit., p. 21.7. Come noto la Commissione comprendeva non solo addetti ai lavori in senso stretto, che certo furo-
no numerosi e assai autorevoli. Numerosi furono anche i parlamentari.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
1 | 2012NAZIONE
la programmazione regionale nel suo insieme”8, a “sede idonea di interpreta-
zione e comunicazione” dei valori del “territorio come «museo diffuso»”9.
Non potremmo però cogliere adeguatamente questo obiettivo, osser-
vando i fatti dal chiuso recinto dello specifico settore disciplinare della sto-
ria dell’arte, del restauro e della museologia, invece di allargare lo sguardo
al più vasto contesto culturale, sociale e politico. Il dibattito sulla questione
culturale, sulla contrapposizione fra la cultura materiale e la tradizione cro-
ciana, è evidentemente permeato dai valori eminentemente politici della
nuova stagione democratica, che per molti decenni ancora, quantomeno
fino a tutti gli anni settanta, indirizzeranno l’attenzione sul diritto sociale
alla cultura e, a tal fine, anche sulla necessità di superare la forma tradizio-
nale del museo in favore di un nuovo “museo sociale”10, sulla incompatibi-
lità del modello di sviluppo industriale capitalistico rispetto alla salvaguar-
dia del paesaggio, sulla democratizzazione dei processi culturali e delle stes-
se discipline storiografiche in ordine tanto alla individuazione degli ogget-
ti di studio, quanto alle forme di divulgazione.
Carlo Levi
Per ritrarre quel clima e le sue interne contraddizioni, più delle persona-
lità di assoluto specialismo professionale che caratterizzarono quegli anni
conviene prendere perciò in esame chi portò nella Commissione France-
schini un contributo intellettuale più largamente coinvolto nei basilari fer-
menti ideologici del tempo.
Una figura ben rispondente a questa esigenza sembra essere quella di
Carlo Levi, perché aderisce allo spirito composito di quegli anni con l’im-
mediata sensibilità del “poeta”, come ebbe giustamente a considerarlo Vit-
torio Foa in contrapposizione ai «tecnici»”, ai “professionisti”11, e perché
157
8. B. Toscano, Museo locale e territorio, in «Spoletium», dicembre 1972, XIV, 16-17, pp. 7-8.9. D.M. 2001. Rinvio a P. Dragoni (a cura di), La qualità nel museo. Ricognizione sullo stato di alcuni
musei locali, EUM, Macerata 2008.10. In merito si veda P. Dragoni, Processo al museo. Sessant’anni di dibattito sulla valorizzazione musea-
le in Italia, Edifir, Firenze 2010.11. M. Pera, Presentazione, in C. Levi, Discorsi parlamentari, il Mulino, Bologna 2003, p. 11.
1 | 2012 NAZIONE
fu al tempo stesso artista, letterato, politico. La sua vicenda intellettuale,
dalla formazione giovanile imprescindibilmente legata a Croce e poi
maturata con Gobetti fino all’approdo all’azionismo di “Giustizia e
Libertà”, si intreccia con le maggiori personalità della cultura, dell’arte e
della politica a partire dagli anni Venti del Novecento12. Nel suo pensiero
vivacemente si manifestano tanto le ansie di rinnovamento sociale e poli-
tico, e dunque anche culturale, del dopoguerra, quanto il faticoso supera-
mento dell’eredità di pensiero ricevuta dai precedenti decenni soprattut-
to in materia di arte. Vi convivono, in gradi diversi, il mito della bellezza
artistica sempiterna e universale e l’arte come prodotto storicamente cir-
costanziato, la cultura alta e la cultura popolare, il riconoscimento di un
diritto di cittadinanza alla cultura da cui non debbono essere esclusi i ceti
popolari più miseri, però accompagnato da un concetto di cultura di per-
durante sapore elitario, l’arte per l’arte e l’arte socialmente impegnata, la
libertà dell’arte e l’arte di partito.
A base di tutto nel pensiero di Levi agisce la strenua volontà di costrui-
re un nuovo Stato e una nuova società che dovevano essere retti da ideali di
libertà e di giustizia sociale e che, perciò, dovevano nettamente contrappor-
si al periodo liberale antecedente al fascismo. Quando si occupa di arte e
più ancora di paesaggio, il suo obiettivo primario e totalizzante è sempre e
comunque di dare attuazione agli ideali della Resistenza, vista “anche, e for-
se soprattutto” come “una reale rivoluzione culturale, nel mondo della cul-
tura e del pensiero. La rivoluzione culturale del nostro tempo […] costitui-
ta dal fatto di far nascere, di portare alla storia, milioni di uomini nuovi, che
non esistevano prima come esseri, come persone coscienti, come persone
nella storia reale. […] è anche logico e giusto e splendido che questo con-
tenuto poetico e culturale generi, nel campo più specifico dell’arte e della
letteratura, nuove forme, nuovi linguaggi”13.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
158
12. Si veda G. De Donato, S. D’Amaro, Un torinese del sud: Carlo Levi, Baldini Castoldi Dalai, Milano
2005.13. Il sole di aprile, discorso pronunciato per il ventennale della Resistenza nel 1965, ora in C. Levi, Il
dovere dei tempi. Prose politiche e civili, Donzelli, Roma 2004, pp. 271-272.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
1 | 2012NAZIONE
È su questo terreno e dunque anche sulla diversa lettura politica dellastoria d’Italia che poggia anzitutto il distacco decisivo di Levi dall’insegna-mento di Benedetto Croce14.
La volontà di Levi era, però, tanto ferma e appassionata quanto non pro-prio politicamente “scientifica”. Soprattutto quando affronta questioni piùpropriamente artistiche, anche nel momento in cui cerca di assumere piùaggiornate posizioni, egli resta solitamente a metà del guado. Esemplare èil modo in cui articola il suo pensiero nell’intervento pronunciato in Parla-mento a proposito del disegno di legge sulla revisione della tassa alla espor-tazione degli oggetti di antichità e d’arte. Dapprima, infatti, afferma che “dimolte opere - un quadro di Raffaello, per esempio - si può benissimo soste-nere che rappresentano lo stesso bene per l’umanità se esposte nel museodi New York anziché nel luogo dove sono state create.” Così dicendo egli siallinea alla visione gerarchicamente selettiva dei prodotti artistici, alla con-cezione capolavoristica dell’assolutezza dei valori. Poi però aggiunge che “lacosa non è così semplice perché effettivamente un’opera d’arte e di culturaha un valore diverso, che l’atmosfera culturale giustifica, se rimane nel luo-go d’origine; mentre perde una buona parte del suo significato quando vie-ne distaccata dal suo ambiente naturale e portata altrove”15. Altro, però, èparlare di “atmosfera”, altro di contesto e atmosfera.
Arte contemporanea
La difficoltà che Levi incontra nel tentare di coniugare la visione che hadella attività artistica con i suoi ideali di etica politica16 emerge bene nellepagine su «L’Arte Contemporanea» da lui curate nel volume di atti dellaCommissione Franceschini.
Il problema di fondo con cui lì si misura, e che subito infatti enuncia inapertura del testo, consiste molto significativamente nel “continuo, non eli-
159
14. L. Sacco, L’Orologio della Repubblica, Argo, Lecce 1996.15. Levi, Discorsi parlamentari, cit., p. 189.16. “Che romanzi volete che ci siano, dopo Auschwitz e Buchenwald?”: C. Levi, L’Orologio, Einaudi,Torino 1989, pp. 53-58.
1 | 2012 NAZIONE
minabile, necessario rapporto”17 fra l’arte contemporanea e lo Stato. A suo
giudizio, perciò, non solo è privo di senso il concetto di arte pura, poiché
“sarebbe agevole dimostrare che anche le forme d’arte che negano ogni
rapporto con la realtà, e intendono limitarsi a esprimere astrattamente non
i contenuti né le forme, ma il puro metodo del pensiero, non sarebbero
pensabili né esistenti”. Egli ritiene, più ancora, che nessuna attività artistica
possa realizzarsi a prescindere da “un certo tipo storicamente costituito di
società e di Stato”18.
Tuttavia questo avvio non porta alla conclusione che ci si aspetterebbe,
ovvero ad una visione in qualche modo deterministica circa il condiziona-
mento che la società e perfino il “tipo storicamente costituito di Stato” eser-
citerebbero sull’arte. Per discostarsi dall’idea dell’arte come spazio rarefat-
to, distaccato dalla normale esistenza, Levi non sembra disposto ad alli-
nearsi su posizioni come quelle di Ranuccio Bianchi Bandinelli, di cui nel
1950 era apparsa la seconda edizione Storicità dell’arte classica con un testo
introduttivo in cui si diceva dell’opera d’arte come prodotto socialmente
determinato19, o di Antal e di Hauser, le cui opere, pubblicate rispettiva-
mente nel 1947 e nel 1953 e tradotte in versione italiana nel 1955 e nel
1960, godevano allora di grande fortuna20. Al contrario gli preme afferma-
re il principio fondamentale secondo cui “L’arte è libera”. “Organizzare il
mondo attorno alla libertà” era l’assoluto precetto gobettiano fatto proprio
da Levi. Doveva poter essere, secondo l’insegnamento di Gobetti, una
libertà di specie assolutamente nuova, da costruire democraticamente a
partire dal basso, e doveva potersi realizzare rispetto sia al potere dello Sta-
to che a quello del mercato.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
160
17. Per la salvezza dei Beni Culturali in Italia, cit., vol. I, p. 381.18. Ibidem.19. R. Bianchi Bandinelli, Storicità dell’arte classica, Electa, Firenze 1950.20. F. Antal, Florentine Painting and its Social Background The Bourgeois Republic Before Cosimo de’
Medici’s Advent to Power: XIV and early XV centuries, Kegan Paul, London 1947, Id., La pittura fio-
rentina e il suo ambiente sociale nel Trecento e nel primo Quattrocento, Einaudi, Torino 1960; A. Hau-
ser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, 2 voll., Beck, Munich 1953, Id., Storia sociale dell’arte,
Einaudi, Torino 1955.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
1 | 2012NAZIONE
Perciò la soluzione alla quale pensa di potersi affidare parte dalla ipote-
si di poter costruire uno Stato talmente diverso dal passato, da dover rinun-
ciare in fin dei conti a se stesso, ad una propria identità e all’influenza chenecessariamente esercita. Levi teorizza, infatti, il superamento di “ogni resi-duo di concezioni desuete e rifiutate dello Stato e dell’arte”, di “ogni mortaeredità del passato, ogni pretesa di tutela, di strumentalizzazione, di pater-nalismi moralistici, che ripugnano al sentimento e al pensiero del nostropaese”. Ma non precisa mai in quale modo alternativo debba essere organiz-zato. Quando, nelle pagine che seguono, si trova a dover spiegare la moda-lità di pratica realizzazione di tale disegno, l’impaccio prevale.
Il compito gli riesce agevole fintanto che procede per negazioni. Noall’arte di Stato, perché “nessuna tendenza o indirizzo o scuola artistica può
identificarsi con dei supposti principî estetici dello Stato”, perché “l’arte
non può essere considerata in nessun modo strumento né di un’ideologia
statale, né di una morale statale, né comunque un indirizzo di Stato, né di
alcun interesse estraneo all’arte stessa”21. No a qualunque forma di censura,
“sia la censura diretta sotto forma di divieto, sia quella indiretta che si cela
sotto le forme della tutela, dell’incoraggiamento, del mecenatismo di Stato,
del paternalismo burocratico”22.
Ma non è chiaro come lo Stato possa, senza incorrere in questa indiretta
censura,“difendere l’autonomia e la libertà dell’arte” contro “l’influenza esclu-siva del mercato, che tende a mercerizzarla e a livellarla a bisogni artificiali e afalsi interessi (problema grave del nostro tempo)”23, né come possa farlo nel
momento in cui gli si chiede di “riportare l’arte al suo carattere pubblico”, di
“incoraggiarla senza interferire nel suo sviluppo”, di liberare “gli artisti dal
peso della propria povertà e dalla pressione dell’altrui ricchezza e autorità”.Una prima risposta tentata da Levi è tanto condivisibile quanto difficil-
mente separabile dai temuti condizionamenti sia mercantili che statalistici:
161
21. C. Levi (a cura di), L’arte contemporanea, in Per la salvezza dei Beni Culturali in Italia, cit.,vol. I, p. 382.22. Ibidem.23. Ibidem, p. 384.
1 | 2012 NAZIONE
“curare che il pubblico sia incoraggiato e aiutato, attraverso la scuola e gli
strumenti di cultura di massa (come la televisione, i giornali, ecc.) ad avvi-
cinarsi alla comprensione dell’arte”24. Al tema della scuola Levi dedica uno
spazio inferiore solamente a quello dedicato all’architettura e all’urbanisti-
ca, “che è, di tutti i problemi dell’arte moderna, quello dove lo Stato ha un
compito insostituibile”25. Chiede nuove norme per “vivificare” le scuole
artigiane, per le scuole d’arte, per le Accademie, che dovrebbero essere por-
tate a livello di università. Ma, spingendosi più oltre, decisamente contrad-
dittoria appare la proposta di costituire un ministero della cultura contem-
poranea e, nell’impossibilità di fare questo, di fare affidamento su organiz-
zazioni pubbliche, necessariamente orientate dai poteri dello Stato, quali la
Biennale, la Quadriennale e la Triennale, ancorché profondamente rifor-
mate. La novità, che dovrebbe assicurare un’azione di tali organismi “tale
da rispettare totalmente la libertà delle espressioni e da non rischiare di
opprimerle e mortificarle sotto una tutela burocratica o paternalistica”,
sarebbe dovuta consistere nell’affidarsi per la loro conduzione a persone
competenti, da ricercarsi fra gli artisti e i critici militanti invece che fra i
pubblici funzionari. Ma, di nuovo, questa abbastanza ingenua ipotesi non
ha molte possibilità di sfuggire così al mercato che ai pubblici poteri.
In astratto assai giusta, ma praticamente irrealizzabile anche essa senza
il filtro di quei poteri pubblici o mercantili ai quali Levi vorrebbe sottrar-
si, è l’idea di “istituire un archivio completo dell’arte contemporanea, che
la documenti totalmente; una biblioteca continuamente aggiornata di tut-
te le pubblicazioni sull’arte contemporanea; una filmoteca dei documenti
scientifici e critici sull’arte moderna, la produzione di film e di documen-
tari televisivi, una casa editrice che promuova e pubblichi libri, monogra-
fie, riviste e saggi; un archivio fotografico che offra a tutti gli artisti la pos-
sibilità di documentare l’intera loro produzione […]; l’organizzazione
annuale di mostre locali e regionali in tutta Italia, da servire di base e di
premessa per le mostre nazionali e da correttivo e difesa contro l’influen-
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
162
24. Ibidem, pp. 384-385.25. Ibidem, p. 387.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
1 | 2012NAZIONE
za del mercato; lo studio delle nuove tecniche; l’istituzione di borse di stu-
dio per i giovani artisti”26. Meno difficilmente attuabile, invece, è la propo-
sta di consentire agli artisti di pagare il debito d’imposta cedendo allo Sta-
to proprie opere.
Insomma, essendo animato da una volontà di progressismo democrati-
co di ideologia liberalsocialista unito ad una visione idealistica per la quale
l’“arte è libera” in quanto ha “un valore universale che si manifesta come un
interesse collettivo, fuori da ogni interesse professionale e di ogni vantaggio
economico”27 e che deve essere tenuto al riparo dai condizionamenti eser-
citabili da parte sia dei poteri pubblici che del mercato, Levi non riesce a
formulare linee d’azione intrinsecamente coerenti e praticamente attuabili
in materia di arte contemporanea.
Patrimonio storico artistico e paesaggio
Non così avviene per quanto concerne le sue posizioni in materia di
patrimonio culturale storico e di paesaggio. Ciò, forse, proprio perché rite-
neva di non poter vantare a questi riguardi “quel tanto di competenza spe-
cifica che mi può forse essere attribuita sui fatti dell’arte”28. Probabilmente
per questo motivo, infatti, la sua opinione attinge molto da altri. In tal
modo egli mostra un’ampiezza di sguardo che resta a tratti viziata da ele-
menti di un’ingenuità legata a quel suo giovanile “estetismo-misticimo” che
gli rimproverava Sapegno, ma che pure sa cogliere alcuni dei punti caratte-
rizzanti della nuova concezione di bene culturale e di paesaggio.
Del resto è proprio il suo essere scrittore politicamente impegnato che
gli consente di inquadrare il tema del patrimonio culturale nella più ampia
cornice del paesaggio e della disciplina urbanistica, così come molti allora
suggerivano di fare sia in campo giuridico che storico artistico, architetto-
nico, urbanistico e socioeconomico, a cominciare, per esempio, da Enrico
163
26. Ibidem, pp. 391-392.27. Ibidem, p. 394.28.C. Levi, Sul disegno di legge «Costituzione di una Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazio-
ne del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio», in Id., Discorsi parlamentari, cit., p. 70.
1 | 2012 NAZIONE
Spagna Musso29, Alberto Predieri30, Adriano Olivetti, Gaetano Salvemini,
Ludovico Quaroni, Federico Gorio, Manlio Rossi Doria, Tullio Tentori,
Ernesto de Martino. Infatti molte delle sue aperture si legano alle esperien-
ze compiute, a seguito della pubblicazione Cristo si è fermato ad Eboli, in
relazione a quei progetti di risanamento dei “Sassi” di Matera, con i quali si
cercava di misurarsi con una questione di cui si scorgeva il contestuale inte-
resse culturale, sociale, economico e urbanistico.
Si pensi, in particolare, a quanto i progetti materani abbiano concorso a
fargli cogliere in via pratica il principio conservativo, sul quale insisterà poimolto Giovanni Urbani, ma per nulla ovvio nella cultura del restauro deltempo, della sopravvivenza dei nuclei architettonici e di interi abitati, otte-nuta mediante la continuità d’uso, previo un efficace adeguamento funzio-nale alle nuove esigenze di vita.
È questo un tema di tale importanza, che, per ben chiarire la novità delpensiero di Levi, sembra utile mettere a confronto le sue parole con quellepronunciate circa quindici anni più tardi da Giovanni Urbani.
In occasione del convegno su Gramsci e il Mezzogiorno, oggi, tenuto aMatera nel marzo 1967, Levi fece riferimento “al problema dei Sassi diMatera, alla necessità della loro vita, della loro esistenza come fatto vitaleper salvare un patrimonio architettonico unico al mondo e che non si puòsalvare se non dandogli una ragione effettiva di esistenza, se non cioèsecondo le linee che ho cercato di esporre anche nella mia relazione al Sena-to, cioè rendendoli nuovamente abitabili, senza voler riprendere le stessestrutture, le stesse abitazioni e gli stessi vicinati di prima; trovando ivianche altre destinazioni, ma rendendoli veramente un fatto vivo e del restosu questa linea lavorano architetti e urbanisti che vengono qui a Matera siada Venezia sia da Napoli sia di altrove e lavorano anche i giovani di Mate-ra, che hanno fatto quell’importante lavoro sulle chiese rupestri e sui ten-tativi di dar vita al Sasso, e per cui dovremmo evitare di ridurre il Sasso diMatera, che vi ripeto è effettivamente una delle meraviglie dell’architettura
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
164
29. E. Spagna Musso, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, Morano, Napoli 1961.30. A. Predieri, Pianificazione e costituzione, Edizioni di Comunità, Milano 1963.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
1 | 2012NAZIONE
popolare del mondo, a un fatto morto. […] Ma, deve essere, invece, quasi,
direi a segnare la vitalità del mondo meridionale, deve ancora riprendere
una sua vita quotidiana e reale”31. Similmente tre anni prima, nel suo inter-
vento in Parlamento sul disegno di legge per costituzione della Commissio-
ne Franceschini, aveva sostenuto che il problema dei Sassi potesse essere
risolto “con un rifacimento interno, risanando totalmente questo blocco
unico di costruzioni, dotandolo dei servizi necessari, mettendo in comuni-
cazione le varie grotte dei «sassi» in modo da trasformarli in abitazioni pos-
sibili, spaziose e sane, da affidarsi ad un numero sufficiente, ma non gran-
de come prima, di abitanti, che possano occuparlo intero, diventando così
anche dei custodi di questo complesso”32. Nel 1981, al convegno nazionale
di Italia Nostra sul tema Risorse culturali e territoriali per l’avvenire del Pae-
se, Giovanni Urbani, richiamandosi al disastro causato dal terremoto del-
l’Irpinia, esprimeva il medesimo concetto, sia pure con tanto maggior
respiro, chiarendo che “la conservazione dell’ambiente e del patrimonio
culturale passa necessariamente attraverso una profonda revisione del
modello di sviluppo economico che si è dovunque accompagnato al pro-
gresso tecnologico. […] non è necessaria nessuna competenza in economia
per sapere quale sarà il saldo di una politica economica che non si è mai
degnata di far entrare nei propri conti i costi del dissesto geologico, del
disordine urbanistico e della incuria verso il patrimonio edilizio storico.
Costi […] che vanno calcolati […] tenendo anche conto del fatto che […]
sarà […] andata perduta per sempre, con la scomparsa dell’edilizia antica,
l’unica condizione per cui le popolazioni locali potevano riconoscersi in
una comunità e sentirsi legate alla propria terra. […] Cosa può rappresen-
tare, in termini economici, l’attaccamento affettivo di una comunità a un
abitato plurisecolare, e, per contro, il trasferimento forzato in un nuovo
abitato […] che in nessun caso potrà soddisfare […] l’umanissimo senti-
mento di appartenenza e immedesimazione dell’abitante alla cosa abitata?
165
31. C. Levi, Gramsci e il Mezzogiorno, 1967, in C. Levi, Il dovere dei tempi. Prose politiche e civili, Don-
zelli, Roma 2004, p. 297.32. Levi, Discorsi parlamentari, cit., pp. 85-86.
1 | 2012 NAZIONE
[…] guardando al passato, troviamo che il problema dell’uso dell’edilizia
storica come risorsa economica decisiva si è già posto una volta, e precisa-
mente quando la civiltà industriale rischiò di non sopravvivere al suo stes-so atto di nascita per l’incapacità della città antica a reggere la pressionedell’inurbamento delle masse contadine, in mancanza di sistemi adeguatidi distribuzione di acqua potabile e di fognature. Se tra Sette e Ottocentocittà come Londra o Parigi riuscirono a sopravvivere a questa situazione,non lo si dovette certo all’espansione dell’edilizia, nella massima parteancora di là da venire, , ma al semplice fatto che ai bisogni crescenti inmateria di servizi igienici, corrispose una crescita tecnica in materia disistemi di adduzione e smaltimento delle acque”33.
Le più significative dichiarazioni di Levi in materia di tutela del patri-monio storico e del paesaggio piuttosto che in relazione alla Commissio-ne Franceschini sono frequentemente rinvenibili in diversi scritti e ininterventi parlamentari connessi ad eventi come la frana di Agrigento el’alluvione di Firenze. Nell’ambito della Commissione, infatti, egli sioccupò, come detto, di arte contemporanea e durante il dibattito parla-mentare dedicato alla proposta di legge avanzata dal ministro Gui per lasua costituzione34 enunciò tesi a volte intrinsecamente contraddittorie,alcune delle quali consapevoli dei nuovi orientamenti concettuali chevenivano allora manifestandosi, altre viziate dal persistere di antichi ste-reotipi. Ad esempio, la stessa affermazione non troppo convincente, fattaad apertura del suo intervento, secondo cui la necessità di affrontare ilproblema del patrimonio culturale era avvertita “da parte dell’opinionepubblica, dell’opinione popolare”, viene per altro smentita da lui stesso,quando, subito dopo, parla dei pochi “happy few” che fino allora avevano
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
166
33. G. Urbani, Le risorse culturali, in B. Zanardi (a cura di), Intorno al restauro, Skira, Milano 2000, pp.
49-55.
34. “Voglio anzitutto affermare la grande importanza, a mio avviso, di questo disegno di legge e la
mia totale approvazione, con tutto il cuore, del disegno di legge stesso, che mi sembra estremamen-
te opportuno, estremamente necessario”. Il disegno di legge n. 723, “Costituzione di una Commis-
sione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del
paesaggio”, presentato alla Camera il 2 novembre 1963. Divenne legge il 26 aprile 1964, n. 310.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
1 | 2012NAZIONE
provato a contrapporsi alla rovina del patrimonio storico artistico. Inoltre
il suo dire, poco dopo, che il patrimonio artistico non deve essere conside-
rato semplicemente come “un ornamento a cui molti, i più, potrebbero
anche essere indifferenti di fronte a problemi più urgenti e più personali”,
perde di effettivo significato quando per converso prova a spiegare, affi-
dandosi a figure retoriche, che il patrimonio dell’arte e del paesaggio
riguarda “l’esistenza stessa di ciascuno, l’esistenza stessa di uomini che cia-
scuno deve sentire in sé; che riguarda il linguaggio comune del nostro Pae-
se; che riguarda per ciascuno la sua individuazione storica, cioè la sua pos-
sibilità di essere, e di essere per il futuro come portatore e creatore di sto-
ria; di essere cioè uomini con un passato e un futuro vivo nell’oggi, non
dei puri esseri inesistenti in un presente senza forma”35. Queste espressio-
ni, intenzionalmente analoghe a quelle, sia pure non immuni da una vena
retorica, che userà il senatore Franceschini nella prolusione agli atti della
Commissione da lui presieduta, non sembrano avere, anche sul piano civi-
le, la medesima forza e lucidità. Franceschini, infatti, dirà più propriamen-
te che, “quando appena divengano meno pressanti i bisogni, […] meno
oppressivo il potere”, affiorano istanze per le quali le “imperiose esigenze
dello spirito”36 si dilatano tanto da ricomprendere più estesamente e più
concretamente aspettative di benessere non più limitate alle necessità pri-
marie. Arte e libertà non possono progredire “se prima non divengono in
maggiore o in minore misura patrimonio di tutti, se tutti i singoli non
attingano in qualche modo la consapevolezza dei propri fini individuali e
collettivi. Sta qui il divenire delle nazioni, sta qui il destino dell’Umanità:
nell’educazione intesa come fatto sociale e plurimo - vorrei dire nella
quantificazione personale dell’essere e dei suoi valori - affinché coi singo-
li e per i singoli accrescano i popoli a dignità di non illusoria democrazia.
La povertà, l’egoismo, il dispotismo, storicamente ostacolano o rallentano
questo processo, per natura inarrestabile anche se soggetto a fortunosi cor-
si e ricorsi; ma quando appena divengano meno pressanti i bisogni, meno
167
35. Urbani, Le risorse culturali, pp. 70-71.36. F. Franceschini, Prolusione, in Per la salvezza dei beni culturali in Italia, cit., pp. XXVI, XXVII, p. XXVI.
1 | 2012 NAZIONE
insensibili i rapporti umani, meno oppressivo il potere, ecco riaffiorare
imperiose le esigenze dello spirito, e con esse riprendersi il moto ascensio-
nale e vorrei dire apostolico del fatto educativo”37.
In un tratto del suo intervento sembra poi cogliere con grande acutezza
un elemento fondamentale del tema conservativo. Infatti fa notare che “tut-
te le trasformazioni storiche, nel passaggio dialettico di civiltà diverse, si
sono sempre pagate con il sacrificio di una parte del passato, prezzo delle
nuove possibilità del presente”38. Anche gli esempi che adduce appaiono
calzanti e tali da adombrare la nozione di “bene culturale” come verrà di lì
a poco definita dalla Commissione: i piemontesi che dopo l’Unità operano
cambiamenti nell’aspetto delle città che, mentre cancellano molte forme
del passato, rappresentano però un preciso “momento storico”, esprimono
“un’effettiva vitalità di un Paese, che trovava in certe forme e con certe limi-
tazioni la sua nuova struttura e la sua nuova unità”; le “quasi totali distru-
zioni di città e di paesaggi del nostro Paese avvenute con le invasioni bar-
bariche e con la caduta dell’impero romano e nel medio evo corrisponde-
vano tuttavia […] a un passaggio drammatico di civiltà […] in nome di
altri valori, di una nuova religione, di una nuova dimensione dell’uomo”.
Perciò, quando, sviluppando l’argomento, arriva ad affermare che “oggi la
distruzione, la perversione, la corruzione dei beni che costituiscono il
nostro patrimonio storico e artistico, è forse più grave di quanto non sia
avvenuto mai, ha una natura diversa, più totale, più irrimediabile e ine-
mendabile”, ci si aspetterebbe un’analisi distaccata e lucida della civiltà del-
l’economia industriale capitalistica, come avrebbero fatto più tardi Andrea
Emiliani, Bruno Toscano, Giovanni Urbani e numerosi altri. Invece accusa
genericamente la “presenza di forze astoriche e negatrici della storia, […]
negatrici in generale di un qualunque rapporto di libertà”39. Denuncia “una
civiltà massificata e del tutto totalitaria, alienata, disumana, incapace di for-
ma e di espressione”. Ma, quando passa ad indicarne le cause, fa solo riferi-
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
168
37. Ibidem.38. Ibidem, p. 71.39. Ibidem, pp. 72-73.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
1 | 2012NAZIONE
mento al fascismo, all’“affacciarsi al potere […] di una concezione totalita-
ria dello Stato, cioè dell’idea dello Stato di massa, come informe presenza”
e risolve tutto in una questione decisamente sproporzionata e che in fin dei
conti è di arte, di stile, di gusto estetico per di più ideologicamente condi-
zionato. Indica, infatti, come “massimo responsabile” l’architetto Piacenti-
ni, la cui architettura “è stata veramente l’inizio della nuova forma di
distruzione, di disgregazione, di corruzione dei beni e dei valori dell’arte
del nostro Paese”40. Anche la spiegazione che poi aggiunge conferma che si
tratta di una critica tutta interna ad una “polemica per l’arte moderna” in
nome della “lotta progressiva per la libertà”, della “nuova architettura della
libertà” a suo avviso impersonata da Giuseppe Pagano Pogatschnig41 e da
Gian Luigi Banfi42, ad onore di entrambi i quali ritiene di dover soltanto
ricordare la morte nei campi di concentramento nazisti.
In modo analogo, quando denuncia il “decadimento” e la “distruzione
del patrimonio artistico italiano” registrabili negli ultimi venti anni, defini-
sce il suo obiettivo polemico in termini non più che poetici: “la coesistenza
di una spinta di ideologie, di sentimenti, di terrori di massa, di un mondo
totalitario privo di autonomia e quindi di possibilità di forma, con la pre-
senza di gruppi di potere mossi soltanto dal puro interesse economico,
espressioni puramente economiche, in senso mercantile, di una civiltà di
cosificazione dell’uomo”43.
Per contro, però, è capace di avvertire che per la sopravvivenza del patri-
monio non bastano gli interventi “di carattere difensivo, di carattere premi-
nentemente conservatore delle cose come sono, limitato alla pura difesa e
alla tutela di quello che esiste, considerato come un documento di archivio,
come una polvere sacra”. Non basta “un intervento puramente tecnico a cui
è necessario trovare in qualche modo dei mezzi adeguati, ma che non esce
dai limiti di un lavoro specifico di esperti e di funzionari specializzati”. Per
169
40. Ibidem, p. 73.41. Fece parte del Movimento Italiano per l’Architettura Razionale.42. Fece parte dello studio di architettura e design BBPR, composto anche da Barbiano di Belgioioso,
Peressutti, Nathan Rogers.43. Franceschini, Prolusione, in Per la salvezza dei beni culturali in Italia, cit., p. 75.
1 | 2012 NAZIONE
quanto certamente utile, un simile lavoro di ordinaria amministrazione è
“destinato a fallire, per l’immensità delle forze contrarie, o a risolversi in
una continuazione dello stato attuale di difesa parziale e marginale”44. Per
eliminare il problema alla radice, occorre capire che “la distruzione della
faccia del nostro Paese non può essere considerata solo sintomatologica-
mente, difendendo questo o quel punto”45, affidandosi a “un intervento di
carattere estetico e formalistico”46. Ciò che gli appare necessario è “una pia-
nificazione integrale e democratica”47, è una legge urbanistica, è la riforma
agraria, “che ci darà sì, un diverso e nuovo paesaggio (che non sarà quello
ereditato, ma la storia è fatta appunto di questi mutamenti di ordine posi-
tivo); che ci darà un nuovo paesaggio, ma non ci darà la terra vuota di
uomini, destinata ad una natura senza forma”48. L’obiettivo della salvaguar-
dia della “faccia del nostro Paese” non è di specie settoriale, ma si connette
con tutti gli aspetti della vita nazionale, comporta una politica generale che
rinnovi il modello economico, il sistema finanziario, fiscale, giuridico, sco-
lastico, agricolo, urbanistico, amministrativo. Perciò chiede che la Commis-
sione Franceschini si avvalga non soltanto di esperti d’arte e di architetti,
ma di urbanisti, economisti, giuristi.
Proprio a partire da questo approccio eminentemente politico, Levi
può dunque approdare ad una concezione di paesaggio di ampiezza antro-
pologica e socioeconomica che riflette l’impostazione di Emilio Sereni, di
cui tre anni prima era stata pubblicata la Storia del paesaggio agrario ita-
liano49, e del quale egli fa infatti espressa menzione, nonché di Ernesto de
Martino, che si distaccò dallo storicismo crociano anche in virtù del rap-
porto stabilito con Levi, dopo la pubblicazione del Cristo si è fermato ad
Eboli, e con altre personalità della sua cerchia, come il poeta contadino
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
170
44. Ibidem, p. 78.45. Ibidem, p. 78.46. Ibidem, p. 82.47. Ibidem, p. 79. Dirà in altra occasione: “dovremmo veramente giungere a quello che alcuni urbani-
stici chiamano un governo del territorio”; ibidem, p. 155.48. Ibidem, p. 83.49. E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Bari 1961.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
1 | 2012NAZIONE
Rocco Scotellaro. Per questa via, infatti si allontana decisamente dalla
visione crociana del “senso estetico più raffinato”, gratificato dallo “spetta-
colo di acque precipitanti nell’abisso, di cime nevose, di foreste secolari, di
riviere sonanti, di orizzonti infiniti”, e giunge ad affermare che “il paesag-
gio italiano, che noi vogliamo difendere, non è un luogo estetico che stia
fuori dalla storia. Il paesaggio italiano non è altro che la storia vivente del
popolo italiano. Non esiste un paesaggio di natura selvatica, senza nome,
senza storia; il paesaggio non è che l’uomo, la campagna non è che il con-
tadino, le infinite generazioni di contadini che l’hanno lavorata e costrui-
ta come un’opera d’arte”50.
Questo passo, al quale coerentemente si aggiunge la significativa
preoccupazione per il “fenomeno dell’abbandono delle terre”51, segna
una visione del problema che troverà poi continue conferme. Anni dopo,
ad esempio, Andrea Emiliani parlerà, con parole analoghe, delle zone
montane che manifestano “disgraziatamente tutti i fenomeni di degrada-
zione sociale, economica ed ambientale di maggior incidenza negativa:
migrazioni interne, spopolamento delle campagne, abbandono delle col-
ture e degli insediamenti, abbandono degli edifici chiesastici, degrado
del suolo”52. Con lui e con numerosi altri lo stesso farà Bruno Toscano, il
quale ancora in tempi recenti insiste a descrivere lo stato di rovina del
patrimonio culturale dell’Appenino umbro, dicendo de “la decadenza in
termini sociali ed economici, l’aumento degli squilibri, l’abbandono
degli insediamenti in territori che almeno fino al XVIII secolo costitui-
vano un fitto tessuto culturale […], il processo di rapida trasformazione
degli assetti culturali dei territori, che perdono punti e centri di interes-
se e tendono a concentrarsi in poli di maggiore resistenza circondati da
sempre più vaste zone di abbandono […] riducendo a moderno
«latifondo» quello che era un fitto tessuto di insediamenti comunali -
terre murate, ville, edifici sparsi - e religiosi, storicamente alimentato da
171
50. Franceschini, Prolusione, in Per la salvezza dei beni culturali in Italia, cit., pp. 82-83.51. Ibidem, p. 83.52. A. Emiliani, Dal museo al territorio, Bologna 1974, p. 196.
1 | 2012 NAZIONE
un’economia agro-silvo-pastorale alternata ad artigianato e a prestazio-
ne di servizi come fattori stagionali di riequilibrio, nei quali risaltava una
singolare creatività”53.
Si dirà che anche per Croce il paesaggio è specchio della storia civile. Ma
lo è in un senso decisamente diverso. Per lui si tratta di storia “civile e let-
teraria”54. È storia civile in quanto storia patriottica, per cui il paesaggio è“la rappresentazione materiale e visibile della patria”. A sua volta il patriot-tismo “nasce dalla secolare carezza del suolo agli occhi”, dalle “bellezze del-la natura, che danno all’uomo entusiasmi spirituali così puri e sono inrealtà ispiratrici di opere eccelse”. La necessità di tutelare la bellezza dellanatura è per corrispondere ai “bisogni del senso estetico più raffinato”, checonsiste in quel “sentimento, tutto moderno, che si impadronisce di noiallo spettacolo di acque precipitanti nell’abisso, di cime nevose, di forestesecolari, di riviere sonanti, di orizzonti infiniti”: sentimento che “deriva
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
172
53. “Oggi dobbiamo purtroppo riconoscere che quei processi da noi temuti ma previsti hannocompiuto inesorabilmente il loro corso. Quella entusiasmante onnipresenza di dipinti, che pun-teggiano il territorio senza escludere il più esiguo insediamento e di cui le ricerche sul primo(1976) e sul secondo quadrante (1980) umbro sono riusciti almeno a dare testimonianza, nonesiste più. La carta della geografia artistica dell’Umbria appenninica, fino a venticinque anni fa,era gremita di segni, cioè di vive impronte di cultura, che oggi dobbiamo uno dopo l’altro can-cellare dando sempre più spazio a zone di assenza o di scomparsa. […] Sono […] sintomi di unatendenza a interpretare i compiti di tutela che presenta molti altri aspetti inquietanti. […] Rat-trista dover constatare che gli organi ufficiali della tutela sembrano scoprire quel tessuto connet-tivo fatto di tanti piccoli punti - che quando viene a mancare rende meno comprensibili e, perdir così, meno umani anche i monumenti maggiori - solo dopo eventi catastrofici: come è avve-nuto anche dopo il sisma del 1997 con i lunghi, mesti elenchi ministeriali di edifici terremotati,in genere assenti da decenni da qualsiasi programma di manutenzione e di consolidamento. Maanche quando a quegli elenchi corrispondessero altrettanti interventi di consolidamento erestauro il risultato complessivo aprirebbe una nuova fase di precarietà e di rischio per edificistorici rimessi, sì, in sesto ma destinati a subire le conseguenze del sempre più rapido e inarre-stabile indebolimento dei relativi contesti territoriali. (…) il salto di qualità da sparsi interventidi emergenza ad un vero sistema di conservazione”, B. Toscano, Il territorio come campo di ricer-
ca storico-artistica, oggi, in Pittura del’600 e del’700. Ricerche in Umbria. 3. La Teverina umbra e
laziale, Canova, Treviso 2000, pp. 23-29.54. Così Croce, allora nella sua qualità di ministro, la definisce nella presentazione del disegno di leg-ge n. 204, Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, sfociatonella legge 11 giugno 1922, n. 778.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
1 | 2012NAZIONE
della stessa sorgente, da cui fluisce la gioia che ci pervade alla contempla-
zione di un quadro dagli armonici colori, all’audizione di una melodia ispi-
rata, alla lettura di un libro fiorito d’immagini e di pensieri”55.
La ben diversa concezione di paesaggio esposta da Levi in occasione del
dibattito sulla legge istitutiva della Commissione Franceschini non è un fat-
to isolato. Essa tornerà, sempre arricchendosi, negli anni successivi.
Nel dibattito parlamentare del 26 ottobre 1966, dedicato alla frana di
Agrigento, egli prenderà la parola ricordando di essere anche stato membro
della Commissione Franceschini, che si era misurata con problemi che, per
le loro infinite implicazioni, toccano “tutto il tessuto politico e sociale del
nostro Paese”, poiché “si tratta della forma stessa della nostra vita, del pae-
saggio della nostra esistenza, che è l’esistenza stessa in tutti i suoi aspetti,
nella sua realtà, che è la sua storia”56. Insisterà perciò a dire che la tutela del
paesaggio così concepito non è “una questione di gusto (questo rovinoso
concetto venturiano)”, non implica “puri problemi estetici, né puri proble-
mi giuridici, economici e sociali, ma tutti insieme, in una unità che sta pri-
ma delle determinazioni fino a un punto profondissimo che è la radice del
nostro essere come popolo e come Nazione civile”57.
Ancora una volta la soluzione che Levi prospetta attiene al rovesciamen-
to di alcuni elementi cardine del sistema politico liberale. Chiede nuova-
mente, infatti, che si adotti una nuova legge urbanistica che abbatta il
“mito”, l’idea “ormai antistorica, che viene però praticamente accettata da
tutti: il mito della proprietà privata del suolo, dell’iniziativa privata”58.
Chiede che sia resa obbligatoria l’adozione di piani regolatori e chiarisce, in
linea con quanto resterà al centro del dibattito nei decenni successivi e fino
alla recente stipula della Convenzione Europea del Paesaggio avvenuta nel
2000, che il concetto di piano non va mitizzato, che un piano può essere
173
55. In proposito, si veda M. Montella, Valore culturale, in G.M. Golinelli (a cura di), Patrimonio cultu-
rale e creazione di valore, CEDAM, Padova 2012, pp. 3-70.56. Ibidem, p. 139.57. Ibidem.58. Ibidem, p. 149.
1 | 2012 NAZIONE
anche sbagliato e che è perciò essenziale il metodo con il quale viene
costruito. L’errore da evitare è l’imposizione dall’alto. Come la libertà
gobettiana, concetto a lui carissimo, doveva sorgere a partire dal basso, così
“il piano non può essere imposto dall’alto, non può essere puramente tec-
nologico. La pianificazione deve essere insieme dal basso e dall’alto, in
modo da rendere responsabile e vivo tutto il corpo sociale, che deve parte-
cipare alla sua elaborazione. Non deve permettere degli interventi esterni,
paternalistici, di rottura brutale di un tessuto storico, come quelli che pur-
troppo hanno fatto gli enti di riforma, con risultati, forse non involontari,
di sfacelo totale del Mezzogiorno”59.
Proposte di riforme giuridiche e amministrative
Per riferire senza eccessive lacune il pensiero di Carlo Levi, sarà infine
doveroso ricordare, in rapida sintesi, quelle sue proposte di riforme legisla-
tive e amministrative ancora oggi di attualità, molte delle quali pienamen-
te consonanti con quelle ufficialmente avanzate, però senza successo, dalla
Commissione Franceschini.
Procedendo per rapidi cenni, da non trascurare sembra la sua opposi-
zione, nel 1967, alla richiesta comunitaria di abolire la tassa di esportazio-
ne delle opere d’arte, che motivò affermando che “la tesi che si tratta di una
merce come tutte le altre è una tesi insostenibile” e che, se “la questione giu-
ridica è stata già risolta, e in senso sfavorevole alla nostra tesi, la nostra
risposta dovrebbe essere una sola: cioè una legge che impedisca l’esporta-
zione di ogni opera d’arte […]: il blocco totale delle esportazioni. Perché
come conseguenza diretta della liberalizzazione si avrebbe immediatamen-
te la fuga verso la Francia, per esempio, delle nostre opere d’arte che pren-
derebbero successivamente la via dell’America o di altri Paesi per i quali,
dalla Francia, non esistono barriere”60.
Altrettanto forte dissenso manifestò, nel 1964, nel corso del dibattito
sulle iniziative per la celebrazione del VII centenario della nascita di Dante,
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
174
59. Ibidem, pp. 155-156.60. Ibidem, p. 191.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
1 | 2012NAZIONE
nei confronti dell’“antico vezzo celebrativo”, che “ci induce a stanziamenti
notevoli, i quali andrebbero invece, secondo me, diversamente e più util-
mente usati”. Per fare qualche cosa di utile, a suo avviso, invece delle solite
grandi mostre, sarebbe stato bene fare una grande riedizione nazionale di
quest’opera in modo criticamente rigoroso: studiato, cioè, perfettamente,
ma senza alcun peso di pura erudizione. “Questa edizione popolare, infat-
ti, appunto perché popolare, dovrà essere rigorosamente elaborata dal pun-
to di vista scientifico. Le note dovranno essere semplici, ridotte all’essenzia-
le senza nessun appesantimento. In questo modo, in tutte le famiglie italia-
ne entrerà il testo della Divina Commedia. […] Questo fatto sarebbe di
un’utilità estrema, perché riproporrebbe a tutti un punto comune che si
pone all’origine dello sviluppo culturale del nostro Paese e che si perpetua
nei secoli con il rinnovarsi delle generazioni”61.
In ordine a specifiche misure a sostegno dell’amministrazione del patri-
monio culturale, degne di interesse risultano la sollecitazione ad imitare il
sistema fiscale americano di detassazione per le spese destinate al patrimo-
nio, a concedere la possibilità di pagare le tasse di successione con la cessio-
ne allo Stato di opere d’arte, a riformare il Consiglio Superiore di Antichità
e Belle Arti anche includendovi i rappresentanti degli enti locali, a stabilire
un “collegamento organico fra Soprintendenze e Regioni”, ad ampliare gli
organici, ad adottare “nuove norme contabili ed amministrative in armo-
nia con le effettive necessità e i compiti specifici degli uffici di tutela e di
ricerca”62, a stanziare fondi adeguati.
La novità però, che più di tutte avrebbe a suo parere concorso ad “una
politica generale di totale rinnovamento, di innovazione di principi giuri-
dici, di riforme delle strutture dello Stato, di mutamento delle sue scelte di
politica generale ed economica, di coerente azione in tutti i settori collega-
ti della vita politica e sociale”63 sarebbe stata un’amministrazione delle bel-
le arti autonoma rispetto all’amministrazione centrale dello Stato o la
175
61. Ibidem, p. 65.62. Ibidem, pp. 69-70.63. Ibidem, p. 86.
1 | 2012 NAZIONE
costituzione non solo di un distinto ministero della cultura sganciato da
quello della Pubblica Istruzione, come poi fece effettivamente Giovanni
Spadolini, ma, come aveva “ripetuto diecimila volte” in seno alla Commis-
sione Franceschini, interparlamentare d’inchiesta sulle belle arti e le bellez-
ze naturali di “un ministero, diciamo, del territorio”64.
Su molti di questi temi il dibattito, anche se via via decrescente, è anco-
ra in corso.
STORIA DELLE MARCHE IN ETÀ CONTEMPORANEA
176
64. Ibidem, p. 155.