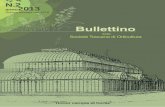Strade, campi e sepolture nelle terre di Marino tra I e II sec. d.C.
Le sepolture nell’area delle Terme di Traiano, Bullettino della Commissione Archeologica Comunale...
Transcript of Le sepolture nell’area delle Terme di Traiano, Bullettino della Commissione Archeologica Comunale...
COPYRIGHT © 2011 by «L’ERMA» di BRETSCHnEIDER - ROMAVia Cassiodoro, 19
Curatore redazionale Daniele F. Maras con Iosetta Corda
Periodico: Autorizzazione Tribunale di Roma n. 523 del 24-10-1988
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma. - n.S. 1(1987/88)- . - Roma : «L’ERMA» di BRETSCHnEIDER, 1989- . - v. ; 29 cm.- Annuale
ISSn 0392-7636
CDD 20. 930.1’05
un volto divino? una nuova proposta di lettura per l’“antefissa” dall’Arce Capitolina di Anna Mura Sommella 7
Gli esemplari di “aes signatum” e aes grave della collezione del Medagliere Capitolino di Maria Cristina Molinari 15
Ostia antica: due nuovi casi di studio nella regio iii 55 di Francesca Regina
The Theater of Pompey in 2009: A new Excavation di James E. Packer, Maria C. Gagliardo, John N. Hopkins 71
Il comprensorio di S. Croce in Gerusalemme: novità topografiche e archeologiche di Mariarosaria Barbera 97
nuovi dati sulle volte in calcestruzzo della Basilica ulpia e del Foro di Traiano di Elisabetta Bianchi, Roberto Meneghini 111
un secondo nucleo di dirham della Collezione Stanzani nei Musei Capitolini di Arianna D’Ottone 141
La ceramica dei contesti bassomedievali e rinascimentali di via del Foro Romano di Paolo Güll et alii 157
SCAVI nELLE TERME DI TRAIAnO SuL COLLE OPPIO (Atti della giornata di studi, Roma, Istituto Archeologico Germanico, 20 ottobre 2005)
Introduzione di Rita Volpe 227
Colle Oppio: scavi e prospettive di Giovanni Caruso 229
Scavi della Soprintendenza Archeologica di Roma nell’angolo sud-orientale delle Terme di Traiano
di Ida Sciortino, Elisabetta Segala 243
Scavi nell’angolo sud-occidentale delle Terme di Traiano di Giovanni Caruso et alii 257
Edifici precedenti le Terme di Traiano di Rita Volpe 283
L’affresco della ‘Città Dipinta’ il restauro conservativo 2004-2005 di Sabina Marchi, Maria Rotondi 301
I materiali del contesto traianeo (saggio m) dallo scavo nell’angolo sud-occidentale di Tommaso Bertoldi 307
Sommario
6 Sommario
Il rivestimento pavimentale dell’esedra sud-occidentale delle Terme di Traiano di Matthias Bruno 311
I laterizi bollati dallo scavo nell’angolo sud-occidentale di Elisabetta Bianchi 321
Le sepolture nell’area delle Terme di Traiano di Francesca Carboni 327
Le sepolture dello scavo nell’angolo sud-occidentale delle Terme di Traiano. Relazione antropologica
di Carla Caldarini, Paola Catalano, Walter Pantano 335
L’immagine delle Terme di Traiano nel Codice Destailleur e in altre vedute d’epoca di Maximilian Schich 339
Visitatori e cercatori rinascimentali sul Colle Oppio di Carla Termini 353
I materiali dei contesti postantichi dallo scavo nell’angolo sud-occidentale di Simona Pannuzi 363
La Polveriera o Salnitrara Camerale di Monica Pontani 367
Bibliografia 375
Tavole 383
Scavi nelle Terme di Traiano sul Colle Oppio
a cura di
Rita VolpeSovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale
Atti della giornata di studi (Roma, Istituto Archeologico Germanico, 20 ottobre 2005)
1 In questo articolo sono state messe a confronto, in particola-re, le zone a valenza funeraria individuate nel corso delle indagini eseguite dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma, nell’area delle esedre nord-orientale e sud-occidentale, alle quali ho partecipato in qualità di collaboratore archeologo. Le ri-flessioni che qui si presentano sono parte dello studio delle trasfor-mazioni topografiche che hanno interessato il Colle Oppio nel Me-dioevo, argomento del dottorato di ricerca che ho svolto, sotto la direzione di Philippe Pergola, presso l’Université d’Aix-Marseille.
Limitando l’analisi dell’uso sepolcrale del complesso alle fasi di frequentazione immediatamente successive alla fine del funziona-mento delle terme in quanto tali, non si fa di seguito riferimento alle sepolture scoperte all’interno della cisterna delle Sette Sale, in occasione delle ricerche ivi effettuate negli anni 1966-67, datate a epoca ben più recente (cfr. Cozza 1976).
2 L’interpretazione dell’esedra come ninfeo è sostenuta dal-la presenza di nicchie che si aprono lungo la sua parete interna,
alla base di ognuna delle quali si trova un’apertura quadrango-lare. Auspicando la futura possibile ispezione del sistema idrau-lico sottostante, comunicante con il collettore di alimentazione in uscita dalla cisterna delle Sette Sale, che consentirà, forse, di comprendere l’effettiva funzione di questa parte del complesso, si sottolinea, allo stato attuale delle indagini, la mancata presenza di una vasca per la raccolta delle acque, a ridosso della parete interna dell’emiciclo.
3 Per i dati relativi a questo scavo e la descrizione più puntuale della necropoli, si rimanda a Carboni 2003 e Ead. 2007.
4 Lo stato sconvolto delle coperture ha permesso di ipotizzare per una sola delle tombe un rivestimento a cappuccina, mentre le altre dovevano essere sigillate con frammenti laterizi e lapidei di-sposti orizzontalmente.
5 Una sola tomba mostrava una chiara declinazione verso Sud-Ovest, forse a indicare di essere stata realizzata in un tempo diver-so, rispetto a quelle ad essa vicine.
La fortunata circostanza di aver individuato nell’area dello stesso complesso architettonico tre distinti nuclei sepolcrali1, caratterizzati da di-verse tipologie funerarie e collocati in tempi fra loro successivi, ha consentito una lettura “per fasi” del fenomeno delle sepolture in urbe, lad-dove, senza il caposaldo topografico del recinto delle Terme di Traiano cui riferirsi, si sarebbe, per l’ennesima volta, rimasti sorpresi dalla varie-tà dei casi documentati, quanto a localizzazione delle tombe, modalità di concentrazione e diver-sità dei rituali funebri adottati.
Zona antistante l’esedra nord-orientale
L’utilizzo funerario della zona interna al re-cinto delle Terme di Traiano è stato attesta-to nell’area prospiciente l’esedra nord-orien-
tale, tradizionalmente considerata un ninfeo2, dove la Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma ha svolto delle indagini ne-gli anni 1997-19983 (fig. 1, area a). Qui è sta-to messo in luce un nucleo sepolcrale ben leg-gibile, sebbene coperto da una stratificazione formatasi in seguito allo sconvolgimento del-le coperture e profondamente danneggiato da un’intensa attività di spoliazione rinascimenta-le (fig. 2).
Sulla base dei resti superstiti, le sepolture, sca-vate in numero di 13, sono tutte fosse terragne4, caratterizzate da un comune orientamento Nord-Ovest/Sud-Est, parallelo alla fronte dell’esedra5 e dall’univoca direzione di giacitura degli inu-mati, tutti deposti con il capo ad Ovest.
Vi sono diversi indizi relativi ad un utilizzo in-tensivo del sepolcreto, non eccessivamente limi-tato nel tempo, e che connotano il carattere fa-
Le sepolture nell’area delle Terme di Traiano
328 Francesca Carboni
6 Una tomba a cappuccina contenente due diverse deposizioni, entrambe relative a bambini, una delle quali già rimaneggiata in antico, risulta aver tagliato una sepoltura precedente. Di questa era stata conservata solo un’estremità, sul fondo della quale si trova-va un mucchietto di ossa, sistemate in seconda giacitura. Un’altra tomba presenta, invece, una fossa di larghezza doppia, rispetto alla sepoltura ivi messa in luce, a ridosso di uno dei suoi margini, come se essa fosse stata apprestata per poter contenere due deposizioni affiancate, una delle quali mai collocata.
7 Per l’identificazione e la catalogazione delle monete cfr. il testo di E. Spagnoli in Carboni 2003; esse sono state rinvenute fra la ter-ra che costituiva il riempimento delle fosse, in posizione più volte connessa con il cranio dell’inumato. Per questo parrebbero inter-
pretarsi, più che come elementi di corredo, come offerta rituale, epigono dell’ “obolo viatico”. Per la problematica del rinvenimen-to di monete nell’ambito di necropoli altomedievali cfr. Giuntella 1998, p. 83, con bibliografia precedente.
8 La ricorrente presenza di chiodi nelle tombe può essere attribu-ita ad una cassa lignea ma sembra, nella maggior parte, aver avuto funzione apotropaica. Cfr. Cantilena 2010. I metalli, in tal senso le monete, ma anche i chiodi, avrebbero prerogative magiche.
9 Due soli oggetti rinvenuti, un orecchino in argento e l’estremi-tà di una spatolina bronzea, sono interpretabili come elementi di ornamento personale, ed erano verosimilmente associati a depo-sizioni femminili. Per la distinzione fra corredo rituale e corredo personale cfr. Gastaldo 1998, p. 25.
In base al dato numismatico, la collocazio-ne cronologica della necropoli è condizionata, come termini post quem, dalla monete di Mar-ciano (450-457 d.C.) e di Valentiniano iii (430-437 d.C.), trovate in due tombe. Gli scarsi dati desumibili dal materiale ceramico rinvenuto nel-la terra di riempimento delle fosse, si riferiscono
miliare di alcune delle tombe scavate6, nonché il riconoscimento di una ritualità comune applica-ta nelle varie sepolture, quest’ultima sostenuta dal rinvenimento di numerali bronzei in quasi la metà delle tombe individuate7, dalla scoperta di chiodi deposti all’interno di esse8 e dalla presen-za di sporadici elementi di corredo personale9.
1. Localizzazione delle tombe rinvenute nell’area delle Terme di Traiano.
Le sepolture nell’area delle Terme di Traiano 329
10 Per l’analisi antropologica dei resti scheletrici rinvenuti nelle due tombe cfr. qui il testo di C. Calderini, P. Catalano e W. Pantano.
11 Sulla base della copiosa documentazione epigrafica a disposi-zione, si è a conoscenza di disposizioni tendenti a limitare l’uso del-le tombe. In molte di esse si evince il desiderio di essere riuniti con
la propria famiglia nella morte. Questo si lasciava scritto nel testa-mento. Le fonti giuridiche asseriscono che il titolare del ius sepulcri è libero di far entrare nella sepoltura chi vuole ed è lui che deve sta-bilire il tipo di successione per la tomba, se familiare o ereditaria. Cfr. de Visscher 1993, pp. 93-123 e Lazzarini 1997, pp. 83-97.
(fig. 1, area b, tombe 1 e 2), entrambe ricavate entro gli interri tardo antichi, databili nell’ambi-to del vi secolo, che ricoprivano l’estradosso del-la volta della galleria, già spoliato dell’originario rivestimento pavimentale.
La prima di esse (fig. 3), del tipo a fossa con pareti rinforzate da tegole disposte di taglio, era addossata al setto in opera laterizia che chiude la fronte dell’esedra, verso Nord. Questa si pre-sentava tagliata da un cunicolo di spoliazione e conservata solo limitatamente alla sua porzione settentrionale. La copertura, pure sconvolta, era realizzata con frammenti di lastre marmoree.
All’interno della tomba sono stati rinvenuti re-sti scheletrici10 non in connessione, attribuibili ad almeno 8 bambini, di età compresa fra gli 1 e gli 8 anni. Gli esami finora effettuati non hanno permesso di appurare se esistessero, fra gli inu-mati, vincoli di parentela, che sembrano tuttavia suggeriti dalla riunione intenzionale dei piccoli individui in un solo sepolcro11. Le ossa appaio-no, infatti, collocate in modo volontario, così da
a frammenti di ciotole in sigillata africana, tipo Hayes 84.
In considerazione di questi elementi e del dato stratigrafico secondo il quale l’impianto del se-polcreto sarebbe pressoché contemporaneo (o im-mediatamente successivo) alla messa fuori uso del collettore di alimentazione delle terme provenien-te dalla vicina cisterna delle Sette Sale, esso sem-bra potersi datare in un periodo di poco anteriore alla fine del v secolo, mentre appare non più utiliz-zato già entro la prima metà del secolo seguente.
L’area funeraria in sé indica una modifica nella destinazione d’uso e probabilmente della condi-zione giuridica di almeno questa parte del com-plesso, per la quale diviene lecito dubitare circa il persistere del carattere pubblico.
Zona dell’esedra sud-occidentale
Nel corso dello scavo nell’area dell’esedra sud-occidentale sono state individuate due sepolture
2. Terme di Traiano, esedra nord-orientale. Pianta delle sepolture individuate (a).
330 Francesca Carboni
12 La sepoltura individuata rientrerebbe nell’ambito delle true secondary burials, se interpretata come il risultato di una re-inuma-zione di ossa che, trasferite da altro contesto funerario, sono state ricomposte in una nuova tomba. Cfr. Duday 2009.
13 La fi bbia, rinvenuta priva dell’ardiglione, è una variante del tipo Siracusa, ampiamente diff uso in tutto il Mediterraneo, pre-sente in molti corredi longobardi italiani e attestato fra i materiali prodotti dall’offi cina romana che doveva far capo al monastero di S. Lorenzo in Pallacinis, rinvenuti nel deposito di vii secolo dell’e-sedra della Crypta Balbi. Cfr. Ricci 1997, fi g. 2, 8 e Arena et al. 2001, pp. 375-376, in particolare n. ii.4.608.
14 Recipienti simili, comuni nell’uso domestico, costituiscono il cor-redo tipico di tombe attestate a Roma nel periodo in esame, general-mente associati a sepolture infantili e localizzati in prossimità del capo degli inumati. Il bicchiere in questione trova un confronto puntuale con un esemplare proveniente dal Foro di Nerva (Arena et al. 2001, p. 572, n. v.3.7) e con quello associato alla cappuccina addossata alla parete esterna dell’esedra nord-orientale delle Terme di Traiano (cfr. Carboni 2003, p. 79, fi g. 18 e Carboni 2007, p. 415, fi g. 5 v. infra). Il riconoscimento della presenza peculiare di analoghi contenitori vitrei o fi ttili in sepolture intramuranee di età tardontica è stato per primo analizzato in Meneghini–Santangeli Valenzani 1994, pp. 321-337.
La seconda tomba (fi g. 6) era, invece, una se-poltura singola, a fossa, foderata da una sorta di cassone, realizzato con laterizi, scapoli lapidei e lacerti pavimentali in cocciopesto e mosaico, ac-costati senza alcun legante. Orientata in direzione Nord/Sud, essa si presentava priva di copertura e conteneva lo scheletro di un individuo di sesso
ridurre in un’unica sepoltura più antiche deposi-zioni, probabilmente distinte in origine12.
Assieme all’ossame disarticolato deposto in se-conda giacitura, sono stati messi in luce una pic-cola fi bbia bronzea13, del tipo a placca fi ssa (fi g. 4), e un’olletta globulare monoansata in cerami-ca comune14 (fi g. 5).
3. Tomba messa in luce a ridosso della fronte dell’esedra sud-oc-cidentale (t. 1, b).
4. Fibbia rinvenuta nella tomba 1, b.
5. Olletta monoansata rinvenuta nella tomba 1, b. 6. Pianta della sepoltura individuata nell’area del portico antistante l’esedra sud-occidentale (t. 2, b).
Le sepolture nell’area delle Terme di Traiano 331
15 Buchi di palo interpretati come sedi di segnacoli lignei sono stati individuati in corrispondenza di alcune tombe terragne di età longobarda rinvenute in territorio veronese, cfr. De Marchi–Ma-riotti–Miazzo 2004, pp. 114-119, mentre nell’ambito della necro-poli tardo antica di Mirabella Eclano (AV) è stata messa in luce una sepoltura singola agli angoli della quale quattro buche di palo defi-nivano uno spazio quadrangolare forse provvisto di una recinzione deperibile, cfr. Lo Pilato 2005, p. 152, fig. 5.
16 Nel corso delle indagini condotte dalla Soprintendenza Ar-cheologica di Roma a partire dall’ultimo trentennio del secolo scorso, sono state in quest’area messe in luce delle sepolture isolate datate genericamente al vi secolo. In attesa di un’edizione puntua-le dei dati che riguardano, in particolare, quelle più recentemente
rinvenute, delle quali si fa menzione nel contributo di I. Sciortino ed E. Segala in questa sede, le notizie finora disponibili testimo-niano, comunque, un uso sepolcrale anche della zona Sud-Est del complesso termale, in un’epoca pressoché contemporanea a quella documentata nell’area dell’opposto emiciclo.
17 Cfr. supra, nota 12.18 Cfr. Nencini 2002. Il corredo associato ai resti ossei è costi-
tuito da un ago crinale, che suggerirebbe il sesso femminile dell’i-numato, e da una piccola olla. Entrambi i manufatti non sono ul-teriormente descritti.
19 Per la zona dell’Oppio si ricorda la necropoli di vi secolo messa in luce all’interno della Porticus Liviae, per la quale si veda Mar-celli 1989 e Panella 2001a.
Sembra significativo, inoltre, il rinvenimen-to avvenuto, in corrispondenza di via Mecenate, nel 2002, in occasione di uno scavo preventivo, di una tomba alla cappuccina abbastanza ben con-servata, disposta secondo lo stesso orientamento delle precedenti, relativa alla deposizione di una bambina, anch’ella sepolta con oggetti di corre-do18. Quest’ultima testimonianza potrebbe, infat-ti, far ipotizzare una notevole estensione dell’area esterna al vertice nord-orientale delle Terme di Traiano allora utilizzata a scopo sepolcrale (fig. 7), caratterizzata da tombe accomunate da un univoco orientamento, da una medesima tipolo-gia e dall’applicazione dello stesso rituale fune-rario.
Conclusioni
Sulla base delle testimonianze finora presentate, si possono avanzare delle considerazioni riguardo al carattere e all’evoluzione dell’utilizzo funerario di alcune zone comprese nel recinto delle Ter-me di Traiano e ad esso immediatamente pros-sime, riconoscendo in quello qui individuato un aspetto del fenomeno, documentato a partire dal v secolo, che vide il diffondersi di sepolture in modo capillare all’interno delle mura urbane, di preferenza entro organismi architettonici pubbli-ci provvisti di ben definiti limiti spaziali19, fra i
maschile, di età compresa fra i 40 e i 45 anni, de-posto in decubito dorsale, con il capo verso Sud, gli arti inferiori distesi, quelli superiori disposti con le mani incrociate sopra il pube.
Due buche circolari, entrambe del diametro di cm 30 circa, sono state rinvenute, in posizione simmetrica, ai due lati del margine meridionale della fossa, in prossimità del cranio dell’inumato. Data la localizzazione e il limite, abbastanza ben definito, di questi incavi, si può ipotizzare che essi ospitassero degli elementi verticali, aventi, forse, funzione di segnacolo15 o, qualora essi fos-sero gli unici supersiti, costituenti una sorta di recinzione, allestita attorno alla fossa.
Zona esterna all’esedra nord-orientale
Le tombe finora descritte confermano l’uso fu-nerario della zona interna, a ridosso del recinto delle Terme di Traiano, in seguito alla defunzio-nalizzazione dell’edificio pubblico.
Tale utilizzo, da ultimo documentato pure nel settore sud-orientale del complesso (fig. 1, area c1)16, è stato accertato anche per l’area subito a ridosso della parete esterna dell’emiciclo nord-orientale (fig. 1, area d), interessata, negli anni 1997-1998, dalla stessa indagine condotta nel-la striscia di terra prospiciente la sua fronte (v. supra). Qui sono state messe in luce due tombe, non sconvolte in antico, databili al vi-vii secolo (fig. 7). Si tratta di una cappuccina e di un’emi-cappuccina ad essa addossata, ospitanti un bam-bino e un adulto, entrambi deposti con oggetti di corredo. All’altezza della clavicola destra dell’in-dividuo adulto è stato rinvenuto un vago di col-lana in pasta vitrea e, nei pressi, una moneta bronzea, mentre in connessione con lo scheletro di fanciullo è stato trovato un bicchiere monoan-sato in ceramica comune, alloggiato in uno scas-so quadrangolare appositamente praticato entro la parete laterizia dell’esedra, subito a Nord del capo del defunto17.
La sovrapposizione fra queste due tombe e la probabile identificazione del fondo di un’al-tra, ad esse affiancata, suggeriscono una notevole concentrazione di sepolture in questo spazio.
7. Foto delle tombe messe in luce a ridosso della parete esterna dell’esedra nord-orientale.
332 Francesca Carboni
20 Nell’area delle Terme di Caracalla sono state rinvenute nu-merose tombe all’inizio del secolo scorso ed una estesa necropoli, datata al vi-vii secolo, è stata ivi scavata nel 1983; nell’ultimo tren-tennio del 1800, nell’area delle terme di Diocleziano è stata indi-viduata una sepoltura isolata e, nell’ambito dello stesso complesso, o immediatamente a ridosso di esso, sono state scavate un nume-ro imprecisato di tombe. Cfr. Meneghini–Santangeli Valenzani 2004, pp. 103-115, con le referenze bibliografiche relative ai siti summenzionati, catalogati dagli autori ai nn. 83, 17, 70.
21 Tale dato, accertato in occasione degli scavi svolti nel 1997-98, conferma le indagini effettuate da de Fine Licht nel 1981-83 (De Fine Licht 1983 e De Fine Licht 1990, pp. 49-84) ed è stato definitivamen-te comprovato dalle ultime ricerche eseguite fra il 2003 e il 2006 dalla Sovraintendenza per i Beni Culturali del Comune di Roma, nell’am-bito dell’esedra Sud-Ovest, e da quelle svolte dalla Soprintendenza Archeologica di Roma nel 2000-2003 (v. i contributi in questa sede).
22 Se già nell’ambito del v secolo, venne spoliato anche il pavi-mento del portico antistante l’esedra sud-occidentale, il tessella-to pavimentale dell’emiciclo più prossimo alla cisterna delle Sette Sale, così come il lastricato marmoreo di quello Sud-Ovest venne-ro divelti solo all’inizio del secolo seguente, nel corso del quale si verificò anche la spoliazione delle colonne del portico Sud-Ovest. Cfr. Carboni 2003, pp. 78-79, e il contributo sugli scavi nell’ango-lo sud-occidentale delle Terme di Traiano, in questa sede.
23 CIL, vi, 1670, cfr. Scharf 1992.24 Al momento dell’indagine archeologica, l’estensione della ne-
cropoli è stata accertata almeno per una striscia lunga sette metri, oltre il limite orientale del saggio di scavo aperto.
25 Due distinti nuclei di sepolture, ascrivibili al v secolo, costi-tuiscono la più antica fase di occupazione di tipo funerario del-la Valle del Colosseo. Entrambi presentano evidenti caratteri di mancanza di programmazione nella disposizione delle tombe. Cfr. Rea 1993.
26 Meneghini–Santangeli Valenzani 1993, pp. 89-111; Id. 1995, p. 287; Id. 2004. Nel recente convegno 410 A.D. The sack of Rome (Roma 2010), R. Meneghini ha presentato un’interessante analisi della portata delle epidemie succedute al sacco di Alarico, in relazione alla comparsa delle sepolture urbane a Roma.
27 Pur senza riuscire a risolvere la questione, si comprende che il primo problema da affrontare è quello concernente la proprietà dell’area trasformata in necropoli. Un passo del De Legibus di Ci-cerone ci insegna che il suolo pubblico di Roma non poteva esse-re vincolato dalle norme della religio privata, cioè che la presenza di tombe non era sufficiente, in sé, a renderlo religiosus (Cic., De leg., 46-57). Questa impossibilità fu formulata e sanzionata da un decreto dei pontefici, in virtù di un principio che ribadiva la neces-sità di essere proprietari del suolo per costituire un locus religiosus. Sembra cioè, sulla base della giurisprudenza classica, che la sola condizione giuridica posta per la creazione di un sepolcro sia data dal legittimo possesso del terreno destinato a tale scopo. (cfr. Te-sta 1990, pp. 77-78; Ducos 1995, pp. 135-144). E questo carattere privato della tomba si mantenne sempre, anche dopo la diffusione del cristianesimo.
28 Cfr. Meneghini–Santangeli Valenzani 1995, pp. 278-279. 29 Martorelli 1993. Sulla base del dato epigrafico, la tomba si col-
loca nell’ambito del vi secolo. Cfr. da ultima Rea 2002, pp. 121-125.
comune ritualità funeraria, occupò l’area dell’e-sedra nord-orientale del recinto (area a).
Questo spazio a destinazione sepolcrale, in quanto luogo organizzato e gestito, si presenta, invero, con caratteri anomali, rispetto alle poche sepolture accertate a Roma nell’ambito del v se-colo, connotate, anche nel caso degli aggregati più consistenti, da una certa sporadicità nella di-slocazione e da un’evidente mancanza di pianifi-cazione25, e per questo considerate il prodotto di una situazione critica, quale gli assedi dei Goti di Alarico del 408-41026.
Sulla base dei dati disponibili, è impossibile definire con esattezza lo status delle tombe qui messe in luce27. La disposizione delle sepolture ed alcune caratteristiche ivi individuate sembra-no suggerire una qualche forma di controllo nel-la definizione della necropoli.
Non sapendo attribuire all’autorità civile un tale ruolo, si riprende l’ipotesi formulata da Ro-berto Meneghini a proposito del più tardo cimi-tero individuato nel settore settentrionale della valle del Colosseo28, dove la straordinaria circo-stanza del rinvenimento dell’epigrafe sepolcrale della piccola Gemmula29, in cui si riporta la di-chiarazione di proprietà della tomba da parte dei genitori della defunta, ha indotto a considerare che l’area sepolcrale fosse organizzata e gestita da qualcuno che avesse diritto di venderne i loci. Nel caso della zona adiacente al Colosseo, si è pensato al possesso, da parte della chiesa, di una porzione della piazza e del portico che la delimi-tava verso Nord, in un’epoca in cui nell’Anfitea-tro, divenuto una cava di materiale edilizio, non si celebravano più ludi.
quali, appunto, i grandi complessi termali impe-riali20, e spesso, come nel nostro caso, in modo apparentemente indipendente dalla presenza di edifici ecclesiastici.
Innanzi tutto, si osserva come il nucleo se-polcrale più antico rinvenuto, quello all’angolo nord-orientale del complesso, sia stato installa-to in concomitanza con la messa fuori servizio dell’impianto termale, verificatasi ancora entro il v secolo, quando fu reso inutilizzabile il colletto-re di alimentazione delle terme proveniente dalla vicina cisterna delle Sette Sale21.
All’interruzione del sistema di approvvigiona-mento idrico è succeduta un’attività di spoliazio-ne quanto meno di alcune parti del complesso (riscontrata, per esempio, nella galleria dei servi-zi summenzionata), che sembra non aver riguar-dato, ancora, gli elementi decorativi e architetto-nici delle terme, nella loro totalità22.
Sebbene il dato ceramico, ovvero lo studio dei materiali rinvenuti entro il riempimento del con-dotto di alimentazione, sembrerebbe orientare la collocazione cronologica della sua formazione proprio alla metà del v secolo, valutando anche la testimonianza epigrafica che ricorda la dispo-sizione di statue nelle terme di Traiano ad ope-ra del prefetto urbano in carica nel 467 d.C.23, la defunzionalizzazione del complesso termale può ritenersi avvenuta in un tempo subito posteriore a questa data. E in un momento pressoché con-temporaneo una vera e propria necropoli, di si-curo più ampia della piccola area indagata24, ca-ratterizzata da una certa organizzazione nella di-sposizione delle tombe, da un utilizzo intensivo dello spazio disponibile, dall’applicazione di una
Le sepolture nell’area delle Terme di Traiano 333
30 Per fare un paragone fuori da Roma, a Verona la presenza di se-polture urbane è attestata da numerosi ritrovamenti di inumazioni iso-late di età longobarda effettuati in “aree di proprietà pubblica”; la loro presenza, dunque, non sembra attribuibile all’abbandono di alcuni settori della città, quanto piuttosto ad un recupero a fini cimiteriali di aree che, proprio per il loro carattere pubblico, erano rimaste esenti da un precedente sviluppo dell’edilizia privata (cfr. La Rocca 1985 e La Rocca 1986). Stesso fenomeno è riscontrabile a Brescia dove, pure, sembrerebbe essere stata la disponibilità di suolo pubblico, facilmen-
te accessibile a determinati gruppi sociali, a consentire l’installarsi di cimiteri in area urbana (v. Brogiolo–Cuni 1988 e Brogiolo 1997).
31 Riguardo ad una lettura del fenomeno delle sepolture in urbe nel v e vi secolo, come sfruttato dall’autorità ecclesiastica per gua-dagnare gradualmente potere su ampie fasce del paesaggio cittadi-no cfr. Costambeys 2001.
32 Sul procedimento di occupazione da parte della Chiesa di spa-zi pubblici a fini edificativi, cfr. Hillmer 2002.
Non sono chiaribili i passaggi giuridici di que-sto fenomeno32: o la Chiesa si appropriò in qual-che modo di parte di questo complesso, o esso passò alla chiesa tramite un trasferimento legit-timato. In ogni caso, sia che fosse trasferito o fat-to oggetto di un’appropriazione, esso finì nelle mani di quelli che meglio erano in grado di eser-citarvi un controllo quotidiano31.
Nel quadro topografico di riferimento, sembra verosimile che la proprietà del terreno e la ge-stione di esso fossero esercitate da membri del clero afferenti ai vicini tituli di Equitio e Silve-
Nel nostro caso, possiamo ritenere che una pre-coce disponibilità di terreno già di proprietà de-maniale30 favorì l’installarsi di un cimitero in un settore angolare del complesso balneare. Quest’a-rea, in particolare, aveva le caratteristiche di es-sere limitata da un grande emiciclo e da parte del muro di recinzione e di essere facilmente accessi-bile, perche prossima all’ingresso principale del-le terme, le quali, verosimilmente, continuavano a mantenere, verso l’esterno, un prospetto archi-tettonicamente intatto, a salvaguardia del decoro del paesaggio urbano circostante.
8. Localizzazione delle spazi sepolcrali individuati nell’area delle Terme di Traiano, nell’ambito della topografia circostante.
334 Francesca Carboni
33 Per le problematiche relative alla localizzazione di questi tituli, comunque prossima o corrispondente alla successiva basilica di S. Martino ai Monti, e alla loro definizione come distinti o coinciden-ti, con due diverse titolazioni, vedi Serra 1999 e Accorsi 2002, con bibliografia precedente.
34 LP, i, p. 262.35 Cfr. Carboni 2007.36 Non è stata individuata, in questa parte dell’organismo ar-
chitettonico, una fase di occupazione posteriore alla prima metà del vi secolo, diversamente da quanto avviene, per esempio nell’a-rea dell’emiciclo sud-occidentale. Cfr. relazione generale, in que-sta sede.
37 Particolarmente interessante, in quest’area, è il rinvenimento della cappuccina all’interno della iii galleria traianea, che, essendo coeva all’impianto della limitrofa cisterna, è un’ulteriore testimo-nianza dell’uso di seppellire presso i luoghi dove si abitava. Cfr. il testo di I. Sciortino ed E. Segala in questa sede.
38 Occorre, tuttavia, ricordare che la tomba 1-b, rinvenuta nella zona prospiciente l’esedra sud-occidentale, potrebbe essere il ri-sultato della riduzione di diverse sepolture infantili facenti parte di un più esteso nucleo sepolcrale, verosimilmente localizzato nelle vicinanze, e che la tomba 2-b, pur se assolutamente semplice quan-to a tipologia, e del tutto priva di corredo, poteva tuttavia avere un particolare prestigio, a motivo dei pali lignei posti a segnacolo o a recinto, che la caratterizzano.
39 Si ricorda, in particolare, il rinvenimento, a pochi metri di di-stanza dalla tomba 2, nell’area b, di un piccolo vano quadrangolare dalla probabile funzione abitativa, attribuibile alla stessa fase cro-nologica della sepoltura, nonché quello di coeve strutture in bloc-chi di tufo e laterizi di reimpiego, nei settori i e ii (v. contributo di Caruso et al. in questa sede).
40 Già dall’inizio del v secolo sono documentati, a Roma e Geru-salemme, casi di occupazioni di edifici pubblici in disuso da parte di privati, autorizzate da costituzioni imperiali (Cod. Theod., xv, i, 46, 50, 51, 52). Stando alle Variae di Cassiodoro, tale fenomeno si incrementa in età teodoriciana, quando l’occupazione poteva av-venire tramite concessione ufficiale da parte del sovrano, riservata questa solo ai cittadini altolocati (Cassiod., Var., iv, 29, 30), oppure con occupazione abusiva. Per la trattazione di questa problemati-ca nell’ambito della valle del Colosseo, cfr. Rea 2002, pp. 137-139.
41 Tale funzione di controllo può essere stata svolta da una “ge-stione attenta del degrado urbano”, che per la Roma del vii secolo è stata di recente ricondotta alla persistenza di una amministrazione pubblica rappresentata dagli iudices inviati dall’esarca di Ravenna “ad disponendam civitatem”(cfr. Delogu 2000, pp. 93-94).
42 Si riferisce, come nel caso dell’area A, anche quest’ultimo ci-mitero all’ambito di competenza del vicino edificio ecclesiastico, in un’epoca in cui l’uso di seppellire entro la città comincia a soppian-tare la radicata pratica delle inumazioni suburbane. Cfr. Fiocchi Nicolai 2001, pp. 134-137 e Fiocchi Nicolai 2003.
Dai dati di cui disponiamo, parrebbe invece di leggere una più “regolarizzata”, anche se ormai totalmente diversa, destinazione d’uso degli spa-zi all’interno e a ridosso del nostro complesso, nell’epoca seguente.
Dall’inizio del vii secolo, infatti, sembra che una qualche forma di autorità centrale41, occu-pandosi dello smaltimento dei rifiuti cittadini, deputi a questo scopo l’emiciclo sud-occidenta-le, la cui originaria funzione era quella di archi-vio o biblioteca, mentre, grossomodo negli stessi anni, un’unica gestione organizzatrice42 si preoc-cupava di sistemare una vasta area cimiteriale, addossando le tombe a cappuccina dei membri di una comunità, sepolta seguendo un unico ri-tuale, direttamente alle pareti esterne del recinto perimetrale delle terme (area c1), senza mostrare ormai la benché minima attenzione al manteni-mento, anche solo esteriore, della funzione mo-numentale dell’organismo architettonico.
Evidentemente, il definitivo abbandono del complesso e la ormai avviata ruralizzazione dello spazio urbano avevano fatto venir meno la neces-sità di “contenere” entro uno spazio chiuso, e ap-partato rispetto alla viabilità ordinaria, le sepol-ture, collocate anche fra gli edifici del quartiere che si estendeva a Nord delle terme.
Alcune di queste tombe, mai profanate in an-tico, sono giunte fino ai nostri tempi sotto uno strato di rifiuti accumulatisi nel corso del vii se-colo, che ha costituito, con la sua matrice organi-ca, la base favorevole alla trasformazione di que-sta parte del Colle Oppio in quell’area occupata da orti e vigne che le fonti iconografiche, a parti-re dal Rinascimento, descrivono così fedelmente.
Francesca Carboni
stro, di fondazione costantiniana33, nell’area dei quali papa Simmaco (498-514) edificò la basilica sanctorum Silvestri et Martini34.
Per ciò che concerne, poi, l’obliterazione defi-nitiva di questo nucleo sepolcrale antistante l’e-sedra nord-orientale delle terme, essa pare effet-tivamente imputabile ad un’attività radicale di bonifica, che si colloca, su base stratigrafica, en-tro la prima metà del vi secolo35 e che testimo-nia, almeno in questa zona delle terme, l’effetti-vo momento di abbandono36.
Dopo questa data si assiste ad una completa e radicale spoliazione dell’edificio termale e all’oc-cupazione generalizzata delle sue varie parti, meglio testimoniata nell’area dell’esedra sud-oc-cidentale.
In tale nuovo contesto si inquadrano, infatti, le sepolture a più riprese individuate all’angolo sud-orientale del complesso (area d)37 e le due tombe rinvenute nell’area opposta (area b), al di sopra dell’estradosso del cd. criptoportico sot-tostante il lato occidentale delle terme, comple-tamente privato della sua originaria pavimen-tazione, ma già rivestito di nuovi battuti di cal-pestio.
Queste due sepolture, datate al pieno vi secolo, sembrano connotate dall’essere disposte in modo piuttosto occasionale, distinte per differenti ti-pologie sepolcrali, ciascuna isolata dall’altra38, collocate in uno spazio contemporaneamen-te destinato ad altri usi39, a stretto contatto con il “mondo dei vivi”. Per questi motivi, la loro localizzazione parrebbe piuttosto interpretabile come dovuta a scelte di tipo individuale o fami-liare, le stesse che caratterizzano la contempora-nea occupazione, apparentemente “spontanea”, e forse abusiva, di questa parte delle terme40.
Accorsi 2002 M.L. Accorsi, Il complesso di S. Silve-stro e Martino ai Monti dal iii al ix se-colo. Appunti di studio, in Guidobal-di–Guiglia Guidobaldi 2002, pp. 533-563.
Alberti 2005 F.P. Fiore, A. Nesselrath (a cura di), La Roma di Leon Battista Alberti. Uma-nisti, architetti e artisti alla scoperta dell’antico nella città del Quattrocento, Catalogo della Mostra (Roma, 24 giu-gno-16 ottobre 2005), Milano 2005.
Angelelli–Guidobaldi C. Angelelli, F. Guidobaldi, Le pavi-2002 mentazioni in opus sectile: progetto ori-
ginario e restauri, in F. Rossi (a cura di), Nuove ricerche sul Capitolium di Brescia. Scavi, studi e restauri, Atti del Convegno (Brescia, 3 aprile 2001), Milano 2002, pp. 201-213.
Arena et al. 2001 M.S. Arena, P. Delogu, L. Paroli, M. Ricci, L. Saguì, L. Vendittelli (a cura di), Roma dall’antichità al medioevo. Ar-cheologia e storia nel Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi, Milano 2001.
Atlante 1995 Atlante di Roma. La forma del centro sto-rico in scala 1:1000 nel fotopiano e nella carta numerica, Venezia 1991.
Auriemma 2000 R. Auriemma, Le anfore del relitto di Gra-do, in MEFRA, 112, 1, 2000, pp. 27-51.
Bailey 1980 D.M. Bailey, A Catalogue of the Lamps in the British Museum. 2. Roman lamps made in Italy, London 1980.
Ball 2003 L.F. Ball, The Domus Aurea and the Roman Architectural Revolution, Cam-bridge 2003.
Barabási 2002 Albert-László Barabási, Linked. The New Science of Networks. How every-thing is Connected to Everything Else and What it Means for Science, Business and Everyday Life, Cambridge (Mass.) 2002.
Bartoli 1914-1922 A. Bartoli, I monumenti antichi di Roma nei disegni degli Uffizi di Firenze, Roma 1914-22.
Bartoloni 1985 V. Bartoloni, Ceramica invetriata, in Crypta Balbi 3, pp. 471-498.
Bartsch 1854-1870 A. Bartsch, Le Peintre Graveur, Leipzig 1854-1870.
Baukunst 1975 H-R. Hitchcock, H. Seton-Lloyd, A. Boyd, A. Carden, P. Rawson, D. Talbot Rice, N. Lynton, J. Jacobus, Baukunst. Von den Anfängen bis zur modernen Architektur, Gütersloh 1975 (trad. di: World Architecture. An Illustra-ted History, London 1963).
Becatti 1961 G. Becatti, I mosaici e i pavimenti mar-morei, in Scavi di Ostia iv, Roma 1961.
Bertelli et al. 1988 C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano, Storia dell’arte Italiana, iii, Milano 1988.
Betori–Mari 2005 A. Betori, Z. Mari, Sectilia pavimenta di Villa Adriana: un primo aggiornamento a dieci anni dal Corpus, in C. Angelelli (a cura di), Atti del x Colloquio dell’Asso-ciazione Italiana per lo studio e la conser-vazione del mosaico (Lecce, 18-21 febbra-io 2004), Tivoli 2005, pp. 777-792.
Berckenhagen 1970 E. Berckenhagen, Die französichen Zeichnungen in den Sammlungen der Kunstbibliothek Berlin, Berlin 1970.
Berti 1998 F. Berti, Storia della ceramica di Monte-lupo, ii, Montelupo Fiorentino 1998.
Bertoldi 2007 T. Bertoldi, Terme di Traiano: materia-li dal saggio iii m, in meFRa, 120, 2, pp. 447-467.
Bertoldi 2011 T. Bertoldi, Ceramiche comuni dal su-burbio, Roma 2011.
Bertotti Scamozzi 1785 O. Bertotti Scamozzi, Le Terme dei Ro-mani disegnate da Andrea Palladio e ripub-blicate con la giunta di alcune osservazioni da Ottavio Bertotti Scamozzi giusta l’e-semplare del Lord Co. di Burlington impres-so in Londra l’anno 1732 (edizione doppia italiano/francese 2°), Vicenza 1785.
Bertotti Scamozzi 1797 O. Bertotti Scamozzi, Le Terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio e ripubblicate con la giunta di alcune os-servazioni da Ottavio Bertotti Scamozzi giusta l’esemplare del Lord Conte di Bur-lington impresso in Londra l’anno 1732 (edizione italiana 8°),Vicenza 1797.
Bibliografia
376 Bibliografia
Bruno et al. 2002a M. Bruno, S. Cancelliere, Gorgo-ni, L. Lazzarini, P. Pallante, P. Pen-sabene, Provenance and distribution of white marbles in temples and public build-ings of Imperial Rome, in J.J. Herrmann Jr., N. Herz, R. Newman (eds.), Asmo-sia 5. Interdisciplinary studies on ancient stone, Proceedings of the Fifth Interna-tional Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, Museum of Fine Arts (Boston, 1998), London 2002, pp. 289-300.
Bruno et al. 2002b M. Bruno, L. Conti, P. Pensabene, B. Turi, Pompei after the AD 62 earth-quake: historical, isotopic, and petro-graphic studies of quarry blocks in the Temple of Venus, in J.J. Herrmann Jr., N. Herz, R. Newman (eds.), Asmosia 5. Interdisciplinary studies on ancient stone, Proceedings of the Fifth International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity (Museum of Fine Arts, Bos-ton, 1998), London 2002, pp. 282-288.
Burlington 1730 Lord Ricardo Conte di Burlington, Fabbriche antiche disegnate da Andrea Palladio vicentino, London 1730.
Busiri Vici–Martini A. Busiri Vici D’Arcevia, C. Martini, 1997 Jacob de Heusch (1656- 1701). Un pitto-
re olandese a Roma detto il “copia”, Roma 1997.
Cameron 1772 C. Cameron, The Baths of the Romans explained and illustrated. With the res-torations of Palladio corrected and im-proved, London 1772.
Cameron 1939 C. Cameron, Termy rimljan. Ich opisan-ie i izobrazenie vmeste s ispravlennymi i dopolnennymi restavracijami Palladio... Perevod s angl, Moskau 1939 (ed. in russo con annotazioni di C. Cameron, 1772).
Cantatore 2005 F. Cantatore, Piante e vedute di Roma, in Alberti 2005, pp. 166-175.
Cantilena 2010 F. Cantilena, Non solo mezzo di scam-bio. Spigolature sul significato simbolico della moneta, in RivNum, 111, 2010, pp. 459-469.
Carbonara–Messineo A. Carbonara, G. Messineo, La Celsa 1991-1992 (circ. xx), in BCom, xci, 1991-1992, pp.
179-194.Carboni 2003 F. Carboni, Scavi all’esedra nord-orien-
tale delle Terme di Traiano, in BCom, civ, 2003, pp. 76-80.
Carboni 2007 F. Carboni, Rome, Thermes de Trajan: contextes d’abandon (ve-viie s.), in M. Bonifay, J.C. Treglia (eds..), LRCW 2 Late Roman Coarse Wares, Cooking Wa-res and Amphorae in the Mediterranean-Archeology and Archaeometry, (BAR In-ternational Series 1662), 2007, pp. 411-422.
Carboni cds. F. Carboni, Una tabula lusoria dall’ese-dra sud-occidentale delle Terme di Traia-no sul Colle Oppio, in ArchCl, cds.
Carignani et al. 1989 A. Carignani, A. Gabucci, P. Palaz-zo, G. Spinola, La Basilica Hilariana sul Celio a Roma: una testimonianza di un terremoto altomedievale?, in E. Gui-doboni (a cura di), I terremoti prima del Mille in Italia e nell’area mediterranea, Bologna 1989, pp. 512-517.
Carnabuci 2006 E. Carnabuci, La nuova Forma del Foro di Augusto: considerazioni sulle destina-zioni d’uso degli emicicli, in R. Meneghi-ni, R. Santangeli Valenzani (a cura di), Formae Urbis Roma: nuovi frammen-ti di piante marmoree dallo scavo dei Fori Imperiali, Roma 2006, pp. 173-195.
Bianchi 2001 E. Bianchi, I bolli laterizi del Foro di Tra-iano. Il catalogo del Bloch e i rinvenimenti delle campagne di scavo 1991-1997 e 1998-2000, in BCom, cii, 2001, pp. 83-120.
Bianchi 2003 E. Bianchi, I bolli laterizi dei Mercati di Traiano, in BCom, civ, 2003, pp. 335-357.
Bianchi 2004 E. Bianchi Produzioni laterizie e cantie-ri edilizi traianei, in Atti del Convegno “Archeological methods and approaches: ancient industry and commerce in Italy” (Oxford, 18-19 Aprile 2002) (BAR In-ternational Series 1262), 2004, pp. 268-290.
Bianchi et al. 2000 F. Bianchi, M. Bruno, A. Coletta, M. De Nuccio, Domus delle Sette Sale. L’o-pus sectile parietale dell’aula basilicale: studi preliminari, in Atti vi Colloquio AI-SCOM (Venezia, 1999), Ravenna 2000, pp. 351-60.
Bianchi et al. 2002 F. Bianchi, M. Bruno, M. De Nuccio, La Domus sopra le Sette Sale: la deco-razione pavimentale e parietale dell’aula absidata, in Marmi colorati Catalogo del-la mostra, Venezia 2002, pp. 161-169.
Bianchi–Meneghini E. Bianchi, R. Meneghini, Il cantiere 2002 costruttivo del foro di Traiano, in RM,
109, 2002, pp. 395-414.Bianchi–Bruno 2007 F. Bianchi, M. Bruno, La domus delle
Sette Sale: il pavimento dell’aula rettan-golare, in C. Angelelli, A. Paribeni (a cura di), Atti del xii colloquio AISCOM (Padova, 14-15 e 17 febbraio - Brescia 16 febbraio 2006), Tivoli 2007, pp. 279-286.
Bloch 1947 H. Bloch, I bolli laterizi e la storia edi-lizia romana. Contributi all’archeologia e alla storia, Roma 1947 (rist. da BCom, lxiv, 1936-66, 1938 e lxxi, 1943-1945).
Bodel 2005 J. Bodel, Speaking signa and the brickstamp of M. Rutilius Lupus, in C. Bruun (a cura di), Interpretare i bolli la-terizi di Roma e della Valle del Tevere: produzione, storia economica e topografi-ca, in AIRF, 32, 2005, pp. 61-94.
Breda–Brogiolo 1985 A. Breda, G.P. Brogiolo, Piadena, Loc. Castello, scavo 1984, lotti 2 e 3, AMe-diev, xii, 1985, pp. 181-188.
Briganti et al.1983 G. Briganti, L. Trezzani, L. Laurea-ti, I bamboccianti: pittori della vita quo-tidiana a Roma nel Seicento, Roma 1983.
Brogiolo–Cuni 1988 G.P. Brogiolo, C. Cuni, Le sepolture di età longobarda di S. Giulia in Brescia, in Sepolture e necropoli tra tardo-antico ed alto medioevo nell’Italia nord-occidenta-le, Atti della giornata di studio (Savona, 1987), RStLig, liv, 1988, pp. 145-158.
Brogiolo 1997 G.P. Brogiolo, Modi e luoghi delle sepol-ture a Brescia tra tarda antichità e prima età longobarda (sec. iv-vii), in L. Paroli (a cura di), L’Italia centro settentrionale in età longobarda, Atti del convegno (Ascoli Piceno, 1995), Firenze 1997, pp. 413-424.
Brogiolo– G.P. Brogiolo, G. Cantino Wataghin, Cantino Wataghin 1998 Sepolture tra iv e vii secolo, 7° Seminario
sul tardo antico e l’alto medioevo in Ita-lia centro settentrionale (Gardone Ri-viera, 1996), Mantova 1998.
Broise 2000 H. Broise, Les estampilles anépigraphes sur “bessales” de la Rome impériale, in P. Boucheron, H. Broise, Y. Thébert et al. (éds.), La Brique Antique et Mé-diévale. Production et Commercialisation d’un matériau, actes du colloque Interna-tional organisé par le Centre d’Histoire urbaine de l’École normale supérieure de Fontenay- Saint Cloud et l’ École Fran-çaise de Rome (Saint Cloud, 16-18 no-vembre 1995), (CollEFR 272), Roma 2000, pp. 113-125.
Bibliografia 377
century Rome, in PBSR, lxix, 2001, pp. 169-189.
Cozza 1976 L. Cozza, I recenti scavi alle Sette Sale, in RendPontAcc 1976, pp. 79-101.
Cozza–De Fine Licht L. Cozza, K. De Fine Licht, Colle 1985 Oppio, in Archeologia nel centro, ii,
Roma 1985, pp. 467-477.Crypta Balbi 1 D. Manacorda (a cura di), Crypta Bal-
bi, Archeologia urbana a Roma: il proget-to della Crypta Balbi. ii. Un “mondezza-ro” del xviii secolo, Firenze 1984.
Crypta Balbi 3 D. Manacorda (a cura di), Crypta Balbi 3, Archeologia urbana a Roma: il proget-to della Crypta Balbi. 3. Il giardino del Conservatorio di S. Caterina della Rosa, Firenze 1985.
Crypta Balbi 5 L. Saguì, L. Paroli (a cura di), Crypta Balbi 5. L’esedra della Crypta Balbi nel medioevo (xi-xv secolo), Firenze 1990.
Curia 1989 C. Morselli, E. Tortorici, Curia, Fo-rum Iulium, Forum Transitorium. Lavo-ri e Studi di Archeologia, 14, i-ii, Roma. 1989.
Dacos 1964 N. Dacos, Les peintres belges à Rome au 16. siècle, Bruxelles 1964.
Dacos 1965 N. Dacos, Visitatori di Villa Adriana in Palatino, 9, 3, 1965, pp. 9-11.
Dacos 1967 N. Dacos, Graffiti de la Domus Aurea, in BBelgRom, 38, 1967, Bruxelles, pp. 145-175.
Dacos 1969 N. Dacos, La découverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques à la Renaissance, London-Leiden 1969.
Dacos 1995 N. Dacos, Roma quanta fuit. Tre pitto-ri fiamminghi nella Domus Aurea, Roma 19952.
David 1998 M. David (a cura di), Frammenti di Roma antica nei disegni degli architetti francesi vincitori del Prix de Rome 1786-1924, Novara 1998.
De Fine Licht 1974 K. De Fine Licht, Untersuchunghen an den Trajansthermen zu Rom, in Anal-RomInstDanici, Suppl. vii, 1974, pp. 5-48.
De Fine Licht 1976 K. De Fine Licht, Marginalia on Trajan’s Bath in Rom, in Studia Romana in honorem P. Krarup, Odense 1976, pp. 87-95.
De Fine Licht 1983 K. De Fine Licht, Scavi alle Sette Sale, in AnalRomInstDanici, Suppl. x, 1983, pp. 186-202.
De Fine Licht 1990 K. De Fine Licht, Sette Sale. Untersu-chungen an den Trajansthermen zu Rom, AnalRomInstDanici, Suppl. 19, Roma 1990.
De Fine Licht 2004 K. De Fine Licht, Aula con due absi-di. Studi sulle terme di Traiano 3, in AnalRomInstDanici, 30, 2004, pp. 119-136.
Del Francia 2000 R. Del Francia, Sectilia Pavimenta della Venetia: una rivisitazione critica, in F. Guidobaldi, A. Paribeni (a cura di), Atti del vi Colloquio AISCOM (Ve-nezia, 20-23 gennaio 1999), Ravenna, 2000, pp. 81-98.
Delogu 2000 P. Delogu, Solium imperii-urbs eccle-siae. Roma fra la tarda antichità e l’al-to medioevo, in G. Ripoll, J.M. Gurt, A. Chavarria (eds.), Sedes regiae (ann. 400-800), Barcelona 2000, pp. 83-108.
De Marchi et al. 2004 P.M. De Marchi, V. Mariotti, L. Miazzo, La necropoli longobarda di Ar-sago Seprio, in AMediev, 31, 2004, pp. 101-168.
De Paoli 1623 F. De Paoli (ed.), Nova urbis Romae de-scriptio, 1623.
De Romanis 1822 A. De Romanis, Le antiche camere esqui-line dette comunemente delle Terme di Tito, Roma 1822.
Carta et al. 1978 M. Carta, I. Pohl, F. Zevi, Ostia. La ta-verna dell’Invidioso. Piazzale delle Corpo-razioni, portico ovest: saggi sotto i mosaici, NSc, suppl. xxxii, 1978.
Caruso 1991-1992 G. Caruso, Terme di Tito, in BullCom, 94, 1991-1992, pp. 81-83.
Caruso 2001 G. Caruso, Mosaico dalle Terme di Tra-iano, in Atti del vii Colloquio AISCOM, Ravenna 2001, pp. 381-386.
Caruso–Volpe, 1994 G. Caruso, R. Volpe, Terme di Traiano. Scavi nel criptoportico nordoccidentale, in Archeologia Laziale, 12, 1994, pp. 181-184.
Caruso–Volpe 1999 G. Caruso, R. Volpe, in LTUR, v, Roma 1999, pp. 67-69.
Caruso–Volpe 2000 G. Caruso, R. Volpe, Preesistenze e per-sistenze delle Terme di Traiano, in Roma-nization and the City: Creation, Dyna-mics and Failures, JRA Suppl. 38, 2000, pp. 42-56.
Caruso–Volpe 2001 G. Caruso, R. Volpe, Terme di Traiano, in Tra Damasco e Roma: l’architettura di Apollodoro di Damasco nella cultura clas-sica, Roma 2001, pp. 91-102.
Caruso et al. 1990 G. Caruso, A. Ceccherelli. P. Giu-sberti, L. Maestri, C. Vannicola, Scavi alle terme di Tito, in Archeologia Laziale, 10, Roma 1990, pp. 58-67.
Cassas 1994 A. Gilet, U. Westfehling (Hrsg.), Louis-François Cassas 1756-1827. Dessi-nateur-Voyageur. Im Banne der Sphinx, Catalogo della mostra (Köln, 22. Apr. - 19. Jun. 1994), Mainz 1994.
Castagnoli 1956 F. Castagnoli, Le Sette Sale cisterna delle Terme di Traiano, in ArchCl, viii, 1956, pp. 53-55.
Castagnoli 1978 F. Castagnoli, Roma Antica. Profilo Urbanistico, Roma 1978.
CensUs A. Nesselrath (ed.), Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance, banca dati su DVD e online, München 1997-2005 [www.census.de]
Chessex–Haskell 1985 P. Chessex, F. Haskell, Roma Roman-tica. Vedute di Roma e dei suoi dintorni di A.L.R. Ducros (1748-1810), Milano 1985.
Ciotola et al. 1989 A. Ciotola, S. Picciola, R. Santan-geli Valenzani, R. Volpe, Roma, tre contesti. 1. Via Nova-Clivo Palatino. 2. Crypta Balbi. 3.Via Sacra-Via Nova, in Amphores romaines et histoire écono-mique: dix ans de recherche, Actes du col-loque (Sienne, 22-24 mai 1986), Roma 1989 (CollEFR, 114), pp. 604-609.
Cipriano–Manacorda M.T. Cipriano, D. Manacorda, La ma-1984 iolica, in Crypta Balbi 1, pp. 37-82.CipRo G. Schelbert, CIPRO. Catalogo delle
piante di Roma online, Roma 2001-2006 (fmdb.biblhertz.it/cipro/).
Clauset et al. 2009 A. Clauset, C.R. Shalizi, M.E.J. New-man, Power-law distributions in empirical data, in SIAM Review, 51.4, 2009, pp. 661-703.
Coarelli 2007 F. Coarelli, Aree aperte e concezione dello spazio a Roma, in Fragmenta, 1, 2007, pp. 25-32.
Coletti 2003 C.M. Coletti, Ceramica da cucina di Ostia: presenze e dati quantitativi, in G. Olcese (a cura di), Ceramiche comuni a Roma e in area romana: produzione, cir-colazione e tecnologia (Documenti di Ar-cheologia, 28), Mantova 2003.
Coletti–Pavolini 1996 C.M. Coletti, C. Pavolini, Ceramica comune da Ostia, in Les Céramiques com-munes de Campanie et de Narbonnaise, Napoli 1996, pp. 391-419.
Colini–Matthiae 1966 A. Colini, G. Matthiae, Ricerche intor-no a S. Pietro in Vincoli, MemPontAcc, 9, 1966.
Costambeys 2001 M. Costambeys, Burial Topography and the power of the church in fifth- and sixth-
378 Bibliografia
Gori Sassoli 2000 M. Gori Sassoli (a cura di) Roma ve-duta: disegni e stampe panoramiche della cittá dal xv al xix secolo, Catalogo della mostra, Roma 2000.
Greuter 1618 M. Greuter, Disegno nuovo di Roma moderna con le sue strade, siti et edifitii in pianta esatta cosi come sta al presente sot-to il fel.mo pont.to di N.S. Paolo P. P. V., Roma 1618.
Gros–Torelli 1988 P. Gros, M. Torelli, Storia dell’urbani-stica. Il mondo romano, Roma-Bari 1988.
Guerrini 1987 R. Guerrini, Contributo alla conoscenza di Francesco da Siena. Documenti e opere, in M. Fagiolo, M.L. Madonna (a cura di), Baldassarre Peruzzi. Pittura, scena e architettura nel Cinquecento, Atti del con-vegno (Roma-Siena, 1981), Roma 1987, pp. 503-536.
Guidobaldi 1985 F. Guidobaldi, Pavimenti in opus sec-tile di Roma e dell’area romana: proposte per una classificazione e criteri di datazio-ne, in P. Pensabene (a cura di), Marmi antichi, Problemi di impiego, di restauro e di identificazione, Studi Miscellanei, 26, Roma 1985, pp. 171-251.
Guidobaldi 1994a F. Guidobaldi, Piccole Terme, in F. Guidobaldi (a cura di), Sectilia pavi-menta di Villa Adriana, Roma 1994, pp. 157-165.
Guidobaldi 1994b F. Guidobaldi, Piazza d’Oro, in F. Gui-dobaldi (a cura di), Sectilia pavimenta di Villa Adriana, Roma 1994, pp. 194-214.
Guidobaldi 1994c F. Guidobaldi, Valle di Tempe, in F. Guidobaldi (a cura di), Sectilia pavi-menta di Villa Adriana, Roma 1994, pp. 215-218.
Guidobaldi et al. 1994 F. Guidobaldi, F. Olevano, D. Trucchi, Sectilia pavimenta di Ercolano: classifica-zione e confronto con il campione Pompeia-no, in vi Colloquio Internacional sobre Mo-saico Antiguo (Palencia-Mérida, Octubre 1990), Guadalajara 1994, pp. 63-82.
Guidoboni, 1989 E. Guidoboni (a cura di), I terremoti prima del Mille in Italia e nell’area me-diterranea: storia, archeologia, sismologia, Bologna 1989.
Hayes 1983 J.W. Hayes, The villa Dionysos excava-tions, Knossos : the pottery, in BSA, 78, 1983, pp. 97-169.
Hillmer 2002 J. Hillmer, Le chiese paleocristiane di Roma e l’occupazione degli spazi pubbli-ci, in F. Guidobaldi, A. Guiglia Gui-dobaldi (a cura di), Ecclesiae Urbis, Atti del Congresso Internazionale di stu-di sulle Chiese di Roma (IV-X secolo) (Roma, 4-10 ottobre 2000), Città del Va-ticano 2002, pp. 321-329.
Hollstein 1969 F.W.H. Hollstein, Dutch and Flem-ish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700, Amsterdam 1969.
Jordan–Huelsen H. Jordan, Topographie der Stadt Rom-1871-1907 im Alterthum. Bd. I,1 (1878); I,2 (1885);
I,3 (1907; bearbeitet von Christian Huelsen); II (1871), Berlino 1871-1907.
Kettering 1988 A. McNeil Kettering, Drawings from the Ter Borch drawings estate, Den Haag 1988.
Kloek 1975 W.Th. Kloek, Beknopte Catalogus van de Nederlandse tekeningen in het Prenten-kabinet van de Uffizi te Florence, Utrecht 1975.
Krencker 1929 D. Krencker, Die Trierer Kaiserther-men. Mit einer Übersicht über die wichtig-sten Thermenanlagen des römischen Rei-ches, Augsburg 1929.
Kulawik 2002 B. Kulawik, Die Zeichnungen im Codex Destailleur D (HDZ 4151) der Kunstbi-bliothek Berlin Preußischer Kulturbesitz zum letzten Projekt Antonio da Sangallos
de Visscher 1993 F. de Visscher, Le droit des tombeaux ro-mains, Milano 1993.
Donati 1665 A. Donati, Roma vetus ac recens, Roma 1665 (rist. 1694, 1695, 1725, 1738).
Ducos 1995 M. Ducos, Le tombeau, locus religiosus, in F. Hinard (éd.), La mort au quotidien dans le mond romain, Actes du colloque (Paris, 7-9 octobre 1993), Paris 1995, pp. 135-144.
Duday 2009 H. Duday, The archaeology of the dead : lectures in archaeothanatology, Studies in funerary archaeology, 3, Oxford 2009.
Duncan 1964 G.C. Duncan, A Roman Pottery near Sutri (Sutrium), in BSR, xxxii, 1964, pp. 38-88.
Du Pérac 1575 E. Du Pérac, I vestigi dell’antichita di Roma. Raccolti et ritratti in perspettiva con ogni diligentia, Roma 1575.
Du Pérac 1577 E. Du Pérac, A. Lafréry, (edd.), Nova Urbis Romae Descriptio, Roma 1577.
Egger 1931 H. Egger, Römische Veduten, Wien 1931-32².
Envois 1992 Roma Antiqua. “Envois” degli architetti francesi (1786-1901), Roma 1992.
Fagiolo 1991 M. Fagiolo, Roma antica. L’immagine delle grandi città italiane 1, Lecce 1991.
Fabbrini 1982 L. Fabbrini, Domus Aurea: il piano su-periore del quartiere orientale, in Mem-Pont Acc, xiv, 1982, pp. 5-24.
Falsone–Bound 1986 G. Falsone, M.M. Bound, Archeologia subacquea a Marsala, in BArte, suppl. 35-36, Roma 1986, pp. 161-178.
Ficacci 2000 L. Ficacci, Giovanni Battista Piranesi: the complete etchings, Köln 2000.
Filippi 2008 F. Filippi (a cura di), Horti et Sordes, uno scavo alle falde del Gianicolo, Roma 2008.
Fiocchi Nicolai 2001 V. Fiocchi Nicolai, Strutture funerarie ed edifici di culto paleocristiani di Roma dal iv al vi secolo, Città del Vaticano 2001.
Fiocchi Nicolai 2003 V. Fiocchi Nicolai, Elementi di trasfor-mazione dello spazio funerario tra tarda antichità ed altomedioevo, in Settimane CISAM 50, ii, (Spoleto 2002), Spoleto 2003, pp. 921-969.
Fogagnolo 2006 S. Fogagnolo, Lo scavo del Tempio del Foro della Pace e un nuovo contesto di cera-miche rinascimentali, in Meneghini−San-tangeli Valenzani 2006, pp. 145-167.
Frommel–Adams 2000 C.L. Frommel, N. Adams, The Archi-tectural Drawings of Antonio da Sangallo the Younger and His Circle, ii: Churches, Villas, the Pantheon, Tombs, and Ancient Inscriptions, New York 2000.
Frutaz 1962 A.P. Frutaz, Le piante di Roma, Roma 1962.
Funiciello et al. 2008 R. Funiciello, A. Praturlon, G. Gior-dano, La geologia di Roma dal centro sto-rico alla periferia (Memorie descrittive della Carta Geologica d’Italia, lxxx), Roma 2008.
F.U.R. 1960 G. Carettoni, A. Colini, L. Cozza, G. Gatti, Forma Urbis Romae. La Pianta marmorea di Roma antica, Roma 1960.
Gabucci 1985 A. Gabucci, Ceramica acroma rinasci-mentale e moderna, in Crypta Balbi 3, pp. 499-536.
Garms 1995 J. Garms, Vedute di Roma. Dal medioevo all’Ottocento. Atlante iconografico, topo-grafico, architettonico, Napoli 1995.
Gasparri 1979 C. Gasparri, Aedes Concordiae Augu-stae, Roma 1979.
Gastaldo 1998 G. Gastaldo, I corredi funerari nelle tombe tardo romane in Italia settentrio-nale, in Brogiolo, Cantino Wataghin 1998, pp. 15-59.
Giuntella 1998: A.M. Giuntella, Note su alcuni aspetti della ritualità funeraria nell’alto medioevo. Consuetudini e innovazioni, in Brogiolo–Cantino Wataghin 1998, pp. 61-75.
Bibliografia 379
ria economica di Roma nell’alto Medioe-vo alla luce dei recenti scavi archeologici, Atti del seminario (Roma, 1992), Firen-ze 1993, pp. 89-111.
Meneghini– R. Meneghini, R. Santangeli Valen-Santangeli Valenzani zani, Corredi funerari, produzioni e pae-1994 saggio sociale a Roma tra vi e vii secolo, in
RACr, lxx, 1994, pp. 321-337.Meneghini– R. Meneghini, R. Santangeli Valen-Santangeli Valenzani zani, Sepolture intramuranee a Roma tra 1995 v e vii secolo d. C. – aggiornamenti e con-
siderazioni, in AMediev, xxii, 1995, pp. 283-290.
Meneghini– R. Meneghini, R. Santangeli Valen-Santangeli Valenzani zani, Roma nell’altomedioevo, Roma 2004 2004.Meneghini− R. Meneghini, R. Santangeli Valen-Santangeli Valenzani zani (a cura di), Roma. Lo scavo dei Fori 2006 Imperiali 1995-2000. I Contesti ceramici,
Roma 2006 (CollEFR, 365).Meneghini– R. Meneghini, R. Santangeli Valen-Santangeli Valenzani zani., I Fori Imperiali. Gli scavi del Co-2007 mune di Roma (1991-2007), Roma 2007.Meneghini 2009 R. Meneghini, I Fori Imperiali e i Mer-
cati di Traiano. Storia e descrizione dei monumenti alla luce degli studi e degli sca-vi recenti, Roma 2009.
Mercando 1974 L. Mercando, Portorecanati (Macera-ta). La necropoli di Portorecanati, in NSc, s. 8, xxviii, 1974, pp. 142-430.
Mercati 1629 G.B. Mercati, Alcune vedute et prospet-tive di luoghi dishabitati di Roma, Roma 1629.
Messineo 1985 G. Messineo, Suppellettile fittile per uso agricolo a Roma e suburbio, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo ro-mano. Città, agricoltura, commercio: ma-teriali da Roma e dal suburbio, Modena 1985, pp. 151-154.
Milella et al. 2002 M. Milella, L. Ungaro, M. Vitti, L’utilizzo di varietà diverse di marmi bianchi nel Foro di Traiano e nel Foro di Cesare, in M. De Nuccio, L. Ungaro (a cura di), I marmi colorati della Roma Im-periale, Venezia 2002, pp. 143-145.
Mirri–Carletti 1776 L. Mirri, G. Carletti, Le antiche came-re delle Terme di Tito, Roma 1776.
Molinari 1985 A. Molinari, Reperti residui di età me-dievale. Maiolica arcaica, in Crypta Bal-bi 3, pp. 256-280.
Molinari 1990 A. Molinari, Le ceramiche rivestite basso-medievali, in Crypta Balbi 5, pp. 357-484.
Morricone Matini 1967 M. L. Morricone Matini, Roma: Reg. x Palatium, (Mosaici antichi in Italia, Regio i), Roma 1967.
Muñoz 1936 A. Muñoz, Il Parco di Traiano, Roma 1936.
Nencini 2002 M. Nencini, Via Mecenate. Resti di strut-ture murarie antiche e di una sepoltura, Re-lazioni su scavi, trovamenti, restauri: Re-gio iii, in BCom, ciii, 2002, pp. 115-117.
Nesselrath 1989 A. Nesselrath, Monumenta Antiqua Romana. Ein illustrierter Rom-Trak-tat des Quattrocento, in R. Harprath, H.Wrede (Hrsg.), Antikenzeichnung und Antikenstudium in Renaissance und Frühbarock, Akten des Internationalen Symposions (Coburg, 8. Sept. - 10. Sept. 1986), Mainz 1989, pp. 21-37.
Nesselrath 2004 A. Nesselrath, Disegni di Francesco di Giorgio Martini, in F.P. Fiore (a cura di), Francesco di Giorgio alla corte di Federico da Montefeltro, Firenze 2004, pp. 337-367.
Newman 2003 M.E.J. Newman, The Structure and Function of Complex Networks, in SIAM Review 45, 2, 2003, pp. 167-256 (http://www.siam.org/journals/sirev/45-2/42480.html).
des Jüngeren für den Neubau von St.Peter in Rom, (Diss.), Berlin 2002.
Lanciani 1902-1912 R. Lanciani, Storia degli Scavi di Roma e notizie intorno alle collezioni di antichi-tà, i-iv, Roma 1902-1912.
Lanciani 1985 R. Lanciani, Rovine e scavi di Roma an-tica, Roma 1985.
Lanciani, FUR R. Lanciani, Forma Urbis Romae, Roma 1893-1899.
Lanciani 1990 R. Lanciani, Storia degli Scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità, ii, Roma 1990.
La Rocca 1989 C. La Rocca, Le fonti archeologiche di età gotica e longobarda, in A. Castagnet-ti, G.M. Varanini (a cura di), Il Veneto nel Medioevo. Dalla Venetia alla Marca veronese, ii, Verona 1989, pp. 83-164.
La Rocca– C. La Rocca, C. La Rocca Hudson, La Rocca Hudson 1986 “Dark Ages” a Verona: edilizia privata,
aree aperte e strutture pubbliche in una cit-tà dell’Italia settentrionale, in AMediev, xiii, 1986, pp. 31-78.
La Rocca 2000 E. La Rocca, L’affresco con veduta di cit-tà dal Colle Oppio, in Romanization and the City: Creation, Dynamics and Failu-res, JRA Suppl., 38, 2000, pp. 57-71.
Lazzarini 1997 S. Lazzarini, Tutela legale del sepolcro familiare romano, in M. Mirabella Ro-berti (a cura di), Monumenti sepolcra-li romani in Aquileia e nella Cisalpina, Atti della xxvi settimana di studi aqui-leiesi (Aquileia, 1995), (Antichità altoa-driatche, 43), Trieste 1997, pp. 83-97.
Liljenstolpe–Klynne P. Liljenstolpe, A. Klynne 1999, The 1997-1998 imperial gardens of the Villa of Livia at
Prima Porta, in OpRom, 22-23, 1997-1998, pp. 127-147.
Lo Pilato 2005 S. Lo Pilato, La necropoli tardo anti-ca e l’insediamento altomedievale di Via San Michele a Mirabella Eclano (AV), in AMediev, 32, 2005, pp. 145-156.
Lotz 1939 W. Lotz, Protokoll der 67. Wissen-schaftlichen Besprechung. 20. Januar 1939, in MKuHistFlorenz, 5. 4, 1940, pp. 441-444.
ltUR E.M. Steinby (ed.), Lexicon topographi-cum urbis Romae, Roma 1993-2000.
Maetzke 1986 G. Maetzke, Roma: area nord-occi-dentale del Foro romano 1980-1985, in BCom, xci, 1986, pp. 360-391.
Maggi 1618 G. Maggi, Aedificia et ruinae Romae ex antiquis atque hodiernis monimentis, s.l. 1618.
Mancini 2006 D. Mancini, Contesti ceramici della se-conda metà del xvi dall’area del mona-stero di S. Urbano al Foro di Traiano, in Meneghini−Santangeli Valenzani 2006, pp. 169-183.
Marcelli 1989 M. Marcelli, Su alcune tombe tardoan-tiche di Roma: nota preliminare, in AMe-diev, 16 , 1989, pp. 525-540.
Martines 1999 G. Martines, Macchine da cantiere per il sollevamento dei pesi, nell’antichità, nel Medioevo, nei secoli xv e xvi, in Annali di architettura, 10-11, 1998-99, Vicenza 1999, pp. 261-275.
Martini 1967 C. Maltese (a cura di), Francesco di Giorgio Martini: Trattati di Architettura, Ingegneria e Arte Militare, Milano 1967.
Martorelli 1993 R. Martorelli, L’epigrafe di Gemmula, in Rea 1993, p. 657.
Medri 1996 M. Medri, sUet. Nero, 31.1: Elementi e proposte per la ricostruzione della Domus Aurea, in C. Panella (a cura di), Meta Sudans i, Roma 1996, pp. 165-188.
Meneghini– R. Meneghini, R. Santangeli Valen-Santangeli Valenzani zani, Sepolture intramuranee e paesaggio 1993 urbano a Roma tra v e vii secolo, in L.
Paroli, P. Delogu (a cura di), La Sto-
380 Bibliografia
Pannuzi 2002 S. Pannuzi, Produzioni di ceramica inve-triata postmedievale dal pozzo di scarico della fornace della Consolazione e dal for-nice lxviii del Colosseo, in E. De Mini-cis, G. Maetzke (a cura di), Le cerami-che di Roma e del Lazio in età medievale e moderna, Atti del iv Convegno di stu-di (Viterbo, 22-23 maggio 1998), Roma, pp.165-184.
Pannuzi 2003c S. Pannuzi, Schede, in S. Pannuzi (a cura di), Le ceramiche tardomedievali e rinascimentali del Castello di Ostia Anti-ca, Roma 2003, pp. 91-120.
Pannuzi 2006 S. Pannuzi, Produzioni di ceramica da fuoco dal tardomedioevo all’età moderna in area romana e nel Lazio meridionale, in Albisola, xxxix, 2006, pp. 203-223.
Paola Scavizzi 2008 C. Paola Scavizzi, La fabbrica per la la-vorazione del salnitro sul Colle Oppio, in asRsp, 131, 2008, pp. 237-292.
Paroli 1985 L. Paroli, Reperti residui di età medie-vale. Ceramica a vetrina pesante (Forum Ware). Ceramica a vetrina pesante a mac-chia (Sparse glazed), in Crypta Balbi 3, pp. 206-224.
Paroli 1990 L. Paroli, Ceramica a vetrina pesante al-tomedievale (Forum Ware) e medievale (Sparse Glazed). Altre invetriate tardo-antiche e altomedievali, in Crypta Balbi 5, pp. 314-356.
Paribeni 1927 R. Paribeni, Optimus Princeps. Sag-gio sulla storia e sui tempi dell’imperatore Traiano, ii, Roma 1927.
Pavolini 1993 C. Pavolini, L’area del Celio fra l’anti-chità e il medioevo alla luce delle recenti in-dagini archeologiche, in L. Paroli, P. De-logu (a cura di), La Storia economica di Roma nell’alto Medioevo alla luce dei re-centi scavi archeologici, Atti del seminario (Roma, 1992), Firenze 1993, pp. 53-70.
Pavolini 2000 C. Pavolini, Scavi di Ostia. La cerami-ca comune. Le forme in sigillata depurata dell’antiquarium. xiii, Roma.
Pinna 1985 A. Pinna, Terraglia, in Crypta Balbi 3, pp. 439-458.
Pinon–Amprimoz 1988 P. Pinon, F. Amprimoz, Les envois de Rome (1778-1968). Architecture et ar-chéologie, Roma 1988.
Piranesi 1748-1778 G.B. Piranesi, Vedute di Roma, Roma 1748-1778.
Piranesi 1756 G.B. Piranesi, Le antichità romane, i, Roma 1756.
Ponti 2002 G. Ponti, Lastre pavimentali in situ, in M. De Nuccio, L. Ungaro (a cura di), I marmi colorati della Roma Imperiale, Ve-nezia 2002, pp. 538-539, scheda cat. 303.
Rasch 1996 J.J. Rasch, Zur Entstehung des Kaiser-typus im römischen Thermenba, in RM, 103, 1996, pp. 201-230.
Rea 1993 R. Rea, Roma: l’uso funerario della valle del Colosseo tra tardo antico ed alto me-dioevo, in AMediev, xx, 1993, pp. 645-656.
Rea 2002 R. Rea (a cura di), Rota Colisei. La val-le del Colosseo attraverso i secoli, Roma 2002.
Rejna 1911 V. Rejna, Media pars Urbis, Roma 1911. Ricci 1985 M. Ricci Maiolica di età rinascimentale e
moderna, in Crypta Balbi 3, pp. 303-424.Ricci 1990 M. Ricci, Ceramica acroma depurata, 2.
Brocche, catini, orcioli ed altre forme mi-nori, in Crypta Balbi 5, pp. 288-307.
Ricci 1997 M. Ricci, Relazioni culturali e scambi commerciali nell’Italia centrale romano-longobarda alla luce della Crypta Balbi in Roma, in L. Paroli (a cura di), L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, atti del convegno (Ascoli Piceno, 6-7 ot-tobre 1995), Firenze 1997, pp. 239-273.
Newman 2005 M.E.J. Newman, Power laws, Pareto dis-tributions and Zipf’s law, in Contemporary Physics, 46, 2005, pp. 323-351 (http://arxiv.org/abs/cond-mat/0412004).
Newman 2010 M.E.J. Newman, Networks. An Intro-duction, Oxford 2010.
Nielsen 1993 I. Nielsen, Thermae et balnea. The ar-chitecture and cultural history of Roman public baths, Copenhagen 1993.
Oehler 1997 L. Oehler, Rom in der Graphik des 16. bis 18. Jahrunderts, Berlin 1997.
Olcese 2003 G. Olcese, Ceramiche comuni a Roma e in area romana: produzione, circolazione e tecnologia (Documenti di Archeologia, 28), Mantova 2003.
Olevano 1994a F. Olevano, Teatro Marittimo e Sala dei Filosofi, in F. Guidobaldi (a cura di), Sectilia pavimenta di Villa Adriana, Roma 1994, pp. 107-114.
Olevano 1994b F. Olevano, Roccabruna, in F. Guido-baldi (a cura di), Sectilia pavimenta di Villa Adriana, Roma 1994, pp. 171-173.
Olevano 1994c F. Olevano, Sala dei Pilastri dorici, in F. Guidobaldi (a cura di), Sectilia pavi-menta di Villa Adriana, Roma 1994, pp. 221-224.
Ostia ii F. Berti, A. Carandini, E. Fabbricotti et al., Ostia ii. Le Terme del Nuotatore. Scavo dell’ambiente i, (Studi Miscellanei, 16), Roma 1970.
Ostia iii A. Carandini, C. Panella, Ostia iii. Le Terme del Nuotatore. Scavo degli am-bienti iii, vi, vii, (Studi Miscellanei, 21), Roma 1973.
Overbeek 1763 B. van Overbeek, Les restes de l’ancienne Rome, Den Haag 1763.
Palazzo 1985 P. Palazzo, Reperti residui di età medie-vale. Ceramica maculata, in Crypta Balbi 3, p. 301.
Palombi 1997 D. Palombi, Tra Palatino ed Esquilino. Velia, Carinae e Fagutal. Storia urbana di tre quartieri di Roma antica (RIA, sup-pl. 1), Roma 1997.
Panella 1986 C. Panella, Oriente ed occidente : con-siderazioni su alcune anfore ‘egee’ di età imperiale, in Recherches sur les amphores grecques, in BCorrEllénique, suppl. xiii, pp. 609-636.
Panella 1992 C. Panella, Mercato di Roma e anfo-re galliche nella prima età imperiale, in F. Laubenheimer (éd.), Les ampho-res en Gaule. Production et circulation, Luxeuil-les-Bains 1992, pp.185-206.
Panella 2001a C. Panella, La Porticus Liviae, in Are-na et al. 2001, pp. 614-615.
Panella 2001b C. Panella, Le anfore di età imperiale del Mediterraneo occidentale, in P. Lévêque, J-P. Morel (éds.), Céramiques Helléni-stiques et Romaines iii, Besançon 2001, pp. 177-275.
Pannuzi 1998 S. Pannuzi, “La fornace del Pignattaro” di Via della Consolazione a Roma: l’ulti-ma fase della sua produzione di xvii-xviii secolo, in E. De Minicis (a cura di), Le ceramiche di Roma e del Lazio in età me-dievale e moderna, Atti del iii Conve-gno di studi (Roma, 19-20 aprile 1996) Roma, pp. 49-64.
Pannuzi 2000 S. Pannuzi, Produzione e consumo a Roma di ceramica invetriata da fuoco tra xvi e xviii secolo, in Preatti del ii Congresso Nazionale di Archeologia Medievale della SAMI (Brescia, 28 settembre - 1 ottobre 2000), Firenze 2000, pp. 453-461.
Pannuzi 2001 S. Pannuzi, Una fornace per ceramica in-vetriata a Roma tra xvii e xviii secolo: “la Fornace delle Pile” di Via della Con-solazione, in Archeologia Postmedievale, 5, pp. 169-201.
Bibliografia 381
Stanford, FUR Stanford Digital Forma Urbis Ro-mae Project, Rom/Stanford 2002-2003 http://formaurbis.stanford.edu (30. Sep-tember 2005)
Steinby 1974 M. Steinby, Le cronologie delle “figline” doliari urbane dalla fine dell’età repub-blicana all’inizio del iii secolo, in BCom, lxxxiv, 1974-1975, pp. 7-132.
Stella–Bezzi 1979 C. Stella, L. Bezzi, Itinerari di Bre-scia romana: guida e carta archeologica di Brixia, Brescia 1979.
Stendhal 2002 Stendhal, Viaggi in Italia. Roma, Na-poli e Firenze; passeggiate romane illu-strate dai pittori del romanticismo, a cura di M. Colesanti, Firenze 2002.
Tognocchi 2004 L. Tognocchi, Ceramiche di xviii seco-lo da un pozzo del Foro di Cesare, in Ar-cheologia Postmedievale, 8, pp. 11-42.
Thöne 1960 F. Thöne, Ein Deutschrömisches Skiz-zenbuch von 1609, Berlin 1960.
Thuillier 1982 J. Thuillier, Claude Lorrain e i pittori lo-renesi in Italia nel xvii secolo, Roma 1982.
Tognocchi 2006 L. Tognocchi Uno scarico di ceramica del xviii secolo dal Foro di Cesare, in Me-neghini−Santangeli Valenzani 2006, pp. 185-220.
Toro 1985 A. Toro, Porcellana, in Crypta Balbi 3, pp. 459-470.
Trevisan 1995 S.Trevisan, I pavimenti in opus sectile del complesso della Mensa Ponderaria di Tivoli, in I. Brigantini, F. Guidobal-di (a cura di), Atti del ii Colloquio AI-SCOM (Roma, 5-7 dicembre 1994), Bordighera 1995, pp. 467-474.
Trucchi 1994a D. Trucchi, Pretorio, in F. Guidobal-di (a cura di), Sectilia pavimenta di Villa Adriana, Roma 1994, pp. 187-193.
Trucchi 1994b D. Trucchi, Terrazza e padiglione di Tempe, in F. Guidobaldi (a cura di), Sectilia pavimenta di Villa Adriana, Roma 1994, pp. 227-233.
Uggeri 1793-1810 A. Uggeri, Journées pittoresques des Edi-fices de Rome Ancienne, Roma 1793-1810.
Ungaro 2002 L. Ungaro, Il Foro di Augusto, in M. De Nuccio, L. Ungaro (a cura di), I marmi colorati della Roma Imperiale, Venezia 2002, pp. 109-123.
Ungaro et al. 2001 L. Ungaro, G.L. Ponti, M. Vitti, Le pavimentazioni del Foro di Augusto, del Foro e dei Mercati di Traiano alla luce dei recenti restauri, in A. Paribeni (a cura di), Atti del vii Colloquio dell’Associazio-ne Italiana per lo studio e la conservazione del mosaico (Pompei, 22-25 marzo 2000), Ravenna 2001, pp. 565-573.
Vacca 1594 F. Vacca, Memorie di varie antichità trova-te in diversi luoghi della città di Roma scritte nell’anno 1594, in C. Fea, Miscellanea fi-lologica critica e antiquaria i, Roma 1790.
Valori 1985 S. Valori, Disegni di antichità dell’Al-bertina di Vienna, Xenia. Quaderni 6, Roma 1985.
Vanvitelli 2002 Gaspare Vanvitelli e le origini del vedu-tismo, Catalogo della mostra (Roma-Ve-nezia, 2002), Roma 2002.
Venuti 1763 R. Venuti, Accurata, e succinta descri-zione topografica delle antichità di Roma, Roma 1763.
Virlouvet et al. 1993 C. Virlouvet et al. (1993), Palatino, Vigna Barberini, in BA, 23-24, 1993, pp.131-164.
Vitti 2002 M. Vitti, L’uso del marmo nelle pavi-mentazioni dei fori imperiali, in M. De Nuccio, L. Ungaro (a cura di), I marmi colorati della Roma Imperiale, Venezia 2002, pp. 138-141.
Volpe 2000 R. Volpe, Paesaggi urbani tra Oppio e Fagutal, in MEFRA, 112, 2000, pp. 511-556.
Ricci 1998 M. Ricci, Appunti per una storia della produzione e del consumo della cerami-ca da cucina Roma nel medioevo, in E. De Minicis (a cura di), Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e mo-derna, Atti del iii Convegno di Studi (Roma 19-20 aprile 1996), Roma 1998, pp. 34-42.
Ricci 2010 M. Ricci, Catalogo, in M. Ricci, L. Vendittelli, Museo Nazionale Roma-no − Crypta Balbi. Ceramiche medievali e moderne, i, Milano 2010, pp. 25-300.
Rizzo 2003 G. Rizzo, Instrumenta Urbis I. Cera-miche fini da mensa, lucerne ed anfore a Roma nei primi due secoli dell’impero (CollÉfr, 307), Roma 2003.
Romei 2001 D. Romei, Il deposito di ix secolo nell’e-sedra della Cripta Balbi. Ceramica a ve-trina pesante, in Arena et al. 2001, pp. 515-518.
Romeo 1974-1975 P. Romeo, Restauro delle Terme di Traia-no (Anno 1967- 1968), in BCom, lxxxiv, 1974-75, pp. 249-259.
Roethlisberger 1969 M. Roethlisberger, Bartholomäus Breenbergh Handzeichnungen, Berlin 1969.
Roisecco 1745 G. Roisecco (a cura di), Roma antica e moderna o sia nuova descrizione della mo-derna città di Roma, e di tutti gli Edifizij notabili, Roma 1745 (rist. 1750, 1765).
Roma 1994 B. Tellini Santoni, A. Manodo-ri, Roma. Disegno e immagine della cit-tà eterna. Le piante di Roma dal ii secolo d.C. ai giorni nostri, Roma 1994.
Rosazza Ferraris 2006a P. Rosazza Ferraris (a cura di), 1818-1826. Gli anni romani del giovane D’A-zeglio, Catalogo della mostra (Roma, 2005-2006), Roma 2006.
Rosazza Ferraris 2006b P. Rosazza Ferraris, Gli Arsenali della Polveriera Camerale e le vicende dei due appaltatori Basilio Salvi e Vincenzo Nel-li: 1795-1820, in Strenna dei Romanisti, 2006, pp. 553-560.
Rossini 1827-1829 L. Rossini, I sette colli di Roma antica e moderna, [Roma] 1827-1829.
Salza Prina Ricotti E. Salza Prina Ricotti, Giochi e giocat-1995 toli (Vita e costumi dei Romani antichi,
18), Roma 1995. Santangeli Valenzani– R. Santangeli Valenzani, R. Volpe, Volpe 1986 Lo scavo, in A. Capodiferro et al., Am-
bienti tra Via Nova e Clivo Palatino, in BCom, XCI, 2, 1986, pp. 416-422.
Saxl 1947 F. Saxl, Continuity and Variation in the Meaning of Images, in Lectures, Wien 1957 (conferenza del 1947), pp. 1-12.
Scharf 1992 R. Scharf, Der Stadtpraëfekt Iulius Felix Campanianus, in ZPE, 94, pp. 274-278.
Schenk 1705 P. Schenk, Roma aeterna Petri Schenkii, Amsterdam 1705.
Schich 2005 M. Schich, Terme e Basilica di Massen-zio, in Alberti 2005, pp. 274-281.
Schich 2009 M. Schich, Rezeption und Tradierung als Komplexes Netzwerk. Der CENSUS und visuelle Dokumente zu den Thermen in Rom, München 2009.
Schich 2010 M. Schich, Revealing Matrices, in J. Steele, N. Iliinski (eds.), Beautiful Vis-ualization, Sebastopol 2010, pp. 227-254.
Serra 1999 S. Serra, in LTUR iv, Roma 1999, pp. 325-328, s.v. Ss. Silvester et Equitius, ti-tulus.
Settis 1995 G.B. Mercati, Alcune vedute et prospet-tive di luoghi dishabitati di Roma [rist. della versione del 1629 con una introdu-zione di Salvatore Settis], Milano 1995.
Spielmann 1966 H. Spielmann, Andrea Palladio und die Antike. Untersuchung und Katalog der Zeichnungen aus seinem Nachlass, Mün-chen 1966
382 Bibliografia
Volpe–Rossi cds. R. Volpe, F. M. Rossi, Nuovi dati sull’esedra Sud-Ovest delle Terme di Traiano sul Colle Oppio. Percorsi, iscri-zioni dipinte e tempi di costruzione, in S. Camporeale, H. Dessales, A. Piz-zo (éds.), Les chantiers de construction en Italie et dans les provinces romaines. 3e rencontre (Paris, Ecole normale supé-rieure: L’Economie des chantiers, 10-11 décembre 2009), cds.
Wechssler 2000 S. Wechssler, Ernst Fries (1801-1833), Heidelberg 2000.
Yegül 1992 F.K. Yegül, Baths and bathing in clas-sical antiquity, New York-Cambridge, 1995 (1992).
Zamperini 2007 A. Zamperini, Le grottesche. Il sogno del-la pittura nella decorazione parietale, San Giovanni Lupatoto (VE), 2007.
Zevi–Pohl 1970 F. Zevi, I. Pohl, Ostia. Saggi di scavo, in NSc, suppl. xxiv, Roma 1970.
Zevi et al. 2007 F. Zevi, Ostia. Sondaggio stratigrafico di uno degli ambienti della domus dei Pe-sci (1995-1996), in NSc, xv-xvi, 2004-2005, 2007, pp. 21-327.
Zorzi 1959 G. Zorzi, I disegni delle antichità di An-drea Palladio, Venezia 1959.
Zwollo 1973 A. Zwollo, Hollandse en vlamse vedute-schilders te Rome 1675-1725, Assen 1973.
Volpe 2000a R. Volpe, La domus delle Sette Sale, in Aurea Roma. Dalla città pagana alla cit-tà cristiana, Roma 2000, pp. 159-160.
Volpe 2002 R. Volpe, Un antico “giornale di cantie-re” delle Terme di Traiano, in RM, 109, 2002, pp. 377-394.
Volpe 2007 R. Volpe, Le Terme di Traiano e la xu-stic¾ sÚnodoj, in A. Leone, D. Palombi, S. Walker (a cura di), Res bene gestae, Roma 2007, pp. 427-437.
Volpe 2008 R. Volpe, Le giornate di lavoro nelle iscri-zioni dipinte delle Terme di Traiano, in Epigrafia 2006. Atti della xvie rencontre sur l’épigraphie in onore di Silvio Pancie-ra con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori, (Tituli, 9), Roma 2008, pp. 453-466.
Volpe cds. R. Volpe, Organizzazione e tempi di la-voro nel cantiere delle Terme di Traiano sul Colle Oppio, in S. Camporeale, H. Dessales, A. Pizzo (a cura di), Cantie-ri edili dell’Italia e delle Province roma-ne - workshop di Siena: Italia e Province orientali (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 novembre 2008), cds.
Volpe–Parisi 2009 R. Volpe, A. Parisi, Alla ricerca di una scoperta. Felice de Fredis e il ritrovamen-to del Laocoonte, in BCom, cx, 2009, pp. 81-109.