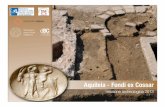Area II, saggio 2 in Aquileia, Fondi ex Cossar - Missione archeologica 2013
La ripresa delle ricerche nell’area archeologica di S. Omobono a Roma
Transcript of La ripresa delle ricerche nell’area archeologica di S. Omobono a Roma
Introduzione
a Sovraintendenza ai Beni Cultura -li di Roma Capitale ha intrapreso,
in collaborazione con l’University ofMichigan e l’Università della Calabria,un programma pluriennale per la prose-cuzione delle ricerche e la valorizzazionedell’area archeologica di S. Omobono apartire dal 2009. Il sito archeologico, giàoggetto di importanti ritrovamenti, nonè ancora adeguatamente indagato nétantomeno valorizzato, sebbene posizio-nato in un’area centrale della città. I pri-mi interventi realizzati nel programmadel progetto sono stati rivolti al recuperoe allo studio dei documenti editi e di ar-chivio, successivamente si è procedutoalla documentazione delle unità strati-grafiche direttamente sul sito e alla siste-mazione e studio dei reperti nei magaz-zini dell’area archeologica. Si è quindiprovveduto ad intervenire con restauri diurgenza su alcune situazioni localizzatee a risolvere problematiche concernentila sicurezza. Per una fruizione miglioredell’area sono stati rimossi la maggior
parte dei ponteggi e delle passerelle e in-terrate, previa documentazione, partedelle cavità che, lasciate aperte dall’epo-ca dei precedenti scavi, costituivano nonsolo elementi di pericolo, ma anche didegrado della stratigrafia. All’esternodell’area di scavo è stato collocato unpannello illustrativo visibile dal pubblicoche transita su via L. Petroselli. Diversiinterventi sul sito hanno dunque portatoad una migliore comprensibilità del-l’area, tra questi è anche il riordino delmateriale lapideo che giaceva in manieradisordinata. Senza la piena conoscenzascientifica del sito è difficile procedere aduna corretta valorizzazione ma è anchefondamentale muoversi in questa dire-zione con tappe intermedie, di pari passocon le ricerche. L’area archeologica pe-raltro, trovandosi ad una quota inferiorerispetto al piano di calpestio moderno, ri-sulta ben visibile dall’esterno almeno suun lato e mezzo del suo perimetro, casoestremamente favorevole. Tali caratte -ristiche non consentono di rimandarenel tempo l’impegno rivolto alla fruizio-ne dell’area. La ricerca sul campo vera e
* Si ringrazia la Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale nella persona del Sovraintendentedott. Umberto Broccoli, senza il quale l’intero progetto non avrebbe avuto inizio, e il dott. Giovanni Carusoindispensabile e costante punto di riferimento. Una sentita gratitudine è rivolta all’architetto Francesco Gio-vanetti. Siamo inoltre grati alla dott.ssa Paola Chini, responsabile dell’Archivio Storico della Sovraintenden-za, per la costante collaborazione.
L
LA RIPRESA DELLE RICERCHE NELL’AREAARCHEOLOGICA DI S. OMOBONO A ROMA*
Paolo Brocato · Anna Maria Ramieri · Nicola TerrenatoIvan Cangemi · Mattia D’Acri · Luca De Luca ·Maurizio Giovagnoli · Geraldine Pizzitutti ·
Carlo Regoli
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 9
10 brocato et alii
propria è iniziata nel maggio 2010 conuna serie di interventi di scavo sulla basedi una prima concessione ministerialeannuale.1
[Paolo Brocato]
La scoperta del sito
«Una grande lacuna esisteva nelle nostreconoscenze di topografia romana perl’area compresa tra la vecchia PiazzaMontanara e Piazza Bocca della Verità…La zona avrebbe conservato forse persempre il suo mistero se non fosse statadecisa la costruzione in essa, sui due latidi via Bocca della Verità, di due grandifabbricati per gli uffici del Governato -rato».2
Così commenta A. M. Colini il risulta-to archeologico più importante dei mas-sicci interventi urbanistici, realizzati apartire dalla fine degli anni Venti del se-colo scorso e che comportarono la di-struzione quasi completa di uno deiquartieri più antichi ed importanti dellacittà, compreso tra il Tevere ed il ColleCapitolino sino alla chiesa di S. Maria inCosmedin.3
All’isolamento del Campidoglio, ini-ziato secondo A. Muñoz nel 1926, si af-fiancò l’apertura della “via del Mare”, ilcui primo tratto terminante all’altezzadella chiesa di S. Nicola in Carcere, fuinaugurato nel 1932, mentre per il suosuccessivo completamento venne ripre-sa ed ampliata la via della Bocca della Ve-rità con la demolizione di tutti gli edificiposti ai suoi lati.4
Nel settore orientale si salvarono dalla“furia liberatrice” soltanto le chiese di S.Giovanni Decollato e di S. Omobono. Laprima si trovava infatti in posizione defi-lata rispetto alla nuova arteria stradale ealle aree destinate alla riedificazione inessa prospicienti, mentre per la seconda– in procinto di essere demolita nella sistemazione delle pendici meridionalidel Colle Capitolino che era ripresa nel19365 – si modificò il progetto urbanisti-co. Si studiò infatti l’inserimento di S.Omobono nella fronte del palazzo desti-nato agli Uffici Tecnici del Comune diRoma e che, insieme a quello dell’Ana-grafe e Tributi, doveva fiancheggiarecon imponenza la via del Mare, l’attualevia L. Petroselli.6
Senonché, dopo le prime scoperte ac-cidentali verificatesi nel corso degli sterridelle fondazioni per il nuovo edificio,vennero “ordinate” dal Governatore7 econdotte da Colini, Ispettore capo deiServizi Archeologici presso la × Riparti-zione, le indagini archeologiche che ri-velarono una vasta area detta “sacra” perla presenza di due templi identificati inseguito con quelli di Fortuna e di MaterMatuta. Sotto la pressione della stampacittadina si decise di interrompere l’atti-vità edificatoria per intraprendere leesplorazioni, destinando “una limitatis-sima zona” al fabbricato ivi previsto(Fig. 1). 8
Intanto nel 1937 la chiesa di S. Omobo-no – di cui era stato demolito sia il cam-
1 Per un primo inquadramento generale e alcu-ni approfondimenti anteriori all’inizio degli scavi siveda Terrenato et alii c.s.
2 Colini 2000, p. 30.3 Ramieri 2011.
4 Muñoz 1932, pp. 35-36; Muñoz 1943, p. 5.5 Muñoz 1943, p. 20.6 Ramieri 2004-2005, p. 4.7 Colini 1938, pp. 279-281.8 La decisione era stata presa nel 1937 nel corso
di un sopralluogo congiunto di G. Q. Giglioli e Mu-ñoz: Colini 2000, p. 85.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 10
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 11
panile a vela sopraelevato sul lato destrodella facciata sia il campanile medievaleriutilizzato come abitazione sul latoorientale dell’abside – appare isolata.Colini e R. Krautheimer ne approfittaro-no per esaminare le murature lateralidella chiesa prima del previsto rivesti-mento in cortina laterizia,1 senza tutta-via la possibilità di attribuire con sicurez-za all’edificio di culto gli esigui restimurari databili al secolo ix.2 Qualchecontributo importante a tal fine sarebbepotuto provenire dalla “zona della fon-dazioni medievali” rinvenute e non ulte-riormente indagate tra S. Omobono,piazza della Consolazione e via di S. Gio-vanni Decollato. Nelle vicinanze e nei
pressi dell’imbocco di via Bucimazza av-venne nel 1937 “un bellissimo trovamen-to di ceramiche medievali” datate al xiv-xv secolo e poste in collegamento conl’ospedale di S. Maria in Portico,3 antica-mente annesso alla chiesa di S. Salvatorein Portico che, ricostruita nel 1482, vennededicata nel 1574 a S. Omobono.4
Ma furono proprio gli interventi di re-stauro ed i lavori di sottofondazione del-l’abside di S. Omobono a portare nelfebbraio 1938 alla scoperta del tempio ar-caico, di cui successive campagne di sca-vo evidenziarono l’importanza eccezio-nale per la storia e la topografia di Romain epoca regia anche attraverso la resti-tuzione di un gran numero di pregevoli
1 Ramieri 2002, p. 566, fig. 2.2 Colini 2000, p. 114; Ramieri 2004-2005, p. 6.
3 Colini 2000, p. 90.4 Ramieri 2004-2005, pp. 20-21.
Fig. 1. La chiesa e l’area sacra di S. Omobono al termine dei lavori di sistemazione.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 11
12 brocato et alii
reperti poi presentati al pubblico in di-verse mostre di successo.1
Attenzione minore hanno avuto le te-stimonianze del periodo postantico: lefondazioni cosiddette medievali venne-ro eliminate per la costruzione del nuo-vo palazzo, mentre i reperti mobili furo-no trasferiti altrove. Entrate a far partedella collezione del Museo di Roma,2 leceramiche provenienti dall’area di S.Omobono sono state oggetto di diversistudi3 ma mancano di una pubblicazio-ne sistematica, peraltro necessaria an-che alla luce delle nuove acquisizioni dimaioliche arcaiche, straordinarie pernumero e per qualità, recuperate negliscavi condotti tra il 1985 ed il 1999 nelprimitivo edificio di culto installato all’interno della cella del tempio B.4
Per sottolineare l’importanza di unasimile ed ormai improcrastinabile inizia-tiva, utile anche per la ricomposizione diun quadro quanto mai ricco della produ-zione romana, si richiama qui una dellescodelle che, insieme ad un numero im-precisato di esemplari simili e provenien-ti dagli scavi del 1985-1992 nell’area sotto-stante la chiesa di S. Omobono, venneroinviati per il restauro al Museo di Roma.L’esemplare (Fig. 2), confrontabile sianel tipo che nel decoro con i frammentirinvenuti più di recente e conservati in situ, ripropone nella forma le scodelledatate al xv secolo, con orlo leggermen-te ripiegato verso l’alto con ampia tesadecorata da tratti verticali paralleli, ca-vetto percorso da una spessa linea on -dulata e il fondo occupato da un motivovegetale.5
Discorso analogo dovrà essere impo-stato per i frammenti scultorei dell’viii eix secolo, attualmente conservati neimagazzini di S. Omobono e con ogniprobabilità provenienti dalla stessa area,il cui interesse è stato riproposto dal ri-trovamento di un frammento triangola-re nel corso dell’indagine all’interno del-la chiesa.6 Finora sono stati inventariatiundici rilievi, tra cui un frammento dicornice con il motivo del tralcio stilizza-to e desinente in un fiore di giglio7 tra-sformato in un elemento a croce rigida-mente disposto all’interno del girale,mentre all’esterno piccole volute si di-spongono negli spazi intervallari (Fig. 3).
La mancanza di notizie di archivio ren-de difficoltoso il censimento dei nume-rosi frammenti altomedievali recuperati
1 Colini 1938, pp. 279-292; Pisani Sartorio1995, pp. 281-285; Colini 2000, pp. 95-108, 143, 164,172-173, 192; Sommella Mura 2000, pp. 7-20.
2 Lio 2010, p. 69.3 Mazzuccato 1968, pp. 37-40; Mazzuccato
1972, pp. 24-25, 32; Mazzuccato 1993, p. 61.4 Giustini 2004-2005, pp. 79-118.
5 Giustini 2004-2005, p. 102, figg. 12-13.6 Ramieri 2004-2005, p. 74, n. 42.7 Sul tipo di decorazione e la sua diffusione nel
secolo ix, cfr. Ramieri 1983, n. 88.
Fig. 2. Museo di Roma.Maiolica arcaica – scodella, xv secolo.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 12
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 13
nel corso delle demolizioni della via delMare1 e ricoverati anche nei fornici delTeatro di Marcello e nei magazzini delMuseo di Roma. Se non sfugge infattil’importanza dei frammenti di suppellet-tile liturgica quali testimonianze, spessouniche, di edifici di culto scomparsi, va ri-badito altresì il loro valore documentarioanche come materiale edilizio e decora-tivo di edifici di epoca medievale demoli-ti nel corso degli sventramenti. È il casoad esempio delle cornici con decorazio-ne a treccia e a girali reimpiegate nella ri-quadratura di una finestra nella torremedievale distrutta in via Bucimazza,2anch’essa soppressa nel percorso paralle-lo e poco distante dall’abside di S. Omo-
bono e ove viene segnalato anche un ora-torio medievale, scomparso insieme allenumerose stratificazioni urbane che diquesta zona attestavano una continuitàdi vita da epoca arcaica.
[Anna Maria Ramieri]
Il riesame dei vecchi scavi
La ripresa delle ricerche nell’area archeo-logica ha da subito imposto la priorità diconoscere e approfondire quanto svoltosul campo nel corso delle indagini pre -cedenti. D’intesa con la Sovraintendenzasi è proceduto a digitalizzare tutti i do -cumenti presenti in archivio e organiz-zarli in modo da facilitarne lo studio.3 Si
1 A tale proposito cfr. Ramieri 2002a, pp. 304-305.2 Per la localizzazione della torre, si veda Lan-
ciani 1893-1901, tav. 28. Cfr. anche Colini 2000, p. 90.
3 Ringrazio la dott.ssa Paola Chini, responsabiledell’archivio della Sovraintendenza, per la collabo-razione e la disponibilità.
Fig. 3. Magazzini di S. Omobono. Frammento di cornice, secolo ix.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 13
14 brocato et alii
è poi proceduto ad una documentazionegenerale del sito e ad un esame prelimi-nare delle evidenze archeologiche, a se-guito delle quali sono stati svolti appro-fondimenti specifici. Sebbene il lavoro dasvolgere sia ancora molto lungo si è pre-
ferito dar conto di questo processo, an-che correndo il rischio di incorrere insuccessive revisioni che possano portarenon solo a precisazioni ma anche, a volte,a modifiche di quanto esposto. Il proces-so di ricostruzione infatti è progressivo e
Fig. 4. Planimetria generale con la localizzazione dei vecchi e dei nuovi saggi.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 14
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 15
soltanto al termine di questo sarà possi-bile restituire una visione complessivache consenta di contestualizzare i dati edi sanare, forse non sempre, possibilicontraddizioni.
Su tutti i settori è già stata svolta unaanalisi preliminare,1 adesso seguita daapprofondimenti realizzati attraversol’assegnazione di tesi di laurea e studispecifici.
Sono qui stati scelti, per ragioni di spa-zio, soltanto tre settori indagati nei pre-cedenti scavi: il settore vi, attualmenteinterrato, il settore viii, rimasto apertodall’epoca degli scavi, e la cosiddetta “ta-berna repubblicana”, sempre ai marginidell’interesse degli studiosi che si sonooccupati dell’area (Fig. 4). La maggiorecomplessità nel lavoro di revisione è nel-la ricomposizione dei contesti di prove-nienza dei reperti. Questi ultimi infattisono stati divisi tra i depositi museali e i
magazzini dell’area archeologica. Allostato attuale è stato possibile ordinare edesaminare soltanto i reperti conservatinei magazzini dell’area archeologica.2
[Paolo Brocato]
3. 1. Il settore vi
Il settore, posto tra l’anta sinistra deltempio B e la fondazione della colonnaanteriore sinistra dello stesso, è stato og-getto di indagine archeologica nel 1964,nel 1979 e nel 1981.3 L’area di scavo hauna forma rettangolare con orienta-mento W-E, le dimensioni del saggio,inizialmente di 5 m × 3,60 m circa vengo-no ridotte più volte durante le operazio-ni di scavo.4
1 Si veda Terrenato et alii c.s.
2 Ringrazio il dott. Graziano Mantiloni per avercoordinato l’organizzazione del magazzino dei re-perti.
3 Per una prima analisi di questi interventi si ve-da Terrenato et alii c.s.
4 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, cc. 4051.67, 211, 232.
Fig. 5. Pianta di scavo del settore vi (asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, c. 4051.53).
Mediterranea_IX_Layout 1 21/08/12 09.36 Pagina 15
16 brocato et alii
Rimosso lo strato superficiale vengo-no individuati: l’anta occidentale deltempio B; i residui di una canalizzazionenella parete S; una fossa di riempimentomedioevale nel lato N; un pozzo e unmuro medioevale nell’angolo N-E delsaggio; infine, viene individuato lo stra-to 1, il cui ingombro corrisponde alla ri-manente superficie del saggio.1 Le evi-denze, sono ben visibili nell’unica piantadettagliata presente nel giornale di sca-vo relativa al settore vi (Fig. 5).2
Le operazioni di scavo continuano conlo scavo parziale del pozzo medievale edella c.d. fossa medioevale, il materialeproveniente da tali riempimenti risultaessere prevalentemente di ceramica me-dievale.3
Nei giorni seguenti, invece di ultima-re lo scavo delle evidenze poste nellaparte N del saggio, si iniziano ad aspor-tare lo strato 1 e lo strato 2. Individuatolo strato 3, composto da terreno carbo-nioso con nuclei di argilla, nell’angolo S-E si nota uno “scasso” negli strati 2 e 3 perla messa in opera della canalizzazione.4
Si continuano a scavare lo strato 3, lafossa ed il pozzo, raggiungendo la quotadi 2,35 m dalla quota base. A questa quo-ta viene identificato lo strato 4, con ca-ratteristiche analoghe a quelle dellostrato 3. Il riempimento del pozzo siesaurisce a quota 3,38 m dalla quota ba-se. Si inizia lo scavo dello strato 5 com-posto da sabbia giallastra mista ad argil-la. Lo strato 6 è composto da sabbia congrossi ciottoli, il materiale ceramicomaggiormente attestato è la ceramica
d’impasto così come negli strati superio-ri. A quota 3,95 – 4 m circa viene segna-lata la presenza di acqua.5
Si decide di restringere l’area di scavo,pertanto le indagini si concentrano sol-tanto su circa un terzo della superficietotale a partire dalla parete W, la nuovaarea forma un rettangolo con l’orienta-mento dei lati lunghi N-S.6 Lo strato cor-rispondente al xii filare viene denomi-nato strato 7, si differenzia dallo stratoprecedente per la maggiore presenza diargilla. Si raggiunge la quota di 5,60 m,a questa quota termina la campagna discavo.7
Le ricerche riprendono nel 1979. Loscavo si concentra sulla parte risparmia-ta nel 1964. Asportati i residui dello stra-to 6, si scava il successivo strato 7, ridu-cendo a metà l’area di scavo. Si scava poilo strato 8, differente per la consistenza.A questo punto si decide di ridurre ulte-riormente lo scavo e si raggiunge lo stra-to 9. Terminano quindi le operazioni discavo.8
La campagna del 1981 è finalizzata adultimare lo scavo nel settore. I lavori ini-ziano con lo scavo di una buca per l’al-loggiamento della pompa idraulica, siprocede quindi allo scavo vero e proprioanche se è da evidenziare, per i primigiorni, una nuova denominazione deglistrati incontrati a causa dello smarri-mento del giornale di scavo.9
1 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, cc. 4051.50, 52.2 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, c. 4051.53.3 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, cc. 4051.52, 53.4 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, cc. 4051.53, 54.
5 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, cc. 4051.65, 66.6 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, c. 4051.67.7 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, cc. 4051.68, 69.
Per un riepilogo della stratigrafia messa in luce nellacampagna si veda anche asrcm, S. Omobono, b. 31,5, c. 4051.81.
8 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, cc. 4051.209, 215.9 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, c. 4051.230. La re-
dazione a tratti confusa delle pagine relativa al gior-nale di scavo del 1981, unita alla nuova denomina-
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 16
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 17Le indagini si concentrano a partire
dalla parete E del settore: vengono a -sportati gli strati vi a e vi b e si ricono-sce una sottile lente composta da scagliedi cappellaccio, denominata strato 7a. Acirca 50 cm dall’ultimo filare della fon -dazione della colonna del tempio B, sul-lo strato 8, si evidenzia l’impronta di unblocco, che, secondo l’opinione deglistudiosi «sembra corrispondere ad unodei blocchi della fondazione».1 Con lacartoccia infine si preleva la terra prove-niente dalla buca realizzata per alloggia-re la pompa idraulica (strato 9), la terraè composta da materiale tufaceo anneri-to. Il settore viene quindi interrato.2
La sequenza stratigrafica, per quantoriguarda le fasi più tarde è interessatadalla presenza del muro, del pozzo e dal-la fossa. Quest’ultima sembra essere ta-gliata dalle fosse relative al muro e alpozzo. Il rapporto tra il muro e il pozzoè meno chiaro, molto probabilmentevanno considerati parte di un’unica atti-vità costruttiva.
Lo strato 1 è interpretabile come un ri-porto tardo considerando anche i mate-riali rinvenuti, forse in fase con il pozzoe il muro. Tra gli strati 2 e 3 si nota unafondazione per l’alloggiamento della
struttura idrica costruita in blocchi di tu-fo sagomati ad “U”,3 che taglia gli stratimenzionati. Gli strati 2 e 3 sono inter-pretabili come riporti per l’innalzamen-to dell’area per la costruzione del gran-de podio di età repubblicana. Lo strato 3restituisce perlopiù ceramica d’impastoma sono anche attestati frammenti cera-mici più tardi, che sono però da ritenersiintrusioni di strati più recenti.4
Anche gli strati 4, 5, 6 e 7 possono esse-re interpretati come colmate per l’innal-zamento del livello dell’area, nonostantepresentino tra loro alcune differenze.Nella sezione edita del settore sono pre-senti delle sottili lenti di scaglie di cappel-laccio, nello specifico tra le interfacce degli strati 4 e 5, queste possono far ipo-tizzare la presenza di piani di lavoro in-termedi utilizzati per la lavorazione e lamessa in opera dei blocchi di cappellac-cio. I materiali provenienti dagli strati 4,5, 6, e 7 non sembrano essere posteriorialla fine del vi sec. a.C.5 Lo strato 8 puòessere interpretato come strato alluvio-nale, per la composizione e la scarsa pre-senza di materiale ceramico, e può esse-re datato non oltre la fine del vi sec. a.C.I tufi anneriti provenienti dallo strato 9dovevano essere pertinenti al tempio arcaico.6
zione degli strati (ad esempio è il caso dello strato 7,nei giorni durante il quale non era disponibile ilgiornale di scavo fu denominato strato “vi a1” enello stesso tempo “vi a2”), ha reso più difficoltosala ricostruzione delle operazioni di scavo.
1 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, cc. 4051.230-233.Le impronte sono anche visibili nell’unica sezioneedita del settore per la quale si rimanda a Roma1989, tav. ii.
2 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, cc. 4051.234-235,237-238. Per una sezione riepilogativa non in scaladella campagna del 1981 si veda asrcm, S. Omobo-no, b. 31, 5, cc. 4051.229.
3 La definizione della composizione della strut-tura idrica è presente in Ioppolo 2000, p. 174.
4 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, cc. 4051.73.5 Escluse alcune intrusioni presenti nello strato
4 di cui restano valide le motivazioni riportate perlo strato 3.
6 Per quanto riguarda la composizione deglistrati 8 ed 8a si registra una chiara contraddizionetra le pagine del diario del 1979 e quelle del 1981: nel1979 lo strato di argilla gialla copre lo strato di argil-la grigia, mentre, nella campagna successiva è lostrato di argilla grigia a coprire lo strato compostoda argilla gialla.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 17
18 brocato et alii
3. 2. Alcuni reperti dallo strato 7
1) Balsamario ionico (n. inv. vi/135-136;Roma, deposito di S. Omobono)
Quasi integro, mancante della sola te-sta, ricomposto da due frammenti. Figu-ra di banchettante vestito di chitone,con capigliatura a trecce ricadenti sulpetto. Distesa su kline con il braccio sini-stro flesso e in mano un rhyton e il brac-cio destro adagiato lungo il corpo diste-so. Argilla di colore rosso chiaro (2.5yr6/6 light red) con frequenti inclusionimicacee; sono inoltre visibili tracce dicolore bruno (2.5yr 3/4 dark reddishbrown). Lunghezza max 12,6 cm; lar-ghezza max 2,7 cm; altezza max 6,7 cm.Un confronto puntuale proviene daGravisca,1 altri esemplari di bronzo pro-vengono invece da Samo.2 Datazionetra il 550 e il 530 a.C. (Fig. 6).
2) Antefissa frammentaria (n. inv.vi/134, Roma, deposito di S. Omobo-no). Si conserva parte di un volto uma-no di cui è visibile l’occhio destro e partedella capigliatura. Impasto chiaro sab-bioso con frequenti inclusioni augitiche.L’argilla è di colore marrone chiaro(10YR 8/2 very pale brown); presentatracce di pittura di colore scuro (10yr3/2 very dark grayish brown) e lievi tracce di colore rosa (5yr 7/4 pink). Lun-ghezza max 9,5 cm, larghezza max 3,4cm, altezza max 5,8 cm. Lo stato fram-mentario non consente confronti puntuali, tuttavia può essere avvicinataad un esemplare proveniente da Cerve-teri,3 il tipo di capigliatura genericamen-te ricorda anche un’antefissa da Velletri(Fig. 7).4
[Mattia D’Acri]
1 Boldrini 1994, p. 60, fig. 87.2 Baughan 2011, p. 28, figg. 17-18. Per ulteriori
studi sui simposiasti ionici scolpiti o presenti nellacoroplastica o nella toreutica si veda ivi, pp. 19-53 eDentzer 1982.
3 Cristofani 1992, tav. iii.b31.1, antefissa, tipo ii.4 Andrén 1939, pl. 129.I:9, per il catalogo del-
l’ultimo cfr. citato si veda Andrén 1940, pp. 413-414.
Fig. 6. Parte di balsamario ionico (settore vi, strato 7).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 18
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 19
3. 3. Il settore viii
Nel 1976 si decise di esplorare un piccolosaggio situato tra le due colonne frontalidel tempio B, in corrispondenza del pi-lone di fondazione della colonna occi-dentale, in un punto in cui i blocchi ditufo di Grotta Oscura dello stilobate set-tentrionale risultavano mancanti.1 Siidentificava quindi un’area di scavo ret-tangolare, con orientamento nord-sud,estesa per m 1,90 × 1,14. Altri due inter-
venti, condotti nel corso degli anni 1981e 1985, hanno ampliato il saggio versoest, fino ad interessare l’intera area com-presa tra le due colonne: gli ampliamen-ti furono denominati viiia e viiib.2
Durante lo scavo del 1976, dopol’asportazione di un sottile strato super-ficiale, si individua lo strato 13 tagliatodalla canalizzazione realizzata con bloc-chi di tufo sagomati a ‘U’, poggianti su
1 Per una prima analisi degli interventi di scavoin questo settore si veda Terrenato et alii c.s.
2 In realtà viiib è un approfondimento di viiia,ma si è deciso di utilizzare una diversa denomina-zione per distinguere le operazioni di scavo del 1981da quelle del 1985.
3 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, c. 4051.121.
Fig. 7. Parte di antefissa a testa umana (settore vi, strato 7).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 19
20 brocato et alii
lastre di cappellaccio.1 Al di sotto dellostrato 1, si trovano, in successione, lostrato 2 – caratterizzato da terra fine – elo strato 3 – di colore marrone e ricco diinclusi organici.
Le indagini riprendono nel 1981 con lacreazione di un ampliamento definitoviiia, separato dal precedente saggiotramite un testimone di terra. L’area discavo risultante misura circa m 2,70 ×1,75. Per una migliore comprensione del-le relazioni tra le unità stratigrafiche,l’architetto G. Ioppolo mette a punto unsistema di definizione degli strati identi-ficandoli con un numero e un prefissoche ne chiarisce la natura.2 Si decide di
dividere il saggio in due metà: in unaparte si effettua lo scavo, nell’altra si la-scia un testimone di terra per verificareche le operazioni di scavo si svolgano inmaniera corretta.
Si identifica quindi lo strato R1, com-posto da terra mista ad argilla conschegge di tufo rosso, peperino e traver-tino: lo strato viene asportato intera-mente nella parte settentrionale del sag-gio, fino alla comparsa di un battuto discaglie di tufo rosso definito DA2.3 Neltestimone di terra lasciata nella partemeridionale, però, si identifica un sottilestrato di argilla posto tra R1 e DA2, cheviene denominato DA1 (Fig. 8). Sullasuperficie di DA2, in posizione centrale,si individua una fossetta riempita da ar-gilla gialla. Coperto da DA2, è uno stra-to caratterizzato dalla frequente presen-za di scaglie di peperino e cappellaccio,
1 Per la canalizzazione si veda Ioppolo 1998.2 Si stabiliscono le seguenti abbreviazioni: S o
ST, strato archeologicamente sterile; R o RP, ripor-to; C o CR crollo; I o INC, incendio; DN, depositonaturale; DA, deposito artificiale (asrcm, S. Omo-bono, b. 31, 5, c. 4051.241 e 264). Inoltre un numerotra parentesi identifica la posizione dello strato nel-la sequenza stratigrafica.
3 Corrisponde, insieme a DA1 e DA3, allo strato1 del 1976.
Fig. 8. Sezione di scavo del settore viii.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.52 Pagina 20
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 21miste a terreno argilloso; viene definitoDA3 (Fig. 8, nella figura lo strato corri-sponde a quello siglato DA2/b). Lo stra-to in questione è molto sottile, infatti siregistra subito un evidente cambiamen-to nella composizione della terra, orapiù ricca di materiale ceramico, repertiosteologici e grossi ciottoli. Il nuovostrato viene definito R2.1 Inoltre, nelcorso della campagna, è stata osservataanche la fossa di fondazione del canalein tufo, che taglia gli strati DA1, DA2,DA3 ed R2 (Fig. 8).
Nel 1985, come già detto, continua loscavo del settore viiia, denominato oraviiib, dal punto in cui si era arrestatonella precedente campagna, ossia allaquota di 11,52 m s.l.m. È doveroso ricor-dare che “nell’ambito di ogni strato vie-ne adottata una sottodefinizione al finedi distinguere le varie lenti costituenti lostrato stesso. Ex. RP2/02 = riporto 2,sabbioso terroso”.2 Si decide, anche inquesto caso di dividere il settore in dueparti: la parte est verrà scavata; la parteovest sarà risparmiata.
Lo scavo inizia dallo strato R2, identi -ficato nel 1981, dal quale si distinguonodue lenti (RP2/01 ed RP2/02).3 Si identi-fica poi RP2/03, caratterizzato da terre-no sabbioso con nuclei di argilla e di ter-reno organico. A questo punto si inizia adasportare RP2/03, nonostante RP2/02sia ancora presente nella parte sud delsaggio. Livellata la superficie dello scavo,si riprende l’asportazione di RP2/03, aldi sotto del quale “riaffiora lo stratoRP2/02”.4 Al di sotto si trova uno stra to
compatto con frequenti ciottoli di fiumee blocchetti di tufo, definito RP2/04.
Una nuova lente, costituita da terrenosabbioso con nuclei di argilla e di carbo-ne e grandi frammenti di tufo, viene de-finita RP2/05. Al di sotto di essa si iden-tificano in successione RP2/06 – stratosabbioso con massiccia presenza di ciot-toli – RP2/07 – caratterizzato da matriceargillosa con ciottoli – ed RP2/08 – co-stituito da terra mista ad argilla con mi-nute scagli di peperino. Lo scavo si inter-rompe alla quota di 10.075 m s.l.m. per lapresenza della falda acquifera.
Una ricostruzione puntuale della stra-tigrafia del settore è assai ardua vista lapovertà e, soprattutto, la contradditto-rietà della documentazione archeologi-ca. Tra l’altro, la scelta di indagare un pic-colo saggio ampliato molti anni dopo, edi lasciare cospicui risparmi di terreno,con il rischio di infiltrazioni di materiali,genera dubbi sull’effettiva affidabilità deldato archeologico. Inoltre, per quanto ri-guarda la campagna di scavo del 1985, èevidente un utilizzo non corretto del me-todo stratigrafico che ha fortemente pre-giudicato la possibilità di comprensioneed interpretazione di quanto indagato.
Gli scavi precedenti non hanno rag-giunto gli strati di vita e distruzione deltempio arcaico, perciò le unità stratigra-fiche più antiche documentate sonoquelle relative all’innalzamento del livel-lo dell’area all’epoca della costruzionedei templi gemelli. Al di sopra dellagrande colmata si sono rinvenuti tre bat-tuti molto compatti (DA1, DA2, DA3),forse di preparazione per la deposizionedi un piano pavimentale in lastre di cap-pellaccio – il quale è ancora visibile al-l’interno della sezione meridionale delsaggio ed al di sotto dello stilobate in
1 Corrisponde allo strato 2 del 1976.2 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, c. 4051.264.3 La denominazione R2 viene sostituita da RP2.4 asrcm, S. Omobono, b. 31, 5, c. 4051.267.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 21
22 brocato et alii
tufo di Grotta Oscura ad est ed ovest –databile, in base ai precedenti studi, alprincipio del v sec. a.C.1
È improbabile che la canalizzazione ablocchi di tufo sagomati ad ‘U’ sia in fase
con questa pavimentazione, in quanto ilcanale stesso, in origine, era coperto dauna lastra piana di tufo, la quale si trove-rebbe alla stessa quota del piano pavi-mentale in cappellaccio.2 È ipotizzabile,
1 Pisani Sartorio 1989, p. 13. 2 Ioppolo 1998, p. 174.
Fig. 9. Pianta dell’angolo sud-ovest dell’area sacra, con al centro la cosiddetta“taberna repubblicana”.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 22
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 23di conseguenza, che il sistema idrico ap-partenga ad una sistemazione successivadell’area templare. Inoltre, nei pressi delsettore in questione, a sud dello stiloba-te, si può osservare che, in corrisponden-za di tutto il canale superstite, le lastrepavimentali di cappellaccio sono semprestate rimosse: questo dato potrebbe es-sere un’ulteriore conferma dell’anterio-rità del pavimento rispetto al canale.
[Luca De Luca]
3. 4. La “taberna repubblicana”
Nell’angolo sud-ovest dell’area sacra,immediatamente a sud del podio deitempli gemelli, si trova un ambiente ret-tangolare denominato nel corso dellevecchie campagne di scavo “taberna re-pubblicana” (Fig. 9). La struttura è com-posta da una pavimentazione a cubettilaterizi delimitata da tre muri di blocchisquadrati di tufo di Grotta Oscura, pur-troppo scarsamente conservati. La stra-tigrafia pertinente alle fasi di vita e abbandono dell’ambiente non è più con-servata, essendo stata asportata durantegli scavi degli anni Trenta e degli anniSessanta-Settanta. Sulla base della docu-mentazione disponibile, non è possibileinquadrare tali interventi nel contestodelle ricerche generali condotte nel-l’area sacra.1
Questi fattori rendono particolar-mente importante una lettura accuratadella documentazione relativa alle ricer-che condotte in quest’area del sito, cheperaltro si approfondirono notevolmen-te sotto il livello del pavimento a cubetti,fornendo significativi dati sulle fasi di vi-ta dell’area sacra. Nonostante i lavorinon raggiunsero i livelli arcaici, i datiraccolti costituiscono, insieme a quellipertinenti al Settore vii-ix, gli unici rela-tivi alla sequenza stratigrafica al di fuoridel podio dei templi gemelli.
In questa sede si propone una letturadei risultati delle ricerche condottenell’area, che non furono mai pubblica-ti. Purtroppo, la documentazione d’ar-chivio risulta incompleta e non sistema-tica, come lo è anche per la maggiorparte degli interventi condotti nel restodel sito. La ricostruzione del caratteredei lavori e l’interpretazione della se-quenza stratigrafica dell’area qui propo-ste sono quindi da intendersi come con-tributi preliminari in attesa di un nuovostudio delle stratigrafie murarie sulcampo, possibilmente in congiunzionecon interventi mirati di pulizia e scavo.
I primi documenti pertinenti ai lavoricondotti presso la struttura consistono indue foto datate 26 settembre 1962, nonaccompagnate da appunti o descrizioni,che documentano un saggio di scavolungo la parete ovest dell’ambiente, sulfondo del quale era esposta la pavimen-tazione a cubetti laterizi.2 Di questa fasedei lavori non si dispone di altre informa-zioni. La documentazione riprende con
1 L’unica indicazione in questo senso è fornitada vari schizzi con brevi appunti, purtroppo non da-tati, che indicano che almeno in alcune fasi le ope-razioni di scavo presso la cosiddetta taberna furonomotivate dal bisogno di contestualizzare la ricca se-quenza di strutture murarie sovrapposte nei pressidell’ambiente con i dati di scavo (asrcm, S. Omobo-no, b. 28, 5, cc. 3041-3042a; b. 29, 7, c. 3518). In parti-colare, su 3041, uno schizzo delle strutture a estdell’ambiente, appare l’annotazione «Sezione ac-canto alla taberna. È molto importante per lo stu-
dio specialmente dopo lo scavo delle aree sui due la-ti». Le citazioni dirette dagli appunti di scavo vengo-no qui riprodotte verbatim.
2 asrcm, S. Omobono, b. 29, 7, cc. 3494 e 3503.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 23
24 brocato et alii
degli appunti datati 3 luglio 1968, che ri-guardano una pulizia generale e ricogni-zione nell’angolo sud-est dell’area sacravolte a documentare «ambienti e struttu-re già individuate negli scavi preceden-ti»”.1 Come dimostra una foto dell’areapulita prima delle operazioni di scavo del1968, il pavimento a cubetti laterizi risul-tava allora completamente coperto dauno strato uniforme con superficie oriz-zontale; sembra comunque individua -bile il riempimento della trincea di sca-vo del 1962 lungo la parete ovest.2
La documentazione disponibile noncontiene altre informazioni pertinenti ailavori del 1962 o ad altre operazioni pre-liminari del 1968, a parte un breve cata-logo dei materiali rinvenuti nel 1968 inun quaderno di appunti del 1972.3 Seguequindi una presentazione dei lavori con-dotti da M. L. Morricone e G. Sartorionel 1969 e 1972, che sono documentati inmodo più dettagliato in due quaderni diappunti.4
Lo scavo del 1969 ha inizio il 14 lugliocon l’asportazione di un risparmio la-sciato sopra il pavimento a cubetti late-rizi nel corso di lavori condotti nel set-tembre-ottobre 1968, dei quali non sidispone di documentazione. Gli appuntirivelano solo che il risparmio (ca. 23 cmin spessore) sembrava appartenere adun unico strato con tracce di bruciaturae che la quota della superficie superiorecorrispondeva approssimativamente aquella di un pavimento “di graniglia dimarmo” visibile in sezione presso l’an-
golo sud-est dell’ambiente.5 Questasommaria descrizione, insieme a unabreve lista dei materiali rinvenuti, costi-tuisce l’unica fonte di informazioni suquesti due strati e l’unico punto di ap-poggio per proporre un terminus antequem per il pavimento a cubetti laterizi.Purtroppo, la descrizione dei materiali ètroppo generica, e una proposta crono-logica dovrà quindi attendere uno stu-dio dettagliato dei materiali pertinenticonservati nel magazzino.
Il 17 luglio viene rimossa una notevoleporzione del pavimento a cubetti late -rizi nell’angolo nord-ovest della struttu-ra.6 Gli appunti includono una breve de-scrizione del pavimento: «Il pavimento acubetti laterizi è formato nel seguentemodo: i cubetti laterizi, le cui misure va-riano da cm 4 × 4 × 3 a cm 4 × 2 × 2 circa,furono annegati in un letto di cocciope-sto piuttosto fine (h. cm 6/4) – questococciopesto aderisce perfettamente adun pavimento a blocchi di tufo (Monte-verde?) che presenta il piano superiorescalpellato. Su questo piano a blocchi ditufo poggiano i muri a blocchi di tufo diGrottaoscura che delimitano l’ambien-te. Il pav. a cubetti è legato alle pareti del-l’ambiente per mezzo di un “codolo” dicocciopesto che presenta una sezione aquarto di cerchio».7
Successivamente, vengono rimossedue delle lastre di tufo di Monteverdesulle quali aderiva il pavimento a cubettilaterizi, la prima sul limite nord-ovestdell’ambiente e la seconda, contigua, inposizione centrale.8 Lo strato sottostan-
1 asrcm, S. Omobono, b. 29, 7, c. 3506-3507.2 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c. 16361.41.3 asrcm, S. Omobono, b. 70, 2.4 1969: asrcm, S. Omobono, b. 70, 5 (M. L. Mor-
ricone e G. Sartorio); 1972: asrcm, S. Omobono, b.70, 2 (M. L. Morricone).
5 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c. 16361.39.6 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c. 16361.42.7 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, cc. 16361.43-44.8 L’esatta sequenza di questo lavoro di smantel-
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 24
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 25
te (strato i) viene scavato in tre parti, co-minciando con la rimozione di una por-zione a nord del pavimento a cubetti,che non era coperta dalle lastre di tufodi Monteverde, per poi proseguire conlo scavo in sequenza delle due porzionial di sotto delle lastre rimosse (Fig. 10).1Dalle brevi descrizioni delle tre porzioniindagate, si desume che lo strato, di cir-ca 20 cm di spessore, era composto di“terra” argillosa marrone con numerosiinclusi carboniosi, e che alcuni fram-
menti delle lastre rimosse presentavanotracce di bruciatura.2 Al di sotto dellaseconda lastra vengono documentatidue blocchi informi di tufo (indicativa-mente identificato come tufo di GrottaOscura).3
Lo strato di “terra” argillosa coprivauno strato uniforme di ghiaia (strato ii),del quale viene asportato solo un picco-lo “campione” rettangolare lungo il li-mite nord della struttura in data impre-cisata.4 La superficie di questo strato,descritta come ondulata e irregolare,era probabilmente stata intaccata du-rante lo scavo dello strato superiore.5
Dopo una breve interruzione, dietroincoraggiamento di Colini, lo scavo
lamento non risulta chiara dagli appunti; di certo idue blocchi vengono asportati tra il 17 e il 21 luglio;asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, cc. 16361.44, 50, e 52.
1 Negli appunti, l’assenza dei blocchi di tufo diMonteverde a nord dell’ambiente viene attribuita alriutilizzo dell’area in epoca post-antica: «Il tratto diterreno scavato non appare, sul lato Nord dell’am-biente in questione, sigillato dai blocchi, asportatiprobabilmente all’atto della costruzione della canti-na moderna, se non prima» (asrcm, S. Omobono,b. 70, 5, c. 16361.45).
2 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, cc. 16361.45-57.3 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c. 16361.53.4 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, cc. 16361.87 e 92.5 Tra gli inclusi dello strato i sono indicati “Mol-
ti ciottoli e ghiaia”; asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c.16361.47.
Fig. 10. Sezione della parete nord del saggio del 1969, scala 1:25(asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c. 16361.33).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 25
26 brocato et alii
dell’ambiente viene ripreso il 29 settem-bre 1969 da G. Sartorio.1 La ripresa deilavori ha come obiettivo la documenta-zione degli strati al di sotto della super-ficie di ghiaia, ma si decide di restringerel’area indagata a un piccolo saggio ret-tangolare a nord della sezione asportatadello strato ii (i.e., al di fuori del limiteoriginario del pavimento a cubetti); ilsaggio si estende per l’intera larghezzadella taberna, a eccezione di un piccolorisparmio sul lato orientale.2 Lo stratoiii, composto di argilla giallastra com-patta con inclusi carboniosi e ricco dimateriali, viene scavato per uno spesso-re di 15-17 cm, finché viene individuatoin sezione un quarto strato, di argillagrigia.3
Il 30 luglio, prima di asportare lo stra-to iv, il saggio viene allargato tramite larimozione del risparmio sul limite estdell’ambiente (effettuata senza distin-guere gli strati costituenti).4 Segue loscavo dello strato iv, con numerosi in-clusi carboniosi e di argilla gialla e unospessore di 20 cm.5 Lo strato sottostan-te, di “terra” argillosa grigia meno com-
patta (“terreno […] abbastanza sciolto”)con numerosi frammenti di tegole escarsi inclusi carboniosi, viene asportatol’1 settembre per una profondità di 25cm.6 Data la sua superficie regolare (“laterra argillosa [dello strato iv] infatti sistaccava a zolle”), lo strato v viene iden-tificato indicativamente come un “pia-no”.7 Lo scavo dello strato, consideratonon terminato, viene ripreso il 4 settem-bre per un’ulteriore profondità di 13-15cm. Tuttavia, in base a un notevole au-mento di materiali, viene distinto un ul-teriore strato (strato vi).8 Oltre a scagliedi tufo di Fidene e cappellaccio, questostrato, come il precedente, presentavascarsi inclusi carboniosi, ma i frammentidi tegole recavano tracce di bruciatura.9Un breve catalogo dei materiali riportavari attacchi tra frammenti ceramici de-gli strati v e vi.10
Quattro foto – due datate generica-mente ottobre 1969 e due gennaio 1970 –documentano un approfondimento e al-largamento del saggio che aveva interes-sato lo strato ii, tra il pavimento a cubet-ti laterizi (che appare restaurato o incorso di restauro in una delle foto del1970) e il saggio effettuato a partire dal30 luglio 1969 (Fig. 11).11 Altre foto conbrevi descrizioni incluse nel quadernodel 1969 documentano i risultati di lavoridi pulizia e di scavo intorno alla struttu-
1 Per la direttiva di Colini, v. asrcm, S. Omobo-no, b. 70, 5, c. 16361.89; per la ripresa dei lavori, asr-cm, S. Omobono, b. 70, 5, c. 16361.92.
2 Da una foto (asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c.16361.91) si osserva che questo approfondimentoera separato dalla porzione asportata dello strato iida tre frammenti di pietra (presumibilmente tufo)di forma irregolare disposti verticalmente al di sot-to del le lastre di tufo di Monteverde; questi fram-menti non sono descritti o altrimenti discussi negliappunti.
3 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c. 16361.92; ladifferenza in colore tra i due strati viene attribuitaindicativamente alla presenza nello strato iv di“una maggiore percentuale di elementi vegetalibruciati”.
4 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c. 16361.97.5 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c. 16361.101.
06 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c. 16361.105.07 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c. 16361.101.08 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, cc. 16361.109-110.19 Ibidem.10 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, cc. 16361.110-
16361.112.11 1969: asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c. 16361.115;
1970: asrcm, S. Omobono, b. 70, 4, cc. 16323 e 16325;nella pianta di G. Sartorio del 1970, il pavimento acubetti è rappresentato nella sua estensione primadel restauro (cfr. Fig. 1).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 26
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 27ra.1 Queste operazioni, alcune di note-vole importanza, non sono altrimentidescritte o documentate, rendendo piùdifficile una lettura comprensiva delcontesto stratigrafico e strutturale del-l’ambiente. A questo punto, le operazio-ni di scavo e studio sistematiche nel-l’area sembrano essersi interrotte fino al1972, anno a cui risale un quaderno diappunti di M. L. Morricone. Il 23 giugnoviene recuperato del materiale nell’an-golo sud-est della taberna, presso unaporzione conservata del “pavimento digraniglia” (identificato non come dimarmo ma come “pavimento di grani-glia bianca [travertino]”),2 e si osservanel processo la presenza di uno strato di“stucco” steso su uno dei blocchi diGrotta Oscura della parete orientale dell’ambiente.3 Questo prelievo non si-stematico di materiali prosegue nellesettimane seguenti. L’11 luglio, due“boccaletti” vengono recuperati da unsaggio a est della taberna, non descrittoin dettaglio.4 Il 27 luglio, altro materialeviene prelevato dal risparmio al di sottodella porzione conservata del cosiddettopavimento di graniglia: “si è eseguital’operazione “cuci e scuci” cioè si è pre-levata la terra rimasta sotto il pav. di gra-niglia bianca, tra questo e il pavimento acubetti, rinforzando via via con matto-ni”.5 I lavori nell’area terminano su que-sta nota. Anche se questo secondo qua-
derno di appunti non contiene informa-zioni importanti sulla stratigrafia neipressi della struttura, conserva un im-portantissimo – anche se sommario – in-ventario dei materiali recuperati nel1968, 1969 e 1972.
Oltre allo strato al di sopra del pavi-mento a cubetti, asportato a più ripresein modo non sistematico, negando quin-di l’affidabilità dei dati raccolti, la stra -tigrafia esaminata sembra includere cinque unità. Questa sequenza apparecaratterizzata da quattro colmate di livel-lamento del terreno (strati i, iii, iv, v evi; gli ultimi due, distinti in base all’au-mento del materiale a c. 25 cm di profon-dità dalla superficie dello strato v, in tutta
1 asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, cc. 16361.80-85;una di queste (asrcm, S. Omobono, b. 70, 5, c.16361.83), in particolare, mostra una piccola porzio-ne di una “pavimentazione a blocchi di cappellac-cio” sul fondo di un saggio di difficile collocazione.
2 asrcm, S. Omobono, b. 70, 2, c. 16311.1.3 Ibidem.4 asrcm, S. Omobono, b. 70, 2, c. 16311.3.5 Ibidem.
Fig. 11. Saggi di scavo sul limite norddell’ambiente, fotografati da est
(asrcm, S. Omobono, b. 70, 4, c. 16323).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 27
28 brocato et alii
probabilità rappresentano un’unica uni-tà stratigrafica, come dimostrato dalla si-mile composizione e dalla presenza di at-tacchi tra frammenti ceramici). Una diqueste colmate (strati v e vi), caratteriz-zata da una superficie regolare, può forseessere interpretata insieme allo strato IIcome un piano di calpestio, possibilmen-te relativo ad attività di cantiere.
La determinazione dei parametri cro-nologici di questa sequenza è purtroppopreclusa in questa fase dalla difficoltà nelraccordare i numeri di inventario fornitinegli appunti del 1972 con i materialiconservati nel magazzino, che in molticasi non contengono indicazioni strati-grafiche o risultano rimescolati. Inoltre,le descrizioni dei materiali rinvenuti ne-gli strati iii, iv, v e vi negli appunti del1969 – le più dettagliate tra la documen-tazione disponibile – risultano comun-que incomplete; gli schizzi che accom-pagnano le descrizioni di alcuni deiframmenti non sono utilizzabili dal pun-to di vista tipologico se non in modo as-solutamente generico. La stratigrafiastrutturale risulta altrettanto problema-tica. Le tracce di bruciatura documenta-te su alcune delle lastre di tufo sul qualeaderiva il pavimento a cubetti sembre-rebbe indicare che questi due elementiappartengano a fasi di vita diverse del-l’area.1 Il rapporto tra i muri dell’am-biente e il pavimento a cubetti non è necessariamente di contemporaneità,come presunto dagli scavatori. In alcunipunti, i blocchetti del pavimento appaio-no tagliati in corrispondenza dei blocchidi tufo di Grotta Oscura delle pareti. Ciòpotrebbe indicare che un precedente pa-vimento fu tagliato per adagiare i bloc-
chi che delimitano la struttura, ma que-sta possibilità va verificata tramite unapulizia accurata di tutta l’area.2 In ognicaso, il pavimento a cubetti trova con-fronti tipologici databili tra il ii e il i sec.a.C.3 Tuttavia, come osserva A. M. Ra-mieri in un recente contributo, tale data-zione è resa problematica dal rinveni-mento di una notevole quantità dicubetti di cotto erratici all’interno distrati datati al iii sec. a.C. nei saggi con-dotti nel 1961-1962 tra i due altari deitempli gemelli.4
È interessante osservare che la scali-nata frontale di accesso al podio dei tem-pli gemelli in lastre di travertino e il ba-solato antistante, entrambi attribuibilialla ristrutturazione dell’area sacra inepoca imperiale, rispettano i muri dellastruttura. Se il pavimento a cubetti e imuri dell’ambiente risultassero esserecontemporanei, questo fatto indiche-rebbe che l’utilizzo di quest’ultimo siestese perlomeno fino alla ristruttura-zione; altrimenti, l’aggiunta dei muripotrebbe essere connessa alla ristruttu-razione stessa.5 Il cosiddetto “pavimen-to di graniglia” – la porzione conservatadel quale si estende al di sopra del primofilare di blocchi del muro est dell’am-biente – sembrerebbe quindi attribuibilead una fase posteriore a questo restauro.
La documentazione disponibile per-
1 Cfr. Ramieri 2011, p. 1159.
2 Questa ipotesi, tra l’altro, giustificherebbe lapresenza del cordolo in cocciopesto lungo che in al-cuni punti lega il pavimento ai muri.
3 Ramieri 2011, pp. 1159-1160; per i confronti daRoma, cfr. Morricone 1970, pp. 603-604.
4 Ramieri 2011, p. 1165. Per i lavori del 1961-1962,si veda Mercando 1963-64.
5 Blocchi di tufo di Grotta Oscura appaiono in-tegrati in strutture di epoca imperiale in vari puntinell’area sacra (particolarmente lungo il limite suddel podio).
Mediterranea_IX_Layout 1 21/08/12 09.40 Pagina 28
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 29tanto non consente di accertare il carat-tere dell’ambiente come “taberna”, nétantomeno l’attribuzione generica ditutti i suoi elementi strutturali al perio-do repubblicano.1 Come premesso,un’interpretazione definitiva di questoimportante componente dell’area sacradovrà attendere uno studio accuratodelle strutture sul campo affiancato dainterventi di pulizia e scavo e da un esa-me complessivo dei materiali pertinenticonservati nel magazzino.
[Ivan Cangemi]
3. 5. Reperti dalla “taberna repubblicana”
Nello scavo della cosiddetta taberna re-pubblicana è stata recuperata una note-vole quantità di frammenti ceramici chesolo ora, a distanza di molti anni dalle in-dagini archeologiche, è stato possibileriunire. I frammenti, infatti, erano con-servati nei depositi dell’area sacra di S.Omobono all’interno di alcune cassetteprive delle indicazioni di provenienza,spesso misti a numerosi altri reperti, rin-venuti sempre nel sito di S. Omobono,ma relativi a indagini successive o sem-plicemente raccolti sporadicamente.L’attività di riordino di tutto il materiale,che ha comportato il lavaggio dei repertie la loro sistemazione in nuovi sacchetti,ha permesso di recuperare tutti queiframmenti che al momento dello scavoerano stati fortunatamente siglati e dei
quali M. L. Morricone aveva iniziato unprimo, seppur sommario, catalogo.2Purtroppo la stragrande maggioranzadei reperti recuperati proviene generica-mente da “sopra il pavimento a cubetti”,cioè da quello strato intermedio di obli-terazione della pavimentazione a cubet-ti laterizi, a sua volta ricoperto dal cosid-detto pavimento a scaglie di travertino.Dal saggio effettuato sotto il pavimentoa cubetti si conservano invece alcuniframmenti che recano le indicazioni del-lo strato in cui sono stati rinvenuti, i qua-li, con il proseguimento dello studio,permetteranno di precisare meglio lacronologia e l’evoluzione della struttu-ra. Dallo scavo della taberna, in breve,provengono terrecotte architettonicheed elementi fittili di copertura, fram-menti di ceramica a figure rosse, a verni-ce nera – comprese produzioni riferibiliall’atelier dei petites estampilles –,3 piattel-li del tipo Genucilia, ceramica a vernicerossa interna, d’impasto, a pareti sottili,unguentari, lucerne, sigillata italica, ce-ramica comune e da fuoco, anfore.
[Carlo Regoli]
La prima campagna di ricerca
L’indagine, svolta nei mesi di maggio,giugno e luglio 2010 ha interessato il set-tore occidentale dell’area archeologica,dove in passato erano stati effettuati al-cuni sondaggi, non documentati in ma-niera completa, e dove non vi era certez-za di precedenti interventi.
1 I documenti di scavo, come si è visto, si riferi-scono all’ambiente senza alcuna spiegazione o ela-borazione come “taberna” (e.g., asrcm, S. Omobo-no, b. 70, 2, c. 16311.1; asrcm, S. Omobono, 5, c.16361.39) e “taberna repubblicana” (e.g., asrcm, S.Omobono, b. 29, 7, cc. 3494 e 3503); negli appunti del1972 compare anche la definizione “taberna/cister-na” (asrcm, S. Omobono, b. 70, 2, cc. 16311.5 e 37).
2 asrcm, S. Omobono, b. 70, 2, c.16311.3 Tra questi si segnala un frammento di fondo
con piede ad anello, pertinente ad una coppetta dipiccole dimensioni, sulla quale si conserva la por-zione di un’epigrafe graffita sulla superficie ester-na: ]uo[.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 29
30 brocato et alii
Sono così stati aperti sei saggi di scavo(Fig. 4), di cui quattro nell’area A (saggi1, 2, 3, 5) e due nell’area F (saggi 4 e 6).
4. 1. Area A saggio 1
Il saggio 1 è localizzato nella zona anti-stante la cella del tempio repubblicanooccidentale, in prossimità dell’angolosud est. La zona di scavo si presentava pri-va delle lastre di pavimentazione che era-no già state asportate, determinando co-sì la forma poligonale del saggio, con unaappendice verso nord (dimensioni: m3.00 × 2.50 ca., con appendice verso norddi m 2.00 ca.). Lo scavo è iniziato il28.05.2010 ed è terminato il 21.07.2010. Laquota di partenza risulta analoga allaquota delle lastre della pavimentazione esi aggira intorno a m 13.00 s.l.m. mentrela quota di fine scavo è di m 11.37 (Fig. 12).
L’area occupata dal saggio era statagià oggetto di una precedente indaginedi Colini che aveva praticato un sondag-gio più piccolo rispetto alla superficiescavata nel nuovo intervento. L’indagi-ne quindi ha previsto una prima fase disvuotamento del vecchio cavo e unoscavo degli strati risparmiati. In totalesono state individuate sessantanove uni-tà stratigrafiche.1
Dopo alcuni tagli e accumuli recenti2si è immediatamente individuata la fos-
1 Si tratta delle us: 573, 584, 585, 579, 580, 572, 146,587, 294=295=296, 736, 737, 762, 763, 581, 677,661=662=663, 666, 674, 706, 738, 739, 740, 741, 758, 759,760, 761, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773,774, 775, 776, 777, 778, 779, 704, 676, 667, 665, 742, 743,744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755,756, 757, 664, 670, 588, 671, 672, 568.
2 us 573, 584, 585.
Fig. 12. Il saggio 1 nell’area A (fotografia P. Brocato).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 30
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 31sa e il relativo riempimento1 dell’indagi-ne Colini che peraltro aveva messo in luce la fondazione di un pilastro di etàimperiale.2 Al di sotto della pavimenta-zione a lastre3 è stato individuato unostrato giallo4 di preparazione sul qualeinsistevano alcune piccole fosse con i lo-ro riempimenti.5 Quindi è stata rilevatauna lente di scaglie di cappellaccio6 e unbattuto di tufo rosso sottile ma moltocompatto.7 Sotto questi tre strati erapresente un battuto di colore grigio8 ta-gliato da numerose buche di piccole di-mensioni con i loro riempimenti.9 Al disotto è stato scavato uno strato di coloremarrone rossiccio, con una superficie irregolare, costituito da diverse scagliedi cappellaccio e tufo rosso e dalla lorofrantumazione.10 Coperto da questostrato era un grande blocco di tufo ros-so.11 Altri due strati, il primo a matriceargillosa e il secondo caratterizzato dascaglie di tufo e cappellaccio erano loca-lizzati nella sezione ovest del saggio.12L’unità stratigrafica più bassa, non sca-vata, era costituita da uno strato di argil-la particolarmente spesso.13
Dal fondo dello scavo, corrispondentealla quota finale del sondaggio Colini, siè proceduto alla realizzazione di un ca-rotaggio manuale. Si è raggiunta così la
profondità di m 4.56, corrispondente am 7.03 s.l.m., individuando una sequen-za di strati a matrice argillosa e limosaanche con la presenza di tufo rosso.
4. 2. Area A saggio 2
Il saggio 2 è localizzato al centro del-l’area A nella zona antistante la cella deltempio repubblicano occidentale ed in-teressa una parte dove il lastricato in tu-fo risulta mancante (m 4.40 × 3.00 ca.).La quota di partenza dello scavo è di m12.95 circa s.l.m. Lo scavo è iniziato il28.05.2010 ed è terminato il 18.06.2010.Nei giorni successivi vengono effettuatialcuni carotaggi (Fig. 13). Lo scavo ha in-dividuato trentatré unità stratigrafiche14 che vengono di seguito descritte.
Dopo la rimozione del riempimentoaccumulatosi in età moderna,15 che oc-cupava lo spazio lasciato dalle lastremancanti della pavimentazione, si è pro-ceduto all’individuazione di una fossa edel suo riempimento relativi ad un son-daggio praticato all’epoca degli scaviColini.16 La fossa tuttavia non interessa-va l’intera superficie del saggio ma pocomeno della metà settentrionale. Nellametà meridionale è dunque stata esami-nata e scavata una stratigrafia non com-promessa da interventi moderni. Al disotto di uno strato giallo di modestospessore17 è stato messo in luce un bat-tuto bruno18 nel quale erano scavate di-verse piccole fosse con i loro relativiriempimenti.19 Al di sopra del battuto si
01 us 580, 579.02 us 146, 587. 03 us 294.04 us 581.05 us 737, 763 e us 736, 762.06 us 661=662=663.07 us 666. 08 us 664.09 us 706, 739, 741, 759, 761, 765, 767, 769, 771, 773,
775, 777, 779, 676, 665, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757(buche); us 674, 738, 740, 758, 760, 764, 766, 768, 770,772, 774, 776, 778, 704, 667, 742, 744, 746, 748, 750, 752,754, 756 (riempimenti). 10 us 670.
11 us 588. 12 us 671, 672.13 us 586.
14 us 575, 574, 577, 576, 294, 578, 707, 708, 709, 710,712, 711, 714, 713, 718, 717, 720, 719, 590, 644, 643, 641,589, 642, 604, 605, 611, 610, 619, 620, 614, 621, 622.
15 us 575. 16 us 576, us 577.17 us 578. 18 us 589.19 us 708, 710, 711, 713, 717, 719, 643 (fosse); us 707,
709, 712, 714, 718, 720, 644 (riempimenti).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 31
32 brocato et alii
notavano lacerti di uno strato caratte -rizzato da scaglie di cappellaccio conser-vato soltanto in alcuni punti.1 Seguiva-no una serie di colmate caratterizzatedalla presenza di tufo rosso e di cappel-laccio.2 Questa sequenza era intervalla-ta da una fossa3 che tagliava una dellecolmate e dal relativo riempimento.4 Aldi sotto un consistente strato di argilla,scavato solo parzialmente, era interval-lato con alcune lenti di scaglie di cappel-laccio e tufo. 5
La quota di fine scavo raggiunta nelsondaggio Colini, corrispondente al fon-do della fossa si aggira intorno ai m 10.60circa s.l.m., mentre le quote di fine scavo
nel settore meridionale si aggirano intor-no a m 11.50, corrispondente ad un livelloarbitrario interno allo strato di argilla.6
Dal fondo della fossa Colini si sonopraticati due carotaggi manuali che han-no evidenziato la situazione sottostante.Si è raggiunta quindi la quota di m 7.65s.l.m. evidenziando una sequenza distrati a matrice argillosa e limosa, anchecon tufo rosso, analoga al saggio 1. Allaquota indicata il carotiere si è arrestatosu una superficie compatta, il cui disfaci-mento sembra indicare la presenza di tufo rosso.
4. 3. Area A saggio 3
Il saggio 3 si sviluppa lungo il lato setten-trionale dello stilobate nord, in partico-
1 us 641.2 us 642, 604, 605, 611, 610, 614.3 us 620. 4 us 619.5 us 621e 622. 6 us 621.
Fig. 13. Il saggio 2 nell’area A (fotografia P. Brocato).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 32
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 33lare nella sua metà occidentale. L’areainteressata corrisponde ad una lacuna diforma rettangolare nella pavimentazio-ne in tufo repubblicana (m 12.30 × 1.50ca.). Lo scavo ha interessato questo sag-gio dal 07.06.2010 al 05.07.2010 da unaquota di partenza analoga all’adiacentepavimentazione a lastre e pari a m 12.92s.l.m., per scendere ad una quota di finescavo, di poco inferiore, pari a m 12.74 cir-ca s.l.m. (Fig. 14). Sono state scavate po-che unità stratigrafiche in quanto lo sca-vo si è fermato su uno strato uniformecomposto dalle lastre in tufo della pavi-mentazione repubblicana sconnesse erovesciate, che non sono state rimosse.L’apertura del saggio ha comportatol’analisi delle stratigrafie esposte e maidocumentate che si trovano nell’am-biente moderno collocato sotto lo stilo-bate.1 Complessivamente sono state in-dividuate un totale di ventitré unitàstratigrafiche, di cui soltanto una partesono state scavate, le altre sono state do-cumentate in sezione.2
Dopo una serie di fosse e riempimentidi età moderna dovuti alle diverse attivi-tà di cantiere svolte nell’area3 e ad inter-venti moderni relativi alla costruzionedell’ambiente sotto lo stilobate,4 è da se-gnalare la fossa di fondazione per il poz-zo quadrato ed il suo riempimento.5Questa situazione taglia uno strato gial-
lo6 che a sua volta copre uno strato co-stituito dalle lastre della pavimentazionerimosse e ricollocate rovesciate e nonconnesse tra loro.7 Tutti e due questi ul-timi strati riempiono la fossa realizzataper la costruzione dello stilobate.8 Que-st’ultima viene quindi a tagliare la prece-dente pavimentazione repubblicana alastre di tufo.9
Gli strati successivi, riferibili alle di-verse colmate presenti al di sotto dellelastre, sono tutti stati osservati in sezio-ne. Si tratta di uno strato giallo interpre-tabile come strato di preparazione o allettamento.10 Sotto sono due strati amatrice argillosa e limosa di colore bru-
1 Si tratta di un ambiente realizzato in età mo-derna dalla Sovraintendenza, con copertura in ce-mento armato e cancello in ferro che affaccia versovia Petroselli, per proteggere le stratigrafie sotto-stanti.
2 us 612, 613, 608, 609, 599, 601, 602, 600, 615, 616,603, 606, 285, 607, 294, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597,598. 3 us 612, 613, 608, 609.
4 us 599, 601, 602, 600.5 Rispettivamente: us 616, 324, 615.
6 us 603. 7 us 606.8 us 607 (fossa) e us 285 (stilobate).9 us 294. 10 us 591.
Fig. 14. Il saggio 3 nell’area A(fotografia P. Brocato).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.21 Pagina 33
34 brocato et alii
no.1 Seguono una colmata piuttostospessa di tufo rosso sbriciolato insieme ascaglie dello stesso materiale, uno stratoa matrice argillosa plastica di colore gial-lo-beige, un altro strato a matrice argil-losa di colore bruno con ciottoli e spora-dici frammenti ceramici, ed un ultimostrato di argilla gialla.2 Quest’ultimo siappoggia su due blocchi in peperino,3che costituiscono la struttura a quotapiù bassa rinvenuta nell’area ovest delpodio dei templi,4 forse da interpretarsi
come i resti di uno stilobate anteriore aquello in tufo di Grotta Oscura.
4. 4. Area F saggio 4
Il saggio 4 è localizzato nello spazio com-preso tra i due stilobati dei templi gemel-li, in particolare nella zona occidentaleaccanto al saggio 6. La superficie interes-sata dall’intervento presentava una lacu-na della pavimentazione a lastre di tuforepubblicana a forma di L (lungh. dei duebracci: m 3.60 e m 2.60 ca., largh. m1.00/1.50 ca.). Lo scavo è iniziato il gior-no 21.06.2010 ed è terminato il 20.07.2010.La quota di partenza dello scavo risultaanaloga alla quota delle lastre di pavi-mentazione e si aggira intorno a m 12.61s.l.m. ed una profondità massima rag-
1 us 592 e 593.2 Rispettivamente: us 594, 595, 596, 597.3 us 598.4 Una fotografia dell’Archivio della Sovrainten-
denza documenta la struttura prima della costru-zione dell’ambiente moderno.
Fig. 15. Il saggio 4 nell’area F (fotografia P. Brocato).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 34
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 35giunta di m 10.00 s.l.m. (Fig. 15). Com-plessivamente sono state rinvenute tren-tuno unità stratigrafiche.1
Dopo la rimozione dello strato di hu-mus, sono stati scavati una serie di stratiche riempivano la fossa estesa su tutta lalacuna della pavimentazione a lastre.Questi erano caratterizzati da terra mar-rone scura con materiali ceramici e pie-tre.2 Al di sotto di questa situazione èstata individuata una fossa circolare, coni suoi riempimenti ricchi di ossa e cera-mica.3 A lato di questa fossa è stato indi-viduato un pozzo circolare costruito asecco con scaglie di pietra del diametrodi m 1.40 circa. All’interno sono stati sca-vati alcuni riempimenti caratterizzatidalla presenza di cenere e carbone.4 Siala fossa che il pozzo sono localizzati sullato orientale del saggio.
Nel settore occidentale del saggio duestrati5 coprivano una situazione sotto-stante che comprendeva un piccolo poz-zo localizzato proprio all’angolo del set-tore e i suoi riempimenti costituiti dauno strato di cenere, uno strato di terracon ossa, ceramica e carbone e uno stra-to di terra marrone scuro.6 Il pozzo diforma circolare (diam. m 0.60/0.50),presentava una struttura piuttosto ap-prossimativa con utilizzo di materiali di-versi da costruzione. L’ultimo stratomesso in luce dallo scavo, ma non scava-
to, è caratterizzato da argilla di coloremarrone chiaro.7 Questo risultava ta-gliato dalle fosse per la realizzazione dientrambi i pozzi menzionati.
In sezione è stato possibile documen-tare una serie di strati pressoché oriz-zontali che non si estendevano nel sag-gio a causa della asportazione dovutaalla fossa.8 Si tratta di strati collocati im-mediatamente al di sotto della pavimen-tazione a lastre che non sono stati scava-ti ma soltanto documentati in sezione. Ilprimo strato, di colore rosso, aveva con-sistenza friabile e superficie piana; coninclusi di tufo rosso, calcare e carboncinidi piccole dimensioni. Al di sotto erauno strato compatto di colore giallo conmatrice limosa. Seguono altri quattrostrati sovrapposti a matrice argillosa e limosa.9
4. 5. Area A saggio 5
Il saggio di scavo è localizzato in prossi-mità dell’angolo nord ovest della cella deltempio repubblicano occidentale, lungoil muro ovest. Lo scavo è stato condottodal 24.06.2010 fino al 06.07.2010. La quotaassoluta di inizio scavo è di circa m 13.00s.l.m., corrispondente alla pavimenta-zione a lastre repubblicana, mentre loscavo si è fermato alla quota media di m11.60 circa s.l.m. (Fig. 16).
L’intervento è stato realizzato in cor-rispondenza di una lacuna presente nel-la pavimentazione a lastre di tufo. Il sag-gio ha una forma approssimativamenterettangolare e misura m 1.80 × 1.70 circa.Per ragioni di sicurezza non si è ritenutoopportuno procedere a maggiore pro-fondità.
1 Si tratta delle us 624, 626, 629, 627, 625, 628, 698,630, 631, 640, 647, 675, 678, 687, 634, 635, 689, 699, 703,694, 715, 787, 716, 788, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786.
2 us 625(fossa), us 624, 626, 627, 629.3 us 630 (fossa), us 628, 698 (riempimenti).4 us 634 (pozzo), us 635 (fossa di fondazione), us
631, 640, 647, 675, 678, 687 (riempimenti).5 us 689, 699.6 us 716 (pozzo), us 788 (fossa di fondazione), us
694, 715, 787 (riempimenti).7 us 786. 8 us 625.9 us 780, 781, us 782, 783, 784, 785.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 35
36 brocato et alii
Lo scavo ha messo immediatamentein evidenza che un precedente interven-to risalente alla campagna del 1969, ave-va già interessato la stratigrafia.1 Al finedi procedere alla realizzazione di unadocumentazione più analitica si è sceltodi svuotare la cavità già indagata. La fossa relativa alle precedenti ricerche,conteneva un riempimento eterogeneo,con numeroso materiale moderno.2 Lariapertura della cavità ha consentito diprocedere alla documentazione dellepareti del saggio, costituite da una stra-tigrafia in terra su tre lati e dal muro difondazione della cella sul lato est. Que-st’ultimo è stato reso visibile interamen-te per tre filari e soltanto per l’inizio delquarto. Sugli altri lati sono state docu-mentate in sezione, ma chiaramente
non scavate, un totale di undici unitàstratigrafiche.3
La sezione nord presentava una fossarelativa alle operazioni della precedentecampagna di scavo e il riempimento re-lativo di terra grigia friabile.4 Al di sottodelle lastre in tufo repubblicane era visi-bile uno strato a matrice argillosa, di co-lore giallo verosimilmente da interpre-tare come letto di posa per le lastremenzionate.5 Tra questo strato e le la-stre, in alcuni punti si interponeva unsottile strato di tufo rosso sbriciolato.6Una ampia fossa interessava tutta la pa-rete sud e in misura minima la pareteovest,7 arrivando ad intaccare lo stratopiù basso messo in luce8 e aveva come
1 Si veda Brocato 2012 c.s.2 us 734 (fossa), us 735 (riempimento).
3 us 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659,660.
4 us 656 (fossa), us 657 (riempimento).5 us 659. 6 us 649.7 us 651. 8 us 658.
Fig. 16. Il saggio 5 nell’area A (fotografia P. Brocato).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 36
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 37riempimento uno strato caratterizzatoda una parte inferiore con numerosescaglie di tufo rosso e cappellaccio.1 Sul-le sezioni ovest e nord, dove la fossa ap-pena menzionata non arriva è uno stra-to compatto a matrice argillosa di coloremarrone scuro.2 Sulla sezione ovest èparzialmente visibile una fossa, riempitadallo strato sovrastante, caratterizzatoda scaglie di cappellaccio e tufo rosso dipiccole dimensioni.3 La fossa taglia glistrati di argilla sottostanti.4
4. 6. Area F saggio 6
Il saggio si trova localizzato tra i due sti-lobati dei templi gemelli ad ovest rispet-to al saggio 4, da cui è separato da unsottile setto di stratigrafia. La forma delsaggio è determinata da una lacuna,pressoché rettangolare, presente nellapavimentazione a lastre (m 3.70 × 3.00ca.). Non si è potuta scavare una strisciadi terreno sul lato settentrionale per ra-gioni di sicurezza; al di sopra infatti in-combevano due grandi blocchi di traver-tino. Le indagini sono iniziate il 1.07.2010e terminate il 17.07.2010. La quota di par-tenza dello scavo risulta di m 13.07 s.l.m.,mentre la quota di fine scavo si aggira in-torno a m 11.25 s.l.m. In totale sono statescavate e individuate sedici unità strati-grafiche.5
Nella parte superiore dello scavo, al disotto dell’humus è stato scavato unostrato con numerose componenti artifi-ciali;6 al di sotto di questo è stata indivi-
duata una fossa moderna con relativoriempimento tra cui è stato possibile re-perire materiale moderno.7 La localizza-zione, lungo lo stilobate, fa pensare chesi tratti di un vecchio intervento di scavoarcheologico lungo lo stilobate. Al disotto sono stati individuati due riempi-menti della fossa che probabilmente hacausato l’asportazione delle lastre di pa-vimentazione repubblicane.8 Si è quindipotuto individuare il taglio e il riempi-mento esterno dello stilobate meridio-nale dei templi gemelli.9 Diversi strati ri-sultano tagliati dalla fossa e posizionatisotto le lastre della pavimentazione re-pubblicana, questi sono stati documen-tati ma non scavati.10
1 us 650. 2 us 660.3 us 653 (fossa), us 652 (riempimento).4 us 655, 658.5 Si tratta delle us 632, 646, 645, 636, 648, 637, 679,
682, 683, 684, 685, 686, 688, 701, 680, 681.6 us 632.
07 us 646 (fossa), us 645 (riempimento).08 us 637 (fossa), us 636, 648 (riempimenti).09 us 680 (fossa), us 681 (riempimento).10 us 679, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 701.
Fig. 17. Epigrafe funeraria dal saggio 6dell’area F (fotografia P. Brocato).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 37
38 brocato et alii
4. 7. Alcune considerazionisulla stratigrafia
La prima campagna di scavo è stata fon-damentale per la ripresa delle attività diindagine sul sito e l’acquisizione di nuo-vi dati scientifici. Le precedenti indagini,dopo i primi momenti della scopertadell’impianto monumentale, si sonopressoché esclusivamente dedicate adindagare le fasi più antiche del tempioarcaico, tralasciando la gran parte dellestrutture monumentali e le stratigrafiedi età successiva. Non è un caso che tut-ta la zona occidentale dell’area archeo-logica di S. Omobono non sia stata sot-toposta alla stessa intensità della ricercasvolta nella parte orientale del podio deitempli repubblicani. In tale situazione laprima necessità è stata quella di docu-mentare quanto esposto su tutta l’areaarcheologica e di approfondire per pri-ma cosa le ricerche nell’area ovest.
Nell’area occidentale è stato possibileriaprire alcuni saggi scavati nelle prece-denti indagini e non documentati. In-nanzitutto i saggi 1 e 2, di fronte alla celladel tempio ovest, interessati dagli scaviColini fino ad una certa quota ma total-mente privi di documentazione. Inoltreil saggio 5, localizzato presso l’angolosud ovest della cella del tempio ovest,realizzato da G. Pisani Sartorio. I primidue saggi non erano stati scavati inte-gralmente e quindi è stato possibile in-dagare la sequenza stratigrafica e recu-perare diversi reperti. Il terzo saggio erastato realizzato con uno scavo integrale,addirittura condotto ad un livello infe-riore rispetto ai nuovi scavi, ed è peròstato possibile documentare le sezionistratigrafiche che all’epoca non furonodocumentate se non attraverso uno
schizzo schematico, rivelatosi poi moltosemplificativo.
Le stratigrafie risparmiate da Colininei saggi 1 e 2 hanno consentito di docu-mentare una sequenza di strati anteriorealle lastre della pavimentazione in tuforepubblicana, fattore di notevole impor-tanza per l’acquisizione di elementi da-tanti. L’analisi dei materiali è attualmen-te in corso. Interessante è la scopertaimmediatamente al di sotto delle lastredi strati di preparazione e di battuti chepotrebbero forse riferirsi ad impiantiprecedenti ma anche a rimozioni o di-sfacimenti di precedenti pavimentazio-ni. Altri elementi importanti emergonoanche dalle colmate di rialzamento, checome è stato osservato nel saggio 5, pre-sentano una articolazione interna mag-giore di quanto noto, con la presenza difosse e riempimenti ancora da approfon-dire e comprendere.
Gli altri saggi, per i quali non si avevatraccia di documentazione relativa adeventuali scavi precedenti, hanno invecerivelato una situazione indisturbata cheha permesso di acquisire importanti in-formazioni relative anche alle fasi più re-centi della frequentazione dell’area.
Per quanto riguarda il saggio 3 lo sca-vo si è arrestato pochi centimetri sotto illivello dell’humus per la scoperta dellelastre di tufo della pavimentazione re-pubblicana spostate dalla loro posizioneoriginaria e rigirate, a formare comun-que un piano orizzontale, sebbene trauna lastra e l’altra non ci sia una strettaconnessione. Tale situazione, che inten-zionalmente in questa campagna non èstata rimossa, costituisce il risultato del-le operazioni di costruzione dello stilo-bate settentrionale dei templi gemelliche quindi, se l’interpretazione data è
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 38
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 39corretta, si daterebbe in età imperiale oquantomeno successiva alle lastre dellapavimentazione in tufo repubblicana.
Nei saggi 4 e 6 è stato possibile scavaredelle fosse riempite da strati databili pre-liminarmente al xiii-xiv secolo, al di sot-to dei quali si è presentata una situazio-ne articolata, con la presenza di pozzi efosse di epoca anteriore.
Tra gli aspetti generali più significati-vi che i sondaggi hanno messo in evi-denza è la completa assenza di resti dipavimentazione in pietra, nell’area nordovest del podio, precedenti quella re-pubblicana attualmente visibile. In piùparti tuttavia, immediatamente al disotto delle lastre, sono state individuatepiccole fosse ravvicinate, visibili soprat-tutto in sezione, e uno strato di disfaci-mento di materiale in cappellaccio lecui interpretazioni devono essere ap-profondite.
[Paolo Brocato]
4. 8. Osservazioni preliminari sui repertidella prima campagna di scavo
Viene qui di seguito presentata una pri-ma analisi di alcuni materiali rinvenuti,in seguito verranno presentati appro-fondimenti più completi. Si tratta di re-perti provenienti dai saggi 1, 2 e 5 del-l’area A ed una iscrizione funeraria dalsaggio 6 dell’area F. Da questi saggi so-no stati recuperati, al momento, pochireperti diagnostici relativi alle stratigra-fie anteriori alle lastre di pavimentazio-ne in pietra repubblicane, pertanto sarànecessario procedere in futuro allo sca-vo di estensioni di superficie maggiori.Le stratigrafie sottostanti alla pavimen-tazione, che corrispondono alle diversecolmate e preparazioni, contengonomateriale d’impasto dell’età del ferro,
ceramica d’impasto arcaico e tardo ar-caico, diversi frammenti di tegole e cera-miche in impasto chiaro sabbioso. Mol-to meno consistente è la presenza diframmenti di bucchero e di importazio-ni. Tra queste ultime segnaliamo un or-lo e un’ansa di una kylix miniaturisticaattica non meglio identificabile1 e unminuscolo frammento di ceramica atti-ca a figure nere.2 Il materiale sembradunque, nel complesso, potersi generi-camente collocare nella seconda metàdel vi sec. a.C., tuttavia la presenza diuna situla in impasto chiaro sabbioso in-quadrabile nel v-iv sec. a.C.3 sembra ri-bassare la cronologia e prospettare lapossibilità che il pavimento a lastre di tu-fo possa ascriversi ad una fase più avan-zata rispetto a quanto ritenuto fino adora. Questo terminus post quem necessitaperò di altri riscontri con reperti coeviche al momento la stratigrafia non sem-bra ancora aver restituito, è quindi necessario sospendere il giudizio e at-tendere ulteriori elementi. Di seguitopresentiamo una selezione esemplifica-tiva dei reperti con valenza per lo più dicarattere ceramologico.
[Paolo Brocato]
Ceramica geometrica
1. Anfora? (n. inv. 664/27; Tav. 1.1). AreaA, Saggio 1, us 664. Si conserva unframmento di parete. La superficieesterna presenta una decorazione di-pinta (2.5yr 5/8, red), composta da trecerchi concentrici eseguiti a compassodelimitati inferiormente da due linee
1 Saggio 1, area A us 664.2 Saggio 2, area A, us 578.3 Si veda la scheda reperti n. 20 infra.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 39
40 brocato et alii
orizzontali parallele. Argilla figulina(7.5yr 8/4, pink) modellata al tornioveloce. ∅ min. ric. 6,7; ∅ max. ric. 9,1;h. 4,7; sp. p. 0,8-0,9. Il frammento, cheper il tipo di argilla sembra attribuibilead una produzione locale, potrebbeessere pertinente al collo troncoconi-co di un’anfora italo-geometrica, cosìcome attestato a Ficana,1 o tutt’al piùad una oinochoe della stessa classe.2Non è comunque da escludere chepossa trattarsi di un alto piede a trom-ba, simile a quello dell’anfora – sem-pre di produzione italo-geometrica –rinvenuta a Vulci, nella tomba B diMandrione di Cavalupo.3 Databileagli ultimi decenni dell’viii sec. a.C.[C. R.]
2. Skyphos (n. inv. 664/28; Tav. 1.2). AreaA, Saggio 1, us 664. Si conserva unapiccola porzione dell’orlo assottiglia-to. Presente una decorazione dipinta(2.5yr 5/8, red) su entrambe le super-fici: una fila di punti (se ne conservanotre), esternamente; due linee orizzon-tali parallele, all’interno. Argilla figuli-na (10yr 7/4, very pale brown) model-lata al tornio veloce. ∅ ric. 10,5; h. 1,1;sp. p. 0,3-0,4. Il piccolo frammento tro-va un confronto puntuale con unoskyphos da Vulci, purtroppo sporadi-co, prodotto in Eubea in una fase avan-zata del Geometrico Recente Euboi-
co.4 Un altro esemplare del tutto simi-le, ma con una sottile linea orizzontalesopra la fila di puntini esterni, provie-ne invece da Ficana.5 Ultimo terzo del-l’viii sec. a.C. [C. R.]
Impasto protostorico
3. Tazza. carenata (n. inv. 664/17; Tav.1.3). Area A, Saggio 1, us 664. Fr. di or-lo arrotondato assottigliato; labbrosvasato con spigolo interno smussato;parete rettilinea; carena a spigolo ac-centuato. Impasto modellato a manocon inclusi di calcare e mica. Superficilisciate e lucidate di colore 10yr 2/1(black). ∅ orlo esterno ric. 17; l. 2,8; h.3,8. Tazze a parete rettilinea sono atte-state all’Osteria dell’Osa in tombe ri-feribili alla prima età del Ferro.L’esemplare in oggetto è ascrivibile algruppo 22, tipo 22a e può essere data-to, in base al confronto, alla Fase iia1.6[G. P.]
4. Scodella a orlo rientrante (n. inv.664/9; Tav. 1.4). Area A, Saggio 1, us664. Fr. di orlo rientrante arrotonda-to; labbro rientrante; carena smussa-ta; accenno di vasca con parete retti -linea. Superficie esterna lisciata e
1 Brandt 1996, pp. 254-256, n. 183a, fig. 156.2 Significativo è il confronto con un esemplare di
produzione tarquiniese: Neri 2010, p. 71, n. T.a/132,tav. 11, 2. In via del tutto ipotetica il frammento po-trebbe identificarsi anche con una spalla molto incli-nata, per la quale un rimando significativo – anchese in scala minore – possono essere le due brocchet-te dalla tomba del Guerriero di Tarquinia: Åker-ström 1943, p. 79, nn. 11-12, tav. 21, 3 e 5.
3 Falconi Amorelli 1969, p. 167, n. 16, tavv. 37b, 38 c; La Rocca 1978, pp. 483-484, fig. 9.
4 La Rocca 1978, pp. 498-499, fig. 27. Datazionee provenienza sono confermati in FugazzolaDelpino 1984, pp. 131-132. Per un confronto da Ere-tria, sempre databile al periodo tardo-geometrico, siveda ad esempio Andreiomenou 1998, p. 154, fig. 1;invece, per alcuni esemplari da Kyme eolica sempredel TG euboico, ma decorati con una “fila di mac-chiette”: Frasca 1998, pp. 277-278, fig. 14, nota 25.
5 Anche questo frammento è considerato diproduzione euboica: Brandt, Jarva, Fischer-Hansen 1997, pp. 222, 226-227, n. 4, figg. 1 e 3; V. Niz-zo in Catanzaro 2005, p. 350, n. iii. 10.
6 Bietti Sestieri et alii 1992, p. 600, fig. 3a99,7(tomba 90/3,7).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 40
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 41
Tav. 1. Area Sacra S. Omobono. 1-2: ceramica geometrica.; 3-8: impasto protostorico.Scala di riduzione: n. 1, 3-8: 1:3; n. 2: 1:2.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 41
42 brocato et alii
lucidata (10yr 2/1, black); superficieinterna lisciata del medesimo colore.Impasto modellato a mano con inclu-si di sabbia, calcare e mica. ∅ orloesterno ric. 17; l. 3,9; h. 3,5. La forma èpresente in tutti i contesti italianidell’età del Ferro, con precedenti neicomplessi “protovillanoviani”. In am-bito funerario villanoviano la scodellaa orlo rientrante è frequentementeutilizzata come coperchio delle urned’impasto. Confronti puntuali a Oste-ria dell’Osa, S. Omobono, Veio, Vulci,Isola Farnese e, più in generale, incontesti databili al Bronzo finale/pri-ma età del Ferro. I confronti da Oste-ria dell’Osa e da Veio suggerisconouna datazione alla prima età del Ferrolaziale, Fase iib1.1 [G. P.]
5. Scodella (n. inv. 677/48; Tav. 1.5). AreaA, Saggio 1, us 677. Fr. di parete con ca-rena. Sulla spalla, appena al di sopradella carena, presenta una decorazio-ne a doppia linea incisa con motivo atriangoli. Superfici lisciate e lucidate(7.5yr 2.5/1, black). Impasto modella-to a mano con inclusi di calcare e sab-bia. ∅ orlo non ric.; l. 3,3; h. 2. Il tipopuò rientrare nella classe delle scodel-le a orlo rientrante della prima età delFerro. Si confronta con un esemplare,simile anche nella decorazione, da uncontesto del Fucino e a Osteria del-l’Osa.2 [G. P.]
6. Olla ovoide (n. inv. 579/45; Tav. 1.6).Area A, Saggio 1, us 579. Fr. di orlo ar-rotondato e assottigliato; labbro di-stinto e rilevato all’esterno; paretecurvilinea. In prossimità del labbro lasuperficie esterna è decorata da unabugna di forma schiacciata. Superficilisciate a stecca (2.5yr 4/1, dark red-dish grey). Impasto modellato a ma-no con inclusi di sabbia e augite. ∅ orlo esterno ric. 16,4; l. 3,8; h. 3,2.Ascrivibile alle olle del gruppo 3, tipo3a di Osteria dell’Osa per la formaovoidale e il labbro rilevato all’ester-no. Si confronta inoltre con un esem-plare miniaturizzato proveniente dalPalatino privo di decorazione. È data-bile alla prima età del Ferro laziale,Fase iia1.3 [G. P.]
7. Olla ovoide (n. inv. 664/15; Tav. 1.7).Area A, Saggio 1, us 664. Fr. di orlo ar-rotondato inclinato verso l’interno;labbro leggermente rientrante conprofilo rettilineo. Sulla superficieesterna al di sotto del labbro è presen-te una piccola presa frammentaria diforma schiacciata, ai lati della quale sidiparte un cordone plastico orizzonta-le privo di decorazione. Superficigrezze (10yr 2/1, black). Impasto mo-dellato a mano con inclusi di calcareed augite. ∅ orlo esterno ric. 20,5; l.5,5; h. 7. Il tipo è ampiamente attestatoin contesti di abitato databili al Bron-zo finale e alla prima età del Ferro co-me Sorgenti della Nova, Isola Farnesein un tipo con cordone digitato, Vulciin un tipo privo di presa e di cordone,
1 Bietti Sestieri et alii 1992, pp. 638-639, fig.3a176, 3 (tomba 433/3) (Osteria dell’Osa); Colonna1966, pp.7-8, fig. 3.18 (S. Omobono); Bartoloni etalii 1980, p. 97, tav. xxxviii.10.12; Guidi 1993, p. 31,fig.7,3; p. 55, fig. 19.1 (Veio); Pacciarelli 2000, p. 60,fig. 89, n. 1 (Vulci); V. Olivieri in Formello 2003,Struttura B, p. 49 cat. 33, tav. Vie (Isola Farnese).
2 Ialongo 2007, p. 312 n. 27 (Fucino); Bietti Ses-tieri et alii 1992, p. 578, fig. 3a47,5 (tomba 133/5)(Osteria dell’Osa).
3 Bietti Sestieri et alii 1992, p. 587. fig. 3a70,1(tombe 139/1), p. 606, fig. 3a112,2 (tomba142/2)(Osteria dell’Osa); Falzone 2001a, p. 167, tav. 2.5.(Palatino).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 42
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 43e dal territorio del Monte Cimino (So-riano del Cimino, Vt).1 [G. P.]
8. Vaso a collo troncoconico (n. inv.664/8; Tav. 1.8). Area A, Saggio 1, us664. Fr. di orlo arrotondato legger-mente assottigliato; labbro distinto esvasato; collo distinto, largo, tronco-conico, a parete rettilinea; accennodella spalla. Superficie esterna lisciatae lucidata (10yr 2/1, black); superficieinterna lisciata (7.5yr 4.2, brown). Im-pasto modellato a mano con inclusi disabbia, calcare e mica. ∅ orlo esternoric. 27,7; l. 6,9; h. 6,6. Ascrivibile ai vasibiansati del gruppo 8, tipo 8a varI diOsteria dell’Osa.2 Datazione: primaetà del Ferro laziale, Fase iia2. [G. P.]
09. Forma non ricostruibile (n. inv.664/3;tav. 2.1). Area A, Saggio 1, us 664. Fr.di parete di vaso. La superficie ester-na è decorata ad incisione con due fileparallele di punti. Superfici lucidate(10yr 2/1, black). Impasto modellatoa mano con inclusi di augite. l. 1,1; h.1,2. La presenza di materiali riferibiliall’orizzonte culturale “appennini-co” dell’età del Bronzo medio è resapiù consistente da rinvenimenti inscavi stratigrafici della seconda metàdel 1900. I frammenti appenninici diS. Omobono sono quasi tutti di impa-sto nero, spesso lucidato, con ornatidi tipo tardo.3 [G. P.]
10. Fornello a piastra piana (n. inv. 664/5;
Tav. 2.3). Area A, Saggio 1, us 664. Fr.di piastra piana, cornice arrotondata,parete verticale. Sulla cornice è pre-sente una decorazione circolare im-pressa. Superficie esterna lisciata (10R4/1, dark reddish grey); superficie in-terna grezza (5yr 3/1, very dark grey).Impasto modellato a mano con inclu-si di sabbia, augite e mica. l. 7,8; h. 8,6;sp. p. 2,6. La forma trova paralleli a S.Omobono, nell’Area Sacra del Tem-pio di Vesta, a Vulci;4 inoltre in varicontesti abitativi protostorici dell’Ita-lia centrale (bf-pf).5 [G. P.]
Impasto bruno
11. Piatto (n. inv. 664/4; Tav. 2.2). Area A,Saggio 1, us 664. Fr. di orlo a tesa.Sull’orlo è presente una decorazioneformata da due semicerchi, forse rea-lizzati al compasso, che si interseca-no. Superfici lucidate (10yr 2/1,black). Impasto modellato a manocon sabbia, calcare e mica. ∅ non ric.;h. 0,7; sp. p. 0,5-0,6. Confronti puntua-li per la forma dell’orlo e per la deco-razione provengono da Roma, sullaVelia e sul Palatino.6 Dalla metà delvii sec. a.C. [L. D. L.]
Impasto rosso-bruno
12. Olla (n. inv. 664/14, Tav. 2.4). Area A,Saggio 1, us 664. Fr. di orlo arroton-dato, appena ingrossato e legger-mente pendulo; labbro svasato. Su-
1 N. Negroni Catacchio in Milano 1981, pp.421-422, tav. 118, n. 36 (Sorgenti della Nova); V.Olivieri in Formello 2003, Struttura B, p. 53 cat. 46(Isola Farnese); Pacciarelli 2000, p. 156, fig. 94, n.2 (Vulci); di Gennaro 1986, p. 64, fig. 11 (Soriano delCimino).
2 Bietti Sestieri et alii 1992, pp. 589-590, fig.3a79,7 (tomba 103/7).
3 Peroni 1962, pp. 7-9, fig. 1.
4 Peroni 1962, p. 30, fig. 4. 4-6.; Colonna 1966p. 11 (S. Omobono); Scott, Steffensen, Trier2009, pp. 97-98, tav. 20.F44-45 (Tempio di Vesta);Pacciarelli 2000, pp. 148-151, fig. 89.3 (Vulci).
5 Cocchi Genick 1999, p.434, fig. 5.7A-7B.6 Magagnini, Van Kampen 2009, p. 71, fig. 8.b
(Velia); Falzone 2001, p. 182, tav. 19.91 (Palatino).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 43
44 brocato et alii
perfici lisciate (esterna 2.5yr 4/4, red-dish brown; interna 10yr 2/1, black).Impasto tornito con inclusi di sabbia,calcare ed augite. ∅ ric. 16,2; h. 2,3;sp. p. 0,5-0,8. Ascrivibile al gruppo Btipo C di S. Omobono. Confrontipuntuali provengono dal Palatino eda Cerveteri.1 Databile al vi sec. a.C.[L.D.L.]
13. Olla (n. inv. 664/30; Tav. 2.5). Area A,Saggio 1, us 664. Fr. di orlo inclinatoall’esterno, fortemente ingrossato ependulo; labbro leggermente svasatoe assottigliato. Appena al di sottodell’orlo presenta una scanalaturaorizzontale. Superficie esterna liscia-ta, interna lucidata (2.5 yr 5/6, red).Impasto tornito con inclusi di sabbia,calcare ed augite. ∅ ric. 13,5; h. 3; sp. p.0,4-1,6. Ascrivibile alle olle del grup-po C, tipo B di S. Omobono. Costitui-scono, invece, confronti più precisiesemplari provenienti dal Palatino, daVeio e da Acqua Acetosa.2 Databile alvi sec. a.C. [L. D. L.]
14. Ciotola-coperchio (n. inv. 573/50;Tav. 2.6). Area A, Saggio 1, us 573. Siconserva il fr. di orlo con parte dellavasca: orlo piano, inclinato all’ester-no, ingrossato; vasca con pareti retti-linee. Superfici lisciate (5yr 4/2, darkreddish gray). Impasto tornito con in-clusi di calcare ed augite. ∅ ric. 12, l.2; h. 1,8; sp. p. 0,7. Un esemplare pres-
soché identico proviene da Gravisca.3Tra l’ultimo quarto del vii e la metàdel v sec. a.C. [M. D.]
15. Olla miniaturistica (n. inv. 650/202;tav. 2.7). Area A, Saggio 5, us 650. Inte-gra. Orlo arrotondato, labbro indi-stinto, corpo cilindro-ovoide decora-to da tre bugne coniche disposteirregolarmente sulla massima espan-sione, fondo piano. Superfici non li-sciate. Impasto modellato a mano eprivo di inclusi significativi (5yr 4/2,dark reddish brown). ∅ 2,9 (orlo), 1,7(fondo); h. 2,7; sp. p. 0,4. Forma estre-mamente diffusa a Roma e nel Latiumvetus all’interno di contesti votivi dietà arcaica. A Roma, reperti simili pro-vengono sempre dall’Area sacra di S.Omobono, dai depositi votivi del Cli-vo Capitolino, del Comizio presso ilLapis Niger, della Meta Sudans e dallastipe di S. Maria della Vittoria.4 Esem-plari analoghi, ma con dimensioni va-riabili, sono stati rinvenuti anche nelsantuario orientale di Lavinium e nel-le stipi votive di Satricum, Gabii, Cam-poverde, Valvisciolo, Anagni e Pome-tia.5 Databile al vi sec. a.C. [C. R.]
1 Colonna 1966, figg. 7, 8 (S. Omobono);Carafa 1995, p. 150, tipo 364 e Colazingari 2009,p. 27, fig. 14: 307 (Palatino); Rendeli 1993, tipo Ka8.5, p. 280, fig. 504 (Cerveteri).
2 Colonna 1966, figg. 7, 8 (S. Omobono); Fal-zone 2001, p. 191, tav. 27.122 (Palatino); Torelli,Murray Threipland 1970, p. 82, fig. 27.1, tipo G 1(Casale Pian Roseto); Bedini 1990, p. 176, 8.1.25 (Ac-qua Acetosa).
3 Gori-Pierini 2001, p. 110, tav. 27.256, formaciotola-coperchio tipo A variante A2.
4 A. Magagnini in Roma 1981, p. 146, C 59 (set-tore vii, strato 5), cfr. Roma 1989, tavv. xvi, b-xvii, a(S. Omobono); E. Segala, I. Sciortino in Roma1990, p. 67 (Clivo Capitolino); Gjerstad 1960, p. 236,fig. 147, nn. 31-33 e Müller-Karpe 1962, pp. 98-99,tav. 39, n. 22 (Comizio); Zeggio 1996, pp. 109, 111, fig.99 (Meta sudans); Gjerstad 1960, pp. 155, 157, fig.100 e Müller-Karpe 1962, p. 100, tav. 42, n. B, 5 (S.Maria della Vittoria).
5 P. A. Gianfrotta in Roma 1981, p. 200, D 76(Lavinium); M. Micozzi in Roma 1990, p. 238, n. 37e Bouma 1996, vol. ii, p. 253, Min16, tav. cxxiv (Sa-tricum); Guaitoli 1981, pp. 164-165, fig. 6 (Gabii);Crescenzi 1978, p. 53, tav. xx, 1 (Campoverde);Mengarelli, Paribeni 1909, p. 258, n. 4, fig. 26; E.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 44
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 45
Tav. 2. Area Sacra S. Omobono. 1-3: impasto protostorico; 4-7: impasto rosso-bruno; 8-9:bucchero; 10-11: bucchero grigio. Scala di riduzione: n.1: 1:1; n. 2, 7: 1:2; n. 3-6, 8-11: 1:3.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 45
46 brocato et alii
Bucchero
16. Coppa (n. inv. 578/117; Tav. 2.8). AreaA, Saggio 2, us 578. Si conserva unframmento. Orlo leggermente in-grossato, breve labbro svasato e va-sca carenata. Pasta modellata al tor-nio veloce con superfici lucidate(7.5yr 2.5/1, black). ∅ ric. 18; h. 2,1; sp.p. 0,4-0,5. La forma, databile alla se-conda metà del vi sec. a.C., è ampia-mente attestata a Roma, nonché aLavinium e Gravisca.1 [C. R.]
17. Coppa (n. inv. 590/112; tav. 2.9). AreaA, Saggio 2, us 590. Si conserva unframmento. Orlo arrotondato con ac-cenno della vasca a calotta. Pasta mo-dellata al tornio veloce con superficilucidate (10yr 2/1, black). ∅ ric. 18,5;h. 2,4; sp. p. 0,5-0,6. La forma, simile altipo Rasmussen 4, è ampiamente dif-fusa a Roma e nell’Italia centrale nelcorso di tutto il vi sec. a.C.2 [C. R.]
Bucchero grigio
18. Scodella (n. inv. 677/54; Tav. 2.10).Area A, Saggio 1, us 677. Due fram-menti. Orlo arrotondato, labbro sva-sato e vasca carenata. Pasta modellataal tornio veloce con superfici lucidate(10yr 5/3, brown). ∅ ric. 19; h. 4,8; sp.p. 0,4-0,6. Questo tipo di scodella, affi-ne al tipo 1 di Rasmussen,3 è ampia-mente diffusa a Roma e nell’Italiacentrale4 – con attestazioni anche aPontecagnano e Spina5 – a partire dal-la metà del vi fino ai primi decenni delv sec. a.C. [C. R.]
19. Brocchetta (n. inv. 577/89; Tav. 2.11).Area A, Saggio 1, us 577. Si conservaun frammento di parete con un’ansaverticale a bastoncello leggermenteschiacciato. Pasta modellata al tornioveloce con superfici opache (2.5Y 6/1,reddish gray). ∅ non ric.; h. 4,1 (conansa); sp. p. 0,4-0,7. La forma, simile altipo 1c di Rasmussen,6 trova confron-
M. in Roma 1990, p. 213, n. 14 (Valvisciolo); Gatti1996, pp. 27-28, 32-33, nn. 76, 79, 84-85, 104, 106, 151(Anagni); Melis, Quilici Gigli 1972, p. 277, n. 4,fig. 3, 12 (Pometia). Stesso profilo e dimensioni, maprivo delle bugne coniche: T. Gizzi in Albano 1985,pp. 140, 142, n. 64 (Satricum).
1 Gjerstad 1960, p. 151, n. 37, fig. 96 (S. Mariadella Vittoria); Gjerstad 1960 193, 12, fig. 124 (ClivoCapitolino); Gjerstad 1960, p. 225, fig. 139 (Comi-zio); Gjerstad 1960, 418, n. 16, fig. 259 (S. Omobo-no); Rossi 2001, p. 267, tipo 7, tav. 84, 398 (Palatino);Sommella 1975, pp. 44, 46-47, n. 172 (Lavinium); Pi-anu 2000, p. 24, n. 46, tav. 6 (Gravisca).
2 Per il tipo: Rasmussen 1979, p. 125, tav. 41, fig.256. A semplice titolo esemplificativo si vedano gliesemplari da S. Omobono (C. Martini in Roma1981, pp. 144, nn. C 52-C53 dal settore vii, strato 5),dal Palatino (Rossi 2001, p. 265, tipo 4, tav. 84, 394con ulteriori confronti da Roma, Latium vetus edEtruria) e da Cerveteri (Pandolfini 1992, pp. 167-168, E 50.5, figg. 376-378).
3 Rasmussen 1979, tav. 41, n. 2484 Gjerstad 1966, pp. 427-428, fig. 115.11. Si veda-
no, ad esempio, reperti simili da S. Omobono (Gjer-stad 1960, p. 416, nn. 14-16, fig. 259;), dai depositi diS. Maria della Vittoria (Gjerstad 1960, p. 147, n. 37,fig. 96) e del Lapis Niger (Gjerstad 1960, p. 225-226,n. 12, fig. 139), dal Palatino (Rossi 2001, p. 265, tipo 3,tav. 83, 393), dal Foro Romano (Van Kampen 2004,pp. 271-272, tipo 3 e Scott, Steffensen, Trier 2009,p. 110, nn. H63, H66-H67, tav. 42-43) e, inoltre, da La-vinium (Sommella 1975, pp. 76, 78, n. 307 e M.Guaitoli in Roma 1981, p. 183, n. D 44), Veio (Mur-ray Threipland 1963, pp. 62-63, n. 33, fig. 20) e Cer-veteri (Pandolfini 1992, pp. 159-160, E 41.2, fig. 370).Si vedano inoltre Tomba 940: M. Cristofani in Fi-renze 1985, pp. 131, 133, n. 5.10 (Pontecagnano); Tom-ba 897: Camerin 1993, p. 271, n. 121 (Spina).
5 Tomba 940: M. Cristofani in Firenze 1985, pp.131, 133, n. 5.10 (Pontecagnano); Tomba 897: Came-rin 1993, p. 271, n. 121 (Spina).
6 Rasmussen 1979, p. 91, tav. 24.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 46
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 47ti da S. Omobono1 e dai depositi diS. Maria della Vittoria e del Lapis Ni-ger.2 Databile alla seconda metà delvi sec. a.C. [C. R.]
Impasto chiaro-sabbioso
20. Situla (n. inv. 579/51 + 579/52 + 677/53;tav. 3.1). Area A, Saggio 5, us 579 e US677. Si conservano tre frammenti,due dei quali (579/51, 579/52) sonocombacianti. Orlo ingrossato, labbroa colletto leggermente svasato, ac-cenno della spalla. Il terzo frammen-to (677/53), pertinente ma non ricom-ponibile, conserva parte di un’ansa aponte a sezione ovale. Superfici nonlisciate, delle quali l’esterna conservaparte di una fascia dipinta (2.5yr 4/1,dark reddish gray) alta circa cm 2,5.Impasto modellato al tornio veloce(10yr 8/3 very pale brown) e ricchissi-mo di inclusi di mica e augite. ∅ ric.17,8; h. 3,7; sp. p. 0,7-1,5. La forma, attestata anche a Veio,3 Pyrgi e Gra -visca,4 è databile al v-iv sec. a.C.[C. R.]
Internal slip ware
21. Olla (nn. inv. 577/107, 577/108; Tav.3.2). Area A, Saggio 2, us 577. Fr. di orlo
arrotondato, ingrossato e distinto,labbro a colletto, spalla con parete ret-tilinea. In corrispondenza della parteesterna e superiore dell’orlo, la super-ficie è rivestita con uno strato di in -gobbio (8/1 2.5yr, white). Superficigrezze (2.5/1 7.5yr, black). Impastotornito con inclusi di calcare, augite emica. ∅ ric. 13,5; h. 3; sp. p. 0,4-1,6. La ti-pologia, riscontrata prevalentementein contesti domestici, è assai diffusa aRoma – a S. Omobono, nel Vicus Juga-rius, sul Palatino, nella villa dell’Audi-torium – e nel Latium Vetus – ad Acqua-fredda, a Cosa, a Narce.5 I confrontisuggeriscono una datazione dalla finedel v sino al iii sec. a.C., con massimadiffusione nel iv secolo. [L. D. L.]
Ceramica attica a figure rosse
22. Cratere a figure rosse (n. inv. 579/59;Tav. 3.3). Area A, Saggio 1, us 579. Siconserva un frammento della spalla,arrotondata, con l’accenno del collo.Superficie esterna decorata da unmotivo dipinto raffigurante un voltoumano rivolto a destra, del quale siconservano parte della capigliatura,l’occhio e il sopracciglio. Sulla spalla,sequenza di linguette rosse e nere.Superficie interna parzialmente di-pinta (5YR 2.5/1, black). Argilla figu-lina modellata al tornio veloce (5yr6/6, reddish yellow). ∅ min ric. 22; ∅
1 C. Martini in Roma 1981, pp. 141-142, n. C 44(settore vii, strato 5). Attestata anche in buccheronero: Gjerstad 1960, p. 419, n. 46, fig. 260 (stratoC13).
2 Gjerstad 1960, p. 152, n. 16, fig. 97 (S. Mariadella Vittoria); Gjerstad 1960, p. 227, n. 19, fig. 140;ivi, p. 229, fig. 141, 2 (Lapis Niger).
3 La classe è definita “coarse creamware bucket-handled jars”: Murray Threipland in Torelli,Murray Threipland 1970, pp. 79-80, fig. 21, G
4 Pandolfini Angeletti 1992, pp. 83-84, 87, n.90, fig. 65; ibidem¸ p. 106, n. 93, fig. 83 (Pyrgi); Gori,Pierini 2001, p. 237 tav. 51, 544 (Gravisca)
5 Mercando 1966, tav. vii, 9 e 10 (S. Omobono);Virgili 1977, p. 154, fig. 3, tipo 26 (Vicus Jugarius);Pensabene 1984, p. 72, fig. 14.3 (Palatino); Pens-abene 1984, p. 72, fig. 14.3 (Palatino); Di Giuseppe2006, p. 396, tav. 34, tipo 293 (Villa dell’Auditorium);Damiani, Pacciarelli 2006, p. 521, fig. 214, tipo 293(Acquafredda); Dyson 1976, p. 56, fig. 14.16IV35 (Co-sa); Potter 1976, p. 277, tav. 278, tipo 851, 868; p. 283,fig. 99, tipo 884 (Narce).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 47
48 brocato et alii
max. ric. 28,9; h. 4,1; sp. p. 0,5-0,9. Ilframmento appartiene ad un cratere,molto verosimilmente a colonnetteanche se non è da escludere la tipolo-gia a volute, databile agli inizi del vsec. a.C. [C. R.]
Reperti anforacei
23. Anfora (n. inv. 621/111; Tav. 3.4). AreaA, Saggio 2, us 621. Si conserva partedell’orlo, ingrossato con labbro leg-germente svasato. Superfici grezze(5yr 7/4, pink); sul collo è presenteun sottile strato di ingobbio (7.5yr8/4, pink). Impasto tornito con fre-quenti inclusioni augitiche e mica-cee. ∅ 14,4; l. 7,9; h. 3,5; sp. p. 2. Unesemplare simile, pertinente adun’anfora etrusca proviene dagli sca-vi del Palatino;1 un altro confrontoproviene da Fidene.2 Databile alla se-conda metà del vi sec. a.C. [M. D.]
Ceramica acroma depurata
24. Olpe (n. inv. 704/55; Tav. 3.5). AreaA, Saggio 1, us 704. Si conserva unframmento di orlo, arrotondato,con labbro svasato. La superficieesterna è decorata con una lieve sca-nalatura appena al di sotto dell’orlo.Superfici lisciate (10yr 8/2, very palebrown). Impasto tornito depurato.∅ 7,2; l. 3,2; h.1,6; sp. p. 0,4. Si trattadi una forma molto comune, sonoattestati esemplari ad Acqua Aceto-sa, Lavinio, Veio (Casale Pian Rose-
to).3 Databile generalmente al ivsec. a.C., è tuttavia presente anchein contesti di iii sec. a.C. [M. D.]
Ceramica a vernice nera
25. Coppetta (n. inv. 577/82; Tav. 3.6).Area A, Saggio 1, us 577. Fr. di orlo ar-rotondato; labbro rientrante; vascabassa con pareti concave; piede adanello. Superfici lisciate e lucidate. Ilcolore della superficie nei punti in cuiil rivestimento è risparmiato è 5yr7/6 reddish yellow. Probabile produ-zione locale o regionale. Impasto tor-nito fortemente depurato. ∅ ric. 7,2;h. 3,6; sp. p. 0,5-0,6. La coppetta, di ti-po Morel 2787, trova un confrontopuntuale in un esemplare rinvenutonel santuario in località Campetti aVeio.4 Datato ai primi decenni del iiisec. a.C. [L. D. L.]
Instrumentum domesticum
26. Peso da telaio (n. inv. 577/115; Tav.3.7). Area A, Saggio 2, US 577. Si con-serva integralmente. Forma prossi-ma al parallelepipedo con base ret-tangolare; foro passante praticato frale facce minori, a circa 2 cm di distan-za dalla faccia superiore. Sulla baseminore è presente una scanalaturaparallela al foro. Superfici grezze(8/3 10yr, very pale brown). Impastocon frequenti inclusi di sabbia gros-solana, augite e mica. Base maggiore6,4; base minore 6; h 9,2; sp. 2. Con-fronti puntuali sono riscontrabili a
1 Pensabene, Falzone 2001, p.281, Tav.89.427.
2 Pasquarelli in Di Gennaro et alii 2009, p.199, Fig. 22.30. Nel contributo il frammento in que-stione non viene classificato come anfora bensì co-me brocca.
3 Bedini in Roma 1990, p. 175, 8.1.22-23 (AcquaAcetosa); Roma 1981, p. 204, D102 (Lavinio); Torelli,Murray Threipland 1970, p. 98, Fig. 13.4 (Veio).
4 Morel 1981, p. 225, pl. 63; Comella, Stefani1990, tipo M 89, p. 140, tav. 49 (Veio).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 48
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 49
Tav. 3. Area Sacra S. Omobono. 1: impasto chiaro-sabbioso; 2: internal slip ware; 3: ceramica attica a figure rosse; 4: reperti anforacei; 5: ceramica acroma depurata; 6: ceramica a vernice nera; 7: instrumentum domesticum; 8: bronzo.Scala di riduzione: n. 1-5, 7: 1:3; n. 6: 1:2; n. 8: 1:1.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 49
50 brocato et alii
Roma e in tutta l’Italia centrale. A talproposito si vedano: Roma, Palatinoe villa dell’Auditorium, Cerveteri,Palestrina, Narce.1 Pesi di forma pa-rallelepipeda sono attestati a partiredal iv sec. a.C. [L. D. L.]
Bronzo
27. Lamina a figura umana (n. inv.578/126; Tav. 3.8). Area A, Saggio 2,us 578. Si conservano la testa, il corpoe parte degli arti. Figurina schemati-ca di sesso maschile, testa ovoidale,braccia distese lungo il corpo, ben vi-sibile, arti inferiori distesi. Non sem-brano esserci ulteriori caratterizza-zioni del corpo. Discreto stato diconservazione. l. 3,4; spessore 0,2. Sitratta di laminette votive molto co-muni in area laziale e in altre regioniitaliane, l’esemplare rientra, per lesue caratteristiche formali nel c.d.gruppo del “Campidoglio”.2 Da Ro-ma esemplari analoghi provengonoda S. Omobono e dal Palatino (strut-tura ipogea al di sotto del tempio del-la Vittoria); mentre per il Latium Vetussono attestati ad esempio a Valviscio-lo, al Circeo, ad Anagni.3 Databile alvi sec. a.C. [M. D.]
Materiale epigrafico
28. Nell’area F dello scavo dell’area di S.Omobono, all’interno di uno stratodi riempimento di epoca medievale(saggio F6/us 648), è stata rinvenutaun’iscrizione funeraria in marmomutila su tutti e quattro i lati (cm 28× 23 × 2,4; lett. 2-3,5).
Il testo dell’epigrafe recita (Fig. 17):
D(is) [M(anibus)].Aurelio [- ca. 3/4 -]=mo filio p[iis]=simo qu[o vix(it)]
5 anis (!) VII, m[ens(ibus) - - -][A]ure(lius) Uti[lis][et A]ureli[a - - -]- - - - - -?
Presenza di segni di interpunzione allerr. 3 e 5. A livello paleografico occorresottolineare la lettera E caratterizzatadal tratto orizzontale inferiore poco ac-centuato che la rende simile alla F. L’ul-tima riga è stata incisa in caratteri mino-ri per ovviare a una mancanza di spazio.
Iscrizione sepolcrale posta dai genitorial figlio, morto all’età di sette anni e qualche mese, di cui si conservano il gen-tilizio Aurelius e parte del cognomen, nonintegrabile in quanto troppi sono i co-gnomi terminanti in -mus. Il testo, moltosintetico, menziona oltre all’età del fan-ciullo, il consueto epiteto di piissimus, assai diffuso nell’epigrafia sepolcrale.
Riguardo ai dedicanti, la presenza del-lo stesso gentilizio Aurelius potrebbe farpensare che i due fossero liberti o di-scendenti di liberti, condizione che tro-
1 Pensabene, Falzone 2001, p. 246, tav. 71, tipo2-1 (Palatino); Argento 2006, p. 372, tav. 21, tipo 170(Villa dell’Auditorium); Moscati 1993b, p. 473, tipoR 2.1 (Cerveteri); Quilici 1983, p. 102, fig. 20, nn.182, 185, 187, 190 (Palestrina); Potter 1976, p. 164, fig.53, small finds, n. 165 (Narce).
2 Uno studio specifico su queste lamine bronzeea figura umana è stato effettuato dal Colonna, defi-nendone i gruppi e la cronologia (Colonna 1970,pp. 107-114).
3 Sommella Mura in Roma 1981, pp. 148-149, C66(S. Omobono); Falzone, Rossi 2009, p. 44, Fig. 13,presente anche in Pensabene, Falzone 2001, p. 287tav. 100.B e in Rossi 2006, p. 49, 1.12 (Tempio della
Vittoria); Roma 1990, p. 212, 9.1.9 (Valvisciolo);Cassieri in Roma 1990, p. 218, 9.3.1 (Circeo); S. Gattiin Roma 1990, p. 229, 9.5.54-57 (Anagni).
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 50
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 51verebbe un riscontro anche nel cogno-men dell’uomo integrabile in Utilis, nonmolto attestato e documentato proprioin ambito servile e libertino.1
La mancanza del prenome nell’ono-mastica del defunto e la paleografia per-mettono di datare l’iscrizione al iii sec.d.C. Del resto la diffusione del gentilizioAurelius si registra in età antonina e seve-riana.2 [M. G.]
Future Prospettive di Ricerca
Il progetto di ricerca ha in programmauna serie di interventi per il futuro dasvolgere nel corso degli anni 2012-2014sulla base del rinnovo della convenzionetriennale stipulata fra il Comune di Ro-ma, l’Università della Calabria e la Uni-versity of Michigan nel 2009. Molto in-fatti rimane da fare nell’area sul frontedel riordino della documentazione e deimateriali, della lettura delle strutturemurarie visibili, dello scavo stratigraficoe del restauro e valorizzazione dell’area.Gli interventi degli enti convenzionati simuoveranno in tutte queste direzioni.Specificamente, è ancora necessario col-lazionare molta della documentazionedi scavo con l’archivio dei disegni e foto-grafico in modo da poter giungere aduna versione definitiva della sequenzastratigrafica dei saggi scavati a più ripre-se nel sito e mai pubblicati in dettaglio.Molte delle strutture visibili al livello delpodio dei templi gemelli, inoltre, devo-no essere rilevate in dettaglio maggioree in elevato, nonchè schedate, così che si
possa consolidare la lettura stratigraficadegli elevati e la messa in fase di detta-glio. A livello dei reperti, vi sono varicontesti che devono ancora essere ri-composti fra depositi differenti e consi-derati nel loro insieme.
Sul fronte dei futuri interventi di sca-vo, va segnalata la fattibilità di completa-re lo scavo al di sotto del pavimento dellacella ovest dove dovrebbe essere possibi-le esplorare il riempimento del podio sudi un’estensione molto maggiore diquanto non sia finora stato possibile. Ciòdovrebbe fornire indicazioni cronologi-che ancora più precise sul momento del-la creazione del grande podio, su cui per-sistono tuttora interpretazioni diverse.3Indagini nella cella ed intorno ad essapotranno anche fornire indizi importan-ti per quanto riguarda il rapporto strati-grafico e costruttivo fra le strutture inblocchi di cappellaccio e quelle in bloc-chi di peperino,le quali hanno un’impor-tanza cruciale per la logica architetto -nica del primo complesso post-arcaico.
Un’ulteriore possibilità che va men-zionata è quella di estendere una delletrincee esistenti al di sotto della falda ac-quifera, come è stato fatto a più ripresenel corso degli scavi del dopoguerra. Vainfatti ricordato che dai rendiconti editi,come pure dai materiali rinvenuti, è indi-scutibile che a S. Omobono vi siano deglistrati profondi dove si verificano le con-dizioni di conservazione umida (o asfit-tica). In tali situazioni può essere possibi-le recuperare manufatti ed altri resti inmateriali organici come legno o cuoio.Poiché le tecniche di recupero, stabiliz-zazione e identificazione di oggetti diquesto genere ha fatto grandi passi avan-1 Kajanto 1965, p. 286; Solin 1996, p. 116.
2 Cfr. Giovagnoli 2011. Ringrazio il professorGian Luca Gregori per l’attenzione riservata anchea questo studio. 3 Si veda ora una sintesi in Terrenato et alii c.s.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 51
52 brocato et alii
ti negli ultimi decenni, vi è la possibilitàconcreta che un nuovo scavo di questi li-velli possa dare un contributo molto si-gnificativo alla nostra conoscenza dellacultura materiale di Roma arcaica edell’ambiente originale del Foro Boario.
Sul fronte del restauro e della valoriz-zazione, infine, il sito necessita di nume-rosissimi interventi. Una volta che il de-grado delle superfici lapidee fosse statomesso sotto controllo, cosa che richiede-rà notevoli sforzi da parte di tutte le partiin causa, sarà possibile pensare ad un pia-no definitivo di sistemazione e presenta-zione al pubblico dell’area. In questosenso, la rimozione di alcuni elementi ditravertino ha rappresentato un passo im-portante per la creazione, almeno nellazona della cella occidentale, di una situa-zione cronologicamente più omogeneache renda questo complesso monumen-to di più facile lettura per i visitatori.
[Nicola Terrenato]
Abbreviazioni bibliografiche
Albano 1985: Area sacra di Satricum: tra scavo erestituzione. Catalogo della mostra (Alba-no, Museo Civico, 20 aprile-2 giugno1985), a cura di P. Chiarucci, T. Gizzi, Ro-ma, 1985.
Andreiomenou 1998: A. K. Andreiome-nou, Eretria in età geometrica; Calcide eAkraiphia in età sub-protogeometrica, in Na-poli 1998, pp. 153-166.
Åkerström 1943: Å Åkerström, Der Geome-trische Stil in Italien, Lund-Leipzig 1943.
Andrén 1939: A. Andrén, Architectural terracottas from Etrusco-Italic temples. Plates,ii, Lund, 1939.
Andrén 1940: A. Andrén, Architectural ter-racottas from Etrusco-Italic temples. Text, i,Lund, 1940.
Argento 2006: A. Argento, Periodi 1 e 2, inCarandini et alii 2006, pp. 341-374.
Bartoloni et alii 1980: A. Bartoloni, A.M. Bietti Sestieri, M. A. FugazzolaDelpino, C. Morigi Govi, F. PariseBadoni, Dizionari terminologici. Materialidell’età del bronzo finale e della prima età delFerro, Firenze, 1980.
Baughan 2011: E. P. Baughan, SculptedSymposiasts of Ionia, «aja», 115, 2011, pp. 19-53.
Bedini 1990: A. Bedini, Laurentina-AcquaAcetosa, in Roma 1990¸ pp. 171-177.
Bietti Sestieri 1992: La necropoli laziale diOsteria dell’Osa, a cura di A. M. Bietti Se-stieri, Roma, 1992.
Boldrini 1994: S. Boldrini, Le ceramiche io-niche (= Gravisca. Scavi nel santuario greco,4), Bari, 1994.
Bouma 1996: J. W. Bouma, Religio votiva: thearchaeology of latial votive religion. The 5th-3rd c. BC votive deposit south west of the maintemple at Satricum Borgo Le Ferriere, Gronin-gen, 1996.
Brandt 1996: Scavi di Ficana. 2.1. Il periodoprotostorico e arcaico: le zone di scavo 3b-c, acura di J. R. Brandt, Roma, 1996.
Brandt, Jarva, Fischer-Hansen 1997: J.R. Brandt, E. Jarva, T. Fischer-Hansen, Ceramica di origine e d’imitazionegreca a Ficana nell’viii sec. a.C., in Le necro-poli arcaiche di Veio. Giornata di studio in me-moria di Massimo Pallottino, a cura di G.Bartoloni, Roma, 1997, pp. 219-231.
Camerin 1993: N. Camerin, Alcune tipologietombali, in Spina. Storia di una città tra Grecied Etruschi, a cura di F. Berti, P. G. Guzzo,Ferrara, 1993, pp. 267-272.
Carafa 1995: P. Carafa, Officine ceramichedi età regia, Roma, 1995.
Carandini et alii 2006: La fattoria e la villadell’Auditorium, nel quartiere Flaminio di Ro-ma, a cura di A. Carandini, M. T. D’Ales-sio, H. Di Giuseppe, Roma, 2006.
Catanzaro 2005: Magna Græcia. Archeologia diun sapere. Catalogo della mostra (Catanza-ro 2005), a cura di S. Settis, M. C. Parra,Milano, 2005.
Cocchi Genick 1999: Criteri di nomenclaturae di terminologia inerente alla definizione delle
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 52
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 53forme vascolari del Neolitico/Eneolitico e delBronzo/Ferro. Atti del Congresso (Lido diCamaiore 1998), a cura di D. Cocchi Ge-nick, Firenze, 1999.
Colazingari 2009: O. Colazingari,L’area sudoccidentale del Palatino. Produzionidomestiche di età protostorica e arcaica, inRendeli 2009, pp. 13-29.
Colini 1938: A. M. Colini, Notiziario,«BCom», 66, 1938, p. 203.
Colini 2000: A. M. Colini, Appunti degliscavi di Roma, ii, a cura di C. Buzzetti, G.Ioppolo, G. Pisani Sartorio, Roma, 2000.
Colonna 1966: G. Colonna, Area sacra diS. Omobono. La ceramica di impasto posterio-re agli inizi dell’età del ferro, «BCom», 79,1966, pp. 3-32.
Colonna 1970: G. Colonna, Bronzi votiviumbro-sabellici a figura umana. I. Il periodoarcaico, Firenze, 1970.
Comella, Stefani 1990: A. M. Comella,G. Stefani, Materiali votivi del santuario diCampetti a Veio. Scavi 1947 e 1969, Roma,1990.
Crescenzi 1978: L. Crescenzi, Campover-de, in Archeologia Laziale, 1 (= QuadAEI, 1),Roma, 1978, pp. 51-55.
Cristofani 1992: Caere 3.1. Lo scarico arcaicodella Vigna Parrocchiale, a cura di M. Cristo-fani, Roma, 1992.
Damiani, Pacciarelli 2006: I. Damiani,M. Pacciarelli, L’insediamento di Acqua-fredda e l’occupazione rurale del territorio traRoma, Caere e Veio dal primo Ferro all’età arcaica, in Carandini et alii 2006, pp. 511-556.
Daminato 1977: L. Daminato, La ceramicadell’età del Bronzo e del Ferro, in Lazio arcaicoe mondo greco, «PP», 32, 1977, pp. 35-42.
Di Gennaro 1986: F. Di Gennaro, Formedi insediamento tra Tevere e Fiora dal Bronzofinale al principio dell’età del Ferro (= Biblio-teca di Studi Etruschi, 14), Firenze 1986.
Di Gennaro et alii 2009: F. Di Gennaro, F.Bartoli, E. Foddai, B. Giorgietta, C.Iaia, M. Merlo, S. Pasquarelli, S. TenKortenaar, Contesti e materiali della pri-ma età del ferro, di età orientalizzante, arcaica
e tardo arcaica da Fidene, in Rendeli 2009,pp. 137-210.
Di Giuseppe 2006: H. Di Giuseppe, Periodi3 e 4 (fasi 1 e 2), in Carandini et alii 2006,pp. 375-402.
Dyson 1976: S. L. Dyson, Cosa, the utilita-rian Pottery, Rome, 1976.
Falconi Amorelli 1969: M. T. FalconiAmorelli, Corredi di tre tombe rinvenute aVulci, «StEtr», 37, 1969, pp. 181-211.
Falzone 2001a: S. Falzone, Ceramica d’im-pasto bruno di epoca protostorica e orientaliz-zante, in Pensabene, Falzone 2001, pp.161-184.
Falzone 2001b: S. Falzone, Ceramica di im-pasto rosso di età orientalizzante, in Pens-abene, Falzone 2001, pp. 185-196.
Falzone, Rossi 2009: S. Falzone, F. M.Rossi, L’area sud ovest del Palatino tra l’viii
e il vi secolo a.C. Il bucchero e la ceramica de-purata come indicatori della produzione e del-la circolazione di vasellame di uso domestico esacrale, in Rendeli 2009, pp. 31-47.
Frasca 1998: M. Frasca, Ceramiche greched’importazione a Kyme eolica nell’viii secoloa.C., in Napoli 1998, pp. 273-279.
Fugazzola delpino 1984: M. A. Fugazzo-la Delpino, La cultura villanoviana, Ro-ma, 1984
Firenze 1985: Civiltà degli Etruschi. Catalogodella mostra (Firenze, Museo Archeologi-co), a cura di M. Cristofani, Milano, 1985.
Formello 2003: Dalla capanna alla casa. I primiabitanti di Veio. Catalogo della mostra(Formello, 2004), a cura di I. Van Kampen,Formello, 2003.
Gatti 1996: S. Gatti, Anagni (Frosinone). Lo-calità S. Cecilia. Indagini nel santuario erni-co: il deposito votivo arcaico, «NSc », ix, v-vi,1994-1995 [1996], pp. 5-164.
Giovagnoli 2011: M. Giovagnoli, L’appa-rato epigrafico dell’ipogeo degli Aureli, inL’ipogeo degli Aureli in viale Manzoni. Re-stauri, tutela, valorizzazione e aggiornamentiinterpretativi, a cura di F. Bisconti, Città delVaticano, 2011, pp. 229-232.
Giustini 2004-2005: M. Giustini, Appendi-ce: Ceramica medievale, laterizi, reperti me-
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 53
54 brocato et alii
tallici, oggetti in osso e monete, in La chiesa diS. Omobono alla luce di nuove scoperte («Ren-dPontAc», 77), 2004-2005, a cura di A. M.Ramieri, pp. 79-136.
Gjerstad 1960: E. Gjerstad, Early Rome, iii.Fortifications, domestic architecture, sanctua-ries stratigraphic excavations, Lund, 1960.
Gjerstad 1960: E. Gjerstad, Early Rome, iv.Synthesis of Archaeological Evidence, Lund,1960.
Gori, Pierini 2001: B. Gori, T. Pierini, Laceramica comune (Gravisca. Scavi nel santua-rio greco, 12), Bari, 2001.
Guaitoli 1981: M. Guaitoli, Gabii, in LazioArcaico e Mondo Greco. Il convegno di Roma,«PP», 36, 1981, pp. 152-173.
Guidi 1993: A. Guidi, La necropoli veiente deiQuattro Fontanili nel quadro della fase recentedella prima età del Ferro italiana (= Bibliotecadi Studi Etruschi, 26), Firenze, 1993.
Ioppolo 2000: G. Ioppolo, Inediti architetto-nici dall’area sacra di S. Omobono, in «Ren-dPontAc», 70, 2000, pp. 167-175.
Jalongo 2007: N. Jalongo, Il Fucino nellaprotostoria (= Grandi contesti e problemi dellaprotostoria italiana, 10), Firenze, 2007.
Kajanto 1965: I. Kajanto, The Latin Cogno-mina, Helsinki 1965.
La Rocca 1978: E. La Rocca, Crateri in ar-gilla figulina del Geometrico Recente a Vulci.Aspetti della produzione ceramica d’imitazio-ne euboica nel villanoviano avanzato,«mefra», 90, 2, 1978, pp. 465-514.
Lanciani 1893-1901: R. Lanciani, Forma Urbis Romae, Roma-Milano, 1893-1901.
Lio 2010: A. Lio, La collezione di ceramiche delMuseo di Roma, «BMusRom», xxiv, 2010,pp. 69-84.
LTUR: Lexicon Topographicum Urbis Romae, i-v, a cura di E. M. Steinby, Roma, 1993-1999.
Magagnini, Van Kampen 2009: A. Maga-gnini, I. Van Kampen, I pozzi della Velia:la lettura di un contesto, in Rendeli 2009,pp. 67-91.
Mazzuccato 1968: O. Mazzuccato, Laraccolta di ceramiche del Museo di Roma, Ro-ma, 1968.
Mazzuccato 1972: O. Mazzuccato, La ce-ramica a vetrina pesante, Roma, 1972.
Mazzuccato 1993: O. Mazzuccato, Tipo-logie e tecniche della ceramica a vetrina pesan-te, ix-x secolo, Roma, 1993.
Mengarelli, Paribeni 1909: R. Men-garelli, R. Paribeni, Norma. Scavi sulleterrazze sostenute da mura poligonali pressol’abbazia di Valvisciolo, «NSc», vi, 1909, pp.241-260.
Melis, Quilici Gigli: F. Melis, S. QuiliciGigli, Proposta per l’ubicazione di Pometia,«ArchCl», xxiv, 2, 1972, pp. 219-247.
Mercando 1963-64: L. Mercando, Saggi discavo sulla platea dei templi gemelli, «BCom»,79, 1963-64 [1966], pp. 34-67.
Milano 1981: Sorgenti della Nova. Una comunitàprotostorica e il suo territorio nell’Etruria me-ridionale. Catalogo della mostra (Milano1981), a cura di N. Negroni Catacchio, Ro-ma, 1981.
Morel 1981: J. P. Morel, Céramique campa-nienne. Le formes, Roma, 1981.
Morricone 1973: M. L. Morricone, Pavi-mento, s.v., Enciclopedia dell’Arte Antica,Classica e Orientale (Suppl. 1970), Roma1973, pp. 601-605.
Moscati 1993a: P. Moscati, Impasti bruni,in Cristofani 1993, pp. 253-261.
Moscati 1993b: P. Moscati, Pesi da telaio,rocchetti, fuseruole, in Cristofani 1993, pp.467-476.
Müller-Karpe 1962: E. Müller-Karpe,Zur Stadtwerdung Roms, Heidelberg, 1962.
Muñoz 1932: A. Muñoz, Via dei Monti e Viadel Mare, Roma, 1932.
Muñoz 1943: A. Muñoz, L’isolamento del Col-le Capitolino, Roma, 1943.
Murray Threipland 1963: L. MurrayThreipland, Excavations beside the North-West Gate at Veii 1957-58. Part II. The pottery,«bsr», 31, 1963, pp. 33-73.
Napoli 1998: Euboica. L’Eubea e la presenza eu-boica in Calcidica e in Occidente, Atti delConvegno Internazionale (Napoli 1996), acura di M. Bats, B. D’Agostino, Napoli,1998.
Neri 2010: S. Neri, Il tornio e il pennello. Ce-
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 54
la ripresa delle ricerche nell’area di s. omobono a roma 55ramica depurata di tradizione geometrica diepoca orientalizzante in Etruria meridionale(= Officina Etruscologia, 2), Roma, 2010.
Orvieto 1994: M. Bonamici, S. Stopponi, P.Tamburini, Orvieto. La necropoli di Canni-cella, Roma, 1994.
Pacciarelli 2000: M. Pacciarelli, Dal vil-laggio alla città. La svolta protourbana del1000 a.C. nell’Italia tirrenica (= Grandi conte-sti e problemi della protostoria italiana, 4), Fi-renze, 2000.
Pandolfini 1992: M. Pandolfini, Il bucche-ro, in Cristofani 1992, pp. 141-177.
Pandolfini Angeletti 1992: M. Pandolfi-ni Angeletti, Le ceramiche, in Pyrgi,«NSc», xlii-xliii, ii suppl. (1988-89), 1992,pp. 68-110.
Pensabene 1984: P. Pensabene, Sesta e set-tima campagna di scavo nell’area sud-ovest delPalatino, in Archeologia Laziale, 6 (= Qua-dAEI, 8), Roma, 1984, pp. 149-155.
Pensabene, Falzone 2001: Scavi del PalatinoI. L’area sud-occidentale del Palatino tra l’etàprotostorica e il IV sec. d.C. Scavi e materialidella struttura ipogea sotto la cella del tempiodella Vittoria, a cura di P. Pensabene, S. Fal-zone Roma, 2001.
Peroni 1962: R. Peroni, S. Omobono. Mate-riali dell’età del Bronzo e degli inizi dell’età delFerro, «BCom», 77, 1959 [1962], pp. 7-32.
Pianu 2000: G. Pianu, Il bucchero (= Gravi-sca. Scavi nel santuario greco, 10), Bari,2000.
Pisani Sartorio 1989 = G. Pisani Sarto-rio, La scoperta dei Templi della Fortuna edella Mater Matuta, in Il viver quotidiano inRoma arcaica. Materiali dagli scavi del Tem-pio Arcaico nell’area sacra di S. Omobono,Catalogo della mostra (Roma 1989), a curadi G. Pisani Sartorio, P. Virgili, G. Ioppolo,Roma, 1989.
Pisani Sartorio 1995 = G. Pisani Sarto-rio, s. v. Fortuna et Mater Matuta, aedes, inltur, ii, Roma, 1995, pp. 281-285
Potter 1976: T. W. Potter, A Faliscan townin South Etruria. Excavations at Narce 1966-71, London, 1976.
Quilici 1983: L. Quilici, Palestrina: luoghi
di ritrovamento di materiale votivo, in Archeo-logia Laziale, 5 (= QuadAEI, 7), Roma, 1983,pp. 88-103.
Ramieri 1983: A. M. Ramieri, La diocesi diFerentino (= Corpus della scultura altomedie-vale, 11), Spoleto, 1983.
Ramieri 2002: A. M. Ramieri, Nuovi scavinella chiesa di S. Omobono, in Ecclesiae Urbis.Atti del Congresso Internazionale di Studisulle Chiese di Roma (iv-x secolo) (Roma,4-10 settembre 2000), Città del Vaticano,2002, pp. 565- 578.
Ramieri 2002a: A. M. Ramieri, Frammentiinediti di sarcofagi e di rilievi altomedievali da“Via del Mare” in Roma, «RACr», lxxviii,2002, pp. 301-323.
Ramieri 2004-2005: A. M. Ramieri, La chie-sa di S. Omobono alla luce di nuove scoperte,«RendPontAc», 77, 2004-2005, pp. 3-78.
Ramieri 2011: A. M. Ramieri, Pavimenti in la-terizio ed in mosaico nell’area sacra di S.Omobono, in Marmoribus vestita. Miscella-nea in onore di Federico Guidobaldi, a cura diO. Brandt, P. Pergola, Città del Vaticano,2011, pp. 1153-1176.
Ramieri 2011: A. M. Ramieri, Il Foro Boarioe le trasformazioni urbanistiche tra il 1926 edil 1944, «Internet Archaeology», 2011.
Rasmussen 1979: T. B. Rasmussen, Buccheropottery from Southern Etruria, Cambridge,1979.
Rendeli 1993: M. Rendeli, Impasti arcaici etardo-arcaici, in Cristofani 1993, pp. 273-317.
Rendeli 2009: Ceramica, abitati, territori nel-la bassa valle del Tevere e Latium vetus, a curadi M. Rendeli, Roma, 2009.
Roma 1976: Civiltà del Lazio primitivo. Catalo-go della mostra (Roma 1976), a cura di G.Colonna, Roma, 1976.
Roma 1981: Enea nel Lazio: archeologia e mito.Catalogo della mostra (Roma 1981), Ro-ma, 1981.
Roma 1989: Il viver quotidiano in Roma arcaica.Materiali dagli scavi del Tempio Arcaico nel-l’area sacra di S. Omobono. Catalogo dellamostra (Roma 1989), Roma, 1989.
Roma 1990: La grande Roma dei Tarquini. Ca-
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 55
56 brocato et alii
talogo della mostra (Roma 1990), a cura diM. Cristofani, Roma, 1990.
Rossi 2001: F. M. Rossi, Bucchero, in Pens-abene, Falzone 2001, pp. 258-270.
Rossi 2006: F. M. Rossi, La struttura ipogeasotto il tempio della vittoria. Schede I.2-12, inTomei 2006, pp. 47-49.
Scott, Steffensen, Trier 2009: R. T.Scott, C. Steffensen, C. Trier, Thepottery, in Excavations in the Area Sacra ofVesta (1987-1996), a cura di R. T. Scott, AnnArbor, 2009, pp. 83-124
Solin 1996: H. Solin, Die stadtrömischenSklavennamen: ein Namenbuch, Stuttgart,1996.
Sommella 1975: P. Sommella, Lo scavo stra-tigrafico delle platee, in Lavinium, II. Le tredi-ci are, a cura di F. Castagnoli, Roma, 1975,pp. 7-88.
Sommella Mura 2000: A. Sommella Mu-ra, “La grande Roma dei Tarquini”. Alternevicende
Tomei 2006: Roma. Memorie dal sottosuolo, ri-trovamenti archeologici 1980/2006. Catalogodella mostra (Roma 2006), a cura di M. A.Tomei, Roma, 2006.
Terrenato et alii c.s.: N. Terrenato, P.Brocato, G. Caruso, A. M. Ramieri, H.W. Becker, I. Cangemi, G. Mantiloni,C. Regoli, The S. Omobono sanctuary in Ro-me. Assessing eighty years of fieldwork and ex-ploring perspectives for the future, «InternetArchaeology», in corso di stampa.
Torelli, Murray Threipland 1970: M.Torelli, L. Murray Threipland, A se-mi-subterranean Etruscan building in the Ca-sale Piano Roseto (Veii) Area, «bsr», 38, 1970,pp. 62-121.
di una felice intuizione, «BCom», 101, 2000, pp.7-20.
Van Kampen 2004: I. Van Kampen, I mate-riali dal Foro Romano e una classe di ciotole adorlo ingrossato, in Appunti sul bucchero. Attidelle Giornate di Studio, a cura di A. Naso,Firenze, 2004, pp. 269-273.
Virgili 1977: P. Virgili, Vicus Jugarius: Re-perti archeologici (saggi di scavo del 1959),«BCom», 84, 1977, pp. 149-171.
Zeggio 1996: S. Zeggio, Il deposito votivo, inMeta Sudans I. Un’area sacra in Palatio e lavalle del Colosseo prima e dopo Nerone, a curadi C. Panella, Roma, 1996, pp. 95-113.
Mediterranea_IX_Layout 1 20/08/12 14.22 Pagina 56