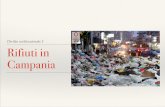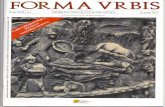Iacopo Pirona epigrafista, «Quaderni Friulani di Archeologia» 2004
In itinere. Ricerche di archeologia in Campania.
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of In itinere. Ricerche di archeologia in Campania.
a cura di Francesco Sirano
Laavieri
In itinereRicerche di archeologia in Campania
Atti del I e del II ciclo di conferenze di ricerca archeologica nell’Alto Casertano
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania
A cura di Francesco Sirano
Lavieri editoreISBN 88-89312-20-3.Edizione © 2006 Associazione Ipermedium Comunicazione e Servizi s.a.s.Contributi © 2006 dei rispettivi autori.
Francesco Sirano / In itinere. Ricerchedi archeologia in Campania - Lavieri editore, 2006 - PaginePagine 360, cm 24 - Indice Introduzione - 1. Archeologia - I. Sirano, Francesco. ISBN 88-89312-20-3.
ComposizioneIpermedium Comunicazione e Servizi s.a.s.www.ipermedium.net
RedazioneIlaria D’Ambrosio
Volume pubblicato con il contributo dei comuni di Alife, CarinolaMignano Montelungo, Presenzano, S. Potito Sannitico, Sessa Aurunca, Teano
Materiale iconografico originaleConcessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni archeologici delle provincie di Napoli e Caserta.
Sommario
Sommario
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7di Elio Meschinelli
Introduzione soprintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Introduzione Dir Gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Premessa Sirano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Le vittime ercolanesi dell’eruzione pliniana del 79 A.D. . . . . . . . .15Pier Paolo Petrone
Una nuova tomba osca dipinta dalla necropoli di Cuma: rapporto preliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Paolo Caputo
Mondragone, località Triglione Indagini lungo la via Appia . . . . .33Maria Grazia Ruggi d’Aragona, Maria Ester Castaldo
Nota preliminare sullo scavo della porticus post scaenam e della latrina pubblica del teatro romano di Sessa Aurunca . . . . .43Sergio Cascella
Una proposta di parco archeologico ambientale del Montemaggiore (Archeologia dei Monti Trebulani) . . . . . . . . . . .53Colonna Passaro
Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna . . . . . . . . . . . . . .67Francesco Sirano
Il santuario in località Loreto: aspetti del culto femminile . . . . . .95Nicoletta Scala
La tomba 50 della necropoli in località Torricelle di Teano . . . .109Rita Benassai
La ceramica fi gurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec. a.C. 121Angela De Filippis
L’antica via Teanum-Allifae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143Rosaria Sirleto, Antonio Petriccione
Nuovi documenti per la conoscenza della . . . . . . . . . . . . . . . . .163
necropoli alifana di Conca d’Oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163Gianluca Tagliamonte
Allifae e il suo ager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183Floriana Miele
L’antica popolazione di Presenzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221Pier Paolo Petrone, Enzo Monetti, Luciano Fattore
L’acquedotto romano Formose-Torelle e il grottinodella Pincera a San Potito Sannitico . . . . . . . . . . . . . .229Nicolino Lombardi
Archeologia e lavori pubblici: l’esperienza del Treno ad Alta Velocità nell’Alto Casertano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243Gabriella Gasperetti
Rufrium sannitico e romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265Domenico Caiazza
Le ville rustiche dell’ager Falernus: il territorio di Carinola . . . .287Tommaso Conti
La via Domitiana antica nel territorio di Liternum . . . . . . . . . . .299Patrizia Gargiulo
Tavole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Introduzionedi Elio Meschinelli
L’iniziativa In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania, ricca di signifi cativi appuntamenti culturali sull’archeologia campana nell’Alto Casertano, approda ad una pluralità straordinariamente feconda di testimonianze, delle quali si accoglie l’eco nei contributi di tanti illustri ricercatori.
Nell’estate del 2002, commentando la felice stagione che vide l’avvio di un’in-tensiva utilizzazione del Teatro Romano di Sessa Aurunca, luogo di straordinaria affabulazione che accoglie da millenni la storia magnifi ca di un’antica Città d’arte e la ricanta, mi avvenne di dichiarare “beati quei Popoli che affi darono alle Pietre le memorie di quanto amarono e soffrirono e credettero nei giorni della loro esistenza terrena”.
Di essi permane vivo il segno, infatti, se lo ripropone e lo ricanta, quasi urna vocale, un magnifi co impianto teatrale, la molteplice ricchezza di straordinari se-dimenti monumentali, un corredo funerario, una necropoli che l’investigazione appassionata degli studiosi restituisce alla luce del sole.
Metafora straordinariamente felice, costantemente riproposta dal lavoro degli archeologi, quella foscoliana, che vede il divino Omero penetrare negli avelli e ab-bracciar l’urne e interrogarle, perché esse, le urne, rinarrino la storia dei popoli.
Metafora che sostanzia la fi losofi a vichiana della storia, che si vale del documento d’archivio, del dato, del reperto archeologico, della fi lologia, ma perennemente vi associa la fi losofi a, l’interpretazione, che si incarica di ricercare le mediazioni cultu-rali coerenti e struttura la narrazione storica di contesto.
L’Alto Casertano, come attesta la stratifi cazione archeologica straordinaria po-sta in luce nei contributi che, in coerente concerto polifonico, ritessono l’armonia anche dissonante di culti e po-polazioni e antropologie diverse, si rivela felicissima terra, luogo di Teatri di Pietra, in cui una pluralità di messaggi fu confi data ad edifi ci splendidi, dei quali permane rilevante, oltre il tempo, la testimonianza.
Le Amministrazioni Comunali che hanno inteso aderire ad un dibattito culturale di spessore rilevante, come quello che sostanzia i contributi accolti nella presente pubblicazione, plaudono all’iniziativa che l’ha resa possibile e formulano voti perché eventi consimili ulteriormente attestino l’interesse scientifi co e la passione culturale che la ricerca archeologica nutre per la Campania Felix, come per ogni terra che generosamente conservi vestigia nobili d’antichi eventi.
Le vittime ercolanesi dell’eruzione pliniana del 79 A.D.Pier Paolo Petrone
La scoperta delle vittime di ErcolanoLa scoperta nel 1982 dei primi scheletri delle vittime dell’eruzione del 79 A.D.
sull’antica spiaggia di Ercolano ha rappresentato un evento eccezionale per l’archeo-logia e la vulcanologia mondiale e una svolta nella storia degli scavi della città sepol-ta dai prodotti piroclastici dell’eruzione del complesso del Somma-Vesuvio (Tav. 1). Per la prima volta dal 1738, anno della fortuita scoperta del teatro, ci si imbatteva nelle vittime dell’eruzione rifugiatesi sulla spiaggia nel tentativo di sfuggire alla cata-strofe in atto (fi g. 1). Nelle indagini di scavo condotte dai Borboni, come attestano i diari di scavo dell’epoca, alcuni scheletri furono trovati negli edifi ci della città, ma si tratta di rinvenimenti sporadici.1
Solo molto più tardi, nella prima metà degli anni ’80 e nei primi del ’90, fu siste-maticamente indagata la spiaggia ed una serie di dodici fornici ad essa antistanti. La rimozione di immani quantità di tufo2 che seppelliva le strutture riportò via via alla luce più di 300 scheletri, la gran parte dei quali si trovava nei fornici e solo alcune decine sulla spiaggia, in più di un caso ammassati all’ingresso di questi.3 Si tratta di meno di un decimo dell’intera popolazione, stimata intorno ai 4-5000 abitanti, pur considerando che ad oggi è stato indagato solo un terzo dell’intera città ed il resto è ancora da riportare in luce.
L’assenza quasi totale di vittime nella città e la presenza di scheletri solo in pros-simità della spiaggia, insieme a suppellettili, oggetti personali e persino animali domestici (2 cani e 2 cavalli) accanto alle persone, indicano da un lato la completa evacuazione dell’abitato e dall’altro il ricovero di questi sfollati per alcune ore negli ambienti e sulla spiaggia in attesa che l’evento eruttivo terminasse. Il ritrovamento di lucerne (fi g. 2) confermerebbe una permanenza notturna o, comunque, in uno stato di oscuramento, condizione plausibile con le ricostruzioni basate sulle descrizioni di Plinio e quanto atteso in una eruzione di questo tipo.4 Il resto degli Ercolanesi è verosimile avesse trovato scampo verso Napoli, visto che l’andamento della colonna pliniana era sud-est, a causa della direzione del vento.
Le recenti indagini biogeoarcheologicheLe recenti indagini di sito – condotte da ricercatori dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” e dell’Osservatorio Vesuviano, in collaborazione con archeo-logi della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Pompei5 – hanno permesso di intervenire in modo sistematico in un sito che per il tipo di evidenze correlate agli
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 16
effetti di un’eruzione vulcanica costituisce certamente un unicum. Ad eccezione di Pompei, l’unico riferimento noto è dato dal rinvenimento di due vittime di un’altra eruzione pliniana verifi catasi circa duemila anni prima (3780 ± 100 da oggi), iden-tifi cate e recuperate presso Nola dall’Autore6 (fi g. 3). Per la prima volta nella storia degli scavi si è intervenuti sulla base di un progetto scientifi co interdisciplinare, fi nalizzato alla comprensione dell’impatto dell’evento eruttivo su persone e cose. Lo studio di sito, condotto da un team di antropologi, archeologi e vulcanologi, me-diante l’uso di tecniche di indagine di dettaglio, sia a livello di macro- che di micro-stratigrafi e, ha consentito l’individuazione delle relazioni tra stratigrafi e vulcaniche e stratigrafi e archeologiche, con specifi ca attenzione alle singole unità e alle strutture deposizionali dei prodotti vulcanici e dell’interazione con le evidenze archeologiche, bioarcheologiche e bioantropologiche: l’insieme di tali indagini è stato etichettato “biogeoarcheologia”.
Fig. 1 - Gli scheletri nel fornice 12 (foto dell’Autore).
17Le vittime ercolanesi dell’eruzione pliniana del 79 A.D.
In particolare, l’integrazione di ricerca di campo, analisi di labora-torio e modellistica ha fornito infor-mazioni originali sulle conseguenze di questa eruzione e sugli effetti meccanici, termici e chimici subiti da persone, animali, strutture e cose. L’interpretazione delle evidenze tafo-nomiche, vulcanologiche, geofi siche e biologiche ha permesso di stabilire le proprietà fi siche e le condizioni di deposizione del primo fl usso pirocla-stico (surge). In particolare, è stato dimostrato che questo primo surge, di impatto meccanico praticamen-te nullo, investì le persone ad una temperatura di almeno 500° C, ucci-dendole all’istante per shock termico fulminante e con effetti devastanti sui corpi. I risultati di tali ricerche7 hanno avuto risonanza mondiale.8
Parallelamente al lavoro scientifi -co di campo, il progetto di studio si è anche posto l’obiettivo di rendere visibili al grande pubblico le vittime dell’eruzione nel loro contesto di rin-venimento.9 Tale programma di mu-sealizzazione del sito ha portato alla realizzazione in situ di una serie di calchi quale replica fedele degli originali attraverso la collaborazione di antropologi e tecnici del settore.10 Si tratta dei calchi attualmente esposti nella mostra Storie da un’eruzione Pompei Ercolano Oplonti.11
Per la realizzazione dei calchi è stato necessario l’intervento degli antropologi per la ricomposizione degli scheletri, il cui stato di conservazione era fortemente com-promesso dalla lunga esposizione agli agenti atmosferici e dalle ripetute visitazioni. Molte ossa non erano più in connessione anatomica e spesso si trovavano spostate altrove. Solo un attento studio della documentazione grafi ca, fotografi ca e delle possibili posizioni anatomiche relative dei vari elementi scheletrici ha reso possibile una ricostruzione delle posture originarie delle vittime. Senza questo lavoro il calco non avrebbe avuto alcun valore scientifi co ed anche un impatto visivo estremamente basso, ma, soprattutto, sarebbe stato impossibile rilevare e documentare scientifi ca-mente le evidenze degli effetti dell’eruzione. Inizialmente si è dovuto compiere una
Fig. 2 - Una lucerna in bronzo accanto ad un bambino nel fornice 10 presso l’antica spiaggia
di Ercolano (foto dell’Autore).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 18
sorta di scavo “al contrario”, attraverso il riempimento di tutti gli spazi vuoti con la stessa cenere vulcanica in cui le ossa erano inglobate, fi no alla completa ricomposi-zione di tutti gli individui. Dopo la documentazione fotografi ca e scientifi ca sono stati realizzati i calchi (fi g. 4).
La fase fi nale è stata quella dello scavo archeologico.12 Man mano che venivano riportati a vista gli scheletri nella loro interezza (Tav. 2) si è proceduto al lavoro di analisi e poi al recupero degli scheletri. In tal modo ci si è resi conto che non si trat-tava di un unico “strato” di corpi, bensì di vari livelli di scheletri sovrapposti gli uni agli altri. In un solo ambiente si è arrivati a documentare e recuperare più di qua-ranta individui, gli ultimi dei quali, in perfetto stato di conservazione, si trovavano sul fondo di sabbia dei fornici. L’intero lavoro di campo ha richiesto due anni per i due fornici indagati (il 12, 1997-98, e il 10, 1998-99).
Le evidenze tafonomiche e biologicheLo studio della stratifi cazione e della posizione originaria all’interno dei fornici
degli scheletri delle vittime ha permesso di valutare gli effetti dell’impatto con la nube ardente del primo surge sulle persone e le cause di morte.13 L’analisi comparata delle relazioni spaziali delle ossa dei singoli individui e degli individui tra loro mo-stra che la maggior parte di essi era seduta prima di morire, mentre alcuni – per lo più bambini - erano distesi nella sabbia sul fondo degli ambienti e solo qualcuno stava in piedi. In generale, l’integrità e le posizioni rilevate per gli scheletri sugge-riscono che i corpi non furono esposti ad impatto meccanico, dato in accordo con l’orientamento dei fornici rispetto alla direzioni dei fl ussi piroclastici e la posizione sulla spiaggia, dove il dislivello in corrispondenza della linea di costa rispetto alla città è di circa 15 metri.
Le ossa mostrano una serie di caratteristiche che sono indicative di esposizione ad elevata temperatura. La maggior parte dei crani presenta numerose fratture da
Fig. 3 - Il calco di una delle due vittime dell’eruzione preistorica delle “Pomici di Avellino” (3780 ± 100 da oggi) rinvenuta a San Paolo Belsito, nel nolano
(esposto nel Museo di Antropologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”).
19Le vittime ercolanesi dell’eruzione pliniana del 79 A.D.
esplosione e annerimenti della superfi cie esterna ed interna (fi g. 5), i residui dei quali sono stati analizzati a livello istologico.14 La presenza e il numero di tali frat-ture dipendono, oltre che dalla temperatura,15 dallo spessore dell’osso e dal grado di obliterazione delle suture craniche (risultando così correlate sia al sesso che all’età), ma anche dall’orientamento della testa nello spazio. Precipitazioni di ossidi di ferro, unico residuo della completa vaporizzazione dei tessuti e dei fl uidi corporei, si ri-scontrano sulle ossa, ma anche nella cenere a contatto con esse, al di sotto dei corpi.16 Molte ossa lunghe e anche i denti recano fratture di vario tipo, sia longitudinali che trasversali, morfologicamente simili a quelle riscontrabili nei resti incinerati di ossa umane.17 Anche in questo caso, alcune parti sono annerite e recano incrostazioni anche consistenti da ossidi di ferro.
Studi condotti in laboratorio su elementi ossei umani sottoposti a temperature crescenti sino a 1000° C circa, hanno stabilito delle correlazioni tra la temperatura e la colorazione dell’osso.18 Nella scala di riferimento ottenuta, la gradazione di colori marrone, nero, grigio e bianco corrisponde a variazioni di temperatura comprese tra i 200° C e gli 800° C. Osservazioni simili sono state fatte anche su ossa umane antiche di individui incinerati.19 La colorazione dei resti scheletrici e il tipo di frat-ture riscontrate sullo scheletro e sui denti ad Ercolano suggeriscono un’esposizione a temperature di almeno 500° C,20 valori confermati anche da studi istomorfologici in corso.21
Fig. 4 - Realizzazione del negativo in gomma siliconica del calco (foto dell’Autore).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 20
Ulteriori indicazioni sono fornite dalla particolare contrazione rilevata per le mani e i piedi, che trovano riscontro con le posizioni assunte dalle vittime da esposi-zione al fuoco22 o di recenti eruzioni vulcaniche, sulle quali è stato possibile studiare gli effetti anche dal punto di vista medico-legale.23 Nella maggior parte delle estremi-tà è presente una iperfl essione delle dita, con le falangi prossimali fl esse dorsalmente, mentre le medio-distali lo sono ventralmente (fi g. 6). La fl essione osservata indica che i muscoli attaccati a queste ossa sono stati soggetti a contrazione istantanea do-vuta a rifl esso fl essorio nocicettivo (nociceptive o fl exor refl ex)24 indotto dall’elevata temperatura. La caratteristica posizione da lottatore (pugilistic attitude) dovuta alla fl essione degli arti quale risultato dell’accorciamento e disidratazione di tendini e muscoli post mortem, tipica delle vittime da esposizione al fuoco e vittime nei PDCs (Pyroclastic Density Currents), è solo parzialmente presente in alcune delle vittime di Ercolano. La carbonizzazione di alcune ossa, la preservazione delle connessioni anatomiche e la incipiente posizione da lottatore evidenziate indicano che i tessuti corporei, incluso i muscoli, furono rapidamente dissolti dall’intenso calore della cenere e da questa sostituiti.
In generale, le evidenze tafonomiche rilevate nel corso dello scavo e la posizio-ne naturale degli scheletri umani sono indicative della istantaneità della morte: la popolazione di Ercolano, una volta inglobata dalla nube ardente del surge, è morta istantaneamente a causa dello shock termico (fulminant shock syndrome).
Fig. 5 - Cranio di maschio adulto con fratture da calore ed annerimento della superficie esterna (individuo 11, fornice 12; foto dell’Autore).
21Le vittime ercolanesi dell’eruzione pliniana del 79 A.D.
Questi dati, integrati con le eviden-ze di trasformazioni chimiche e fi siche di sostanze organiche ed inorganiche, trovano corrispondenza con quanto evidenziato dai dati vulcanologici. Il primo surge (S1) avanzava sulla città, arrestandosi e depositandosi in massa presso la spiaggia; a differenza dei sur-ge e dei fl ow successivi, il suo impatto meccanico era trascurabile mentre la temperatura di almeno 500° C causa-va la morte e la rapida vaporizzazione dei tessuti.
ConclusioniI risultati di questi studi mostrano
come l’indagine biogeoarcheologica mirata dei siti archeologici sepolti si ri-veli uno strumento essenziale per valu-tare l’assetto del territorio al momento dell’eruzione e gli effetti causati dai prodotti vulcanici sugli insediamenti umani e sul territorio. Le innumere-voli evidenze sulle relazioni tra l’am-biente geografi co, gli eventi naturali e il contesto antropico rendono, di fatto, la Campania un riferimento mondiale per la ricerca biogeoarcheologica.
Oltre ai risultati specifi ci per l’area vesuviana, tale approccio interdisciplinare ser-ve a fornire informazioni puntuali per la valutazione del rischio vulcanico applicabili in altre aree e, più in generale, utili a tracciare le linee guida per una metodologia di ricerca scientifi ca nei siti archeologici.
Note1 Si tratta di 32 individui, come è stato possibile stabilire attraverso un riesame degli antichi diari di scavo (v. Pagano 2002).2 Le sezioni di tufo a vista sulla spiaggia raggiungono uno spessore massimo di circa 25 metri.3 Durante questi scavi solo una metà circa degli scheletri fu recuperata dalla spiaggia e da cinque ambienti, lasciando gli altri parzialmente a vista nelle restanti sei camere.4 Sigurdsson et al. 1985.5 P.P. Petrone, attuale curatore del Museo di Antropologia, e L. Fattore della “Federico II”, G. Mastrolorenzo
Fig. 6 - Contrazione dei piedi dovuta all’esposizione ad elevata temperatura (individuo 14, giovanile,
fornice 12; foto dell’Autore).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 22
dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e M. Pagano, all’epoca delle indagini archeologiche direttore dell’Uffi cio Scavi di Ercolano.6 Cfr. Petrone, Fedele 1996 e Petrone 1999. Nel 1995, per la prima volta al mondo sono state rinvenute due vittime di un’eruzione preistorica del Somma-Vesuvio, sepolte da una spessa coltre di pomici. Chi scrive ha operato per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta nel riconosci-mento e recupero dei due individui. Gli scheletri di un uomo e di una giovane donna giacevano su di un fi anco, con le mani sul volto nell’estremo tentativo di respirare. I depositi di questa eruzione, defi nita delle “Pomici di Avellino” per la direzione e la distanza di caduta del materiale piroclastico, costituiscono un marker cronologico importante per l’archeologia in Campania che separa l’antica età del bronzo (la cosidetta “cultura di Palma Campania”) dalla media età del bronzo. Il calco della giovane donna e i reperti originali dei due individui sono esposti nel Museo di Antropologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.7 Per le pubblicazioni e i convegni vedi Mastrolorenzo et al. 1998; Mastrolorenzo et al. 1999; Petrone 1999; Mastrolorenzo, Petrone 2000; Mastrolorenzo et al. 2001 a; Mastrolorenzo et al. 2001 b; Mastrolorenzo et al. 2001 c; Mastrolorenzo et al. 2002; Mastrolorenzo, Petrone 2002.8 Hanno scritto sull’argomento le maggiori testate giornalistiche mondiali, tra cui l’ANSA, The New York Times, il Washington Post, il Los Angeles Times, il Times, il Guardian, il Daily Telegraph, la BBC, il New Scientist, The British Medical Journal, The Japan Times.9 Qualunque intervento di scavo pur costituendo l’unico mezzo per acquisire conoscenze del passato, al tempo stesso è in gran parte distruttivo e, dunque, causa di perdita defi nitiva delle evidenze di contesto.10 I diversi calchi in vetroresina sono stati realizzati ad opera della ditta IKHOS Progetti s.a.s. di Torino, di M. Pellì e G. Farelli della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Pompei e di tecnici dell’Istituto Centrale del Restauro. I calchi di dettaglio (mani e piedi) sono stati realizzati da L. Fattore e dall’Autore.11 Storie da un’eruzione. Pompei, Ercolano, Oplonti, A cura di A. d’Ambrosio, P. G. Guzzo, M. Mastroroberto, Napoli 2003.12 Per lo scavo sono stati adottati piccoli strumenti di precisione e spruzzatori ad acqua, il che ha permesso di mantenere intatte le connessioni anatomiche, data sia la fragilità dei resti che la mobilità e la poca consistenza del substrato di cenere vulcanica.13 Per una sintesi v. Mastrolorenzo et al. 2001 a.14 Le fratture del cranio sono conseguenza dell’ebollizione della massa cerebrale e del conseguente aumento della pressione intracranica. Le incrostazioni nerastre, osservate al SEM (Scanning Electron Microscope), corrispon-dono a microframmenti di osso.15 Wells 1960; Gejvall 1969.16 Geraci et al. 2002.17 Bohnert et al. 1997 e Bohnert et al. 1998.18 Holden et al. 1985 a e Holden et al. 1985 b.19 Holck 1986.20 Mastrolorenzo et al. 2001 c.21 Per le analisi istomorfologiche v. Guarino 2002.22 Knight 1996.23 Baxter 1990.24 La Motte-Campbell 1978.
Una nuova tomba osca dipinta dalla necropoli di Cuma(Pozzuoli/NA): rapporto preliminare
Paolo Caputo
Il presente contributo riguarda la recente scoperta di un nuovo monumento della pittura funeraria osca, avvenuta nella necropoli di Cuma a ottobre 20031 nel corso di lavori di scavo effettuati in una proprietà privata. Questi hanno consentito l’ina-spettato rinvenimento, le indagini di scavo e il recupero di una tomba osca a camera ipogea, dipinta sulle pareti interne e su quella di ingresso esterna, effettuati in occa-sione dei lavori di straordinaria manutenzione a un ambiente di una masseria priva-ta, posta sul lato ovest della Via Provinciale Cuma-Licola, già Via Vecchia Palombara (corruzione dialettale del termine latino columbaria, cioè i sepolcri collettivi visibili ancora nel XIX sec. ai suoi lati) corrispondente all’antico asse extraurbano Cumis Capuam, uscente in origine dalla porta mediana delle mura settentrionali (fi g. 1). I lavori sono stati condotti nel periodo ottobre 2003/aprile 2004,2 su un’area, che corrisponde all’originario fondo Correale, già indagato dal Conte di Siracusa (1853-1855) e ubicato nel settore di necropoli posto subito a ridosso delle mura urbane su questo lato, di fronte alla Tomba “a tholos” e al Mausoleo delle “Maschere di cera”, dove in antico, e in diversi periodi della storia dell’antica città, si addensarono nu-merose sepolture (fi g. 2).
Sotto pavimenti e massetti dell’ambiente sono subito apparsi, infatti, i resti di alcuni piccoli edifi ci funerari romani di età tardo repubblicana, coperti in antico da voltine a tutto sesto, con ingresso ad arco sulla parete est, del tipo sormontato in origine da coronamento a dado fuori terra. Sotto questi resti, lo scavo ha poi rivelato altre testimonianze d’età sannitica: una tomba a cassa di tufo a copertura piana, non decorata, sotto il cui fondo, collassato nella metà nord, è stata, infi ne, individuata una sottostante tomba. Profanata in antico, o, al più tardi, nel XVIII sec., prima, cioè, dell’edifi cazione della stessa masseria, come fanno ipotizzare i dati di scavo, la tomba si presentava a camera ipogea, con tetto a doppia falda, orientata est-ovest, con ingresso a ovest (fi g. 3). Realizzata con lastre di tufo giallo (spess. cm 20), le sue dimensioni interne erano alquanto modeste (m 2,27 x 1,38; h. pareti lunghe late-rali m 1,15; h. pareti di testata e h. al culmine degli spioventi m 2,37); la tomba fu fondata ed edifi cata in una fossa appositamente scavata, coperta poi da uno spesso strato di terra, la cui disposizione e stratifi cazione non fanno tuttavia ipotizzare la forma del tumulo, bensì, piuttosto, quella di una copertura piana, che meglio si
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 24
Fig. 1 - Cuma (Pozzuoli): l’area delle necropoli come individuata dal Gabrici (da Gabrici 1913, tav.1).
25Una nuova tomba osca dipinta dalla necropoli di Cuma
adatterebbe anche alla presenza delle altre sepolture realizzate superiormente in epo-che successive. La sepoltura era, inoltre, preceduta anche da un dromos, con pareti verticali realizzate a piccoli blocchi irregolari di tufo, uniti senza malta e forse volta superiore a conci di tufo, costruiti con lo stesso sistema, realizzato in pendenza per superare il dislivello dalla quota di m 4,45 a quella di m 5,05,3 dove alcuni gradini in tufo, superstiti, sul lato ovest dell’area di indagine, sono riferibili alla sommità della struttura architettonica di ingresso alla sepoltura. Questa, infatti, doveva individuar-la e segnalarla in superfi cie. L’esame dei dipinti fa ipotizzare che tale struttura, come si dirà più avanti, sia raffi gurata – nei suoi principali elementi architettonici, ma in maniera estremamente schematica, come vista su uno dei prospetti laterali – sulla parte sinistra della parete di falda dipinta della tomba, subito entrando a sinistra (parete nord).
La decorazione, eseguita nella tradizionale tecnica a fresco, direttamente sull’in-tonaco bianco, costituente tuttavia un sottile supporto,4 si sviluppa all’interno, al di sopra di uno zoccolo rosso dipinto sulle quattro pareti laterali, chiuso in alto da un fregio a onda nero e da una sottile striscia gialla, e sulla sommità della facciata esterna della parete breve d’ingresso. Le sagome dei personaggi e degli oggetti rap-presentati sulle pareti sono tutti contornati da una sottile linea nera, presente nella pittura di tradizione etrusco-italica.
Fig. 2 - Cuma (Pozzuoli): l’area del ritrovamento, ubicata di fronte a quella della Tomba “a tholos” (da Gabrici 1913, tav.1).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 26
Sulla parete est, di fronte all’entrata, è rappresentata una scena di banchetto fu-nerario (Tav. 3): al centro, è un uomo sdraiato su una kline, vestito di una tunica decorata da fregi neri a onde, e di un mantello ricadente a pieghe sulla parte inferio-re del corpo. La robusta fi gura è in bruno, come quelle maschili nella pittura greca, etrusco-italica e romana; gli occhi, castano scuri, sembrano essere stati scalpellati mediante uno strumento metallico, verosimilmente un picconcino, dai profanatori, forse per superstizione, onde evitare lo sguardo del profanato; barba e capelli corti, brizzolati caratterizzano il maschio adulto, la cui espressione, dallo sguardo distac-cato, bene si addice a un defunto; l’impressione, tuttavia, è quella di un ritratto fi sionomico, piuttosto che di genere, confermato anche dalle dimensioni del naso prominente, dalle rughe sulla fronte e alla base del collo.
Fig. 3 - Cuma (Pozzuoli): pianta e sezioni AA e BB della tomba osca dipinta (rilievo grafico Arch. Andrea Padovano).
27Una nuova tomba osca dipinta dalla necropoli di Cuma
Il personaggio esibisce una ricca corona di fi ori di melograno sul capo, con-frontabile con quelle di coeve pitture funerarie, come quelle da località Spinazzo a Paestum,5 identica a quella esibita pure dalla donna, dal viso e corpo bianchi, seduta accanto a lui, sul lato destro della rappresentazione, ma più in basso rispetto all’uo-mo, anche se su uno scanno riccamente decorato, a indicare evidentemente la diver-sa posizione maschile e femminile nel contesto sociale osco. Vestita del tradizionale costume femminile, la donna, che sembra certo caratterizzarsi come la moglie del defunto, esibisce monili d’oro, indicati dal colore giallo: due collane a semplice fi lo, due bracciali a spirale con protome di serpente, due orecchini forse “a cestello”, di tipologie riscontrabili anche da altri rinvenimenti archeologici di Cuma e di altre località campane e dell’Italia Meridionale. Le lacune di pittura agli occhi, alla fron-te e alle tempie non impediscono, tuttavia, di cogliere l’atteggiamento ieratico, o, piuttosto, intenzionalmente inespressivo della donna, forse a indicare il suo senso di dignità, rappresentandola secondo i canoni generici del tipo femminile del ceto do-minante osco. Le tracce di pittura superstite indicano pure che i capelli, come spesso è consuetudine nelle rappresentazioni femminili, erano stretti in una rete, coperta da un velo, trattenuto sulla fronte e alle tempie da una fascia rossa.6
A destra dell’uomo, dietro la kline, una giovane ancella, vestita di una semplice tunica, appena stretta in vita, è in atto di versare il vino dalla brocca, sostenuta al manico con la destra e al fondo con la sinistra, nella coppa metallica retta dalle mani dell’uomo. Davanti alla kline, di un tipo smontabile, come sembra rivelare il perno a incastro della gamba sulla sinistra della parete, è la trapeza, col piano reso in pro-spettiva per meglio evidenziare cibi e oggetti poggiati su di essa:
– un piatto circolare bianco, su cui sono due pesci neri, identifi cabili apparente-mente come sogliole, per forma e colore;
– due pani bianchi rotondi;– tra questi ultimi e i pesci, sono anche due oggetti di colore grigio scuro, di
forma quadrangolare, rettilinei su tre lati, curvilinei sul quarto: i bordi rettilinei in alto e in basso sono dotati di tre circoletti o, piuttosto, uncini, resi in nero, mentre il quarto lato curvilineo è reso in nero, nell’apparente forma di un bordo semilu-nato. Consideratane la posizione sulla trapeza, si può solo ipotizzare, al momento, che tali oggetti fossero usati per mangiare il pesce, forse per tagliarlo, con le lame, e diliscarlo, con gli uncini (?). Il colore grigio-nero sembra, inoltre, indicarne la ori-ginaria, verosimile realizzazione in un metallo prezioso, come l’argento. Finora essi si confrontano solo con la descrizione di due oggetti simili, attualmente irreperibili, rinvenuti in un’altra tomba dipinta da Cuma (Weege2 = Cu.2), che furono così de-scritti: «due laminette d’argento rettangolari coi bordi arrotondati e rigonfi ; terminano a uncino»;7
– sotto la trapeza è un piccolo levriere bianco;– davanti e sotto di essa si notano le tracce di una sinopia, tracciata in rosso con
strumenti di precisione, forse a volere indicare, all’esecutore materiale della scena,
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 28
lo spazio che, nel contesto, doveva occupare la trapeza stessa, resa poi, tuttavia, a quanto pare, diversa dal “suggerimento” fornito.
Sopra i tre personaggi pende, sospesa a chiodi, resi pure in maniera prospettica, una complessa ghirlanda di fi ori di melograno, formata da più elementi semicircola-ri, dai quali pendono tre altri elementi verticali, formati sempre da fi ori dello stesso tipo.
La scena di banchetto sopra descritta si confronta bene direttamente con le altre analoghe rappresentazioni coeve su vasi8 e, indirettamente, con le altre più antiche rappresentazioni presenti sulle pareti di alcune tombe etrusche.9
La parete nord, alla cui base era posto il lettino funerario, e quella sud mostrano, rispettivamente, due scene di danza con fi gure rese al tratto, alquanto diverse, sti-listicamente, dalle fi gure della scena principale: nella prima (Tav. 4), un suonatore di doppio fl auto, di linea straordinariamente moderna, avanza a destra di profi lo a piedi nudi, con indosso un costume formato da una corta tunica su anassiridi; ai lati due danzatrici nude, con gesto speculare, sembrano avere appena terminato una danza, mentre si levano in volo tre uccelli, identifi cabili come colombe, piuttosto che come cigni, al di sopra delle loro teste, volendo forse qui sottolineare lo svolgi-mento della scena in uno spazio aperto.
All’estremità sinistra di questa rappresentazione, a breve distanza dalla mano destra della danzatrice, si vedono, rese con spesse linee geometriche di colore grigio alquanto evanescenti, tre forme geometriche quadrangolari, sovrapposte, allineate a sinistra, le prime due dal basso allineate anche a destra, la terza arretrata a sinistra rispetto alle due inferiori di un terzo circa della larghezza. Il restauro delle pitture, inoltre, ha messo meglio in evidenza, alla base del quadrangolo di maggiori dimen-sioni, tracce dipinte in grigio, anch’esse evanescenti, di due piante su stelo, spuntan-ti dal suolo, allargate a palmetta, alte un terzo circa rispetto al quadrangolo inferio-re.10 Questa circostanza lascia ipotizzare che la presenza delle piante voglia indicare specifi camente la crescita di vegetazione, forse spontanea, in uno spazio aperto, alla base di una struttura, resa intenzionalmente di profi lo, sul prospetto laterale sini-stro. Escludendo l’identifi cazione della struttura con un altare, perché troppo alto, si potrebbe, invece, ipotizzare che i tre elementi quadrangolari sovrapposti rappre-sentino schematicamente, quelli di una struttura architettonica relativa all’ingresso della sepoltura: il quadrangolo inferiore rappresenterebbe una delle due spallette reggenti una piccola volta (il quadrangolo superiore), suggerita anche da una lieve curva dello stesso sul lato destro, sormontata a sua volta da una struttura di corona-mento, forse a timpano. Tale suggestiva ipotesi, ancora da valutare meglio, sembra in connessione con la circostanza della presenza, come detto sopra, di due gradini in tufo superstiti, posti sul lato ovest dell’area di indagine, riferibili, verosimilmente alla struttura architettonica di ingresso al dromos della sepoltura, che doveva indivi-duarla e segnalarla in superfi cie (quota m 5,05), così come in basso i resti del dromos
29Una nuova tomba osca dipinta dalla necropoli di Cuma
sono riconoscibili da quelli delle pareti verticali realizzate a piccoli blocchi irregolari di tufo, uniti senza malta, visti ai lati della porta della tomba (quota m 4,45).
Nella seconda scena (Tav. 5), una suonatrice di doppio fl auto avanza a sinistra, producendo un elegante movimento di torsione elicoidale dalle gambe alla testa; ai lati due fi gure maschili avanzano nude a sinistra, in atteggiamento di danza sfrenata, tipica di rappresentazioni di alcune tombe etrusche,11 al suono concitato del fl auto della donna, visualizzabile dalle gote gonfi e. Sopra le teste dei personaggi tre volatili, identifi cabili come germani reali (due integri, del terzo avanzano resti di pittura) sono raffi gurati in atto di planare a sinistra, forse su uno specchio d’acqua, verosi-milmente ubicato non lontano da dove si immaginava lo svolgimento della danza: forse si voleva qui, in tal modo, alludere alla presenza del bonifi cato Lago di Licola, posto in antico non lontano dall’area della necropoli più vicina alle stesse mura set-tentrionali, e la cui etimologia dal latino ad follicolas, indicherebbe proprio il luogo frequentato da folaghe e altri uccelli palustri.12
Sulla parte superiore della parete esterna della sepoltura si leggono pure resti della decorazione pittorica: un’ampia fascia di colore giallo, delimitata da due spesse linee di colore nero, sormonta l’arco d’ingresso alla sepoltura; ai due lati e in alto si vedono resti di racemi vegetali di colore rosso bruno, dai quali pendono, ai lati dell’arco, due melograni per parte di colore rosso, frutti spesso presenti in ambito funerario italico, così come i loro fi ori, in quanto allusivi, forse per il loro contenuto, alla credenza della sopravvivenza dell’anima nella vita ultraterrena.13
Allo stato preliminare delle ricerche, l’insieme delle pitture sembra suggerire che la scena di banchetto funebre sia ambientata in un padiglione prospiciente uno spiazzo, dove, al cospetto del defunto e della moglie, si svolgono danze in suo onore, da intendersi, verosimilmente, come una sorta di “coreografi a”, tipica delle danze popolari: in questo caso, per esempio, mentre la coppia di donne ha appena termi-nato una parte delle danze, l’altra coppia di uomini ha già iniziato la sua sul lato opposto. Per quanto attiene alla rappresentazione degli spazi chiusi, si fa presente che non mancano esempi di tombe campane ambientate in spazi chiusi o padiglioni (“stile strutturale”), come in alcune dell’antica Capua.14
Escludendo che la scena rappresenti i Campi Elisi, in considerazione delle evi-denti connotazioni realistiche, la scena del banchetto funerario appare caratterizzata come forgiata su un modello campano di lontana ascendenza etrusca,15 dai valori conservativi, quali quello dei costumi osci, in particolare quello femminile, ma “armonizzata”, in questo caso, con le scene di danza, rese al tratto e con lumeggia-ture grigie, di derivazione ellenistica, o, piuttosto, ispirate alle pitture parietali delle tombe macedoni (IV-III sec. a.C.), qui evidentemente indebolite stilisticamente dalla distanza geografi ca e cronologica dei modelli originali e dalle caratteristiche peculiari della pittura funeraria italica. Tali caratteri di derivazione, che sono pure rintracciabili nel tipo di pittura, che sarà denominata “compendiaria” in età romana,
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 30
sembrano bene addirsi proprio alle pitture eseguite col solo tratto e in monocromia sulle pareti nord e sud della tomba.16
La scena sembra, inoltre, rivelarsi, piuttosto, come una rappresentazione ideo-logico-religiosa (le danze in onore del defunto, cui lo stesso assiste), del ceto domi-nante cumano, detentore di un livello di benessere e opulenza. Tale aspetto potrebbe forse essere attribuibile già all’entrata di Cuma, come civitas sine suffragio, nello Stato romano (338 a.C.), e alla conseguente ripresa dei traffi ci commerciali dei mercatores italici, dopo la verosimile, ipotetica stasi delle guerre sannitiche.
Si ritiene comunque opportuno rimandare le conclusioni sull’argomento a uno studio più approfondito e complessivo del monumento e delle altre testimonianze documentate nel corso delle indagini effettuate, anche in considerazione degli altri dati, di valenza urbanistica e topografi ca, desumibili dalle indagini eseguite. Per i criteri stilistici, tuttavia, e gli oggetti raffi gurati, oltre che per i primi confronti sopra effettuati, dal punto di vista cronologico la tomba sembra bene datarsi al 300-290 a.C.
Note1 Esso vuole necessariamente essere solo una prima analisi di dati e problemi relativi al monumento, il cui studio è in corso da parte dell’Autore, in attesa della sua edizione completa e al di là delle notizie già datene istituzio-nalmente (XLIV Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 2004), oltre che in uno degli annuali Incontri di Archeologia, presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (febbraio 2004), e in due seminari di studio (maggio 2004) rispettivamente presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Lettere Clas-siche, Dipartimento di Discipline Storiche, e la II Università degli Studi di Napoli di S. Maria Capua Vetere, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, ma anche in occasione di una trasmissione televisiva realizzata per la Francia (Des racines & des ailes, France Trois, 03.03.04) e di un’altra in Italia (Passepartout, RAI 1, 18.07.05). Inoltre, dopo il preliminare restauro, recupero e trasporto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli nell’aprile 2004, per proseguirne il restauro, la sepoltura è stata esposta al pubblico durante il “Maggio dei Monumenti” (2004), la VI Settimana della Cultura (2004) e la “Notte bianca” di Napoli (29.10.2005), visibile nelle sue pareti smontate, che la compongono, in attesa della futura idonea sede di allestimento. Pertanto l’Autore si scusa sin d’ora per eventuali imprecisioni e futuri ripensamenti interpretativi.2 Con l’occasione, desidero sentitamente ringraziare: la Dott.ssa Valeria Sampaolo, all’epoca Soprintendente Reggente della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, per avere sostenuto questo lavoro; la Dott.ssa Cristina Regis, Archeologa, per avere collaborato allo scavo con la Direzione scien-tifi ca, nella persona di chi scrive; i Sigg. Gennaro Carandente e Cesare Giordano, Assistenti Tecnici ai lavori e alla logistica, nonché Operatori Tecnici di restauro, in particolare, per avere contribuito alla scoperta in fase di controllo dei lavori e quali effettivi scopritori della tomba dipinta; i loro colleghi Operatori Tecnici dell’Uffi cio Beni Archeologici di Cuma, Sigg. Eugenio Barretta, Angelo Gaudino, Raffaele Freda, per avere, unitamente ai primi e insieme al Restauratore, Sig. Pasquale Musella, collaborato al restauro preliminare sul sito, il Sig. Cesare Giordano anche presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; la Dott.ssa Luisa Melillo, Responsabile del laboratorio di restauro del MANN, e i Restauratori, Sigg. Pasquale Musella, Ciro Verde, Ciro Liberti, Maria Teresa Operetto e gli stagisti Paolo Autiero, Rossella Testa e Giuseppe Montella per la fase di restauro al MANN e per il lavoro effettuato unitamente all’Arch. Andrea Padovano, per avere realizzato il plastico in scala della tomba, ai fi ni della temporanea esposizione; quest’ultimo anche per la documentazione grafi ca, compresa quella
31Una nuova tomba osca dipinta dalla necropoli di Cuma
in scala 1:1 delle superfi ci dipinte; il Direttore dei Lavori, Capo Tecnico Geom. Antonio Taccogni, l’Ing. Strato Teano, collaboratore esterno per la sicurezza del cantiere, e l’assistente Umberto Castaldo, per avere risolto i problemi connessi allo scavo, recupero, e trasporto al MANN della tomba; il Fotografo Antonio Morello, la Dott.ssa Cristina Regis e gli Assistenti Gennaro Carandente e Cesare Giordano per la documentazione fotogra-fi ca; il Fotografo Gennaro Morgese e l’Arch. Eva Nardella per il progetto dei pannelli all’epoca realizzati; la Ditta Donato Di Meo di Bacoli (NA) e il suo personale di scavo (in particolare i Sigg. Gennaro Barretta, Maurizio Lucci, Franco Capuano, Carlo Baiano) per la competenza professionale e per avere la stessa generosamente sponsorizzato la realizzazione dei pannelli del restauro in mostra al MANN; infi ne i Sigg. Salvatore e Maria Tammaro, nella cui proprietà è stata effettuata la scoperta, per la loro esemplare pazienza, disponibilità e senso di ospitalità.3 Le quote sono riferite al livello del mare.4 Le caratteristiche del substrato pittorico sembrano analoghe a quelle riscontrate in alcune tombe dipinte da Capua antica; si veda in proposito G. Prisco, M. Valenzuela, Tecnica esecutiva di un gruppo di tombe dipinte da Capua antica, in Bollettino ICR, n.s. 1, 2000, 28-48.5 M. Cipriani et alii, I Lucani a Paestum, Fondazione Paestum, 1996, 77; A. Pontrandolfo, A. Rouveret, M. Cipriani, Le tombe dipinte di Paestum, catalogo della Mostra, Fondazione Paestum, 1998, 76, fi g. 74; A. Pon-trandolfo, Le tombe dipinte di Paestum, Ingegneria per la Cultura, 2004, 116 (fi g. 91), 117 (fi g. 92).6 Benassai 2001, 153-168.7 Benassai 2001, 82.8 Magna Grecia. Vita religiosa e cultura letteraria fi losofi ca e scientifi ca, a cura di G. Pugliese Caratelli, Milano 1988, 286 (fi g. 342), 287 (fi g. 343), 310 (fi g. 384), 311 (fi g. 385); Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, a cura di S. De Caro, Napoli 1994, 53.9 Si confrontino: Ducati 1937, tav. V.1; Romanelli 1938, tav. C.10 Ringrazio la Dott.ssa Luisa Melillo, per avermi fatto notare, nel corso di un sopralluogo, queste novità, meglio evidenziate dal restauro, in relazione alle quali lo scrivente ha potuto formulare l’ipotesi in coerenza anche con gli altri dati di scavo.11 Ducati 1937, tavv. I, III.12 R. Annecchino, Storia di Pozzuoli e della zona fl egrea, Napoli 1996, 314.13 A. Pontrandolfo, A. Rouveret, Le tombe dipinte di Paestum, Modena 1992, 35; Benassai 2001, 151.14 Benassai 2001, 130-136.15 Per la scena di banchetto funebre e di danza si confrontino: Ducati 1937, tavv. I, III, V.1; Romanelli 1938, tav. C.16 Si confrontino in particolare i dipinti eseguiti al tratto in monocromia nero-grigia e rosso bruna-rosso arancio della “Tomba di Persefone” a Vergina: La pittura parietale in Macedonia e Magna Grecia, a cura di A. Pontran-dolfo, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Beni Culturali, 2002, tavv. II.1, VIII.2.
Mondragone, località TriglioneIndagini lungo la via Appia
Maria Grazia Ruggi d’Aragona, Maria Ester Castaldo
Le struttureL’indagine archeologica in località Triglione, nell’area destinata al parcheggio del
cimitero di Mondragone, è stata condotta su incarico del Comune di Mondragone, tra gennaio e marzo del 2003, dalla dott.ssa Ester Castaldo, della Soc. Coop. Daida-los, per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta (fi g. 1).
Essa ha interessato una superfi cie di circa 250 mq (m 25 x 10) ad ovest della zona nella quale la Soprintendenza aveva già individuato, tramite saggi di scavo, un’area di frequentazione antropica molto estesa (Tav. 9).1
Lo scavo ha messo in luce una serie di ambienti contigui – 14 – prospicienti la via Appia, che si sviluppano su due fi le lungo un asse nord-sud. L’area in cui è stato effettuato lo scavo era stata precedentemente coltivata a frutteto, ma lo sfruttamento
Fig. 1 - Mondragone, località Triglione: inquadramento topografico, stralcio cartografia IGM, F. 171 II NE (elaborazione grafica G. Fiorentino).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 34
agricolo, praticato con arature superfi ciali, non aveva alterato in modo rilevante gli strati archeologici.
Le strutture murarie affi oravano ad una quota molto elevata, a 20-30 cm di pro-fondità dal piano di campagna.
Negli ambienti sono stati distinti, sulla base di alcune caratteristiche composizio-nali, uno o più strati di riempimento, che peraltro non presentavano mai dei limiti ben defi niti. Ciò è dovuto probabilmente al modo di formazione degli strati, che si presentano come uno scarico di materiali ributtati quando l’area era stata ormai abbandonata.
Che i riempimenti fossero costituiti da uno scarico di abitato sembra essere testimoniato dalla presenza in esso di residui alimentari, quali denti di cinghiale, conchiglie di mitili e di numerose ossa di animali. Le strutture erano conservate per un’altezza massima di circa 1 metro, ma in qualche caso si seguivano solo a livello della fondazione, mentre altre strutture avevano perso gran parte del paramento. Anche le strutture meglio conservate avevano subito numerosi interventi e modifi -che; infatti, molto spesso sullo stesso setto di muro o sui lati opposti del paramento erano riconoscibili tecniche e materiali diversi (Tav. 8).
Dal punto di vista cronologico, le strutture scavate sono ascrivibili allo stesso arco temporale nel quale si collocano le evidenze messe in luce precedentemente dalla Soprintendenza Archeologica,2 compreso tra l’epoca tardo repubblicana e l’età tardo imperiale.
Fig. 2 - Mondragone, località Triglione: strutture lungo la via Appia, ambiente XXXIII.
35Mondragone, località Triglione. Indagini lungo la via Appia
Le strutture più antiche sono in opera incerta di calcare e sono databili alla fi ne del II o agli inizi del I secolo a.C.
A tale fase sono riferibili le strutture situate all’estremità est ed ovest dell’area d’indagine (ambienti XXXI, XXXII, XXXIII; ambienti XXXVII, XX), che conser-vavano muri in opera incerta, realizzata con pietre di calcare di dimensioni molto variabili, appena sbozzate, allettate su fi lari molto irregolari (fi gg. 2, 3).
Il nucleo era formato da pietrame e malta sabbiosa ed era di scarso spessore (circa 20 cm). Le fondazioni erano in calcestruzzo, con malta molto resistente e compatta, e creavano rispetto all’elevato una risega di circa 10 cm per lato.
Ancora riferibili all’impianto più antico in opera incerta sembrano essere le strut-ture dell’ambiente XL, rinvenute ad una quota notevolmente più bassa rispetto alle altre, forse non più in uso nell’ultima fase di frequentazione, di cui, purtroppo, per motivi di tempo, è stato possibile mettere in luce solo la cresta.3
Alla stessa tecnica è riferibile forse anche il muro che separa l’ambiente XXXIII dal XXXV, per il quale, però, il pessimo stato di conservazione e la perdita di buona parte del paramento non consente un’identifi cazione certa. Tracce della stessa tec-nica si individuano anche nell’angolo sud occidentale dell’ambiente XXXV, per il quale però, visti i numerosi interventi di cui è stato oggetto l’ambiente stesso, non si può escludere che si tratti di un riutilizzo. Da notare che, mentre nell’area orien-tale, messa precedentemente in luce, sono presenti numerose strutture in opera laterizia, nell’area in oggetto, tale fase edilizia è rappresentata solo da due pilastri affi ancati posti a nord dell’ambiente XXXIII.
Fig. 3 - Mondragone, località Triglione: strutture lungo la via Appia, ambienti XXXI, XXXII, XXXIII.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 36
Si riconoscono poi alcuni rifacimenti e rappezzi, messi in opera con tecniche e materiali diversi, adoperati spesso nello stesso setto murario.
Tra questi, alcuni interventi in opera vittata con blocchetti di tufo grigio, di dimensioni irregolari, riconoscibili nel muro sud dell’ambiente XXXI (dove il rifa-cimento si imposta sui primi fi lari del muro in opera incerta) e nel tompagno della parete est dell’ambiente XXXV. Sulla stessa parete, nella parte nord, si individua, poi, un rifacimento in vittato misto, con fi lari alternati di tufelli e laterizi.
Vi sono infi ne una serie di strutture attribuibili probabilmente all’ultima fase di frequentazione, realizzate con materiali di reimpiego: laterizi, tegole fratte, pietre e blocchi di calcare di diverse dimensioni, legati generalmente con malta sabbiosa e poco resistente e assemblati con tecnica molto trascurata.
È interessante notare che le strutture siffatte chiudono sul lato nord tre ambienti – XXXIII, XXXV e XXXVII – appoggiandosi a quelle preesistenti, ma si dispongo-no lungo assi diversi; nel caso dell’ambiente XXXVII il muro nord risulta, poi, non essere parallelo rispetto a quello sud, relativo all’impianto più antico.
Sembrerebbe, inoltre, che alcuni degli ambienti risalenti al primo impianto, originariamente più ampi, siano stati successivamente suddivisi in ambienti più piccoli, forse con diversa destinazione d’uso.
Ciò si è verifi cato per gli ambienti XXXI e XXXII, il cui il muro divisorio, rea-lizzato con tegole fratte, si appoggia al muro est in opera incerta, e per gli ambienti XX e XXXVII, separati da un muro conservato solo a livello della fondazione, che è successivo al muro sud, sempre in opera incerta.
Altre trasformazioni sono visibili negli ambienti XXXIII e XXXV: nel primo, sul muro sud vi è un ampio tompagno in conglomerato, poggiato su tre grossi bloc-chi di calcare, che sembra aver chiuso o, con più probabilità, modifi cato l’accesso all’ambiente dal lato strada, mentre nell’ambiente XXXV, è stato tompagnato l’in-gresso dal lato est.
I pavimenti sono andati tutti distrutti, ad eccezione dell’ambiente XX dove sono parzialmente conservati i resti di un pavimento a lastre di laterizio, che però sembra essere pertinente non a tutto il vano, ma solo ad un’area ristretta, a pianta rettango-lare (m 1,20 x 0,80), delimitata da un muretto in conglomerato.
Infi ne, nell’angolo nord-orientale dell’ambiente XLI è conservato un rivestimen-to pavimentale in cocciopesto, con i bordi rialzati, relativo verosimilmente ad una piccola vasca (m 1,50 x 1,20)
M.G.R.d’A. - M.E.C.
37Mondragone, località Triglione. Indagini lungo la via Appia
Elementi di datazione e funzione degli ambienti Per datare la fase di abbandono del sito, in attesa di portare a termine lo studio
complessivo di tutti i materiali rinvenuti nello scavo, ci si è basati sulle forme di terra sigillata provenienti dal riempimento dell’ambiente XXXVI. Tale ambiente è stato scelto essendo l’unico nel quale si è rinvenuto in situ il crollo della copertura, sulla quale poggiava il riempimento (fi g. 4).
I dati analizzati e riportati nella tabella (fi g. 5) si riferiscono solo agli orli, per un totale di 75 frammenti. Le sigillate sono tutte di produzione africana, ad ecce-zione di un frammento di sigillata focea. La sigillata africana A4 è rappresentata da un solo frammento, di una forma per la quale non si è trovato confronto, che è da considerare residuo. Per la sigillata chiara C5 vi è un solo frammento di Hayes 57 in C3, databile secondo Hayes tra il 325 e il 400 d.C.,6 mentre sono più numerosi i frammenti di Hayes 73B in C4, che si colloca tra la fi ne del IV sec. d.C. e il terzo venticinquennio del V sec. d.C.7 e quelli in C5 (Hayes 84,8 85A e 85B9), databili alla seconda metà del V sec. d.C.
Nell’insieme la sigillata chiara C costituisce il 17,3% della terra sigillata, mentre la classe di gran lunga più attestata è la sigillata chiara D10, che rappresenta il 77,3% del totale.
Limitandoci a considerare solo i contesti più vicini, si nota che il rapporto per-centuale tra i frammenti di sigillata chiara D e chiara C è molto vicino a quello
Fig. 4 - Mondragone, Località Triglione: strutture lungo la via Appia, ambiente XXXVI.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 38
riscontrato a Napoli nelle Terme di Carminiello ai Mannesi nella fase VI, datata alla metà-terzo quarto del V sec. d.C., dove però il riferimento è sul totale dei frammen-ti,11 mentre si discosta leggermente da quello riscontrato a Roma nel Saggio P del Tempio della Magna Mater,12 contesto datato tra il 430 e il 475 d.C.
Le forme più frequenti sono la Hayes 6113 che costituisce il 27,5% delle forme della D e il 21,3% del totale degli orli, la Hayes 91A-B14 (20,6%; 16% del totale), la Hayes 80/8115 (15,5%; 12 % del totale ) e la Hayes 6316 (13,7%; 10,6% del totale). Da sottolineare che tra le Hayes 61 si distinguono tre 61A e tredici 61B, all’interno delle quali si riconoscono diverse varianti: le più numerose si accostano alla forma indicata da Bonifay come variante tarda n. 3, con profi lo ad “S”, mentre una è vicina alla variante n. 5.17
Nell’insieme le prime tre forme rappresentano il 63,6 % degli orli della D e il 49,3 % del totale della sigillata. Esse risultano le tre forme prevalenti anche a Napoli nella fase VIC18 e a Roma, sia nel Tempio della Magna Mater,19 che nel contesto della Schola Praeconum datato al 430-450 d.C.,20 dove variano però alcuni indici.
Abbastanza numerosi anche i frammenti di Hayes 67,21 che all’interno della sigil-lata chiara D costituiscono il 12 % degli orli.
Interessante, poi, la presenza di due frammenti di Hayes 69,22 forma non molto diffusa e assente tra i materiali di Napoli.
Sono attestati poi un frammento di Hayes 76,23 uno di 53B24 e infi ne uno della forma Atlante XXXIX,7.25
Classe Tipo N. orli % per produzione % sul totale dei frr.SCA non id 1 1,3SCC H. 57 1 7,6 1,3
H. 73B 6 46,1 8H. 84 1 7,6 1,3
H. 85A 2 15,3 2,6H. 85B 3 23 4
SCD Atl.XXXIX,7 1 1,7 1,3H. 53B 1 1,7 1,3H. 61A 3 5,1 4H. 61B 13 22,4 17,3H. 63 8 13,7 10,6H. 67 7 12 9,3H. 69 2 3,4 2,6H. 76 1 1,7 1,3
H. 80/81 9 15,5 12H. 91A-B 12 20,6 16H. 99B 1 1,7 1,3
Produz. nn.126-128 2 2,6Sigillata focea H. 3C 1 1,3
Fig. 5 - Numero degli orli per produzione e tipo.
39Mondragone, località Triglione. Indagini lungo la via Appia
Le forme della sigillata chiara D fi n qui esaminate si collocano tutte entro la pri-ma metà o al massimo il terzo venticinquennio del V sec. d.C., mentre l’unica forma databile al VI sec. d.C. è costituita da un frammento di Hayes 99B.26
La sigillata microasiatica è rappresentata da un solo frammento di sigillata focea (Late Roman C - Phocean Red Slip Ware)27 Hayes 3C, che si afferma nel terzo ven-ticinquennio del V sec. d.C.28 Sono stati poi rinvenuti due frammenti con pareti molto sottili (circa 3 mm) e orlo indistinto, caratterizzati da una argilla rossiccia e da una vernice rosso scuro, con superfi cie granulosa. Per questo materiale il confron-to più stretto è rappresentato dalla “Produzione fi g. 73, nn.126-128” delle Terme di Carminiello ai Mannesi a Napoli,29 dove questa produzione, per la quale è stata ipotizzata una provenienza nord-africana, è attestata con maggiore frequenza negli strati della prima metà del V sec. d.C.
La maggior parte delle forme prese in esame si data, dunque, entro la metà del V sec. d.C.; esigua è la presenza delle forme che si affermano a partire dalla metà del V secolo (H84, 85A e 85B n C5, Hayes 99B in D) e, soprattutto, sembrano mancare le forme caratteristiche della seconda metà del V sec. e degli inizi del VI sec. d.C.
Questi dati inducono a collocare l’abbandono dell’area in esame ai decenni cen-trali del V secolo, datazione che potrà essere confermata solo dallo studio comples-sivo dei materiali.
Di grande interesse si presentano anche gli altri materiali rinvenuti nel riempi-mento degli ambienti, sia per la notevole quantità e varietà dei reperti sia per l’ampia differenziazione tipologica all’interno delle classi ceramiche.
Essi testimoniano una continuità di frequentazione del sito in pieno V sec. d.C., probabilmente in un’area più ristretta, ma sicuramente poco lontana, e risultano particolarmente signifi cativi in quanto relativi ad un periodo per il quale a Sinuessa mancano evidenze archeologiche,30 mentre per il territorio, con la sola eccezione delle ville di Posto e di S. Rocco, i dati provengono soprattutto da indagini di su-perfi cie.31
Un’elevata percentuale è rappresentata da frammenti di ceramica comune – mol-ti dei quali con decorazione a bande o incisa – e da cucina, ma anche di grossi contenitori (situle e dolii); numerosi anche i frammenti di anfore sia africane che di fabbricazione orientale.
Interessanti, poi, i reperti in marmo, soprattutto lastre di rivestimento di diverse va-rietà, ma anche alcuni frammenti architettonici, tra cui una base modanata e un piccolo capitello. Sono stati rinvenuti inoltre numerosi frammenti di vasellame in vetro.
Da segnalare anche il rinvenimento di tre frammenti con iscrizione, attualmente in fase di studio.
Particolarmente articolato si presenta, poi, il repertorio degli oggetti metallici sia in bronzo che in ferro. Tra quelli in bronzo, oltre a qualche oggetto di ornamento (uno spillone, alcuni pendagli, un bracciale), vi erano anche elementi di rivestimen-to, tra cui diverse guarnizioni in lamina per piccole serrature.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 40
Numerosi anche gli oggetti in ferro, in discreto stato di conservazione, tra cui attrezzi agricoli, coltelli, catene, chiodi. Assai elevato anche il numero delle monete, per la maggior parte di piccolo nominale, rinvenute quasi tutte in pessimo stato di conservazione
Per quanto riguarda la funzione degli ambienti scavati, va innanzitutto ribadito che essi erano parte integrante di un complesso molto più ampio, i cui limiti ancora non sono stati individuati, di cui allo stato attuale è stata messa in luce un’esten-sione di oltre 1200 mq, per il quale era già stata proposta una identifi cazione come mansio.32
Considerando nello specifi co solo il gruppo di ambienti fi n qui esaminati, può essere utile evidenziare alcuni aspetti che possono fornire qualche ulteriore indizio interpretativo. Gli ambienti erano preceduti probabilmente da un portico con pi-lastri, aperto sulla strada, di cui restano tre basamenti. Un altro elemento di sicuro interesse è rappresentato, poi, dall’ambiente XXXVI, aperto sia sul lato strada che su quello opposto (fi g. 6) e che immette in un’ampia area aperta.
L’ambiente, come si è detto, è anche l’unico in cui è stato rinvenuto il crollo in situ della copertura, costituita probabilmente da una tettoia ad unico spiovente, composta di sole tegole. Esso potrebbe dunque essere interpretato come un ingresso con tettoia, che poteva consentire l’accesso dei veicoli senza creare intralcio lungo il percorso principale. Tale ipotesi sembrerebbe confermata dal fatto che, nella zona antistante, la via Appia crea un piccolo slargo, proprio in direzione dell’ambiente XXXVI.
Diffi cile risulta invece identifi care la destinazione degli altri ambienti, alcuni dei quali potrebbero essere interpretati come tabernae soprattutto per la loro posizione a ridosso della strada, anche se mancano ulteriori elementi di riscontro, essendo stati completamente espoliati. Una funzione di servizio o di tipo artigianale potrebbe aver avuto il piccolo vano situato nell’ambiente XX, collegato per altro ad una lunga canaletta di scolo delle acque.
La diffi coltà, per il momento, di una più precisa identifi cazione dipende dalla problematicità, verifi cata in molti casi, della distinzione tra le mansiones e le ville rustiche, complessi che, pur avendo funzioni diverse, potevano avere degli elementi costitutivi comuni.33
Le mansiones, infatti, erano predisposte non solo al ricovero e al cambio degli animali, ma anche al pernottamento dei viaggiatori e disponevano spesso di un im-pianto termale, di tabernae e talvolta di piccoli edifi ci di culto.
È molto probabile poi che alcune ville poste in prossimità di importanti vie di comunicazione avessero una duplice funzione, e destinassero una parte dell’edifi cio all’accoglienza dei viaggiatori.34
L’identifi cazione specifi ca di questi complessi risulta in ogni caso ancora molto problematica, anche a causa di una certa scarsità di dati di scavo, che appare partico-larmente rilevante per l’Italia meridionale,35 ma soprattutto di analisi tipologiche.
41Mondragone, località Triglione. Indagini lungo la via Appia
Tuttavia, alcune delle caratteristiche descritte sembrerebbero rafforzare l’ipotesi che almeno una parte degli ambienti svolgesse funzioni assimilabili a quelli di una mansio: in particolare la presenza del porticato sulla strada, l’ingresso con tettoia che immette in aree aperte, che potevano fungere da cortile di accoglienza, oltre natu-ralmente alla immediata vicinanza ad una importante via di comunicazione, sono elementi riscontrati anche in diversi siti identifi cati come mansiones.
In particolare, i confronti più stringenti sono ravvisabili nella mansio Ad Vacanas sulla via Cassia, dove sono presenti una serie di ambienti interpretabili come taber-nae, aperti sulla strada e preceduti da un porticato,36 e nelle strutture di Settecamini sulla via Tiburtina, dove il porticato immette in un ampio cortile.37
Tali ipotesi potranno, comunque, essere ulteriormente chiarite col proseguire degli studi, cosi come è ancora da approfondire il rapporto tra le strutture fi n qui esaminate e quelle rinvenute a poca distanza, all’interno del moderno cimitero di Mondragone38 nelle quali è stato riconosciuto il centro pubblico del Pagus Sarcla-nus.39
L’area presa in esame presenta, dunque, elementi e problematiche di grande interesse, che andranno ulteriormente approfonditi e a cui lo studio dei materiali fornirà, senz’altro nuovi indizi interpretativi, relativi sia alle fasi di vita che di ab-bandono del sito.
M.E.C.
Note1 Per quanto riguarda questo settore cfr. Ruggi d’ Aragona in Ruggi d’Aragona, Sampaolo 2003, 156-158.2 Ruggi d’ Aragona in Ruggi d’Aragona, Sampaolo 2003, 157.
Fig. 6 - Mondragone, località Triglione: strutture lungo la via Appia, ambiente XXXVI.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 42
3 Da notare che i muri di quest’ambiente presentavano uno spessore - circa 60 cm - maggiore rispetto a quello delle strutture relative agli ambienti prospicienti la strada (35 - 40 cm), che erano realizzati anche con una tec-nica costruttiva più rozza. Ciò può essere dovuto alla diversa funzione degli ambienti o a motivi di tipo statico, come ad esempio l’assenza di un livello superiore per gli ambienti affacciati sulla strada. 4 Hayes 1972, 289; Atlante 1981, 19.5 Hayes 1972, 67-133; Atlante 1981, 58-78.6 Hayes 1972, 92; Atlante 1981, 66.7 Hayes 1972, 121-124; Atlante 1981, 72-73.8 Hayes 1972,132-133; Atlante 1981, 69.9 Hayes 1972, 133; Atlante 1981, 73.10 Hayes 1972, 291-298; Atlante 1981, 78-117; sui centri produttivi Mackensen 1998, 23-39; Tortorella 1998, 41-69.11 Soricelli 1994, 147. Colgo l’occasione per ringraziare il Prof. Soricelli per i preziosi suggerimenti.12 Carignani et al. 1986, 27-31.13 Hayes 1972, 100-106; Atlante 1981, 83-84.14 La condizione molto frammentaria dei vasi di questa forma non consente di attribuirli con certezza all’uno o all’altro tipo. Hayes 1972, 140-144; Hayes 1977, 289; Atlante 1981, 105-107; di recente Tortorella 1998.15 Hayes 1972,127-128; Hayes 1977, 283; Atlante 1981, 104.16 Hayes 1972, 109; Atlante 1981, 85-86.17 Bonifay 1998, 71-77.18 Soricelli 1994,158 Tab.19.19 Carignani et al. 1986, 27-43.20 Whitehouse et al. 1982, 54-101.21 Hayes 1972, 112-116; Atlante 1981, 88.22 Hayes 1972, 118; Atlante 1981, 89; di recente Hayes 1998, 10.23 Hayes 1972, 124-5; Atlante 1981, 89-90.24 Atlante I, 87. Anche questa forma non è attestata tra i materiali di Carminiello ai Mannesi.25 Atlante 1981, 90.26 Hayes 1972, 152-155; Hayes 1980, 516; Atlante 1981, 109-110; Tortorella 1998, 43.27 Hayes 1972, 323-370; Hayes 1980, 525.28 Hayes 1972, 337; Atlante 1981, 232.29 Soriecelli 1994, 139-141.30 Per Sinuessa e il suo territorio cfr. Gasperetti 1993, 59-69; Crimaco 1993, 49-52.; Proietti 1993, 71-76.31 Per le villa di Posto cfr. Cotton 1979; per quella di San Rocco, Cotton, Metraux 1985.32 Ruggi d’Aragona in Ruggi d’Aragona, Sampaolo 2003, 157.33 Per una analisi complessiva del problema cfr. Mezzolani 1992, 105 segg., con bibliografi a generale.34 Uno degli esempi più signifi cativi in tal senso è rappresentato dalla villa-mansio di Albisola, in Ligura (indicata sulla Tabula Peutingeriana come Alba Docilia) posta lungo la via Iulia Augusta. L’impianto è articolato in diversi settori, di cui quello abitativo, con impianto termale, è distinto da quello produttivo, al quale si affi ancano i cubicula per i viaggiatori. Cfr. Tinè Bertocchi 1971, 64-66; Tinè Bertocchi 1976, 113-122; Tinè Bertocchi 1978, 95 segg..35 In Campania è notizia recente il ritrovamento di un asse stradale affi ancato da una struttura interpretata come mansio con fase di abbandono databile al III-IV d.C., situata nel Comune di Teverola all’incrocio tra la via Appia ed i Regi Lagni. Cfr. Laforgia, De Filippis 2002, 43-44; sulle stationes in Calabria cfr. Crogiez 1990, 389-431.36 Gazzetti 1985, 39-56; Gazzetti 1986, 155-165.37 Caiola et al. 1986, 678-690; Messineo 1987, 135-138 con bibliografi a precedente.38 Ruggi d’Aragona in Ruggi d’Aragona, Sampaolo 2003, 152-153.39 De Caro 1999 b, 367-368; per l’ipotesi di individuazione nelle strutture del cimitero di un villaggio rurale, identifi cato con il Vicus Papius, parte di un sistema di vici afferenti al Pagus Sarclanus cfr. Crimaco 2002, 95-97.
Nota preliminare sullo scavo della porticus post scaenam e della latrina pubblica del teatro romano di Sessa Aurunca*
Sergio Cascella
È oltremodo diffi cile offrire in forma succinta, ma al tempo stesso esaustiva, i risultati della seconda campagna di scavo effettuata, nel corso del 2003, nell’area del teatro romano di Sessa Aurunca.1 Infatti, la mole di dati recuperata circa l’architet-tura e le dinamiche di abbandono e seppellimento delle evidenze scavate è tale che avrebbe richiesto uno studio ben più approfondito. Ciò nonostante si è scelto di fornire il presente contributo come edizione assolutamente preliminare delle princi-pali risultanze dello scavo. Considerato che già nel corso del primo lotto di lavoro2 era apparsa evidente l’entità dei resti che si estendevano alle spalle dell’edifi cio sce-nico, in questa seconda tranche di scavo, la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta ha ritenuto conveniente da un lato completare il disseppellimento di quelle parti del teatro che non erano state ancora portate in luce, e dall’altro indagare, per quanto possibile, la zona postica alla scena. Questa è occupata dalla porticus post scaenam, che è stata completamente portata in luce, dal relativo piazzale antistante e dalla latrina pubblica, questi ultimi purtroppo solo parzialmente esplorati (fi g. 1).
Fig. 1 - Sessa Aurunca, teatro romano: pianta ricostruttiva.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 44
Il sito, che è contraddistinto da dislivelli in parte naturali e in parte modifi cati per accogliere la cavea del teatro, ha ai suoi piedi un pianoro, di forma grosso-modo triangolare, con il lato di base corrispondente all’asse N-S lungo il quale si organizzano il frontescena e le due basiliche laterali. Per la realizzazione di que-sti edifi ci si rese necessaria una massiccia regolarizzazione artifi ciale del pendio roccioso, che ancora oggi mostra improvvisi salti di quota convergenti verso il vallone “Fossitiello”, forse coincidente con una strada antica che si riallacciava alle percorrenze che menano verso la via Suessa-Minturnae.3 Ovviamente una simile orografi a ha sicuramente fortemente condizionato sia l’architettura del teatro, che le sistemazioni adiacenti. Difatti, il salto di quota meridionale, compreso tra l’area dell’antico foro e il teatro, fu oggetto di imponenti opere di sbancamento che permisero la creazione di un piano edifi cabile per la costruzione della monu-mentale basilica meridionale e della relativa scalea di collegamento con la viabi-lità cittadina. A settentrione, invece, la scarpata rocciosa che delimita la cavea, condizionò l’orientamento (E-O) e le dimensioni della connessa basilica, la cui planimetria non è speculare a quella meridionale, ed inoltre, essendo essa limitrofa alla campagna circostante, risultò poco adatta ad assolvere la funzione di grande foyer rappresentativo, ed ebbe quindi principalmente lo scopo di redistribuire le percorrenze comprese tra la parodos settentrionale e la porticus. In ogni caso, come era uso comune, le due basiliche furono disposte lateralmente all’edifi cio scenico formando con la facciata del portico posto dietro di essa, una successione di co-struzioni dal grande impatto scenografi co e monumentale estesa per una lunghez-za complessiva di 130 m.
Dato che la particolare morfologia dell’area non permetteva la costruzione del classico quadriportico4 che di solito si dispone alle spalle della scena dei teatri, ven-ne realizzata una sorta di stoa rettilinea a due navate, chiusa a nord e a sud dalla fronte occidentale delle due basiliche e a est dalla facciata postica del frontescena.5 Il piazzale antistante, indagato per il momento solo per una porzione molto piccola, limitata sostanzialmente ai primi 5 m lungo la fronte, aveva una forma irregolare, probabilmente trapezoidale, con il lato nord delimitato dalla facciata sud della latri-na pubblica, mentre il versante meridionale è defi nito da un lungo muro in opera reticolata che ha una giacitura divergente (NE-SO) rispetto agli assi di sviluppo del teatro, essendo ad esso preesistente. Infatti, la porzione del declivio meridionale, risparmiato dagli sbancamenti per la costruzione della relativa basilica, conserva il suo pendio originario delimitato alla base da un muro di contenimento che ad E si raccordava con la fase più antica della scalea d’ingresso al teatro, mentre a O inglo-bava tratti in opera quadrata di blocchi di tufo, con andamento a scarpa, relativi alla primitiva murazione della colonia latina. Scavi, ancora in corso, hanno interessato l’area soprastante questa struttura, rilevandone la natura sostruttiva. In realtà questo muro costituiva la basis di una grande domus suburbana, che disponendosi su terraz-
45Nota preliminare sullo scavo della porticus post scaenam...
ze digradanti, occupava il pendio compreso tra l’attuale Porta dei Cappuccini e lo spiazzo antistante la porticus.
Quale fosse la delimitazione occidentale del piazzale al momento non è dato sapere, così come ad un primo esame l’imponente deposito di blocchi architettonici di tufo, che si disponeva lungo quasi tutta la fronte della porticus, potrebbe essere re-lativo ad un edifi cio medio o tardo repubblicano, distrutto in epoca tardo imperiale, con evidenti fi ni spoliativi, forse localizzato al disotto di quel che resta dell’uliveto della “Gagliardella”. Ovviamente solo lo scavo integrale di tutta l’area potrà chiarire la natura di questi ultimi rinvenimenti e la sistemazione della scarpata occidentale.
Le strutture murarie della porticus mostrano le due principali fasi edilizie che caratterizzano il teatro romano di Sessa Aurunca: la prima, d’età augustea, contrad-distinta da strutture in opera quadrata, e la seconda, d’età antonina, testimoniata degli imponenti rifacimenti in opera mista e laterizia voluti da Matidia Minore.6 La porticus, che si estende per una lunghezza di 56 m, ha una pianta contraddistinta da due navate (largh. 5 m l’una) accostate per i lati lunghi (fi g. 2). Quella più interna comunicava a N e a S con le relative basiliche tramite due ingressi speculari, di cui quello meridionale (fi g. 2, n.1) è particolarmente ben conservato. Si tratta di un vano (largh. 2,10 m) con tre gradini in blocchi di tufo (pedata di 45 cm; h. 20 cm) che raccordano la quota del pavimento del portico con il livello di calpestio della basilica, sottoposto a questo di circa 55 cm. Il braccio più esterno, corrispondente
Fig. 2 - Sessa Aurunca, teatro romano: pianta ricostruttiva della porticus post scaenam e dell’edificio scenico.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 46
alla facciata del portico, mostra, invece, l’ingresso meridionale (fi g. 2, n.2), costi-tuito da un ampio portale (largh. 4 m) che immetteva nella basilica lungo la navata antistante il ninfeo del Nilo, mentre quello settentrionale (fi g. 2, n.3), più piccolo (largh. 2,35 m), permetteva l’ingresso nell’angolo SO della basilica. Delle strutture originarie dell’età di Augusto restano, oltre ai lacerti del muro di fondo dell’edifi co scenico, la prima e parte della seconda assise di blocchi (largh. max 1,40 m - min. 40 cm; lungh. 90 cm; h. 60 cm) che delimitano la parete sud della basilica settentriona-le e quella nord della basilica meridionale, strutture che per la loro natura vennero quasi completamente spoliate.
Ben conservato è, invece, il basamento in blocchi di tufo della fronte del portico. Il fatto che esso, nelle porzioni lasciate libere dagli interventi posteriori, non riveli tracce di piedritti o plinti di colonne fa ipotizzare che i successivi pilastri medio imperiali abbiano occupato la medesima posizione di quelli che probabilmente nella fase augustea costituivano l’elevato della porticus, rendendo quindi sostanzial-mente immutata la planimetria dell’edifi cio. Un piccolo saggio, effettuato ai lati del basamento, ha rivelato che i blocchi di tufo poggiano su una trave in calcestruzzo che funge da fondazione. Questa è eseguita in cavo armato, come testimoniano le impronte di tavole e paletti in legno lasciate sulla malta, mentre i pochi reperti ce-ramici recuperati confermerebbero una datazione all’età augustea per l’impianto del basamento del portico. Infi ne, sul lato esterno di questa struttura fu addossata una serie continua di blocchi di tufo sagomati per accogliere la canaletta atta allo scolo delle acque meteoriche che displuviavano dalla copertura del portico.
Come si vede la esiguità dei resti non ci consente alcuna ipotesi ricostruttiva del-l’elevato della prima fase, che in ogni caso dovette subire i danni conseguenti ad un evento sismico o ad un cedimento statico, verifi catosi forse tra la fi ne del I o l’inizio del II sec. d.C. Infatti, com’è testimoniato dalla monumentale iscrizione trovata nella basilica meridionale, il portico venne completamente ricostruito da Matidia Minore.7 I massicci interventi in opera laterizia e mista, che in parte inglobarono le strutture precedenti, collegarono in un unico complesso sia il rifacimento delle due basiliche che la porticus post scaenam, che venne adeguata ai nuovi canoni estetici e funzionali della media età imperiale.
Oltre le murature augustee che a N e S delimitarono ancora nel II sec. d.C. il portico, l’intera facciata venne ricostruita con la successione di 22 pilastri (fi g. 2, n.4), 12 per navata, a pianta rettangolare (1,15 m x 75 cm), oggi conservati per una altezza variabile compresa tra 1,30 m e 40 cm, costruiti in opera laterizia (lateres lungh. 23 cm; spess. 3 cm; il modulo di 5 mattoni e 5 letti di malta è di 25 cm) e di-stanziati l’uno dall’altro di 2,70 m. Lo strato di crollo al momento dello scavo con-servava chiaramente i resti delle piattabande in bipedali che raccordavano i pilastri, mentre altri elementi, fortemente inquinati da manomissioni posteriori, potrebbero indicare la presenza di un piano superiore. La distanza tra i pilastri e le strutture in crollo suggerisce un’altezza originaria del primo piano di circa 5-6 m, misura che
47Nota preliminare sullo scavo della porticus post scaenam...
può essere portata a circa 12 m se ipotizziamo un secondo piano. Nel corso del rifacimento voluto da Matidia, venne anche ricostruita la canaletta (fi g. 2, n.5) per il defl usso delle acque meteoriche. Questa, realizzata in mattoni e tegole (largh. 46 cm; prof. 25 cm) per una lunghezza di quasi 60 m, obliterando la precedente con una serie di bipedali, era costituita da due bracci che dalle estremità settentrionale e meridionale del portico convergevano verso l’arcata centrale della facciata (largh. 4,42 m), posta in corrispondenza dell’apertura postica della porta regia. Qui era ricavato un pozzo (diam.1 m ca.) in muratura (fi g. 2, n.6), probabilmente in antico monumentalizzato con una vera marmorea, che collegava la canaletta con la grande cloaca che, dopo aver raccolto le acque provenienti da tutte le condotte e le pluviali dislocate nel teatro, attraversava il centro dell’orchestra e l’iposcenio (fi g. 2, n.7), menando all’esterno del complesso teatrale. Questa disposizione suggerisce che la canaletta non raccoglieva le acque pluviali per percolamento, ma attraverso due discendenti posti ai margini N e S del prospetto della porticus.
La ricostruzione della facciata, che è possibile ipotizzare dai dati di scavo, la rende quindi più simile a quella di un grande edifi cio pubblico d’età medio imperiale, che ai classici ed eleganti portici posti dietro le scene dei teatri. L’aspetto esterno (Tav. 6), sebbene incassato tra le alte pareti delle due basiliche e della retrostante scena, sarà ovviamente stato ingentilito da un’abbondante decorazione marmorea e pittorica oggi scomparsa e che quindi non ci è possibile nemmeno ipotizzare. Maggiori dati, invece, possediamo circa le decorazioni interne. Riguardo i livelli pavimentali, oggi completamente scomparsi, i dati di scavo indicano che le due navate dovevano es-sere pavimentate con lastre di calcare o marmo che una volta divelte hanno lasciato poche tracce, in parte visibili al momento della scoperta sullo strato di preparazione conservato nei pressi dell’ingresso alla basilica meridionale. Tracce di un differente strato di allettamento si sono riscontrate in prossimità delle aperture postiche della scena. Infatti, in corrispondenza della porta regia, il piano di calpestio del portico mostra tracce evidenti della preparazione di un emblema in opus sectile, come di-mostrano i moltissimi frammenti di lastrine in marmi colorati, purtroppo non più ricomponibili. Alcuni elementi ancora in situ, e quelli recuperati durante lo scavo dello strato di crollo, indicano che i pilastri e le pareti erano decorate per almeno i primi due o tre metri da lastre di marmo. Queste erano bianche sui pilastri, mentre una porzione, conservata nei pressi dell’ingresso alla basilica meridionale (fi g. 3), dà un’idea dello sfarzo profuso nella navata più interna durante i restauri medio imperiali. È, difatti, ancora visibile parte della zoccolatura in lastre di marmo grigio antico, di forma rettangolare (lungh. 1,30 m; h. 32 cm; spess.1 cm) unite con malta cementizia alle pareti, e ulteriormente fi ssate tramite le tipiche grappette bronzee. Su queste si impostava un piccolo listello in marmo bianco (spess. 2 cm) su cui erano montate le lastre (largh. 75 cm), anch’esse in grigio antico, conservate per un’altezza di circa 1 m. I numerosi frammenti di affreschi in tardo IV stile trovati coinvolti nello strato di macerie indicano che le parti alte della muratura erano in-
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 48
vece decorate con dipinti. Tra i frammenti segnaliamo un lacerto di intonaco con graffi ti, oggi esposto nella sala VII della mostra attrezzata nei locali del Castello Ducale di Sessa Aurunca,8 ove compaiono alcuni cavalli, di cui uno mostra evidente la palma del vincitore.
La fi la più esterna dei pilastri della facciata della porticus mostra, nel lato rivolto verso l’interno della navata, la successione 12 basamenti in muratura (fi g. 2, n.8), addossati ai pilastri, di cui alcuni recavano al momento della scoperta resti del rive-stimento marmoreo. Si tratta probabilmente di una serie di basi per statue che do-vevano formare una galleria di sculture iconiche,9 tra cui una probabilmente doveva rappresentare la personifi cazione della colonia. Infatti, tra i numerosi frantumi di sculture recuperati, è stata trovata la parte sommitale di una cornucopia colma di frutti e un brandello di iscrizione, databile ancora al I sec. d.C., in cui è possibile ravvisare le parole: GENIO COLONIAE.
Durante lo scavo, l’analisi delle strutture murarie ha mostrato una ulteriore fase edilizia che non si era evidenziata in altre parti del teatro. Probabilmente, in epo-ca tardo imperiale (forse alla fi ne del III sec. d.C.?), un nuovo cedimento statico interessò gran parte della facciata della porticus, che dovette crollare. Sei pilastri su quattordici del prospetto esterno vennero completamente rifatti. Essi, impostati sui primi tre o quattro fi lari in laterizio dei pilastri d’epoca precedente, sono realizzati in vittato misto, composto da blocchetti di tufo grigio alternati a due mattoni. È probabile che anche alcune parti dell’elevato, poste al di sopra delle piattabande, vennero “cucite”10 con le murature d’età medio imperiale, almeno a giudicare da alcuni frammenti di parete, anch’esse in vittato misto, trovati coinvolti nello strato di crollo.
La stratigrafi a archeologica di riempimento della porticus post scaenam, forte-mente condizionata dalla continuità d’uso che non ha permesso la formazione di
Fig. 3 - Sessa Aurunca, teatro romano: particolare del rivestimento marmoreo della parete sud della porticus post scaenam.
49Nota preliminare sullo scavo della porticus post scaenam...
scarichi omogenei, è apparsa divisa sostanzialmente in due unità sovrapposte. Quel-la immediatamente sottoposta al piano di campagna era costituita dalle macerie delle murature mescolate in uno stato caotico ed in parte fortemente inquinate da elementi posteriori, riferibili all’attività di spoliazione medievale. Questo strato, che copriva anche la fossa scenica, mostra un livello di schegge in marmo bianco, anche minutissime, che costituisce un piano di lavorazione riconosciuto in più punti dello scavo. È evidente che l’attività di recupero degli elementi in marmo bianco era solo in parte fi nalizzata al reimpiego, poiché quasi tutto ciò che veniva trovato era fran-tumato sul posto per essere più facilmente trasportabile verso le calcare.11 L’opera di spoliazione, nonostante che alcune basi, architravi e capitelli fossero stati sgrossati e poi inspiegabilmente abbandonati, fu portata a termine. Infatti, i pochi elementi architettonici integri in marmo bianco giacevano nel sottostante strato che mostrava intatto il crollo delle strutture. Questo deposito di macerie sigillava i piani di cal-pestio e le pareti già prive dei rivestimenti marmorei, indizio che l’edifi cio era stato ampiamente defunzionalizzato e spoliato, almeno dei rivestimenti, probabilmente già nel corso della prima metà del IV sec. d.C. Inoltre, la disposizione delle rovine mostra alcune caratteristiche che hanno consentito di formulare un’ipotesi circa le dinamiche di seppellimento dell’edifi cio. Invero, il quadro fessurativo e i nuclei di muratura trovati in posizione di caduta durante lo scavo degli edifi ci annessi al teatro indicano che l’intera costruzione dovette crollare, probabilmente ad opera di una calamità naturale. Questo dato è reso ancor più evidente dalla giacitura dei pilastri di ambedue le navate del portico che, frammentati in vari tronconi ancora in connessione anatomica, sono stati trovati fracassati sul piano di calpestio, come abbattuti da un onda d’urto proveniente da NE.
I pochi frammenti ceramici in terra sigillata chiara D, recuperati sotto il crollo e a contatto con il piano di calpestio, indicano una datazione per questo evento collocabile intorno alla metà del IV sec. d.C. È suggestivo collegare questi elementi cronologici al famoso terremoto che nel 346 d.C. squassò il Sannio e la Campania settentrionale,12 ma ovviamente solo analisi più approfondite di questi dati di scavo, confrontati con quelli dei monumenti delle aree vicine, potranno chiarire la dina-mica e la datazione di questa distruzione.
Lungo il lato settentrionale del piazzale antistante la porticus, forse nel corso delle medesime ristrutturazioni tardo imperiali, fu creato un altro apprestamento rien-trante in quei commoda che caratterizzavano molti edifi ci pubblici dell’età imperiale. Quest’area, dopo le ristrutturazioni volute da Matidia, era delimitata da un muro in opera mista di reticolato e laterizio, oggi conservato per circa 1,30 m di h. e 10 m di lungh., con almeno un ingresso, che permetteva il passaggio dalla piazza all’area retrostante, ingresso che venne quasi subito murato con un tompagno, anch’esso realizzato in opera reticolata (mod. 8 x 8 cm). Questa sistemazione fu alterata in epoca tardo imperiale quando, nell’angolo NO della parete occidentale della basilica settentrionale, venne addossato un muro realizzato in opera vittata di blocchetti di
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 50
tufo grigio che, con la delimitazione settentrionale del piazzale prima de-scritta, costituì un vasto ambiente adibito a latrina (Tav. 7). Purtrop-po quest’edifi cio è stato scavato solo per poco più di metà della sua estensione, poiché la restante parte ricade in un’area non espropriata e parzialmente devastata nel corso dei decenni passati dalla costruzione di un fabbricato per uso abitativo. In ogni caso la sua planimetria è age-volmente ricostruibile poiché suppo-niamo che la parte ancora sepolta, o
più probabilmente andata distrutta, doveva essere speculare a quella portata in luce. Sostanzialmente si tratta di un ambiente a pianta rettangolare che in origine doveva misurare circa 12 m di lungh. e 9 m di largh., con pareti, oggi conservate per 4 m di h., ma che probabilmente dovevano superare abbondantemente i 5 m.
La costruzione, che sembra rientrare nel tipo di latrina a peristilio,13 mostra il tipico contrasto tra l’angusto ingresso, ricavato lungo la parete O della basilica, e lo spazio interno, contraddistinto da una certa ricchezza ornamentale. Il pavimento, in tassellato bianco14 (fi g. 5) di grossa pezzatura, si interrompe al centro della parete meridionale dove è visibile una sorta di impluvio a pianta rettangolare (3 x 2 m), pa-vimentato con il medesimo mosaico, mentre i bordi e le pareti erano rivestite di la-stre di marmo bianco Proconnesio, di cui sono stati trovati molti frammenti. Questa disposizione suggerisce che l’intero ambiente doveva avere una copertura a spioventi compluviati. Poiché il lato sud della vasca coincide con il perimetro meridionale della latrina, è evidente che in questo punto le travi della copertura dovevano essere infi sse nella parete senza alcun sostegno. Lungo i vertici settentrionali della vasca, invece, la pavimentazione mostra le tracce di due basi di colonne divelte che dove-vano reggere le falde displuviate del tetto. Questo dato potrebbe essere associato alla notizia, data dagli abitanti del posto, circa il ritrovamento, avvenuto molti anni ad-dietro, di colonne in marmo colorato. Parimenti nel pavimento musivo posto lungo il lato settentrionale dell’impluvio, fu ricavata una fossa di spoliazione di forma perfettamente circolare (diam. 1,50 m; prof. 60 cm). Questa buca fu praticata per asportare la base di un probabile labrum marmoreo, come sembrerebbero testimo-niare anche le tracce lasciate sulla malta di una fi stula di piombo per il collegamento idrico. Come in tutte le latrine monumentali anche in questa del teatro di Sessa il pavimento in tassellato era bordato da una canaletta, scolpita in blocchi di calcare (lungh. 1,80 m; largh. 70 cm) giust’apposti, che si origina dall’impluvio, ed era usata per le necessarie pulizie dei frequentatori di questo locale.15 Tra la canaletta e
Fig. 4 - Sessa Aurunca, teatro romano: veduta d’insie-me della pavimentazione in mosaico della latrina.
51Nota preliminare sullo scavo della porticus post scaenam...
le pareti perimetrali dell’edifi cio si svolge un profondo canale (largh. 70 cm; prof. 2 m ca. ) utilizzato, ovviamente, come fognatura che con pendenza da S verso N convogliava i liquami verso la cloaca principale, oppure verso un pozzo nero, ripulito periodicamente dal conductor foricarium.16
Sulle pareti E e N sovrastanti la fogna, sono presenti, a distanze regolari (1,60 m), i fori per l’inserimento delle mensole che reggevano i sedili (fi g. 6). Di queste ne sono perfettamente conservate due in tufo ancora collocate nei loro allog-giamenti (30 x 30 cm), mentre, durante lo scavo del sottostante canale fognario, sono stati rinvenuti molti frammenti di lastroni di marmo bianco (spess. 10 cm) riferibili sia ai resti dei sostegni, che ai se-dili, i quali, posti sulle suddette mensole e tramite alcuni fori posti a distanze regola-ri, assicuravano l’utilizzo dell’impianto.17 Lo scavo della fogna ha restituito, inoltre, molti frammenti di lastre di marmo bian-co (spess. 2 cm) che dovevano costituire il rivestimento delle pareti, e un gruppo di ceramica che data l’abbandono dell’edifi cio entro la prima metà del IV sec. d.C., forse immediatamente prima del sisma che in epoca tarda distrusse gran parte del teatro romano di Sessa Aurunca.
Note* Vorrei ringraziare il Prof. Stefano De Caro, Direttore Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Cam-pania e, sino al 2003, Soprintendente per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, la Dott.ssa V. Sampaolo, Soprintendente reggente dal 2003 al 2004, il funzionario responsabile per l’uffi cio archeologico di Sessa Aurunca, Dott.ssa M.G. Ruggi d’Aragona, per aver concesso i permessi necessari. Le foto sono a cura dell’Autore, mentre i rilevi topografi ci sono degli Architetti A. Balasco e F. Sampaolo; le elaborazioni grafi che e ricostruzioni dell’Architetto G. Bruno.1 D.M. 23.03.2001 – Legge n. 662/96 art. 3 comma 83 – Capitolo di spesa 7753 – Piano triennale Lotto 2001/2003.2 Per un inquadramento preliminare sullo scavo del teatro romano di Sessa Aurunca cfr. Cascella 2002.3 Villucci 1981, 156 segg.
Fig. 5 - Sessa Aurunca, teatro romano: veduta della parete est della latrina, con
mensole per il sostegno dei sedili.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 52
4 Gros 1996, 310 segg. Vitruvio dopo aver parlato del foro e del teatro dice che «dietro la scena vanno costruiti dei portici che offrono riparo agli spettatori durante gli improvvisi temporali» (V, 9, 1-5). Non sembra esistere uno studio specifi co sui portici dei teatri romani, ma studi monografi ci su singoli monumenti affrontano lo scavo delle relative porticus post scaenam. Caputo 1959, 28 segg.; Caputo 1987, 114 segg.; Cateni 1993, 52 segg.; Manacorda 2000, 11 segg. 5 Una analoga sistemazione, dettata da simili condizioni geomorfologiche, è presente nel teatro romano dell’an-tica Trieste ove dietro la scena compare una porticus rettilinea, ad una sola navata, composta da 18 pilastri. Cfr. Verzár-Bass 1991, 40.6 Sugli interventi di Matidia nel teatro romano di Sessa e sul suo evergetismo cfr. Cascella 2002, 86 segg. e relativa bibliografi a. 7 Cascella 2006, 101 segg..8 N. inv. 318209.9 I portici posti alle spalle dei teatri erano spesso decorati con vere e proprie gallerie d’arte. Il caso più clamoroso è costituito dai portici del teatro di Pompeo a Roma, sotto i quali erano esposte opere di artisti greci, alcune delle quali procurate da Attico, noto mercante d’arte, mentre al centro del portico erano aiuole delimitate da muri e fontane che racchiudevano boschetti di platani. Cfr. Coarelli 1996, 360 segg.10 Per un inquadramento generale sulle tecniche di consolidamento antico cfr. Giuliani 1990, 207 segg.11 Nessuna traccia di calcara è stata trovata nell’area del teatro che quindi era usato solo come una cava di pietra. È probabile che questo materiale servì al cantiere di costruzione del Duomo cittadino, ove tra i marmi reimpie-gati, fi gurano anche alcuni monconi di colonna, capitelli e architravi provenienti dal teatro. 12 CIL IX, 2337, 2338.13 Per un inquadramento generale sulla funzione e sulla tipologia di questi necessaria cfr. Neudecker 1994.14 La latrina del foro di Ostia e le due monumentali foricae del macellum puteolano sono pavimentate con lastre di marmo, mentre la latrina lungo il cardo massimo di Minturnae ha un pavimento in opus spicatum.15 Sen., Epist.1, 70, 20; Mart. 12, 48, 7.16 Iuv., Sat. 3, 38.17 Considerando una distanza media tra i fori di circa 60-70 cm, è possibile ipotizzare una capacità di accoglien-za di circa 30 posti.
Una proposta di parco archeologico ambientale del Montemaggiore (Archeologia dei Monti Trebulani)*
Colonna Passaro
L’idea di un parco archeologico-ambientale dei Monti Trebulani nasce dalla con-sapevolezza, seguita ad anni di quotidiano lavoro, che l’intero comparto accoglie realtà naturali e storico-archeologiche di rilevante interesse.
La pluristratifi cazione storica di questi luoghi non ha avuto fi nora l’attenzione che merita da parte della ricerca scientifi ca. I centri antichi di Cales e di Trebula, ad esempio, pur tutelati da anni da strumenti urbanistici e da norme specifi che di tute-la, attendono interventi sistematici e continuativi di recupero e di valorizzazione.
In termini territoriali la perimetrazione del parco dovrebbe comprendere l’intero massiccio del Montemaggiore (fi g. 1), una zona sicuramente meglio preservata di altre: penso all’area a ridosso dell’agro aversano, al litorale domitio e specialmente all’hinterland napoletano. In tali zone il paesaggio agricolo-collinare, caratterizzato da colture arboree, in particolare ciliegi e meli, è praticamente sparito in conse-
Fig. 1 - Caserta, cartografia IGM (1/100.000), corografia del Massiccio dei Monti Trebulani. Ipotesi di perimetrazione del Parco Archeologico Ambientale.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 54
guenza di una dissennata politica che, privilegiando massicci interventi di edilizia abitativa, non ha saputo gestire un’antropizzazione dei luoghi in termini graduali e qualitativamente accettabili. Lo stravolgimento ambientale ha comportato anche la dispersione del patrimonio storico, architettonico ed archeologico dovuta non tanto alla mancanza di leggi di tutela, quanto all’irresponsabilità degli amministra-tori pubblici, che non hanno voluto, o potuto, rendere la trasformazione dei luoghi compatibile con la conservazione delle caratteristiche tradizionali. Come diceva il Croce: « [...] il paesaggio è un prodotto dell’intelligenza e delle mani dell’uomo non solo un dono del Signore [...]». Tuttavia, mentre per molte aree del napoletano si potreb-be ormai parlare solo di recupero ambientale, per questo territorio molto ancora è possibile fare, purché ci sia la volontà d’intervenire con piani articolati che tengano conto delle specifi cità dei luoghi e delle realtà socio-economiche esistenti ed abbiano come obiettivo il raggiungimento di soluzioni rispettose delle diverse esigenze di tutela e di sviluppo, così come è avvenuto per i massicci del Taburno, del Matese e di Roccamonfi na.
Il massiccio dei Monti Trebulani costituiva in antico una vera e propria barriera tra la pianura alifana e quella capuana – quest’ultima delimitata a Nord dal corso del Volturno, fi ume navigabile ed importante via commerciale (Stat., Silv. IV, 3, 67). Ad occidente il fi ume Savo separava il distretto dei Monti Trebulani dal cono vulcanico del Roccamonfi na. Il territorio, segnato da una fi tta rete di sentieri e di passi, formatisi nel tempo anche attraverso la pratica della transumanza, ha conser-vato peculiarità paesaggistiche praticamente intatte. Gran parte dei rilievi rimane ammantata di boschi con profondi burroni, altopiani e verdi valli. Sulle pendici più basse dominano le selve di castagni e la macchia mediterranea con piante aromati-che, altrove scomparse. I boschi cedui hanno dato lavoro a generazioni di carbonai: bastava, fi no a qualche tempo fa, percorrere la mulattiera “le Campole” nel territorio dell’antica Trebula Balliensis per vederli all’opera. Notevole è ancora oggi la presenza di sorgenti d’acqua con proprietà benefi che, decantate dalle fonti antiche. Nelle fasce pedemontane si snodano paesaggi di dolci colline a coltura di viti e olivi, con un’attività agricola e pastorale praticata nel solco di antiche tradizioni.
Tale paesaggio fa da sfondo e cornice alle numerose e rilevanti testimonianze archeologiche che attestano la frequentazione di questo territorio fi n da epoca anti-chissima, anche se le emergenze più monumentali sono rappresentate da impianti abitativi e strategici di difesa per lo più di epoca sannitica, localizzati sulle vette più alte, e dai centri urbani romanizzati di Cales, Trebula, Caiatia e Cubulteria.
Al paleolitico medio e superiore vengono attribuite punte e lame di selce rinve-nute sul versante settentrionale e nell’area centrale del massiccio del Montemaggio-re.1 La fase eneolitica è documentata da cuspidi di selce, punte di ossidiana, pugnali silicei, raschiatoi e percussori di pietra levigata e frammenti ceramici d’impasto, tutti ritrovamenti sporadici e di superfi cie. In territorio caiatino, nei pressi di Monte Grande, località Castelluccio, è stata segnalata la presenza di un villaggio dell’età del
55Una proposta di parco archeologico ambientale del Montemaggiore
bronzo medio e recente; alla stessa età risale l’insediamento di Monte La Costa nel Comune di Calvi Risorta.2 A partire dall’età del ferro s’intensifi ca, soprattutto nella fase orientalizzante, il popolamento dell’area documentato da materiali provenienti da abitati e da necropoli, a riprova di una stabile e più consistente occupazione del territorio. D’incerta localizzazione restano la necropoli con ricchi corredi rinvenuta nell’Ottocento, forse sulle pendici, di Rocchetta e Croce, e quelle indiziate da reper-ti decontestualizzati in zone varie dei Monti Trebulani.3
Gli scavi degli ultimi anni hanno accresciuto la conoscenza del sito preromano di Cales, uno dei più importanti della Campania, ancora poco esplorato special-mente per l’abitato arcaico. Cales è attribuita dalle fonti al popolo degli Ausoni. Gli Ausoni/Aurunci – a seconda che si privilegi la tradizione letteraria o l’ambito geografi co – popolo di lingua affi ne allo strato più antico del latino, occuparono, tra l’età del bronzo e la prima età del ferro, un’ampia zona nel centro della penisola italiana dal Lazio alla Campania. Sul popolamento della Campania settentrionale all’arrivo dei Greci a Cuma, gli storici antichi ci hanno tramandato i nomi di due popoli: gli Ausoni, con i loro discendenti Aurunci, e gli Opici/Osci antenati dei Campani, gli Italici della pianura distinti dagli Italici della montagna: i Sanniti.4
Cales, localizzata fi n dal Seicento nella località Calvi Vecchia del Comune di Calvi Risorta,5 a differenza di altri siti come Teanum Sidicinum, Allifae e Capua non è stata oscurata dalla sovrapposizione del centro urbano moderno, il quale è invece sorto più a monte alla base delle ultime pendici occidentali del Montemaggiore. In epoca arcaica, il pianoro tufaceo su cui insisterà la città romana è già scelto come sede di abitato. Un settore di esso, costituito da capanne a forma circolare con mate-riali databili tra il VII e VI sec. a.C., è stato messo in luce in anni recenti nelle aree di parcheggio Cales dell’autostrada Roma-Napoli,6 a poca distanza da quelle ritrovate in località S. Casto negli anni Sessanta del secolo scorso.7 Il luogo era naturalmente difeso da corsi d’acqua, in posizione sopraelevata con buona visibilità sul territorio circostante ed attraversato dalla principale via interna di transito, utilizzata in segui-to dalla via Latina che metteva in comunicazione il Lazio e il Sannio con la Campa-nia: una posizione, quindi, favorevole per il controllo del territorio e dei traffi ci.
Tutto il territorio caleno era, ed ancora lo è in parte, solcato da corsi d’acqua, alimentati da numerose sorgenti poste sulle pendici più basse della catena montuosa che fa da sfondo all’insediamento antico. Le acque del rio Cifoni e del rio Palomba-ra, attraverso canaloni naturali e cunicoli sotterranei giungevano a lambire il pianoro della città antica prendendo il nome di rio Pezzasecca e rio dei Lanzi. La fi tta rete di canali, cunicoli e pozzi, facilmente rilevabili per chi percorre sia il territorio a monte del centro urbano moderno che le vie vicinali e le “cupe” del sito archeologico, indu-ce ad ipotizzare che, forse già in epoca preromana, esso fosse oggetto di un articolato progetto di irregimentazione delle acque superfi ciali non solo per fi ni agricoli ma anche, verosimilmente per usi civili, in connessione con la deduzione coloniale del 334 a.C. Più improbabile appare l’ipotesi di un progetto di ingegneria idraulica,
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 56
messo in essere per fi nalità militari e di strategia difensiva.8 Si auspica di poter avviare uno studio accurato della morfologia dei luoghi che, attraverso un rilievo puntuale di tali presenze, suffragato anche da scavi stratigrafi ci, consenta di inquadrare cro-nologicamente e di comprendere le varie funzioni di un sistema idraulico in parte naturale ma, in gran parte, creato dalla mano dell’uomo per proprie utilità.
Coeve e prossime all’abitato sono le necropoli esplorate nelle località il Migliaro9 e Rocioloni ove è stato possibile recuperare, accanto alle tombe a cassa di tufo sistemati-camente trafugate dagli scavatori clandestini, soprattutto le sepolture a fossa terragna, risparmiate perché non facilmente individuabili ma anche perché di minore interesse. Le tombe messe in luce nelle località suindicate erano tutte ad inumazione, in parte coperte da ciottoli, talvolta evidenziate da segnacoli in pietra calcarea e/o da un grande conteni-tore d’impasto grezzo, andati il più delle volte dispersi a causa delle manomissioni dovute sia agli scavi abusivi, sia al massiccio impiego dei mezzi meccanici pesanti nei lavori agricoli. All’interno delle fosse, i vasi erano generalmente collocati ai piedi dell’inumato e nei pressi della testa. Talvolta qualche vaso era deposto sul grembo e sul corpo erano distribuiti gli oggetti d’ornamento personale. La consistenza e l’importanza degli oggetti funerari era commisurata al censo e al ruolo del sepolto. Le sepolture a fossa terragna hanno fornito importanti dati per l’arricchimento del quadro delle conoscenze, in par-ticolare della fase orientalizzante recente in Campania, considerato il trafugamento dei corredi, presumibilmente ricchi di armi e di pregevoli vasi fi gurati, delle tombe a cassa di tufo, databili tra il VI ed il IV sec. a.C.
Lo studio dei contesti tombali, tutti di notevole entità, attesta l’esistenza di lega-mi culturali tra il mondo ausone e l’area medio adriatica, forse da mettere in rela-zione con un precoce arrivo di stirpi sannitiche tra il VII ed il VI sec. a.C. e quindi
Fig. 2 - Calvi Risorta, veduta del teatro romano di Cales.
57Una proposta di parco archeologico ambientale del Montemaggiore
una civiltà che nelle sue linee essenziali si rapporta e nel contempo si differenzia da quella laziale a nord e da quella che, più a sud, fu diffusa da Capua. Sotto l’impulso di ceti aristocratici, la comunità calena si rivela socialmente articolata e mostra ca-pacità di iniziativa politica e forme di aggregazione con il mondo transappeninico e contatti con l’ambiente etrusco e magno greco, assumendo probabilmente un ruolo egemone all’interno del mondo ausone. L’economia calena sin dall’età arcaica accompagna allo sfruttamento agricolo del territorio un’attività artigianale caratte-rizzata dalla produzione di manifatture ceramiche e di coroplastica votiva che, senza soluzione di continuità, avrà una lunga tradizione anche con l’inserimento di Cales nell’orbita romana.
I luoghi di culto costituiscono, dopo le necropoli, la seconda importante fonte di informazione per la conoscenza della comunità antica. Indizi di aree sacre sono emersi sia all’interno del perimetro urbano che sulle pendici a ridosso della città antica.10 Il perimetro della città romana (Tav. 11), circondata da mura in opera qua-drata entro cui, secondo le fonti epigrafi che, si aprivano sei porte, è perfettamente ricostruibile nella cartografi a territoriale anche per la sua connotazione di contesto rurale senza generalizzate sovrapposizioni successive. In esso si conservano monu-menti pubblici di rilevante interesse di età tardo repubblicana ed imperiale, come il teatro (fi g. 2), l’anfi teatro, i due complessi termali, un tempio, ma anche di età me-dioevale e moderna come la cattedrale romanica (fi g. 3), il castello aragonese (fi g. 4) e il seminario settecentesco.
Il sito antico, opportunamente recuperato e valorizzato, potrà costituire il punto di partenza di un itinerario culturale che comprenda lo splendido contesto ambien-tale dei Monti Trebulani.
Fig. 3 - Calvi Risorta, la cattedrale romanica: particolare della cripta.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 58
Da Cales, attraversata dalla strada statale Casilina e posta a poca distanza dal-l’uscita Capua dell’autostrada del Sole, è possibile, infatti, raggiungere la città san-nitica di Trebula Balliensis. Percorrendo strade pedemontane che ricalcano antichi tracciati, tratturi e mulattiere inerpicati tra i monti, il visitatore attraversa luoghi interessati dalla presenza sia di santuari, riferibili a culti della terra e delle acque, sia di villae rusticae e di borghi medievali, quest’ultimi caratterizzati da edifi ci religiosi, testimonianze di un’arte minore poco conosciuta ma signifi cativa per la storia dei luoghi. Il territorio che in antico rientrava nella giurisdizione di Trebula attualmente ricade nei comuni di Pontelatone, Liberi e Castel di Sasso in provincia di Caserta. In esso la frequentazione umana è attestata fi n dall’epoca protostorica, ma degli insediamenti preromani si sa ancora molto poco. Ricognizioni di superfi cie hanno evidenziato rari insediamenti rurali di età arcaica nella pianura a sud del centro mo-derno di Pontelatone e nelle valli in prossimità di corsi di acqua e di tracciati viari. All’età tardo arcaica risale il quartiere artigianale, rinvenuto a seguito del taglio del bosco ceduo, subito a monte della strada provinciale d’accesso alla frazione di Treglia, poco più a sud del centro antico. Di tale impianto è stato possibile scavare una grande fornace verticale a pianta circolare con ampio prefurnio,11 localizzata lungo il versante nord della collina di Monte Castello, sulla cui sommità sono at-testate una cinta fortifi cata e una necropoli desumibile dal ritrovamento di oggetti bronzei (piccole fi bule a sanguisuga e a navicella) e in ferro, pertinenti a sepolture. L’impianto produceva una varietà straordinaria di vasellame rientrante nelle classi ceramiche attestate in età arcaica nella Campania interna. Interessanti i frammenti in impasto grezzo relativi a vasi di grandi dimensioni: mortai, scodelloni ad orlo in-
Fig. 4 - Calvi Risorta, il castello aragonese.
59Una proposta di parco archeologico ambientale del Montemaggiore
grossato, olle e pentole ad orlo piatto; insolita la presenza di askoi. I vasi di impasto a superfi cie bruna e quelli in bucchero, recanti segni e lettere incise, confermano il repertorio campano di età tardo orientalizzante, mentre i vasi in impasto a superfi cie rossa richiama-no in modo puntuale alcune forme attestate nelle necropoli calene. Non mancano prodotti in argilla fi gulina e in ceramica a vernice nera e con deco-razioni a fasce.
Il sito dell’antica Trebula, indivi-duato a nord di Treglia in località Ca-sale o Corte nel comune di Pontelato-ne, costituiva il fulcro di un sistema di cinte fortifi cate, deputate al controllo dei valichi e delle vie di comunicazio-ne di un territorio interposto a quello capuano a sud ed alifano a nord. L’acropoli della città sannitica loca-lizzata sulla vetta del colle di Cesco Cupo, difesa da più linee di fortifi ca-zione, secondo il Maiuri accoglieva il centro religioso e politico dell’abitato antico. Ipotesi confortata dalle numerose porte e postierle, documentate dal Caiaz-za, localizzate lungo il muro sud dell’acropoli12 (Tav. 12). La poderosa fortifi cazio-ne in blocchi di calcare locale di medie e grandi proporzioni, lievemente sbozzati (fi g. 5), scendeva dal colle a comprendere la città bassa, delimitando un’area di circa venti ettari. Ben conservato è il tratto occidentale delle mura con porte e postierle, mentre quello orientale che correva lungo il margine ovest del torrente Pisciariello/S. Giovanni è andato distrutto. Il sito di Trebula conserva intatte le sue peculiarità ambientali e storico-culturali perché sostanzialmente risparmiato da manipolazioni moderne. In tale area continuano attività agricolo-pastorali di antica tradizione. Anche l’economia del centro antico, come ci tramandano le fonti che esaltano la fer-tilità del territorio nonchè la bontà del vino e dei formaggi, si basava sull’agricoltura e la pastorizia per il carattere del paesaggio ricco di boschi, di altopiani e terrazzi col-linari degradanti verso la pianura. A tali attività principali, già in età arcaica, Trebula affi anca una notevole produzione artigianale attestata dalle fornaci tardo arcaiche di Monte Castello. Tale attività perdura senza soluzione di continuità ancora in età tardo repubblicana, epoca a cui risalgono le fornaci rinvenute in numero elevato in
Fig. 5 - Trebula, tratto della fortificazione dell’arce vista da nord.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 60
località Ceravarecce, nella vallata ai piedi di Monte la Colla, a poca distanza dal cor-so medio del Volturno.13 Esse, tutte del tipo verticale, a pianta circolare e semiipogee, connesse ad ambienti per la preparazione dell’argilla e la lavorazione dei manufatti, erano destinate alla produzione di ceramiche e laterizi (fi g. 6). Notizie d’archivio, fonti letterarie e orali tramandano il ritrovamento di tombe a cassa di tufo lungo il perimetro delle mura di Trebula e nel territorio, con corredi di V e IV sec. a.C..14 Tuttavia la dispersione dei materiali, la mancanza di documentazione e di scavi siste-matici non consentono una collocazione topografi ca precisa delle stesse. Di recente, invece, in località Masseria Valle, sulle pendici di Monte Nizzola, è stato effettuato il recupero di alcuni corredi di un’ampia necropoli violata dagli scavi clandestini, databili tra la fi ne del VI ed il IV sec. a.C.
Trebula cade in mano romana nel 305 a C.,15 ma verosimilmente diviene civitas foederata come Caiatia e Kupelternum/Cubulteria. La città romana si sovrappone all’insediamento sannitico, occupando la piana in località Corte ai piedi del colle di Cesco Cupo. Brevi campagne di scavo, eseguite nel Settecento ed alla fi ne dell’Ot-tocento,16 scoprirono l’area del foro con i resti del teatro romano ora interrato, ma la cui collocazione è nota perché l’edifi cio apparse su tutte le foto aeree degli anni passati. Scavi eseguiti per fi ni edilizi nel 1975 portarono alla luce statue di marmo, lastre con iscrizioni e strutture pertinenti forse ad un criptoportico.17 Nel 1976 a seguito dello sbancamento per la creazione di una strada ad opera del dipartimento forestale di Caserta, in piena area archeologica, si rinvenivano gli ambienti di un
Fig. 6 - Pontelatone, loc. Ceravarecce, fornace di età romana.
61Una proposta di parco archeologico ambientale del Montemaggiore
complesso termale pubblico di età medio imperiale.18 Recenti indagini, preliminari alla realizzazione della rete di metanizzazione lungo il lato occidentale ed orientale della via provinciale Pontelatone-Liberi, hanno confermato l’ubicazione della piazza lastricata del foro ed evidenziato fi lari in blocchi di tufo e basi di colonne in laterizio pertinenti ad edifi ci pubblici. Nell’area suddetta al momento sono visibili i resti imponenti delle mura, gli ambienti del complesso termale ed i resti di strutture per-tinenti all’approvvigionamento idrico della città. Attraverso percorsi pedonali, in un paesaggio rasserenante e suggestivo, è possibile altresì raggiungere l’arce della città e da lì spaziare con lo sguardo all’intorno, ripercorrendo idealmente il circuito delle fortezze satelliti, interdipendenti tra loro e la città antica, che hanno fortemente caratterizzato il territorio dei Monti Trebulani in età sannitica e di cui restano co-spicue tracce sulle maggiori vette del complesso.19 Il quadro attuale delle conoscenze non consente di formulare ipotesi attendibili sulla natura e l’organizzazione degli spazi all’interno dell’impianto urbano. Rare sono anche le notizie deducibili dalle fonti sugli aspetti politici, amministrativi e sui culti della città che, pur schierandosi con Annibale nella seconda guerra punica e prontamente riconquistata da Fabio Massimo (Liv. XXIII, 39-6), sembra aver conservato la propria autonomia pur non coniando moneta come gli altri centri limitrofi . Il corpus epigrafi co ci dice che Tre-bula fu municipium, retto da quattuorviri prima e poi da duoviri, e che in età tardo imperiale era ancora un centro attivo.20 Vitalità confermata dai numerosi siti rurali, di piccole e medie dimensioni, che attestano una continuità di vita che va dall’età repubblicana al tardo antico e testimoniano la riorganizzazione del territorio, at-traverso suddivisioni agrarie conseguenti alla romanizzazione.21 Calamità naturali e
Fig. 7 - Pontelatone, torre angioina.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 62
invasioni barbariche determinano, tra V e VI sec. d.C., una forte contrazione del popolamento dell’area e lo sposta-mento della linea di difesa più a sud, lì dove sorgerà il centro di Pontelatone, che conserva al suo interno una note-vole torre di età angioina (fi g. 7) e i re-sti del borgo medioevale con splendidi episodi di gotico catalano.
Da Cales seguendo il tracciato della via Latina e di una delle sue diramazio-ni – la via ad Dianam che conduceva al celebre santuario di Diana Tifatina ora sovrastato dalla basilica benedettina di S. Angelo in Formis – si prosegue oltre il cd. ponte Annibale per giungere a Caiatia.22 Questo è un altro signifi -cativo centro sannitico sulle ultime propaggini orientali del massiccio dei Monti Trebulani. L’abitato di Caiatia, odierna Caiazzo, era arroccato su un valico tra la media e la bassa valle del Volturno ai confi ni tra il Sannio Cau-
dino e la Campania, all’incrocio di vie che collegavano Capua con Allifae e Telesia. La città, situata a breve distanza dalla grande arteria fl uviale del Volturno, e l’arce che la domina da notevole altezza furono fortifi cate con mura in opera poligonale a grossi blocchi di calcare liscio e a leggero bugnato, che ne ha circoscritto la datazione al IV sec. a.C. (fi g. 8).
Dall’esame del tessuto urbano sembra che la città antica avesse, come Cales, un impianto urbanistico per strigas articolato su di un asse viario principale intersecato da vie secondarie disposte a pettine. Delle mura in opera poligonale restano visibili cospicui tratti sui lati ovest e sud e sull’arce dove, per il rinnovarsi di esigenze di-fensive, sarà impiantato il castello menzionato già in epoca longobardo-normanna; mentre ad est e a nord restano tratti di rifacimenti in opera incerta d’età romana tardo repubblicana. Nella cinta si aprivano quattro porte che in età medioevale pre-sero i nomi di Porta Pace a nord, Porta S. Pietro a sud, Porta Portanza ad est e Porta Vetere ad ovest.
Caiatia, che fi n dall’età sannitica doveva essere un centro di primo piano sia dal punto di vista strategico che economico, sicuramente ebbe un ruolo di rilievo du-rante le guerre sannitiche a proposito delle quali è menzionata da Livio (IX, 43, 1) e da Diodoro (XX, 80, 1). Sotto le sue mura si accampò l’esercito romano prima
Fig. 8 - Caiatia, Largo Fossi, tratto delle mura in opera poligonale.
63Una proposta di parco archeologico ambientale del Montemaggiore
di cadere nell’imboscata delle Forche Caudine. Caduta in mano romana nel 306 a.C., fu probabilmente civitas foederata, conservando una certa autonomia e anche coniando monete con legenda Caiatino. Secondo una notizia dedotta dal Liber Co-loniarum (233,10-11), la rocca fu rifortifi cata nell’epoca dei Gracchi; a questo perio-do risale, forse, una prima divisione del suo territorio secondo un piano centuriato con maglie quadrate di 13 x 13 actus.23 All’interno del perimetro urbano antico, nei pressi dell’attuale via Egizi, negli ambienti sotterranei della proprietà Sangiovanni, è attestata la presenza di un muro in grandi blocchi squadrati di tufo, uniti senza malta, impostati sul banco tufaceo naturale a cui si sovrappone un muro in opera incerta di calcare. Si tratta con molta probabilità di resti di muri di terrazzamento risalenti almeno al III-II sec. a.C., realizzati per regolare le forti pendenze del terreno soggetto a lenti ma continui smottamenti. Tuttavia non è da escludere la possibilità che tali strutture possano far parte di un’area sacra o di un edifi cio pubblico. Scavi effettuati nel settore sud-orientale della città presso la porta di S. Pietro, in occasione della ristrutturazione di palazzo Mazziotti destinato dal Comune a sede culturale, e della sistemazione delle aree ad esso adiacenti, hanno evidenziato una frequentazio-ne dell’area già dalla fi ne del IV sec. a.C. e strutture che vanno dall’età romana tardo repubblicana al tardo antico.24
Le fonti epigrafi che attestano il suo stato di municipium dopo la guerra sociale, retto da duoviri, ma ci forniscono pochi dati sulle magistrature e sui culti religiosi della città; molte iscrizioni ci dicono che i Caiatini erano iscritti alla tribù Falerna e che Caiatia aveva numerosi patroni.25 Al periodo romano imperiale risalgono il com-plesso termale di vico Fontanelle, in opera laterizia, innucleato in una costruzione rinascimentale, una cisterna ubicata sotto la piazza della cattedrale in corrisponden-za del foro, segmenti del sistema viario urbano nonché parti di domus inglobate in palazzi moderni. La città, mai abbandonata, divenne nel V secolo sede vescovile; interessata dalle invasioni barbariche, divenne gastaldato longobardo prima e contea normanna dopo. Il territorio caiatino aveva una notevole estensione confi nando a nord con quello dell’antico centro sannitico di Kupelternum, la romana Cubulteria/Compulteria, della quale il Caiazza ha individuato il sito sannitico nell’insediamento di Monte Castello di Dragoni, mentre il sito romano è tuttora non localizzato ma noto dalle fonti epigrafi che e letterarie. Scavi eseguiti attorno alla notevole chiesa altomedievale di S. Ferdinando ad Alvignano non hanno confermato l’ubicazione tradizionale, in tale sito, della città romana ma, nei pressi, in località Cacciapulli sono stati rinvenuti un bronzetto di Ercole ed una lamina bronzea con menzione di due edili e di un bosco sacro.26
Il Volturno segnava il confi ne ad est e a sud rispettivamente con i territori di Tele-sia e Capua; ad occidente invece c’era Trebula. Il territorio caiatino, che oggi rientra nei comuni di Piana di Monte Verna, di Caiazzo, di Ruviano e di Castelcampagna-no, favorito dal clima e dalla disposizione delle colline, fu intensamente sfruttato dal punto di vista agricolo con coltivazioni di vite e di ulivo. Lo documentano le
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 64
numerose fattorie disseminate sui dolci pendii terrazzati, da riferirsi ad un sistema di insediamenti di tipo sparso, riconducibile ad un arco cronologico che va dalla media età repubblicana al tardo impero. Esso è altresì, interessato da numerose sorgenti che alimentavano acquedotti e cisterne, tra cui quella in località Formale di età romana imperiale, costituiva il caput aquarum per rifornire d’acqua le ville di località Cesa-rano poste più a valle e, forse, ma con minore probabilità, l’abitato stesso di Caiatia (fi g. 9). Numerosi anche i siti fortifi cati come quello di Monte Alifano. L’imponen-za e la rilevanza dei resti di quest’ultimo hanno indotto La Regina ad identifi care tale sito con un abitato di nome Scyllae;27 mentre Pagano avanza l’ipotesi che possa trattarsi di Austicula,28 la città espugnata con le vicine Cubulteria e Trebula da Q. F. Massimo nel 215 a.C. Nella tradizione erudita e degli storici antichi, Caiatia viene spesso confusa con l’antica Calatia, sito ubicato a sud-est dell’antica Capua tra S. Nicola La Strada e Maddaloni, sempre in provincia di Caserta.
A tali vestigia di età preromana e romana nel comparto dei Monti Trebulani s’accompagnano signifi cativi esempi di arte cristiana medioevale e rinascimentale ed una ricca presenza di rocche, di fortezze e castelli di età angioina-aragonese, e preziose testimonianze d’età contemporanea (mulini ad acqua, neviere ecc.).
Realtà ambientali e testimonianze antiche portano quindi alla considerazione che la tutela dei beni culturali è imprescindibile dalla tutela del territorio circostante. La salvaguardia degli uni e dell’altro è possibile solo con la realizzazione di un parco
Fig. 9 - Caiatia, loc. Il Formale, strutture di incanalamento delle acque collegate alla cisterna di età medio imperiale.
65Una proposta di parco archeologico ambientale del Montemaggiore
archeologico ambientale dei Monti Trebulani che non si presenti come mera impo-sizione di vincoli, o di interventi occasionali, rivelatisi insuffi cienti sia per la tutela che per la valorizzazione del bene, ma che tenga conto delle peculiarità naturali e storico-culturali dell’area e delle sue tradizioni agricole e pastorali, preservandole e potenziandole. Con l’approfondimento del principio di sussidiarietà e di coopera-zione interistituzionale si auspica che siano perseguite forme di incentivazione delle attività locali per la produzione e la commercializzazione di prodotti tipici e piani particolareggiati che tengano conto dello sviluppo abitativo sostenibile, creando altresì strutture di interesse pubblico di tipo ricettivo e sportivo. Le località dell’en-troterra, grazie alla ricchezza del loro patrimonio naturale e di storia, integrato da risorse artigianali, gastronomiche e dall’offerta di attività sportive, possono quindi costituire itinerari culturali alternativi a quelli tradizionalmente scelti dai fl ussi tu-ristici, e contribuire a sollevare dal punto di vista economico ed occupazionale tali aree del nostro paese e a renderle competitive e non più ai margini del sistema eco-nomico nazionale. Un’occasione importante per la difesa e la tutela di quest’antico patrimonio storico, artistico e ambientale è il Piano Integrato Territoriale Archeo-logico – Itinerario Monti Trebulani-Matese – di recente approvazione e in fase di realizzazione. Si spera fortemente che esso, attraverso il recupero e la valorizzazione di parte di un così ingente e straordinario patrimonio, faccia da volano alla realizza-zione del parco archeologico ambientale coniugando passato e presente, nel rispetto della storia e delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
Note* Il testo è una rielaborazione del contenuto degli incontri tenutisi nella sede dell’istituendo museo archeologico dell’antica Allifae e dell’ex Convento di S. Domenico di Piedimonte Matese, nati allo scopo di far conoscere ad un pubblico non addetto ai lavori ed al mondo studentesco, in particolare, l’archeologia di aree dell’alto caser-tano, in gran parte ancora poco note.1 Caiazza 1986, con bibl. precedente.2 Pagano 1998, 17; Albore Livadie 1984, 364-365.3 von Duhn 1924; Caiazza 1986.4 Per un’ampia bibliografi a sulle popolazioni attestate in Campania cfr. Gasperetti, Passaro, De Caro, 1999, 145 segg. 5 Femiano 1990 con bibl. precedente. 6 Di Giovanni 1991-1992, 146-147; Chiosi 1991-1992 a, 147; Passaro 1993 a, 49-51; Crimaco, Proietti 1993, 51-54. 7 Johannowsky 1961, 258-268.8 Ødegard 1997, 213-224.9 Chiesa 1995; Ciaccia, Passaro 1996, 36-41; Ciaccia, Passaro 2000, 20-25; Ciaccia, Passaro 2001.10 Passaro 1993 b, 54-57.11 Albore Livadie 1991-1992, 149-151.12 Maiuri 1930, 214-228; Caiazza 1986, 339, tav. LVII.13 Proietti 1991-1992, 151-153.14 Cfr. A(rchivio) S(oprintendenza) A(rcheologica) di N(apoli), Formicola 1-3; 1-13; Pontelatone 1-35; De Caro 2002 b, 495-497.15 Liv. X, 1-2.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 66
16 Iannelli 1878, 19-22, 45-53; Faraone 1878, 51-53; Ruggiero 1888, 377; v. ASAN, Formicola 1-8.17 Pendolino 1978, 61. 18 ASAN, Pontelatone 1-44.19 Sulle cinte fortifi cate in questa parte di territorio cfr. Conta Haller 1978; Caiazza 1986; Oakley 1995. 20 Sulla scoperta della prima iscrizione osca, rinvenuta nell’area urbana di Trebula, cfr. De Caro 2002 b; Solin 1993, 13-62. L’autore, nel quadro dei lavori per una nuova edizione del CIL X, effettua un’ampia disamina delle iscrizioni rinvenute nei centri antichi e nei territori di pertinenza. 21 Chouquer et al. 1987, 151-152.22 Per notizie sulla città cfr. Melchiorri 1619; Trutta 1776 [1976]; Faraone 1899; Di Dario 1940; Pagano 1998, 17.23 Chouquer et al. 1987, 150 segg.24 Ciaccia, Passaro 1993, 58-61; Autieri 1993, 61-63. 25 Solin 1998, 65-143.26 Crimaco 1991-1992 b, 144-146; Caiazza, Passaro 1996, 32-35. 27 La Regina 1989, 424 seg.28 Pagano 1993, 113.
Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna*
Francesco Sirano
L’antico centro di Teanum Sidicinum è apparso, sin dai primi scavi sistematici ad opera di E. Gabrici,1 quale uno dei siti di maggiore rilevanza nell’orizzonte italico sia per la qualità storico artistica dei materiali rinvenuti, sia per lo stato di conservazio-ne complessivamente buono dei livelli tardo classici ed ellenistici entro una forma urbana che risulta molto più estesa nell’antichità rispetto al Medio Evo e all’età moderna.2 I prodotti dell’artigianato artistico locale, sia piccola plastica fi ttile sia ceramica fi ne da mensa, mostrano tra il VI e il III sec. a.C. con grande evidenza ca-ratteristiche iconografi che e stilistiche originali, tali da renderli non solo facilmente identifi cabili, ma soprattutto riconducibili con immediatezza ad un’identità etnica dai connotati culturali marcatamente autonomi.3 I contesti di rinvenimento giocano un ruolo fondamentale sia nell’indirizzare la moderna ricerca scientifi ca, sia nell’at-tribuire appropriati signifi cati ai ritrovamenti.
Il presente contributo prende le proprie mosse da uno scavo di emergenza effet-tuato nell’anno 2002 nel santuario detto di località Loreto.4 Lo scavo di un tempio e lo studio di un gruppo di statue fi ttili qui recuperate hanno condotto all’identifi -cazione del più antico luogo di culto di Popluna, divinità italica legata ai Sidicini in maniera speciale, poi inglobato nelle fondazioni di un tempio ellenistico degli inizi del II sec. a.C.
A seguito di alcune campagne di scavo effettuate tra il 1960 e il 1962, W. Johan-nowsky ha defi nito i tratti principali della topografi a del santuario, collocato su un pianoro elevato rispetto al corso del Savone, nonché la sequenza delle fasi edilizie.5 Le più antiche strutture monumentali si localizzano nell’estrema zona sud occiden-tale del santuario e, sulla base dei rinvenimenti associati, sono state datate alla fi ne del VI-inizi del V sec. a.C. Successivamente due terrazze parallele (II-III), la cui realizzazione è datata da Johannowsky alla prima metà del III sec. a.C., si estendono a coprire la parte meridionale del pianoro prospettante sul Savone. Tra il III e il II secolo sorgono quattro tempietti sulla terrazza II e, nel corso della seconda metà del II sec. a.C., viene creata la terrazza IV. Una rampa porticata di età sillana e diffusi restauri della prima età imperiale completano il quadro sintetico delle conoscenze.
Nel 2002 indagini geofi siche avviate in collaborazione con la British School at Rome 6 sull’intera area di Loreto hanno dato chiare indicazioni circa la presenza di un edifi cio a pianta templare localizzato sul limite occidentale della terrazza III
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 68
(Tav. 15). È stata indagata un’area pari complessivamente a mq 500 che ha presenta-to, pur in presenza delle abituali interferenze dovute al secolare procedere dei lavori agricoli, una sequenza stratigrafi ca piuttosto lineare all’interno della quale l’elemen-to più importante è rappresentato da un tempio che ha inglobato precedenti costru-zioni (fi g. 1). Non sono state rinvenute evidenze rapportabili a modifi che strutturali successive all’edifi cazione del tempio, se non lacerti murari e canalizzazioni posti a nord di quest’ultimo; la realizzazione di una deposizione funeraria in fossa terragna in corrispondenza dell’angolo nord ovest del muro perimetrale del tempio segna la defi nitiva perdita della funzione originaria dell’area dopo una fase di abbandono, nei cui strati di accumulo tale fossa risulta tagliata. Oltre al tempio e ai suoi prece-denti, dei quali si dirà tra breve, degna di nota è anche la scoperta di un tratto di strada con orientamento nord-sud7 che lambisce il tempio sul lato occidentale.
Le più antiche costruzioni (fi g. 2) sono conservate solo a livello di fondazione e si presentano come due strutture murarie separate, collocate rispettivamente in corrispondenza dell’attuale pronao (struttura A) e della cella del tempio (struttura B). Entrambi i manufatti sono realizzati in blocchi quadrati di tufo grigio privi di legante e allettati direttamente sul banco tufaceo naturale (tasso), risultando in parte tagliati dai muri del tempio più recente; inoltre condividono l’orientamento nord/est-sud/ovest. La costruzione A è di pianta rettangolare (m 4,15 x 3,35) aperta
Fig. 1 - Località Loreto, terrazza III. Planimetria delle strutture scavate nel 2002 (rilievo T. Conti).
69Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna
sul lato meridionale; la struttura B è una piattaforma, anch’essa all’incirca rettango-lare, mal conservata a causa di una parziale distruzione in antico. La conservazione a livello di fondazione delle strutture non consente un’interpretazione univoca. La costruzione A, per le contenute dimensioni e per la caratteristica pianta ad U, po-trebbe interpretarsi quale base per un altare. Tuttavia, tali impianti di solito presen-tano un basamento sul quale viene successivamente impostato il plinto su cui sorge l’altare vero e proprio, elementi questi ultimi dei quali non è traccia sul terreno; né sono stati rinvenuti materiali votivi solitamente associati ad altari. Maggiore vero-simiglianza riveste la proposta che si tratti di un sacello, con la cui planimetria non contrasterebbero le proporzioni dei blocchi perimetrali.8
Passando alla piattaforma B, essa presenta due incisioni longitudinali parallele poste alle estremità nord e sud con andamento est-ovest (fi g. 3). L’ipotesi che si tratti di linee guida per il posizionamento di una struttura in elevato sembra confermata dalla circostanza che, sull’allineamento dell’incisione meridionale, sono stati tro-vati tre blocchetti di tufo in situ, a nord dei quali, e in fase con essi, si rinvenivano anche i resti di un accumulo di detriti del medesimo materiale: si tratta, con ogni probabilità dei resti del basamento di un altare, con plinto in tufo e riempimento di scaglie.9
Per completezza d’informazione si menziona anche la possibilità che entrambe le strutture conservate siano appartenute ad un unico edifi cio, danneggiato in parte considerevole dalla costruzione del tempio più recente, identifi cabile con un altare
Fig. 2 - Località Loreto, panoramica da sud del tempio, al termine dello scavo.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 70
sopraelevato del tipo greco detto “a gradini”,10 oppure con un “recinto su podio” come quelli noti in Campania a Capua, fondo Patturelli,11 e in Etruria,12 con scala di accesso, le cui spallette dovrebbero riconoscersi nelle mura della struttura A, e alta piattaforma sul quale sorgeva l’altare, le cui fondazioni corrisponderebbero alle evidenze descritte come B. A favore di tale interpretazione militano sia il comune orientamento delle strutture, sia la reciproca vicinanza, sia le assai ridotte dimen-sioni del supposto sacello inglobato nel pronaos. Di contro, si osserva però come manchino tanto un legame fi sico tra A e B, quanto un qualsiasi accenno di risvolto dei muri perimetrali della costruzione A, i quali risultano fondati direttamente sul tasso naturale; infi ne, non si troverebbe una plausibile spiegazione per il tracciato delle due linee parallele all’interno delle fondazioni di un edifi cio sopraelevato.
Non sussistono invece dubbi circa la funzione cultuale di tali manufatti, non solo per la forma e l’assetto planimetrico, ma anche per il ritrovamento dei resti di un sacrifi cio celebrato al momento della chiusura dell’altare, e della contestuale co-struzione del tempio, in corrispondenza del negativo risultante dallo strappo di uno dei blocchi costituenti la piattaforma B (fi g. 4). In particolare, signifi cativa appare la presenza di un coltello in ferro (fi g. 5), con manico realizzato in materiale deperibile (legno), nello strato immediatamente al di sopra di una spessa lente con tracce di bruciato, frammenti di carbone, ossa di animali di piccola taglia,13 statuine e piccoli busti votivi, coppette a vernice nera, coperchi di olle di impasto con sfi ammature di nero fumo (fi gg. 6 e 7).14 Il già ricordato comune orientamento delle strutture e la
Fig. 3 - Località Loreto, tempio, particolare della cella con, all’interno, la struttura B, ripresa da sud.
71Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna
condivisione della tecnica di costruzione costituiscono un indubbio segnale di reci-proco legame. Tale legame diffi cilmente è precisabile in termini di rapporto funzio-nale diretto (cioè di sacello e relativo altare), come denunziato sia dall’apertura del sacello verso sud, e non verso nord ove si trova l’altare, sia dal leggero sfalsamento dell’asse longitudinale di ciascun manufatto. Senza meno, le due strutture sono da ritenersi quali installazioni poste su un punto topografi camente eminente dell’area, dotato di una particolare e durevole valenza religiosa, come dimostrato dall’edifi ca-zione di un tempio in corrispondenza di questo sito.15
Del resto già Johannowsky aveva osservato, a seguito di alcuni saggi in profondi-tà effettuati a pochi metri dal luogo in esame, come i resti murari più antichi nella sequenza stratigrafi ca dell’intero santuario fossero localizzati proprio in tale settore sud occidentale.16 Da quei livelli provengono, infatti, antefi sse tardo arcaiche con protomi femminili entro nimbo che rimandano alla presenza di edifi ci di modeste dimensioni.17 Signifi cativo appare il ritrovamento, tra i materiali riversati in una fossa votiva (US 7) connessa alla costruzione del tempio più recente, di un fram-mento di coronamento modanato in tufo con kyma dorico ripetuto anche sotto la gola della stessa serie, e di identica manifattura, dei famosi capitelli in tufo rinvenuti nel santuario di località Masseria Soppegna-Fondo Ruozzo e datati alla fi ne del VI - inizi del V sec. a.C.18 Il frammento di Loreto potrebbe appartenere alla sima di una
Fig. 4 - Località Loreto, tempio, particolare della struttura B: sacrificio (US 29) nel negativo del blocco (US 28) della platea in tufo.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 72
costruzione, più probabilmente, al coronamento di un altare, identifi cabile anche con la struttura B.19
Nonostante le evidenti diffi coltà di inquadramento dovute allo stato di con-servazione dei resti di prima fase, sacelli di dimensioni confrontabili con quelle dell’edifi cio A di Teano sono noti in area medio italica sin dal VI sec. a.C. e fi no al III-II sec. a.C.20 Anche il fenomeno dell’assorbimento di strutture cultuali antece-denti all’interno di edifi ci templari successivi, ben noto nel contesto centro italico sin dalla tarda età arcaica,21 non è privo di confronti nel periodo medio repubblicano sia in Etruria,22 sia nel Sannio.23
L’analisi della stratigrafi a ha evidenziato lo stretto rapporto tra l’edifi cazione del tempio recenziore e la perdita di funzione delle strutture che lo hanno preceduto. Tra i materiali costituenti il già ricordato sacrifi cio praticato sulla distruzione della piattaforma B, è degno di nota il ritrovamento della gamba di una statua fi ttile di guerriero,24 i cui restanti frammenti sono stati rinvenuti negli strati di preparazione della pavimentazione del tempio.25 La struttura di deposizione del sacrifi cio appare del più grande interesse, risultando i resti dell’atto cruento, con relativo instrumen-tum di libagione, chiusi in alto dalle già ricordate statuine e da busti fi ttili posti volontariamente ai livelli superiori dell’apprestamento.26
Connessa alle operazioni di consacrazione e costruzione del nuovo edifi cio è an-che la deposizione di un secondo coltello di ferro in una delle trincee di fondazione della cella, mentre sembrano appartenere ad una stipe riversata negli strati di prepa-razione del pavimento del tempio un saurocter e una punta di lancia.27
I medesimi strati hanno restituito anche frustuli di scultura fi ttile28 che al mo-mento del restauro si sono rivelati appartenere a statue, i cui ulteriori frammenti erano stati scaricati nella fossa votiva (US 7) praticata sul lato esterno orientale del tempio.
Fig. 5 - Località Loreto, tempio. Coltello in ferro dalla US 15 in corrispondenza del sacrificio (US 29).
73Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna
Appare pertanto appurata la coincidenza tra la perdita di funzione della più an-tica area sacra, e con ogni probabilità anche la sua distruzione, con la costruzione del tempio più recente. Tale attività costituisce non solo il discrimine cronologico tra le due fasi architettoniche, ma anche la principale fonte di dati di cronologia assoluta.
Lo studio preliminare dei materiali provenienti dagli strati costituenti i livelli di preparazione del pavimento del tempio più recente29 e da quelli del sacrifi cio praticato presso la piattaforma B,30 mostra non solo una composizione comune,31 ma anche un orizzonte cronologico omogeneo, riferibile ad un periodo compreso tra la fi ne del IV e il III sec. a.C.32 (fi gg. 6 e 7).
Concordano con questo quadro anche i dati offerti dal materiale recuperato nel riempimento della fossa di fondazione del muro perimetrale della cella, costituito da ceramica a vernice nera con forme di lunga durata, databili tra il IV e il III sec. a.C.,33 nonché da una testa femminile (fi g. 8) appartenente ad una statua votiva prodotta da offi cina campana della seconda metà del III sec. a.C.34
I rinvenimenti monetali, infi ne, effettuati sia nei livelli di preparazione del pavi-mento della peristasi (US 45, lato nord del tempio), sia negli strati che aderiscono all’edifi cio dall’esterno, forniscono indicazioni per una datazione a dopo la fi ne del III sec. a.C.35
Il tempio, dotato di pronaos e cella, è orientato nord-sud e presenta una lunghez-za di m 18,44 per una larghezza di m 12,44; la cella è piuttosto arretrata rispetto al fronte del tempio e misura m 8,44 x 6,44. I muri sono realizzati in opera incerta di calcare e tufo legati con malta e sono spessi rispettivamente: il muro perimetrale del tempio m 1,48; il muro della cella m 0,74.
Saggi realizzati su tre lati dell’edifi cio hanno consentito di appurare come esso sia costruito su podio sui lati nord e ovest, mentre su quelli sud ed est sia stato realizzato contro terra. Il podio, alto all’incirca m 1,98, presentava un paramento in blocchi di tufo, probabilmente modanati, strappati in età tardo antica per essere riutilizzati come materiale da costruzione.
Un saggio praticato sul lato ovest del podio, ha individuato la carreggiata della strada, già riconosciuta dalle indagini geognostiche, che costituiva il probabile limi-te del santuario verso la città (fi g. 9). Il piano basolato è posto ad almeno due metri al di sotto del piano di frequentazione del tempio: tale dislivello veniva superato mediante una scala scavata nel banco naturale, i cui gradini sono stati strappati in età post antica, analogamente ai blocchi di tufo del podio.
La peculiarità costruttiva del tempio, applicata sia pure con minore evidenza nel tempio C sulla terrazza II dello stesso santuario di Loreto36 e non ignota altrove,37 marca l’adattamento dell’architettura alle caratteristiche pedologiche del sito, che doveva presentarsi in antico come un’altura con pendenza verso sud/ovest, nonché concretizza l’esigenza di inglobare nelle fondazioni del tempio più recente l’area
Fig. 7 - Località Loreto, tempio, materiali ceramici e votivi dai livelli dipreparazione del pavimento (US 15, disegni L. Ricci).
Fig. 6 - Località Loreto, tempio, materiali ceramici e votivi dal sacrificio (US 29, disegni L. Ricci).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 76
sacra precedente, evidentemente de-gna di particolare venerazione.
Non sono state rinvenute tracce dell’altare di questo tempio nell’area immediatamente antistante il fronte sud, ma è assai verisimile che esso si trovasse poco oltre l’area indagata, sul limite del santuario segnato dal poderoso muro che sostiene la ter-razza III: un indizio è rappresentato dalla circostanza che proprio in cor-rispondenza del limite della terrazza, e sull’asse longitudinale del tempio, è localizzato un ricco deposito vo-tivo continuamente razziato dagli scavatori clandestini. Altra ipotesi è che, secondo la tipica struttura italica, l’altare fosse collocato nel pronao e pertanto sia stato distrutto dalle arature insieme con i livelli di frequentazione del tempio.
Per quanto riguarda le fasi di vita dell’edifi cio successive alla sua costruzione, i dati stratigrafi ci non forniscono indicazioni circa even-
tuali mutamenti planimetrici, mentre nell’area sita immediatamente a nord del lato posteriore, in età romana, comunque precedente il II sec. d.C., furono costruite alcune strutture servite da canalette, forse realizzate nell’ambito della sistemazione dell’area corrispondente ad una delle estremità della rampa porticata tra le terrazze II e IV.
La realizzazione di limitati interventi decorativi nella prima età imperiale è, inoltre, confermata dal rinvenimento, sul fondo di una fossa lungo il perimetro occidentale esterno dell’edifi cio, di una scultura femminile panneggiata in marmo pentelico di dimensioni maggiori del vero, con ogni verosimiglianza identifi cabile con la statua di culto del I sec. d.C.
Il defi nitivo abbandono delle strutture e il mutamento di funzione dell’area si pone intorno alla prima metà del VI sec. d.C., data a partire dalla quale la zona è utilizzata anche per sepolture in piena terra.
Circa l’inquadramento architettonico, tipologico e cronologico del tempio, si fa osservare come la pianta appaia chiaramente impostata su un piede romano, come dimostrano sia le misure dei muri, sia le dimensioni del pronaos e della cella, tutte
Fig. 8 - Località Loreto, tempio, testa fittile (Inv. Gen 306453) dalla US 25.
77Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna
esprimibili secondo tale unità di misura. Lo spessore del muro perimetrale del tem-pio risulta, infatti, pari a 5 piedi, un passus, e il muro che delimita la cella ha uno spessore corrispondente esattamente alla metà. La misura del passo sembra dettare le proporzioni sia del muro perimetrale del podio, sia del muro della cella, sia della distanza tra quest’ultimo ed il limite interno del muro perimetrale, pari ancora ad un passus. La lunghezza del tempio corrisponde a 62,29 piedi, essendo la larghezza complessiva pari a 42 piedi. Le dimensioni della cella sono di 28,51 piedi di lun-ghezza per 21,75 piedi di larghezza. Interessanti sono le reciproche relazioni tra le parti del tempio: la lunghezza è pari a poco più del doppio di quella della cella (rap-porto 1:2); ancora, la larghezza del tempio è pari ai due terzi circa della lunghezza, mentre la larghezza della cella è pari ai due terzi di quella del tempio.
La cella rettangolare spostata verso il fondo del tempio, ma non coincidente con il retro, fa escludere che l’edifi cio appartenga al tipo sine postico,38 e spinge ad ipotizzare, pur con la dovuta cautela, un periptero o un prostilo tetrastilo, soluzione che sarebbe coerente con quanto conosciuto dell’architettura degli altri tempietti del santuario.39
La pianta ricorda, per proporzioni e forma, il tempio D sull’arce e il tempio B nel foro di Cosa (per i quali è stata recentemente ribadita la cronologia alla prima metà del II sec. a.C.),40 nonché il sacello di Aufi dena41 e il tempio di Apollo a Pompei,42 mentre nell’Urbe un interessante confronto è offerto dal tempio di Spes al Foro Oli-torio,43 la cui cella presenta proporzioni più allungate rispetto al tempio di Teano.44
Fig. 9 - Località Loreto, tempio, saggio 4, panoramica del podio depredato del rivestimento in tufo e, sul fondo, i basoli della strada N-S.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 78
Ulteriori dati provengono dal confronto con i quattro tempietti scavati da Johan-nowsky sulla terrazza II nel medesimo santuario di località Loreto, tutti su podio e con la caratteristica sagoma italica a doppio cuscino ancora conservata al momento della scoperta.45 Dal punto di vista dimensionale e delle proporzioni, il nuovo edi-fi cio si avvicina al tempio C, la cui larghezza era pari a m 11,48, presentando sul retro quattro colonne e ricostruito dal Johannowsky come periptero, o meno pro-babilmente anfi prostilo.46 Anche l’altezza dei due podi risulta compatibile, sebbene il podio di recente ritrovamento sia privo del rivestimento. Differente da quella utiliz-zata nel tempio C è, invece, la tecnica costruttiva la quale può paragonarsi a quella adottata per i templi A e B. Sulla scorta della decorazione delle modanature, il cui confronto migliore si trova con il tempio grande di Schiavi d’Abruzzo,47 i due citati edifi ci sono databili nel corso della prima metà del II sec. a.C. e comunque in un momento precedente il tempio B di Pietrabbondante48 e non posteriore al tempio di San Giovanni in Galdo,49 se bisogna prestare fede all’evoluzione sintattico stilistica delle modanature architettoniche medio italiche.50
Sembra pertanto che, sulla base sia dei confronti, sia dei dati stratigrafi ci si possa proporre una datazione per l’edifi cio alla prima metà del II sec. a.C., il che lo por-rebbe tra le più antiche costruzioni in opera cementizia della Campania.51
Fig. 10 - Località Loreto, tempio (US 7), fanciullo assiso (Inv. Gen. 306457).
Fig. 11 - Località Loreto, tempio (US 7), statua (Inv. Gen. 306196), vista frontale (foto L. Spina).
79Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna
Poco possiamo dire sull’aspetto dell’alzato, essendo i resti conservati al livello delle fondazioni, ovvero all’avvio dello spiccato dei muri. Sembra accertato, sulla base della notevolissima quantità di maceria rinvenuta nel riempimento delle fosse di spoglio, che anche l’elevato dei muri fosse in opera incerta con modanature ed epistilio in tufo, del quale si conservano pochi frammenti con decorazione vegetale acantina, basi di lesena e un frammento di testina maschile, da capitello fi gurato o da fregio di architrave, che fanno ipotizzare un ordine corinzio.52 Altra questione è stabilire se tali elementi dell’elevato debbano attribuirsi all’impianto dell’edifi cio della prima metà del II sec. a.C. o ad un suo rifacimento in epoca successiva. Da notare, però che, contrariamente a quanto osservato da Johannowsky nel corso dello scavo dei tempietti, non si è in grado di associare alle strutture elementi fi ttili della copertura del tetto. Mancano, altresì, dati per stabilire l’ordine e l’altezza delle co-lonne. Il pavimento era costituito da tessere rettangolari di calcare bianco disposte irregolarmente con inserti di pietra colorata, opus signinum.
Si illustrano qui di seguito alcuni dei più signifi cativi reperti dalle fosse di de-posizione e dai livelli di preparazione del pavimento del tempio più recente, utili all’identifi cazione del culto, preannunziandone un prossimo studio esaustivo.
1. Testa femminile con polos (Inv. Gen. 306455, Tavv. 13-14). Impasto a super-fi cie bruno rossastra chiara, inclusi vulcanici. Cava all’interno con superfi cie perfet-tamente lisciata e accomodata con le dita all’interno. Resti della campitura (rossa?) circolare delle pupille. Ricomposta da frammenti, lacunosa. H. cm 31; prof. cm 23; spess. massimo cm 2.
Testa di dimensioni pari al vero proveniente da una statua della quale è stato recuperato solo un frammento della spalla sinistra (vedi qui n. 2). È coronata da un alto polos liscio, alla sommità appiattito in forma trapezoidale, con una serie di fori passanti posti simmetricamente sulla tesa e ripetuti in corrispondenza delle tempie e sulla fronte al centro, segno della presenza di un diadema realizzato in altro materiale, forse prezioso, andato perduto. I capelli sono acconciati in piatte bande organizzate su tre linee parallele, ripiegate sulle tempie davanti alle orecchie. L’ovale del volto è pieno, con la mascella forte e il mento arrotondato ben pronunziato, arcate sopracciliari curve; occhio a mandorla dal profi lo leggermente allungato, pal-pebre gonfi e segnate da due linee e pupille a rilievo; un leggero rilievo al limite dello zigomo destro denunzia che il naso doveva essere ben largo (certo più di quanto suggerito dall’integrazione attuale) con un dorso ben pronunziato; le labbra, lunghe e carnose – meno turgido quello superiore – hanno profi lo metallico, leggermente tirate, sottolineate da incisioni superiormente e inferiormente; orecchie grandi trat-tate schematicamente.
La lavorazione è estremamente accurata e rivela una produzione senza l’apporto di matrici. I dettagli sono stati lavorati con la stecca e le superfi ci lisciate con cura prima di essere coperte dall’ingobbio realizzato nello stesso impasto.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 80
2. Spalla di statua femminile con fanciullo assiso (Inv. Gen. 306457; fi g. 10). Impasto, vedi n. 1. Ricomposta da frammenti, lacunosa. La statua maggiore è cava all’interno con superfi cie rifi nita rozzamente a stecca. H. cm 29,5; h. fanciullo cm 19; prof. cm 18,3; spess. cm 1,7.
Frammento relativo al lato sinistro di una statua dalle dimensioni pari al vero. Si conserva il piano inclinato dal profi lo esterno convesso della parte piana del petto. Sull’estremità superiore, corrispondente all’insellatura tra clavicola e omero, siede un fanciullo visto di prospetto con busto leggermente inclinato a sinistra e spalla sinistra levata, probabilmente nel gesto di protendersi verso la testa della fi gura che lo sostiene. Il fanciullo, quanto meno svezzato poiché in grado ergersi con il dorso, veste una corta tunica spessa, smanicata, ovvero un corsetto, lasciando i genitali sco-perti. Il braccio sinistro è allungato con la mano poggiata sulla coscia. La fi gurina è stata lavorata a tutto tondo in parti separate, poi assemblate e incollate sulla fi gura maggiore, apparentemente senza l’uso di colle o pece.
L’accuratezza della lavorazione, il colore della superfi cie e dell’impasto in frattu-ra, chiaramente differenti rispetto agli altri frammenti di terracotta rinvenuti nella fossa US 29, rendono quanto mai probabile l’appartenenza alla stessa statua della testa n. 1.
3. Torso di statua con copricapo a busta e fanciulli assisi sulle spalle (Inv. Gen. 310196; fi g. 11). Impasto a superfi cie rosso arancio, lisciato e ricoperto da una pa-tina bituminosa nera brillante. Inclusi micacei. La statua maggiore è cava e rifi nita anche all’interno, lavorata in due valve. Ricomposto da frammenti, lacunoso. H. cm 85; largh. cm 60; prof. 18,5; spess. cm 2.
Statua femminile di dimensioni pari al vero vista frontalmente, abbigliata con una tunica a maniche lunghe, visibile sul braccio sinistro, coperta dal mantello avvolto in-torno alle spalle e ricadente con due piegoni verticali lungo il fi anco sinistro. Il braccio sinistro è piegato al gomito, la mano sollevata esponendo il dorso verso lo spettatore con le dita affusolate e defi nite sino alle unghie; il braccio destro era certamente pie-gato ma non è possibile precisare se fosse proteso in avanti, oppure rivolto verso l’alto. Su entrambe le spalle, in corrispondenza dell’omero, si individuano le impronte di un fanciullo assiso: si è conservato solo un frammento della gamba sinistra di quello di destra. La testa è impostata sul lungo e robusto collo cilindrico ed è coronata da un polos “a busta”, troncopiramidale in sezione, rifi lato lungo i margini con un bor-dino. Il volto ha una struttura inscrivibile in un quadrato, con fronte breve, zigomi piatti e distanti, mascella forte, mento arrotondato. Le arcate sopracciliari sono curve, leggermente asimmetriche, prolungate sulla linea del dorso nasale; nell’ampio spazio orbitale gli occhi sono impostati leggermente obliqui verso il basso, con globo a rilievo a mandorla, palpebre sottolineate da due incisioni. Il setto nasale ha il profi lo di una V e le pinne sono brevi, oblique e non pronunziate; la bocca, orizzontale, ha il labbro superiore appena accennato e sottolineato dal solco che nasconde la ghiera dei denti, il labbro inferiore è schematico e segnato da un solco in basso. Orecchie schematiche
81Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna
risolte in forma geometrica. In sezione la fi gura ha un profi lo ellittico, priva di volume; sul retro non si notano rilievi anatomici, né pieghe, segno che era destinata ad una esposizione contro muro. La statua è stata realizzata dall’assemblaggio di più parti la-vorate separatamente; la testa deriva da una matrice, le rifi niture sono a stecca.
4. Torso di statua femminile di dimensioni maggiori del vero con fanciullo assi-so sulla spalla (Inv. Gen. 306454; fi gg. 12-13). Impasto a superfi cie rosso arancio, lisciato e ricoperto da una patina bituminosa nero brillante. Inclusi micacei. La statua è cava e perfettamente rifi nita anche all’interno; lavorata in due valve, proba-bilmente su due livelli verticali, unite prima della cottura, foro sfi atatoio dietro la spalla sinistra; la parte conservata del corpo del fanciullo è stata realizzata a stampo, contestualmente e nello spessore della statua maggiore. Ricomposto da frammenti. H. cm 84; largh. cm 44; prof. cm 21,8; spess. medio cm 1,8.
Statua femminile vista frontalmente, abbigliata con un chitone, o mantello, drappeggiato sul davanti in pieghe verticali sul fi anco e curve sul tronco. Il braccio sinistro è piegato con la mano sollevata in alto a sostenere un fanciullo seduto sulla spalla tra omero e clavicola. Il fanciullo indossa una corta e spessa tunica che lascia scoperti i genitali e le gambe. Si conserva solo l’attacco del forte collo della fi gura
Fig. 12 - Località Loreto, tempio (US 7), statua (Inv. Gen. 306454),
vista frontale (foto L. Spina).
Fig. 13 - Località Loreto, tempio (US 7), statua (Inv. Gen. 306454),
vista lato posteriore (foto L. Spina).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 82
maggiore. Sul retro la statua presenta profi lo convesso che disegna le curve anatomi-che e in sezione il frammento conservato si presenta troncoconico. La scultura era probabilmente destinata ad essere vista anche sul retro.
Tecnicamente le statue sono realizzate con una lavorazione per parti separate delle valve del corpo, delle testa, delle braccia, poi unite dopo l’essiccamento, e prevedono una lavorazione sia a mano, sia mediante l’inserimento di parti ottenute a stampo, secondo una tecnica ben nota a Teano dai ritrovamenti del fondo Ruoz-zo53 e conosciuta in ambiente etrusco italico, a Cerveteri54 e a Lavinio.55 Notevole è, inoltre, la presenza di una patina nera compatta, più evidente sulle statue nn. 3 e 4, che sembra riferibile ad un rivestimento, forse al fi ne di proteggere i manufatti destinati ad una prolungata esposizione all’aria aperta, oppure per imitare l’aspetto del bronzo, piuttosto che essere causata dalle condizioni di giacitura dei materiali come era parso in un primo momento.
I frammenti compongono un gruppo di soggetto femminile iconografi camente omogeneo, sebbene stilisticamente di livello assai diseguale.
Cominciando da questo secondo aspetto, emergono con nettezza le statue nn. 1 e 4, per la realizzazione delle quali è stato profuso un notevole impegno tanto da un punto di vista tecnico – si pensi alle notevoli proporzioni di entrambe – quanto nella resa accurata dei dettagli. In particolare la statua n. 1, con la nitida defi nizione dei volumi della testa, così come la resa delicata degli arti del fanciullo sulla spalla, presenta una qualità di lavorazione tale da distinguerla non solo dalle altre statue dello stesso tipo, o simili, note a Teano e in altri siti della Campania interna, come sarà meglio illustrato tra breve, ma da conquistare una posizione di assoluta eviden-za nel panorama della coroplastica di ambiente etrusco italico di età classica.
Non del tutto fuori luogo appare il richiamo ad opere di alto livello di area etru-sco meridionale, quali le sculture prodotte dall’offi cina veiente tra la fi ne del VI e i primissimi anni del V sec. a.C.,56 e forse con maggiore puntualità quelle di produzio-ne ceretana.57 Proprio ai rapporti tra questo ambiente e l’ambito campano, ben noti relativamente a numerose classi di materiale nell’età arcaica,58 e in una prospettiva tracciata si direbbe quasi profeticamente da G. Colonna,59 rimandano anche alcuni degli accorgimenti tecnici osservabili sulle migliori delle terrecotte in esame e in par-ticolare al modellato della statua n. 2 il cui «profi lo del cavo interno ripete invece con sorprendente fedeltà il contorno delle fi gure, quasi come l’anima di terra di un grande bronzo approntato per il getto a cera perduta, diramandosi sgombro da ogni ostacolo o strozzatura non strettamente inerente la forma esterna».60 In effetti, le due statue sidici-ne richiamano la tecnica del Maestro dell’Ercole e della Minerva di Veio anche per la mancanza di ispessimenti e diaframmi nei punti critici, per lo spessore ridotto delle pareti e per la delicata cura nel rifi nire le pareti interne.61
Venendo alle questioni più strettamente connesse all’inquadramento stilistico e cronologico della testa n. 1, l’acconciatura riprende la grande statuaria marmorea e
83Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna
fi ttile greca di età tardo arcaica (fi ne del VI sec. a.C.),62 nonché coni monetali della stessa epoca.63 Essa è attestata, sempre nella seconda metà del VI sec. a.C., su alcune antefi sse a testa femminile entro nimbo pertinenti al sistema di copertura detto campano;64 è, inoltre, impiegata per protomi femminili raffi gurate su varie classi di materiale nella prima metà del V sec. a.C. sia in Sicilia,65 sia in Magna Grecia,66 sia in Etruria.67
Il copricapo, con la caratteristica forma “a busta”, ricorda il tipo dell’alto polos, genericamente ritenuto di origine ionica, semplifi cato in ambiente magno greco acheo, noto da terrecotte arcaiche sia da Poseidonia-Paestum,68 sia soprattutto dal santuario di San Biagio alla Venella di Metaponto.69
Entrambi gli elementi sono presenti su teste votive, con differenti proporzioni, di Teano sia dal santuario di località Loreto,70 sia da quello di Masseria Soppegna-Fondo Ruozzo.71 Si tratta di prodotti seriali derivati da matrici in rapporto con quelle impiegate per realizzare alcune teste votive di Cales 72 e di Capua,73 tra le quali se ne segnala per il disegno della capigliatura un tipo con basso copricapo della prima metà del V sec. a.C.74
Ai caratteri arcaizzanti della pettinatura, tenuto conto della lacuna su parte de-gli occhi e sul naso,75 si associano tratti del volto, soprattutto mascelle e bocca, che risentono della lezione severa così come letta in ambito siceliota76 e magno greco,77 fenomeno peraltro ben noto in Etruria anche su prodotti seriali.78
A Teano stessa, pur in assenza di puntuali corrispondenze, non mancano termini di paragone nella plastica fi ttile realizzata a mano, ad esempio una testa dal san-tuario di località Loreto che propone la stessa pettinatura dell’esemplare n. 1,79 che confermano l’alto livello della bottega sidicina.80 Con l’eccezione della testimonianza offerta da una serie di antefi sse a testa giovanile di recente identifi cazione da Capua, fondo Patturelli,81 si fa osservare come i confronti in ambito campano siano del tutto insoddisfacenti da un punto di vista qualitativo anche allargando l’esame a tutti i tipi di sculture fi ttili capuane, seriali e non,82 ovvero ampliando l’area geografi ca di riferimento.83 Le uniche terrecotte non importate in grado di superare un esame formale nel confronto con la testa di Teano sono quelle della scuola coroplastica po-seidoniate.84 Qualche utile termine di paragone per la comprensione dell’orizzonte formale entro il quale la testa in esame si inscrive si rinviene con alcune sculture dal santuario orientale di Lavinio, i cui volti ripropongono non solo l’impalcatura del viso dell’esemplare sidicino, ma anche il profi lo a V delle arcate orbitali, nonché il disegno delle labbra,85 e con una testa dalla decorazione architettonica del tempio di Giunone Moneta a Segni.86 È stata assegnata ad ambiente etrusco meridionale una splendida testa di Minerva (?) a Berlino, proveniente dal mercato antiquario napoletano:87 sul volto si ripetono con una certa coerenza tanto la struttura ossea, quanto il disegno delle labbra osservabili sull’esemplare in esame. Volendo inserire la testa della statua n. 1 in una seriazione cronologica,88 essa dovrebbe essere chiara-mente successiva alle sculture acroteriali del Portonaccio,89 agli altorilievi frontonali
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 84
più antichi del tempio A di Pyrgi, e opere ad essi riconducibili,90 ma precedente tanto la testa giovanile dal medesimo santuario coerentemente classica, di recente datata agli ultimi decenni del V sec. a.C.,91 quanto la famosa cosiddetta Mater Matuta da Chianciano.92 Da quest’ultima la testa di Teano si differenzia non tanto per la qua-lità, quanto per la mancanza di qualsiasi inserimento di elementi riferibili allo stile classico, la cui commistione con stilemi severi è invece praticata dalla scuola scul-torea chiusina della seconda metà inoltrata del V sec. a.C.93 Su queste basi sembra appropriata una datazione della statua n. 1 al 450 circa a.C.
Per la statua n. 3, dirimente per la determinazione dell’ambito cronologico è la testa, realizzata con una matrice riconducibile al tipo Ciaghi A I a1 di Cales,94 datato alla seconda metà del V sec. a.C. Per una più precisa datazione sarebbe utile lo studio delle serie locali sidicine poiché, come già accennato in precedenza, questo tipo di testa è ben attestato a Teano.95 Il tipo della statua, il cui aspetto disadorno era proba-bilmente mitigato da una decorazione dipinta,96 è replicato su un esemplare acefalo dal santuario di fondo Ruozzo97 e trova riscontri a Capua con ex voto con panneggi più elaborati datati dalla Bonghi Jovino alla seconda metà del III sec. a.C.98
La statua n. 4, il cui stato frammentario non rende giustizia della imponenza dell’originale, può essere giudicata solo sulla base della già ricordata perizia tecnica e della realizzazione del panneggio. Questo elemento è disegnato sulla base del movi-mento della fi gura: pieghette verticali tra il braccio alzato e il seno, ampie e lunghe pieghe curve parallele che seguono la proiezione in avanti del busto99 per asseconda-re il passo, oppure rispondono alla tensione esercitata dalla mano destra che solleva un lembo della veste.100 La resa delle pieghe, disposte su piani paralleli a formare una sorta di scala, ha la tipica cadenza e la consistenza dei mantelli della statuaria fi ttile etrusca della fi ne del VI - prima metà del V sec. a.C.,101 replicati sulla piccola plastica in bronzo102 e raffi gurati sulla ceramica a fi gure rosse sia etrusca,103 sia campana della seconda metà del V sec. a.C.104 Nulla di più diverso tanto dai mantelli ispirati alla plastica di età classica, la cui consistenza reale si adatta al corpo sottostante, quanto dalle pieghe a cannello, spesso meramente disegnative, esemplifi cate dalla statuaria in terracotta campana di III e II sec. a.C.105 Non vi sono motivi ostativi per una da-tazione della statua entro il V sec. a.C. e piuttosto nella prima metà dello stesso.106
Lo straordinario gruppo di sculture fi ttili illustrato assomma al valore storico artistico, anche un particolare interesse iconografi co.
Come appare chiaramente anche ad una visione superfi ciale delle statue, esse sono accomunate dalla circostanza di riprodurre una medesima immagine femmini-le stante in atto di recare sulle spalle degli infanti e di sorreggerne almeno uno solle-vando il braccio, defi nibile come kourotrophos o più precisamente kourophoros.107
Si tratta di un tipo di statua sinora mai rinvenuto negli scavi del santuario di Loreto, ma altresì noto attraverso un buon numero di esemplari dal santuario di Masseria Soppegna-Fondo Ruozzo.108 Nonostante nessuno degli esemplari recupe-
85Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna
rati presso quella seconda località sia in uno stato di completezza paragonabile agli esemplari di nuovo rinvenimento, si deve a J.P. Morel e a M.J. Pena109 non solo un primo inquadramento del tipo, ma soprattutto una coerente proposta di identifi -cazione con la dea Popluna,110 divinità particolarmente legata ai Sidicini, titolare di un culto testimoniato da attestazioni epigrafi che proprio nell’area sacra di località Loreto.111
Come già proposto in altra sede,112 e come sarà approfonditamente chiarito da chi scrive in un prossimo studio sulla plastica fi ttile sidicina,113 la possibilità offerta dai nuovi esemplari di un aggancio cronologico sicuro, almeno alla metà del V sec. a.C., consente ora di apprezzare a pieno il signifi cato dell’invenzione da parte dei coroplasti locali di un vero e proprio signum fi ctile114 senza precedenti nei contesti culturali di riferimento.
Infatti, contrariamente a quanto prospettato dalla Pena,115 il rapporto con le sculture fi ttili veienti non può in alcun modo confi gurarsi in termini di dipendenza da un “modello” etrusco, ma va bensì inquadrato nel più vasto alveo delle sollecita-zioni venute agli artigiani sidicini non solo dalle produzioni artigianali dell’Etruria campana e tiberina, ma anche dall’area poseidoniate.116 Si tratta di suggestioni, di un orizzonte iconografi co se così si può dire, che i maestri locali hanno sviluppato con lo studio e la coerenza formale propria di una bottega di alto livello che risponda ad una commessa molto precisa. Non altrimenti è possibile spiegare l’esistenza di statue di dimensioni pari e maggiori del vero sin dalla metà del V sec. a.C., se non in un momento antecedente, plasmate secondo tecniche non seriali, come gli esemplari nn. 1 e 4. Lo strettissimo legame intercorrente tra la nuova kourophoros e i Sidicini è, inoltre, confermato dalle attestazioni del tipo diffuso solo sul territorio propriamen-te sidicino e nella regione immediatamente circostante, dove i limitati esemplari ritrovati potrebbero essere traccia di un atto di devozione praticato da frequentatori provenienti dall’area teanese.117
Il tipo statuario in sé, ripetuto in parecchie decine di esemplari, sembra rispon-dere con chiarezza all’esigenza rappresentativa di una divinità quale Popluna, sotto la cui protezione era posta la continuità del corpo cittadino non solo in termini me-ramente biologici, ma soprattutto sociali e di difesa militare del corpo civico.118 In tal senso si comprendono tanto la esplicita distinzione nel dimorfi smo sessuale (genitali scoperti per i soli maschi, con pudenda coperte per le bambine), quanto l’abbiglia-mento dei fanciulli che replica quello indossato dalle statuine di offerenti adulti.
Circa la temperie storica della commessa, i dati del contesto dello scavo del 2002, uniti alle osservazioni stratigrafi che dello Johannowsky per l’area nelle immediate vi-cinanze, forniscono indicazioni per la costruzione di strutture di una notevole cura decorativa, se non proprio monumentalità, agli inizi del V sec. a.C., come suggerito dalla cornice in tufo con kymation dorico e dalle antefi sse con protome femminile entro fi ore di loto. Questi dati, che trovano un signifi cativo parallelo a Masseria
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 86
Soppegna-Fondo Ruozzo, concorrono nel focalizzare l’attenzione sulla prima metà del V sec. a.C.119
Si tratta, come noto, di un periodo importante e delicato caratterizzato dallo scardinarsi degli equilibri regionali di età arcaica e dall’emersione di nuove comu-nità ad una consapevolezza etnica in molti siti dell’Italia centro meridionale, con particolare riferimento alla Campania.120 In un clima di tal genere, considerata l’im-portanza strategica da sempre rivestita dal territorio sidicino posto a controllo della più importante via di traffi co interna tra nord e sud della Penisola, sembrerebbe ap-propriato da parte della comunità sidicina esprimere il proprio orgoglio identitario in una sede cultuale e attraverso sistemi di rappresentazione propri e autonomi, in discontinuità con il periodo tardo arcaico.121
In base a quanto sopra osservato, vale la pena riassumere i risultati dello scavo prima di avviarci a concludere:
1. Nella prima metà del V sec. a.C. su un’altura prospettante sul Savone prende forma monumentale il culto di Popluna, con un santuario il cui aspetto planimetri-co sembra rifl ettere fedelmente la famosa defi nizione latina di sacellum come “locus parvus deo sacratus cum ara”;122
2. Tra i donari presenti nell’area e datati nel corso del V sec. a.C. spicca un grup-po di tre statue raffi guranti tutte una kourophoros, originale creazione sidicina;
3. Una delle tre statue, la n. 1 del nostro catalogo, si distingue dalle altre per raffi nata fattura e preziosità (si ricordi che il polos era rivestito con una lamina) e si presta ad essere identifi cata come la statua di culto del 450 circa a.C.;
4. Tra la fi ne del III e gli inizi del II sec. a.C., nell’ambito della riorganizzazione dell’area sacra in forme grandiose mediante la creazione di terrazze con accesso mo-numentale da sud, l’antico sacello di Popluna viene smantellato con una cerimonia di chiusura e i donari più importanti pietosamente sepolti; un nuovo edifi cio tem-plare ingloba nelle sue fondazioni le strutture più antiche;
5. Questo nuovo tempio, che non si esita ad identifi care con quello di Iuno Po-pluna, è utilizzato almeno sino a tutto il II sec. d.C., essendo l’area completamente adibita ad altra funzione nella prima metà del VI sec. d.C.
In conclusione, grazie al carattere pubblico uffi ciale rivestito nell’antichità dal sito indagato, lo scavo ha non solo permesso di ricostruire la sequenza di attività svoltesi sull’area dal VI sec. a.C. al VI sec. d.C., ma ha altresì consentito di recupe-rare elementi di microstoria locale utili all’inquadramento di alcuni reperti di parti-colare impegno come indicatori di elaborazione culturale nel contesto dei fenomeni storici di scala sovra regionale del V sec. a.C.
In particolare, la statua di culto in terracotta si candida, nella prospettiva dei rapporti con le grandi scuole di plastae attive tra il VI e il V sec. a.C. in Etruria e
87Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna
nel Lazio quale interlocutore rispetto alla bottega veiente/ceretana,123 soprattutto nel momento della crisi delle commesse pubbliche capuane dopo il 474 a.C.124 Nell’ot-tica regionale, della produzione seriale di teste e statue votive con copricapo a polos detto “a busta”, la Popluna di località Loreto può essere identifi cata come vera e pro-pria testa di serie in quanto prodotto di alto livello qualitativo in grado di imprimere alla bottega sidicina, nel corso del V e nella prima metà del IV sec. a.C., una certa forza di proiezione verso l’area ausone,125 calena e capuana.126 Comincia a defi nirsi, in altre parole, il ruolo della coroplastica come una delle produzioni artigianali di punta di Teano che formano, naturalmente insieme ad altri aspetti dei quali non è qui luogo per discutere, le precondizioni e il contesto in termini di attrazione e di potenza dell’interesse e della credibilità oramai acquisite dalla touta sidicina al co-spetto di Roma, al momento delle scelte decisive della seconda metà del IV sec. a.C. per l’egemonia nell’area centro tirrenica.
Note* Questo studio è stato concluso durante un soggiorno di studio presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene concesso allo scrivente nell’ambito della Convenzione tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e SAIA; viva gratitudine si esprime al Direttore Generale per l’Archeologia dott.ssa Anna Maria Reggiani, al Direttore della SAIA, prof. Emanuele Greco e al Soprintendente per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, dott.ssa Maria Luisa Nava. Si ringrazia altresì il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania dott. Stefano De Caro, già Soprintendente, per la fi ducia accordata a chi scrive e per il permesso di studiare i materiali. Si coglie l’occasione per ricordare la disponibilità e la gentilezza tanto della signora Anna Mazzoccolo di Lignola, proprietaria dei terreni, quanto i signori Ruozzo, fi ttavoli della masseria Loreto. Un ringraziamento per i consigli ai professori Heinz Beste, Maddalena Mertens Horn, Werner Johannowsky, Carlo Rescigno, Gianluca Tagliamonte, Fausto Zevi. Piace ricordare l’intelligente supporto offerto dal Direttore dei lavori geom. Franco L’Affl itto. Lo scavo si è avvalso dell’assistenza scientifi ca del dott. Tommaso Conti con il quale si prepara l’edizione defi nitiva dei risultati. I restauri, coordinati dalla collega Luigia Melillo, sono stati eseguiti con rara perizia dalle dott.sse Viginia Iengo e Laura Parrella. Le foto dei reperti ove non altrimenti spe-cifi cato sono di Ortensio Fabozzi. Vivo compiacimento si esprime anche alla ditta MD Archeologia di Morelli e d’Alonza s.n.c. e alle maestranze, la cui dedizione è stata determinante per il buon fi ne della ricerca. Tra i tanti amici e colleghi verso i quali si è in debito di consigli e discussioni, si ricordano Alfredo Balasco, Paolo Caputo, Francesca Casule, Virginia D’Avino, Floriana Miele, Antonio Salerno, Valeria Sampaolo, Nicoletta Scala.1 Gabrici 1910, 6-8, 28-39, 46-58.2 Sulla storia e l’archeologia di Teano: Cerchiai 1995, 175-177; De Caro, Miele 2001, 520-527; Sirano 2006a, 331-334; Sirano 2006b, con bibliografi a. 3 Fondamentali Johannowsky 1963, 142-152; Morel 1998, 157-167 (con bibliografi a).4 De Caro 2003, 608-611. 5 Johannowsky 1963, 133-142.6 Un ringraziamento non formale si indirizza al direttore della BSR prof. Andrew Wallace Hadrill, ai proff. Simon Keay, Martin Millet, Helen Patterson e ai colleghi che hanno eseguito sul campo le indagini: dr. Sophie Hay, Kriss Strutt. 7 L’asse stradale si è rivelato, a successive indagini geofi siche, appartenente al reticolo stradale urbano delimitante una serie di isolati del quartiere immediatamente contiguo all’area sacra di Loreto: Zevi 2004, 881, fi g. 4.8 Le fondazioni in grandi blocchi sembrano, infatti, destinate a sostenere un piccolo edifi cio del cui alzato, forse in materiale deperibile, non sono state rinvenute tracce nel corso del presente scavo. È però degno di segnalazio-ne il ritrovamento da parte di W. Johannowsky a poche decine di metri da questo sito di alcune antefi sse a pro-
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 88
tome femminile entro nimbo, le cui dimensioni sembrano compatibili con il tetto del supposto sacello (Sirano 2006a, 331-338 con bibliografi a). Per sacelli di contenute dimensioni si vedano per l’Etruria: G. Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, 111, n. 5.2 (Falerii, santuario di Celle, edifi cio a); G. Gazzetti, ibidem, 155-156, n. 8.3 (santuario di Grasceta dei Cavallari, Monti della Tolfa, edifi ci minori); Colonna 1992 a, 72-74, 83-84, tav. 2, fi gg. 3, 15 (Pyrgi, edifi ci α e γ - rispettivamente del V-III e della prima metà del V sec. a.C.); Jolivet, Marchand 2003, 42, 44, fi g. 6 (Bolsena, Poggio Moscini); per il Lazio: Zaccagni 1978, 44-45, fi g. 2, tav. 17, 1 (Gabii, san-tuario orientale) De Cristofaro, Di Rienzo 2004, 807-811, fi g. 1(Cassino); per la Lucania: Bracco 1978, 52-53, fi g. 69; Russo Tagliente 1995, 41, 43-44, fi gg. 35- 36, 41-42 (Armento, Serra Lustrante).9 Per il tipo: Yavis 1949, 128-130, 203-204; Cassimatis et al. 1991, 269-271, tav. 1. F. 1 a. Cfr. a Lavinio le incisioni osservate sulle alcuni plinti di base degli altari del complesso delle XIII are (Cozza 1975, 90, 97, 107, 108, 114, tav. 7, datazione: metà del VI - metà del V sec. a.C.); per un contesto stratigrafi co simile: de Cazanove 2004, 279-285, fi gg. 14, 15, 16.2 (Civita di Tricarico, corte basolata antistante il tempio P).10 Yavis 1949, 185-196; Cassimatis et al. 1991, 269- 271, tav. 1. F. 4; Ohnesorg 2005, 5-7.11 Koch 1907, 368-385, fi g. 1-9; Yavis 1949, 187; Johannowsky 1976, 273.12 Si pensi agli esempi di V sec. a.C. citati in Colonna 1986 a, 430, 473-474, 491, fi gg. 116, 356-357, tav. 21.13 Il coltello è stato trovato nella US 15, in corrispondenza del sacrifi cio US 29. I reperti osteologici sono in fase di analisi e studio da parte del prof. Jacopo de Grossi Mazzorin dell’Università degli Studi di Lecce.14 La US è formata, oltre che dal frammento di una gamba di statua di guerriero (Inv. Gen. 310199), dai seguen-ti materiali: n. 2 busti fi ttili con polos (Inv. Gen. 310282; 310283: per il tipo cfr. Johannowsky 1963, 148, fi g. 14 c; Bedello 1975, 66-68, tipo A XXIII a1, tav. 18.1; D. Giampaola, in Napoli Antica 1985, 321, 97.9; Chiosi 1993, 115, S3, tav. 15.2); n. 2 kourotrophoi stanti (Inv. Gen. 319284; 319285, tipo D I A1 di Capua: cfr. Greco 1990, 113, tipo IV, fi g. 202); n. 1 kourotrophos assisa (Inv. Gen. 309366: cfr. Greco 1990, 112-113, tipo I, fi gg. 200, 204-205; Chiosi 1993, 131-132, S 77-78, 81, tav. 17.4); n. 1 offerente stante (Inv. Gen. 310286: cfr. Chiosi 1993, 130, S 76, tav. 17.2 con errata interpretazione come offerente con animale); n. 1 parte inferiore di statuina di offerente (Inv. Gen. 310287) con tracce di bruciato; n. 1 coperchio emisferico di impasto (Inv. Gen. 310288); vernice nera: n. 1 coppa assimilabile alla serie Morel 2714 (Inv. Gen. 310289: cfr. Morel 1981, 208-209, 2714 i, tav. 67); n. 2 coppette echiniformi assimilabili alla serie Morel 2765 (Inv. Gen. 310290; 310292: Morel 1981, 219, 2765 d1, tav. 71); n. 2 coppette assimilabili alla serie Morel 2783 (Inv. Gen. 310291; 310293: cfr. Johannowsky 1963, 136, fi g. 7 i; Morel 1981, 223, 2783, tav. 72). L’orizzonte cronologico dei materiali si inscrive tra la fi ne del IV e la prima metà del III sec. a.C.15 A titolo di confronto si vedano i casi di Veio, Piazza d’Armi (Bouma 1996, 107-108, n. 125 c, con biblio-grafi a); Portonaccio, zona est (Colonna 2001, 37-44, fi gg. 1-2; Colonna 2002, 158-159, fi gg. 9-10); Gabii, santuario orientale (Colonna 1984, 401, fi g. 6); Cassino (De Cristofaro, Di Rienzo 2004, 809); Campochiaro, santuario di Ercole (Capini 2003, 243, 247, fi g. 11).16 Johannowsky 1963, 133.17 Sirano 2006a, 33, 337-338; per un confronto da contesto nel quale il rapporto tra antefi sse e strutture, di dimensioni confrontabili con quelle dell’edifi cio di Teano, è stratigrafi camente accertato: Russo Tagliente 1995, 102-103, nn. 321-322, fi gg. 103-104.18 Zevi 1980, 267-269; Zevi 1981, 346-351; Mertens 1993, 173; Sirano 2006a, 332-334, 335-337, fi g. 33.6-8.19 Contrariamente a quanto sostenuto da chi scrive (in Sirano 2006a, 331, fi g. 33.2), ad una più attenta analisi il frammento di coronamento trova più calzanti confronti con cornici di altari tardo arcaici in contesto ellenico: Ohnesorg 2005, 28, tav. 9.40, 7-9.20 Jolivet, Marchand 2003, 40-45, fi gg. 1, 6 (Bolsena, Poggio Moscini); Tagliente 2005, 115-116, fi gg. 2-3 (San Chirico Nuovo). Vedi anche edifi ci citati a nota 8.21 Si pensi a Satricum: Maaskant-Kleinbrink et al. 1992, 113-128, tavv. 38, 44; Bouma 1996 a, 54-56; Lanu-vium: Colonna 1984, 401, 406-408, fi g. 17; Bouma 1996, 43-45, n. 81 a; più discussi i casi di Ardea, Colle del Noce (Bouma 1996, 18-19, n. 17 c, con bibliografi a) e Veio, Piazza d’Armi (Bouma 1996, 107-108, n. 125 c). 22Brown et al. 1993, 51-56, 142-143, 147-148 (Cosa, Foro, tempio Beta/B); Buonamici 2003, 43-83, 524-526, fi g. 1 (Volterra, templi dell’acropoli).23 Johannowsky 2004, 285, fi g. a p. 287 (Circello).24 Inv. 310199, US 29.25 US 8 = 15.
89Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna
26 Per pratiche simili di sacrifi cio e di “abbandono” documentate in un contesto cultuale italico: A. Lupia, in Bailo Modesti, Cerchiai et al. 2005, 212-213, fi gg. 26-28 (Pontecagnano, via Verdi); Osanna, Sica 2005, 135-137 (Torre di Satriano).27 Il coltello proviene dalla US 63, trincea di fondazione del muro meridionale della cella (USM 58). Gli ele-menti di lancia provengono da uno strato di terreno combusto (US 45) localizzato tra il muro settentrionale della cella e il muro perimetrale del podio. Coltelli sono stati rinvenuti in molte stipi italiche, si vedano ad esem-pio: Lo Porto 1991, 185-186, nn. 304-306, tav. 35 (Timmari); Maioli, Mastrocinque 1992, 123-124, fi gg. 9-10 (Villa di Villa); P. Riccitelli, in I luoghi degli dei 1997, 131, nn. 31-34 (stipe di Vacri). Armi erano state rinvenute in gran numero anche a fondo Ruozzo sia in versione reale, sia in miniatura riprodotte in argilla (Morel 1992, 221-232). Per armi in santuari: Talamo 1987, 103, n. 22, tav. 46; (Mondragone, Panetelle); Lo Porto 1991, 184-185, nn. 296, 299, 301-303, tav. 35 (Timmari); Gatti 1995, 119-121, nn. 588-601, fi g. 75 (Anagni); Russo Tagliente 1995, 70-71, fi gg. 76-77 (Armento); Papadopoulos 2003, 61-62, nn. 161-163, fi gg. 79 e 63-65, nn. 167-170, fi gg. 81-82 (Timpone della Motta, Francavilla); M. Mancasi, in Bailo Modesti, Cerchiai et al. 2005, 200, fi g. 13. In generale sulle armi nei santuari femminili: Cardosa 2002, 99-103.28 Inv. Gen. 306454, frammenti provenienti dalle UUSS 7 e 15.29 UUSS 15 e 35.30 US 29, vedi nota 14.31 Il confronto tra la composizione della US 29 e la US 15 mostra infatti non solo la presenza in forma residuale di ceramica comune (US 15 anche in miniatura, come lo skyphos Inv. Gen. 309930), ma soprattutto di vasi in vernice nera riferibili a libagioni, coppe e coppette, in proporzioni che vedono una netta prevalenza delle seconde sulle prime (US 29: 1 coppa a fronte di 4 coppette; US 15: 4 coppe a fronte di 20 coppette), ai quali si aggiungono nella US 15 anche una coppetta concavo convessa e due oinochoai miniaturistiche. Anche nella piccola plastica ricorrono le statuette di offerenti stanti (Inv. Gen. 309938) e le kourotrophoi di tipo Panetelle (Inv. Gen. 309935), con alcune specifi cità che distinguono la US 29 dalla US 15. Quest’ultima annovera tana-grine nello schema della “Grande Ercolanese” (Inv. Gen. 309934; 309983; 309932: cfr. Greco 1990, 114, F I, fi gg. 206-207), Muse (Inv. Gen. 309939), fi gurine maschili con copricapo a punta tipo Attis (Inv. Gen. 309936; 309937) e poche attestazioni in impasto che sembrerebbero appartenere alla più antica stipe, per gran parte scaricata nella fossa US 7: teste di statuette con copricapo a punta (Inv. Gen. 309937, cfr. Johannowsky 1963, 146, fi gg. 11 l-m, 12 c-d), con elmo crestato (s.n. inv: cfr. Morel 1991, 23, fi g. 8 c-d; Sirano 2006 c, 75, fi gg. 12-15); frammento di fanciullo assiso sulla spalla di una kourophoros (vedi infra note 107 e 108).32 Per la cronologia della US 29, vedi nota 14; per la US 15, materiale diagnostico sono le coppe a vernice nera assimilabili alla serie Morel 2714 (Inv. Gen. 309940; 309941: Morel 1981, 209, 2714 h, tav. 67), alla serie Morel 2713 (LOR/15/827, s.n. inv.: Morel 1981, 208-209, 2713 a1, tav. 66), alla serie Morel 2737 (Inv. Gen. 309929: Morel 1981, 214, 2737 b, tav. 68); coppette echiniformi assimilabili alla serie Morel 2765 (in tre varianti, I gruppo: Inv. Gen., 309921; 309923; 309924; 309925; 309945; 310208; 310212; 310215; 310224; II gruppo: 309927; 399942; 310209; LOR/15/821; LOR/15/826; III gruppo: 309922; 309926; 309928; 309944; 309948; 310207; 310210: cfr. Morel 1981, 219-200, 2765 d-e, tav. 71); coppetta concavo convessa assimilabile alla serie Morel 2435 (Inv. Gen. 309947: Morel 1981, 171, 2435 c1, tav. 50); oinochoe triloba assimilabile alla serie Morel 5644-5645 (Inv. Gen. 309931: Morel 1981, 377-378, 5644 a1, 5645 d1, tav. 181). Il contesto rinvia alla prima metà del III sec. a.C. 33 US 25: ceramica a vernice nera, coppette echiniformi assimilabili alla serie Morel 2765 (Inv. Gen. 310228, 310229; 310233: Morel 1981, 219-220, 2765, tav. 71); coppe assimilabili alla serie Morel 2714 (Inv. Gen. 310230; 310232: Morel 1981, 209, 2714, tav. 67); coppetta concavo convessa assimilabile alla serie Morel 2424 (Inv. Gen. 310240: Morel 1981, 169, 2424, tav. 49); piccola plastica, statutte di erote alato con mano sinistra sul fi anco (Inv. Gen. 310264; 310272; s.n. inv. 1: cfr. Greco 1990, 120, H I, 1-II, 1, fi gg. 232-233); teste di statuine con copricapo a punta (s.n. inv. 2), di statuine femminili (Inv. Gen. 310273, s.n. inv. 3-4); pesi da telaio troncopiramidali (Inv. Gen. 310245-310247). 34 La testa (US 25, Inv. Gen. 306453; h. cm 31,5; largh. cm 19; prof. cm 19; spess. cm 2) presenta sulla su-perfi cie ocra arancio ancora tracce della decorazione pittorica sulle pupille incise e deriva da matrice fresca. La testa velata, che rientra nel tipo D della classifi cazione delle teste di Capua antica (Bonghi Jovino 1965, 19, 45, D VIII a1; 46, D VIII b 1, tavv. 12, 3-4, 13, 1) può riferirsi a torsi e statue femminili simili a quelle capuane (Bonghi Jovino 1971, 61, n. 34, tav. 28, 1-2, anteriore all’esemplare teanese). Stilisticamente sembra possibile proporne una collocazione alla fi ne del gruppo ellenistico defi nito dallo Hofter delle teste “cubiche- organiche”
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 90
della seconda metà inoltrata del III sec. a.C. (Hofter 1985, 86-87, 200, n. 189-190, fi g. 10) e si inquadra in un momento di passaggio alle teste “frontali espressive”, come indicano l’ovale allungato del volto e il setto nasale più stretto rispetto agli esemplari del primo ellenismo (cfr. Hofter 1985, 97, 209, n. 246, fi gg. 25-26; 99, 210, n. 249, fi gg. 29-30). I prototipi di riferimento nell’ambito delle terrecotte votive si riconducono in particolare a tipi medio italici (si veda ad esempio: Comella 1986, 17, 38, A2 XVII, tav. 18, d; Bartoloni 1992, 65-67, n. 1, fi g. 49), attestati a Cales (Ciaghi 1993, 91, D IIa 1, fi g. 57) e a Lucera (D’Ercole 1990, 70-71, A2 VI Ab, A2 VI Ba, tav. 14, a-b) risalenti sino alla metà del IV sec. a.C.; i caratteri del viso trovano confronti, seppure non del tutto soddisfacenti, con terrecotte calene (Ciaghi 1993, 58, C Va 1, fi g. 28; 66, C Xa 1, fi g. 33; 72, C XVa 1, fi g. 38) e capuane (Bonghi Jovino 1965, 70, J I a 1, tav. 28, 1-2; Bonghi Jovino 1971, 61, n. 34, tav. 28,1-2; 71, n. 53, tav. 38, 1-2) datate al III e al II sec. a.C.; molto interessanti i rapporti istituibili con teste dalla stipe di Lucera del III - metà del II sec. a.C. (D’Ercole 1990, 60, A1 XVI, tav. 11, a; 73, A2 XIV, tav. 17, b) la cui bottega utilizza tecniche e stilemi simili a quelli apprezzabili sulla testa rinvenuta a Teano. Non chiara l’illustrazione di una testa che potrebbe costituire il migliore confronto, da Veroli: Rizzello 1980, 60, C 4, fi g. 225.35 La US 45 presenta: coppette echiniformi assimilabili alla serie Morel 2714 (Inv. Gen. 310213; 310216; 310221; 310222: Morel 1981, 209, 2714, tav. 71); n. 1 frammento di coperchio di pisside con decorazione a palmette applicata con vernice nera (Inv. Gen. 310243); un’olla miniaturistica in impasto, carenata a fondo piatto con prese a linguetta (LOR/45/1703). Sono stati rinvenuti: un obolo di Cuma (460-420 a.C.) in argento (Inv. 318362); cinque monete bronzee di Neapolis (Inv. Gen. 318363, 318367, 318368, 318369: 317/310-270 a.C.; Inv. Gen. 318364: 270-250 a.C.); monete bronzee di Roma: un quadrante (Inv. Gen. 318365: post 211 a.C.), una semuncia (Inv. Gen. 318366: post 211 a.C.); un semisse (Inv. Gen. 310205: 211 a.C. ca); un sestante (Inv. Gen. 310204: 210 a.C.). Lo studio dei reperti monetali si deve alla collega dr.ssa Teresa Giove, alla quale si esprime profonda gratitudine.36 Johannowsky 1963, 136.37 Esempi di edifi ci costruiti in parte contro terra per superare le diffi coltà imposte dal pendio naturale: Bracco 1978, 52-53, fi g. 70 (Buccino, S. Mauro; vedi anche De Gennaro, Santoriello 2003, 22); de Cazanove 2004, 269, fi g. 10, 11 (Civita di Tricarico).38 Gros 1996, 124-130.39 Cfr. Johannowsky 1963, 136-138, fi g. 2, dove le basi del tempio C avevano cm 72 di diametro. A tale propo-sito si fa notare come, ipotizzando che al diametro delle colonne sia stato assegnato un valore pari a due piedi e mezzo in relazione al modulo di cinque piedi romani, quattro colonne con diametro di base di cm 74 darebbero un intercolumnio di m 3,16 uguale a dieci piedi e tre quarti. Tale intercolumnio appare coerente con le dimen-sioni del tempio anche confrontando edifi ci dalle proporzioni vicine: Capini 2003, 247, fi g. 12 (Campochiaro, lato corto del tempio m 14,30 con colonne dal diametro di cm 89).40 Scott 1992, 97-98, fi g. 1; Taylor 2002, 68-73, 80-81; Fentress 2004, 30-32. Sempre al II sec. a.C. viene data-to anche il tempietto 15 Sestieri, nell’area sacra meridionale di Paestum, con planimetria compatibile con quella del tempio teanese: Torelli 1987, 73 fi g. 7, tav. 11.41 La Regina 1976, 223, fi g. II.42 De Caro 1986, 10-13, 24-25, tav. 10, b; sulla cronologia dell’impianto: Martelli 2005, 383. 43 Coarelli 1999, 336-337.44 Un confronto con edifi ci di proporzioni simili, ma dalla cella differente da quella del tempio sidicino si può proporre con il tempio maggiore di Schiavi d’Abruzzo (Lapenna 1997, 81), della prima metà del II sec. a.C., e con quello di Vastogirardi, della seconda metà del II sec. a.C. (Morel 1976, 256-260, fi g. B; Pagano et al. 2005, 451-454 con bibliografi a).45 Johannowsky 1963, 136-138, fi g. 8.46 Johannowsky 1963, 138.47 La Regina 1976, 230, fi g. XI; Lapenna 1997, 81-82; altrettanto calzante è il confronto con la modanatura della sagoma superiore del rivestimento del tempio che ha preceduto il tempio B di Pietrabbondante: La Regina 1976, 223-226, fi g. VI. 48 Johannowsky 1963, 138; La Regina 1976, 226-229, fi g. VIII.49 La Regina 1976, 237-241, fi g. XIII.50 Adam 1994, 46-49, fi gg. 37-38; Gros 1996, 127, fi g. 145.51 Johannowsky 1976, 270-272; Adam 1990, 82-83; Gros 1996, 391, fi g. 441. Per la più antiche attestazioni di opus caementicium per le preparazioni pavimentali, e non già per l’elevato dei muri: De Cristofaro, Di Rienzo
91Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna
2004, 811-815.52 Testa maschile ad altorilievo (Inv. Gen. 309950). Lacunosa. Tufo. H. cm 16; largh. cm 11,4; spess. cm 5,4. Si confronta con sculture in tufo del II sec. a.C.: Coarelli 1976, 25, fi gg. 2-6; I. Macchiarola, in Samnium 1991, 157, d 15.53 Morel 1990, 512-513.54 Colonna 1989, 186; V. Martelli Antonioli, L. Martelli, in Il santuario di Portonaccio 2002, 197, n. 586, tav. 51.55 M. Fenelli, in Enea nel Lazio 1981, 217, D 171; 218, D 180-181; 225, D 202. La tecnica fu poi ripresa in età medio e tardo repubblicana: D’Ercole 1990, Cfr. 7, tav. 38, c.56 Colonna 2001, 40-42.57 L’impostazione generale del volto della fi gura n. 1 ricorda quella delle fi gure sugli altorilievi della prima metà del V sec. a.C. del tempio A di Pyrgi, naturalmente più antichi, più fortemente legati alla cultura fi gurativa del tardo arcaismo e pienamente severi (G. Colonna, in Pyrgi 1970, 59-62, tav. 1, fi g. 1; tav. 2, Atena; 73, fi g. 47; per la cronologia: Colonna 2000, 309-322 con discussione sulle altre proposte di datazione). Si confronti anche la mano della statua n. 3 con l’affusolato profi lo su un frammento da Cerveteri: Cristofani 2000, 399, fi g. 3.58 Cfr. d’Agostino 1994, 432-448.59 Colonna 1997, 80 e nt. 41.60 Cit. da Colonna 1987, 24.61 Colonna 1987, 24-26, fi g. 53.62 Nell’ambito delle korai in marmo si confronti la kore 670 dell’Acropoli (Karakasi 2001, 119, tab. a p. 168, tavv. 153, 237) datata al 520 circa a.C. Per una eco agli inizi del V sec. a.C. nella plastica fi ttile ellenica: Crois-sant 1983, 355-357, n. 237, tav. 139. 63 Croissant 1983, 218-219, tavv. 86, 89 (Colofone e Cnido).64 Rescigno 1998, 92-93, tipi C 3206, 3207, tav. 31.1.65 Per la coroplastica, sia pur con un trattamento differente: A. De Miro, in Lo stile severo 1990, 262-263, nn. 97-98. Per le monete, si pensi alla famosa serie del demarateion di Siracusa: R. Macaluso, in Lo stile severo 1990, 358, n. 171.66 Milanesio Macrì 2005, 228, nn. 27, 29.67 J. Mavleev, in Die Welt der Etrusker 1988, 289, D. 3.2.68 Cipriani 1996, 207, fi g. a p. 206, con bibliografi a e inquadramento dei rapporti con Metaponto; B. Ferrara, in Magna Grecia 2005, 336, II. 239.69 Si vedano, citando a titolo esemplifi cativo solo le corrispondenze puntuali anche nella resa: Olbrich 1979, 45, 78; 115-116, A 31, tav. 8; 136, A 74, tav. 17; 150-151, A 106, tav. 24; 204, C 16, tav. 50; 206, C 20, tav. 51; 207, C 23, tav. 52; 210, C 31, tav. 53. Per attestazioni da Metaponto, santuari urbani: Barberis 2004, 49, aAVIII, fi g. 12; 77, aALVI, fi g. 88; 78, aALVIII, fi g. 97; 87, aALXXII, fi g. 124; 45, aBIX, fi g. 146.70 Johannowsky 1963, 142, fi gg. 9, c, d; 10, a, b. 71 Le teste (Inv. Gen. 202676) sono ancora inedite, ma derivate dalle stesse matrici delle teste dal santuario di località Loreto, anch’esse inedite (Inv. Gen. 205305): per il momento si vedano le foto: Sirano 2006c, 72-73, fi g. 7.72 Ciaghi 1993, 44, A Ia1, fi g. 17; 46, A III a1, fi g. 19.73 Bonghi Jovino 1965, 31-40, B I a 1, tav. 5, 4; B II a 1, tav. 6, 1; B VIII a 1, tav. 7, 3; B XII a 1, tav. 8, 3. 74 Per l’esemplare di Cales, anch’esso riferibile all’ambiente cerita: Ciaghi 1993, 49, B I a 1, fi g. 23; per Capua: Bonghi Jovino 1965, 27, A I a1, tav. 1, 1-2.75 L’attuale integrazione, che volutamente suggerisce ma non integra i volumi mancanti, è probabilmente da sottoporre a revisione poiché, come si detto, non tiene conto del netto rilievo al limite interno degli zigomi che denunzia un naso assai più potente di quello suggerito, basato sulla testa della scultura n. 3, derivata da matrice e sul confronto con altre teste votive sidicine di datazione e impianto stilistico di pieno IV sec. a.C.76 De Miro 1990, 107-116; Marconi 1994, 142-143, E4, fi g. 13 e atlante p. 64; 145, E6, fi g. 17; 155, n. 14, fi g. 25; 165, n. 15, fi g. 26; 159, n. 18, fi g. 29.77 Si vedano le teste di Medma: Milanesio Macrì 2005, 228, II. 27-32.78 Vagnetti 1971, 36-37, A XIV, a- d, tav. 10.79 Johannowsky 1963, 144, fi g. 9, h-i.80 Morel 1991, 18, fi g. 5, a, b (rispettivamente metà e fi ne del terzo venticinquennio del VI sec. a.C.); Sirano
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 92
2006c, 72-73, fi g. 3 (seconda metà del V - inizi del IV sec. a.C.).81 Rescigno 2003, 221-227, fi gg. 1-6.82 Ad eccezione delle ben note terrecotte (architettoniche?) arcaiche di elevatissimo livello (Johannowsky 1983, 78, tav. 49, a), bisogna giungere al IV sec. a.C. per rinvenire prodotti di una certa cura formale, sebbene tecni-camente non confrontabili alle terrecotte veienti e ceretane di età tardo arcaica e classica: Bonghi Jovino 1971, 23-42. 83 In ambito sannitico si potrebbe richiamare la ben nota Atena di Roccaspromonte, la cui cronologia è però discussa: Colonna 1997, 80, nota 41 con bibliografi a. 84 Rolley 1987, 203-208.85 F. Castagnoli, in Enea nel Lazio 1981, 190-191, D 61; M. Fenelli, ibidem, 223, D 199; 224, D 200; 226, D202; 228, D 205- 206.86 Cifarelli 2003, 145-146, fi gg. 143-144.87 V. Kästner, in Die Welt der Etrusker 1988, 237, C 2.2488 Per un inquadramento complessivo della scultura etrusca del V sec. a.C.: Colonna 2000 a, 378-384.89 Colonna 1987, 24-32; C. Carlucci, in Veio, Cervetri, Vulci 2001, 57; Colonna 2001, 40-42.90 Colonna 2000, 309-322.91 M.P. Baglione, in Veio, Cervetri, Vulci 2001, 76, I.F.6.9. È stato sottolineato dalla Baglione l’allungamento del volto come uno dei caratteri distintivi di questa testa, che condivide peraltro con la meglio nota testa Malavolta (C. Zaccagnino, in Gli Etruschi 2000, 622, n. 280). 92 A. Rastelli, in Gli Etruschi 2000, 588, n. 145. 93 Colonna 2000 a, 384. Molte delle precedenti considerazioni si potrebbero ripetere per le terrecotte votive seriali di area tiberina: Comella 1986, 211-215.94 Ciaghi 1993, 44, A I a1, fi g. 17 con discussione sul tipo e attestazioni; si veda anche a Capua: Bonghi Jovino 1965, 33, B II a 1, tav. 6. 1.95 Vedi qui note 70-71. È annunziato un lavoro a fi rma di S. Svanera tratto dalla Tesi di Dottorato di Ricerca in Archeologia, dedicata alle teste e alle mezze teste sidicine. 96 Si confrontino i resti di pittura sulle statue da Lavinio: P. Sommella, in Enea nel Lazio 1981, 248, D 230; E. Tortorici, ibidem, 250, D 233.97 Inedito. Inv. Gen. 199444. 98 I termini di confronto sono la mancanza di defi nizioni anatomiche e la rigida caduta verticale dei piegoni sul lato sinistro: Bonghi Jovino 1971, 69-70, nn. 47-49, tavv. 35, 1-4, 36, 1. Non mancano, peraltro, confronti per la costruzione generale e la caduta del risvolto del mantello a Lavinio, con statue del V sec. a.C.: M. Fenelli, in Enea nel Lazio 1981, D 209; a Veio: Comella, Stefani 1990, 39, Cfr. 2, tav. 10, b.99 Si veda lo schema assunto dalle pieghe della veste dell’Apollo di Veio che compie un passo in avanti: Colonna 2000, 381, fi g. a p. 35; cfr. la Latona, sempre dal Portonaccio: C. Zaccagnino, in Gli Etruschi 2000, 609, n. 219, e fi g. a p. 371.100 Si tratta di un gesto ben noto dalle korai arcaiche dell’Acropoli, sulle quali è inutile soffermarsi (si veda ad esempio la kore Acropoli 680: Karakasi 2001, tav. 248), che si trova tante volte replicato su bronzetti etruschi (Z. Bilimovič, in Die Welt der Etrusker 1988, 197, B 7.53; B. Bundgaard Rasmussen, in Gli Etruschi 2000, 622, n. 278, fi g. a p. 170).101 Oltre agli esempi già richiamati a nota 99, si vedano: V. Kästner, in Gli Etruschi 2000, 609, n. 218; Colonna 2000, 317-322, fi gg. 37, 39. 102 A mero titolo semplifi cativo: M. Cristofani, in Civiltà degli Etruschi 1985, 285, 10.30.2 (Etruria settentrio-nale?); P. Zaccagni, M. Guaitoli, ibidem, 287, 10.33 (Gabii). Terracotta votiva: Vagnetti 1971, 61, F XI, tav. 26.103 M. Cristofani, in Ceramica degli Etruschi 1987, 313-314, nn. 139-141.1. 104 Ci si riferisce ai vasi del Gruppo dell’Owl Pillar: U. Kästner, in Die Welt der Etrusker 1988, 227, C 1.19-20.105 Ciaghi 1993, 30-35, fi gg. 4-6.106 Si confrontino a tale proposito le pieghe sulle statue fi ttili: M. Fenelli, in Enea nel Lazio 1981, 224, D 201 (Lavinio); M.P. Baglione, in Veio, Cerveteri, Vulci 2001, 71, I.F. 6.3 (Veio, Portonaccio).107 Le statue si inseriscono nel tipo D della classifi cazione Hadzisteliou Price (Hadzisteliou Price 1978, 47-50) e si confrontano con i tipi a. VI (ibidem, 58, n. 457, fi g. 34, Sicilia), b. Iv. (ibidem, 49, n. 478, fi g. 35, Cortona) che trattengono i fanciulli dai piedi; i tipi c. i (ibidem, 49, nn. 480-488, fi g. 36-37) passano un braccio dietro
93Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna
la testa per sostenere i fanciulli: un gesto simile a quello della statua Teano, che però alza il braccio in avanti. Per quanto concerne la nomenclatura e i problemi connessi ai molteplici signifi cati che il termine kourotrophos assume in Grecia: Bonfante 1997, 179. Su queste basi si è ritenuto opportuno defi nire le sculture teanesi kou-rophoroi con allusione alla sola iconografi a. 108 Morel 1991, 18-21, fi g. 6.109 Pena 1989, 741-744.110 Morel 1998, 160-164.111 Izzo 1994, 277 segg.; CIL X, 4789-4791. 112 Sirano 2006c, 72-77.113 La quantità e qualità del materiale sinora noto sono di tale rilevanza da richiedere uno studio autonomo.114 Vitr. III 3, 5.115 Pena 1989, 744; cfr. Morel 1998, 164 con osservazioni critiche. In particolare sui rapporti che la studiosa propone con l’iconografi a della famosa Latona dal santuario di Veio Portonaccio va osservato come: 1) la statua di Veio è un’opera unica, inserita all’interno di un grandioso ciclo decorativo mitologico, alla quale fu tributata una certa importanza già nell’antichità (si pensi alle circostanze di pietosa deposizione delle statue e al loro rinvenimento); 2) non si conoscono dalla stipe del santuario di Portonaccio repliche a nessun titolo di questa immagine; 3) le statue di fondo Ruozzo sono invece molto numerose e riprodotte in varie proporzioni, da una misura pari al vero alle più piccole; 4) la Latona di Veio trasporta un solo fanciullo, mentre le statue di Teano ne trasportano almeno uno per spalla, se non una coppia. 116 Oltre al già noto confronto offerto dal santuario del territorio geloo di Bitalemi (Orlandini 1966, 20, tav. 9, fi gg. 1-2), le kourotrophoi del tipo Bitalemi sono attestate sin dalla prima metà del V sec. a.C. ad Agrigento (De Miro 2000, 169, n. 467, tav. 75; 246, n. 1481, tav. 75), dove il tema è ripreso anche per una variante maschile (De Miro 2000, 246, n. 1480, tav. 75); si veda anche Pautasso 1996, 39, 41, n. 47, tav. 5. Il tipo ritorna in un ambito geografi co signifi cativamente più vicino a Teano, a Poseidonia-Paestum, santuario di Santa Venera, e in misura minore nelle necropoli, nonché nella chora: Miller Ammerman 2002, 128-130, 132, n. 1822, tav. 25; 134, n. 1829, tav. 35.117 Attestazioni al di fuori di Teano sono: Panetelle, Mondragone (Chiosi 1993, 113-114, n. S1, tav. 15, 1); santuario della dea Marica alla foci del Garigliano (Mingazzini 1938, 736, tav. 17, 2). Un esemplare dalle ridotte dimensioni è stato rinvenuto negli scavi ancora in parte inediti eseguiti dalla Soprintendenza presso il santuario del Fondo Patturelli a Capua: il personaggio femminile, in rozzo impasto, sembra assiso in trono o inquadrato in un naiskos e presenta una fi gurina su ciascuna spalla; sulla base della testa, impressa con uno stampo, si data nel IV sec. a.C. (sulla ripresa degli scavi a Fondo Patturelli: Sampaolo, Grassi 2006, 321-322 con bibliografi a).118 Concordano con tale impostazione le defi nizioni date a Popluna dalle fonti letterarie antiche: Mytogr. Vat. III, 3; Mart.Capella II, 149; si veda Morel 1998, 162-163. Si tenga presente che la dea stessa era rappresentata in armi a Fondo Ruozzo (Morel 1991, 25, fi g. 9, e) e che la sfera della guerra è molto ben attestata all’interno degli ex voto: Morel 1990, 510; Morel 1991, 23, fi g. 8, a, c, d; Morel 1992, 223, 226.119 Sirano 2006a, 331-333.120 Cerchiai 1995, 178-190; Tagliamonte 2004 a, 133-151 (entrambi con bibliografi a). 121 Si confronti, a tale proposito, la kourophoros di Loreto con la statua femminile, probabilmente di culto, trovata a Fondo Ruozzo e datata alla fi ne del VI sec. a.C. Essa reca un porcellino secondo un’iconografi a che risente del tipo dell’offerente con porcellino di marca siceliota (Sguaitamatti 1984) connesso al culto di Demetra (Morel 1991, 25, fi g. 9, a-b; Sirano 2006c, 7, fi g. 4): in questo caso l’adesione ad un modello iconografi co è esplicita, l’immagine è però tradotta nel linguaggio locale.122 Trebatius, apud Gell. 7, 12, 5: cfr. Colonna 2000, 278.123 A tale proposito si leggano le lucide osservazioni in Johannowsky 1983, 79, 338.124 Rescigno 2003, 229-231.125 Una testa votiva con copricapo “a busta” è stata rinvenuta nella stipe di Cassino (Valenti 2001, 35-36, fi g. a pag. 34). Per la diffusione nella media Valle del Liri di terrecotte votive provenienti da prototipi campani, ma che ben potrebbero essere sidicini: Rizzello 1980, 60, C3, fi g. 222-224. 126 Vedi attestazioni alle note 70-71, rispetto alle quali si fa notare come la documentazione sidicina sia non solo anteriore, ma di alto livello qualitativo.
Il santuario in località Loreto: aspetti del culto femminile
Nicoletta Scala
Verso la fi ne del VI sec. a.C. in un luogo non lontano dalla rocca della futura Tea-num Sidicinum, su un’altura dominante il Savone (località Loreto), sorse un edifi cio templare con le fondazioni in blocchi di tufo e un tetto con antefi sse a testa fem-minile; con il passare dei secoli in questa zona sarebbe sorto il più grande santuario cittadino dei Sidicini che, nel momento della massima espansione (II-I sec. a.C.), avrebbe occupato un’area superiore ai due ettari.
L’area è stata indagata, negli anni Sessanta del secolo scorso, da W. Johannowsky,1 che ha anche dato un’edizione preliminare dei materiali; il culto più importante del-l’area sembra essere quello di Iuno Populona, recentemente meglio delineato grazie ai materiali venuti in luce nei nuovi scavi.2
La selezione dei materiali degli scarichi votivi recuperati con gli scavi del se-colo scorso, in vista dell’esposizione nel museo e una prima revisione inventariale condotta dalla scrivente insieme alla dott.ssa Virginia D’Avino, hanno evidenziato l’esistenza di attestazioni che possono sostanziare ancor meglio l’aspetto cultuale principale o, forse, rinviare ad altre divinità tributarie di devozione.
Lasciando da parte il culto per Ercole, attestato con chiarezza dal rinvenimen-to di statue di grandi dimensioni, bronzetti, statuette fi ttili e antefi sse,3 si con-centrerà l’attenzione, in questa sede, sulle forme di religiosità collegate a fi gure femminili.
Non sarà inutile ricordare che individuare la o le divinità venerate in un san-tuario partendo dagli ex-voto in esso rinvenuti risulta particolarmente diffi cile;4 se, infatti, nella maggior parte degli esempi, non esiste alcun particolare che consenta di stabilire se le fi gure rappresentate negli ex-voto siano devoti o divinità, anche nel caso in cui l’immagine sia chiaramente connotata come divina, non si può asserire con sicurezza che sia titolare di culto. Inoltre può accadere che la devozione assuma sfumature particolari per cui la divinità diventa diffi cilmente riconoscibile e non sono rari i casi in cui soltanto le testimonianze epigrafi che hanno fatto chiarezza.
Fatte dunque tali necessarie premesse si metteranno di seguito in evidenza i ma-teriali più signifi cativi della stipe, lasciando emergere le suggestioni cui inducono, senza alcuna pretesa di chiarire defi nitivamente e interamente il quadro dei culti praticati nel santuario.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 96
Il periodo più antico offre testimonianze abbastanza omogenee; se il culto di Iuno Populona è attestato almeno dalla metà del V sec. a.C.,5 alcune terracotte, comunque legate alla sfera della maternità e della fecondità, permettono di meglio determinar-ne le caratteristiche.
Di particolare interesse risultano due statuette, già pubblicate da W. Johan-nowsky6 che vi ha riconosciuto fi gure di gestanti. Anche se, purtroppo, entrambe acefale, l’iconografi a sembra comunque riconoscibile con un buon margine di cer-tezza. La prima (fi g. 1) è caratterizzata dal seno e dal ventre sporgente, mentre sulle spalle restano le tracce di una lunga capigliatura; la seconda (fi g. 2) è riconoscibile per il ventre prominente e, in particolare, per l’ombelico evidenziato. La datazione
Fig. 1 - Statuetta di donna incinta (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
97Il santuario in località Loreto: aspetti del culto femminile
risulta dubbia, anche per la mancanza della testa; tuttavia la raffi gurazione enorme-mente semplifi cata, la rozzezza dell’impasto, il crudo realismo dei particolari incli-nerebbero a collocarle nel primo periodo di vita del santuario. L’iconografi a è senza confronti, a quanto sembra, per questo orizzonte cronologico; in epoca più recen-te, nel santuario in loc. Privati a Stabia, P. Miniero ha suggerito di riconoscere una gestante in una raffi gurazione di donna con chitone aperto sul ventre sporgente.7
A queste due fi gure si può accostare, nello stesso periodo, una terza statuetta femminile (fi g. 3), caratterizzata da un singolare copricapo, seduta, con accanto un bambino raffi gurato schematicamente, inginocchiato, stretto alle sue gambe.8
Più ricche di sfaccettature risultano le fasi più recenti di occupazione del sito collegate, del resto, anche a complesse trasformazioni strutturali: se, infatti, già nella prima metà del III sec. a.C. il santuario assunse un aspetto monumentale mediante la costruzione di due terrazze, nel corso del II sec. a.C., su una di esse (II) vennero costruiti quattro templi su podio, mentre all’estremità sud dell’area, nascevano altre strutture, tra le quali una fontana. Nell’enorme massa di votivi riferibili a questo periodo bisogna distinguere, ai fi ni dell’individuazione del culto, le attestazioni più o meno isolate dai casi in cui più indizi rinviano al riconoscimento di una stessa realtà cultuale.
Poco signifi cativa una statuetta di donna in trono (fi g. 4);9 si tratta con ogni pro-babilità della raffi gurazione di una divinità ma non è possibile precisare chi ritragga, dal momento che si tratta di una delle iconografi e più neutrali, un’immagine divina
Fig. 2 - Statuetta di donna incinta (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
Fig. 3 - Statuetta di madre (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 98
il cui signifi cato può esplicitarsi nell’ambito della specifi ca offerta e, dunque, solo in un contesto più chiaro.
Altra attestazione isolata è una statuetta di Atena acefala (fi g. 5);10 la dea, che indossa un lungo peplo a piegoline con apoptygma, è riconoscibile per la presenza dell’egida. Anche se si tratta di una testimonianza unica, essa non è tuttavia irrile-vante; se, infatti, si scorrono le attestazioni del corpus delle stipi votive si evince che le statuette fi ttili raffi guranti la divinità non sono diffusissime e la loro presenza viene generalmente collegata al culto.
Un nucleo di otto esemplari proviene da Cerveteri, dal santuario in loc. Vignac-cia;11 una testa pertinente a statua di grandi dimensioni e frammenti riconducibili ad almeno due statuette provengono dalla stipe del Belvedere a Lucera,12 mentre un altro nucleo di attestazioni proviene da Locri, dai pressi di un piccolo tempio alla Mannella, scavato dall’Orsi;13 infi ne un altro frammento proviene dal santuario in loc. Campetti a Veio.14 Nella Campania tirrenica statuette fi ttili ritraenti la divinità sono state rinvenute a Punta della Campanella,15 dove il culto è attestato almeno dal-la fi ne del V sec. a.C., a Pompei nell’antico tempio dorico ridefi nito in età sannitica, e a Stabia nel santuario in loc. Privati.16
Il confronto più vicino per l’esemplare teanese è offerto da una statuetta con-servata al museo Campano e proveniente, secondo la Bonghi Jovino, dal fondo
Fig. 4 - Statuetta femminile in trono (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
Fig. 5 - Statuetta di Atena (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
99Il santuario in località Loreto: aspetti del culto femminile
Patturelli;17 anche qui la dea doveva essere venerata, come già ipotizzato da Mauro Cristofani per la presenza della sua testa su una stele votiva della fi ne del IV sec. a.C.18
In gran parte degli esempi addotti, il culto da Atena si connette alla sfera della fertilità e della fecondità: se è quasi su-perfl uo sottolinearlo al fondo Patturelli, dal quale provengono le famose sculture in pietra raffi guranti madri con infanti in grembo,19 anche alla Vignaccia la con-nessione sembra suggerita dal fatto che una delle statuette della dea reca frutti, mentre alla Punta della Campanella le attestazioni sono associate a statuette di kourotrophoi.20 La dea si confi gura come protettrice della fecondità della donna, laddove, nel santuario orientale di Lavi-nio o al Belvedere a Lucera, essa era stata garante del passaggio all’età adulta attra-verso le nozze, secondo le ricostruzioni di Mario Torelli e Cecilia D’Ercole.21
Se la presenza di Atena si riduce a quest’unica testimonianza, più nume-rosi gli indizi che rinvierebbero ad un culto di Demetra; almeno dieci sono i frammenti di bustini acromi (fi g. 6) con protome femminile coronata da polos, di un tipo diffuso e frequente nelle stipi dell’Italia meridionale (fi g. 7) e general-mente connesso al culto di questa divi-nità;22 alla stessa sfera si legano alcuni più rari esemplari di thymiateria limitati alla sola testa, generalmente considerati imitazione di una produzione punica (fi g. 7).23 Attestazione non frequente nei santuari campani, questi bruciaprofumi sono da connettersi in origine alle feste dette kernophoriai, durante le quali si era soliti offrire alla dea il paniere colmo
Fig. 6 - Bustino acromo con protome femminile (Museo Archeologico Teano;
foto SBANC).
Fig. 7 - Thymiaterion configurato di tipo “punico” (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 100
delle primizie, che le donne reggevano con il capo: da questo deriverebbe la partico-lare iconografi a delle fi gure.24 Il riconoscimento del culto appare ancor più certo sulla base di un’iscrizione incisa sul foculo di un’arula in tufo (fi g. 8) collocabile nel II sec. a.C.: K S, letta da Johannowsky come keri o kerri sakarom.25 Se l’editore lasciava aperta la possibilità di riconoscere nella prima parola il nome della divinità o quello dell’offerente sembrerebbe senz’altro possibile propendere per la prima ipotesi: sa-rebbe infatti alquanto strano che l’offerente invece di scrivere per esteso il proprio nome perché fosse chiaro a tutti lo abbreviasse; più probabile, invece, una dedica a Kerri, così attestata epigrafi camente, ad esempio, sulla tavola di Agnone.26 Anche in questo caso il legame alla sfera della fertilità e della fecondità appare chiaro: la vita, infatti, nasce dalla terra e ad essa ritorna.
Rappresentata in due statuette la dea Artemide (fi g. 9), caratterizzata dalla corta veste della cacciatrice, dalla presenza del cane accosciato ai suoi piedi e dalla fi acco-la;27 la sua presenza accanto a Demetra non stupisce, dal momento che l’associazione è frequente a Siracusa e, in generale, in Sicilia e ricorre anche nella stipe di S. Aniello a Caponapoli.28 La tradizione conferma che le due divinità erano frequentemente associate, se non addirittura assimilate, e d’altro canto anche Artemide è divinità kourotrophica e presiede alle nascite; essa è, inoltre, attestata assieme ad Atena nella
Fig. 8 - Arula in tufo (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
Fig. 9 - Statuetta di Artemide (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
101Il santuario in località Loreto: aspetti del culto femminile
già menzionata stipe della Vignaccia a Cerveteri.29
Se volessimo provare a tirare le fi la del discorso fi n qui condotto non potremmo non riproporre l’eterna querelle sull’effettiva possibilità di recuperare i culti di un santuario at-traverso l’esame degli ex-voto in esso rinvenuti: esistono effettivamente più divinità titolari del culto? Oppure (per dirla con J.P. Morel)30 alcune sono, per così dire, le affi ttuarie di un santuario di cui un’altra divinità è ti-tolare? Le statuette sono immagini di culto oppure sono state dedicate ad una divinità diversa da quella che esse stesse rappresentano? Sono domande di diffi cile risposta; quanto si può affermare è che esiste senza dubbio e fi n dai primi momenti di frequenta-zione un culto femminile, legato alla maternità, alle nascite; ad esso si ver-rebbero poi a collegare le attestazioni più specifi che. I fedeli dedicherebbe-ro cioè gli ex-voto riconoscendo un aspetto di Demetra, Artemide o Atena nella dea titolare della devozione; si potrebbe parlare (come suggerito anche dal Trotta)31 di un culto matronale multiplo o, comunque, di un culto aperto a varie forme di assimilazione e associazione con divinità greche. Infatti, accanto alle statuette che le rappresentano, continuano ad essere dedicati ex-voto più genericamente collegabili con la sfera dell’infanzia e della procreazione: sono infatti ben attestati i caratteri-stici votivi raffi guranti infanti avvolti in fasce (fi g. 10), nonché diverse statuette di kourotrophoi; singolare una raffi gurazione di scrofa con le mammelle in evidenza (fi g. 11). Non mancano anche attestazioni più direttamente legate al mondo del-l’infanzia: tra esse un tintinnabulum (fi g. 12), nonché una placchetta fi ttile di un tipo generalmente rinvenuto nelle sepolture dei bambini, forse miniaturizzazione di una sorta di giocattolo (fi g. 13).32
Se esiste dunque la possibilità di legare tutti i materiali presentati ad una stessa forma di devozione, non si può, d’altro canto, nemmeno escludere del tutto che esistesse una pluralità di culti rivolti alle divinità raffi gurate nei fi ttili; inoltre, dal momento che i titolari dei quattro tempietti sono per noi ancora anonimi, resta la suggestione che essi potessero essere dedicati ad alcune delle divinità individuate.
Fig. 10 - Statuetta di infante (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 102
Se infatti essi sono eretti, come si è detto, solo dalla fi ne del III sec. a.C., non è da escludersi che ne esistano anche fasi precedenti, non ancora individuate, che po-trebbero essere cronologicamente coerenti con i votivi mostrati.
Il santuario continua ad essere frequentato fi no al I sec. d.C. e le continue tra-sformazioni da cui è interessato confermano una particolare attenzione per l’area; se tra il II e il I sec. a.C., viene creata la terrazza IV e vengono restaurate le altre, tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., vengono eseguiti lavori di restauro e abbellimento che accentuano l’aspetto scenografi co del complesso.33
Le testimonianze epigrafi che attestano che il culto dell’osca Pupluna continuò fi no alla fi ne della repubblica e convisse con quello romanizzato di Iuno Populona;34
Fig. 11 - Statuetta di scrofa (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
Fig. 12 - Tintinnabulum (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
Fig. 13 - Placchetta fittile con infante (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
103Il santuario in località Loreto: aspetti del culto femminile
più diffi cile risulta cogliere altre sfumature, nel momento in cui la produzione degli ex-voto fi ttili diminuisce fi no a terminare.
Esiste, tuttavia, per queste fasi più tarde, un’altra classe di materiali meritevole di particolare attenzione: si tratta di frammenti di bacini in ceramica comune, de-corati all’interno con raffi gurazione di fi gure femminili, poggianti o meno su klinai (fi g. 14); in alcuni casi la raffi gurazione è, invece, limitata al solo busto oppure alla
Fig. 14 - Patella con figura femminile su kline (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
Fig. 15 - Patella con busto femminile (Magazzini Ufficio Archeologico Teano; foto dell’Autore).
Fig. 16 - Patella con testa femminile (Magazzini Ufficio Archeologico Teano; foto dell’Autore).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 104
sola testa (fi gg. 15-16). Sul bordo dei recipienti sono spesso presenti alcuni forellini, forse destinati ad accogliere fi ori o altre decorazioni vegetali.
I confronti disponibili per la classe rinviano a Pompei, dove bacini di questo tipo sono stati ritrovati nelle case, in particolar modo in quelle pertinenti a ceti medio alti; i circa 50 frammenti rinvenuti nella città sono stati accostati già dall’Elia35 e poi nel recente catalogo di M.R. Borriello e A. d’ Ambrosio36 ad arule e a particolari recipienti di forma simile a culle, decorati allo stesso modo e accomunati ai bacini anche dalla presenza di tracce di esposizione al fuoco: si tratterebbe di utensili usati per offrire alla divinità sostanze odorose o piccole libagioni. Il rinvenimento di un recipiente del tipo in situ, in un larario, garantisce che gli oggetti erano legati al culto domestico, come conferma anche una pittura pompeiana di larario che raffi -gura l’intera famiglia impegnata in una cerimonia religiosa; uno dei familiari regge appunto un bacino dello stesso tipo. Inoltre un soggetto affi ne è rappresentato an-che su alcune statuette fi ttili e in un esemplare marmoreo, rinvenuti, comunque, in larari.37 In particolare, se, secondo Festo, per il sacrifi cio ai Penati, venivano usati il salinum (recipiente per il sale) e la patella con una porzione di carne e farina, deco-rata appunto con fi gure, è proprio a quest’ultima, descritta anche da Cicerone come “patella grandis cum sigillis ac simulacris deorum” che rinviano tali attestazioni. Di particolare interesse il rinvenimento, recentemente pubblicato da Grete Stefani, a
Fig. 17 - Patella con testa femminile (Magazzini Ufficio Archeologico Teano; foto dell’Autore).
105Il santuario in località Loreto: aspetti del culto femminile
Boscoreale, di un bacile di questo tipo, analogo ad un altro esemplare sempre da Bo-scoreale, conservato a Berlino e distrutto nella seconda guerra mondiale; il recipien-te, decorato da una fi gura femminile distesa su kline e fi ancheggiata da due bustini femminili, è stato rinvenuto all’interno di un piccolo sacello domestico, insieme con una statuetta marmorea e una laminetta d’argento con la stessa raffi gurazione: il dato conferma la pertinenza ad un culto domestico.38
La frammentarietà dei materiali da loc. Loreto rende diffi cile stabilire quanti fossero in origine i bacini conservati; se, in attesa di un loro restauro, si provasse a darne una stima approssimativa, si potrebbero prendere in considerazione i soli frammenti decorati che ammontano a più di 70 attestazioni; considerando che, negli esempi pompeiani, in alcuni casi un’unica fi gura decora la patella, mentre in altri ne ricorrono tre possiamo ipotizzare la presenza certa di un numero di almeno 23, al massimo 70 bacini. Particolarmente interessante è il ricorrere in alcuni casi, di testine decorative ricavate dalle stesse matrici usate per la realizzazione delle ap-pliques che decorano i modellini di tempietti rinvenuti nel santuario (fi gg. 17-18) suggerendo dunque la possibilità di una produzione nata e sviluppatasi proprio per le esigenze dei devoti e comunque, con ogni probabilità, locale.
Non risultano altre attestazioni da aree santuariali; un confronto per la forma è stato istituito dalla Borriello con una settantina di esemplari provenienti dal santua-rio di Demetra e Kore a Corinto, nei livelli romani del tardo I sec. a.C.,39 e, anche se
Fig. 18 - Acroterio di tempietto (Museo Archeologico Teano; foto SBANC).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 106
si tratta di esempi privi di decorazione fi gurata, mi sembra importante sottolineare il dato che potrebbe suggerire una continuità con i culti del periodo precedente.
La fi gura femminile dei vasi pompeiani è generalmente interpretata come raffi gu-razione di Vesta, che, insieme ai Lari e ai Penati, aveva un ruolo di primo piano nei culti domestici e familiari; l’associazione alle cd. “culle” ugualmente decorate ha per-messo di ipotizzare una connessione a rituali privati collegati al mondo dell’infanzia. G. Stefani, esaminando accanto al citato rinvenimento di Boscoreale, una serie di pitture pompeiane ha sottolineato la quasi costante presenza nelle raffi gurazioni di un serpente e della cornucopia, individuando così nella fi gura Bona Dea, divinità indigena della fecondità e della salute, oggetto di un culto esclusivamente muliebre. Determinare senz’ombra di dubbio il soggetto delle raffi gurazioni teanesi non è pos-sibile; se si potrebbe escludere con buoni margini di sicurezza che si tratti di Bona Dea per la mancanza dell’elemento fondamentale a sostegno di questa ipotesi e cioè del serpente, resta aperta la possibilità che si tratti di Vesta o di Demetra o di un’altra divinità per noi non riconoscibile. Tuttavia l’accostamento iconografi co delle fi gure rappresentate a queste divinità, il rinvenimento di utensili simili soltanto in conte-sti privati o forse, nel santuario di Demetra a Corinto, l’affi nità di decorazione tra questi oggetti e le cd. “culle”, suggeriscono l’esistenza, anche nelle ultime fasi di vita del complesso, di un culto tributato ad una divinità comunque femminile e ancora strettamente connessa alla sfera familiare.
Note1 Johannowsky 1963.2 Sui nuovi scavi ha ampiamente relazionato Francesco Sirano: cfr. in questo stesso volume il suo contributo.3 Johannowsky 1963, 148-150; inedite le antefi sse, esposte oggi nel Museo Archeologico di Teano.4 Comella 1981, 759-762.5 Se tarde sono infatti le attestazioni epigrafi che (su cui Izzo 1994) i reperti archeologici consentirebbero di risalire a questa data.6 Johannowsky 1963, 146.7 Miniero et al. 1997, 27.8 Johannowsky 1963, 134.9 Johannowsky 1963, 151.10 Johannowsky 1963, 150.11 Nagy 1988, 28, A I.12 D’Ercole 1990, 179, E9 VI-VIII.13 Barra Bagnasco 1996, 222.14 Comella, Stefani 1990, 59 E1 fr 2.15 De Caro 1992, 173 segg.16 Miniero et al. 1997, 15 segg.; 24, n. 12; Miniero 2002, 20-21.17 Bonghi Jovino 1971, 44, n. 2.18 Cristofani 1992, 6.19 De Caro 1991, 314-318, con bibl. precedente.20 Le stesse ricorrono anche nel santuario in loc. Privati insieme a raffi gurazioni di infanti.
107Il santuario in località Loreto: aspetti del culto femminile
21 D’Ercole 1990, 297; Torelli 1984.22 Per una testimonianza da loc. Loreto cfr. Johannowsky 1963, 149. Sull’identifi cazione delle protomi con polos con Demetra cfr. Ambrosini, Michetti 1994, 135 segg., con raccolta della bibliografi a precedente.23 Johannowsky 1963, fi g. 16, c.24 Ambrosini, Michetti 1994, 139 segg.25 Johannowsky 1962, 64-65.26 Prosdocimi 1989, 513-519.27 Johannowsky 1963, 149; un altro esemplare è stato rinvenuto nel corso della revisione inventariale.28 Borriello, De Simone 1985, 159 segg.29 Nagy 1988, 32.30 Morel 1998, 166.31 Trotta 1991, 276.32 Johannowsky 1963, 147, sui bambini in fasce; la scrofa è pubblicata come cinghiale (col. 150) senza notarne le mammelle particolarmente evidenziate; il tintinnabulum è pubblicato dall’editore in col. 151. 33 Johannowsky 1963, 140-141.34 Cfr. nota 5.35 Elia 1962. 36 d’Ambrosio, Borriello 2001.37 Su tutte queste testimonianze cfr. d’Ambrosio, Borriello 2001.38 Stefani 2000.39 d’Ambrosio, Borriello 2001, 46.
La tomba 50 della necropoli in località Torricelle di Teano in relazione agli scambi culturali tra la Campania
settentrionale e l’Etruria interna in età arcaica*
Rita Benassai
Tra le espressioni dell’identità di una comunità le manifestazioni relative alla sfe-ra funebre rivelano con maggiore chiarezza di altre ideali di vita e rapporti culturali più o meno stabili e duraturi con altre comunità. Ciò è tanto più valido quando le manifestazioni della sfera funebre rappresentano la sola modalità di autorappresen-tazione che noi conosciamo di una comunità, come spesso avviene nella ricerca ar-cheologica in Campania. È il caso anche delle comunità insediate in età arcaica nelle zone pedemontane dell’interno, nei territori pertinenti a Cales e poi a Teano, come è il caso della necropoli di località Torricelle, posta sulla riva sinistra del torrente Savone. La necropoli fu scavata nel 1978-1979 rivelando la presenza di un cospicuo numero di tombe, articolate cronologicamente tra la seconda metà del V sec. e la metà del IV sec. a.C., quando gli insediamenti sparsi nel territorio si diradano e gli abitanti si spostano nei nuovi centri urbani di Cales e di Teano.
Tra le tombe più antiche e più signifi cative in relazione alla conoscenza dei rapporti intercorsi tra queste comunità e quelle limitrofe, si segnala la tomba 50, a cassa con copertura a doppio spiovente (Tav. 16),1 fortunatamente rinvenuta in buone condizioni di conservazione. La cassa è composta da una serie di lastre di tufo accostate con cura: gli spioventi del tetto sono decorati da un motivo a scacchiera in rosso e nero, dipinto direttamente sul tufo senza alcuna preparazione della super-fi cie; il timpano della testata è decorato da una palmetta stilizzata in rosso, mentre sulla fascia superiore della stessa lastra corre un fregio ad archetti (fi g. 1); il corredo di accompagnamento è costituito da una oinochoe di bronzo, posta ai piedi della defunta, e da un alabastron di vetro blu e bianco, trattenuto nella sua mano destra. L’oinochoe, caratterizzata dal profi lo a sacco, dalla bocca circolare con orlo perlinato, dall’attacco inferiore dell’ansa a palmetta (fi g. 2), rientra nel tipo IX della classifi -cazione di J.D. Beazley, la cui produzione in bronzo è stata da tempo riconosciuta come pertinente alla techne etrusca, e che ha ricevuto di recente un nuovo e appro-fondito inquadramento tipologico:2 in particolare il dettaglio del bocciolo di loto a rilievo all’estremità superiore della palmetta che decora l’attacco inferiore dell’ansa permette di inserire l’oinochoe di Teano in un gruppo defi nito Lotosblütenwerkstatt, comprendente diverse forme di vasellame pertinente al simposio.3 L’alabastron, che
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 110
Fig. 1 - Teano, loc. Torricelle, tomba 50: testata (disegno SBANC, rielaborato dall’Autore).
appartiene a una produzione localizzata sulle sponde del Mediterraneo orientale4 (fi g. 3) è un oggetto di grande pregio tanto in termini di valore intrinseco quanto in qualità di oggetto “esotico”, importato da un paese lontano. L’esame e l’inquadramento cronologico dei due vasi suggeriscono che la chiusura della se-poltura sia avvenuta entro il terzo quarto del V sec. a.C. (450-430), sebbene il loro pregio non escluda la possibilità di un lungo utilizzo nella vita della defunta o della sua famiglia di origine, portando ad abbassare ulteriormente la cronologia an-che di qualche decennio.5 Anche il motivo a scacchiera dipinto sugli spioventi del tetto indirizza verso questo stesso oriz-zonte cronologico. La decorazione dei tetti a doppio spiovente con la scacchiera è tipica delle tombe dipinte etrusche di VI e V sec. a.C., tanto a complemento di una più complessa decorazione fi gu-rata, quanto come motivo decorativo
isolato o unito ad altri motivi decorativi semplici; in entrambi i casi essa veniva tracciata spesso senza alcuna preparazione della superfi cie con intonaco, proprio come è avvenuto per la tomba di Teano. Le numerose tombe tarquiniesi decorate con scene fi gurate che presentano tetti decorati dalla scacchiera si collocano tra la metà del VI sec. e la metà del V sec. a.C.6: tra gli ultimi esempi sono da annoverare la Tomba della Caccia al Cervo, e la Tomba della Nave, datate rispettivamente in-torno alla metà del V sec. e nel V sec. a.C. inoltrato (seconda metà), con le quali si trova una piena corrispondenza nei colori, con una bicromia (nero-rosso su fondo chiaro) che si contrappone alla policromia delle tombe di piena età arcaica (per es. Tombe Bartoccini, dei Leopardi e del Cacciatore). Tra le tombe a semplice deco-razione ornamentale, la scacchiera ricorre a Tarquinia in quattro casi, tutti databili tra il secondo quarto e la seconda metà del V sec. a.C.,7 e nel territorio volsiniese a Grotte di Castro.8 Tradizionalmente la scacchiera dipinta sui soffi tti delle tom-be etrusche è stata interpretata come la rappresentazione realistica di tendoni o stoffe che decoravano la copertura di padiglioni di legno apprestati in occasione delle cerimonie funebri,9 oppure di stuoie di paglia che rivestivano internamente i tetti delle abitazioni etrusche.10 Più recentemente la considerazione del fatto che molte delle tegole della fase arcaica trovate negli abitati in ricognizioni di superfi cie
111La tomba 50 della necropoli in località Torricelle di Teano
conservano tracce di colore rosso o bruno, ha suggerito la possibilità che l’intenzione fosse piuttosto di riprodurre l’aspetto dei soffi tti interni delle abitazioni etrusche, in conformità a quanto suggerisce la presenza stessa del tetto a doppio spiovente.11 La questione relativa all’interpretazione di tale decorazione non può prescindere dalla considerazione che essa ricorre non solo in associazione alla rappresentazione di strutture lignee o padiglioni, che potrebbero essere stati effettivamente rivestiti di stoffe decorate a scacchi (es. Tomba del Cacciatore), ma anche in contesti in cui la decorazione a scacchiera è isolata oppure associata a scene di tutt’altro ambito se-mantico. Mi sembra quindi da considerare la possibilità che la scacchiera vada letta in associazione con l’architettura della camera, cioè con la volontà di riprodurre un determinato tipo di ambiente, talvolta defi nito architettonicamente come una vera e propria camera, talaltra come padiglione, in relazione più o meno stretta con le pitture dipinte sulle pareti.
Più autonoma rispetto alla tradizione decorativa etrusca la decorazione del tim-pano della tomba, con la palmetta stilizzata, e del fregio di coronamento, con gli archetti, che potrebbero essere frutto di una elaborazione locale di motivi tratti da repertori decorativi di altre classi di monumenti, non essendo noti altri esempi del genere nella pittura funeraria etrusca.12
Nel complesso la defunta della tomba 50 di località Torricelle dimostra, nelle caratteristiche allogene della sua sepoltura, di appartenere a un ambito cultura-
Fig. 2 - Teano, loc. Torricelle, tomba 50: olpe di bronzo, con dettaglio dell’attacco inferiore dell’ansa (si noti il fiore di loto tra le due volute superiori) (foto SBANC).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 112
le non locale, da identifi care forse con quello etrusco; non si può escludere che la sua presenza nel territorio sidi-cino alla metà del V sec. a.C. dimostri il rafforzamento dei rapporti culturali e commerciali tra le famiglie etrusche e sidicine attraverso unioni coniugali tra rappresentanti delle diverse gentes: in questo caso l’oinochoe di bronzo etrusca potrebbe essere un oggetto di corredo portato con sé dalla nubenda insieme ai contenitori da toletta di origine esotica, che la identifi cano come esponente di una élite aristocratica.
Questa tomba non rappresenta un fatto isolato nel panorama delle eviden-ze del territorio sidicino in qualità di testimonianza dell’apertura di quest’area agli scambi culturali con l’Etruria. Nelle necropoli del territorio, che occupano in età tardo arcaica e classica aree sparse
intorno al sito della futura città di Teanum, esistono numerosi segnali in tal senso. In particolare l’architettura funeraria assume tra VI e V sec. a.C. caratteri peculiari: le tombe a cassa, che insieme a quelle a fossa sono le più comuni nel comprensorio, presentano una complessa articolazione interna, in cui le pareti sono movimentate da nicchie profonde, dove trova posto il corredo, spesso sostenute da colonnine a fusto liscio, e che terminano in una cornice riccamente modanata. Nella necropoli di Masseria Ilei - loc. Carrano, indagata nel 1997, che contava circa quaranta tombe di età arcaica e tardo arcaica, tutte le sepolture a cassa avevano cornici modanate e alcune, in particolare le tombe 8, 29, 34 e 38, avevano il pilastrino a sostegno della nicchia (fi gg. 4-5).13
La tomba con nicchie, che non fa parte della tradizione locale ed è attestata solo nel territorio di Teano e, in una fase successiva, a Capua, trova confronto con un tipo diffuso ampiamente nell’area veiente14 e falisco-capenate,15 nella Sabina tiberi-na a Poggio Sommavilla,16 a Crustumerium,17 a Vetralla,18 e più a nord a Pitigliano, Sovana e Poggio Buco, dove questo tipo di tomba è defi nito il “più signifi cativo dell’orientalizzante antico”.19 A Poggio Buco, a Pitigliano, a Trevignano Romano, nell’Agro Falisco (Falerii e Narce), e a Blera è attestata la variante con loculi assai ampi, che raggiungono la lunghezza della fossa stessa, nei quali trova posto l’inuma-to insieme al corredo20 (fi g. 6). Dalle tombe a fossa l’uso si estese anche alle tombe a camera della stessa area geografi ca, in particolare di Veio e dell’agro falisco,21 dove è
Fig. 3 - Teano, loc. Torricelle, tomba 50: alaba-stron di pasta vitrea (foto SBANC).
113La tomba 50 della necropoli in località Torricelle di Teano
più verosimile che si siano stabiliti contatti durevoli con esponenti del popolo sidi-cino e campano, come vedremo dopo.
Anche le colonnine a sostegno delle nicchie e le modanature delle cornici del fre-gio superiore delle pareti delle tombe, assenti nella tradizione campana, dimostrano di essere una rielaborazione autonoma da un modello esterno. Il modello a cui gli artigiani locali possono essersi ispirati può probabilmente essere ricondotto a quello stesso ambiente da cui essi traggono ispirazione per il tipo della tomba a fossa con loculi. Nella tradizione architettonica dell’Etruria meridionale interna infatti si svi-luppa nella tarda età orientalizzante e fi no al periodo alto arcaico il tipo della tomba con camere coassiali separate da pilastri,22 la cui attestazione più antica è per ora rap-presentata dalla tomba 1 di Valle Cappellana (San Giuliano - Barbarano Romano), ascrivibile alla fi ne del VII sec. a.C.23: in questa tomba l’ingresso alla seconda camera è segnato da due colonne doriche con fusto scanalato il cui echino, basso e rigonfi o, sostiene un abaco quadrato collegato all’architrave (fi g. 7). Nello stesso territorio, di poco successive sono le tombe del tumulo del Caiolo (fi g. 8) e la tomba M. Gab-brielli (fi g. 9), in cui le colonne sono sostituite da pilastri risparmiati nel tufo, dai caratteristici capitelli a cavetto.24 A Caere, che potrebbe essere stato il centro propul-sore di questo tipo architettonico, esso è attestato però fi nora solo in un momento successivo, nella seconda metà del VI sec. a.C., con la Tomba Policroma, arricchita da una semplice decorazione dipinta.25 Mi sembra verosimile che le tombe a cassa con loculi sostenuti da pilastri siano una riproposizione in termini ridimensionati del modello delle tombe a camera etrusche: mentre in quelle le colonne sottolinea-
Fig. 4 - Teano, loc. Masseria Ilei, di una delle tombe, particolare della nicchia con pilastrino (foto SBANC).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 114
no concretamente il passaggio da un ambiente, che costituisce una sorta di atrio, a un altro che funge da vera e propria camera funebre, in quelle sidicine la nicchia suggerisce soltanto un diverso ambiente, ma è ben chiara l’idea della separazione dei due spazi, sottolineata dalla colonnina, che segna il limite e il passaggio tra i due. È pos-sibile che il tipo della nicchia sostenu-ta da colonnine si sia poi diffuso dalla Campania ad alcune aree dell’Italia meridionale, come sembrano dimo-strare alcune tombe a semicamera di Egnatia, databili alla seconda metà del IV sec. a.C., che presentano lo stesso tipo di nicchia con colonnina dorica.26
Nella stessa direzione vanno ricer-cati i modelli seguiti per la realizzazio-ne dei fregi modanati che occupano nelle tombe di Teano le cornici di coronamento delle pareti laterali, ca-ratterizzate, nei casi più vistosi, da tori alternati a canali concavi e a listelli dritti o dentelli. Anche in questo caso infatti un interessante confronto mi
sembra possa essere ricercato nelle cornici a coronamento dei dadi di base, tipici della tradizione decorativa delle tombe rupestri della zona di San Giuliano,27 Blera, Norchia: dalla monumentalità di quelle realizzazioni, rivolte a una visibilità esterna, si passa in Campania alla dimensione ridotta dello spazio chiuso della tomba a cassa (in particolare si noti come ritorni nelle due serie la sequenza cavetto, toro, fascia) (fi g. 10).
I dati fi nora raccolti suggeriscono che alla base della creazione del tipo della tomba a cassa di tufo con nicchie decorate da colonnine e con cornici modanate, sia stato un modello proveniente dall’Etruria meridionale, debitamente riadattato e rielaborato. Ciascun elemento infatti ricorda, in forma ridotta, elementi decorativi e strutturali tipici della tradizione di quell’area. Quanto in Etruria è infatti mani-festato a carattere monumentale, in Campania viene ridimensionato e adattato alle misure della tomba a cassa, nella quale la decorazione occupa solo lo spazio interno. Queste realizzazioni entrano a far parte della tradizione funeraria locale così pro-fondamente da costituire a loro volta un modello per le comunità limitrofe della
Fig. 5 - Teano, loc. Masseria Ilei, tomba 29, particolare della nicchia con
pilastrino (foto SBANC).
115La tomba 50 della necropoli in località Torricelle di Teano
Campania, specialmente per Capua,28 con la quale soprattutto in età ellenistica i rapporti culturali sono strettissimi. In una fase di accentuata espressione di orgoglio di classe, corrispondente a una eccezionale fi oritura nelle produzioni artigianali a Capua e Teano tra la seconda metà del IV sec. a.C. e la prima metà del III sec. a.C., questo tipo di tomba, nella versione a camera o a cassa, si arricchisce di una ricca decorazione dipinta che ne sottolinea e ne esalta le modanature e i rilievi, proponen-do la completa trasposizione di una struttura architettonica con tanto di colonnato, trabeazione con fregio ionico e tetto a doppio spiovente.
La trama dei rapporti culturali tra l’Etruria interna, l’agro falisco e la Campania settentrionale è stata ricostruita a più livelli in relazione alle diverse manifestazioni culturali, tra cui quelle relative all’ideologia funeraria risultano più ricche di docu-mentazione e di spunti per un confronto. Se non appare opportuno parlare di una facies villanoviana per Capua nel IX sec. a.C.,29 la considerazione di alcune evidenti affi nità con la cultura materiale dell’area falisca e capenate, rappresentate prevalen-temente dalla presenza dell’olla biconica in tombe a fossa di incinerati, conferma l’assiduità delle comunicazioni tra quest’area e la Campania settentrionale, se non una vera e propria migrazione di gruppi in grado di partecipare alla fondazione della città di Capua, attestata dallo storico romano Velleio Patercolo per l’800 a.C. Una riprova in tal senso a livello linguistico è data dall’analisi dell’origine del nome di Capua, legato strettamente a quello di Capena, e dei toponimi Campus Stellatis e ager Falernus, riconducibili rispettivamente a un campus stellatinum presso Capena, e al nome della città di Falerii.30 Le evidenze offerte dalla lingua continuano a te-stimoniare, per tutto il corso dell’età arcaica e fi no al IV sec. a.C., l’esistenza di un continuo fl usso di persone, oltre che di merci, dalla Campania all’Etruria interna e viceversa.31 Il consolidamento dei rapporti, avviati nel corso del villanoviano, avviene
Fig. 6 - Poggio Buco, tombe a fossa con loculi laterali (da Matteucig 1951, 5, fig. 1).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 116
durante l’orientalizzante e perdura in età arcaica prevalentemente attraverso la via fl uviale del Sacco e del Liri, che consentiva di raggiungere, con opportuni tratti pedemontani, il corso del Savone, in collegamento con Cales e Teano, l’alta valle del Volturno e quindi Capua, secondo un percorso poi strutturato nella via Latina.32
Nella scia di queste frequentazioni possiamo collocare anche la diffusione di tipologie funerarie allogene, la loro rielaborazione locale, e in particolare lo spo-stamento di singoli, come sembrerebbe il caso della titolare della tomba 50 della necropoli in loc. Torricelle.
Note* Desidero ringraziare il dott. Sirano per l’invito a partecipare a questo ciclo di conferenze, e la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, in particolare l’allora soprintendente prof. S. De Caro, per l’autorizzazione alla consultazione degli archivi e alla pubblicazione delle fi gg. 2-5 e Tav. 16.1 Attualmente esposta nel Museo Archeologico di Teano. La tomba misurava m 2,40 di lunghezza e m 1,20 di larghezza. Per una scheda di dettaglio si veda anche Benassai 2001, T. 7, 105-106, fi g. 159. 2 Cfr. Weber 1976, 176-180, tipo IVEtr.a; Bini, Caramella, Buccioli 1995, 27-29, nn. 40-42, tavv. XVIII-XIX, CXXIV; Grassi 2000, 63-65, 108-110; Bellelli 2002: in particolare per la nostra oinochoe fi g. 8, tipo 2. 3 Jurgeit 1999, 393-396, nn. 646-650; Bellelli 2002, in particolare p. 39.4 Harden 1981, Mediterranean Group I, Form-table 1,4, fi g. 5, n. 142; Grose 1989, Mediterranean Group I, forma I5-I6; il confronto migliore è con l’alabastron a p. 143, n. 93, forse da Rodi.5 Non sono infrequenti i casi di tesaurizzazione di vasi di bronzo e del loro interramento come oggetto di corre-do a decenni di distanza dalla realizzazione; proprio a Teano esiste un caso del tutto simile: Gabrici 1910, 123, fi g. 94, tomba 72.6 Si tratta delle tombe Bartoccini, delle Bighe, della Caccia al Cervo, del Cacciatore, delle Leonesse, dei Leopar-
Fig. 7 - San Giuliano, tomba 1 di Valle Cappellana (da Steingräber 1981, fig. 202).
117La tomba 50 della necropoli in località Torricelle di Teano
di, del Letto funebre, della Nave, del Triclinio: Naso 1996, 364-365.7 Nelle tombe 810, 4170 e in altre due senza numero: Colonna 1973a, 548; Steingräber 1985, nn. 131, 154, 172; Naso 1996, 365.8 Nella necropoli di Maccarino: Naso 1996, 285, datata genericamente dalla seconda metà del VI sec. all’inizio del V sec. a.C.9 È l’interpretazione che ha riscosso maggiore consenso: la ha formulata per primo Holloway 1965, 341-347; seguito da Stopponi 1968 e Stopponi 1983, 41 segg.; Balty 1985, 165-168.10 Come C. Weber Lehmann in Steingräber 1985, 47-48.11 Naso 1996, 367.12 Richiami, assai generici peraltro, possono essere fatti alle decorazioni secondarie di alcune produzioni di cera-mografi a orientalizzante, come il Gruppo degli Anforoni Squamati, il Gruppo degli Archetti Intrecciati, oppure alle catene di fi ori di loto presenti come fregio su molti gruppi dello stesso periodo.13 Ho potuto consultare la documentazione fotografi ca di questa necropoli, in attesa di una pubblicazione com-pleta, grazie alla cortesia di F. Sirano. 14 A Veio, nella necropoli di Quattro Fontanili, sono presenti tombe a fossa con uno o due loculi scavati a una quota superiore rispetto a quella di deposizione: Ward Perkins, Staccioli 1963, 85-86: lo stesso tipo è stato rinvenuto nelle campagne di scavo successive, di cui si dà conto in NSc 19, 1965, 49 segg.; NSc 21, 1967, 87 segg., fi g. 2; NSc 24, 1970, 178 segg., fi g. 2. Nella necropoli di Monte Michele: Mengarelli 1901, 238-246, tombe 1, 4, 7-8, 15, 22, 24, fi gg. 6, 8. In contrada Macchia della Comunità, tombe con loculi scavati a una quota superiore rispetto al piano di deposizione: Adriani 1930, 46-56. In contrada Casalaccio, tombe dello stesso tipo, ma con loculi della stessa lunghezza della fossa: Vighi 1935, 39 segg., tombe I, VIII-IX, XI, XIX. 15 A Corchiano: Gabrici 1912, 82; Giglioli 1924, 179-228. A Capena, nella necropoli di Civitella S. Paolo, si trovarono delle tombe a fossa con loculo praticato a una certa altezza dal piano di campagna: Paribeni 1905, 301 segg.; Colonna 1973b, 51. 16 Martelli 1977, 13-14.17 Nella prima metà del VII sec. a.C.: Di Gennaro 1988, 114-116.
Fig. 8 - San Giuliano, tumulo del Caiolo, pianta (da Gargana 1929, fig. 51).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 118
18 Nella necropoli di Poggio Montano, una sola tomba aveva il loculo laterale per il corredo: Colini 1914, 356, tomba LI: l’autore nota la scarsità di questo tipo di tomba rispetto all’agro falisco e capenate.19 Colonna 1973b, 65. Per Pitigliano cfr. Boehlau 1900, 174, fi gg. 15-17 (tomba a fossa con loculi nei lati lunghi della stessa lunghezza della tomba).20 Per Pitigliano: Boehlau 1900, 174, fi gg. 15-17 (tomba a fossa con loculi nei lati lunghi della stessa lunghezza della tomba); Maggiani 1999, 55-60. Per Poggio Buco: Matteucig 1951, 5, fi g. 1; Bartoloni 1972, 220; Pellegri-ni 1989, 135-136: il tipo della tomba a fossa con loculi a sezione arcuata ricavati nei lati lunghi, dove trova posto il defunto con il corredo, è collocato nell’orientalizzante medio; da ultimo Maggiani 2003, 77-80, che sostiene per il tipo della tomba a fossa profonda con loculi un’origine a Poggio Buco stessa; vedi anche Pellegrini 2003, 305 segg. Per Trevignano: Caruso 1993. Nell’agro falisco: Baglione 1986, 129, nota 20. Per Civita Castellana: Cozza, Pasqui 1887, 170-176. Per Narce: Cozza 1894, 133-164, fi gg. 53-58. A Blera: tomba la Casetta in Ro-manelli 1986, 19, fi g. 3. Questo tipo di tomba è invece sconosciuta tanto a Vulci quanto a Chiusi.21 Naso 1996, 311, note 477-478.22 Prayon 1975, 66-68. 23 Villa D’Amelio 1963, 6-12, fi gg. 4 e 6; Steingräber 1981, 348, fi g. 202; Romanelli 1986.24 Naso 1996, 315-320 con bibliografi a. 25 Naso 1996, 53, n. 1.2.1.11, tav. VI.2.26 Andreassi, Cocchiaro 1986, 49 seg., fi g. 28; Steingräber 2000, 93 seg., note 648 e 112, nota 757, tav. 49,2. A quanto pare in questa necropoli le nicchie erano ricavate in un secondo momento nel calcare in cui era scavata la tomba, ed erano utilizzate per accantonare i resti delle sepolture precedenti e fare posto alle nuove, quindi con una funzione diversa da quelle campane.27 Gargana 1929, fi g. 33.28 Su questo tema vedi Benassai 2005.
Fig. 9 - San Giuliano, tomba M. Gabbrielli, pianta (da Gargana 1929, fig. 56).
119La tomba 50 della necropoli in località Torricelle di Teano
29 Come sosteneva Johannowsky 1965, 691-692, 698; Johannowsky 1983, 81-82, dove si parla di analogie stret-te con l’Etruria centrale interna e l’area intorno al lago di Bolsena. Di opinione contraria già d’Agostino 1974, 15; Pallottino 1982, 69; e più esplicitamente Colonna 1991, 34-40; Colonna 1992, 71. 30 Colonna 1991, 36-38.31 Vedi le rifl essioni di Maggiani 1998, 227-228, relative alla norma scrittoria corsivizzante che nasce a Chiusi alla fi ne dell’età arcaica da un modello rappresentato dall’alfabeto in uso a Cuma all’inizio del V sec. a.C., deri-vato dalla scrittura dipinta attestata con certezza da alcune epigrafi della necropoli cumana, e viene poi passato a Spina. Un’importante evidenza è data inoltre dall’onomastica, che testimonia più di ogni altra il trasferimento di individui, se non di intere gentes: su questa linea già Heurgon 1942, 112.
Fig. 10 - Confronto tra i profili delle cornici dei dadi di base delle tombe di San Giuliano e i profili delle modanature delle tombe a cassa di Teano (da Gargana 1929, fig. 33, e Gabrici 1910, fig. 9).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 120
32 Vedi Quilici Gigli 1970, ma anche Sommella 1971; a questo proposito Ridgway 1974, 291, parla dell’esi-stenza del percorso e dell’assenza di materiali orientalizzanti fra Preneste e Capua come una mancanza casuale della documentazione, oppure in alternativa come indizio del fatto che quei beni erano fruiti solo da ceti elevati presenti nei centri maggiori. Sul Tevere come via di comunicazione Quilici Gigli 1986; Colonna 1986.
La ceramica fi gurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec. a.C.*
Angela De Filippis
L’identifi cazione delle produzioni di ceramica fi gurata di Teano costituisce an-cora un problema aperto e di non facile defi nizione dal momento che i vasi fi gurati noti, sicuramente provenienti dal centro sidicino, costituiscono un insieme nume-ricamente ridotto e rinvenuto in gran parte in scavi condotti agli inizi del secolo scorso.
Il gruppo più signifi cativo, per quanto riguarda le produzioni a fi gure rosse, è senza dubbio costituito dai vasi provenienti dalla necropoli in loc. Gradavola, posta nell’area a SE dell’attuale centro urbano di Teano. La necropoli, indagata nel 1907, fu pochi anni dopo edita da E. Gabrici;1 lo stesso Gabrici, pur non avendo seguito direttamente le operazioni di scavo, poté comunque utilizzare i giornali redatti du-rante le indagini dal Della Corte, le fotografi e, ed esaminare direttamente i corredi funerari. L’edizione della necropoli, pur se non comprensiva di tutte le sepolture sca-vate, risulta comunque ricca di documentazione grafi ca a fotografi ca e di notazioni puntuali sulle caratteristiche tipologiche delle tombe e dei materiali rinvenuti, tanto da permettere di ricostruire l’aspetto generale della necropoli offrendo un quadro ricco di spunti e suggestioni.
Più complessa è la vicenda che riguarda la sorte dei materiali recuperati: alla fi ne dello scavo, sulla base di criteri stabiliti da una commissione ministeriale, questi fu-rono ripartiti fra il Ministero stesso e i proprietari, dando origine ad una dispersione di gran parte dei corredi, molti dei quali ancora oggi non reperibili.2
Fra i corredi rimasti al Museo di Napoli fi gura quello della tomba 62, uno dei contesti più interessanti della necropoli, soprattutto in relazione all’argomento af-frontato in questo contributo, poiché contenente un gruppo di 6 vasi a fi gure rosse attribuito al Gruppo Teano-Tübingen.3
Il corredo era composto originariamente da 32 oggetti;4 di questi, durante il recente lavoro di riordino, è stato possibile recuperarne solo 13. Dei 6 vasi a fi gure rosse, sono stati ritrovati solo il lebete e i due kernoi descritti dal Gabrici.5 La diffi col-tà di reperimento dell’intero contesto, i cui elementi risultano, in parte, in collezioni di musei europei, rende più diffi cile l’esposizione delle problematiche relative alla presenza di ceramica fi gurata e alla fi sionomia dell’intero corredo.
Il lebete,6 del tipo con versatoio, era in origine completato da un coperchio sor-montato da una pisside tipo kemai.7 Sul lato principale è una scena raffi gurante due donne (Tav. 17), recanti bende e specchi, sedute su sgabelli quadrangolari. Le fi gu-
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 122
re sono rese con una silouhette risparmiata sul fondo acromo, con una tecnica che suggerisce l’originaria presenza di una ricca policromia. Di questa restano tracce di bianco e rosso, ben evidenti anche nel motivo decorativo presente sull’orlo del ver-satoio, dove compare una corolla con petali sovraddipinti in bianco. Sul lato secon-dario, una grande testa femminile di profi lo (Tav. 18), quasi sovraddimensionata rispetto al campo pittorico, presenta le stesse caratteristiche tecniche e stilistiche.
Tra i vasi reperiti fi gurano anche due kernoi,8 stilisticamente assimilati dal Tren-dall al Gruppo Teano-Tübingen.9 La classe è stata di recente oggetto di uno studio,10 che ha dedicato particolare attenzione ai kernoi di provenienza teanese e alle proble-matiche relative alla tradizione letteraria e all’origine della forma vascolare.
Gli esemplari della tomba 62, che presentano le caratteristiche proprie dell’ela-borazione di questa forma in ambiente sidicino,11 risultano del tutto simili tra loro: sull’anello di sostegno sono rappresentate due teste femminili di profi lo (fi gg.1-2), alternate a palmette con volute molto stilizzate, la cui resa risulta fortemente as-similabile a quella della testa presente sul lebete. Il vaso è completato da quattro pissidi alternate a testine femminili, tutte a vernice nera, che nel complesso offrono l’immagine di un prodotto artigianale di buona qualità, espressione della vivacità artistica dei ceramografi teanesi della fi ne del IV secolo a.C.
Tra gli oggetti non reperiti, sfortunatamente, fi gurano quei vasi che, per le carat-teristiche tipologiche e stilistiche, rappresentano un elemento importante nel qua-dro della ricostruzione delle fi sionomia delle produzioni a fi gure rosse di quest’area
Fig. 1 - Teano, Fondo Gradavola: tomba 62, kernos a figure rosse (Inv. Gen. 132447).
Fig. 2 - Teano, Fondo Gradavola: tomba 62, kernos a figure rosse (Inv. Gen. 132446).
123La ceramica figurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec.a.C.
della Campania, utile all’identifi cazione di una possibile rete di relazioni culturali e artistiche con produzioni di altri ambiti culturali.
Una prima notazione va fatta a proposito della pisside skyphoide (fi g. 3), già pubblicata dal Gabrici,12 le cui caratteristiche morfologiche, tecniche e pittoriche, valgono un approfondimento specifi co. Sul lato principale del vaso compare una scena con tre fi gure femminili, una seduta le altre stanti, davanti ad una stele o un pilastro con volute ioniche. Sul lato opposto13 è rappresentata una fi gura femminile seduta, con una cista nella mano destra. Una palmetta riempie il campo sotto l’ansa. È lo stesso Gabrici a sottolineare l’abbondante uso di colori sovraddipinti, bianco e rosso, applicati dopo la cottura e utilizzati per campire le fi gure e defi nire dettagli ed elementi delle decorazione vegetale.
Alla pisside skyphoide è assimilabile, per la tecnica e la resa stilistica, una lekane 14 con vasca verniciata di nero e decorata con motivo a meandro sull’orlo (fi g. 4). Il coperchio presenta una ricca decorazione fi tomorfa, con spirali, foglie e fi ori, nella quale sono inserite due fi gure femminili: una seduta, con una phiale nella mano sinistra; l’altra stante, alata, recante uno specchio e che sembra fuoriuscire da uno degli elementi fl oreali. Lo stesso coperchio ha l’orlo decorato da un motivo a kyma lesbio campito di bianco, con contorno in nero. La documentazione fotografi ca disponibile suggerisce anche in questo caso l’uso di una notevole policromia, nella defi nizione delle fi gure e della complessa decorazione vegetale, che riempie comple-tamente lo spazio pittorico.
Ai due pezzi descritti erano associate tre hydriai, inserite dal Gabrici15 all’interno dello stesso contesto, due delle quali descritte in maniera piuttosto sintetica sotto la voce “due hydriai a fi gure rosse”. Il riferimento generico utilizzato dell’autore per due dei pezzi pubblicati, ha ingenerato negli studi successivi alcune inesattezze sul numero e sulla descrizione di questi vasi, tanto da far ritenere che due hydriai
Fig. 3 - Teano, Fondo Gradavola: tomba 62, pisside-skyphos a figure rosse (Inv. Gen. 132443).
Fig. 4 - Teano, Fondo Gradavola: tomba 62, lekane a figure rosse (Inv. Gen. 132442).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 124
conservate a Tübingen16 e del tutto corrispondenti alla descrizione dei vasi di loc. Gradavola, non fossero quelle della tomba 62, ma solo degli esemplari molto simili. I successivi studi del Trendall hanno invece chiarito che gli esemplari in questione sono effettivamente quelli della necropoli in loc. Gradavola.17
I due vasi di Tübingen presentano scene fi gurate analoghe (fi gg. 5-6), rappresen-tanti due fi gure femminili stanti, con offerte, presso un altare; diversa la raffi gura-zione della terza hydria sulla quale compare ancora una volta una fi gura femminile alata, quasi di prospetto, affi ancata da due donne recanti vari oggetti. Il dato interes-sante offerto da questo gruppo di vasi è non solo la forte affi nità stilistica, evidente nella replica di uno schema iconografi co e nella resa della fi gure e della decorazione secondaria che invade gli spazi vuoti, ma anche la presenza, sulla terza hydria de-scritta (fi g. 7), di un motivo decorativo, sulla spalla, a kyma lesbio, del tutto inusuale nelle contemporanee produzioni campane a fi gure rosse e assimilabile a quello visi-bile sul coperchio della lekane dello stesso corredo.
Del corredo della tomba 62 fa parte anche un cratere a vernice nera.18 La forma, estremamente raffi nata, è resa più importante dalla presenza di un sostegno, e si collega a produzioni attiche e peloponnesiache della metà del IV secolo a.C., richia-mando, in contesti più vicini, un gruppo di vasi provenienti dalla necropoli di S. Prisco,19 e dalla necropoli di Cuma.20
Il resto dei 32 oggetti relativi alla tomba 62 è costituito da ceramica a vernice nera, da orefi cerie, da uno specchio di bronzo, alcune stecche di avorio e da un
Fig. 5 - Teano, Fondo Gradavola: tomba 62, hydria a figure rosse (Tübingen 1353).
Fig. 6 - Teano, Fondo Gradavola: tomba 62, hydria a figure rosse (Tübingen 1352).
125La ceramica figurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec.a.C.
probabile piccolo strumento da toilette.
Nella ceramica a vernice nera risulta evidente la netta preponde-ranza di forme e tipi propri delle produzioni teanesi attestate tra la fi ne del IV e gli inizi del III secolo a.C. Del tutto caratteristico è l’askos confi gurato ad uccello,21 o i due piattelli su alto piede.22 A questi si associano due skyphoi,23 un piatto24 ed una coppa25 tutti con la caratte-ristica decorazione graffi ta e dipin-ta a motivi vegetali, con puntini e ovuli, e un piatto da pesce26 a sola vernice nera. Poco si può dire delle orefi cerie, peraltro accuratamente descritte dal Gabrici, e che dai dati desumibili dalla pubblicazione po-trebbero essere molto simili a quelle della tomba 79. Si parla infatti di una collana a maglia cilindrica con terminali a protomi di leone, di due fi bule d’oro ad arco ingrossato, e di due anelli d’oro, uno dei quali con scarabeo di corniola.
Il corredo risulta quindi nel suo insieme uno dei più ricchi della necropoli e, in un certo senso, uno dei più caratterizzati per la presenza del gruppo di vasi fi gurati, che nel complesso rappresentano circa l’80% di tutta la ceramica a fi gure rosse pre-sente nella necropoli.
Un dato non trascurabile, sicuramente, è quello che tutti i vasi attribuiti al gruppo Teano-Tübingen, e provenienti da Teano, siano stati rinvenuti in un unico contesto funerario.
Il gruppo già individuato dal Beazley,27 è stato riesaminato dal Trendall28 che, analogamente a quanto detto precedentemente, lo inserisce nel quadro delle ultime produzioni di ceramica a fi gure rosse connesse alle offi cine cumane. In particolare si sottolinea l’affi nità della decorazione secondaria a palmette, con i prodotti più tardi dell’offi cina cumana CA. Del tutto caratterizzante è anche la tecnica pittorica, con l’uso di bianco sovraddipinto utilizzato in maniera del tutto originale sia nella resa dei panneggi, ridotti in alcuni casi ad una pura campitura di colore sia nella deco-razione vegetale, che nel caso della lekane, risulta addirittura preponderante rispetto a quella fi gurata.29 Il Trendall sottolinea inoltre il tratto espressionistico nella defi ni-
Fig. 7 - Teano, Fondo Gradavola: tomba 62, hydria a figure rosse.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 126
zione delle teste umane, che risultano piuttosto piccole rispetto al corpo, carattere questo che richiama analogie con produzione siceliote contemporanee.
Alle notazioni del Trendall è forse possibile aggiungere alcune considerazioni. La prima riguarda la presenza della pisside-skyphos, la cui forma non rientra nel repertorio morfologico proprio delle offi cine ceramiche campane, quanto piuttosto di quelle siceliote e liparesi,30 dove in alcune momenti questa risulta una delle forme maggiormente adottate dai ceramografi . Tuttavia non è solo l’aspetto morfologico a suggerire degli spunti di rifl essione, quanto piuttosto anche la scelta del soggetto iconografi co e la tecnica pittorica utilizzati nella pisside skyphoide di loc. Gradavola. La composizione della scena con le fi gure femminili richiama temi del repertorio iconografi co dell’offi cina del Pittore di Lipari,31 dove sono molto frequenti scene nuziali, con la sposa seduta che si prepara alle nozze assistita da amiche e ancelle. A tecniche pittoriche presenti nello stesso contesto produttivo, sembra riportare anche la resa dei panneggi e degli abiti, defi niti da un colore uniforme e coprente che crea un effetto di forte policromia.
Ad ambito culturale liparese può essere avvicinata anche la lekane della tomba 62, che presenta sorprendenti affi nità, pur se con una certa semplifi cazione, con un’altra lekane (Tav. 19), proveniente dalla necropoli di Contrada Diana, attribuita anche questa al Pittore di Lipari.32 Appare piuttosto evidente la stretta analogia della sintassi decorativa nella quale gli elementi vegetali, che ricoprono la superfi cie del coperchio, defi niti da una ricca policromia, avvolgono le fi gure femminili, una delle quali alata.
Infl uenze liparesi si possono cogliere anche nelle hydriai presentate, ed in par-ticolare in quella non più reperibile, ma pubblicata dal Gabrici (fi g. 7).33 La raffi -gurazione incentrata sulla grande fi gura femminile alata, richiama le innumerevoli immaginipresenti sui vasi del pittore di Lipari34 e della sua cerchia ed il motivo a kyma lesbio visibile sulla spalla trova chiari confronti nella produzione policroma delle ultime fasi delle offi cine di Lipari.35
C’è da sottolineare inoltre, in tutta la produzione del gruppo Teano-Tübingen, il dato tecnico costituito dal largo uso della policromia, realizzata con l’applicazione del colore dopo la cottura del vaso. Questo aspetto costituisce senza dubbio un dato di una certa importanza, se si considera che l’area di diffusione di questo tipo di produzioni fi gurate, è localizzata essenzialmente in Sicilia e Campania.36
L’acquisizione di elementi nuovi da ambiti culturali diversi non riguarda, tut-tavia, solo l’aspetto tecnico ma, con tutta probabilità, anche l’assimilazione di un repertorio iconografi co portatore di valori e signifi cati complessi.
Gli studi condotti sulle necropoli liparesi37 hanno evidenziato il carattere miste-rico ed escatologico dell’iconografi a connessa alla ceramica a decorazione policroma dell’offi cina del Pittore di Lipari, legata ad esigenze rituali e simboliche che condi-zionano fortemente le scelta dei soggetti e delle forme vascolari. Il repertorio icono-grafi co dei vasi liparesi traccia le tappe della vicenda ultraterrena di iniziati legati a
127La ceramica figurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec.a.C.
credenze escatologiche di tipo dionisiaco. Le raffi gurazioni di giovani donne, intente nella toilette, assistite da amiche ed ancelle, presso altari, con Nikai che recano doni, nei preparativi delle nozze, rappresentano l’unione mistica, simbolica, ultraterrena, nella quale, accanto alle fi gure femminili, non compare mai lo sposo. La fi gura fem-minile quindi assume un valore assoluto di rappresentazione del defunto nell’aldilà, senza distinzione di sesso, tramite con il mondo divino, al quale si collega attraverso l’immagine delle nozze mistiche.38
Questa esistenza ultraterrena si svolge in spazi fi oriti, ricchi di vegetazione; que-sti spazi sembrano essere rappresentati su una serie di lekanai liparesi nelle quali, la raffi gurazione sul coperchio, rappresenta una fi gura femminile che emerge con una Nike, da elementi fi tomorfi .39
Anche le forme vascolari adottate richiamano il mondo femminile e il matri-monio: la lekane, il lebete, la pisside-skyphos erano infatti vasi utilizzati come doni nuziali.
Le considerazioni fatte inducono ad una serie di rifl essioni sui possibili rapporti fra Lipari e la Sicilia con il territorio di Teano e più in generale con la Campania set-tentrionale, richiamando tracce ed elementi relativi a contatti e relazioni fra questi diversi ambiti culturali che, alla luce dei dati esposti, si arricchiscono sempre più di signifi cato.
Sono stati riconosciuti, con una certa chiarezza, apporti sicelioti e liparesi già in ambiente cumano tra la fi ne del IV e gli inizi del III secolo a.C. Indicativa a que-sto proposito è la presenza, nella necropoli cumana, di un corredo contenente vasi attribuiti all’offi cina del Pittore di Cefalù,40 ceramografo attivo a Lipari nell’ultimo quarto del IV secolo a.C. A questo si associa un altro corredo, più tardo di circa un venticinquennio, caratterizzato dalla presenza di una grande pisside-skyphos, a deco-razione policroma,41 che costituisce un elemento del tutto singolare in questo ambito culturale, sia per la tecnica a tempera, sia per l’adozione di un modello iconografi co largamente in uso nella bottega del pittore di Lipari.42
Si tratta di forme di contatto solo apparentemente occasionali ed estempora-nee, che alla luce di una ricostruzione complessiva e di una correlazione di tutti i dati noti offrono spunti per considerazioni più generali sul più ampio quadro delle dinamiche che caratterizzano il panorama storico ed economico della Campania settentrionale sul fi nire del IV secolo a.C., dopo l’avanzata delle popolazioni sanni-tiche, e sul ruolo svolto dai grandi centri costieri, Cuma e Neapolis in particolare, nel controllo dei fl ussi commerciali sulla costa e verso l’entroterra.
Un punto cruciale è senza dubbio costituito dalla situazione di Neapolis che vive una condizione di isolamento, rispetto al suo retroterra ed ai fl ussi commerciali prin-cipali. Il problema è stato ampiamente dibattuto da E. Lepore in alcuni saggi che restano a tutt’oggi fondamentali per la comprensione del contesto storico e politico di quell’epoca.43 L’isolamento di Neapolis,44 tuttavia, non sembra ripercuotersi sul ter-ritorio circostante,45 all’interno del quale continuano ad affl uire prodotti dall’Attica
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 128
e dal Mediterraneo, segno questo di nuove dinamiche commerciali, di nuovi canali di affl usso delle merci e di nuovi equilibri politici e territoriali gestiti dalle comunità sannitiche che controllano vari centri della Campania interna e costiera.
In questo nuovo panorama potrebbe inserirsi Cuma,46 quale tramite ed interme-diario degli scambi fra i centri della Campania interna settentrionale e il Tirreno meridionale. In questa prospettiva vanno forse riconsiderati alcuni elementi che, presenti nella necropoli cumana, si caricano di ulteriore signifi cato se posti in rela-zione con elementi analoghi presenti nella necropoli in loc. Gradavola di Teano.
Un dato interessante è costituito senza dubbio dall’attestazione di statuette del tipo dell’Artemide Sicula, largamente diffuso in Sicilia nell’ultimo quarto del IV secolo a.C.,47 soprattutto in area siracusana e presente con un esemplare a Cuma48 e tre a Teano in due corredi.49
A questo proposito, di particolare interesse risulta uno dei due corredi, quello della tomba 76, sia per la ricchezza delle orefi cerie descritte, sia per l’associazione, fra gli altri, delle due statuette di Artemide Sicula, con due bustini di Demetra, nume-rose statuette femminili e un kernos. Potrebbe, inoltre, non essere casuale l’associa-
Fig. 8 - Teano. Frammenti di kylikes tipo “Aretusaschalen” da Fondo Ruozzo e loc. Loreto.
129La ceramica figurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec.a.C.
zione di questi elementi di coroplastica con il kernos, se si prende in considerazione l’analisi fatta di recente sul probabile signifi cato rituale di questa forma vascolare,50 forse connessa a rituali di offerta a Demetra e Kore e comunque appartenente alla sfera femminile e nuziale.
Una ulteriore attestazione dei contatti con ambienti culturali sicelioti è costitui-ta anche dalla presenza di numerosi esemplari di kylikes del tipo “Aretusaschale”,51 provenienti sia dalla necropoli in loc. Gradavola, che dagli scarichi dei santuari in loc. Loreto e in loc. Fondo Ruozzo.52 Si tratta essenzialmente di frammenti (fi g. 8), alcuni dei quali ottenuti con matrice piuttosto fresca, tutti con lo stesso bollo raf-fi gurante la testa della ninfa di profi lo attorniata dai delfi ni. In questo panorama si inseriscono inoltre numerosi bolli, su coppe a vernice nera, ancora provenienti dal santuario di loc. Loreto, con la triskeles (fi g. 9), chiaro riferimento al simbolo icono-grafi co della Sicilia.53 Tutti i materiali descritti sembrano verosimilmente ascrivibili a produzioni locali, considerata la tipologia delle argille e delle vernici.
Il quadro delineato si arricchisce di un ulteriore dato se si considera la presenza a Teano di iscrizioni graffi te su vasi a vernice nera dopo la cottura, relative ai nomi di alcuni artigiani attivi nelle offi cine teanesi sul fi nire del IV secolo a.C. Molti di questi vasi provengono dalla necropoli in loc. Gradavola, e sono state in parte editi dal Gabrici.54
Esemplari, per quanto attiene alla presenza di offi cine riferibili ad artigiani di ori-gine osca, sono le iscrizioni che menzionano la famiglia dei Berii,55 che personalizza
Fig. 9 - Teano, frammento con bollo con “triskeles” da loc. Loreto.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 130
la produzione di vasellame a vernice nera stabilendo uno stretto legame con la città di Teano.
A queste si aggiungono iscrizioni che più da vicino interessano le problematiche relative a questo contributo, poiché menzionano artigiani provenienti da altre aree geografi che.
La presenza di antroponimi di origine siceliota è attestata da un piccolo gruppo di graffi ti che menzionano i ceramisti Athanas e Platonos. Il primo si ritrova in due iscrizioni, una su un piatto della tomba 7956 (fi g. 10), l’altra su un oggetto analogo dalla tomba 29.57 Gabrici ha riconosciuto in Athanas un antroponimo di origine si-celiota sulla base di una notizia di Diodoro Siculo. Non ci sono dubbi inoltre, sulla provenienza di un altro artigiano il cui nome compare in un’iscrizione graffi ta su una coppa del corredo della tomba 83, al Museo Archeologico Regionale di Paler-mo, sulla quale si legge ΠΛΑΤΟΝΟΣ ΣΙΚΕΛΙΟΤΑΣ ΑΠΟΛΟΝΙΕΥΣ ΕΠΟΙΕΣΕ.58
Di particolare interesse risultano inoltre le iscrizioni relative al ceramista Plator, il cui nome è attestato in due iscrizioni, la prima in lingua greca, su una coppa dalla tomba 29, oggi agli Staatliche Museen di Berlino,59 sulla quale è graffi ta la formu-la, ΠΛΑΤΟΡ ΕΠΟΙΣΕ, nota al Gabrici; la seconda su una coppa dalla tomba 5860 (fi g. 11), che con la formula ΠΛΑΤΟΡ ΟΥΠΣΕ costituisce, con tutta probabilità, un tentativo di traslitterazione in alfabeto greco di una formula in lingua osca, corri-spondente in defi nitiva a quella sulla coppa della tomba 29. L’antroponimo Plator è noto in area messapica, ma non è da escludere che possa trattarsi anche in questo caso di un nome di origine siceliota.61
Fig. 10 - Teano, Fondo Gradavola: tomba 79, piatto a vernice nera (Inv. Gen. 131688).
131La ceramica figurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec.a.C.
I dati esposti vanno inquadrati sicuramente, come già detto, nel contesto più generale dei rapporti sviluppatisi sul fi nire del IV secolo a.C. fra la fascia costie-ra a nord di Neapolis, la Campania settentrionale e il basso Tirreno. Spiegare la presenza di vasi importati da offi cine liparesi e di produzioni strettamente affi ni a quell’ambito culturale, in centri come Cuma e Teano, solo come il semplice sposta-mento di maestranze da un luogo all’altro, signifi cherebbe banalizzare il problema, appiattendo il quadro che comincia a delinearsi per questa area della Campania. In questo panorama Cuma svolge, senza dubbio, un ruolo primario, costituendo una via nuova ed alternativa ai consolidati traffi ci fra Neapolis e la Sicilia, forse anche per il rapporto privilegiato che stabilisce con le comunità sannitiche dell’entroterra. La creazione di nuove vie di penetrazione di fl ussi commerciali, porta tuttavia non solo alla diffusione di prodotti ceramici e coroplastici, ma anche alla trasmissione e all’as-similazione di modelli culturali e religiosi, se si considera la forte valenza escatologia e misterica presente nelle produzioni liparesi che trovano strette analogie nei vasi del Gruppo Teano-Tübingen.
In questo quadro, Teano sembra costituire un recettore importante di apporti che giungono da diverse aree geografi che ed un catalizzatore di temi, tecniche e modelli culturali eterogenei.
I dati esaminati portano a riconsiderare, in una ottica diversa, anche un altro gruppo di vasi fi gurati, vale a dire quelli attribuiti al Pittore di Vitulazio, posteriori di circa un ventennio a quelli del Gruppo Teano-Tübingen, e collocabili agli inizi del III secolo a.C.
Fig. 11 - Teano, Fondo Gradavola: tomba 58, piatto a vernice nera (Inv. Gen. 131642).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 132
L’esame dei contesti relativi agli scarichi votivi dei grandi santuari di Teanum, ha permesso di riconoscere un notevole numero di frammenti attribuibili alla mano del Pittore di Vitulazio, così denominato a seguito del ritrovamento, a Vitulazio,62 di una tomba contenente uno dei crateri attribuito alla sua mano. Questo gruppo di vasi è stato prima identifi cato dal Beazley 63 e poi riesaminato dal Trendall, che ne inserisce la produzione fra le realizzazioni più tarde della ceramica fi gurata connessa alle offi cine cumane.64
I tratti distintivi di questa produzione sono chiari e ben defi niti; essa si caratteriz-za per la presenza su tutti i vasi di una testa, generalmente femminile, resa a semplice contorno nero, su un fondo di argilla risparmiata molto chiara (fi gg. 12-13). La forma vascolare più ricorrente è sicuramente il cratere a campana, di piccole dimen-sioni,65 sul quale le teste, dipinte sui due lati, sono inquadrate da motivi vegetali. Tutto il complesso della raffi gurazione risulta estremamente stilizzato, con una forte standardizzazione nella disposizione degli elementi, delle proporzioni e della deco-razione secondaria, costituita da una grande palmetta sotto le anse, resa con semplici tratti di colore nero e un motivo a linguette verticali sotto l’orlo. Trendall associa questa produzione alle offi cine cumane della fase Cuma C, ma sottolinea anche la sorprendente e innegabile analogia stilistica con i vasi di stile “alto-adriatico”.
Dopo una prima ipotesi di individuazione del centro di produzione di questi vasi a Cales, sembra del tutto plausibile ritenere che questi fossero invece prodotti in una offi cina teanese, considerate le caratteristiche dell’argilla,66 la diffusione estre-mamente limitata di questi manufatti al di fuori di un ristretto ambito territoriale connesso alla città e l’alta incidenza che essi hanno non solo nei santuari, ma anche nelle necropoli.
Fig. 12 - Teano, loc. Campofaio: tomba 10, cratere a campana del Pittore di Vitulazio.
133La ceramica figurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec.a.C.
Moltissimi sono i frammenti provenienti dagli scarichi dei grandi santuari della città, in particolare quello di loc. Loreto, nel quale la presenza di questa ceramica era già stata segnalata in una prima edizione dello scavo.67
A proposito dell’incidenza di questa classe nelle necropoli, c’è da chiedersi, se, a seguito di una attenta lettura dell’edizione del Gabrici dei corredi sidicini, non si possa ritenere che quei vasi, crateri a campana e lekanai, descritti come decorati con «teste umane sulle facce opposte del ventre, e sotto le anse due palmette a solo contorno nero, di stile decadente», o anche «lekane a coperchio imbiancato, su cui sono dipinte a contorno nero due palmette e due teste muliebri» non siano da riconoscersi come quelli realizzati con fi gure a contorno nero e ascrivibili alla mano del Pittore di Vitulazio. Le tombe della necropoli in loc. Gradavola, che recano queste notazioni sono cir-ca 1268 e sono pubblicate purtroppo senza apparato fotografi co. Documentabile è invece la presenza di vasi attribuibili al Pittore di Vitulazio nella necropoli di loc. Campofaio (fi g. 14), dove il piccolo cratere a campana, in argilla chiara, spesso con evidenti difetti di cottura, è un elemento quasi costante.69
Si è accennato al richiamo fatto dal Trendall sulla somiglianza dei vasi del Pittore di Vitulazio con quelli di stile “alto-adriatico”, nella elaborazione con teste umane di profi lo. Questa classe, tipica del Piceno e dei centri di Adria e Spina di recente riconsiderata, viene indicata nel suo insieme come strettamente funzionale ad un uso funerario, e in parte correlata a ideologie misteriche e dionisiache.70
Anche in ambito alto-adriatico nel repertorio vascolare documentato, il cratere a campana risulta comunque predominate rispetto alle altre forme, offrendo un ulteriore elemento di confronto con la produzione sidicina. C’è comunque da
Fig. 13 - Teano, loc. Campofaio: tomba 19, cratere a campana del Pittore di Vitulazio.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 134
considerare il carattere estremamente lacunoso dei dati relativi alle realizzazioni del Pittore di Vitulazio, i cui prodotti sono in generale privi di contesto di provenienza e in gran parte andati dispersi.71
La sorprendente ripetitività, nei vasi alto-adriatici, delle raffi gurazioni di teste femminili inquadrate da elementi vegetali, ha ingenerato numerosi proposte di in-terpretazione.72 La notevole genericità del tipo iconografi co rende plausibili proposte diverse; motivi iconografi ci analoghi sono interpretati frequentemente, soprattutto in ambito italiota, come raffi gurazione escatologica della rinascita del defunto fede-le a Dioniso ma, nel caso dei vasi in questione, non si esclude che si possa pensare anche a pratiche connesse con il mondo e la fertilità femminile. L’uso di questi vasi nei corredi, tuttavia, non sembra determinato solo dall’adesione a particolari riti misterici ma anche, in alcuni casi, all’intento di defi nire il ruolo sociale ricoperto in vita dal defunto, in associazione ad altri elementi del corredo, il cui signifi cato si completa proprio nella reciproca correlazione. Questi vasi costituiscono inoltre, in ambito alto-adriatico, l’unica classe di ceramica fi gurata presente nelle fasi più tarde delle necropoli, mancando quasi del tutto importazioni attiche ed etrusche.73
Una rifl essione analoga può essere fatta per i contesti sidicini dove, la cerami-ca fi gurata, peraltro piuttosto scarsa anche nei periodi precendenti, in questa fase cronologica è rappresentata in maniera quasi esclusiva dai prodotti del Pittore di Vitulazio. Questi sembrano essere il risultato di una produzione di massa destinata ad una committenza non raffi nata, e la cui diffusione rimane limitata, come già det-to, alla Campania settentrionale74 e costituiscono la realizzazione più vicina, fi nora individuata, ai vasi con teste femminili delle serie più tipicamente alto-adriatiche. Il dato che si ricava dai corredi della necropoli di loc. Campofaio sembra confermare la standardizzazione della produzione e l’associazione di questi vasi a corredi che appaiono piuttosto poveri ed estremamente ripetitivi nella composizione. Poco o
Fig. 14 - Teano, loc. Campofaio: tomba 19, corredo.
135La ceramica figurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec.a.C.
nulla si può dire dei contesti della necropoli di loc. Gradavola, la cui edizione, nello specifi co, appare lacunosa e priva di documentazione.
L’esposizione dei dati tuttavia lascia aperta la questione circa la fi oritura nel centro sidicino di una produzione che denota strettissime affi nità stilistiche e tipo-logiche con una classe ceramica presente in un ambito geografi co e culturale, quello alto-adriatico, del tutto diverso e lontano.
Al di là delle considerazioni puntuali sugli esiti delle due diverse produzioni, risulta evidente che, sul fi nire del IV secolo a.C., il centro di Teanum costituisce il punto di arrivo di maestranze, modelli culturali e tecniche provenienti da aree geografi che diverse e lontane, che vengono assimilate dalle offi cine locali e mediate attraverso il forte sostrato autoctono.
Si è già detto dei rapporti con la Sicilia; è possibile aggiungere, a questo punto, sulla scorta di un recente studio, una serie di suggestioni offerte dal quadro storico prodottosi a seguito della politica di espansione di Dionisio I verso l’Adriatico, nel primo quarto del IV secolo a.C. con la rete dei traffi ci provenienti dalla Sicilia ed in particolare da Siracusa. È stata da tempo riconosciuta una componente campaniz-zante nelle prime produzioni di ceramica alto-adriatica del Piceno,75 carattere questo che potrebbe essere stato determinato sia da un affl usso di prodotti connesso al mo-vimento di mercenari, sia dall’immigrazione vera e propria di artigiani campani in questa area geografi ca,76 attraverso direttrici di penetrazione che si muovono lungo la dorsale appenninica.77 In questa rete di contatti che si forma tra la fi ne del V e gli inizi del IV secolo a.C. Teanum potrebbe essere stata inserita assumendo un ruolo di catalizzatore e mediatore.
Il quadro delineato, per quanto sommario, permette di riconoscere nel centro sidicino, ad una certo punto del suo sviluppo, un luogo privilegiato nella ricezione e nella diffusione di prodotti e modelli culturali e religiosi diversi. Risulta evidente la grande vitalità che caratterizza Teanum alla fi ne del IV secolo, dopo il 342, con il processo di aggregazione sinecistica che portò alla formazione del vero e proprio centro urbano. Il dato è stato sottolineato di recente,78 esaminando in particolare la produttività estremamente competitiva delle botteghe di coroplastica, rispetto al resto del territorio della Campania settentrionale. Tale competitività non doveva limitarsi alle sole produzioni coroplastiche, ma anche alle offi cine di ceramica a vernice nera, che riescono ad elaborare e proporre un repertorio formale e decora-tivo del tutto originale, nuovo e caratterizzato. Le diverse offi cine, coroplastiche e ceramiche, sembrano in rapporto tra loro se, come è stato sottolineato, ad esempio, le testine fi ttili che decorano i kernoi teanesi sembrano derivare da tipi coroplastici attestati nei santuari.
Per concludere, resta da fare una rifl essione riprendendo una considerazione del Gabrici. L’autore sottolinea il carattere sidicino della necropoli in loc. Gradavola, ma nello stesso tempo riconosce con chiarezza gli apporti esterni, in particolare da aree di cultura ellenica, del tutto assimilati e rielaborati. Il quadro offerto dai dati
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 136
disponibili permette di tracciare uno schema nel quale si colgono tracce e suggestio-ni di forme di contatto che, lungi dall’essere occasionali ed estemporanee, possono costituire la chiave di lettura delle espressioni culturali del tutto originali del centro sidicino. Si tratta di elaborazioni artigianali, soprattutto ceramiche e coroplastiche, che risultano del tutto specifi che e che, pur rifl ettendo gli apporti esterni, denotano la forte capacità delle maestranze locali di fi ltrare e rielaborare gli elementi esterni. Diffi cile dire, allo stato attuale della ricerca, se questi elementi esterni siano il pro-dotto di semplici fl ussi commerciali, o piuttosto, riprendendo visioni meccaniche di fenomeni di contaminazione, dell’apporto diretto di maestranze giunte nel cen-tro sidicino. Al di là delle possibili risposte, sembra tuttavia di poter delineare un quadro della comunità urbana di Teanum, sulla fi ne del IV secolo a.C., come di un centro estremamente vitale, posto su vie di circolazione e scambi, che coinvolgono aree geografi che anche molto distanti, dalle quali la comunità campana acquisisce di continuo contributi culturali e artigianali. Potrebbe non sembra casuale la coinci-denza di questa condizione con la formazione e la strutturazione del centro urbano, dopo il 342 a.C., quando in concomitanza con gli eventi legati alla prima guerra sannitica, la comunità vive un periodo di profondi mutamenti, determinanti nella confi gurazione della nuova fi sionomia culturale e politica del centro sidicino.
Sicuramente i dati da scavi e ricerche future serviranno a chiarire meglio gli aspetti discussi, contribuendo a delineare un quadro più completo della vita di que-sto importante centro, sul fi nire del IV secolo a.C., in una fase cronologica cruciale, in cui ormai, l’avanzata romana verso l’Italia meridionale ha avuto inizio in maniera irreversibile.
Note* Ringrazio il Prof. Stefano De Caro, Direttore Regionale per i Beni Archeologici e Paesaggistici della Campa-nia, per la cortesia manifestata nell’invitarmi a partecipare al ciclo di conferenze cui si deve questo contributo. Un ringraziamento particolare va al Dott. Francesco Sirano, Funzionario Responsabile dell’Uffi cio per i Beni Archeologici di Teano, per il sostegno e la collaborazione fornita nel corso del lavoro e alla Dott.ssa Madeleine Cavalier Bernabò Brea, che mi ha dato la possibilità di esaminare i materiali liparesi e mi ha fornito consigli e suggerimenti insostituibili.1 Per la storia dello scavo Gabrici 1910; i materiali provenienti da questi contesti e conservati al Museo Archeo-logico Nazionale di Napoli, sono stati di recente riesaminati in De Filippis, Svanera 1996. Dai documenti di archivio si apprende che lo scavo fu effettuato dallo stesso proprietario del fondo, Luigi Nobile, e da Casto Zona, i quali, ottenuta la licenza dal Ministero, effettuarono l’indagine di un ampio settore del fondo portando alla luce oltre 240 tombe. L’ultima fase dei lavori fu seguita dal Della Corte, che compilò i giornali di scavo, corre-dandoli di schizzi e sezioni delle tombe. Lo stesso Zona redasse un elenco dettagliato degli oggetti rinvenuti, con una valutazione economica di ciascuno, elenco che fu utilizzato dallo stesso Gabrici al momento dell’edizione della necropoli.2 Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli spettò un quarto degli oggetti rinvenuti, ma la direzione del Museo ne acquistò altri, così da avere nella loro interezza i corredi delle tombe 58, 62, 79 e 85, e le lastre di tufo dipinte delle tombe 58 e 79, che rimasero a lungo esposte nel cortile occidentale dello stesso Museo. Il corredo
137La ceramica figurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec.a.C.
della tomba 83, contenente la coppa con l’iscrizione di Platonos fu assegnato al Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” di Palermo, mentre al Museo di Archeologico Nazionale di Firenze furono assegnati i corredi delle tombe 36, 64 e 118. Cfr. De Filippis, Svanera 1996, 141, nota 4.3 Al gruppo, riconosciuto dal Trendall, viene attribuita una produzione piuttosto ridotta, costituita da 8 vasi, il cui nucleo è rappresentato senza dubbio dai rinvenimenti teanesi; vedi Trendall 1967, 559-561.4 Gabrici 1910, 107-116. Il corredo era composto da: una collana d’oro; due fi bule d’oro; due anelli d’oro, uno dei quali con corniola; una laminetta di argento dorato; uno specchio di bronzo; una laminetta di ferro; cinque stecche di avorio, forse pertinenti ad una cassetta; una lekane a fi gure rosse; tre hydriai a fi gure rosse; una pisside-skyphos a fi gure rosse; uno stamnos a fi gure rosse; una olletta tipo kemai; due kernoi a fi gure rosse; un cratere a calice a vernice nera con sostegno e con decorazione dorata; un’oinochoe con decorazione sovraddipinta in rosso; un askos confi gurato ad uccello; due skyphoi; tre piattelli su alto piede; un piatto da pesce; tre piatti e una coppa mesonfalica, questi ultimi tutti riferibili alla produzione teanese a vernice nera con decorazione sovraddipinta e graffi ta.5 De Filippis, Svanera 1996, 130-153.6 M(useo) A(rcheologico) N(azionale) N(apoli) Inv. Gen. 132444.7 Cfr. Gabrici 1910, 111, fi g. 83.8 De Filippis, Svanera 1996, 132-133.9 Trendall 1967, 570, 1006-1007.10 Svanera 2001.11 Il kernos generalmente costituito da un sostegno anulare di forma cilindrica sul quale si impostano dei pic-coli contenitori, pissidi o crateri miniaturistici, nel caso degli esemplari di Teano, alterna i piccoli contenitori (pissidi o ollette) a testine femminili realizzate a matrice. In alcuni casi il sostegno presenta una decorazione fi gurata a teste femminili o più semplicemente a palmette ed elementi vegetali. Dal quadro archeologico offerto dagli esemplari di provenienza nota, la produzione sembra comunque avere una forte connotazione territoriale, connessa alle offi cine teanesi attive tra la fi ne del IV e gli inizi del III secolo a.C. Cfr. Svanera 2001, 18-22. La forma sembra comunque largamente diffusa nella necropoli in loc. Gradavola dove numerosi esemplari, oltre a quelli di recente reperiti, vengono descritti dal Gabrici all’interno dei corredi funerari.12 Gabrici 1910, 111, fi g. 82. Il vaso, presente nei vecchi inventari del MANN con Inv. Gen. 132443, non è sta-to reperito. Le immagini relative alla pisside skyphos, alla lekane e alle hydriai risultano di scarsa qualità poiché tratte dalla pubblicazione del 1910 e dal repertorio edito dal Watzinger nel 1924.13 Il lato secondario del vaso non è visibile nella pubblicazione del 1910 e viene solo descritto; Gabrici 1910, 111. 14 Inv. Gen 132442. Gabrici 1910, 109-110, fi g. 79; Trendall 1967, 559, 918, pl. 221.1. Del vaso esiste anche una riproduzione a colori risalente al 1962, edita in Tuttitalia, fasc. 54, 14 Feb. 1962, 419. 15 Gabrici 1910, 110.16 C. Watzinger, Griechischen Vasen in Tübingen, Tübingen 1924, inv. 1352, F34.1, pl. 47; inv. 1353, F34.2.17 Trendall 1967, 560. 18 Berliner Staatliche Museen, 30017. Cfr. G. Kopcke, Golddekorierte attische Schwarzfi rniskeramik des vierten Jahrhuderts v. Chr., in AM 79, 1964, 55, n. 55, taf. 20.1. 19 W. Johannowsky, Nuove tombe dipinte campane, in Le genti non greche della Magna Grecia, Atti del XI Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 1971), Napoli 1972, 375-382.20 Gabrici 1913; pochi tuttavia gli esemplari dalla necropoli cumana, nella quale prevalgono forme quali l’anfora e l’hydria. 21 Inv. Gen. 132449. De Filippis, Svanera 1996, 133, fi g. 12.22 Inv. Gen. 132457, 132453. 23 Inv. Gen. 132460, 132451. De Filippis, Svanera 1996, 134, fi g. 13.24 Inv. Gen. 132450.25 Inv. Gen. 132455.26 Inv. Gen. 132453.27 Beazley 1943, 108; si prendono in esame otto vasi, sei dei quali provenienti da Teano, associati alla due hydriai di Tübingen, che vengono attribuiti all’ultima fase della produzione fi gurata campana. 28 Trendall 1967, 559-561.29 La lekane, visibile in una fotografi a edita dal Gabrici, era munita di un coperchio con una decorazione a
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 138
motivi fi tomorfi che copre completamente tutta la superfi cie, avvolgendo anche le due fi gure, una femminile, l’altra alata, rappresentate sui due lati opposti; Gabrici 1910, 109, fi g. 79. 30 La forma è largamente attestata nella necropoli di contrada Diana a Lipari; Bernabò Brea, Cavalier 1991, infra. Si ritrova inoltre replicata in tutta la produzione siceliota della fi ne del IV sec. a.C.; Trendall 1967, 573 segg. La forma è ben attestata anche nella produzione delle offi cine della Sicilia orientale ed in particolare in quella del Gruppo Etna; cfr. Barresi, Valastro 2000, 152-157.31 Per il Pittore di Lipari cfr. Cavalier 1976; Bernabò Brea, Cavalier 1986, 31-36, 49-62.32 Lekane proveniente dalla tomba 1883; Bernabò Brea, Cavalier 1991, 5, fi gg. 11-15, tavv. A-B; Bernabò Brea, Cavalier 1986, 35, fi g. 37; 42-43, fi gg. 41-42.33 Gabrici 1910, 111, fi g. 80. 34 Cavalier 1976. Il soggetto costituito dalle grandi fi gure femminili alate viene ampiamente adottato sia dal Pit-tore di Lipari che dai suoi successori. Numerose sono le raffi gurazioni di questo tipo sulle lekanai e sulle pissidi skiphoidi del Pittore di Falcone e del Pittore delle Tre Nikai. 35 Questo motivo decorativo ricorre con frequenza su una serie di lekanai di piccole e medie dimensioni, rin-venute in corredi della fi ne del IV sec. a.C. L’elemento a kymation diviene pressoché dominante nello schema decorativo, in alcuni casi del tutto esclusivo, associato ad una pesante policromia. Cavalier 1976, fi gg. 44, 45; Bernabò Brea, Cavalier 1986, 91-94, fi gg. 99-100. 36 Bernabò Brea, Cavalier 1986, 34: si fa riferimento agli ambiti culturali in cui la tecnica policroma è attestata con sicurezza, annoverando tra questi la Campania, con i vasi del Gruppo Teano-Tübingen. 37 Bernabò Brea, Cavalier 1965; Bernabò Brea, Cavalier 1986, 41-48; Bernabò Brea, Cavalier 1991.38 Bernabò Brea, Cavalier 1986, 41-48.39 A questo gruppo di vasi è riferibile la lekane della tomba 62 di loc. Gradavola. 40 Corredo della tomba 12, MANN Collezione Stevens. Gabrici 1913, 586-588; De Filippis 1998. I vasi sono stati attribuiti dal Trendall al Pittore della Cetra, anche se lo stesso autore sottolinea una forte affi nità con pro-dotti di offi cine siceliote, Trendall 1967, 550-551. Per una sintesi generale su tutte le problematiche relative agli scavi nella necropoli cumana: A. De Filippis Gli scavi dal XVIII secolo alla Raccolta Cumana del Conte di Siracusa, in I Greci in Occidente, 1996, 215-222; Ead., Gli scavi cumani di Emilio Stevens e la Collezione Stevens, ibidem, 233-248. 41 Gabrici 1913, 636-638, 731-739, fi g. 228; De Filippis 1995.42 Cavalier 1976, 32-33, fi gg. 21-24.43 E. Lepore, Napoli greco-romana. La vita politica e sociale, in Storia di Napoli, I, Napoli 1967, 215 segg.; G. Colonna, La Sicilia e il Tirreno nel V e IV secolo a.C., in Atti del V Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia Antica, Kokalos 27-28, 1980-8, 157-183; E. Lepore, intervento, ibidem, 184-185; E. Lepore, La città tra Campani e Romani, in Napoli Antica 1985, 109-115.44 Alla fi ne del V secolo a.C. le importazioni di ceramica attica a Neapolis, subiscono una decisa e irreversibile interruzione. Il dato si evince dai risultati degli studi sui corredi funerari delle necropoli cittadine che, pur se provenienti da scavi ottocenteschi privi di una documentazione scientifi ca puntuale, evidenziano una sostituzio-ne dei prodotti di importazione con i manufatti delle offi cine locali che, già a partire dalla fi ne del V secolo a.C., manifestano una fi orente attività. Nel IV secolo tutti i vasi fi gurati sono di produzione campana, ascrivibili nella quasi totalità ad offi cine campane o comunque campane, mentre sono quasi del tutto assenti vasi di produzione cumana. C’è da chiedersi se questa assenza non sia il risultato di una selezione dei fl ussi commerciali anche in entrata alla città, dall’entroterra, fl ussi che escludono Cuma, in quanto parte di un altro circuito economico, legato ad ambiti e contatti commerciali diversi. Per le necropoli di Neapolis cfr. in Napoli Antica 1985 i contri-buti: M. R. Borriello et al., Le necropoli urbane, 228-230; Eaed., 232-275; W. Johannowsky, L’organizzazione del territorio in età greco-romana, 333-334.La diminuzione e la quasi totale scomparsa delle importazioni attiche sulle coste della Campania, dal golfo di Napoli a Poseidonia, è un fenomeno che interessa tutta l’Italia meridionale e più in generale l’Occidente. Il tema, nella sua generalità, è stato oggetto di un incontro di studi: La céramique attique du IVe siècle en Médi-terranée occidentale, Actes du colloque international organisé par le Centre Camille Jullian (Arles, 7-9 décembre 1995), Naples 2000. In particolare sono stati esaminati alcuni aspetti relativi al carattere delle importazioni at-tiche a fi gure rosse e a vernice nera nella Campania centro-meridionale; cfr. A. Pontrandolfo, La ceramica attica di IV secolo in area tirrenica, ibid., 121-130.45 Le importazioni di ceramica attica, malgrado la chiusura del mercato di Neapolis, continuano ad affl uire nei
139La ceramica figurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec.a.C.
centri dell’entroterra, quasi sempre associati a ceramica pestana, attraverso canali di penetrazione evidentemente alternativi a quello neapolitano. Per una sintesi su queste problematiche G. Prisco, Considerazioni su una tomba femminile di Avella, in AnnAstorAnt 7, 1985, 146-148. 46 A Cuma si registra la presenza di vasi attici fi gurati sicuramente fi no alla metà del IV secolo a.C., mai associati a ceramica di produzione pestana. Si tratta di vasi riferibili alle ultime offi cine attiche a fi gure rosse, tra i quali alcune lekanai assimilabili ai prodotti del Gruppo Otchet, skyphoi del Fat Boy Group, e una lekane molto vici-na a realizzazioni del Pittore di Vienna 155; cfr. Beazley 1963, 1496-1502. Da uno dei corredi della necropoli ellenistica di Atella, proviene uno skyphos attribuibile ancora al Fat Boy Group (Inv. Gen. 291895), al quale è possibile avvicinare un altro esemplare, di dimensioni minori, nel Museo Archeologico dell’Agro Atellano, forse prodotto di imitazione locale; cfr. Guida breve. Museo archeologico dell’Agro Atellano, Aversa 2004, 16, fi g. 17. 47 Il tipo è largamente attestato in numerose stipi votive della Sicilia orientale, gravitanti sul territorio siracusano; cfr. D. Adamesteanu, Butera, Piano della Fiera, Consi e Fontana Calda. Scavi e scoperte dal 1951 al 1957 nella provincia di Caltanissetta, in MonAnt 44, 1958, 649-652; A. Di Vita, Camarina e Scornavacche in età timo-leontea, in Kokalos 4, 1958, 94 segg; P. Orlandini, Tipologia e cronologia del materiale archeologico di Gela dalla nuova fondazione di Timoleonte all’età di Ierone II, in ArchCl 9, 1960, 58-59. 48 MANN, Raccolta Cumana, Inv. Gen. 84819. Per l’identifi cazione del tipo: L. Scatozza Horicht, Le terrecotte fi gurate di Cuma, Roma 1987, 36-37, tav. III; L. Scatozza Horicht, Osservazioni sulla coroplastica cumana. L’Artemis Sicula tra Campania e Sicilia, in Artigiani e botteghe nell’Italia preromana. Studi sulla coroplastica etrusco-laziale-campana, a cura di M. Bonghi Jovino, Roma 1990, 123-125.49 Gli esemplari teanesi provengono da due corredi. Nel corredo della tomba 26, la statuetta dell’Artemide è associata presumibilmente a due fi gurine fi ttili femminili del tipo delle “Tanagrine” e a due kourotrophoi, oltre che a due lekythoi a reticolo, a vasi a fi gure nere e ad una collana in pasta vitrea. Ben diversa la composizione del corredo della tomba 76, ricco di orefi cerie e di ornamenti personali, nel quale le due statuette di Artemide si associano ad uno dei rari vasi a fi gure rosse segnalati nella necropoli (una lekythos), ad un kernos, ad alcuni vasi a vernice nera di produzione teanese, a cinque statuette del tipo delle “Tanagrine”, nonché a due bustini fi ttili di Demetra. Gabrici 1910, 74-75, 127-130. 50 Cfr. Svanera 2001. 51 La classe è così denominata dal medaglione centrale a rilievo che replica il tipo monetale siracusano presente sul decadrammo opera di Euainetos, con la testa della ninfa Aretusa di profi lo circondata dai delfi ni, riprodotta su kylikes a vasca bassa e larga, ispirate a prototipi attici presenti a partire dal secondo quarto del IV secolo a.C. La classe è attestata in numerosi contesti della Campania, tanto da far ritenere che in questo territorio esistano uno o più centri di produzione. Un esemplare è noto dalla necropoli di Ponticelli; cfr G. D’Henry, D. Giampaola, Le necropoli dell’entroterra, in Napoli Antica 1985, 305. Alcuni esemplari provengono da Cuma, Gabrici 1913, 589, tav. CVII 5. Senza dubbio tuttavia le attestazioni più numerose provengono da Teano, dove kylikes del tipo “Aretusaschale” si rinvengono sia nella necropoli in loc. Gradavola, sia nelle stipi dei santuari in loc. Loreto e Fondo Ruozzo. Per il tipo monetale e le problematiche relative alla monetazione siracusana: S. Garraffo, Il rilievo monetale tra il VI e il IV secolo a.C., in Sikanie, Storia e civiltà della Sicilia greca, Mila-no1985, 264-276. 52 Molti frammenti di questa classe sono stati riconosciuti nel corso del lavoro realizzato per l’allestimento del Museo Archeologico di Teanum Sidicinum. La presenza di questa produzione era comunque nota nella necro-poli di loc. Gradavola, dove se ne segnala l’attestazione in quattro corredi: tombe 5, 16, 30, 66. Gabrici 1910, 62-63, 68-69, 76-77, 117-118. Esemplari di “Aretusaschalen”, considerati di produzione locale, sono presenti anche negli scarichi del santuario in loc. Loreto: Johannowsky 1963, 136, fi g. 6, h, l. 53 La presenza di questi bolli è stata segnalata anche da W. Johannowsky tra i materiali dello scarico di un pozzo, rinvenuto nei pressi dell’ingresso orientale del santuario in loc. Loreto; Johannowsky 1963, 136. 54 Gabrici 1910, 28-29.55 Una si conserva su un piatto del corredo della tomba 34; un’altra è presente all’interno della vasca di un piat-tello su alto piede, pertinente alla tomba 27 e conservato agli Staatliche Museen di Berlino, la terza sull’esterno di una coppa della Raccolta Spinelli; Gabrici 1910, 28-30, 82-85. Per una trattazione complessiva delle proble-matiche relative queste iscrizioni si veda, P. Poccetti, Nuove iscrizioni vascolari dei Berii di Teano, in RendNap n.s. 59, 1984, 27-35. 56 Gabrici 1910, 133-139; De Filippis, Svanera 1996, 135-139
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 140
57 Gabrici 1910, 30, 76. 58 Gabrici 1910, 30, 140-141.59 Gabrici 1910, 30.60 Gabrici 1910, 99-105. L’iscrizione della coppa della tomba 58 non è nota al Gabrici, che non ne fa menzione nel suo catalogo dei corredi teanesi. Essa è stata individuata nel corso del lavoro di riordino dei materiali della necropoli: De Filippis, Svanera, 1996, 128-130, nota 29.61 Gabrici 1910, 31. 62 P. Mingazzini, Vitulazio. Tomba del IV secolo av. Cr. e via antica, in NSc, 1930, 549-552. La tomba, del tipo a cassa di tufo, conteneva otto oggetti di corredo, tutti di piccole dimensioni: due crateri a campana a vernice nera, una kylix a vernice nera, una coppa a vernice nera, un kyatos a rocchetto a vernice nera, una olpe acroma, una piccola lekane a fi gure rosse con decorazione a teste femminili e palmette alternate, un cratere a campana decorato a teste di profi lo stilizzate fra ramoscelli verticali. 63 Beazley 1943, 104. 64 Trendall 1967, 571-572. 65 Le dimensioni dei crateri variano dai 19 ai 25 centimetri di altezza. 66 W. Johannowsky ha indicato inizialmente come centro di produzione di questi vasi Cales, dato che viene ripreso dallo stesso Trendall; Johannowsky 1963, 136. Lo stesso studioso ha poi dato Teano come sito di lo-calizzazione dell’offi cina del Pittore di Vitulazio, sottolineando la ristretta diffusione areale di questi prodotti, limitata alla Campania settentrionale e alle aree adiacenti del Sannio; Johannowsky 2000, 147. Del tutto irrile-vanti, al momento le attestazioni al di fuori della Campania settentrionale, salvo il rinvenimento in una tomba della necropoli di S. Agata dei Goti (BN), di un’anfora attribuita alla produzione del Pittore di Vitulazio; vedi R. Bonifacio, Le tombe 139 e 26, in La Campania antica dal Pleistocene all’età romana. Ritrovamenti archeo-logici lungo il gasodotto transmeridiano, Napoli 1998, 127-129. In realtà, in questo caso, il riferimento ai vasi del Pittore di Vitulazio si coglie essenzialmente nella tecnica pittorica a contorno nero su fondo chiaro, ma la resa della testa, piuttosto naturalistica e i dettagli del volto ben leggibili e fi siognomici, non sembrano del tutto assimilabili ai modi dell’atelier teanese. Manca la serie di tratti verticali sulla fronte, retaggio stilizzato di un pos-sibile diadema, e la chiusura della testa sulla nuca, defi nita solo da tratti a tremulo. Del tutto atipica è anche la forma vascolare adottata, che non trova confronti in tutti gli esemplari attribuiti alla stessa mano, sia integri che frammentari. Indagini archeologiche recenti, condotte nel 2005 nel territorio di Sessa Aurunca, hanno portato al rinvenimento di una necropoli in loc. Piscinola dove, all’interno di due diversi corredi, sono stati rinvenuti due crateri, sicuramente attribuibili all’offi cina del Pittore di Vitulazio. Lo scavo, diretto dalla dott.ssa M.G. Ruggi d’Aragona è in corso di studio e pubblicazione, e potrà fornire ulteriori dati, utili alla defi nizione della diffusione di questi prodotti in un comparto territoriale che alla fi ne del IV sec. a.C. sembra acquisire ceramiche, fi gurate e non, dal centro sidicino.67 Johannowsky 1963, 136, fi g. 5 p. 68 Gabrici 1910, infra; tombe 8, 10, 15, 16, 17, 18, 31, 33, 39, 42, 69, 78.69 La necropoli, indagata circa trenta anni fa ad opera di W. Johannosky, è stata di recente riesaminata. Parte dei corredi è esposta nel Museo Archeologico di Teanum Sidicinum. 70 Berti, Desantis 2000, 98-100: vengono considerati i crateri, quali forma nobile della produzione di Spina. Di questi 11, con rappresentazioni di fi gure intere, maschili e femminili e con attributi quali il tirso sono associati, per il loro carattere iconografi co, a tematiche di tipo dionisiaco o comunque afferenti alla sfera del dionisismo. Cfr. anche Massai Dräger 2000, 107. 71 Il testo del Gabrici, se correttamente interpretato circa la presenza di vasi attribuibili alla mano del Pittore di Vitulazio, riconoscibili nelle descrizioni di vasi con fondo bianco e fi gure e teste ottenute a contorno nero, fa riferimento a forme quali la lekane di cui però non è stato possibile reperire alcun esemplare. Una lekythos frammentaria e un coperchio di lekane di piccole dimensioni (inedito), attribuibile alla stessa mano, provengo-no dagli scarichi del santuario di loc. Loreto; Johannowsky 1963, 136, fi g. 5 p. 72 La testa femminile, realizzata con un frettoloso tratto funzionale in nero, sulla superfi cie acroma del vaso, raggiunge un notevole livello di astrattismo, tale da richiamare, in maniera sorprendente, opere di arte moderna. La testa femminile costituisce, con tutta probabilità un retaggio di profi li femminili realizzati su vasi insulari di VIII secolo o su anfore attiche della fi ne del VI, o ancora su vasi greci di V e IV secolo dove è utilizzato per rappresentare Demetra, Persephone, Afrodite, Athena, Amazzoni e donne comuni. Senza dubbio la ceramica alto-adriatica imita modelli importati, rielaborando forme e schemi iconografi ci in funzione di una committen-
141La ceramica figurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec.a.C.
za modesta e poco esigente; Landolfi 1997. 73 Massai Dräger 2000, 108.74 Johannowsky 2000, 147.75 Harari 2000, 164-165.76 Cfr. Landolfi 2000, 111-129. La presenza di motivi derivanti dalla ceramica campana a fi gure rosse in area picena è sottolineato anche da W. Johannowsky, il quale, facendo riferimento a due crateri rinvenuti rispetti-vamente a S. Paolina di Filottrano e nella zona di Numana, ritiene che si possa ipotizzare l’attività, in qualche offi cina dell’area anconetana, di qualche pittore di provenienza campana forse collegato alle offi cine cumane del Pittore CA; cfr. Johannowsky 2000, 147.77 Si richiama ancora una volta il confronto, già suggerito dal Trendall, fra il sottogruppo alto-adriatico della tomba 785 valle Trebba e i crateri a campana decorati in outline con teste femminili di profi lo del Pittore di Vitulazio. Questo confronto suggerisce l’ipotesi di forme di contatto culturale, mediate attraverso vie di pe-netrazione appenniniche meridionali, che potrebbero aver ricalcato, in un quadro storico del tutto diverso, la direttrice seguita dagli Etruschi nella spedizione contro Cuma del 524 a.C.: M. Harari, intervento in Spina e il Delta Padano, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Ferrara, 1994), a cura di F. Ribecchi, Roma 1998, 167-170.78 Svanera 2001.
L’antica via Teanum-Allifae *
Rosaria Sirleto, Antonio Petriccione
Nell’ottobre del 2002, le operazioni di scavo di un tratto dell’antica strada che collegava Teanum ad Allifae prendevano avvio in un’area alla periferia nord-orientale del centro sidicino, lungo un viottolo di campagna noto come via Passerelle. L’oc-casione era offerta da uno scavo “compensativo” predisposto quattro anni prima, al termine delle operazioni per la realizzazione della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità, il cui passaggio nella zona aveva interferito con i cospicui resti del lastricato deter-minandone la rimozione. Le indagini, conclusesi nel mese di luglio del 2003, hanno interessato la sistemazione di un segmento di strada individuato a E della trincea del treno, lo scavo di un tratto di 100 metri lungo via Passerelle, una serie di saggi ai lati della stessa ed il restauro di parte della sede stradale.
Storia degli studi e accenni alla topografi a del territorioL’incrocio tra dati cartografi ci, lettura delle foto aeree e indagini di superfi cie
rende noto l’itinerario antico della via, un lungo rettilineo orientato NE-SO i cui resti, ancora leggibili in traccia, sono inoltre perfettamente integrati all’interno della maglia centuriale di epoca augustea.1
Nei pressi di Teano la strada veniva a costituire un braccio della via Latina, un’ar-teria “secondaria” che metteva in collegamento il centro sidicino con l’attuale piana di Pietramelara, percorsa la quale fi niva per confl uire nella rete stradale a servizio della città di Allifae.
Il tracciato era già noto alla trattatistica antiquaria che ne menziona tronchi ri-masti praticamente sempre in vista. Alla “via del Sannio” fa riferimento il Broccoli2 quando nella sua opera del 1821, accenna ai ruderi, “altro capo di strada Latina”,3 che si vedono in sequenza presso Madonna della Carità, la Ferriera e Masseria Grimaldi. L’erudito ne dà notizia riprendendo un passo liviano in cui si parla del cammino percorso dal console romano Marcello per andare a Canosa: in un tratto di quell’itinerario crede di poter riconoscere la strada per Allifae.
Sempre ad essa rimandano in tempi più recenti il De Monaco,4 che alla stessa ma-niera ne indica tronchi ancora ben conservati a S. Amasio e ai Quaglieri, e il Cipria-no,5 che segnalando verso E lo sbocco dell’arteria dalla città di Teano, la fa dirigere verso il pagus di Riardo attraverso «il bel ponte di epoca più tarda in Val d’Assano».
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 144
La menzione del tracciato ritorna ancora una volta nelle pagine del Caiazza6 che seguendone il percorso sul terreno registra anche la serie di evidenze conservate ai suoi lati.
In anni recenti, come anticipato, possibilità di acquisire nuove informazioni sulla strada vengono fornite dall’impianto del grande cantiere per la realizzazione di un tratto della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità Roma-Napoli (TAV), in una zona pe-riferica del territorio teanese. Le indagini, condotte a più riprese, hanno consentito di arricchire la serie di dati in nostro possesso sulla strada, riportando alla luce nuovi tronchi del percorso da tempo nascosti e fornendo elementi sulla tecnica costruttiva, sulle fasi di vita, nonché sulla vocazione funzionale degli spazi ai lati della stessa, rilevando così in alcuni casi la presenza di elementi di “arredo”.
Tratti mal conservati dell’antica platea stradale giacciono in una zona distante 4 km dal centro storico, in una località nota col nome di “contrada Passerelle”.
Il toponimo, come quello vicino di “Rio Ponticelli”, sembrerebbe evocare l’esi-stenza di opere di attraversamento che avrebbero consentito alla strada di guadare il fi ume Savone e i suoi piccoli affl uenti, fi ume che in questo comprensorio viene intercettato dalla via per ben due volte: una prima volta in direzione di Allifae, nella zona compresa tra il Rio e il Fosso del Maltempo; una seconda a ridosso del centro sidicino, dove resti di basolato sono stati individuati nel letto del fi ume all’altezza di Masseria della Ferriera Vecchia, al limite sud orientale della città.
Del lungo segmento conosciuto in direzione di Allifae, restano ancora visibili per un tratto di almeno 3 Km alcune sezioni di selciato a partire dalla zona a monte del ponte autostradale n. 474 dell’Autostrada del Sole. Superato quest’ultimo, dopo un breve tratto asfaltato, la platea lastricata è ancora ben visibile, avanzando in discesa per un altro setto di 100 metri e correndo incassata nel banco di tufo, taglio che fu necessario scavare in antico per ricavare il passaggio.
Non sempre ben conservata, l’antica carreggiata resta a vista nella sola parte cen-trale: la rimanente sezione di sede stradale, comprensiva di margines, è interrata o, come è possibile osservare in alcuni punti lungo la sponda meridionale, questi ultimi mancano del tutto. Assenti nuovamente nei pressi di Masseria Quaranta Moggia per poi riproporsi a tracce dopo aver percorso in discesa, per una cinquantina di metri, un vicino tratturo, i resti del basolato si ripresentano in pessime condizioni, ribassati o del tutto scalzati dalla sede stradale. È in questo punto che la carrozzabile intercetta un affl uente del fi ume Savone, nella località che l’IGM7 riporta come “Passarella”.
Il guado sul fi ume dovette essere realizzato mediante un ponte, un passaggio, da cui appunto il toponimo, opera della quale ad una veloce verifi ca che ci ha condotto fi no al letto del fi ume in secca, non sembrano conservarsi più le tracce.
Pochi i resti individuati in direzione di Teano, dove la coincidenza tra la quo-ta antica e quella moderna ha reso in alcuni punti praticamente nullo lo stato di conservazione del tracciato, lasciando intravedere in maniera discontinua poco più dello spargimento delle schegge di trachite impiegate nella sua realizzazione.
145L’antica via Teanum-Allifae
Risalendo via Passerelle, dove in corrispondenza di tutta la sezione settentrionale, si può ancora osservare un lungo segmento di platea stradale tagliato forse proprio per ricavare l’attuale viottolo di campagna, oltrepassato l’incrocio moderno, sono ancora evidenti pochi resti dei margines o dei basoli che segnano il limite meridiona-le della strada. Proseguendo, e solo saltuariamente, si rintracciano tra la vegetazione allineamenti che defi niscono il suo ingombro anche verso N e blocchi non meglio identifi cati, in calcare e in tufo, residuo di possibili costruzioni che occupavano i lati della strada.
Giunti al punto in cui il sentiero moderno si biforca e una diramazione scende verso il Savone, si conservano ancora in situ i resti della cassa e della copertura in tufo di una sepoltura sconvolta che affi ancava il tracciato, mentre più sotto, a margine di un altro campo coltivato, in un nuovo canale attraversato da un rivolo di modesta portata, altri basoli giacciono alla rinfusa, divelti dalla loro posizione originaria e lì accantonati probabilmente a seguito di lavori agricoli.
I resti della strada si perdono a mano a mano che si scende verso il Savone, per poi riapparire nuovamente in maniera caotica in corrispondenza del fi ume, lì dove il Caiazza vide molti basoli accantonati, nei pressi di Masseria della Ferriera Vecchia, nel punto in cui «un’ampia salita interrompe la riva destra del Savone» e dove lo stu-dioso ritenne possibile che un’altra strada salisse alla città.
Fig. 1 - Carta storica del 1876 con il posizionamento del tratto indagato.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 146
L’analisi della cartografi a storica8 (fi g. 1) consente di ricostruire, in via ipotetica, un percorso leggermente diverso. Seguendo la linea continua riportata sulla tavolet-ta, si evince che la strada, arrivata al Savone in una zona a N di Masseria Bagnonuo-vo, tra questa e Masseria Stabile, doveva valicare il fi ume e risalire fi no all’area in cui si è ipotizzato che sorgesse il Foro.
L’osservazione del lungo segmento attestato aldilà del ramo autostradale, unita a quella dei pochi lacerti individuati lungo la direttrice che porta a Teano, nonché all’analisi della cartografi a, consente di apprezzare come, rispetto alla sostanziale regolarità del tragitto compiuto in direzione di Allifae, dove la natura pianeggiante del territorio consentiva alla strada di assumere un andamento a rettifi lo, nei pressi di località come i Quaglieri o Passerelle, alla periferia del centro sidicino, il tracciato fosse più irregolare, scandito da lente curve dettate dalla morfologia del suolo, qui caratterizzata da una successione di brevi rilievi.
Tale circostanza, che dovette rendere più diffi coltoso il tragitto verso la città, venne evidentemente superata mediante un espediente ampiamente attestato nella tecnica stradale romana, attraverso l’impianto, cioè, di una serie di rettifi li collegati ad angolo in corrispondenza dei principali salti di quota che scandiscono la salita in direzione di Teano, nell’intento probabile di spezzarne la ripidità.
Così sembrerebbe di poter ricostruire anche lungo il tratto intercettato dalle opere TAV, dove un’evidente differenza di quote e un’apparente difformità di orien-tamento caratterizzerebbero i segmenti basolati individuati a E e a O della ferrovia, entrambi sicuramente pertinenti però alla stessa strada.
Lo scavo della stradaL’intervento del 2002, ha interessato un segmento di un centinaio di metri lungo
un sentiero di campagna noto, appunto, col nome di via Passerelle, nella località omonima.
Si tratta di un troncone dell’antica arteria di cui era già nota l’esistenza, ma che alterne vicende legate alla successione di cantieri nell’area per la creazione di moder-ne infrastrutture avevano momentaneamente obliterato.
Nel tratto indagato, lo scavo ha consentito di verifi care come la sovrapposizione tra il tracciato antico e la carrareccia moderna si segua in maniera quasi pedissequa fi no al punto in cui il basolato termina il suo percorso interrotto, letteralmente ta-gliato, dal passaggio della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità.
L’antica arteria era stata intercettata in passato, in questo stesso comprensorio, ben due altre volte in concomitanza della realizzazione di opere stradali: la costru-zione dell’Autostrada del Sole e l’ampliamento della stessa per la realizzazione della terza corsia, rispettivamente negli anni ’60 e ’80 del secolo scorso. I lavori per la realizzazione della Linea Veloce sono gli ultimi in ordine di tempo e risalgono al 1998. Proprio in quest’ultima occasione ne fu indagato un tratto di 55 metri lineari9 conservato sostanzialmente lungo il solo versante meridionale: il percorso era mutilo
147L’antica via Teanum-Allifae
invece della sezione settentrionale, per effetto, forse di una serie di migliorie fondia-rie effettuate nella zona.
Il lungo tronco oggi visibile a O della recinzione delle ferrovie, indagato nel 2002, era invece completamente obliterato. In occasione della realizzazione della terza corsia, infatti, quando via Passerelle era apparso come il tracciato più naturale per il transito di mezzi e materiali atti alla realizzazione delle opere, venne gettato su tutto il sentiero uno spesso strato di stabilizzato per non far slittare le pale cingolate e limitare i danni alla sede stradale antica.
Una prima parte dell’intervento ha riguardato la pulizia ed il conseguente re-stauro di un segmento di platea già noto, individuato in una zona compresa tra il ponte dell’autostrada e la recinzione delle ferrovie, in un punto sopraelevato rispetto all’attuale piano di campagna, isolato e monumentalizzato a monte di una scarpata provvista per l’occasione di una fodera in cemento e accessibile da una scaletta. Il grosso delle operazioni ha avuto luogo, però, lungo via Passerelle, dove, eliminato lo strato di materiale inerte, è apparso il pavimento antico.
La sede stradale, orientata grossomodo E-O, in basoli poliedrici di trachite, come da tradizione provvisti di una faccia superiore levigata e di una parte inferiore a cu-neo, si conservava perfettamente integra per una lunghezza di m 24 e una larghezza di m 2,90, misura che raggiungeva complessivamente i m 3,10 comprendendo an-che i margines.
In corrispondenza della sezione N, lungo l’attuale limite del ciglio alberato, termine confi nario con un vicino e sottoposto frutteto, lo scavo ha consentito di riconoscere un ulteriore allineamento, realizzato con pietre dello stesso tipo ma in grossi spezzoni irregolari a faccia a vista verso il basolato, che veniva così a delimita-re, col margo N della strada, una fascia stretta e allungata, probabile crepidine, della larghezza di m 1,60 ca. attestata integralmente per quasi tutta la lunghezza del tratto indagato. Su ambo i lati e in maniera più continua sul versante meridionale, meglio conservato, alla regolare sequenza di blocchi più piccoli e squadrati costituenti i margines veri e propri si alternano ogni 6 metri pietre in forma di piccole stele con il lato posteriore generalmente a calotta e quello anteriore lisciato e piatto, indicati comunemente come paracarri. Per i successivi 76 metri posti in luce, sono visibili solo sul versante meridionale, e non sempre in maniera continua, una o due fi le di basoli, mentre il resto del lastricato è divelto e appare solo la preparazione in cui esso veniva alloggiato.
Conservata in maniera più apprezzabile è l’estrema sezione orientale della strada, immediatamente a ridosso della recinzione della linea ferroviaria.
Da quest’area proviene una delle novità più interessanti che le ultime indagini hanno permesso di registrare. Anche qui la platea risulta mutila di buona parte della sezione settentrionale, ma si conserva sul lato S per un’ampiezza oscillante tra m 1-1,50. In questo punto, un allargamento effettuato per verifi care la presenza di eventuali evidenze limitrofe alla strada, in un’area non lontana da quella in cui nella
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 148
campagna del 1998 erano state identifi cate alcune sepolture, ha consentito di ripor-tare alla luce una diramazione (fi g. 2).
Si tratta di un segmento basolato, di modulo leggermente inferiore rispetto a quello pertinente alla direttrice principale, orientato grossomodo N-S, largo m 2,40, delimitato solo su di un lato da un paracarro e attestato per una lunghezza di 1 m ca., misura oltre la quale il lastricato si interrompe bruscamente e si distingue una sorta di massicciata. Essa appare realizzata tramite accumulo di spezzoni di trachite di media pezzatura collocati in maniera circoscritta a partire dall’interruzione del lastricato e orientati verso la sezione E, dove l’evidenza sembra proseguire avanzando leggermente in salita.
I paletti in cemento della recinzione delle ferrovie hanno impedito ulteriori verifi che, ma l’insieme dei dati emersi sulla sistemazione di quest’area può fornire qualche indicazione sulla sua probabile destinazione d’uso.
Un ampliamento della larghezza di m 2, in una zona compresa tra il diverticolo individuato ed il margo meridionale della direttrice viaria principale, ha consentito di identifi care un’area libera, sistemata con un battuto molto accurato costituito da terra, minute schegge di trachite e frammenti ceramici (in massima parte pareti di
Fig. 2 - L’ingresso al mausoleo con la piazzola di sosta.
149L’antica via Teanum-Allifae
anfore), fortemente costipato e regolarizzato: un plateau lungo m 6 e largo m 2,70, in cui parrebbe di poter identifi care una probabile piazzola di sosta.
Dal basolato l’accesso all’area era garantito da un andito ricavato interrompendo, per la misura di m 1,60, i blocchi che defi nivano il marciapiede sul lato S.
La sequenza stratigrafi ca infatti, indica che la sistemazione di questa piattaforma precedette la stesura del pavimentum in basoli, pur rientrando all’interno dello stesso intervento.
Non essendo fattibile indagare il settore in maniera estensiva, una possibile chia-ve di lettura sulla natura delle evidenze individuate ci viene offerta dal confronto con i dati emersi dallo scavo del 1998.
In quell’occasione, nelle immediate vicinanze del nostro diverticolo, ad una quota leggermente sopraelevata, corrispondente grossomodo all’attuale scarpata oc-cidentale della trincea del treno, fu rinvenuto, in crollo, un monumento funerario a colonna.
Il posizionamento della colonna rispetto alle evidenze appena richiamate, il pia-no di spiccato del monumento (sopraelevato almeno di un metro rispetto al resto del tracciato in un settore in cui la strada doveva evidentemente superare un forte dislivello e proseguire in salita), la misura inferiore dello svincolo (m 2,40 contro i 2,90 della carreggiata principale), l’interruzione quasi subitanea della platea lastrica-ta a fronte dell’inizio di una sorta di massicciata, nonché la vicinanza di una proba-bile zona di sosta, fanno ritenere molto verosimile che in questa ramifi cazione sia da vedere più che un’arteria secondaria, una sorta di accesso ad una probabile proprietà privata che fi ancheggiava la strada, all’interno della quale doveva dominare il vicino mausoleo con piazzola di sosta accessibile direttamente dalla strada attraverso un andito atto agevolmente al transito di un carretto il cui interasse è stato calcolato appunto in m 1,60.
Un elemento del genere, lungo un percorso extraurbano di una certa importan-za, una così chiara volontà di monumentalizzare, rifl esso di un forte sentimento di autorappresentazione, troverebbe giustifi cazione nell’ostentato valore del sepolcro,10 confi guratosi da subito come la struttura gentilizia principale intorno alla quale erano raggruppate una serie di altre sepolture.
La massicciata individuata a monte del lastricato potrebbe costituire una sorta di sottofondazione allestita per sostenere il peso di eventuali altre costruzioni.
Una circostanza del genere venne registrata anche durante le indagini effettuate da S. Cascella, che rilevò al di sotto della colonna una piattaforma di scaglie di tra-chite larghe quanto la base.
Provando a leggere sull’antica platea i segni del suo vissuto è possibile raccogliere informazioni molto interessanti. Le strade raccontano molto più di quanto l’analisi archeologica documenti: esse non sono solo vie di occupazione militare, di scambi commerciali, ma rifl ettono, attraverso i restauri e le trasformazioni, la temperie po-litica e culturale del territorio all’interno del quadro storico contingente.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 150
Tracce di questo vissuto sono qui ad esempio i segni di usura testimoniati dai sol-chi lasciati dai carri: due perfettamente equidistanti permettono di apprezzare quella che doveva essere l’ampiezza dell’interasse di un carretto che abbiamo già anticipato di m 1,60, e di ipotizzare per questo percorso uno scorrimento a sensi di marcia alternati, con probabile presenza di piazzole per il cambio o la sosta.
Alle saltuarie sconnessioni del piano stradale, seguono i numerosi e puntuali rat-toppi nella struttura, sarciture realizzate con schegge di dimensioni medio piccole o in casi sporadici con terra pressata, tutti elementi che testimoniano indirettamente della vita duratura del tracciato, il suo intenso utilizzo e la volontà di conservarne il transito.
Dalle indagini non emergono dati sull’abbandono: il tracciato è sempre in vista e utilizzato, circostanza che ha chiaramente impedito la crescita dei suoli.11
Una testimonianza sulla continuità di vita e utilizzo anche successiva alla ro-manizzazione proviene dallo scavo di un edifi cio medievale individuato sempre nella campagna del 1998: poste lungo la strada, di cui rispettano il tracciato, poche strutture mal conservate descrivono un piccolo ambiente a pianta rettangolare che i materiali hanno consentito di datare tra XII e XIII sec.
La trattatistica antiquaria, come abbiamo visto, ci consegna l’immagine di tron-chi della strada da sempre in vista e anche la memoria locale descrive per l’immedia-to dopoguerra una situazione non dissimile.
La veste in cui la si vede oggi, con il bel basolato lavico, non appartiene, però, alla prima fondazione del tracciato. Essa è il risultato di un’importante opera di trasfor-mazione di un’asse viario preesistente, come le indagini compiute nel 2002 hanno dato modo di appurare.
Questo lastricato venne infatti preceduto da una più antica glareata in cui è da riconoscere il primitivo impianto.
Uno scavo estensivo su tutta l’area ed una serie di saggi condotti all’interno e al di fuori della platea stradale, hanno consentito di ricostruire la sequenza delle operazioni effettuate per la costruzione dell’opera, con lo scavo della cassaforma e la stesura degli strati di preparazione, sul modello di quanto è noto per altre strade romane,12 nonchè di recuperare dati signifi cativi sulle fasi di vita del tracciato e sulla sua cronologia.
Realizzata tramite taglio nel banco di tufo e massicciata di contenimento, la stra-da ha il rilevato a profi lo convesso per favorire il regolare defl usso delle acque ed è provvista di almeno un canale di raccolta e scolo, profondo cm 30 e largo fi no a 70, indagato in una lunga sezione di ca. 70 metri lungo il versante N,13 nel punto in cui la stradina moderna, ricalcando in maniera precisa l’antica via, appena oltre l’attuale limite di un fi lare di querce, compie uno slargo e raggiunge la misura complessiva di quasi 6 metri.
Sul tasso naturale sagomato a schiena d’asino, vennero gettati in sequenza gli strati di preparazione: lo statumen, con grossi scapoli di trachite, il rudus, una misce-
151L’antica via Teanum-Allifae
la di terreno tufaceo, sabbia, schegge di tufo grigio e di trachite fortemente costipati. Segue una sorta di nucleus, realizzato con uno strato più o meno simile al precedente per composizione ma ad inclusi sminuzzati e fortemente compattati, forse ribattuti da rulli; da ultimo, allettato in summa cresta, il rivestimento pavimentale.
Del più antico lastricato, realizzato con selci di modulo medio e piccolo rara-mente sagomate artifi cialmente, si conserva una lunga sezione del margo setten-trionale, anch’esso costituito da una sequenza di piccoli blocchi appena squadrati allineati per testa, e una serie di brevi sezioni della platea stradale (fi g. 3), venuta fuori quasi immediatamente al di sotto di un esiguo spessore di stabilizzato e pur-troppo in pessimo stato di conservazione a causa del passaggio dei mezzi meccanici e all’azione delle ruspe che molto probabilmente operarono anche lo strappo della pavimentazione in basoli fi no a devastare in alcuni punti lo strato di preparazione in cui il pavimento era alloggiato.
La lacuna registrata nella struttura della strada ha consentito di recuperare dati sull’ampiezza e la sistemazione del tracciato.
Una serie di considerazioni portano a stimare con cautela la larghezza della carreggiata più antica, che chiameremo di primo impianto, intorno ai m 4,60: un
Fig. 3 - Un tratto della glareata di I fase.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 152
punto di verifi ca per ricostruire la misura del transito extraurbano in base ai dati illustrati, l’unico che consenta di fare ipotesi, è compreso nei primi 20 metri.
In questa fascia, infatti, il limite N è segnato da una termine artifi ciale, il margo antico, a monte del quale è stata messa in luce la massicciata di contenimento, e da un elemento naturale, la presenza del fossato, nella cui sezione esposta affi ora il banco di tufo. A S invece, la verifi ca della fi ne delle sequenze stratigrafi che, relative agli strati di preparazione della strada in corrispondenza della linea del marciapiede, può fornire l’altro termine.
La ristrutturazione della strada, con la posa in opera del basolato, determinò la distruzione della metà meridionale del tracciato più antico, poiché quello nuovo, utilizzò come sede carrabile solo una parte della platea di I fase, pur continuando a mantenere identico l’orientamento. Dalla sezione settentrionale dell’antica glareata si ricavò poi la crepidine (Tav. 10).
L’evidenza è apprezzabile soprattutto dopo i primi 30 metri, dove anche il con-trollo delle quote testimonia come il lungo segmento glareato, risparmiato al di fuori della platea stradale di II fase, sia sottoposto a quest’ultima di almeno cm 30.
Fig. 4 - A) Sezione N-S del tracciato stradale nei primi 30 metri; B) Sezione N-S dei resti del basolato e della glareata.
153L’antica via Teanum-Allifae
I dati ricavabili dall’osservazione di un segmento della struttura più antica, anco-ra in vista nella sua completezza in corrispondenza del lungo tronco che negli ultimi 70 metri affi anca la linea del basolato più tardo, unitamente all’analisi dell’ampiezza, del profi lo e della conformazione della strada (fi g. 4), indicano chiaramente come lo strato di preparazione in cui erano allettate le selci della glareata venne ribassato in corrispondenza della metà S per consentire l’alloggiamento dei cunei del basolato.
Il taglio fu più cospicuo nella parte centrale della carreggiata, mentre tendeva a ridursi drasticamente in corrispondenza di quella fascia dove doveva essere ricavato il marciapiede e dove è possibile che vennero fatte aderire alcune di quelle lastre con la faccia posteriore del tutto piatta ritrovate in grande quantità nelle vicinanze.
Lo studio preliminare dei materiali recuperati nei diversi saggi effettuati in cor-rispondenza dell’ingombro delle carreggiate, del marciapiede, nonché all’interno della massicciata di contenimento della strada, conferma un’assoluta omogeneità cronologica (fi g. 5).
Poche forme note a vernice nera e una grande quantità di pareti non attribuibili sembrerebbero indicare un momento di fondazione dell’impianto stradale nel corso della prima metà del II sec. a.C.
Va registrato inoltre, come dato generale, un’incisiva presenza di ceramica a ver-nice nera a fronte di una sostanziale assenza di alcune produzioni peculiari, terre sigillate o anche produzioni a pareti sottili.
Fig. 5 - I materiali a vernice nera dallo scavo della strada.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 154
Su tutta l’ampiezza dello scavo, gli unici frammenti in terra sigillata italica atte-stati sono stati rinvenuti all’interno dell’ingombro pertinente la strada con il lastri-cato in basoli, quella cioè presumibilmente di secondo impianto, allettati in summa cresta, immediatamente al di sotto di questi e che perciò sembrerebbero datare la pavimentazione più recente: tre frammenti dal profi lo poco conservato pertinenti a piatti o coppe su alto piede, non meglio identifi cabili.
Un ulteriore contributo alla defi nizione di cronologia e sistemazione dei due impianti viene dalla valutazione di dati come il rapporto spaziale e l’orizzonte cro-nologico delle sepolture rispetto al tracciato.
Durante la campagna del 1998, infatti, come si è detto, vennero in luce imme-diatamente a S del basolato, cui risultavano affi ancate, un certo numero di sepolture che rispettavano il tracciato e che i dati di scavo consentirono di datare tra età augu-stea e prima età imperiale.
Non meno signifi cativa appare la rifl essione sul massiccio intervento di riorga-nizzazione imposto da Augusto su tutto il territorio, intervento che investì in parti-colare Teano con la fondazione della colonia, trovando testimonianza nella sistema-zione di molti monumenti cittadini e, meno evidentemente dal punto di vista della visibilità archeologica, nella politica di ristrutturazione della campagna circostante14 che portò, come citato nel Liber “A Caesare Augusto de limitibus Augustei”, all’as-segnazione di nuove terre per la città e alla sistemazione della rete stradale, in cui verrebbe perfettamente ad integrarsi un tracciato già esistente, monumentalizzato, i cui segmenti centuriali restano a tutt’oggi visibili.
Sepolture affi ancate alla strada sono state individuate anche nell’ultima campa-gna, lungo il versante opposto, a N del basolato e oltre il limite della strada di primo impianto, il cui ingombro risulterebbe perciò rispettato.
Al di là di quest’ultimo, uno scasso moderno aveva intercettato quello che con tutta probabilità doveva costituire un piano funerario antico, come la natura parti-colare dei materiali rinvenuti sembrerebbe testimoniare: tre olle ad incinerazione, distrutte ma ancora ricomponibili e con resti di ossa combuste, vasetti miniaturistici, balsamari, un frammento di bacino con tre lettere incise in osco sul lato esterno di
Fig. 6 - Planimetria dell’area di scavo con il posizionamento dei saggi.
155L’antica via Teanum-Allifae
diffi cile interpretazione, un frammento di punta forse pertinente a uno spiedo, un frammento di probabile borchia di forma circolare con accennata apofi si centrale, e una placchetta ovale non meglio identifi cata, forse una fi bbia. Si tratta purtroppo di materiali non particolarmente signifi cativi per la determinazione dell’orizzonte cronologico, ma sicuramente utili a chiarire la vocazione funzionale della fascia a margine del tracciato.
Un’ultima sepoltura, rinvenuta ancora in situ molto in prossimità delle evidenze su indicate, con cassa realizzata in spesse lastre di terracotta poste a spiovente, ha restituito solo pochi resti dello scheletro fortemente consunto a causa dell’acidità del terreno e nessun elemento di corredo. Anch’essa rispetta il tracciato con il quale mantiene identico l’orientamento, ma anche nel suo caso mancano elementi da-tanti.15
R.S.
Scheda di dettaglio sull’interventoL’indagine ha interessato lo scavo di un tratto di 100 metri di strada (p.d.c. da m
173,56 a O a m 170,51 a E) lungo via Passerelle, in corrispondenza dell’opera TAV WBS TRJ4, per la costruzione della quale già nel 1998 parte del tracciato veniva portato alla luce, indagato e rimosso dalla sede originaria.
Si è proceduto a liberare l’antico livello pavimentale dallo strato di materiale inerte gettato in epoca moderna e spesso in alcuni punti anche m 0,80, partendo dall’incrocio con Masseria Grimaldi fi no a giungere al limite della recinzione delle ferrovie, dove il tracciato si interrompe bruscamente.
Conservato interamente nella pavimentazione in basoli per la misura di ca. m 30 ne risulta quasi del tutto mutilo nei rimanenti 70 m.
Sistemata su tutta l’area una maglia di m 96 x 12, costituita da quadranti regolari di m 4 x 4, si è proceduto al posizionamento di una serie di saggi in corrispondenza di quei punti che promettevano di dare risultati maggiori: quattordici saggi in tutto (fi g. 6), alcuni dislocati all’interno della platea stradale con una frequenza di m 10,
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 156
gli altri ai lati di questa con una distanza variabile a seconda delle possibilità di inda-gine, dettate dalla morfologia dei luoghi in questa parte di tracciato.16
La natura delle evidenze poste in luce nei saggi praticati all’interno della carreg-giata ed il cattivo stato di conservazione della pavimentazione lungo tutta la metà orientale dell’area indagata hanno fatto ritenere necessaria quasi subito l’estensione delle indagini a tutta la zona, liberando anche la superifi cie coperta tra i vari saggi.
Si presenta qui di seguito una selezione degli interventi più signifi cativi.
Saggio II
Il saggio veniva aperto lungo il limite settentrionale dell’area indagata, in corri-spondenza del versante orientale, lì dove è attualmente visibile una fascia stretta e allungata occupata da un fi lare di querce.
Esso veniva posizionato per verifi care la reale consistenza delle evidenze emerse in maniera appena parziale a N di un allineamento (US 17) costituito da pietre di trachite parzialmente lavorate, formante l’altro limite della crepidine, su quel lato.
Un taglio di m 2,30 x 1,70 ha portato in luce al di sotto di uno strato umifi cato datato ad epoca contemporanea, una probabile massicciata di contenimento. Essa constava di due interfacce sovrapposte gettate direttamente al di sopra del banco naturale di tufo tagliato e regolarizzato.
La prima (US 2) era costituita da un terreno sabbioso estremamente compatto, unito a pezzame di trachite di dimensioni medio grandi, scapoli di tufo grigio, radi frammenti di ceramica e laterizi (quota max. m 173,46 - min. m 173,39 s.l.m.). La seconda (US 7) da una miscela di terreno tufaceo, compatto, misto a rade schegge di trachite, radi frammenti ceramici e pochi scapoli di materiale laterizio.
Gli strati erano stati gettati in sequenza sul tufo in modo da creare una sella al centro che consentisse così il defl usso naturale delle acque meteoriche.
Indagata anche in un altro punto (saggio I), lungo un segmento di m 50 ca., l’evidenza risulta essere presente almeno lungo il settore di basolato ancora in situ e dovette con tutta probabilità avere avuto funzione contenitiva. La strada infatti, secondo una tecnica consueta e ampiamente attestata per i tracciati lungo gli assi extraurbani, fu costruita tramite taglio e livellamento del tasso naturale di tufo, così utilizzato con funzione di cassaforma per il getto dei livelli di preparazione della platea stradale stessa. Probabilmente anche a causa della presenza del salto di quota posto immediatamente a nord e forse più considerevole di quello che vediamo oggi,17 si dovette dotare il tracciato di una massicciata di contenimento per impedire lo smottamento degli strati di terra.
I pochi materiali ceramici rinvenuti, soprattutto le forme a vernice nera, datereb-bero la sua costruzione all’incirca alla prima metà del II sec. a.C.
157L’antica via Teanum-Allifae
Saggio VII
Un sondaggio dell’ampiezza di m 1 x 1 ca., ripetuto altre due volte (saggi IX e X) lungo una fascia di m 30, è stato aperto all’interno della crepidine sul versante settentrionale dell’area di scavo, in un punto molto prossimo a quello in cui il baso-lato si interrompeva e in corrispondenza di uno di quei settori in cui il marciapiede risultava mutilo della lastricatura, in realtà conservata in questo primo troncone in maniera saltuaria e per piccolissimi lembi.
L’indagine aveva lo scopo di verifi care la successione della colonna stratigrafi ca, saggiare la composizione degli strati di preparazione in un settore al limite dell’area occupata dal tracciato, oltre il quale era appunto apparsa la massicciata, e ricostruire da questo lato la misura del plateau gettato per realizzarlo, recuperando dove possi-bile elementi atti a defi nirne la cronologia.
Anche in questo settore, sotto strati umifi cati di età moderna e un livello di breccia dello spessore di cm 15 è apparsa una sequenza di quattro interfacce (UUSS 13, 7, 15, 25). Partendo dall’alto, in successione: uno strato dello spessore di cm 20 (quota max. m 172,81 s.l.m.), composto da una miscela di terreno sabbioso e tufo unita a schegge di trachite, radi frammenti ceramici e laterizi fortemente sminuzzati e compattati; uno strato di terreno tufaceo estremamente costipato con rade schegge di trachite, radi frammenti ceramici e pochi scapoli di materiale laterizio e un altro simile al precedente per composizione ma di colore diverso. Da ultimo, un’interfac-cia a matrice sabbiosa, dello spessore di almeno 10 cm (lo scavo si è arrestato prima di raggiungere il banco di tufo), fortemente costipato e assolutamente sterile.
Le classi di materiali attestate, anfore, ceramica da fuoco, ceramica a vernice nera, balsamari, pur nella esigua presenza di forme riconoscibili, consentono di datare l’intervento alla stessa epoca della massicciata, con cui risulta appunto in fase.
Saggio VIII
Posizionato lungo la sponda S, al limite orientale dell’area di scavo, immediata-mente oltre la linea del margo meridionale della strada, e in prossimità della recin-zione delle ferrovie (uno dei pochi punti in cui era possibile allargare per verifi care la presenza di eventuali strutture) in un terreno di proprietà Masseria Grimaldi tem-poraneamente espropriato, il saggio viene aperto nella misura di m 5,50 x 3,50. La scelta di operare questo ampliamento in un punto quanto più possibile vicino alla trincea della TAV, era stata dettata anche dal fatto che durante l’intervento del 1998, nelle immediate vicinanze dell’area, erano stati individuati il mausoleo e il nucleo di sepolture minori ad esso affi ancate.
L’inizio delle operazioni ha portato all’eliminazione di uno spesso livello di in-terro della misura di m 2,50, costituito probabilmente da terreno di riporto, ricco di radici, di sporadici frammenti di tegole e laterizi ma anche di cospicui materiali di fabbrica moderna; esso presentava nella parte più bassa uno strato di breccia de-posto in maniera irregolare, con pendenza molto accentuata verso E, evidentemente
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 158
costituendo una sorta di rampa d’accesso all’area del cantiere per la trincea del treno. Tutta l’unità obliterava una serie di realtà, già descritte sopra nel paragrafo relativo allo scavo della strada: un nuovo segmento di strada basolata, un accumulo di ma-teriale lapideo e una sorta di piano pavimentale.
La strada basolata, di misura leggermente inferiore rispetto alla principale, si stacca-va da questa con orientamento all’incirca N-S e si interrompeva quasi subito dopo 1 m ca. Oltre questa misura, si registrava la presenza di un accumulo di schegge di trachite abbastanza circoscritto, orientato verso SE e indagato solo parzialmente, costituente con tutta probabilità una sottofondazione per la sistemazione di un monumento. A O di quest’ultimo, la pulizia ha permesso di riconoscere una piano pavimentale (US 14; quota max. m 170,45 s.l.m.), realizzato con terra pressata e pareti di anfore, lungo m 6 e largo m 2,70, cui era possibile accedere direttamente dalla strada.
I dati a disposizione hanno consentito così di riconoscere nella sistemazione di questa porzione di area a S del tracciato, la chiara volontà di monumentalizzare quello che sembrerebbe essere l’accesso ad una probabile necropoli privata affi an-cata alla strada, di cui il segmento basolato costituiva evidentemente l’andito e la piattaforma accessibile dalla strada, una sorta di piazzola di sosta, intervento per la cui cronologia si rimanda a quanto appunto detto sopra, nella descrizione generale dello scavo.
Saggio XII
Il saggio, della misura di m 2 x 2 è stato posizionato all’interno della platea stradale, immediatamente dopo i primi 30 m, a partire dal punto in cui la pavimentazione in basoli risultava divelta. Eseguito per avere uno spaccato della sequenza stratigrafi ca e poter recuperare dati su tecnica costruttiva e cronologia dell’impianto, esso ha portato all’individuazione di tre accurati livelli di preparazione gettati in sequenza a riempi-mento dello scasso praticato nel banco di tufo per la creazione della cassaforma.
Quest’ultimo infatti (US 10) era stato tagliato e sagomato con un profi lo con-vesso, espediente ampiamente attestato nella tecnica stradale romana per garantire il defl usso delle acque meteoriche. Al di sopra era stato gettato uno strato sabbioso (US 15) mescolato a tufo giallo, grandi schegge di trachite e materiali ceramici, dello spessore di cm 30 circa in cui è stato possibile riconoscere una sorta di statuminatio. Seguivano poi il rudus, uno strato simile al precedente per composizione, fortemen-te compattato, ma con inclusi sminuzzati, ceramica e materiale lapideo di pezzatura più piccola e il nucleus, una miscela costituita dalle stesse componenti sopra elencate ma fi nemente tritate e ribattute sulla cui summa cresta erano stati allettati i basoli della pavimentazione.
I materiali ceramici da questo saggio e dagli altri tre, praticati sempre all’interno della platea stradale (IV; V; VI), consentono di datare in maniera univoca l’impianto alla prima metà del II sec. a.C.
159L’antica via Teanum-Allifae
Ampliamento a O del saggio XIII
Durante le operazioni per l’eliminazione dello strato di breccia, in un settore grossomodo centrale rispetto all’ampiezza dell’area indagata, a N del margo che su questo versante delimita la pavimentazione riconosciuta come di primo impianto (glareata), a partire dal punto in cui la strada compie uno slargo, è apparso un pro-babile piano funerario (US 26). Esso era stato intercettato da una trincea scavata in tempi moderni che ne aveva provocato la parziale distruzione. Individuato e svuo-tato il taglio, sono apparsi, rimescolati con il materiale inerte, una serie di oggetti di indiscussa attribuzione già descritti in precedenza.
Rimosso il riempimento moderno (US 23), è apparso il banco di tufo tagliato al centro a formare le due sponde di un cavo, un antico canale (US 24) risultato poi riempito dagli stessi strati di preparazione gettati per la costruzione della strada. Orientato E-O come la strada, lungo in totale m 35,50, largo da un min. di cm 35 a un massimo di cm 75, con profondità variabile da cm 10 a un max. di cm 20, ha restituito numerosi materiali a vernice nera, la cui analisi ha confermato la cronolo-gia precedentemente proposta. Si tratta di un canale per la raccolta ed il drenaggio delle acque meteoriche affi ancato al tracciato stradale, di quelli ampiamente attestati nella letteratura archeologica sull’argomento.
Il restauro conservativoIl restauro garantisce la conservazione fi sica, prolunga la vita e recupera il mo-
dello originario del manufatto restituendogli anche una lettura più chiara, tale da essere fruibile per il pubblico. È questo l’assunto che ha guidato l’intervento sulla pavimentazione della strada: esso ha riguardato in particolar modo il ripristino della parte di platea venuta in luce mutila del lastricato e la sistemazione delle aree limi-trofe che erano state in parte interessate dalle indagini.
Concluso lo scavo e rinterrati i saggi, si è provveduto in primo luogo a recuperare parte di quei basoli che erano stati sistemati durante la campagna del 1998 sulla scarpata dell’opera TAV WBS IV 10, cui si aggiungevano quelli rinvenuti all’incro-cio con Masseria Grimaldi, forse accumulati lì perché di ostacolo alla quotidiana pratica dei campi.
Si è proceduto quindi a coprire con del tessuto non tessuto gli strati antichi, su tutta la lunghezza del tracciato della strada e a N e a S di essa.
Gettato e livellato uno strato di sabbia a grana fi ne, vi si sono fatti allettare i ba-soli partendo da quelli che consentivano per morfologia la ricostruzione del margo settentrionale del tracciato, in tutta la lunga sezione in cui esso risultava mutilo e utilizzando come guida la quota pavimentale desumibile dai pochi lacerti ancora conservati.
Una volta sistemati i basoli, si è provveduto a colare tra gli interstizi un legante costituito da una parte di calce stagionata e due parti di pozzolana ventilata, in modo da evitare il distaccamento delle pietre e consentire al tempo stesso di distinguere la
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 160
parte integrata dall’originale, provvedendo inoltre a tal fi ne a rendere le fughe della parte restaurata più larghe.
Finiti i basoli a disposizione si è provveduto alla sistemazione della residua parte di tracciato compresa tra quella restaurata e l’ultimo segmento di 30 m rinvenuto in ottime condizioni e portato alla luce fi no all’incrocio con Masseria Grimaldi.
È stata così preparata con delle assi di legno una cassaforma di ampiezza corri-spondenza a quella della carreggiata, mancando anche in questo punto i blocchi pertinenti al marciapiede che avrebbero potuto fare da argine e guida.
In sequenza, nell’area così destinata, sono stati sistemati: tessuto non tessuto, uno strato di sabbione, terra e uno spessore di 0,10 m di cemento per conferire durezza al piano. Per eliminare il pericolo di un impatto visivo poco gradevole, si effettuava in contemporanea con il getto di cemento una spolverata di breccia n. 1, materiale visivamente neutro, utile anche al drenaggio dell’acqua piovana, il cui smaltimento veniva garantito ulteriormente dalla creazione di una contropendenza che convo-gliasse l’acqua verso E, dove un canale di scolo provvedeva a far confl uire l’acqua direttamente nella canaletta che corre lungo la linea ferroviaria.
Si è passati poi alla monumentalizzazione di un tratto della strada di I fase, lasciandone in vista una sezione, costruendovi intorno un cordolo in cemento, do-tandolo di scolo per lo smaltimento dell’acqua e di una transenna per impedirne, se possibile, il calpestio.
Da ultimo sono state ripristinate le linee dei cigli lungo la strada e a margine delle proprietà a N e a S di essa, ricavando anche un nuovo ingresso per accedere al frutteto a N della strada con l’intento di fornire così un percorso alternativo che liberasse la strada dal passaggio di mezzi agricoli.
A.P.
Note* Sentiamo di rivolgere un particolare ringraziamento al dott. F. Sirano, Funzionario Responsabile dell’Uffi cio per i Beni Archeologici di Teano, per la fi ducia dimostrata nei nostri confronti e per l’occasione, offertaci in questa sede, di poter lavorare ad una prima sintesi dei dati di scavo. Le indagini sono state condotte sotto la sua direzione dagli scriventi per conto della Cooperativa Opus.1 Per l’analisi delle tracce conservate v. Chouquer, Favory 1987, 197. 2 Broccoli 1821, 152-153.3 L’erudito la chiama così perché, accennando alla rete stradale del centro sidicino, fa riferimento anche agli altri assi viari che partono da questo, ritenendoli delle semplici diramazioni della Latina, appunto “altri capi…”.4 De Monaco 1960, 79.5 Cipriano 1982, 55; Cipriano 1997, 72.6 Caiazza 1995, 57; 109-140.7 IGM F. 172 IV NE, Pietramelara.8 IGM, Carta del Regno d’Italia, Teano F. 172 IV, anno rilevamento 1876.9 Scavo condotto per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta dalla
161L’antica via Teanum-Allifae
Soc. New Archaeology, nella persona del dott. Sergio Cascella. Per i risultati di questo scavo e, più in generale, per le scoperte archeologiche effettuate nel corso dei lavori per la Linea ad Alta Velocita, si veda in questo stesso volume il contributo di G. Gasperetti.10 Dalla relazione di scavo del dott. Sergio Cascella: «Monumento a colonna in tufo grigio di Roccamonfi na composto da quattro rocchi sormontati da un capitello dorico. La colonna era così composta: 1) rocchio di base costituente il terzo non scanalato h. 1,15 m, diam. 80 cm; 2) rocchio h. 90 cm, diam. 70 cm; 3) rocchio h. 90 cm, diam. 65 cm; 4) capitello h. totale 50 cm, diam. 52 cm. Il capitello presenta un abaco dello spessore di 9 cm, per una misura laterale di 70 cm circa. L’echino, regolare, dell’altezza di 9 cm, presenta alla base almeno quattro anuli che formano una fascia di 4 cm di spessore. L’υποτρακελιον non è particolarmente marcato.L’intera colonna rimessa in piedi misurerebbe 3,45 m di altezza, con scalanature che alla base hanno una lar-ghezza di 10 cm e si rastremano verso il collarino fi no ad una misura di 8 cm. Ogni rocchio presenta al centro un incasso quadrangolare di 7,7 cm di lato costituente il foro per il sollevamento e la messa in opera del monu-mento. La base superiore dell’abaco non è liscia, mostra bensì un incasso circolare del diametro di 33 cm e della profondità di 6, che serviva per alloggiare un ulteriore elemento che connotava la colonna come σεµα funerario. Infatti, durante lo scavo, circa 1 m più a N del capitello venne in luce il vaso funerario, scolpito anch’esso in tufo e rotto in due frammenti. Si tratta di un cratere a calice alto 66 cm, perfettamente alloggiabile nell’incasso prima descritto sull’abaco, con un diametro alla base di 33 cm e un’altezza complessiva di 66 cm, simboleggiante chiaramente l’urna cineraria. Continuando lo scavo alla ricerca del plinto e dell’eventuale tomba cui essa doveva afferire, è stato possibile appurare che esso, forse un basamento rettangolare su cui era appoggiata e che la faceva spiccare sul piano di campagna circostante, fu completamente asportato durante la costruzione della rampa di accesso ai fondi agricoli circonvicini. Nonostante tutto comunque lo scavo ha portato in luce la sottofondazione in schegge di trachite su cui esso doveva appoggiare, al cui interno era incastrata una moneta bronzea in pessime condizioni, un asse, il cui verso mostra la testa di un imperatore, forse Cesare Augusto, mentre legenda e rovescio risultano completamente illeggibili. Questo tipo di monumento funerario è formato da una colonna che trova confronti con le molte attestazioni di materiale architettonico d’età tardo ellenistica e proto imperiale nell’area pompeiana. Tipologicamente questo tipo di monumento mostra la volontà del defunto di rivendicare il proprio potere e un sentimento di autorappresentazione tipico del periodo tardo repubblicano. In base ai confronti e alla moneta posta nella fondazione sembrerebbe databile a epoca augustea; non contrasterebbe infatti l’uso dello stile dorico che è invece coerente con il sentimento di restaurazione dell’età di Augusto».11 Solo in epoca recente, come osservato in precedenza, il tracciato è stato nascosto da uno strato di breccia.12 Esempi di questo tipo sono attestati in molti contesti dell’Italia centro settentrionale, per i quali cfr. Tecnica stra-dale romana, 1992; in particolare sulle strade glareate, nello stesso volume, il contributo di J. Ortalli, 147-161.13 Del canale non vi è traccia almeno nei primi 30 metri dove due saggi condotti lungo il ciglio hanno evi-denziato invece la presenza della massicciata di contenimento che nei livelli di preparazione era stata gettata direttamente sul banco di tufo, la cui superfi cie appariva semplicemente regolarizzata.14 Vallat 1981, 290-292.15 La natura non sempre chiara dei rapporti stratigrafi ci in un’aria così devastata dal passaggio dei mezzi mec-canici e coperta inizialmente solo da un esiguo spessore di breccia, consente soltanto di dire che la sepoltura venne sistemata dopo la realizzazione del tracciato. Indisturbata sul lato N, dove era provvista da una sorta di inzeppatura realizzata con scapoli di trachite e di tufo grigio che rincalzavano le lastre, va rilevato che sul lato S essa aveva due dei tre lastroni che costituivano la copertura fratti e ripiegati su se stessi.16 Nello specifi co: quattro saggi nella platea stradale, (IV; V; VI; XII), quattro nella crepidine (III; VII; IX; X), due nella massicciata di contenimento (I; II), gli altri ai lati della strada lungo tutto il suo percorso (VIII; XI; XIII; XIV). Le loro dimensioni sono state di volta in volta condizionate dallo spazio a disposizione nei punti in cui il lastricato non si conservava.17 I contadini ci hanno informato del fatto che buona parte del terreno risultato dagli scassi effettuati nell’area per le opere da realizzare, venne scaricato sulle proprietà limitrofe dietro compenso determinando una parziale modifi ca delle quote dell’originario piano di campagna.
Nuovi documenti per la conoscenza della necropoli alifana di Conca d’Oro
Gianluca Tagliamonte
I lavori di ricerca e di studio fi nalizzati alla redazione e alla realizzazione del pro-getto di allestimento scientifi co dell’istituendo Museo Archeologico dell’antica Alli-fae hanno consentito di acquisire diversi nuovi dati, utili a una migliore conoscenza della storia e dell’archeologia alifana. Fra gli elementi di novità, alcuni attengono propriamente alla storia della ricerca archeologica condotta nel territorio del centro matesino e, più in particolare, alla vicenda che di quella storia è stata a tutt’oggi il momento più rilevante e signifi cativo: le campagne di scavo effettuate tra il 1880 e il 1884 dall’oriundo svizzero Giovan Giacomo Egg nella necropoli situata in località Conca d’Oro, nel territorio dell’allora Piedimonte d’Alife.1
Proprio in riferimento a questa vicenda, di un qual certo rilievo appaiono infatti i risultati di una ricerca di tipo archivistico intrapresa dal sottoscritto2 nell’ambito di un più generale studio sulla storia dell’esplorazione archeologica nell’area alifana. In attesa che tale studio sia completato e se ne possa quindi dare adeguato resoconto scientifi co, in questa sede, aderendo all’invito rivoltomi dall’amico e collega Fran-cesco Sirano, si intende fornire una breve e del tutto provvisoria anticipazione di taluni dei risultati cui la summenzionata ricerca ha portato. In sostanza, ci si limiterà qui a rendere nota la documentazione grafi ca e fotografi ca acquisita e a segnalarne l’importanza, senza entrare nel merito specifi co delle questioni. Queste verranno affrontate dallo scrivente in un futuro studio, al quale si rinvia pertanto il lettore che sia interessato ad approfondire le tematiche connesse all’archeologia preromana dell’area alifana.
Come è noto,3 gli scavi archeologici condotti da Giovan Giacomo Egg, pronipote dello svizzero Johann Jakob Egg, fondatore dell’omonimo cotonifi cio di Piedimonte d’Alife,4 vennero uffi cialmente iniziati dietro formale autorizzazione rilasciata dal Prefetto Agostino Soragni, Presidente della Commissione Conservatrice dei Monu-menti ed Oggetti di Antichità e Belle Arti nelle Province di Terra di Lavoro, in data 11 febbraio 1880.5
Nel corso del mese di gennaio del 1880 erano stati infatti condotti in località Conca d’Oro, in un fondo di proprietà di Giovan Giacomo Egg6 e della moglie Ber-ta Secunda Leiner,7 lavori agricoli che avevano portato al rinvenimento, certo non inatteso, di numerosi reperti antichi. Tra il 30 gennaio e il 4 febbraio 1880 si misero
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 164
in luce tre tombe a cassa di tufo, di cui una con cospicui resti di pitture funerarie, recanti scene fi gurate;8 ulteriori sepolture, fra le quali un paio integre (una del tipo a cappuccina, l’altra a semplice fossa terragna), furono esplorate tra il 5 e il 6 febbraio. Su tali ritrovamenti siamo ora informati, oltre che dalla breve relazione redatta dal locale Ispettore Onorario, Mattiangelo Visco ed edita da G. Fiorelli in Notizie degli Scavi di Antichità del 1880,9 anche da una tavola (fi g. 1) illustrante buona parte dei materiali recuperati, conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma e realizzata dallo stesso Visco.10 Pur con i limiti dovuti alla dispersione dei materiali in questione e al carattere della documentazione grafi ca prodotta, sono questi alcuni dei pochissimi ritrovamenti, fra quelli effettuati da Egg, per i quali disponiamo di un qualche dato di contesto e di associazione.
A seguito dei primissimi rinvenimenti, Giovan Giacomo Egg fornì, con nota del 31 gennaio 1880, comunicazione di tali scoperte alla suddetta Commissione, pre-sentando altresì richiesta di autorizzazione alla continuazione degli scavi. Esaminata nella tornata del 4 febbraio 1880, tale richiesta venne positivamente accolta e quindi autorizzata nel rispetto delle normative allora vigenti e alle condizioni che i lavori si svolgessero sotto il controllo del già citato Ispettore Onorario, Mattiangelo Visco; una relazione settimanale, redatta dallo stesso Egg, avrebbe dovuto inoltre informa-re i membri della Commissione circa gli esiti dello scavo e lo stato di avanzamento degli stessi.11 Gli scavi vennero immediatamente ripresi e si protrassero, con fortunati
Fig. 1 - Alife, loc. Conca d’Oro: materiali archeologici dagli scavi di G.G. Egg (30/1-6/2 1880).
165Nuovi documenti per la conoscenza della necropoli alifana di Conca d’Oro
ritrovamenti, sino al novembre di quell’anno. Alla prima fecero seguito, sempre per iniziativa di Giovan Giacomo Egg, altre campagne di scavo, sino al 1884.
Le ricerche, condotte con modalità e tecniche che in buona sostanza disattende-vano le normative che l’Amministrazione dello Stato neounitario andava in quegli anni defi nendo,12 evidenziarono comunque la particolare rilevanza che la testimo-nianza della necropoli sannitica (ma anche romana) dell’antica Allifae andava assu-mendo nel quadro delle ancora scarse conoscenze che della Campania preromana allora si avevano. Tali ricerche portarono, peraltro, al rinvenimento di quella messe di materiali sui quali più che dalle brevi relazioni pubblicate nelle Notizie degli Scavi di Antichità13 e negli Atti della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti di Antichità e Belle Arti nelle Province di Terra di Lavoro,14 e oltre che da inedita do-cumentazione d’archivio, siamo informati soprattutto dall’importante articolo edito da Enrico (Heinrich) Dressel negli Annali dell’Instituto di Corrispondenza Archeolo-gica del 1884.15
In quest’ultimo lavoro erano specialmente i materiali rinvenuti nel corso della prima campagna di scavo (gennaio/febbraio-novembre 1880), di certo quella più fruttuosa in termini quantitativi, ad essere esaminati dallo studioso germanico. Ed in effetti, gran parte dei non molti riferimenti bibliografi ci esistenti sull’esplora-zione di Conca d’Oro, per limitarci all’edito, riguarda proprio questa prima fase dell’esplorazione della necropoli, i cui risultati ebbero notevole eco non solo tra gli studiosi ma anche tra un più vasto pubblico, come dimostra l’attenzione riservata alle scoperte alifane dalla stampa locale e nazionale dell’epoca.16
Il contributo che le relazioni di Egg e Visco (edite da Giuseppe Fiorelli)17 e, soprattutto, di Dressel (quest’ultima particolarmente rilevante per informazioni e osservazioni in essa contenute) arrecano alla conoscenza dell’evidenza archeologica funeraria proveniente da Conca d’Oro e, più in generale, alla ricostruzione delle più antiche fasi della storia alifana, trova forti limitazioni nelle modalità con le quali vennero condotti gli scavi (vedi oltre); nella successiva dispersione di massima parte dei reperti rinvenuti;18 nella brevità dei resoconti (fatta eccezione per quello di Dres-sel); nella genericità delle descrizioni proposte per i singoli oggetti, nonché nella penuria di dati (indicazioni di provenienza, misure, ecc.) a essi relativi; nell’uso di un lessico tecnico, oggi obsoleto, talora scarsamente connotato e comunque tale da rendere non di rado problematica la possibilità di un’identifi cazione puntuale dei reperti stessi; nella ridottissima o inesistente presenza di apparati grafi ci e fotografi ci posti a corredo delle pubblicazioni sopra ricordate.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, in particolare, se si eccettuano le due tavole d’aggetto (O, P) allegate all’articolo di Dressel19 e recanti la riproduzione gra-fi ca (a diversa scala) di poco meno di una trentina (28, per la precisione) di oggetti, fi ttili e metallici, recuperati negli scavi Egg (quasi tutti in occasione della prima campagna, quella del 1880), praticamente null’altro era noto sino ad oggi, per lo meno in sedi di carattere scientifi co.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 166
A integrare una così scarna do-cumentazione grafi ca concorrono fortunatamente, oltre alla già men-zionata tavola di illustrazioni (fi g. 1) allegata alla relazione di Visco,20 anche altre testimonianze grafi che e fotografi che, sinora poco o affatto note, o del tutto inedite, che si è avuto modo di recuperare nel cor-so della ricerca archivistica fi n qui effettuata.
Preziose sono certamente le due belle tavole disegnate dall’artista calabrese Giuseppe Cosenza per l’articolo di Nicola Lazzaro, ap-parso su L’Illustrazione Italiana del 28 gennaio 1881.21 A una veduta prospettica di una delle trincee di scavo (“fossi”, “cavamenti”, nella terminologia dell’epoca) eseguite nel terreno Egg si associa, in una delle due tavole (fi g. 2), nella parte inferiore della stessa, una selezione dei materiali ceramici più signifi -
cativi rinvenuti nel corso dell’anno 1880.22 Interessanti pure le immagini presenti nell’altra tavola, nella quale vengono illustrate le varie fasi di scavo di alcune tombe della necropoli alifana, due delle quali esplicitamente menzionate nell’articolo di Dressel: si tratta, in un caso, di una tomba a cassa in lastre di tufo con copertura a doppio spiovente e consistenti resti di decorazione fi gurata dipinta, scoperta il 31 gennaio 1880;23 nell’altro, di una tomba alla cappuccina nella quale Dressel ricono-sceva un bustum sepulchrum.24
Le illustrazioni relative alla tomba dipinta vennero successivamente riprese da Fritz Weege, nel suo fondamentale studio sulla pittura funeraria osca pubblicato nello Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts del 1909.25 Solo in anni recen-ti, poi, la tavola originale (fi g. 3), recante oltre ai rilievi, anche gli schizzi misurati delle due sepolture, è stata rinvenuta nella documentazione confl uita nell’Archivio Centrale dello Stato ed edita da Emanuele Romeo, in un interessante articolo,26 tuttavia non esente da talune imprecisioni. Dallo stesso Romeo27 è stata, inoltre, resa nota una fotografi a (fi g. 4) rinvenuta nella medesima documentazione d’archi-vio: si tratta in questo caso, di un’immagine anch’essa relativa allo scavo del 1880, molto simile a quella riprodotta nell’illustrazione di G. Cosenza sopra menzionata.
Fig. 2 - L’Illustrazione Italiana, 28-1-1881: gli scavi di G.G. Egg ad Alife, loc. Conca d’Oro (anno 1880).
167Nuovi documenti per la conoscenza della necropoli alifana di Conca d’Oro
Interessante notare in entrambe le immagini, la presenza, tra la manovalanza impe-gnata nello scavo, di donne, relegate, come di norma all’epoca, a mansioni del tutto secondarie, ovvero essenzialmente a quelle di portatrici dei “cofani” contenenti il terreno rimosso.
Considerata l’esiguità dell’apparato iconografi co sinora noto in relazione agli scavi Egg, e tenuto conto della successiva dispersione dei materiali archeologici rin-venuti in quelle indagini, si capisce, pertanto, il valore che assume, sia dal punto di vista storico che soprattutto da quello documentario, la serie di sette28 belle immagi-ni fotografi che in bianco e nero recuperata presso l’Archivio Centrale dello Stato29 e conservata in copia all’Archivio fotografi co dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma.30 A queste, peraltro, sono adesso da aggiungere anche altre due simili imma-gini già conservate presso la sede dell’Associazione Storica del Medio Volturno a Pie-dimonte Matese e ora esposte nel Museo Civico “R. Marrocco” di quella cittadina.31 Tutte le immagini che si presentano in questa sede sono tratte da lastre fotografi che e sono, tranne una,32 inedite, almeno a quel che consta.
Fig. 3 - Alife, loc. Conca d’Oro, scavi G.G. Egg (anno 1880): “riproduzione delle diverse tombe scoperte”.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 168
Da subito, appare evidente il notevole contributo che esse arre-cano ai fi ni di una migliore defi ni-zione delle facies culturali preroma-na e romana attestate dai materiali archeologici recuperati nel corso delle esplorazione condotte da Egg nella necropoli di Conca d’Oro, in particolare per quanto riguarda quelli rinvenuti durante la prima campagna di scavo. Sulla base di quanto è stato possibile appurare a un primo esame della documenta-zione d’archivio, e coerentemente
con la descrizione fatta di quei rin-venimenti da Dressel (oltre che, in
modo assai più sbrigativo, dallo stesso Egg e da Visco), gli originali delle fotografi e in questione parrebbero infatti essere stati realizzati, nella proprietà Egg, nell’au-tunno del 1880, a ultimazione (o quasi) della prima campagna di scavo. Di certo, copia delle fotografi e fu inviata, come si evince dalla lettura della medesima docu-mentazione, da Egg tanto all’allora competente Ministero della Pubblica Istruzione, quanto allo stesso Fiorelli, in data 17 novembre 1880.33
Proprio questa serie di fotografi e, alle quali del resto fanno esplicito riferimento sia Fiorelli34 che Giulio Minervini,35 parrebbe notevolmente avere contribuito a sol-lecitare l’interesse di studiosi e appassionati dell’epoca sulle scoperte alifane, nonché avere costituito una importante fonte di conoscenza e informazione su quei medesi-mi ritrovamenti (unitamente ai resoconti di scavo). Non a caso è ad esse che fanno riferimento diversi degli interlocutori con i quali Egg intrattenne corrispondenza negli anni 1880-1884; nello stesso carteggio che legò Dressel a Egg, nel periodo compreso fra la venuta dello studioso germanico a Piedimonte d’Alife (1880) e la pubblicazione del suo articolo (1884), in più occasioni il puntuale richiamo, da parte di Dressel, agli oggetti riprodotti nelle fotografi e rappresenta il modo più sem-plice per identifi care i pezzi prescelti per essere disegnati e destinati poi a comparire nelle due tavole d’aggetto (O, P) allegate al suo lavoro. Essendo quest’ultimo, pe-raltro, essenzialmente incentrato sul resoconto e sull’analisi dei materiali rinvenuti nel corso della prima campagna di scavo condotta da Egg a Conca d’Oro, si può tranquillamente affermare che la serie di fotografi e che qui si presenta costituisce un prezioso e necessario complemento iconografi co all’articolo di Dressel, che, per l’appunto, proprio grazie al supporto di queste immagini diviene più esplicito e perspicuo, acquisendo maggiore chiarezza e precisione nei contenuti.
Le fotografi e in questione, tutte – è ovvio – in bianco e nero, sono di eccellente
Fig. 4 - Alife, loc. Conca d’Oro, scavi G.G. Egg (anno 1880): “veduta degli scavi”.
169Nuovi documenti per la conoscenza della necropoli alifana di Conca d’Oro
Fig. 6 - Alife, loc. Conca d’Oro, scavi G.G. Egg (anno 1880): “oggetti fittili diversi”.
Fig. 5 - Alife, loc. Conca d’Oro, scavi G.G. Egg (anno 1880): “oggetti fittili, grandi ed ordinarî”.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 170
qualità, realizzate presumibilmente dallo stesso Egg, appassionato di fotografi a.36 Le immagini sono suffi cientemente nitide e mostrano una buona messa a fuoco, che consente, peraltro, di apprezzare taluni particolari degli oggetti ritratti, sui quali già Dressel aveva soffermato la propria attenzione. Il punto di ripresa fotografi ca dei materiali archeologici alifani (ceramiche e oggetti in metallo, per lo più) è sempre frontale. La fonte di illuminazione è posta in alto rispetto agli oggetti fotografati: su questi la luce cade morbida, diffusa in modo piuttosto uniforme. Gli oggetti sono raggruppati, come si dirà anche in seguito, per classi di materiali o categorie, secon-do quelli che erano i dettami all’epoca ancora più in voga.37 I reperti sono allineati su espositori in legno a più piani, appositamente realizzati, a quel che sembra, e ri-coperti, almeno nel caso del vasellame ceramico e metallico, da un telo di stoffa con
Fig. 7 - Alife, loc. Conca d’Oro, scavi G.G. Egg (anno 1880): “oggetti di bronzo”.
171Nuovi documenti per la conoscenza della necropoli alifana di Conca d’Oro
motivo a scacchiera. I quadrati di quest’ultimo, che parrebbero misurare tra i 4 e 5 cm di lato, fungono forse da riferimento metrico utile a valutare la grandezza degli oggetti collocati sul telo stesso. In tutte le fotografi e, che parrebbero eseguite in un interno, è inoltre presente un fondale, a tinta unita, di media luminosità.
È interessante notare, in una prospettiva di storia della fotografi a archeologica, che la realizzazione di questa serie di immagini si pone in un momento in cui, nell’ambito dell’archeologia italiana e con particolare riferimento ai monumenti di Roma e della Campagna Romana, si andava sperimentando e sempre più affer-mando il ricorso al mezzo fotografi co come prezioso strumento di supporto e di documentazione dell’indagine archeologica. Peraltro, di questo crescente interesse verso le possibilità offerte dal nuovo mezzo fa fede la pubblicazione, appena un anno
Fig. 8 - Alife, loc. Conca d’Oro, scavi G.G. Egg (anno 1880): “oggetti di bronzo”.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 172
prima l’inizio degli scavi Egg, del primo manuale di fotografi a archeologica, redatto da Eugène Trutat.38
Le sette fotografi e qui presentate mostrano, come prima si accennava, i materiali archeologici rinvenuti nel corso della prima campagna di scavo (1880) condotta da Egg nel suo fondo di Conca d’Oro. L’ordinamento degli oggetti, così come ci appa-re dalle foto, rifl ette le scelte messe in atto, dallo stesso Egg, nel corso dello scavo. Queste risultano essenzialmente improntate a un criterio di raccolta e suddivisione dei reperti per categorie e classi di materiale, tale da portare allo smembramento dei contesti funerari alifani e alla perdita dei dati di associazione (oggi solo in minima parte recuperabili sulla base delle indicazioni fornite da Dressel e, ancora meno, da Egg e Visco). Quantunque ancora largamente in auge negli ambienti archeologici italiani del periodo, tali scelte contravvenivano comunque le prescrizioni emanate tra il 1865 e il 1877 a cura del Ministero per la Pubblica Istruzione, nelle quali si faceva esplicito riferimento alla necessità di procedere alla registrazione dei dati di contesto.39 Lo stesso Dressel, del resto, ebbe modo di stigmatizzare in tal senso il comportamento di Egg, lamentando lo smembramento dei corredi funerari e rac-comandando «caldamente al sig. Egg di volere in seguito rivolgere la sua attenzione anche su questo punto, e di separare rigorosamente il contenuto di ogni singola tomba, formando altrettanti piccoli gruppi».40
Fig. 9 - Alife, loc. Conca d’Oro, scavi G.G. Egg (anno 1880): “oggetti di rame”.
173Nuovi documenti per la conoscenza della necropoli alifana di Conca d’Oro
Si è già richiamata la notevole importanza che, a livello documentario, le fotogra-fi e in questione rivestono ai fi ni di una migliore conoscenza della cultura materiale esibita nei corredi della necropoli di Conca d’Oro, specie di quelli preromani. Del potenziale informativo che esse in tal senso racchiudono, qui si farà solo cenno, attraverso alcune esemplifi cazioni, passando velocemente in rassegna le immagini stesse. In un futuro studio se ne darà conto in modo più analitico e dettagliato.
La prima fotografi a (fi g. 5) riproduce 41 «oggetti fi ttili, grandi e ordinarî»,41 rife-ribili a ceramiche d’impasto e a contenitori da trasporto (anfore vinarie). Nei due ripiani superiori dell’espositore sono infatti presenti molti, se non tutti, gli esem-plari di vasellame d’impasto di età tardo-orientalizzante e arcaica sui quali Dressel sofferma brevemente la sua descrizione. Ne abbiamo un esempio con la lacunosa anfora ovoide, ad anse composite (munite di apofi si), con ventre rastremato solcato da costolature longitudinali (che giungono sino alla spalla), ascrivibile alla produzio-ne del cosiddetto bucchero rosso:42 abbastanza accuratamente descritta da Dressel (che la inserisce tra i vasi di “bucchero locale”),43 essa è peraltro riprodotta tanto nella Tavola d’aggetto O dell’articolo di Dressel44 quanto in una delle due illustrazioni di Cosenza (fi g. 2).45 Ad ogni modo, le classi rappresentate sono quelle comuni nella media valle del Volturno nel periodo in questione: ceramica d’impasto bruno, piut-tosto grezzo, oppure lustrata (“buccheroide”); a superfi cie rossa, lustrata a stecca (“bucchero rosso”); forse, bucchero campano o di produzione locale.
Nella parte in basso della medesima fotografi a 5, poggiate o addossate ai ripiani inferiori dell’espositore, sono riprodotte sei anfore vinarie, con i resti di una settima
Fig. 10 - Alife, loc. Conca d’Oro, scavi G.G. Egg: estremità di cinturone “sannitico” (da Dressel 1884 a, tavola d’aggetto P).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 174
(una ottava è collocata sul terzo ripiano, a partire dal basso): due di esse (una di Mende – a quanto sembra – e una greco-italica antica del tipo MGS V) appaiono anche nella appena menzionata illustrazione di Cosenza. In questo caso, il valore documentario della fotografi a 5 è particolarmente rilevante, se si tiene conto della sbrigativa trattazione che di tali materiali fornisce Dressel (per quanto paradossale possa apparire tale affermazione!), che si limita a segnalarne la presenza, senza pe-raltro aggiungere alcun elemento descrittivo utile a una eventuale identifi cazione tipologica degli stessi. Quest’ultima è resa possibile proprio grazie alle indicazioni desumibili dalla fotografi a 5: in tal senso, sembra sin da ora di potere dire che i dati alifani appaiono sostanzialmente coerenti con quello che è il quadro di attestazione e di circolazione delle anfore vinarie nella Campania settentrionale tra la fi ne del V o gli inizi del IV sec. a.C. e la prima età imperiale romana.46 Tali presenze trovano pe-raltro riscontro anche nei risultati di scavi successivamente condotti nelle necropoli alifane, anche in anni recenti e nella stessa località di Conca d’Oro.47
Alla ceramica è riservata anche la seconda fotografi a (fi g. 6). In questa sono ripro-dotti circa 150-160 vasi di varie dimensioni. I pezzi sono collocati a terra e sui sei ripiani dell’espositore: essi paiono accostati in base a criteri morfologici e di disposi-zione simmetrica degli oggetti rispetto a un asse centrale, segnato da oggetti di gran-di dimensioni. Nel complesso, gli esemplari in questione documentano le diverse classi vascolari, decorate e non, in voga nei corredi funerari alifani fra il V sec. a.C. e l’età romana, con una particolare concentrazione di attestazioni riferibili alla fase di
Fig. 11 - Roma, Museo Nazionale Romano, Collezione Gorga, inv. n. 276142: estremità di cinturone “sannitico” da Alife, loc. Conca d’Oro, scavi G.G. Egg
(foto e restituzione grafica da Sannibale 1998, 192).
175Nuovi documenti per la conoscenza della necropoli alifana di Conca d’Oro
IV sec. a.C. Anche in questo caso è fi n troppo evidente il carattere di indispensabile supporto alla sommaria descrizione, fatta di taluni di questi pezzi da Dressel, che questa testimonianza assume. Spiccano al centro della fotografi a un grosso calderone bronzeo, con vasca emisferica e ansa mobile in ferro, e più in basso, un grande bacile a orlo perlinato, contenente al suo interno un più piccolo bacile, pure bronzeo. Di tale vasellame bronzeo Dressel non parrebbe tuttavia fare menzione a proposito dei materiali rinvenuti negli scavi terminati nel novembre del 1880.48
Le successive fotografi e (fi gg. 7-10) si riferiscono ai materiali metallici (in bronzo e in ferro, ma anche in argento, per lo meno nel caso di anelli e fi bule, queste ultime talora placcate in oro) rinvenuti nei corredi alifani. I limiti di spazio assegnati ai sin-goli contributi che compongono questo volume non consentono di soffermarsi in una descrizione, neppure sommaria, di tali immagini. Pertanto, si accennerà appena al loro contenuto, aggiungendo solo qualche rapidissima annotazione.
La terza fotografi a (fi g. 7) bene documenta l’ampio e articolato quadro di attesta-zione tipologica delle fi bule (in bronzo, ferro, argento) in uso presso la comunità ali-fana tra la seconda metà dell’VIII e la fi ne del IV sec. a.C. Tra i vari tipi attestati (ad arco serpeggiante o a drago, a drago con apofi si a ghiande, a navicella, a tre bottoni ed apofi si all’estremità della staffa, ad arco semicircolare, ecc.) spicca, per l’alta an-tichità (è ipotizzabile una datazione alla seconda metà dell’VIII sec. a.C.), la grande
Fig. 12 - Alife, loc. Conca d’Oro, scavi G.G. Egg (anno 1880): “oggetti di ferro”.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 176
fi bula a drago, con arco serpeggiante (decorato da un “tubicino” trasversale munito di apofi si), molla e attacco dell’ardiglione bifi do, già descritta e riprodotta da Dres-sel,49 e, forse presente anche con un secondo, ma più frammentario, esemplare.
Altre fi bule in ferro compaiono nel ripiano inferiore dell’altro espositore ritratto nella medesima fotografi a (fi g. 8). Ma qui sono soprattutto gli strumenti bronzei da toeletta a essere illustrati, con particolare riguardo a nettaunghie e cosiddetti auri-scalpia, attestati ad Alife in una quantità e varietà che trova pochi confronti nell’Ita-lia antica. Non mancano, ad ogni modo, pinzette a molla e una singola pinza con snodo, nonché alcuni isolati ganci “a cicala” riferibili a cinturoni a fascia rettangolare in lamina bronzea di tipo “sannitico”.
Di questi ultimi viene data ampia illustrazione nella quarta fotografi a (fi g. 9), tanto in riferimento a singoli ganci di chiusura o a frammenti di lamina quanto a esemplari pressoché integralmente conservati. Merita, in particolare, di essere segna-lata la presenza, all’estremità destra del ripiano superiore dell’espositore, della parte terminale di un cinturone, con decorazione a lamina lavorata a giorno, ornato, fra l’altro, da una protome bovina. Il pezzo, già segnalato e illustrato da Dressel50 (fi g. 10), è stato di recente rinvenuto e identifi cato (fi g. 11) da Maurizio Sannibale51 tra i materiali confl uiti nella Collezione Gorga custoditi al Museo Nazionale Romano di Roma, circostanza questa che, peraltro, apre nuove prospettive di ricerca sui
Fig. 13 - Alife, loc. Conca d’Oro, scavi G.G. Egg (anno 1880): “vetri, gioielli, ornamenti ecc.”.
177Nuovi documenti per la conoscenza della necropoli alifana di Conca d’Oro
possibili esiti della dispersione dei materiali alifani provenienti dagli scavi Egg. Un interessante specchio bronzeo con disco circolare e manico fuso desinente a protome animale52 e alcuni esemplari (due olpai, un bacile, un colino) di vasellame bronzeo tardo-arcaico completano l’immagine.
Ancora oggetti in metallo, in questo caso in ferro, compaiono nella quinta foto-grafi a (fi g. 12). Si tratta per lo più di armi offensive, in pratica quasi tutte punte di lancia e di giavellotto, fra le quali spicca, al centro dell’immagine, la grande cuspide (45 cm di lunghezza) con lunga immanicatura a cannone e lama foliata, rinvenuta peraltro in una tomba infantile.53 Sono altresì riconoscibili un pugnale con impu-gnatura a codolo, un paio di coltelli, uno o due scalpelli, alari (presumibilmente in piombo), altri oggetti (attrezzi) di più incerta o problematica identifi cazione, non-ché numerosi chiodi (di varia dimensione) verosimilmente pertinenti, come altri elementi, alla presenza di casse, sarcofagi o apprestamenti lignei nelle sepolture.
Carattere molto più eterogeneo hanno i materiali che compaiono nella sesta fotografi a (fi g. 13). Accanto a numerosi oggetti di ornamento personale in bronzo (collari in verga con estremità desinenti a ricciolo, bracciali, armille, fermatrecce, anelli digitali, una châtelaine, ecc.), sono qui, nel complesso, riprodotti buona parte
Fig. 14 - Alife, loc. Conca d’Oro: crani umani (norma frontale) dagli scavi G.G. Egg.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 178
di quei monili e reperti che vanno per lo più identifi cati fra i materiali che Dressel menziona e cataloga nei paragrafi del suo lavoro dedicati ai “Pesi da telaio, fusaruole ed altri simili oggetti”, “Pietra dura (scarabei)”, “Vetro (balsamai e vaghi da colla-na)”, “Varia (Electron, ambra, corallo, conchiglia, denti di cinghiale, osso)”.54 Come per la precedente fotografi a, anche per i materiali che fi gurano in questa non si di-sponeva di alcuna attestazione iconografi ca nello scarno dossier grafi co e fotografi co sinora noto.
Un cenno, infi ne, alle due fotografi e (fi gg. 14-15) oggi esposte nel Museo Civico “R. Marrocco” di Piedimonte Matese: l’interesse è qui rivolto al dato antropologi-co, dal momento che esse ci restituiscono la veduta (norma) frontale e laterale di sei teschi provenienti dalle sepolture di Conca d’Oro, evidentemente quelli meglio conservati, in apparente connessione anatomica.
Note1 Denominazione poi mutata, dal 1970, in quella, attuale, di Piedimonte Matese.2 Presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, l’Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, l’Archivio Comunale di Piedimonte Matese (CE), l’Archivio e la Fototeca dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma (Deutsches Archäologisches Institut Rom). Per quanto riguarda quest’ultimo, mi è gradito, in questa sede, esprimere il mio ringraziamento al dott. Thomas Fröhlich, direttore
Fig. 15 - Alife, loc. Conca d’Oro: crani umani (norma laterale) dagli scavi G.G. Egg.
179Nuovi documenti per la conoscenza della necropoli alifana di Conca d’Oro
della Biblioteca dell’Istituto, e alla dott.ssa Sylvia Diebner, responsabile della Fototeca, nonché alla dott.ssa Marion Menzel, sua valida collaboratrice, per l’aiuto fornitomi nella ricerca e nella riproduzione della docu-mentazione fotografi ca in questione. 3 Sulla storia dell’esplorazione archeologica nella necropoli alifana di Conca d’Oro si vedano, al momento, Toc-co Sciarelli 1984, 175-177 e Lista, Ziviello 1991, 40-43.4 Giovan Giacomo Egg nacque a Piedimonte d’Alife nel 1840 e morì a Zurigo nel 1923. Sulla sua fi gura, sul ruolo della famiglia Egg nella storia e nell’economia matesina dell’Ottocento, nonché sulle vicende dell’impor-tante cotonifi cio (la cui produzione ebbe avvio agli inizi del 1813), indicazioni in Il cotonifi cio Egg di Piedimonte d’Alife, Piedimonte Matese 1996, passim. Sulle attività di acquisizione di materiali archeologici per conto e a favore della Società Antiquaria di Zurigo ad opera di Johann Jakob Egg, vedi Isler 1970 e Isler 1973. Proprio tali attività, combinandosi al dato della omonimia col pronipote, hanno generato non poca confusione circa la sorte dei materiali rinvenuti da Giovan Giacomo Egg negli scavi di Conca d’Oro e il loro possibile arrivo nelle collezioni museali zurighesi.5 Come si evince dalla inedita documentazione d’archivio e dai verbali delle tornate del 4 febbraio, del 10 marzo e del 7 aprile 1880, editi in Atti Terra di Lavoro 11, 1880, 15, 25, 34.6 Il terreno in questione era stato acquistato, a quanto pare, nel 1877, apparentemente allo scopo di impiantarvi un vigneto; alla luce della documentazione d’archivio, sembra di potere dire che a motivare i lavori agricoli nel fondo, da parte di Giovan Giacomo Egg, siano stati anche (e, forse, soprattutto) intenti acquisitivi, esplicitamente riferiti al possibile ritrovamento di materiali archeologici nell’area: A(rchivio) C(entrale dello) S(tato), M(inistero) P(ubblica) I(struzione), Dir(ezione) Gen(erale), AA.BB.AA, I vers. (1860-1890), b. 15, fasc. 26.14.3, lettera del 12-11-1880, indirizzata da G.G. Egg a G. Fiorelli. Del resto, sin da periodi precedenti nella zona di Conca d’Oro si erano avuti rinvenimenti di interesse archeologico, anche se solo a partire dalla metà dell’Ottocento se ne iniziò ad avere puntuale registrazione (per gli anni 1852, 1877, 1878): cfr. Tocco Sciarelli 1984, 175-176 e Lista, Zi-viello 1991, 40-41. Peraltro, diverse delle sepolture messe in luce da Giovan Giacomo Egg furono rinvenute prive di corredo, in quanto già depredate: Fiorelli 1881, 169; Dressel 1884 a, 221.7 In Fiorelli 1880, 83 e Fiorelli 1881, 168 il cognome della donna, anch’ella di origine svizzera, viene erronea-mente indicato in Leiter.8 Anche nella tomba rinvenuta il 2 febbraio si riconobbero tracce di affreschi, andati però perduti: Fiorelli 1880, 170. 9 Fiorelli 1880.10 La tavola è allegata alla lettera indirizzata da Visco a Fiorelli in data 12-3-1880: A.C.S., M.P.I., Dir. Gen., AA.BB.AA, I vers. (1860-1890), b. 15, fasc. 26.14.3.11 Prescrizioni esplicitamente espresse nel verbale della tornata del 4 febbraio, edito in Atti Terra di Lavoro 11, 1880, 15.12 Si pensi, al riguardo, ai contenuti della Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1060 dell’11-3-1865 recante “Istruzioni per gli scavi di antichità” e al relativo Regolamento attuativo, emanato con Regio Decreto n. 3660 del 18-1-1877: Guzzo 1993, 58 segg. (con ulteriori rinvii alla bibliografi a).13 Fiorelli 1880 e Fiorelli 1881.14 Cfr. supra nt. 5. 15 Dressel 1884 a.16 In particolare, come ricorda Dressel 1884 a, 220, nt. 1, grazie agli articoli pubblicati da Nicola Lazzaro nel quotidiano «Roma» del 31-1-1880 e del 2-1-1881, e, con il titolo, I nuovi scavi sannitici e la Conca d’Oro, ne L’Illustrazione Italiana del 28-1-1881 (quest’ultimo corredato di due tavole realizzate da G. Cosenza). Delle scoperte alifane diedero notizia anche i Diarii Napoletani e altri quotidiani e riviste, non solo italiane, dell’epo-ca, come si ricava dalla documentazione d’archivio (ad es., nella lettera del 24-9-1880, indirizzata da Visco a Fiorelli: A.C.S., M.P.I., Dir. Gen., AA.BB.AA, I vers. [1860-1890], b. 15, fasc. 26.14.3). 17 Fiorelli 1880 e Fiorelli 1881.18 Cfr. al riguardo Isler 1970 e Isler 1973; Tocco Sciarelli 1984, 176; Lista, Ziviello 1991, 31, 41-42. 19 Dressel 1884 a.20 Cfr. supra nt. 10.21 Cfr. supra nt. 16.22 In tutto, 16 pezzi, dei quali un paio già riprodotti nella tav. O, nn. 2 e 16, di Dressel 1884 a.23 Dressel 1884 a, 229 n. 3. Del rinvenimento si dà notizia già nei verbali della tornate del 4 febbraio e 10 marzo
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 180
1880, editi in Atti Terra di Lavoro 11, 1880, 15, 25, oltre che in Fiorelli 1880, 83-84. 24 Dressel 1884 a, 227-228. Successive riproduzioni dell’immagine in questione in Marrocco 1951, 65; Mar-rocco 1964, 7.25 Weege 1909, 124, fi gg, 12 a, 12 b. Oltre che da Marrocco 1951, 86 e Marrocco 1964, 7, il disegno è stato ripreso, in anni più recenti, da Benassai 2001, 107 fi g. 122.26 Romeo 1999, 103, fi g. 6.27 Romeo 1999, 103, fi g. 7.28 A queste si aggiunge una ottava immagine, costituita dalla tavola di disegni sopra ricordata (fi g. 3). 29 Le sette fotografi e, unitamente alla tavola con i disegni, sono allegate alla documentazione contenuta in A.C.S., M.P.I., Dir. Gen., AA.BB.AA, I vers. (1860-1890), b. 15, fasc. 26.14.3.30 Deutsches Archäologisches Institut Rom, negg. 80.4434-80.4439. Da questi negativi sono ricavate le stampe che qui si presentano.31 Temporaneamente riaperto al pubblico nel 2004.32 La fi g. 9, edita in Romito 1995, 15 fi g. 6.33 A.C.S., M.P.I., Dir. Gen., AA.BB.AA, I vers. (1860-1890), b. 15, fasc. 26.14.3.34 Fiorelli 1881, 168, oltre che nella corrispondenza confl uita documentazione d’archivio.35 Nel verbale della tornata del 3 marzo 1890, edito in Atti Terra di Lavoro 21, 1890, 53 segg., punto 13.36 Diversi indizi fanno ritenere che la documentazione fotografi ca relativa agli scavi del 1880-1884, prodotta da Egg (direttamente o indirettamente), sia stata ben più consistente di quanto oggi appaia o sia comunque espli-citamente testimoniato. Il recupero, nel Museo Civico di Piedimonte Matese, di altre due fotografi e riferibili a quegli scavi (fi gg. 14, 15), delle quali non vi è alcuna espressa menzione nella documentazione d’archivio (al-meno in quella fi n qui esaminata), ne è una prova. Ma soprattutto sembrerebbero farlo supporre le annotazioni contenute nel «Prospetto delle licenze di esportazione» eseguite in Napoli nel mese di ottobre del 1892: il n. 615 di tale prospetto, recante la data del 24-10-1892, si riferisce infatti alla licenza di esportazione accordata a Berta Leiner, moglie di Giovan Giacomo Egg, in procinto di lasciare l’Italia e fare ritorno a Zurigo, a seguito del tracollo economico del marito e della perdita del cotonifi cio. Tra gli oggetti per i quali B. Leiner richiede il permesso di esportazione non fi gurano reperti antichi, ma disegni, dipinti (ritratti di famiglia, paesaggi), libri e fotografi e. Queste ultime consistono in «una quantità di vedute (settanta), paesaggi e Scavi della Necropoli di Alife eseguitesi nel 1880 in fotografi a»: A.C.S., M.P.I., Dir. Gen., AA.BB.AA, Divisione Musei e Scavi (1891-1897), II vers., I parte, b. 130, fasc. 2168.3. 37 Comunque censurati da Dressel 1884 a, 235, nt. 1.38 Trutat 1879.39 Cfr. supra nt. 12.40 Dressel 1884 a, 235, nt. 1.41 Come tali li defi nisce lo stesso Egg, nella lettera del 17-11-1880 sopra ricordata (nt. 33).42 Per un sintetico inquadramento delle culture arcaiche della Media Valle del Volturno si veda Tagliamonte 20052, 70 segg., 323-324, con rinvii alla bibliografi a precedente.43 Dressel 1884 a, 233, d: «Vaso a due manichi, ognuno dei quali si compone di tre anse riunite nella parte supe-riore (uno dei manichi è ora mancante). Tutta la superfi cie del recipiente è divisa in sezioni verticali da una serie di cordoni».44 Al n. 16 della stessa. 45 Cfr. supra p. 176.46 Ringrazio la dott.ssa Lucia Casavola per i consigli e le indicazioni in tal senso fornite.47 Miele 2004a, 203; 204, fi g. 6; 206, fi g. 8; 208. 48 Successivamente sembrerebbero, ad ogni modo, essere stati rinvenuti materiali simili: Dressel 1884 a, 267.49 Dressel 1884 a, 239, tav. P, n. 3.50 Dressel 1884 a, 246, tav. O, n. 2.51 Sannibale 1998, 193-194, n. 238. 52 Segnalato da Dressel 1884 a, 247, e, presumibilmente identifi cabile con lo «specchio di bronzo con manico lavorato», recuperato in una sepoltura femminile riportata alla luce il 6 febbraio 1880: Fiorelli 1880, 84.53 Dressel 1884 a, 249.54 Dressel 1884 a, 237-238, 249-253. Cfr. anche Dressel 1884 b, 247 segg.
Allifae e il suo ager. Considerazioni sugli aspettistorici e sulle testimonianze monumentali alla
luce delle recenti indagini archeologiche*Floriana Miele
Dalle testimonianze di età preistorica alle forme di occupazione dell’epoca protostorica e preromana sannitica
In questa trattazione si intendono proporre, seppure per accenni, alcune rifl es-sioni sugli aspetti problematici che tuttora pone la ricerca archeologica su Allifae1 romana e su quello che fu nell’antichità il suo ager.
Per una migliore comprensione delle fasi di vita di età romana, è tuttavia op-portuno, in via preliminare, ricordare le coordinate cronologiche fondamentali e il contesto storico-culturale relativi alle epoche pregresse, menzionando soltanto, per i periodi preistorico e protostorico: le prime tracce di frequentazioni antropiche nella media valle del Volturno risalenti al Paleolitico medio (Musteriano), individuate nella località Pantani Fragneto, presso Prata Sannita,2 e a Mastrati di Pratella;3 i re-perti ceramici di recente rinvenuti nella piana a S di Alife, riferibili all’Eneolitico e all’età del Bronzo antico (cultura di Palma Campania),4 nonché quelli ascrivibili alla tarda età del Bronzo provenienti dalla località Starze di Raviscanina;5 e infi ne, le numerose testimonianze attestate soprattutto nelle necropoli, pertinenti all’età del Ferro (IX-VIII sec. a.C.)6 e alle fasi orientalizzante e arcaica (VII-VI sec. a.C.), quando popolazioni di lingua osco-sabellica si insediarono stabilmente in tutta la zona, costituendovi una comunità numerosa e organizzata che raggiunse l’apice del suo sviluppo in piena epoca storica, tra la fi ne del V e il IV sec. a.C.7
La contemporanea espansione di Sanniti e Romani nella valle del Volturno, importante via di penetrazione dalla pianura Campana verso l’Appennino interno, provocò poi l’inevitabile scontro, che portò allo scoppio della prima guerra sannitica (343-341 a.C.) e alla conquista, nel 326-325 a.C., degli oppida di Allifae, Callifae e Rufrae (attuale Presenzano)8 da parte dei nuovi dominatori che, durante il III sec. a.C., consolidarono progressivamente la loro supremazia nella Campania settentrio-nale.
Conclusasi la terza guerra sannitica (295-290 a.C.) con la vittoria romana a Sen-tino, nel corso della seconda guerra punica (218-201 a.C.), il territorio di Allifae fu teatro di nuove lotte tra Annibale e il console romano Fabio Massimo, il quale,
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 184
occupata un’antica roccaforte, assediò e costrinse il generale cartaginese a ritirarsi verso la Puglia.9
Da questi ultimi presupposti deriva il problema, ancora irrisolto su basi scientifi -che inoppugnabili o comprovato da incontrovertibili dati archeologici, riguardante le caratteristiche e la datazione da attribuire al primo insediamento stabile nell’area da parte dei Romani; nonché, per conseguenza, la questione del rapporto, sia spa-ziale e funzionale che sociale e amministrativo, esistente tra la nuova entità urbana o proto-urbana e le forme di frequentazione che l’avevano preceduta nel tempo.
In primo luogo, è inevitabile interrogarsi sulla relazione instauratasi tra l’eventua-le abitato di Allifae, situato nella pianura, occupato ovvero costituito dai Romani, alla fi ne del IV sec. a.C., e i centri sannitici attestati lungo il versante sud-occidentale del Matese:10 a Mandra Castellone di Capriati al Volturno, a Monte Castellone di Ciorlano, a monte Cavuto di Roccavecchia di Pratella, sito identifi cato con Calli-fae,11 ma soprattutto quelli ubicati nelle più immediate vicinanze di Alllifae. Questi ultimi consistono, come è noto, nel complesso di poderose cinte in opera poligonale collocate sul monte Cila e a Castello d’Alife, dove la tradizione di studi storici12 e studiosi di antiquaria locale13 localizzano, seppure con diversi accenti, l’oppidum sannitico citato da Livio; nonché nel sito fortifi cato, individuato sulla collina su cui fu poi eretto il castello normanno di Rupecanina, dove di recente Domenico Caiaz-za14 ha proposto di identifi care, diversamente dai predecessori, l’Allifae preromana.
Su tale punto si osserva, lasciando aperta la discussa questione sull’ubicazione di Allifae sannitica, che la prima occupazione romana nella media valle del Volturno, già documentata dalle fonti storiche (Festo, s.v. praefectura) tra la fi ne del IV e gli inizi del III sec. a.C., sotto forma di amministrazione prefettizia delle comunità san-nitiche (con la conseguente concessione ad esse della civitas sine suffragio15), avrebbe potuto, in linea d’ipotesi, ancora per qualche tempo coesistere con la sopravvivenza di alcuni centri fortifi cati d’altura, in precedenza costruiti per contrastare l’espan-sione dei Romani nell’area, ma presumibilmente abbandonati già alla fi ne del III sec. a.C.,16 se si voglia tenere fede al racconto liviano della campagna annibalica; ma soprattutto la presenza di popolazioni di stirpe latina avrebbe potuto conciliarsi con la persistenza degli abitati sannitici in pianura, anche se non si riesce tuttora a ricostruire una realistica rappresentazione fi sica delle strutture abitative e degli inse-diamenti cd. di tipo pagano-vicanici,17 che sarebbero propri della civiltà sannitica, né la loro distribuzione nella zona.
Alcuni rinvenimenti di sepolture associate a strutture abitative o forse anche cul-tuali, e con resti di murature in materiale calcareo e coperture lignee, databili tra il III e il II sec. a.C., individuate a S/S-E, a N/N-O di Alife e a N di Ailano, sembrano indicare la presenza di insediamenti diffusi sia lungo la valle del Volturno che sulla fascia pedemontana del Matese.18
Prove indirette a sostegno dell’esistenza di tali forme di occupazione e dell’ipo-tetico scenario storico prospettato potrebbero essere la continuità d’uso, dal VII al
185Allifae e il suo ager
II sec. a.C., cioè dal periodo orientalizzante e dall’età arcaica sino all’epoca elleni-stico-romana, delle necropoli attestate lungo tutto l’altipiano Matesino e la fascia collinare che va da Letino e Ailano a Piedimonte Matese sino a San Potito Sannitico, ma in particolare documentate sulle colline circostanti Sant’Angelo di Alife e Alife;19 nonché il precoce impianto, almeno a partire dal III-II sec. a.C., di abitati e ville ru-stiche20 romane nella valle fl uviale del Volturno, da porre senz’altro in concomitanza con il prolungamento della via Latina e delle sue diramazioni verso la pianura cam-pana,21 fenomeno che appare confermato dalle più recenti indagini archeologiche.
La colonia romana e il suo impianto urbano in rapporto all’organizzazione del territorio
Rimane dunque dubbio se la successiva colonia militare di Al-lifae, che coincide con il centro storico della moderna Alife (fi g. 1), fosse stata preceduta da un preesi-stente villaggio di epoca sannitica ovvero un abitato già romanizzato nel luogo stesso in cui fu impian-tata la città nel I sec. a.C. Anche su questo aspetto di carattere cro-nologico non abbiamo ancora ele-menti di certezza, allo stato attuale della ricerca archeologica, per la mancanza di testimonianze sicura-mente databili sulla base di reperti diagnostici rinvenuti al di sotto dei livelli della colonia romana, se si eccettua un frammento residuo di ceramica a vernice nera recuperato negli strati connessi alle fondazioni della cinta muraria romana e pre-cisamente della porta urbica set-tentrionale, detta di Piedimonte22 (fi g. 2). Ma, seppure secondo le sole sovrapposizioni stratigrafi che, altre evidenze potrebbero essere interpre-tate in favore della presenza di un insediamento precedente alla città coloniale, dal momento che alcune strutture murarie in opera cementi-
Fig. 1 - Alife: veduta aerea.
Fig. 2 - Alife: Porta Piedimonte, lato interno.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 186
zia, con fondazioni a sacco direttamente allettate nel terreno vergine alluvionale, sono state rinvenute, nel 1992, sotto il piano pavimentale, smantellato nel II sec. d.C., dell’ambiente con affresco in II stile pertinente alla domus scoperta in via Eren-nio Ponzio, nella proprietà Amato-Rea23 (fi gg. 3, 4 e Tav. 20). Un tratto murario in opera cementizia del tutto simile è stato peraltro messo in luce, nel 1991, sotto il
Fig. 3 - Alife, via Erennio Ponzio, proprietà Amato-Rea: pianta dello scavo con fasi.
187Allifae e il suo ager
Fig. 4 - Alife, proprietà Amato - Rea: veduta dello scavo della domus romana.
pavimento in cocciopesto di una sala, con decorazioni in IV stile su fondo bianco, nella domus scavata in Via Roma nella proprietà Mercorio-Filippelli24
(fi g. 5). Un ritrovamento analogo fu, altresì, effettuato da Dall’Osso e pubblicato da Della Corte, all’inizio del 1900, in Via Alferio25 dove, al di sotto di un atrio tetrastilo con impluvio di una domus databile alla tarda età repubblicana, furono rilevate tracce di muri in opera cementizia. L’osservazione che tali strutture abbiano orientamenti divergenti e siano state completamente rasate e obliterate dagli impianti edilizi suc-cessivi, tutti comunque databili, sulla base della tecnica costruttiva delle murature, alla deduzione della colonia romana, ma anche il rinvenimento di pitture,26 riferibili al tardo II stile sulle pareti in opus incertum della domus in proprietà Amato-Rea e su quelle in opus listatum di tufelli nelle terme pubbliche sotto la cripta della Catte-drale di Alife (fi g. 6), inducono a ipotizzare che la fondazione della colonia sia stata connessa ad una radicale riedifi cazione, forse conseguente a un evento traumatico dal punto di vista militare e politico, quale quello della conquista del Sannio e della violenta repressione operate da Silla all’inizio del I sec. a.C., piuttosto che al contra-stato clima che caratterizzò l’età triumvirale nella seconda metà dello stesso secolo. Non appare, dunque, del tutto inverosimile ipotizzare la preesistenza di un abitato preromano o romanizzato, magari circondato da un sistema difensivo ad aggere, sostituito dalla città romana.
Riguardo alla datazione da attribuire all’impianto della colonia romana e alla
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 188
Fig. 5 - Alife, via Roma, proprietà Mercorio-Filippelli: affresco in IV stile.
Fig. 6 - Alife: scavo delle terme pubbliche sotto la cripta della Cattedrale
189Allifae e il suo ager
connessa assegnazione di terre nell’agro circostante,27 considerata ora preliminare28 ora posteriore,29 ora contestuale30 alla fondazione, rimane, altresì, l’aporia esistente tra la testimonianza delle fonti31 (Lib. Col. I, 231, 332 = Front., De Col. 402, n. 7 Lachmann; Cic. de leg. agr. 2, 66), che la fanno risalire, come la vicina Saepinum, all’epoca triumvirale – tesi sostenuta da alcuni archeologi e studiosi33
–, e l’opinione di altri34 che la datano all’età sillana, collegandola alla cronologia assegnata alla cinta muraria di Allifae (fi g. 7) sulla base soprattutto delle sue caratteristiche costruttive in opus incertum 35 e su confronti tipologici con coevi sistemi di fortifi cazione, e in particolare con la conformazione delle quattro porte urbane, esistenti in area soprat-tutto laziale.
Il problema della cronologia di Allifae romana sopra ricordato non va disgiunto da quello della forma urbis ad essa attribuita. Un preciso e programmatico inter-vento, connesso ad una chiara volontà di riaffermazione militare e politico-ammi-nistrativa da parte dei Romani nel sito, appare come si è detto il presupposto del nuovo impianto urbanistico dato alla colonia militare romana e dell’organizzazione centuriale del territorio ad essa pertinente.36 Nell’agro alifano sono stati, infatti, indi-viduati dagli studiosi francesi37 due tipi di centuriazione: il primo con un modulo di m 180 per 330, pari a 6 per 11 vorsus, che risalirebbe ad epoca sannitica; il secondo con modulo di 20 actus, tipico del I sec. a.C. (fi g. 8).
Vanno menzionate come novità, a tale proposito, le tracce di strade 38 e di assi centuriali rinvenuti nel corso del 2004 nel territorio immediatamente a N e a S della
Fig. 7 - Alife: prospetti delle mura urbane.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 190
città, che si inseriscono nello schema generale a suo tempo defi nito dal Castagnoli e dallo Schmiedt per la Campania, ma che in parte ne divergono, lasciando aperta la questione sul rapporto tra le varie fasi di centuriazione individuate mediante l’ana-lisi delle fotografi e aree da parte degli studiosi di scuola francese e le evidenze effettivamente riscontrate sul terreno.
L’impianto urbano regolare,39 cd. a castrum,40 appare del resto in stretta relazione con il sistema centuriale esterno, anche se rimane ancora incerto quale ne sia la prio-rità e il rapporto reciproco dell’uno rispetto all’altro.41 Come è noto, esso è defi nito dall’incrocio di due assi principali, il decumanus maximus (lungo m 540) e il cardo maximus (lungo m 410), e da una rete regolare di strade ortogonali in corrisponden-
Fig. 8 - Alife: centuriazione romana.
191Allifae e il suo ager
za delle torri di fortifi cazione, che formano quattro fasce di m 360, pari a 3 actus, e isolati rettangolari, con un modulo costante di 300 per 180 piedi romani, pari a m 90 per 60, aventi i lati lunghi prospicienti i decumani. In particolare secondo il Sommella,42 l’impianto è generato dall’asse centuriale che corre all’esterno di Porta Roma, parallelamente alle mura, dove si trova signifi cativamente un cippo ritenuto da Pagano agrimensorio,43 il che giustifi ca il fatto che gli assi stradali principali non si intersechino perfettamente al centro della città (fi g. 9). D’altro canto nessun dato si ricava, purtroppo, dalle recenti indagini archeologiche effettuate (fi g. 10) lungo le
Fig. 9 - Alife: impianto urbano all’interno dello schema centuriale (Sommella 1988, fig. 75)
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 192
vie principali e il perimetro murario agli inizi degli anni Novanta del secolo trascor-so. Nel saggio archeologico (3 S.N.A.M.), aperto nel Largo Tenente Rolando Vitelli, è stato messo in luce l’angolo del muro interno S con paramento in opus incertum e nucleo in cementizio, pertinente alla Porta Napoli, impostata su una robusta fonda-zione cementizia allettata per m 1,60 in quattro strati di terreno naturale. All’ester-no di essa era inoltre addossata una struttura interpretabile, per la presenza in situ di una fi stula plumbea, come una vasca delimitata da tre muri perimetrali, con tracce del fondo in cocciopesto, rimasta in uso fi no alla sua defi nitiva distruzione in epoca tardo-antica. Il piano di calpestio romano è testimoniato dai resti di pavimentazio-ne, coperti da due strati alluvionali di limo e di sabbia formatisi per cause naturali, ed evidenziati davanti alla porta e all’interno dell’area il cui limite settentrionale è rappresentato dal muro della vasca.
Dopo l’obliterazione delle strutture romane seguiva una fase, con ogni probabili-tà di epoca tardo-antica e medievale, documentata dalla presenza, a S della vasca, di un piano di calpestio formato da basoli calcarei riutilizzati e direttamente appoggiati sul terreno alluvionale che ricopriva i livelli di età classica.
Fig. 10 - Alife: ubicazione degli scavi e delle evidenze archeologiche.
193Allifae e il suo ager
Nel saggio (4 E.N.E.L.) aperto a breve distanza dalla Porta Piedimonte, invece, è stato posto in luce un tratto del muro interno con paramento in opus incertum della porta urbica (fi g. 2), in relazione al quale sono stati evidenziati almeno due battuti, realizzati con brecce calcaree e frammenti di laterizi allettati in uno strato di terra mista a calce, alternati a strati di abbandono.
La sovrapposizione delle pavimentazioni stradali,44 riscontrata in prossimità delle porte urbiche, ma anche lungo la viabilità principale e in varie abitazioni private all’interno dell’area urbana, si potrebbe connettere alla necessità di soprelevare pro-gressivamente il livello di calpestio in conseguenza di consistenti accumuli di residui alluvionali.45
Per quanto concerne la cronologia della cinta muraria,46 dunque, solo ulteriori approfondimenti di indagine archeologica,47 e soprattutto lo studio complessivo e analitico delle stratigrafi e verticali, possibilmente contestuale al rilievo strumentale fotogrammetrico e al restauro strutturale, potranno consentire una lettura piena delle fasi di costruzione e di vita dell’unico monumento di Alife romana sopravvis-suto a terremoti, come quello del 346 d.C., e ad interventi antropici ricostruttivi – celebre quello di Fabio Massimo,48 rettore della provincia del Sannio e patrono degli Alifani – seguito da altri restauri ad opera dei Normanni, degli Angioini e degli Aragonesi, in epoca medievale49 e ancora moderna -, o purtroppo distruttivi, tutti avvenuti in epoca recente, come il bombardamento alleato del 1943.50 La cinta muraria, conservatasi per un’altezza media di m 7,00 dal livello stradale attuale, continua a rimanere tuttora la principale testimonianza della città romana nella sua identità storica e fi sica (fi g. 7).
Le mura includono un’area abitata di ca. 22 ettari che, per dare un’idea compara-tiva di immediata comprensione, è pari ad un terzo circa dell’estensione di Pompei, per la quale è stata ipotizzata una popolazione di ca. 6000 residenti, motivo per cui si potrebbe attribuire all’Allifae romana una popolazione di ca. 2000 abitanti, densità in effetti paragonabile a quella del centro storico attuale; dato questo che è stato soggetto ovviamente a incrementi o decrementi in rapporto alle fasi storiche di vita della città.
Mentre non è facile desumere se tutta l’area compresa nelle mura di fortifi cazione sia stata subito e del tutto occupata contestualmente all’impianto nel I sec. a.C., certamente a partire dal I sec. d.C. la città dovette avere un’espansione esorbitante dal perimetro murario, dal momento che si sono rinvenuti, inframmezzati alle aree di necropoli e agli edifi ci funerari, resti di edifi ci residenziali talora anche di un certo rilievo sui lati S ed E della cinta fortifi cata, in particolare in direzione dell’anfi teatro quasi ad integrarlo progressivamente nel tessuto urbano.51
Tale fenomeno di espansione urbanistica e demografi ca, che dovrebbe coinci-dere con l’avvento della pax augustea e la prima età imperiale romana, a partire dal I sec. d.C. e almeno sino al II sec. d.C., è del resto usuale nelle città romane e in Campania.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 194
L’organizzazione della città: l’edilizia pubblica e i quartieri abitativi privatiPer quanto riguarda, invece, l’organizzazione funzionale dell’area urbana interna,52
come in tutti i municipia romani, Allifae doveva avere il suo centro di rappresentati-vità amministrativa e di gestione del potere politico negli spazi e negli edifi ci pubbli-ci (fi g. 11), e in primo luogo nel Foro. A proposito dell’edilizia pubblica interessanti dati conoscitivi sono stati acquisiti nel corso delle ricerche archeologiche, grazie alle quali se ne può forse ipotizzare, seppure in modo ancora parziale, la distribuzione e la destinazione d’uso all’interno della cinta muraria della colonia allifana.53
Nel settore nord-orientale, si trova ancora seminterrato il criptoportico,54 già de-scritto nella letteratura antiquaria,55 costituito da tre bracci, di cui uno trasversale con direzione E-O, di m 45,65, e due perpendicolari con direzione N-S, di m 28,78; le gallerie interne sotterranee presentano due corridoi paralleli, larghi m 3,17, divisi da un muro spesso m 1,00 nel quale si aprono trenta vani di comunicazione ad arco larghi m 1,23, coperti da un soffi tto a volta e illuminati da ventuno fi nestre a bocca di lupo. Per tale struttura, attribuita ad età triumvirale, si è ipotizzata la funzione di cisterna o di sostruzione di un altro edifi cio ad uso pubblico identifi cabile, secondo lo Johannowsky,56 con il Foro.
Il rinvenimento di una pavimentazione di grosse lastre squadrate di calcare a Piazza Termine,57 in corrispondenza dell’incrocio fra il decumanus e il cardo maximi, fa pensare però a una posizione centrale della piazza pubblica. Analogo lastricato è
Fig. 11 - Alife: ubicazione delle aree e degli edifici pubblici.
195Allifae e il suo ager
stato messo in luce nel corso di recenti indagini archeologiche nell’area di proprietà della Banca Capasso, antistante la medesima piazza.58 Queste evidenze sembrano confermare l’interpretazione data alle strutture scoperte sotto l’Uffi cio Postale (fi gg. 12 e 13), comunque pertinenti al Foro, e considerate dalla Tocco59 come ta-bernae disposte lungo un probabile portico intorno ad un’area scoperta lastricata, ovvero da altri60 come resti di edifi ci sacri per la presenza di un pozzo (ritenuto una favissa di un tempio o del Capitolium) con scarichi contenenti abbondante materia-le anche integro (vasellame ceramico e vitreo, frammenti di decorazione marmorea, reperti e scorie di metallo, ecc...).
Simili tabernae con pozzi si sono riscontate anche in due saggi archeologici61 effettuati a poca distanza sul lato N di Piazza Vescovado, dove sono stati messi in luce due ambienti paralleli (fi g. 14) ascrivibili all’età romana, delimitati da muri in opus incertum e con vari piani pavimentali successivi, il più recente dei quali era
Figg. 12 e 13 - Alife, piazza Termine: edifici dell’area del Foro (portico con tabernae e pozzo).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 196
obliterato da uno strato di abbandono particolarmente ricco di materiale ceramico medievale e costituito da un battuto di modesta qualità ottenuto con materiali di risulta. Uno strato di crollo copriva, inoltre, una precedente pavimentazione e una struttura muraria forse abbattuta da eventi sismici, probabilmente di epoca tardo-antica, realizzata con pietre squadrate alternate a fi lari di tegole disposte per taglio.
Il piano di calpestio originario, di età romana, di queste tabernae disposte lungo il decumanus maximus era, infi ne, costituito da un battuto cementizio di ghiaia fl u-viale e calce, tagliato successivamente da un pozzo rivestito di fi lari di pietre calcaree con pedarole, colmo di strati di sabbia e terreno argilloso, misto a scorie ferrose che farebbero ipotizzare una destinazione artigianale62 di queste strutture ed esten-sivamente dell’area. Radicali trasformazioni vi si sono osservate relative all’epoca medievale, come attestano due focolari provvisori con buchi di palo obliterati da un grosso muro di brecce calcaree, con molta probabilità riferibile all’impianto di un vasto complesso ecclesiastico, che forse ospitava anche la sede vescovile, istituita in base alle testimonianze delle fonti storiche e dei documenti epigrafi ci nel V-VI sec. d.C.63 Tali strutture delimitavano uno spazio destinato a coemeterium64 (fi g. 15) di epoca medievale caratterizzato da numerosissime tombe, alloggiate nei condotti di scarico delle terme pubbliche del Foro, contenenti scheletri di individui talora di notevoli dimensioni forse anche appartenenti ad etnie allotrie.65 I resti dell’edifi cio termale, provvisti di ambienti con ipocausti su suspensurae e con articolati sistemi di canalizzazione, sono emersi, oltre che nella piazza, anche nel corso di indagini ar-cheologiche effettuate al di sotto della cripta della Cattedrale, dove è stato scoperto, nel 1994, parte del tepidarium con suspensurae (fi g. 6), delimitato da pareti in opus listatum rivestite da frustuli di interessanti affreschi in tardo II stile con prospetto scenografi co.66 Nessuna traccia resta, invece, degli altri edifi ci municipali per l’attivi-tà amministrativa, almeno la curia se non la basilica, di cui pure bisognerebbe pre-supporre l’esistenza sulla base delle testimonianze epigrafi che67 relative alle cariche pubbliche municipali (IIviri iure dicundo e quinquennales, aediles, quaestores, praefec-ti, curatores), come per esempio avviene nel Foro di Pompei e in quello della colonia marittima di Liternum, seppure più antica, ma confrontabile per dimensioni.
In ogni caso la destinazione pubblica dell’area compresa tra le attuali Piazza Ter-mine e Piazza Vescovado è confermata dai resti del teatro,68 dotato di una cavea in opus incertum sorretta da due ordini di arcate, attribuita alla metà del I sec. a.C.,69 e con scenae frons impostata su un pulpitum ornato da nicchie alternate rettangolari e semicircolari risalenti ad epoca augustea, ma caratterizzata da successivi interventi edilizi effettuati in età antonina (tra il I e il II sec. d.C.). Nel corso degli scavi esegui-ti negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso vi furono rinvenute statue acefale, teste di statue, anfore e altri frammenti della decorazione e dei rivestimenti archi-tettonici, marmorei o calcarei, simili a quelli che purtroppo furono asportati e riuti-lizzati per l’edifi cazione della chiesa cattedrale e del campanile, a partire dalla tarda antichità e sino all’età contemporanea come attestano i documenti ottocenteschi.70
197Allifae e il suo ager
Fig. 14 - Alife, piazza Vescovado: taberna con pozzo.
Fig. 15 - Alife, piazza Vescovado: terme pubbliche riutilizzate con sepolture cristiane.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 198
Stessa infausta sorte toccò all’anfi teatro (fi g. 11),71 che fu distrutto e presto con-siderato come cava a cielo aperto, similmente a quanto accaduto anche nell’antica Capua, per il recupero di materiale edilizio e disponibile per il suo reimpiego nelle costruzioni di età medievale.
Rilievi aerei,72 eseguiti alla metà degli Settanta del secolo trascorso, e successiviscavi di emergenza73 hanno, infi ne, permesso di ubicare l’anfi teatro innalzato in
epoca imperiale fuori Porta Napoli o Beneventana. L’istituzione in Allifae di ludi gladiatorii e di venationes era peraltro nota da due epigrafi (CIL IX, 2350 e 2351), di cui una dedicata a L. Fadius Pierus, oltre che da un graffi to inciso su una delle pareti del criptoportico annesso al teatro nell’antica Suessa Aurunca.
A giochi circensi, che si effettuavano nei giorni 28-30 luglio e 14 agosto, e alle nundinae, mercati che si tenevano periodicamente nelle città romane, alludono i tre o quattro frammenti del calendario alifano74 (CIL IX, 2319-2320), datato al 44 a.C., di cui uno rinvenuto da G.F. Trutta nella chiesa di San Salvatore ora al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (relativo ai gg. 23-30 luglio), un altro da Visco ora al Museo Provinciale Campano di Capua (pertinente ai gg. 12-19 agosto), un terzo recuperato dalla Cancelleria Vecchia ad Alife e ora al Museo di Berlino (rife-rito ai gg. 9-11 agosto), e infi ne un piccolo frustolo ritrovato a Sant’Angelo d’Alife e in seguito perduto. La citazione del circo75 ha indotto qualche studioso locale ad ipotizzare la poco probabile esistenza di un apposito edifi cio ubicato presso la chiesa dei Santi Sette Frati fuori Porta Napoli.
Altrettanto erronea è la tesi di chi76 ha voluto attribuire alla città una zecca auto-noma sulla base di un testo epigrafi co riferito ad un tresvir auro argento aere fl ando feriundo di origine alifana, tuttora murato sulla facciata di una casa privata lungo via G.F. Trutta.
Dell’esistenza, pressoché sicura anche se non accertata, di edifi ci religiosi77 rima-ne testimonianza nell’iscrizione di dedica a Giove di un orologio solare e di un’ara da parte di un Popilius Philodespotus (CIL IX, 2324), rinvenuta nel 1775 presso la chiesa dei Santi Sette Frati e probabilmente proveniente dal Capitolium che non poteva mancare nel Foro della città come in ogni municipum romano.
Sono tuttavia attestate dalle fonti epigrafi che anche sacerdotesse di Giunone (CIL IX, 2323 e 2362), di Cerere (CIL IX, 2321), di Diana (CIL IX, 2326), di Venere(CIL IX, 2358), della Mater Deum (in un’iscrizione rinvenuta a Raviscanina nella località Canale), nonché i seviri augustali (CIL IX, 2364, 2366, 2367 ecc…), addetti al culto imperiale e in genere appartenenti alla classe dei liberti.
Non è dato di conoscere, purtroppo, l’organizzazione interna degli isolati defi -niti dal tessuto stradale, cioè l’orientamento rispetto alle strade delle abitazioni, che dovevano però sicuramente prospettare sul cardo maximus, sul decumanus maximus e sui decumani minori.
Per quanto concerne l’edilizia privata78 (fi g. 16), numerose sono le attestazioni emerse soprattutto nel corso di indagini preliminari ad interventi edilizi privati:
199Allifae e il suo ager
resti di ambienti con muri in opus incertum e latericium e povere pavimentazioni in cocciopesto sono stati individuati, ad esempio, in varie zone della città, nel quarto detto di San Francesco a S, o nel quarto di San Pietro a N, e ancora a Via Anfi teatro, a Via Alferio e anche lungo Via Roma. Appartengono, invece, a vere e proprie do-mus gli ambienti con mosaici tessellati bianco-neri e frustuli di rivestimenti parietali dipinti, rinvenuti soprattutto lungo la viabilità urbana principale. Vanno ricordati, a tale proposito, i citati resti della casa scoperta in Via Roma con impluvium, cir-condato da fasce a mosaico decorate con nodi di Salomone e raffi gurazioni di cinta muraria,79 databile al I sec. d.C.; a tale abitazione patrizia forse si riferisce anche la sala con affresco in IV stile (fi g. 5), di cui sopravvive lo zoccolo a fondo bianco con pannelli e scomparti decorati con piante e altri delicati elementi fi tomorfi .80 In Via Alferio, nello stesso settore cittadino dove precedenti scavi eseguiti da Dall’Osso nel 1907 e da Della Corte nel 1927-192881 avevano portato alla luce l’impluvium calcareo dell’atrio tetrastilo di una domus, con ambienti dotati di pavimenti tessellati a decorazioni geometriche bianco-nere, su tracce fasi edilizie antecedenti, è stato di recente scoperto un triclinio pavimentato da un bellissimo pavimento a mosaico bianco-nero di età giulio-claudia con fascia a meandro,82 asportato e ora conservato nel locale Museo Archeologico. Altri due pavimenti della prima età imperiale, di cui uno tessellato a fondo bianco puntinato da tessere nere e con soglia in calcare, pertinenti ad ambienti rinvenuti in via San Pietro,83 sono da attribuire ad una do-mus prospiciente il decumanus maximus; mentre quello in cocciopesto con tracce di colore rosso decorato da una rete di rombi, databile tra la fi ne del I sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C., messo in evidenza in via G.F. Trutta, era relativo ad una casa fi ancheggiante il cardo maximus, in prossimità di Porta Piedimonte.84
A parte l’interesse che suscita lo studio dei rivestimenti pavimentali e parietali in Allifae romana, ancora tutto da approfondire, la tipologia edilizia e costruttiva di queste dimore patrizie con apparati decorativi di buon livello qualitativo, seppure di fattura locale, confermano che la città ebbe la sua fi oritura tra il I e il II sec. d.C., cioè nell’epoca augustea e poi nella prima e media età imperiale romana; ma signi-fi cativi interventi di restauro sono attestati anche nella tarda età imperiale, sia nelle case private che negli edifi ci pubblici.
Da questo punto di vista, esemplare per l’analisi delle fasi di vita della città è il contesto archeologico messo in luce in Via Erennio Ponzio, nella proprietà Amato-Rea (fi gg. 3 e 4), l’unico contesto abitativo della città completamento esplorato in tutta la sua successione stratigrafi ca sino al terreno vergine.85
Vi è stata rinvenuta, infatti, una domus romana, impiantata alla metà del I sec. a.C. e sopravvissuta sino al II sec. d.C., caratterizzata da un vasto ambiente resi-denziale, delimitato da robusti muri in perfetto opus incertum, contemporaneo per la tecnica costruttiva a quello della cinta muraria, rivestiti di intonaco a fresco con decorazioni in II stile schematico, e con un pavimento smantellato nel II sec. d.C.; essa era altresì dotata anche di tre locali di servizio con due forni da cucina e un
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 200
pozzo, che ha restituito abbondante materiale ceramico comune, da mensa (terra sigillata tardo-italica) e vitreo della prima età imperiale romana. La casa si affacciava su un decumano minore, messo in luce in tutta la sua larghezza con il basolato, la crepidine e il sottostante impianto di smaltimento delle acque nella condotta fogna-ria principale.86
Sugli strati di distruzione della domus, fu poi realizzata, lungo il fronte stradale, ma ad una quota superiore rispetto al livello di calpestio originario, una cucina con un vano di accesso ad un locale adiacente, delimitato da muri costruiti con fi le so-vrapposte di ciottoli fl uviali alternati a ricorsi di frammenti laterizi, secondo una tec-nica edilizia comune nella zona per l’epoca, e pavimentato con un semplice battuto cementizio, nonché dotato di un banco di lavoro in muratura con relativo piano di cottura. Su questa seconda fase edilizia, databile tra il V e l’VIII sec. d.C., dopo una modesta frequentazione nel periodo compreso tra il IX e il X sec. d.C., si impostava, ad una quota immediatamente sottostante all’attuale piano di calpestio e con un orientamento diverso rispetto alle strutture romane, un monumentale edifi cio forse a destinazione religiosa, riferibile ad un periodo compreso tra l’XI e il XIV sec. d.C. Dati analoghi sembrano ripetersi in altri contesti emersi nei quartieri tuttora signi-fi cativamente denominati di San Pietro, di San Francesco e di Santa Maria la Nova, per la presenza di complessi ecclesiastici. La continuità di occupazione in epoca tardo-antica (V-VI sec. d.C.), alto-medievale (VII-X sec. d.C.) e medievale (XI-XIV
Fig. 16 - Alife: ubicazione degli edifici privati.
201Allifae e il suo ager
sec. d.C.) appare, altresì, ben documentata dai risultati delle ricerche archeologiche sinora eseguite in vari luoghi all’interno dell’area urbana.
I reperti ceramici – in particolare anfore e vasellame in terra sigillata africana di tipo C e D, ceramica a bande rosse, sottili e larghe – rinvenuti negli strati di oblitera-zione delle strutture romane, come anche le opere di manutenzione eseguite soprat-tutto nelle strade principali confermano una costante presenza abitativa ancora tra il V e l’VIII sec. d.C., seppure attraverso periodi di parziale abbandono o di decadenza e con modalità di frequentazione più o meno stabili ed estensive all’interno della cerchia muraria.
Questa fase di regressione della città a partire dall’epoca tardo-antica, fu dovuta a ben note cause di carattere soprattutto politico-amministrativo e socio-economico connesse con la crisi dell’Impero romano, ma anche, nel caso specifi co, ad eventi geologici, come il terremoto avvenuto nella metà del IV sec. d.C. (345-346), o a fattori climatici, come le frequenti alluvioni87 verifi catesi nella zona nel corso del tempo.
La presenza di scarichi di materiale residuo all’interno dell’area urbana e in prossimità delle mura, ad es. quelli rinvenuti nei settori orientale e meridionale, le caratteristiche delle strutture di quest’epoca impiantate sugli strati di abbandono alluvionali, come quelle messe in luce in Via Erennio Ponzio o in Piazza Vescovado e in molti altri punti della città, denunciano infatti una contrazione e una concen-trazione abitative intorno ai nuovi luoghi di culto.
Una volta decadute le strutture di gestione e di controllo politico centrali con la fi ne dell’Impero romano, questi complessi a destinazione religiosa assunsero il ruolo di aree di aggregazione sociale e amministrativa della città, e divennero altrettanti poli di attrazione dal punto di vista topografi co, sostituendosi agli edifi ci pubblici romani occupati, come talora anche le strade, da aree di sepolture. L’impianto urbano subì, quindi, un signifi cativo mutamento dei percorsi viari secondari che, costituiti da semplici battuti misti a spezzame laterizio e brecce calcaree, comincia-rono a perdere la loro regolarità ad eccezione che nelle strade principali, rimaste costantemente in uso nelle loro percorrenze, seppure con minime deviazioni e con successivi livelli pavimentali sovrapposti. La forma urbis di Allifae, che in età romana gravitava intorno all’area centrale del Foro, fulcro anche ideale della vita politica-amministrativa, sociale e religiosa municipale, assume dunque in epoca tardo-antica e alto-medievale una struttura policentrica, almeno sino alla costruzione nel XII sec. d.C. della nuova Cattedrale,88 che da allora in poi divenne il nuovo punto di riferimento della città.
Numerose tracce della viabilità urbana interna (fi gg. 10, 17 e 18) sono state rinvenute, altresì, nel corso di saggi di emergenza89 effettuati in occasione di lavori privati e pubblici a quote variabili da - m 3,00 / 3,50 (massima ad E, a N e a Piazza Vescovado), e - m 2,00 in media all’interno dell’area urbana, a - m 0,60 (minima a S e ad O rispettivamente presso Porta Fiume e Porta Roma). Tali indagini, infatti,
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 202
hanno messo in luce lunghi tratti del decumanus e del cardo maximi, e delle vie ad essi ortogonali e parallele, nonché incroci stradali con profondi solchi lasciati dal transito dei carri tra Via G.F. Trutta e Via Castello (saggio 2 E.N.E.L.), presso Piazza Santa Caterina e a Via Anfi teatro (saggio 2 S.N.A.M.).
La carreggiata stradale del decumanus maximus era larga ca. m 6,00, mentre di m. 5,40 era la larghezza dei decumani e di m 4,40 quelli dei cardini secondari (fi gg.17 e 18). Esse erano tutte fi ancheggiate da crepidines, marginate da blocchi calcarei e con marciapiede in terra battuta, che spesso mostrano segni di interventi di riparazione,90 forse anche in occasione dell’allacciamento idrico della città all’ac-quedotto augusteo. I sistemi di canalizzazione per lo smaltimento delle acque me-teoriche e di scarico erano formati da canalette normali alla strada con copertura in tegole e spallette in muratura, che scaricavano in un collettore principale, orientato e inclinato verso E in direzione del Torano, con piano e copertura in tegole connes-se a spiovente e coperte da una gettata di malta cementizia,91 situato al di sotto dei marciapiedi lungo il decumanus maximus. Nei saggi archeologici si è potuta leggere in sezione la tecnica costruttiva del basolato romano: il summum dorsum vi appare costituito da blocchi poligonali di calcare bianco levigati sulla superfi cie e accurata-mente connessi, impostati su un rudus e uno statumen di brecce e ghiaia mista ben costipata di dimensioni crescenti verso il basso e per uno spessore di ca. m 0,80.
Inoltre, è stato possibile individuare, in prossimità della Piazza Vescovado92 e di Porta Napoli,93 una precisa successione stratigrafi ca di pavimentazioni stradali al di sopra del basolato romano, databili dall’età romana a quelle tardo-antica e medieva-le sino ad epoca contemporanea (fi g. 17).
Viabilità extraurbana, infrastrutture e insediamenti rustico-residenziali nell’ager Allifanus
Il decumanus maximus corrisponde, peraltro, al tratto urbano della via publica, diramazione della Via Latina94
che, realizzata dai Romani per esigenze militari sin dal III sec. a.C., divenne presto fondamentale via di comunicazione tra il Latium vetus, la Campania e il Samnium. Essa attraversava appunto Allifae, entrando e uscendo attraverso le porte urbiche occidentale (Porta Roma) e orientale (Porta Napoli o Be-neventana) probabilmente con signifi cative inclinazioni di tracciato, come spesso si verifi ca nelle città antiche, e collegava la colonia con Venafrum a N-O, con Telesia e Beneventum a S-E, seguendo un percorso rimasto più o meno costante nel tempo.
Numerosi tratti di questa viabilità sono emersi all’esterno di Porta Roma, in lo-calità Quattro Venti di Raviscanina95 e, oltre il ponte cosiddetto Latrone, presso Ca-priati al Volturno. Ma rinvenimenti di precedenti battuti stradali nella località Santa Maria del Piano a Capriati e in località Starze di Ciorlano96 confermano la persisten-za d’uso di tale percorso almeno dal periodo arcaico e, dopo l’epoca romana, sino ad età medievale e moderna, quando esso fu ricalcato con qualche deviazione dalla stra-da borbonica ora statale 158: un itinerario peraltro obbligato dalla geomorfologia
203Allifae e il suo ager
dei luoghi, per la presenza di valichi e colline, ovvero condizionato, nelle zone pianeggianti, dall’andamento del letto del fi ume Volturno soggetto a frequenti mutamenti per esondazioni.
Un’altra diramazione della Via Latina, dopo aver attraversato il ter-ritorio dei Latini e la valle del Liri, si staccava da Teanum, passando attra-verso il valico compreso tra i rilievi di Marzanello Appio e di Pietravairano e il Massiccio del Montemaggiore, e scavalcava il Volturno transitando sul ponte di Baia Latina o ponte del-l’Inferno, per innestarsi all’altezza dei Quattro Venti, sulla direttrice interna che conduceva da Venafrum ad Alli-fae.97
A tale proposito è da segnalare che, a differenza di altre viae pubblicae lungo la fascia costiera e nella pianura campana, quali l’Appia, la Domitiana e la via Campana, i tratti extraurbani individuati dalle indagini, siano essi pertinenti alla viabilità principale o agli assi centuriali, si presentano gla-reati, cioè privi, o privati in seguito a
fenomeni di spoglio, dei blocchi che in genere selciavano lestrade romane, circostanza questa attestata anche nell’area laziale e altrove in
Italia.98 Qualora fosse da ritenere valida l’ipotesi di una pavimentazione originaria glareata anziché selciata, peraltro per ora suffragata dalle evidenze archeologiche, la presenza dei blocchi calcarei all’interno della strade di Alife, si dovrebbe spiegare dunque come dovuta all’esigenza di monumentalizzare il contesto urbano.
Un L. Appuleius 99 (CIL IX, 2345) è attestato dalle epigrafi pertinenti all’area Alifana come curator viarum sternandarum, addetto cioè alla manutenzione delle strade.
Tale incarico era spesso connesso a quella delle acque: un’iscrizione rinvenuta in contrada Le Capole è, infatti, relativa ad un M. Granius Cordo, vissuto agli inizi del I sec. d.C., duovir e poi anche quinquennalis nominato con decreto decurionale curator aquarum (CIL IX, 2353).100 Ben cinque, infatti, risultano gli acquedotti101 romani noti, che deviavano l’acqua verso Allifae. Due partivano dalle falde del Cila
Fig. 17 - Alife, via Roma: decumanus maximus.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 204
attingendo alla sorgente del Maretto: uno di essi giungeva su arcate presso Porta Napoli, dove è stato ipotizzato sorgesse un castellum aquae al di sotto dell’attuale Castello medievale; l’altro arrivava a Porta Piedimonte attraverso la contrada Pon-ticello. Il terzo acquedotto attingeva acqua dalla sorgente del Torano, quindi, fi an-cheggiando il monte Cila, entrava in Piedimonte per la Via Paterno in direzione di Alife; di quest’ultimo si conservavano ancora in vista, sino a poco tempo fa, alcuni resti di arcate.
Un quarto acquedotto portava acqua dalla località Fabbrica verso Alife passando per Porta Roma.102 Il quinto acquedotto dalla sorgente di Pietrapalomba alimen-tava le ville dei patrizi alifani: in contrada Fora ne sono ancora attestati i sifoni in fabbrica e avanzi di camere idrauliche. Ulteriori tratti di acquedotti sono quello in località Formose di San Potito Sannitico103 e quello forse collegato con l’acquedotto augusteo derivato dalle sorgenti del Volturno, rinvenuto a Prata Sannita in località Starze,104 in associazione ad una villa rustica.
Questo complesso sistema idraulico serviva, come si è detto, anche le ville ru-stiche, possedute dai membri della classe dirigente locale e distribuite nell’ager Alli-fanus con densità ancora da indagare, ma abbastanza fi tta intorno alla città, dotate spesso di cisterne, ma anche di impianti di conservazione dell’acqua, simili a quello scoperto in prossimità di Sant’Angelo d’Alife in località Petraro,105 di cui non è certa tuttavia la pertinenza ad una struttura residenziale.
I nomina di tali gentes106 sono attestati, altresì, nelle numerose epigrafi funerarie recuperate, per lo più fuori della città di Alife, nelle aree di necropoli,107 oppure
Fig. 18 - Alife, via Erennio Ponzio, proprietà Amato-Rea: decumano minore.
205Allifae e il suo ager
lungo la via pubblica; mentre la loro elevata posizione socio-economica risulta evidenziata in forma monumentale negli edifi ci sepolcrali, come quello cd. degli Acilii Glabriones,108 fuori Porta Napoli, e di Via Cambisi in direzione di Telesia-Be-neventum, nonché il mausoleo inglobato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie109 e quelli eretti nella località Torrione, in direzione di Sant’Angelo d’Alife, lungo la diramazione della Via Latina.
Dopo la conquista romana di questo territorio, infatti, la fertilità e l’amenità delluogo (Cic. Pro Planc. 9), famoso per i suoi vigneti (Hor. Sat. II, 8, 39; Sil. VIII,
537; XII, 526), si popolò di villae rusticae,110 come quella medio-repubblicana messa in luce negli anni Sessanta del secolo scorso in località Ponte Reale presso Mastrati e le ville con criptoportici111 e gli impianti termali ancora in vista tra Sant’Angelo d’Alife e Alife in località Taverna-Starza, Grotte, Crocefi sso, Rondò, e a Piedimonte Matese, in località Le Torelle.112 Rinvenute più di recente, tra il 1994 e il 1996, sono due ville residenziali situate a Raviscanina e a Prata Sannita. La prima in località Santo Stefano – Quattro Venti (fi g. 19 a, b),113 frequentata dal II-I sec. a.C. al I sec. d.C., è caratterizzata da quattro ambienti, delimitati da residui di muri in opus in-certum con rifacimenti in latericium, in origine affrescati, dotati di soglie calcaree e pavimenti di cocciopesto o decorati da crustae marmoree, nonché distribuiti ai lati di un corridoio e intorno ad un cortile scoperto, nel quale le coperture versavano l’acqua pluviale mediante canalette di scolo. La seconda villa, in località Starze (fi g. 20),114 presenta similmente tre ambienti, di cui uno absidato, con muri in opus incertum e restauri in latericium, e pavimenti costituiti da battuti in cocciopesto semplice o con tessere e da mosaici tessellati a fondo bianco con fascia nera, disposti a L intorno ad un cortile scoperto.
I reperti ceramici associati alle strutture fanno propendere per una frequentazio-ne dell’edifi cio dal I sec. a.C. al II sec. d.C. In entrambi i casi le ville sono associate a fornaci per la fabbricazione di laterizi, anfore e vasellame, e appaiono dislocate lungo il percorso della diramazione della Via Latina, insieme a mansiones, come forse quella con impianti termali che sorge in località Santo Stefano - Quercete di Raviscanina.
In molti di questi complessi rustico-residenziali, quale quello situato in località Taverna-Starza, i frammenti di anfore e vasellame in terra sigillata tardo-africana e poi di ceramica a bande rosse e invetriata attestano una continuità di occupazione dell’area in epoca tardo-antica (V-VI sec. d.C.), alto-medievale (VII-X sec. d.C.) e medievale (X-XIV sec. d.C.),115 situazione che appare ben documentata anche nell’area urbana di Alife, in cui tuttavia, da quanto emerso nelle varie esplorazioni archeologiche sinora eseguite, si assiste all’abbandono degli edifi ci pubblici e della viabilità secondaria, e ad un parziale ridimensionamento dei quartieri abitativi.
L’occupazione del territorio dall’epoca tardo-antica al Medioevo
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 206
Le mutate situazioni storiche intervenute tra il IV e il VI sec. d.C. su scala regionale e causate dalla crisi politica e amministrativa dell’Impero romano, con l’abbandono delle campagne e l’estendersi delle aree di pascolo, con la dismissio-ne e la decadenza delle infrastrutture create dai Romani - acquedotti, impianti di canalizzazione, ponti, strade -, e con le conseguenti anche radicali trasformazioni prodottesi nel tessuto sociale e sul sistema economico-produttivo evidenziate in ambito urbano, si rifl ettono in modo forse anche più evidente sul territorio. L’ager un tempo pertinente alla colonia romana di Allifae viene inglobato nei vasti posse-dimenti di nobili e ricchi latifondisti o ancora della Curia e degli ordini monastici,116 in particolare quello benedettino. Dopo l’VIII sec. d.C., infatti, si cominciano ad insediare nella zona i complessi conventuali dipendenti dall’abbazia benedettina di San Vincenzo al Volturno,117 come i monasteri di Santa Maria in Cingla ad Ailano118 e di San Salvatore a Piedimonte Matese, oltre a quello agostiniano nell’omonima località a Prata Sannita.119
Si affermano nuove forme di insediamento umano: villaggi agricoli e abitati sparsi vengono costituiti intorno a piccole chiese campestri, come quella rinvenuta a Ciorlano120 o la cappella situata presso il ponte romano a Capriati al Volturno;121 sorgono edifi ci religiosi come quello, ottagonale in località Santo Stefano (forse un battistero),122 spesso impiantati in prossimità di incroci stradali e su preesistenti siti romani, soprattutto ville e stationes, ma anche inglobati in antichi mausolei sepol-crali riutilizzati, come in quelli del Torrione o di Santa Maria delle Grazie o ancora di quello cd. degli Acilii Glabriones.
Da questo punto di vista un rinvenimento di notevole interesse si è verifi cato appunto nella suddetta località Torrione di Alife (fi g. 21), nella proprietà Iannelli, dove tra il 1996 e il 2000 sono stati eseguiti lavori di restauro conservativo all’im-ponente monumento sepolcrale romano (di recente acquisito al demanio statale) e scavi archeologici nella necropoli annessa.123
L’edifi cio funerario era situato lungo il tracciato della diramazione della Via Latina che collegava Venafrum ad Allifae e Beneventum. Da sempre in vista e noto dalle descrizioni del Trutta124 e dalla tradizione antiquaria locale Sette-Ottocentesca, nonché citato in più recenti studi specialistici,125 esso è costituito da un massiccio corpo cilindrico, forse in origine sormontato da una copertura a tumulo piuttosto che da un coronamento a terrazza, e del quale si conserva, per un’altezza massima di m 9,60, il nucleo in opus caementicium, impostato su un basamento quadrango-lare, di m 13,50 per lato e alto ca. m 3,00, fornito di due gradini e rivestito da un paramento in opus incertum di buona esecuzione. Come altri analoghi monumenti funerari, fra cui il famoso e più tardo mausoleo cd. degli Acilii Glabriones, è altresì ipotizzabile che esso potesse presentare in origine un rivestimento esterno in lastre o blocchi squadrati di calcare. Il Trutta attribuisce, peraltro, alla decorazione del-l’edifi cio anche alcune colonne monolitiche di granito, forse da identifi care con quelle riutilizzate all’ingresso del Palazzo Vescovile nella Piazza San Domenico a
207Allifae e il suo ager
Fig. 19 a, b - Raviscanina, località Santo Stefano-Quattro Venti: villa romana.
a
b
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 208
Piedimonte Matese, nonché altri elementi achitettonici, fregi e cornici, di cui alcuni frammenti sono stati rinvenuti ai piedi del basamento o si trovano tuttora disseminati nelle masserie circostanti.
Il mausoleo, che per la sue caratteristiche architettoniche rientra nel tipo cosid-detto “a tumulo” o “a gasometro”, trova numerosi confronti in area umbro-sannitica (Carsule, Sepino, Sarsina, Corfi nio, Pietrabbondante), laziale (Roma, Tuscolo, Ti-voli, Gaeta) e ovviamente campana (Capua, Napoli e Campi Flegrei), e può essere, pertanto, datato ad epoca augustea, tra la fi ne del I sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C.
Insieme agli altri quattro monumenti funerari presenti nell’ager Allifanus,126 esso si confi gura come un classico esempio di auto-celebrazione da parte di esponenti di prestigio della classe dirigente locale, che poteva forse vantare discendenze dai fon-datori della colonia o legami con importanti famiglie romane e latine, e che si era affermata alla guida politica ed economica di Allifae nel periodo di massima fi oritura della colonia, durante la prima età imperiale. L’area di necropoli (Tav. 21) rimase comunque in uso per tutta l’età romana sino ad epoca tardo-antica e alto-medievale, a giudicare dalle caratteristiche tipologiche e dalla cronologia dei materiali che si trovano associati nelle venti tombe messe complessivamente in luce intorno al mau-soleo o all’interno di una sorta di recinto funerario (fi g. 22), delimitato sui lati set-tentrionale,127 orientale e meridionale128 da un muro costruito in opus caementicium
Fig. 20 - Prata Sannita, località Starze: villa romana, pianta dello scavo.
209Allifae e il suo ager
in adiacenza al basamento e prospiciente il tracciato della via pubblica,della quale si è rilevato il taglio nel banco calcareo in cui sono scavate le sepolture.
Nella prima campagna di scavo, condotta nel corso del 1997, erano state recu-perate cinque tombe, alcune delle quali ad inumazione in fossa terragna, addossate ai lati O e N del basamento, una alla “cappuccina” e un’altra sepoltura infantile ad enchytrismos, poste in prossimità dell’angolo meridionale del monumento. Oltre ai pochi resti osteologici umani, solo tre di esse erano accompagnate da poveri elemen-ti di corredo: la tomba n. 3, a N-E, presentava un’olla monoansata acroma con co-perchio e una fi bbia di cintura o di fi nimento in bronzo; mentre, a S-E, la tomba n. 4 recava, insieme a due grosse olle acrome, una piccola brocca monoansata decorata a bande rosse sottili, presente anche nella n. 5 ad enchytrismos.
Nel corso della seconda esplorazione, tra il 1998 e il 2000, sono state rinvenute le altre quindici sepolture che, ad eccezione della tomba n. 11, addossata al centro del lato O del basamento, sono prevalentemente raggruppate all’interno (tombe nn. 6, 8, 10, 16, 18) o all’esterno (tombe nn. 7, 12, 13, 14, 15) del recinto. Di esse, cinque sono alla “cappuccina” (tombe nn. 6, 8, 10, 13, 16, 18), mentre all’esterno dell’area recintata, si trovavano tre sepolture a fossa terragna (tombe nn. 7, 14, 15), di cui la prima posta in prossimità dell’angolo settentrionale, le altre due a S lungo il supposto tracciato viario antico, insieme ad una tomba con muretti laterali e co-pertura di tegole (n. 12).
Fig. 21 - Alife, località Torrione: mausoleo sepolcrale romano.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 210
All’interno delle deposizioni il defunto, ove rinvenuto, era supino con il capo variamente orientato ma in genere parallelo al lato del basamento presso cui era seppellito; i raggruppamenti riscontrati nei tre settori del recinto funerario forse corrispondono a diversi nuclei familiari.
Le tombe alla “cappuccina” sembrano corrispondere alla fase più antica di uso della necropoli, anche se successiva all’impianto del mausoleo funerario, in base alla tipologia dei corredi rinvenuti all’esterno della tomba n. 10 e nella tomba n. 18, composti da un’olletta di ceramica comune, presente anche nella tomba n. 13, asso-ciata ad una lucerna e a chiodi di ferro, secondo il costume funerario tipico nell’età imperiale romana (fi g. 23 a, b). La lucerna della tomba n. 18, a becco tondo con spalla decorata da una triplice fi la di perline a rilievo (fi g. 23 b),129 si data nell’ambito della seconda metà del II sec. d.C. Di diffi cile collocazione cronologica, perché priva di corredo, la tomba n. 12 con muretti laterali e copertura di tegole, che dal punto di vista tipologico si può attribuire alla tarda età imperiale romana.
Ad epoca alto-medievale (VII-VIII sec. d.C.) risalgono probabilmente le sepol-ture a fossa terragna, anche in quanto i defunti vi appaiono seppelliti con le braccia conserte anziché lungo il corpo (fi g. 24 a, b); una sola di esse, la n. 7 (fi g. 24 b), reca-va un corredo composto da una piccola brocca a bande rosse, simile a quella recupe-rata nella tomba n. 4, deposta presso il capo della defunta, che indossava due anelli alle dita e cinque bracciali di bronzo al polso, tenuti insieme da tre anellini, quattro dei quali terminanti a testa di serpente e uno in lamina sottile a cerchio chiuso.
Le analisi antropologiche130 eseguite sui resti osteologici di diciotto individui recuperati all’interno di dodici sepolture, corrispondenti alla fase romana e tardo-antica della necropoli, hanno evidenziato la presenza di un nucleo familiare gene-ticamente omogeneo, composto da membri adulti e da infanti, contraddistinto da patologie dentarie e ossee proprie di una popolazione con dieta ricca di graminacei e di alimenti animali.
L’obliterazione del sito dovette avvenire intorno al IX-X sec. d.C., forse a seguito dei distruttivi eventi connessi con le incursioni dei Saraceni e i terremoti attestati nelle fonti storiche e d’archivio, quando il basamento del mausoleo, forse riutilizza-to per uso cultuale cristiano, fu parzialmente interrato da cospicui strati di terreno alluvionale.
In essi fu poi seppellito l’ingente tesoretto monetale, scoperto nel 1996 (fi gg. 25, 26),131 composto da una crocetta d’argento e un gruzzolo di quattro tarì aurei e ben seicentotrentuno denari insieme ad altri nominali e frazioni d’argento, contenuti all’interno di un sacchetto di canapa o lino, a sua volta custodito dentro un’olletta di ceramica comune tipica del periodo. Le monete, coniate da varie zecche francesi, dell’Italia settentrionale, della Sicilia, di Amalfi e di Capua, anche con iscrizioni in caratteri pseudo-cufi ci, ne fanno un esempio pressoché unico nel suo genere per composizione e varietà. Sulla base dei tipi le monete si datano tra l’XI e il XII sec. d.C. (con terminus ante quem al 1140), epoca in cui Ruggero II d’Altavilla annientò
211Allifae e il suo ager
l’avversario Rainulfo III Quarrel-Drengot e impose la dominazione della propria famiglia e dei Normanni in tutta l’Italia meridionale.
Sotto l’aspetto delle forme di occupazione del territorio Alifano-Matesino in questa epoca, si assiste al sorgere delle cosiddette terre murate e dei singoli “castel-li”,132 possedimenti dei vassalli e dei dominatori locali succedutisi dopo le invasioni dei Longobardi, e quindi dei Normanni, degli Angioini e degli Aragonesi.133
Da questo punto di vista resta da indagare, oltre che sulle caratteristiche di tali tipi di insediamento umano, sulle cause e sulle motivazioni, ambientali e storiche, che giustifi carono le periodiche “migrazioni” degli abitati tra la pianura e l’altura o la montagna, riscontrabili e ricorrenti dalla preistoria all’età sannitica, dall’epoca romana a quella tardo-antica e ancora in età medievale e moderna; come altrettanto interessante è la questione del loro rapporto asincrono o della loro possibile coesi-stenza, anche se per un lasso cronologico circoscritto.
Fattori ambientali, come la prossimità degli abitati al fi ume Volturno e a sorgenti d’acqua, la presenza di zone di facile approvvigionamento alimentare mediante la caccia e la pesca o favorevoli per la pratica di forme di allevamento itinerante, la posizione strategica per visibilità e sicurezza, furono infatti determinanti per l’ubi-cazione dei siti in epoca preistorica lungo le terrazze fl uviali fi ancheggianti il corso del Volturno, o sulle alture prospicienti per quelli dell’età del Bronzo e di nuovo per i centri fortifi cati nella fase sannitica.
Fig. 22 - Alife, località Torrione: recinto meridionale del mausoleo sepolcrale romano.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 212
L’insediamento stanziale in pianura, tanto in epoca preromana quanto soprattut-to romana, fu invece legato soprattutto alla pratica dell’agricoltura in forme sempre più organizzate, alla creazione di percorsi di comunicazione colleganti centri abitati e luoghi di commercio, che provocarono aggregazioni di villaggi e poi la formazione di città strutturate.
Motivi prevalentemente ambientali e storici sembrano, infi ne, essere presupposti al fenomeno dello spostamento degli abitati in siti arroccati, il cd. incastellamento proprio dell’epoca medievale, conseguente al progressivo decadimento politico e amministrativo, demografi co, sociale ed economico della città e alla distruzione delle infrastrutture romane in età tardo-antica e alto-medievale, ma anche ad eventi climatici e geologici.
A questo fenomeno di “pendolarismo”, che si percepisce in tutto il territorio Matesino e in generale in Campania, non fu ovviamente estranea anche Alife, la cui popolazione, decaduta l’antica colonia romana, si rifugiò ai piedi dell’antico oppi-dum sannitico del Cila, nell’attuale Piedimonte Matese.
Note* Questo contributo comprende i contenuti esposti in due distinti interventi presentati dall’A. nei cicli di confe-
renze “In Itinere” negli anni 2003 e 2004, rispettivamente nei giorni 28 febbraio e 21 giugno.Con l’occasione esprimo la mia profonda riconoscenza al Prof. Stefano De Caro, Direttore Regionale per iBeni Culturali e Paesaggistici della Campania e, sino al 2003, anche Soprintendente per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, sotto la guida del quale ho condotto, tra il 1991 e il 1999, un’intensa esperienza professionale e scientifi ca, quale responsabile dell’Uffi cio Archeologico di Alife, sin dalla sua prima costituzione come sede autonoma, e grazie al cui impulso e costante impegno istituzionale è stato progettato e creato il locale Museo; in quest’ultimo sono esposti a partire dal 2004 in un allestimento permanente, anche se non defi nitivo, oggetti pertinenti ai rinvenimenti passati, un tempo conservati nel soppresso Museo Civico di Piedimonte Matese (su cui cfr. Costarella, Prisco 2004), e soprattutto agli scavi archeologici eseguiti di recente nel territorio e nelle necropoli di Alife. Estendo, altresì, doverosi ringraziamenti ai Soprintendenti, Prof. Fausto Zevi, Dott.ssa Valeria Sampaolo (tra il 2003 e il 2005) e Dott.ssa Maria Luisa Nava (insediatasi nel maggio del 2005), che gli sono succeduti alla direzione dell’Istituto, per avere concesso l’autorizzazione alla pubblicazione. Non da ultimo desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento al Dott. Francesco Sirano, sapiente collega
Fig. 23 a, b - Alife, località Torrione: corredo della tomba n. 18: olletta (a), lucerna (b).
ba
213Allifae e il suo ager
Fig. 24 a, b - Alife, località Torrione: tombe nn. 13 e 7 della necropoli romana e tardo-antica.
Fig. 25 - Alife: tesoretto normanno.
a b
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 214
e fedele amico, che con benevola disponibilità ha voluto sempre rendermi partecipe delle attività culturali da lui organizzate con geniale iniziativa, infaticabile entusiasmo e capacità di coinvolgimento degli amministratori pubblici e della popolazione locale.1 Su Alife in generale si vedano i repertori: Mommsen 1883, CIL IX,214-247, 674; RE 1894, I,2, 1585-1586,
s.v. Alliphae a cura di C. Huelsen; EAA 1958, I, 254, s.v. Alife; EAA 1973, 35-36, suppl. I, s.v. Alliphae; EAA 1994, 169-172, suppl. II,1, s.v. Alliphae a cura di A. Parma; Tocco Sciarelli 1984 a, 173-184; nonché le opere di antiquaria e a carattere generale: Ciarlanti 1644 [1992], 31 segg. e passim; Pacichelli 1703, I, 95 segg.; Trutta 1776 [1976], passim; Mennone 1894 [1997], 42-81; Marrocco 1926, 12-21; Finelli 1928 [1985], sp. 9-56; Marrocco 1951, sp. 13-18; Marrocco 1964, 5-16; Marrocco 1980, 29-53; De Caro, Greco 1981, 243-247; Alife romana 1982; Marrocco 1985, 13-19; Mancini 20053, 5-103 (repertorio epigrafi co, 105-157). Per una descrizione più esaustiva della storia e dei rinvenimenti archeologici ricordati in questa sede, si rinvia a quanto contenuto nelle relazioni annuali presentate negli Atti dei Convegni di studi sulla Magna Grecia, citati ove occorre, e in generale: Miele 1991-1992 b, 130-136; De Caro, Miele 2001, 529-540; Miele 2003, 424-427; e i vari contributi apparsi nel catalogo della mostra Ager Allifanus. La piana alifana alla luce delle recenti ricerche archeologiche inaugurata nel giugno 2004.2 Cfr. per la descrizione dei ritrovamenti Maddalena, Angelotti 1988, 41-65.
3 La presentazione del contesto in questione, oltre a una sintesi sulla storia degli studi e sulle testimonianze ar-
cheologiche preistoriche nel territorio Alifano, si trova in Albore Livadie 1990, 7-17, fi gg. 1-6; ma cfr. anche De Caro, Miele 2001, 229-230. Per le evidenze archeologiche preistoriche nell’area limitrofa del Montemaggiore, cfr. Caiazza 1986, 19-44 (età preistorica); 47-70 (età del Bronzo); 73-89 (età del Ferro); mentre su alcuni aspetti generali riguardanti la preistoria nella Campania settentrionale si vedano anche Cazzella 1973, 192-212, sp. 201-204 e Guadagno 1976, 55-68.4 Questi e altri importanti ritrovamenti di materiale preistorico sono descritti in Talamo 2004, 33-45, 95-103,
171-179, e bibl. ivi citata; Sampaolo 2005, 663.5 Sulle attestazioni dell’età del Bronzo recente, cfr. De Caro 1997 a, 674; Miele 1997 a, 447.
6 Tombe dell’età del Ferro, oltre a quelle scoperte fortuitamente specie agli inizi del Novecento, sono state messe
Fig. 26 - Alife: tarì aureo normanno.
215Allifae e il suo ager
in luce a S-E di Alife (Zevi 2004, 864; Sampaolo 2005, 663). Mentre un’estesa necropoli, databile tra la fi ne del VII e la seconda metà del IV sec. a.C., è stata scoperta nella località Cimitero ad O della città attuale, a prolunga-mento di quella individuata tra il 1964 e il 1965 nella località Croce Santa Maria; altri nuclei di sepolture sono stati messi in evidenza a N di Alife, nelle località Vergini e Conca d’Oro, già nota per gli scavi di fi ne Ottocento: otto sepolture del IV sec. a.C., nel 1993; quattordici tombe, databili tra il VI e il IV sec. a.C., nel 2005. Infi ne un sepolcreto di età orientalizzante e arcaica (tra il VII e la prima metà del V sec. a.C.) è emersa nella località Quattro Venti tra Sant’Angelo d’Alife e Raviscanina, caratterizzato da corredi più affi ni a quelli rinvenuti in area campano-laziale. Sul rinvenimento dei primi anni Novanta del secolo scorso cfr. De Caro 1994, 653; De Caro 1997 a, 684-686; De Caro, Miele 2001, 530-533; Miele 2004 a; schede a cura di F. Miele in Ager Allifanus 2004, 105-123; mentre di quelli recenti dovuti all’amico e collega E.A. Stanco, attuale responsabile dell’Uffi cio Archeologico di Alife, si dà notizia in Nava 2006, 592-594.7 Testi di riferimento generale sulla civiltà preromana e sannitica sono: Salmon 1985, sp. 43, 295, nt. 98, 304,
326, 40.1 per quanto riguarda Allifae; Sannio, Pentri e Frentani 1980-1981; Frederiksen 1984, 134-157; Sannio, Pentri e Frentani 1984; Caiazza 1986, 95-105; La Regina 1989, 301-432; Samnium 1991; Italia dei Sanniti 2000; Tagliamonte 20052, sp. 70-75. Per le testimonianze dalle necropoli di Alife e del territorio Alifano-Mate-sino, si ricordano: Fiorelli 1880, 83-84; Fiorelli 1881, 168-170; Dressel 1884, 219-268; Mennone 1894 [1997], 85-87; von Duhn 1924, I, 610-615; Della Corte 1928, 229-237; Finelli 1928 [1985], 99-100; Cerulli Irelli 1965, 274-287; Caiazza 1990, 19-70, sp. 49-63; Lista, Ziviello 1991, 31-65; De Caro 1994, 653; De Caro 1997 a, 684-686; De Caro, Miele 2001, 530-533; Benassai 2001, 106-108, 252, 261-262; Loffreda 2001, 27-76, Tagliamonte 2001, VII-XVII; Miele 2004 a, 195-235; Tagliamonte 2004, 47-58 e schede del catalogo in Ager Allifanus 2004: A. De Filippis, 133-137; F. Miele, 105-123; G. Tagliamonte, 123-131. Per le altre evidenze archeologiche materiali e monumentali relative alla Campania settentrionale e all’area Alifana in età preromana e sannitica, si ricordano: Trutta 1776 [1976], 77-82; Levi 1916, 111-116; Maiuri, 1927, 450-460; Maiuri 1929, 33-38; Marrocco 1951, 13-26, 66-69, 73-79; Rocco 1951, 133-136; Rocco 1952, 53-55; Poccetti 1979, n. 40; Caiazza 1986, 95-105; Villani 1993; De Caro 1994, 652; De Caro 1997 a, 684-686; Chiosi 1991-1992 b, 119-121; Miele 1991-1992 a, 117-119; Miele, Chiosi 1994 a, 257-259; Miele, Chiosi 1994 b, 308-312; Caiazza 1997 a, 18-49; Miele 1997 b, 51-60; De Caro, Miele 2001, 530-533; Sirano 2004 b, 59-73.8 Le vicende della prima guerra sannitica e la conquista di Allifae, Callifae e Rufrae nel 326-325 a.C. (e ancora
di Allifae nel 310 a.C.) sono narrate da Diodoro Siculo (XX, 35, 2) e Livio (VIII, 25; IX, 38, 6; IX, 42, 6-7), i quali, vissuti tra la fi ne del I sec. a.C. e il I sec. d.C., rappresentano le fonti principali per la ricostruzione della storia del territorio Alifano in epoca preromana. Per lo scontro tra Roma e i Sanniti in Campania tra il IV e il III sec. a.C., si vedano: Marrocco 1951, 131-133; Frederiksen 1984, 159-179; 207-220; 221-235. 9 Le incursioni di Annibale nella valle del Liri-Volturno e nel territorio Alifano-Matesino sono ancora descritte
da Livio (XX, 13, 6, XXII, 17-18 e XXVI, 9, 2). Sugli eventi della seconda guerra punica in Campania cfr. Marrocco 1951, 133-134; Frederiksen 1984, 238-265; mentre una ricostruzione del percorso che il generale Cartaginese avrebbe seguito è proposta da Caiazza 1986, 407-416.10
Per i centri fortifi cati in opera poligonale nella valle del Liri-Volturno e nel territorio Alifano-Matesino, cfr. Conta Haller 1978; De Caro, Greco 1981, 240-241; Caiazza 1986, 109-339; 355-359; Caiazza 1990, 17-70, sp. 37-49; Oakley 1995. Per la tecnica poligonale il riferimento è l’opera del Lugli 1957. Sul rapporto tra siti fortifi cati e villaggi di pianura cfr. anche Caiazza 1986, 343-351; 379-385.11
Sull’oppidum sannitico identifi cato con Callifae, si vedano Caiazza 1986, 291-339 e La Regina 1989, 374-375.12
Sull’ubicazione di Allifae sannitica cfr., oltre a Trutta 1776 [1976], 7-18, nell’Ottocento: Beloch 1880, 135 segg.; Mommsen 1883, 214; Nissen 1883, II, 2, 798; von Duhn 1896, I,3, 49, 52, 59, nt. 42; Mommsen 1908, 206, 217; nel Novecento: Maiuri, 1927, 450-460; Maiuri 1929, 33-38; Conta Haller, 1978, 60; Salmon 1985, 43, 295 nt. 98, 304, 326, 40.1; Caiazza 1990, 43-46; Oakley 1995, 49-51. L’appartenenza di Allifae al Sannio è affermata da Strabone (V, 3, 10) e da Tolomeo (III, 1, 67); mentre Plinio (Nat. Hist, III, 63) l’assegna alla regio I (Latium et Campania), forse in relazione alla divisione territoriale operata da Augusto. Sul sito di Alife, e sui confi ni tra Campania e Sannio in epoca antica, cfr. Caiazza 1986, 389-403 e Caiazza 1997 a, 18-49.13
In particolare, Marrocco 1926, 12-15; Marrocco 1951, 20-21; Marrocco 1964, 6-7; Marrocco 1980, 29-51; Marrocco 1985, 14-15; Mancini 20053, 5-9.14
La nuova identifi cazione in Caiazza 2001 a, 5-82.15
Sugli aspetti storici e giuridici della cittadinanza romana, cfr. Sherwin White 1973, 207; Humbert 1978,
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 216
244 segg., 374, 399.16
Sulla decadenza dei centri sannitici di altura si veda Caiazza 1986, 421-436.17
Sulla formazione degli insediamenti in area italico-sannitica, cfr. La Regina 1970, 191-207, sp. 194-195.18
La descrizione dei siti archeologici databili tra il III e il II sec. a.C. scoperti a S/S-E e a N di Alife si trovano in Sirano 2004, 39-73; 139-168; Sampaolo 2005, 664-665; mentre sul rinvenimento presso Ailano si dà notizia in Nava 2006, 589-590. 19
Sulla distribuzione delle necropoli sannitiche nel territorio Alifano-Matesino, cfr. Caiazza 1990, 49-63 eLista, Ziviello 1991, 31-65.20
Della precoce presenza di ville rustiche romane nell’ager Allifanus si tratta in De Caro 1997 b, 409-410; Miele 1997 b, 60-66; De Caro, Miele 2001, 538-540; Miele 2004 b, 75-76; sui recenti rinvenimenti di strutture di epoca ellenistico-romana in ambito extraurbano, cfr. Zevi 2004, 879; Sirano 2004 a, 21-31; Sirano 2004 b, 59-73, e nel catalogo Ager Allifanus 2004, 139-168, sp. 145-147; Sampaolo 2005, 664. Sulla romanizzazione del Sannio, cfr. in generale La romanisation du Samnium 1991; Torelli 1996, 34 segg.21
Sulla via Latina, Rakde 1973, c. 1487 segg.; Radke 1981, 123-131.22
Le recenti indagini archeologiche riguardanti la cinta romana di Allifae sono esposte in: Miele 1991-1992 b, 130; De Caro 1993, 688-689; De Caro 1999 b, 639-640; De Caro, Miele 2001, 533-534; e sono descritte più in dettaglio in Miele 2001 a, 13-39 con bibl. ivi citata, di cui si ricordano: Trutta 1776 [1976], 56-63; Marrocco 1920, 3-12; Finelli 1928 [1985], 82-88; Blake 1947, 231; Marrocco 1951, 33-38; Merolla 1964, 39-48; Brands 1988, 93-94; Alife romana 1982, 9-22; ma cfr. anche da ultimo Miele 2004 b, 79-82.23
La descrizione delle evidenze archeologiche pertinenti alla domus in proprietà Amato-Rea, si trova accennata in De Caro 1993, 689-690; De Caro 1999 b, 639-640; e dettagliata in Crimaco 1991-1992 a, 136-137; Miele 1991-1992 b, 135-136; e in generale sull’edilizia privata si vedano: De Caro, Miele 2001, 534-536; Miele 2004 b, 82-84.24
Per tale evidenza cfr. Miele 1991-1992 b, 134-135.25
Della Corte 1928, 238-240; De Caro 2003, 613-614.26
Per la descrizione delle pitture e dei rivestimenti parietali in Alife romana, si vedano Miele 1991-1992 b, 135-136 e Miele 1997 c, 245-247.27
Una recente e dettagliata disamina della questione sulla centuriazione dell’ager Allifanus si trova in Taglia-monte, Miele 2002, 191-199, tavv. XXXVI-XXXIX, fi gg. 5-7 e bibl. ivi citata; e Miele 2004 b, 75-91, sp. 77, ntt. 12, 13, 14, 15; mentre sulle recenti acquisizioni di dati attraverso l’indagine archeologica, cfr. Sirano 2004 a, 21-31, sp. 29-31; Sirano 2004 b, 59-73, sp. 59, 61-67. Sulla centuriazione, sull’organizzazione e sull’uso del territorio nella Campania antica, cfr. anche Gentile 1955; Gabba, Pasquinucci 1979; Frederiksen 1981, 265-287; Vallat 1981, 289-297; Vallat 1983, 187-193; Frederiksen 1984, 264-284; Gabba 1985, 20-27, sp. 23-24.28
Questa è l’opinione di Merolla 1964, 39; Sommella 1978, 16-17, 24; Sommella 1979, 108-109; Sommella 1988, 129-130, 248; Sommella 1991, 176, 189.29
Così ritengono invece Chouquer et al. 1987, 156, 251; Compatangelo 1991, 142.30
Secondo Castagnoli 1956 b, 376; Castagnoli 1958, 13, 27; ma cfr. anche Schmiedt 1989, tav V; Camodeca 1990, 123-125; Mancini 20053, 9.31
In generale sulle fonti degli agrimensori, cfr. Toneatto, 1994-1995.32
Lib. Col. I, 231, 3: Allifae, oppidum muro ductum. Ager eius lege triumvirale est adsignatus. Iter populo non debetur.33
Sostenitori di una datazione ad epoca triumvirale sono: Pais 1923, 213; Johannowsky 1973, 147-148; Johan-nowsky 1976, 272-274; Sommella 1988, 117-118, 129-130, 248; Camodeca 1990, 123-125; Gros 1990, 831; Sommella 1991, 189, parla di un impianto post-sillano o della prima età triumvirale.34
Fautori di una fondazione sillana o comunque precedente alla seconda metà del I sec. a.C. sono: il Mommsen 1883, 214 segg.; Beloch, 1926, 493; Blake 1947, 131; Castagnoli 1956 a, 93; Castagnoli 1956 b, 376; Ca-stagnoli 1958, 13, 27; Degrassi 1959, 320; Merolla 1964, 274-287; Salmon 1969, 161; Brands 1988, 93-94; con più cautela Johannowsky 1976, 269, 272, 274-275; Tagliamonte, Miele 2002, 191-199, sp. 193-196. Cfr. anche sulla colonia romana in generale: Trutta 1776 [1976], 83-98, 211-217; Marrocco 1951, 26-28, 135-136; Mancini 20053, 10-11.35
Cfr. i testi citati supra a nt. 20, specie Merolla 1964, 39-48; Brands 1988, 93-94.36
Cfr. le indicazioni nelle ntt. 27-32.37
Una lettura in più fasi cronologiche della centuriazione nell’ager Allifanus, sulla base dell’esame delle fotografi e
217Allifae e il suo ager
aeree, viene proposta da Chouquer, Favory 1983, 318; Chouquer et al. 1985, 42; Chouquer et al. 1987, 155-159; ma contestata da Gabba 1989, 567-570; Moscatelli 1990, 659-677; Quilici 1994, 130-131. Su eventuali preesistenze di divisioni agrarie in epoca preromana si veda, La Regina 1999, 3-18.38
Cfr. le citazioni in De Caro 2002 a, 671-673; Zevi 2004, 879; Sirano 2004 a, 25-26; Catalogo in Ager Alli-fanus 2004, 181-182, 223-228 e 241-246, riguardo ad un ponte sul Torano a cura di LM. Rendina; Sampaolo 2005, 664.39
Sull’impianto urbanistico regolare di Allifae, cfr. Castagnoli 1956 a, 93; Marrocco 1969, 3-8; Sommella1978, 16-17, 24; Sommella 1979, 108-109; Sommella 1988, 117-118, 129-130, 248; Sommella 1991, 189;Torelli 1990 b, 43-64; Miele 1991-1992 b, 130-131;; De Caro, Miele 2001, 533; Tagliamonte, Miele 2002, 191-199, sp. 196; Miele 2003, 424-427; Miele 2004 b, 78-82; Mancini 20053, 10-11.40
Su questa defi nizione alcune perplessità esprime Sommella 1988, 238-239; Torelli 1990 b, 43-64.41
La non necessaria coincidenza tra impianto urbano e centuriazione rispetto alla fondazione di una colonia è già affermata da Brunt 1971, 329 e Keppie 1983, 20 segg., 62. Su questo aspetto, cfr. i riferimenti alle ntt. 27-37. 42
Cfr. Sommella 1988, 238-239.43
I cippi agrimensori di Alife sono oggetto di una specifi ca trattazione in Pagano 1990, 95-101; ma contra vedi Liverani 1987, 111-127.44
Sulle recenti indagini che hanno fatto emergere tratti della pavimentazione stradale, cfr. Alife romana 1982, 9-22; De Caro 1993, 688-689, De Caro 1999 b, 639-640; descritti in dettaglio da Miele 1991-1992 b, 130-132; De Caro, Miele 2001, 536; Miele 2004 b, 80-81.45
Sugli eventi alluvionali che modifi carono l’altimetria e l’aspetto dei luoghi a partire dall’epoca tardo-antica ad Alife e nel territorio campano, cfr. Finelli 1928 [1985], 9-56 passim; Caiazza et al. 1998, 66-74; Caiazza 2002 b, 17-32; Caiazza 2002 c, 33-53, e più in generale sui fenomeni idrogeologici in Campania, si vedano i contributi degli specialisti in I torrenti assassini 2002.46
Un’approfondita descrizione delle caratteristiche della cinta muraria alifana alla luce delle nuove indagini archeologiche si trova in Miele 1991-1992 b, 130-136, sp. 131; e soprattutto Miele 2001 a, 13-39 con bibl. precedente, tra cui si menzionano: Trutta 1776 [1976], 56-63; Finelli 1928 [1985], 82-88; Marrocco 1951, 33-38; Merolla 1964, 39-48; Brands 1998, 93-94.47
Recentissima è la notizia della scoperta di una postierla lungo il lato settentrionale delle mura, a breve distan-za dall’angolo nord-orientale e dal Castello medievale, corrispondente a quanto pare a quella tuttora in vista, situata più oltre in prossimità dell’angolo nord-occidentale; ma non è chiaro a quale epoca risalirebbero tali aperture nelle mura.48
CIL 2337; l’epigrafe, proveniente insieme alla 2338 dalle cd. Terme d’Ercole, presso San Potito Sannitico, fu oggetto di accesi dibattiti sin dal 1700, ma è ormai concordemente riconosciuta come autentica. Cfr. Trutta 1776 [1976], 19-28; Mennone 1894 [1997], 59-63; Marrocco 1916, 8-13; Marrocco 1920, 3-12; Finelli 1928 [1985], 81-82; Marrocco 1951, 34; Alife romana 1982, 19-22.49
Per le fasi medievali della fortifi cazione urbana di Alife si vedano Caiazza 2001 c, 81-145; Cielo 2001 b, 65-79 e bibl. ivi citata; De Caro 2003, 671-673; Tagliamonte, Esposito 2002, 183-191.50
Il bombardamento, la liberazione e le vicende di Alife durante la seconda guerra mondiale e l’immediato dopoguerra sono descritti in Guadagno 1993.51
Strutture forse abitative, esterne alla cinta muraria, sono state individuate in particolare a S in proprietà Ros-setti, su cui cfr. De Caro 1999 a, 793; e ad E, rinvenute in occasione della cementifi cazione del canale del Torano fi ancheggiante le mura e durante altri lavori pubblici lungo la statale 158, ma anche di recente, in proprietà Morelli, presso l’anfi teatro, con impianto termale e resti di mosaici, di intonaci dipinti e decorazioni in stucco fi gurate, su cui cfr. Zevi 2004, 879-880.52
Sull’organizzazione dello spazio pubblico in rapporto a quello privato, cfr. Gros 1981, 133-142.53
Sull’edilizia pubblica in Allifae, cfr. Miele 1991-1992 b, 133-134; De Caro, Miele, 2001, 536; Miele 2004 b, 82-83.54
Cfr. nell’ambito della letteratura antiquaria: Trutta 1776 [1976], 147-163; Mennone 1894 [1997], 82-84;Finelli 1928 [1985], 96; Marrocco 1951, 50-52; e più di recente De Angelis d’Ossat 1973, 47; Johannowsky 1973, 142-165, sp. 143-144, 146-147, 161-162; Staccioli 1973, 59; e ancora Johannowsky 1976, 269, 272, 274-275; Alife romana 1982, 27-32; Miele 2004 b, 82-83. Ma il prosieguo delle recenti indagini a cura del Prof. Federico Marrazzi, presentate da De Caro 2002 a, 672-673, ne potranno forse meglio chiarire destinazione
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 218
d’uso e fasi edilizie.55
Trutta 1776 [1976], 152-153; Mennone 1894 [1997], 82-84; Finelli 1928 [1985], 96; Marrocco 1951, 52-54; ma cfr. anche la descrizione in Alife romana 1982, 27-32.56
Johannowsky 1973, 146-147, 154.57
Nel saggio 5 S.I.P., su cui cfr. Miele 1991-1992 b, 133.58 Devo la notizia ancora al collega E.A. Stanco.59
Come tali considerate da Tocco 1984 b, 486.60
Così in Alife romana 1982, 95-108.61
Saggi 7 e 8 S.I.P., su cui Miele 1991-1992 b, 133-134; De Caro, Miele 2001, 536; Miele 2004 b, 83.62
Testimonianze epigrafi che attestano la presenza ad Allifae di attività artigianali e collegi professionali, a cui accennano Marrocco 1951, 89-91, 103-107; Mancini 20053, 54-55.63
Sulla storia del vescovado alifano cfr.: Trutta 1776 [1976], 379-388; Finelli 1928 [1985], 148-185; Marrocco 1979.64
Scoperto negli scavi eseguiti per il rifacimento della pavimentazione della Piazza alla fi ne degli anni Ottanta del secolo scorso, su cui cfr. Passaro 1990, 526-527.65
Oggetto di recenti studi antropologici ad opera del Dott. P. Petrone, ancora inediti.66
Per la descrizione cfr. Miele 1991-1992 b, 135; Miele 1997 c, 245-247.67
Numerosi i documenti epigrafi ci relativi a magistrati, per i quali oltre a CIL IX, 214-227, 674, si cfr. Trutta 1776 [1976], 99-109; 401-407; Marrocco 1951, 95-100; Alife romana 1982, 109-117; Mancini 20053, 21-28 e l’allegato catalogo epigrafi co, 105-157.68
Strutture pertinenti al teatro erano visibili all’epoca del Trutta 1776 [1976], 29-38. Ma cfr. Finelli 1928[1985], 90-92; Marrocco, 1951, 48-50 e la discussione in Alife romana 1982, 41-48.69
Allo scavo del teatro si accenna in Johannowsky 1973, 143-165, sp. 152; successive indagini furono eseguite negli anni Ottanta del secolo scorso, citate in Passaro 1990, 526-527.70
Come riferito in Atti Terra di Lavoro 1878, 10-11; Ruggiero 1888, 425-426; e cfr. l’approfondimento in Romeo 1999, 97-109.71
Trutta 1776 [1976], 29-38; Finelli 1928 [1985], 88; Marocco 1951, 48-50.72
Cfr. Tocco Sciarelli 1977, 301 segg.; ma cfr. anche Alife romana 1982, 57-68.73
Cfr. Passaro 1988, 737.74
Sul calendario alifano, cfr. Trutta 1776 [1976], 39-55; Fiorelli 1876, 101-102; Finelli 1928 [1985], 92-93; Marrocco 1951, 107-116; Alife romana 1982, 49-55; Mancini 20053, 21-22.75
Sul circo cfr. Trutta 1776 [1976], 29-38; Finelli 1928 [1985], 88-90; Marrocco, 1951, 48-50; Alife romana 1982, 49-55.76
Così Finelli 1928 [1985], 79-81; Marrocco 1917, 11-15; Marocco 1951, 119-121.77
Trutta 1776 [1976], 110-133; Finelli 1928 [1985], 73-78; Marrocco 1951, 80-83, 100-103; Alife romana1982, 95-108; Mancini 20053, 41-42.78
Cfr. Marrocco 1951, 46-48; Alife romana 1982, 33-39; Miele 1991-1992 b, 134-136; De Caro, Miele 2001, 534-536; Miele 2004 b, 84.79
Citato in Johannowsky 1973, 143-165, sp. 152, 161-162; ma si veda anche la ricostruzione in Alife romana 1982, 33-39. In generale sui mosaici ad Allifae cfr. Marrocco 1951, 88-89.80
Cfr. la descrizione in Miele 1997 c, 245-247. Sulle attestazioni di pitture parietali ad Allifae si veda anche Marrocco 1951, 85-88.81
Una dettagliata relazione si trova in Della Corte 1928, 238-240.82
La descrizione in De Caro 2003, 613-614.83
Citati in De Caro 1996, 576.84
Descritta in De Caro 1999 b, 639-640.85
Per l’illustrazione dettagliata della casa cfr. Crimaco 1991-1992 a, 136-137; Miele 1991-1992 b, 135-136; De Caro 1993, 689-690; ma cfr. anche De Caro, Miele 2001, 536; Miele 2004 b, 84.86
Cfr. De Caro 1999 b, 639-640.87
Cfr. testi citt. a nt. 45.88
Sulla cattedrale di Alife, cfr. Trutta 1776 [1976], 389-400; Finelli 1928 [1985], 196-215; e la monografi a di Cielo 1984.89
Come si è evidenziato nei saggi S.I.P. 1, 2, 3, 6, 9, 11; nel saggio 3 E.N.E.L., nel saggio 2 S.N.A.M. e lungo
219Allifae e il suo ager
il tracciato del metanodotto in Via Roma-Napoli e in Via Volturno. Cfr. anche Alife romana 1982, 9-22; Miele 1991-1992 b, 130-133; De Caro 1993, 688-689; De Caro 1999 a, 793-794; De Caro 1999 b, 639-640.90
Come in Via Erennio Ponzio e a Piazza Santa Caterina.91
Canalette di scarico sono state osservate nella suddetta proprietà Amato-Rea e nei saggi 6 e 11 S.I.P., e di recente in proprietà Pisaturo, su cui cfr. De Caro 2003, 613. Sui sistemi fognari cfr. anche Alife romana 1982, 93-94; Miele 1991-1992 b, 131-132; De Caro, Miele 2001, 536; Miele 2004 b, 82.92
Nel saggio 9 S.I.P.; cfr. Miele 1991-1992 b, 132.93
Nel saggio 3 S.N.A.M.94 Per la viabilità romana si veda in generale Radke 1973, c. 1487 segg., trad. it. 1981, 123-131, fi g. a pag. 128; e in precedenza Trutta 1776 [1976], 236-252; Marrocco 1951, 28-33; Mancini 20053, 55-58.95
Il rinvenimento è descritto in De Caro 1997 b, 409-410; Miele 1997 a, 60-66.96
La presentazione dei recenti rinvenimenti archeologici sulla viabilità extraurbana preromana nel territorio di Allifae si trova in De Caro 1999 a, 793-796; De Caro, Miele 2001, 530-531 e Miele 2004 b, 75; Ager Allifanus 2004 passim.97
La viabilità extraurbana e il relativo sistema di ponti di epoca romana nell’area sono descritti in Trutta 1776 [1976], 236-252; Marrocco 1951, 28-33; Carroccia 1989; Caiazza 1995, sp. 114, 128-131, 109-173; Caiazza 1997 b, 67-104; De Caro 1997 b, 409-410; Miele 1997 a, 60-66; De Caro, Miele 2001, 538; Miele 2004 b, 75-76; Mancini 20053, 55-58.98
Ad es. in area emiliana, su cui cfr. Ortalli 1984, 379-394.99
Cfr. Mancini 20053, 24-25.100
CIL IX 2353 = ILS 6513. Cfr. per la discussione Camodeca 1990, 123-143. Lo stesso personaggio è noto anche attraverso un’altra epigrafe funeraria databile agli inizi del I sec. d.C., su cui cfr. Mancini 1975, 108-110 e più di recente Parma 1990, 107-110, tav. I; Mancini 20053, 22-24.101
Sugli acquedotti di Alife cfr. Trutta 1776 [1976], 134-146; Finelli 1928 [1985], 92-95; Marrocco 1951,38-43; Alife romana 1982, 81-91; Mancini 20053, 69; ma di recente in modo più approfondito Cera 2005. Ulteriori ricerche archeologiche hanno portato all’individuazione di nuovi tratti, per la cui breve descrizione cfr. De Caro 1999 a, 795, De Caro, Miele 2001, 539-540; Miele 2004 b, 77; Mancini 20053, 55-58; Nava 2006, 590-591.102
Ad esso potrebbe forse essere connesso un condotto rinvenuto nel 2001-2002 fuori Porta Roma.103
Di recente ne hanno trattato Lombardi et al. 2004, 15-22.104
La villa è brevemente descritta in De Caro 1999 a, 793-796; De Caro, Miele 2001, 539-540; Miele 2004 b, 77.105
Rinvenuto nel 2000 e citato in De Caro 2001, 899-901.106
Sulle gentes alifane si vedano: Trutta 1776 [1976], 164-194; Marrocco 1951, 125-128; Mancini 20053, 37-41; 67-68. 107
Sui rinvenimenti nella necropoli urbana di epoca romana individuata ad es. a N-E della città cfr. Passaro 1987, 566-567; Passaro 1988, 737. Altre tombe pertinenti a necropoli romane sono state messe in luce di re-cente nel corso di vari scavi archeologici, su cui cfr. Ager Allifanus 2004, 181-222; 229-233: Zevi 2004, 879; Sampaolo 2005, 664-665.108
Su questo e sui mausolei sepolcrali Alifani, cfr. Trutta 1776 [1976], 195-210; Mennone 1894 [1997], 87-89; Marrocco 1918, 36-39; Finelli 1928 [1985], 98-99; Marrocco 1951, 55-60 e soprattutto de’ Franciscis, Pane 1957, 104-115; e ancora Alife romana 1982, 69-80; Mancini 20053, 69-72.109
Per la descrizione del monumento si veda Caiazza 1995, 128-131, tav. XXXII; e in seguito Miele 2004 b, 84-85.110
Sulle ville rustiche nell’ager Allifanus, Trutta 1776 [1976], 147-163; Finelli 1928 [1985], 95; De Caro, Miele 2001, 538-540; Miele 2004 b, 75-76; Mancini 20053, 37-41; 67-68. Sulla formazione e sullo sviluppo delle ville rustiche e sul sistema di produzione schiavistico, cfr. Johannowsky 1981, 299-309; Settefi nestre 1985; Ca-randini 1989, 104-192; Torelli 1990 a, 123-132.111
Sui criptoportici in contesti urbani ed extraurbani e in particolare su quelli Alifani: De Angelis d’Ossat1973, 47; Johannowsky 1973, 151, il quale considera come pubblico il criptoportico in località Taverna-Starze, per il ritrovamento di un frammento di epigrafe con la seguente iscrizione: M C[-] IVS QVIVS CLEM.[CALPV]RNIVS PISO. [-]IVS C.F. IIVIR; e Staccioli 1973, 59. Cfr. anche Trutta 1776 [1976], 147-163; Finelli 1928 [1985], 95; Mancini 20053, 37-41.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 220
112 Il Mancini (loc. cit. supra), per il rinvenimento sul posto dell’epigrafe CIL IX, 2338, identifi ca il sito cd.
Terme d’Ercole con la villa che Plinio il Giovane possedeva nella zona secondo le fonti letterarie antiche;: Cera, Rende 2007 c.d.s. Su di esso in precedenza cfr. anche Trutta 1776 [1976], 19-28; Marrocco 1916, 8-13; Finelli 1928 [1985], 81-82; Marocco 1951, 43-46; Marrocco 1980, 50. Altri recenti rinvenimenti di strutture e inse-diamenti agricoli sono descritti in Ager Allifanus 2004, 235-239; Nava 2006, 591-592.113
Il complesso residenziale è descritto preliminarmente in De Caro 1997 b, 409-410 e De Caro 1999 a, 793-796, e più in dettaglio in Miele 1997 a, 60-66; De Caro, Miele 2001, 539; Miele 2004 b, 76-77.114
Il sito è citato in De Caro 1999 a, 793-796; e illustrato in Miele 1997 a, 60-66; De Caro, Miele 2001, 539-540 e Miele 2004 b, 76-77.115
Sui rinvenimenti di ceramica tardo-antica e medievale in questo e altri contesti rustico-residenziali si vedano i contributi di Di Cosmo 1985, 7-24; Di Cosmo 1990, 171-179; Di Cosmo 1997, 123-128.116
Per questo fenomeno si vedano Di Cosmo, 2001, 111-128; De Caro, Miele 2001, 540, Miele 2004 b, 85-86, mentre una presentazione più ampia si trova nei contributi di Miele 2005 e ancora Miele 2007 c.d.s.117
La fonte documentaria principale per la storia dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno è il Chronicon Voltu-rnense, scritto tra il 1124 e il 1130 dal monaco Giovanni, tràdito manoscritto e infi ne edito da Federici in FSI 1925-1938. Sulla storia del monastero, fondazione benedettina dell’VIII sec. d.C. ad opera dei santi Pandone, Tatone e Tasone, e sulle ricerche ivi condotte dalla Scuola Archeologica Britannica in Roma e dal Prof. F. Ma-razzi, che ne fanno un fondamentale contesto storico-archeologico di riferimento, cfr.: Del Treppo 1953-1954, 37-59; Del Treppo 1955, 31-110; Pantoni 1980; De Benedittis 1995; Hodges 1995; Hodges, Marazzi 1995; Marazzi 1996; Mitchell, Hansen 2001; Marazzi, 2002.118
Cfr. a tale proposito Cielo 1990, 185-199, fi gg. 1-10.119
Una citazione preliminare delle recenti indagini archeologiche compiute nei siti è in De Caro 1996, 576, De Caro 1999 a, 793-796; De Caro 1999 b, 639-640; De Caro, Miele 2001, 540; e in modo dettagliato in Miele 2005 e Miele 2007 c.d.s. Sul sito cfr. anche Mancini 20053, 40-41.120
La prima notizia in De Caro 1999 a, 796; De Caro, Miele 2001, 540; Miele 2004 b, 85; mentre una descri-zione più estesa si trova in Miele 2005 e Miele 2007 c.d.s.121
Illustrata in Caiazza 1997 b, 67-104.122
È citato in Caiazza 1995, 114-118.123
I resoconti delle indagini archeologiche sono presentati da De Caro 1997 b, 409-410; De Caro 2000, 618; e in modo più ampio in De Caro, Miele 2001 b, 537; Miele 2001, 119-121; Miele 2005 e Miele 2007 c.d.s..124
Cfr. Trutta 1776 [1976], 195-210.125
de’ Franciscis, Pane 1957, 104-115, sp. 110-111; ma cfr. anche in generale sull’edilizia funeraria Toynbee 1993; Von Hesberg 1994.126
Cfr. ntt. 108, 109 e 125 supra.127
Sullo stesso lato del monumento, una piccola fossa circolare alloggiava forse la base di uno dei cippi, che dovevano segnare il confi ne di proprietà dell’area sepolcrale, separandola da altre adiacenti o da percorsi stradali interni, paralleli alla strada pubblica.128
In prossimità di un crollo presso il muro a S del mausoleo, è stato scavato un pozzo con canaletta di cui non si è potuto chiarire la funzione e la relazione precisa rispetto all’area sepolcrale.129
Del tipo II b Fabbricotti 1974, 28; Bailey 1988, 185, Q 1674, prodotto in Tunisia.130
Eseguite, ma non ancora edite, a cura del Dott. P. Petrone.131
Per il tesoretto monetale cfr. Arslan 1998, 29-30; Arslan 2001, 109-111.132
Su questo fenomeno cfr. in generale: Cielo 2000, 127-143; Caiazza 2001 a, 5-82; Caiazza 2001 b, 83-94; Cielo 2001, 95-110; Marazzi 2001, 129-143; Cielo 2002 a, 41-64 con bibl. ivi citata; e ancora in Miele 2005 e Miele 2007 c.d.s. 133
Sulla storia di Alife e del territorio circostante in epoca medievale e moderna, cfr. Trutta 1776 [1976], 360-378; 401-407; Mennone 1894 [1997], 63-81; Finelli 1928 [1985], 18-73; Marrocco 1985, 12-15.
L’antica popolazione di Presenzano (CE). Indagine paleopatologica e paleonutrizionale
Pier Paolo Petrone, Enzo Monetti, Luciano Fattore
IntroduzioneLo studio paleobiologico dei resti umani è in grado di fornire informazioni sullo
stato di salute e lo stile di vita di uomini vissuti nel passato: attraverso indagini di tipo paleodemografi co, paleopatologico e paleonutrizionale è possibile ricostruire il grado di adattamento bioculturale delle popolazioni nel tempo e le sue relazioni con l’ambiente naturale e socio-economico.1 Più specifi camente, il confronto tra dati di mortalità, analisi dell’incidenza delle patologie e tipo di dieta adottata costi-tuisce uno strumento per comprendere le relazioni esistenti tra comunità di diverse epoche e regioni.
Il materiale scheletrico preso in esame nel presente studio proviene da 65 sepol-ture della necropoli rinvenuta a Presenzano, località Masseria dei Monaci.
Indagini paleodemografi che Come accade anche per le popolazioni attuali, l’età di morte è fortemente cor-
relata agli standard di vita all’interno di una comunità, allo stato economico e alla pressione selettiva delle malattie.2 Mediante l’elaborazione di parametri demografi ci è possibile valutare il modo di estinguersi di una generazione nel tempo, il mutare della mortalità nelle diverse classi di età, gli intervalli di età critici. Correlata ad altri tipi di evidenze, un’analisi di questo tipo può essere indicativa del grado di adatta-mento bioculturale di una popolazione.3
Nel caso di Presenzano, l’analisi della mortalità per sesso e per classi di età eviden-zia alcune tendenze (fi g. 1), in vario modo presenti anche in altre comunità di età protostorica e storica. L’età media di morte è di 28 anni, considerando il campione di popolazione dai 15 anni in poi, con una media di circa 25 anni per le donne e di 30 per gli uomini. Le classi di età più colpite sono quelle comprese tra i 13 ed i 29 anni e, in modo particolare, lo sono le donne, la cui elevata mortalità in queste classi d’età è principalmente dovuta a problemi legati ai parti e alle gravidanze.
Viceversa, dopo i 30 anni c’è un’inversione a cui corrisponde una maggiore mortalità maschile, in quanto le donne che superano i 40 anni tendono ad avere migliori aspettative di vita.
L’apparente contenuta mortalità infantile non deve ingannare, essendo certa-mente sottostimata, come dimostrano le elevate frequenze tutt’oggi rilevabili soprat-
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 222
tutto nei paesi in via di sviluppo. Come spesso si verifi ca nello scavo di necropoli, i resti di bambini sono di più diffi cile rinvenimento, sia perché si preservano meno, sia per l’adozione in antico di pratiche funerarie particolari (ad es. la selezione, o la sepoltura in aree cimiteriali distinte).
P.P.P.
Analisi paleonutrizionaliLe ricerche paleonutrizionali sono rivolte alla ricostruzione delle diete delle anti-
che popolazioni attraverso l’analisi quantitativa di alcuni elementi minerali presenti in traccia (parti per milione/ppm) nelle ossa ed acquisiti per via alimentare.4 Analisi di questo tipo possono essere, inoltre, adottate per uno studio sulle conseguenze degli stress nutrizionali subiti dall’individuo nel corso dell’esistenza. Indagini del genere sono di notevole importanza non solo per la storia dell’evoluzione del modo di alimentarsi nel tempo ma, parallelamente ad informazioni desunte da altri tipi di analisi bioantropologiche, permettono di ricostruire lo stato di salute di una comu-nità e, più in generale, il grado di adattamento di determinate popolazioni all’am-biente naturale e socio-economico dell’epoca. Le analisi nutrizionali sono state effet-tuate su 51 campioni ossei di altrettanti individui della necropoli di Presenzano.
Circa la metodologia di laboratorio adottata, i campioni di ossa sono stati puliti con acqua distillata, per rimuovere eventuali residui presenti, e introdotti in stufa a 105°C per tutta la notte. Dopo l’essiccazione sono stati polverizzati in un mortaio
Fig. 1 - Mortalità (dx) per sesso e classi di età nella popolazione di Presenzano (VI - IV sec. a.C.).
( )
4,6
9,2
7,7
16,9
10,8
1,6
3,2 3,1
1,5
3,1
18,5
15,4
3,2
1,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0-6 7-12 13-19 20-29 30-39 40-49 50-70
classi di età
%Maschi Femmine
223L’antica popolazione di Presenzano (CE). Indagine paleopatologica e paleonutrizionale
di agata e incineriti a 500°C in muffola. Per ogni campione sono stati pesati 0,5 g e per la digestione si è fatto uso di un apparecchio a microonde della Milestone, con controllo di temperatura e tempi di digestione. I campioni sono stati trattati con 5 ml di HNO3 concentrato a 200°C per circa 2 ore, dopodiché sono stati ripresi con HNO3 fi no ad evaporazione totale. Il residuo è stato ripreso con HCL fi no a completa dissoluzione e, dopo raffreddamento, portato a volume 50 ml. Per la determinazione quantitativa degli elementi è stato usato uno spettrofotometro ad assorbimento atomico – Perkin-Elmer 2100 – per la determinazione quantitativa degli elementi. I volumi sono stati calcolati in mg/g (milligrammi per grammo) di Calcio (Ca) e in ppm (parti per milione) di Stronzio (Sr), Zinco (Zn), Magnesio (Mg) e Rame (Cu).
I vari elementi sono presenti in quantità diverse negli alimenti, con una più alta concentrazione di Zinco e Rame nei cibi di origine animale, e di Stronzio e Magne-sio in quelli di origine vegetale.5 Il Calcio, pur non fornendo direttamente informa-zioni di tipo nutrizionale, essendo parte integrante della matrice ossea è preso come riferimento a cui rapportare Zinco e Stronzio, che sono gli elementi più signifi cativi, essendo molto stabili nell’osso e poco soggetti ad alterazione diagenetica (ad es. per azione dei batteri nel terreno).6
Il livello di Zinco nell’osso rifl ette direttamente l’adozione di carne rossa, di latte e dei suoi derivati nella dieta. Inoltre, valori particolarmente alti sono corre-labili al consumo di crostacei e di ostriche ed in misura minore di frutta secca e legumi.7 Ma anche in modo indiretto i valori di Zinco nell’osso sono egualmente importanti. Infatti, lo Zinco viene legato a livello intestinale dai fi tati, presenti nei cereali a chicco intero e nel pane non lievitato. In tal modo, valori bassi di questo elemento possono rifl ettere sia un consumo limitato di carne (e/o prodotti ittici) nella dieta, sia l’uso di pane non lievitato e proteine cereali non raffi nate.8 Lo Stronzio si trova in concentrazioni particolarmente elevate nei vegetali e nei ce-reali in genere, ma è anche presente nei prodotti ittici.9 Essendo presente in quan-tità elevate nelle ossa degli erbivori, ma non in quelle dei carnivori, e risultando variabile nelle piante, nell’acqua e nel terreno, tale elemento viene standardizzato rapportando lo Sr/Ca umano con quello animale erbivoro di eguale provenienza (correzione del sito). Quanto più tale valore si avvicina all’unità tanto maggiore è la parte di vegetali e/o di carboidrati assunti nella dieta.10 Altri elementi testati sono il Rame, presente in alcuni carni rosse, oltre che nella frutta secca e nei cro-stacei, e il Magnesio che, essendo parte integrante della molecola della clorofi lla, è correlabile al consumo di vegetali.
L’analisi dei valori medi ottenuti per i vari elementi (fi g. 2) e dei relativi rapporti Zn/Ca (0,49 ppm) e Sr/Ca (0,35 ppm) fornisce informazioni interessanti sulla dieta degli antichi abitanti di Presenzano. I valori medi rilevati per Zn/Ca e Sr/Ca, con-frontati con i valori noti per le popolazioni antiche comprese tra il VI sec. a.C. ed il
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 224
I sec. d.C. di Alfedena, Populonia, Tarquinia, Siracusa ed Ercolano,11 si dimostrano elevati per lo Zinco e contenuti per lo Stronzio (fi g. 3).
Tenendo conto di entrambi i valori di Zinco e Rame, possiamo supporre un utilizzo notevole di carni rosse e di legumi. Le differenze riscontrabili a livello individuale sono indicative di una dieta più ricca di proteine per alcuni rispetto ad altri, confermando una prevedibile diversifi cazione sociale. In generale, gli uomini con valori superiori rispetto alle donne, sia assoluti (149,4 ppm contro 129,6 ppm) che in rapporto al Calcio (0,44 contro 0,39), mostrano una dieta più ricca di proteine animali. Al contempo, i valori di Stronzio, Magnesio e Rame, sostanzialmente simili nei due sessi, suggeriscono una dieta povera di alimenti marini, quali crostacei e frutti di mare, e contenuta di proteine di origine vegetale. Notevole invece doveva essere il consumo dei carboidrati, come con-ferma la frequenza particolarmente elevata di carie riscontrata. In questo caso, è evidente l’utilità del confronto tra dato nutrizionale e dato patologico.
P.P.P. - E.M.
Studio paleopatologicoL’osteoartrosi (meglio defi nita come osteoarthritis in letteratura anglosassone) è
una delle più ricorrenti e diffuse patologie dell’antichità.12 Si tratta di lesioni di tipo degenerativo legate ai processi di invecchiamento, quale conseguenza dell’usura connessa all’attività meccanica delle articolazioni.13 Tale processo può insorgere
Fig. 2 - Valori medi della concentrazione di alcuni elementi in traccia rilevata nelle ossa umane a Presenzano (in mg/g per il Calcio e in ppm per gli altri elementi).
PRESENZANO Masseria dei Monaci
Paleonutrizione - Elementi in traccia
62
157
355
235
38
67
144
371
234
43
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Sr
stronzio
Zn
zinco
Ca
calcio
Mg
magnesio
Cu
rame
pp
m
Maschi Femmine
225L’antica popolazione di Presenzano (CE). Indagine paleopatologica e paleonutrizionale
precocemente in seguito ad una intensa attività fi sica indotta da fattori di tipo culturale.14
L’analisi di questa patologia sulle ossa degli antichi abitanti di Presenzano mo-stra una sua costante espressione in forme più o meno severe, talvolta riscontrabile nelle ossa di individui di età giovanile e, dunque, correlabile ad un intenso uso delle articolazioni (e degli arti) nel corso dell’esistenza in attività fi siche impegna-tive. L’analisi del grado di espressione individuale dell’osteoartrosi (OA) per sesso e per classi di età, mostra come i maschi siano più colpiti da artrosi medio/forte rispetto alla donne (60,7% contro il 39,3%) (fi g. 4). Una differenziazione è ri-scontrabile nei due sessi a riguardo delle diverse classi di età in cui si manifesta l’artrosi; in età giovanile è più elevato il numero di donne interessate dalla lesione, mentre i maschi sono costantemente più colpiti dai 30 anni in poi.
P.P.P.
La carie ed altre lesioni della boccaLa composizione e la consistenza dei cibi consumati infl uiscono sia sui denti
che sui mascellari, pertanto lo studio delle lesioni che colpiscono entrambi (carie, ipoplasia dello smalto, ascessi, perdita intra-vitam) può dare indicazioni dirette sul tipo di dieta e della sua adeguatezza nutrizionale.15 In particolare, la carie è una delle lesioni dentarie più diffuse nell’antichità. Già in età romana, le frequenze d’inci-
Fig. 3 - Confronto tra i valori Sr/Ca e Zn/Ca rilevati per Presenzano ed altre popolazioni dell’Italia centro-meridionale (VII sec. a.C. - I sec. d.C.).
Italia Centro-Meridionale
Paleonutrizione - Elementi in traccia
0,49
0,36
0,81
0,34
0,43
0,47
0,35
0,54
0,68
0,82
0,660,68
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Presenzano
VI-IV a.C.
Alfedena
VII-IIIa.C.
Populonia
IV a.C.
Tarquinia
III a.C.
Siracusa
III a.C.
Ercolano
79 d.C.
Zn/Ca Sr/Ca
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 226
denza e soprattutto le modalità di espressione di questa patologia sono decisamente paragonabili a quelle di età moderna.16 Il trattamento e la cottura dei cibi, oltre che le caratteristiche stesse degli alimenti consumati, hanno portato ad una graduale diminuzione dell’abrasione dentaria a favore di un costante aumento delle carie e di altre patologie parodontali. Incremento demografi co e della produttività alimentare sono andati di pari passo, ma hanno inevitabilmente comportato un generale impo-verimento delle diete,17 basate essenzialmente sui carboidrati e gli amidi, principali responsabili dell’insorgenza delle lesioni cariose.
A Presenzano l’incidenza di questa patologia è molto elevata, essendo il 37% dei denti colpiti da almeno una carie, su un totale di 1127 denti esaminati, con le donne (38,6%) più colpite degli uomini (35,8%), soprattutto considerando l’età media inferiore di 5 anni rispetto agli uomini. Tali frequenze suggeriscono che gli alimenti adottati fossero altamente cariogeni. La maggiore incidenza rilevata per le donne sembra confermare la maggiore suscettibilità femminile.18
Circa le altre patologie considerate, ascessi periapicali, perdita intra-vitam e retra-zione alveolare, si evidenzia una maggiore incidenza negli uomini, soprattutto per quel che riguarda la perdita di denti in vita, con una frequenza del 14,5% contro il 4,5% delle donne. Ciò può essere dovuto a più fattori, quali l’età media, come abbiamo visto più elevata, ed altri, come particolari attitudini alimentari.
P.P.P. - L.F.
Stress nutrizionali e da malattie
Fig. 4 - Grado di espressione dell’osteoartrosi (OA) per sesso e per classi di età alla morte rilevato a Presenzano.
25
10,7
25
60,7
3,67,1
28,6
39,3
0
10
20
30
40
50
60
70
18-29 30-39 40-x 18-x
%Maschi Femmine
227L’antica popolazione di Presenzano (CE). Indagine paleopatologica e paleonutrizionale
Lo stress è una risposta fi siologica dell’organismo a mutate ed avverse condizioni ambientali;19 la sua entità dipende da durata dello stimolo negativo e condizioni di salute dell’individuo.20 Lo stress dovuto a carenza nutrizionale può avere conseguenze cumulative – con implicazioni ad esempio sulla mortalità – se i suoi effetti sono pro-lungati nel tempo, o semplicemente episodiche – formazione delle ossa o dei denti – se ristretti ad un breve arco temporale.21
Durante i primi sei anni di vita si completa lo sviluppo delle corone dei denti anteriori permanenti (amelogenesi). Tale processo è molto sensibile agli stress e può rallentare o interrompersi causando delle depressioni sulla superfi cie anteriore del dente, note come ipoplasia lineare dello smalto. Queste impronte sono permanenti, costituendo un vero e proprio “registro biologico”.22 Nel corso delle epoche stori-che, l’incidenza dell’ipoplasia aumenta passando da economie di caccia-raccolta ad altre di tipo misto, fi no alle economie agricole di tipo intensivo.23 All’insorgere dell’ipoplasia contribuiscono anche le malattie infettive, maggiormente diffuse in condizioni igieniche precarie e/o di sovraffollamento, oppure particolari condizioni socio-culturali, quale ad esempio la schiavitù.
In questo studio, l’ipoplasia lineare dello smalto è stata misurata ed elaborata su 61 individui. I dati ottenuti sono stati confrontati con quelli noti per la popolazio-ne di Ercolano24 ed alcune comunità di schiavi di età imperiale dei Campi Flegrei, afferenti a ville rurali di produzione.25
La percentuale di individui affetti da ipoplasia è abbastanza simile nei tre cam-pioni di popolazione esaminati (Presenzano 91,7%; Ercolano 96,1%; Campi Fle-
Fig. 5 - Confronto della distribuzione dell’ipoplasia dello smalto per classi d’età (5 mesi) tra la comunità di Presenzano e quelle di Ercolano (79 d.C.) e dei Campi Flegrei (II sec. d.C.).
Distribuzione dell'ipoplasia in Campania
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
0.0-0.4 0.5-0.9 1.0-1.4 1.5-1.9 2.0-2.4 2.5-2.9 3.0-3.4 3.5-3.9 4.0-4.4 4.5-4.9 5.0-5.4 5.5-5.9 6.0-6.5
Intervalli di età
Presenzano
Ercolano
Campi Flegrei
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 228
grei 95,2%), in linea con la considerazione che lo stress è una risposta fi siologica, mentre la frequenza dei denti colpiti, dato che meglio quantifi ca il grado di stress, mostra chiaramente che la popolazione di Presenzano (43%) è in linea con Ercola-no (47,3%), ma nettamente meno soggetta a stress rispetto a comunità di schiavi come quelle dei Campi Flegrei (dato 67,2%). Anche nel confronto della distribu-zione dell’ipoplasia per classi di 5 mesi (fi g. 5), Presenzano ed Ercolano mostrano un andamento simile, con un aumento signifi cativo di incidenza tra 1,5 e 2,5 anni e associabile, dunque, allo svezzamento, mentre le comunità fl egree mostrano un prematuro aumento di incidenza già a partire dal primo anno.
Gli antichi abitanti di Presenzano sono in tal modo associabili a popolazioni in cui una dieta a base vegetale è integrata da importanti contributi di origine animale, come mostrano chiaramente anche i risultati delle analisi nutrizionali, mentre in una comunità di schiavi una dieta a maggiore contenuto proteico è disponibile solo per alcuni e per determinati periodi, cosa che possiamo ipotizzare sia in relazione alle attività produttive cui uno schiavo è soggetto.
Dunque, a Presenzano si rilevano delle condizioni di vita certamente superiori a quelle delle comunità fl egree e del tutto simili a quelle degli abitanti di una città come poteva essere Ercolano nel 79 d.C.
L.F. - P.P.P.
Note1 El-Najjar 1978.2 Brothwell, Higgs 1969.3 Angel 1975.4 Klepinger 1984.5 Sillen-Kanavagh 1982.6 Lambert et al. 1983.7 Bisel 1991.8 Reinhold 1972.9 Lambert et al. 1979.10 Bisel 1991.11 D’Alessandro, Capasso, Bartoli 2000.12 Jurmain 1990.13 Woods 1986.14 Angel et al. 1987; Jurmain 1977; Jurmain 1980; Petrone 1994.15 Luckacs 1989.16 Hillson 1986, part. 283-323.17 Cohen, Armelagos 1984.18 Alciati, Fedeli 1983.19 Levi 1972.20 Martin, Goodman, Armelagos 1985.21 Coppa 1991.22 Goodman, Armelagos, Rose 1980.23 Goodman et al. 1984.24 Petrone, Fattore, Monetti 2002.2% Fattore, Petrone 1997.
L’acquedotto romano Formose-Torelle e il grottinodella Pincera a San Potito Sannitico
Nicolino Lombardi
PremessaLa località Formose di San Potito suscita già di per sé l’interesse degli studiosi
di toponomastica, che intravedono la possibilità che il toponimo1 sia legato alla presenza di forme e acquedotti per la cattura e il trasporto dell’acqua. Spesso nei racconti delle persone più anziane del paese, sulla scena di un avvenimento c’è un cunicolo che da palazzo Sanillo, in località Formose, o dalla località Torelle,2 porta fi no ad Alife; molte persone raccontano di averne percorso un tratto e di essere tornati indietro a causa di un crollo o per mancanza di aria o, più semplicemente, per paura di proseguire. Le stesse indicazioni dei proprietari dei fondi, le emergenze archeologiche, i reperti consegnati per il passato e i materiali che affi orano nell’area compresa fra le località Formose e Torelle hanno da sempre suscitato l’interesse degli archeologi e degli storici. Gli studiosi che si sono occupati del sito, propendendo per la villa o per le terme, fi niscono per dare un quadro per alcuni versi completo di una struttura (villa, terme o villa con terme che sia) in località Torelle con un acquedotto di pertinenza, che parte dalla località Formose.
Enrico Sanillo, uomo ricco e geniale di inizi ’800, ha modo di visitare l’acque-dotto romano in quanto la sua abitazione insiste proprio sui rami di cattura e nel 1855 realizza in un fondo di sua proprietà il grottino della Pincera, che nelle fattezze e nella funzione è molto vicino all’opera antica.
L’acquedottoI Romani furono abili ingegneri e architetti: per le loro grandiose opere pubbli-
che, conservatesi nei secoli, svilupparono tecniche di costruzione effi caci e innova-tive. Tra le imprese maggiori fi gurano proprio gli acquedotti, che erano in grado di trasportare acqua dalle fonti di montagna fi no alle aree abitate più lontane.
Premetto che è tecnicamente possibile che un acquedotto dalle Formose condu-ca per caduta l’acqua alle Torelle, in quanto i rami di cattura, presso le Formose, si trovano a circa m 260 s.l.m. e le strutture delle Torelle a circa m 255 s.l.m., quindi raggiungibili proprio per un fatto di pendenze naturali, che sono addirittura ecces-sive, poiché nelle condotte «la muratura sia il più solida possibile e il letto del canale abbia una pendenza livellata di non meno di un sicilio3 per ogni cento piedi, e queste costruzioni in muratura siano fatte a volta, in modo che il sole non colpisca l’acqua».4
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 230
L’acquedotto, che ha uno svilup-po complessivo di circa 1100 metri, si compone di due lunghi tratti pressoché dritti che si sviluppava-no in parte sotto terra, in parte in superfi cie, «egli è efi ftente, ed intiero fi no al luogo detto le Formofe, appun-to da tali forme, e che paffa al di fopra del Villaggio di San Potito [...] il ri-manente di effo cuniculo, fe ben fecco, e pieno di terra, apparifce in molti terreni arborati con la direzione verfo la cima della nominata collina, dove portava le acque, parte fotterranea-mente, e parte fopra di muri. Egli ha di larghezza due palmi, e di altezza quanto un uomo poteva andarvi per entro, mifurato da me in una frattura fra quelle poffeffi oni».5
Le acque «tiepide e falubri, fca-turifcono all’Oriente del Villaggio di S. Potito, in un querceto, intorno
a cinquecento paffi lontano e poiché il luogo della fontana non ebbe a parergli aprico a baftanza penfò per fotterraneo acquidotto trafportarne le acque fulla cima della più amena, e bella collina di tutte le Alifane contrade [...] Ma per tornare alle noftre Terme ed al Cuniculo che dall’accennata forgiva portava l’acqua alle medefi me».6
Dopo il tratto della cattura, localizzato presumibilmente nell’area fra palazzo Sa-nillo e la chiesa di San Michele, è possibile accedere, attraverso un pozzo presente al-l’interno di palazzo Sanillo, alla vera e propria condotta, percorribile fi no al pozzo di una abitazione privata che dista circa 80 m dal pozzetto d’accesso. Su questo tratto di acquedotto si innestano due pozzi indispensabili alla manutenzione ed utilizzati, quando la condotta era ancora attiva, per scopi irrigui.
Vitruvio nell’opera De Architettura rammenta che nella realizzazione di un ac-quedotto « i pozzi saranno costruiti in modo da trovarsi ogni duecentoquaranta piedi»7 e nel nostro acquedotto quattro pozzi su cento metri sono davvero troppi. Tutto trova spiegazione nel fatto che non tutti i pozzi incontrati risalgono al periodo della realizzazione dell’acquedotto.
Il secondo pozzo dell’acquedotto delle Formose è successivo (è possibile osserva-re la sezione dell’acquedotto che è stata tagliata per raggiungere dal giardino della proprietà Filangieri la condotta) e l’ultimo pozzo, quello ricadente nella proprietà
Fig. 1 - Un tratto dell’acquedotto della Pincera.
231L’acquedotto romano Formose-Torelle e il grottino della Pincera a San Potito Sannitico
D’Orsi, è recentissimo ed è stato motivo di disputa legale fra le famiglie Filangeri e D’Orsi.
Poco più avanti, l’acquedotto ricompare nei locali destinati a cantina di proprietà dell’armiere Antonio Civitillo e poi, pare, sia ricomparso ancora più avanti, nel cor-so dei lavori per asfaltare via Aulecine.
L’acquedotto proseguiva diritto in direzione Piedimonte, procedendo parallela-mente alla via Aulecine8 (la via vecchia per Sepicciano) per poi dirigersi, sempre con tratti rettilinei, verso la collina delle Torelle. Mentre il primo tratto dell’acquedotto viaggiava quasi sempre sottoterra, il secondo segmento, quello che si sviluppava su un lungo muro, diritto verso le Torelle, si presentava come una condotta forse a cielo aperto, avente una sezione di cm 40 di larghezza per cm 60 di profondità, ancora oggi verifi cabile. Forse era coperta con tegoloni o con blocchi di tufo.
Proprio nel punto in cui l’acquedotto piegava e si dirigeva verso la villa, si posso-no osservare grosse quantità di pietre disseminate al suolo. Forse era localizzato pro-prio in questo punto un serbatoio che consentiva di smaltire parte del dislivello.
Viene naturale chiedersi perchè l’acquedotto arrivasse fi n qui, quando sul dosso, e quindi molto prima, poteva già piegare verso la località Torelle, magari facendo lo stesso percorso del vallone di sistemazione idrogeologica realizzato successivamente per deviare l’acqua che da Valle del Londro si riversava attraverso via del Rivo in territorio di San Potito e che oggi taglia due volte il percorso dell’acquedotto. È pos-
Fig. 2 - Veduta aerea di San Potito Sannitico.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 232
Fig. 3 - L’acquedotto Formose-Torelle prima dello sbar-ramento realizzato per sollevare il livello dell’acqua.
sibile che oltre ad avere un impiego idrotermale, l’acquedotto possa es-sere stato utilizzato anche per scopi irrigui per i terreni di pertinenza delle terme, che raccogliesse anche acque da qualche altra sorgente oggi non più attiva e che lo stesso, dove si elevava dal piano, limitasse anche la proprietà di pertinenza delle ter-me.
Il breve tratto di condotta a cielo aperto conservato sul muro di sostegno che dalla via vecchia per Sepicciano corre diritto verso le Torelle presenta un’alveo quasi ostruito dalle concrezioni calcitiche che si sono formate nel momento in cui l’acquedotto non è stato più oggetto di manutenzione. Fra l’altro sulla parete esposta a nord ovest del muro di sostegno dell’acquedotto è ancora possibile osservare numerose colate calcitiche generate dalle per-dite d’acqua della condotta che vi correva sopra.
Sulla sinistra venendo da Piedi-monte, accanto al muro dell’acque-dotto, poco prima del dosso e prima
che si veda San Potito, sono state evidenti fi no a qualche anno fa le tombe venute alla luce quando il muro venne tagliato per realizzare la strada Piedimonte-Telese.
I frammenti di tegoloni, di tufo scuro, di olle e pareti di vasi osservati nell’area, fanno supporre che il terrazzo generato dal lungo muro possa essere stato utilizzato come necropoli; difatti il vecchio cimitero delle Torelle non è molto distante dal-l’area, a dimostrazione della vocazione del sito.
Sulle Torelle, all’interno della proprietà che fu dei Gaetani, del prof. Pellegrino, e che oggi appartiene alla famiglia Eugenio Palmieri-Annamaria Carena, è ancora visibile il tratto terminale dell’acquedotto, quello che si immetteva nel grosso serba-toio circolare localizzato nell’angolo a settentrione dell’area di interesse archeologi-co. L’acquedotto raggiungeva quindi le Torelle, ma già prima del serbatoio, a detta dell’attuale proprietario del fondo, si biforcava per raggiungere con rami separati, le terme localizzate all’interno degli edifi ci e le fontane che si trovavano all’angolo sud,
233L’acquedotto romano Formose-Torelle e il grottino della Pincera a San Potito Sannitico
nelle nicchie ricavate esternamente al muro di cinta, dove in passato sarebbero stati rinvenuti doccioni in piombo.
Non è diffi cile ipotizzare che per l’esecuzione del primo tratto dell’acquedotto, quello più prossimo alle sorgenti, sia stato realizzato lo scavo di una trincea, la co-struzione dell’acquedotto nella trincea a cielo aperto e la ricopertura dello stesso e, che per il secondo tratto, quello prossimo alla località Torelle, si sia proceduto ad innalzare un muro di sostegno all’acquedotto affi nché l’opera idraulica viaggiasse in piano.
I ruderi delle Torelle Non è il caso di chiedersi se ci troviamo in presenza di una villa o di una villa con
terme o delle terme di Alife, in quanto è ovvio che in assenza di uno scavo non si possa andare oltre le semplici supposizioni.
Gianfrancesco Trutta è il principale sostenitore dell’ipotesi delle terme e dedica alla loro descrizione un intero capitolo delle sue Dissertazioni. L’autore riferisce che nel 1690, le terme per «lungo tempo sepolte, [...] ne da altri vedute o descritte, furono fi nalmente scoverte [...] in una collina [...] per opera dell’eccellentissimo Sig. D. Niccolò Gaetani d’Aragona Duca di Laurenzana e conte di Alife, di ogni buona letteratura, non che dell’erudita antichità intendentissimo».9
Fig. 4 - Pianta e sezione del tratto di acquedotto romano insistente sulla proprietà Filangieri.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 234
L’ipotesi che vede nei ruderi delle Torelle i resti delle terme restaurate da Fabio Massimo, è però contestata da molti studiosi, i quali ritengono che l’Alife del I e II secolo dell’Impero Romano, come ogni Municipio aveva sicuramente le sue terme dentro le mura o nel pomerio, cioè nella fascia esterna ed interna che correva lungo le mura delle città e che queste non potevano trovarsi a 6 Km dalla città, come quel le presunte di San Potito.
Per onestà va però ricordato che anche le terme di Telesia si trovano abbastanza distanti dalla città, anche se in questo caso la distanza è giustifi cata dalla presenza della acque termali, cosa che invece non succede per la sorgenti di San Potito.
Va osservato anche, che le facciate più imponenti della costruzione, in pratica quelle delle arcate del terrapieno che si eleva fi no ad 8 metri di altezza e che prose-guono verso nord ovest col lungo muro dell’acquedotto, rivolgono proprio alla città di Alife, per cui vista da Alife la collina delle Torelle assume carattere monumentale funzionale alla città stessa, anche se oggi il bosco ne oscura la vista.
Va pure detto che la stessa strada dritta di collegamento con la città è probabil-mente in parte sopravvissuta con la strada San Vittore, che prosegue attraversando la proprietà Casino del Duca fi no ad arrivare in via Aldo Moro, dove se ne perdono le tracce.
La stessa «iscrizione,
FABIUS MAXIMUS V C RECTOR PROVTHERMAS HERCULIS VI TERRAE MO
TUS EVERSAS RESTITUIT A FUNDAMENTIS
pervenuta da tempo immemorabile in Piedimonte da San Potito Sannitico»10 ed oggi murata nel chiostro di San Domenico di Piedimonte Matese, in ricordo di Fabio Massimo, che riedifi cò dalle fondamenta le terme di Ercole distrutte dalla forza del terremoto, non ci è di aiuto.
C’è da dire, infatti, che il nodo impossibile da sciogliere è proprio la provenienza dell’epigrafe, l’elemento che offre il più valido contributo ai sostenitori dell’esisten-za di edifi ci termali in località Torelle. L’epigrafe, infatti, venne «vista dall’Accursius (1489-1546) nelle scale dell’altare maggiore di Santa Maria della Neve, in Alife»,11 ed in questo luogo vi era stata portata da chissà dove.
L’iscrizione riportata dal giureconsulto Accursio è stata successivamente ripresa da Gianfrancesco Trutta nel 1776, dal Ciarlanti nel 1823, da Raffaele Marrocco nel 1916 e dai numerosi studiosi di storia locale che hanno affrontato l’argomento.
Non ci è d’aiuto nemmeno l’iscrizione12 del 1732, forse mai apposta, che ricorda la riattivazione o forse l’intenzione di riattivare l’acquedotto da parte di Nicola Gae-tani D’Aragona, Principe di Piedimonte, Duca di Laurenzana e Conte di Alife:
235L’acquedotto romano Formose-Torelle e il grottino della Pincera a San Potito Sannitico
Nicolaus Caietanus AragoniusPedemont. Princ. Laurent. Dux. Allif. Com.
Villam. Hanc. Aragniam.Revocatis. ab. Ipsa. Scaturigine. Aquis.
Quas. In. Usum. Thermarum. Herculis. Veteres. Derivaverunt. Subiectaq. Area.
Ac. Per. Ampla. Via. Lapide. Munitis.Sibi. Suisque Excitavit. Exornavitq.
Anno M.DCC.XXXIID.O.M. (post non ante)
…L’iscrizione, infatti, fa riferimento alle terme di Ercole solo perchè è l’ipotesi più
accreditata fra gli studiosi del sito di quell’epoca.N. Mancini avanza per i ruderi delle Torelle l’ipotesi della villa Camil-
liana: «Tra le tante lettere dell’epistolario di Plinio il Giovane, ve ne sono tre per un tal Pontius Allifanus, certamente cittadino di Alife ed intimo amico del nobile personaggio comasco. [...] I due amici si incontrarono spesso anche in Campania, nella villa Camilliana, dove Calpurnia, moglie di Plinio vi andava a riprender salute, lontana dai clamori e dal clima della capitale, ricevendovi, insieme al ma-rito, grande abbondanza di prodotti, offerti dagli amici di Ponzio.
La giovane sposa, orfana di entrambi i genitori era stata allevata dal nonno, L. Calpurnio Fabato, ricco cittadino di Corno, il quale tra le tante proprietà, aveva anche la villa Camilliana, che volentieri metteva a disposizione della nipote.
Gli studiosi di Plinio il Giovane non sono riusciti a localizzare questa lussuosa residenza rurale perchè è mancato loro quell’indizio che è nell’opera del Trutta, il quale, descrivendo i ruderi che erroneamente attribuisce alle Terme di Ercole, dice che vi si rinvennero molti doccioni di piombo de’ quali in uno erano incise le lettere T. CAESARIS, in un altro C. CASSII CAMILLI ed in un altro FRON-TONIS.
Perciò i bellissimi pavimenti a mosaico e le fontane e le stufe ed i bagni e quanto a tali edifici era necessario e conveniente fino all’eccesso appartengono a quella villa, detta Camilliana dal nome del primo proprietario, C. Cassio Camillo, acquistata poi da Calpurnio Fabato [...] Dallo stesso Plinio apprendiamo che la villa era un po’ malandata e bisognosa di riparazioni che egli si offre di sorvegliare e dirigere, ma non può affidare la conduzione della proprietà a persona esperta e capace, come chiede Fabato, perchè non conosce alcuno adatto a quell’incarico. Esprime però parere favorevole su un tale Rufo, che Fabato vorrebbe mandare da Como ad amministrare i suoi beni».13
L’autore in una nota aggiunge di non sapere se questo Rufo provenisse da Alife e che «il Trutta vide a Calvisi l’iscrizione di un Asellius Rufus, unico rap-
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 236
presentante della gens Asellia in Alife, nota nel resto dell’Italia Meridionale solo a Telesia e a Puteoli. È presente però anche nella Gallia Cisalpina, a Lambrugo, in quel di Corno».
Gli edifi ci, la piazza antistante e i portici del terrapienoNell’angolo a settentrione, querce e arbusti ricoprono la montagnola artifi cia-
le generata dai materiali di crollo degli edifi ci che un tempo occupavano l’area.Molto spesso, gli edifi ci importanti di epoca romana erano orientati con un an-
golo di 45° rispetto al meridiano, per “rompere” i venti del nord con le mura delle costruzioni (tutte disposte ortogonalmente) e proteggere così dal freddo i cortili interni. Presumibilmente anche gli edifi ci delle Torelle rispettavano tale regola.
Il muro di sostegno dell’acquedotto, con le arcate del terrapieno degli edifi ci delle Torelle formava un fronte scenico unico ben visibile per chi guardava da Alife.
L’elemento ripetitivo del terrapieno, in pratica l’arcata che funge anche da rin-forzo della muratura, non sempre si tiene costante e pertanto il suo sviluppo, oltre che in altezza, varia anche in orientamento per cui alcuni ambienti si sviluppavano perpendicolarmente all’arcata tipica.
Fig. 5 - Andamento dell’antico acquedotto romano Formose-Torelle.
237L’acquedotto romano Formose-Torelle e il grottino della Pincera a San Potito Sannitico
«L’Aia, offi a la piazza, che racchiudevafi dentro de’ Portici delle medefi me Terme, propriamente fulla cima della Collina, era di ben due moggi, e mezzo, di paffi nove-cento a moggio, e che aveva la fi gura di parallelogrammo, di paffi cinquanta dal lato di Oriente e di Occidente, e paffi quarantacinque dal lato di mezzo giorno, e Settentrione, dalla qual parte però erano gl’interni edifi ci, le rovine de’ quali fanno, che effa refti an-cora bofcofa, ed inculta particolarmente all’angolo, che riguarda Maeftro. Dalli tre lati di Mezzo Giorno, Occidente, e Settentrione, onde incomincia il declivio della collina, erano gli anzidetti Portici de’ quali ne reftano ancora in piedi alcuni intorno all’angolo, che riguarda Libeccio. È cofa affai notabile, [...] che i Portici [...] in dette Terme fono aperti al di fuori e chiufi al di dentro».14
I reperti della località TorelleUna volta abbandonato, il sito delle Torelle è stato a poco a poco spogliato di
ogni oggetto intanto che gli edifi ci collassavano. Nei secoli, le statue, le terrecotte e persino le pietre degli edifi ci sono state saccheggiate per essere riciclate in altri luo-ghi. «Allora che fe ne ritrovarono gli avanzi di quefte magnifi che Terme; che fu nel 1690 perché prima fen’era perduta ancor la memoria, e ftavano fra querce, cefpugli, e fpinai; effendofi fatto fbofcare, zappare in più luoghi, oltre i belliffi mi pavimenti a mofaico, e le fontane, e le ftufe, e quanto a tali edifi ci era neceffario e conveniente fi no all’ecceffo;
Fig. 6 - L’area Torelle: 1) il muro su cui viaggiava l’ultimo tratto dell’acquedotto; 2) i ruderi di un edificio nascosti dalla vegetazione;
3) il muro che sorregge il terrapieno antistante la costruzione.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 238
vi fi rinvennero molti doccioni di piombo, de’ quali in uno erano incife le lettere T. CAESARIS, in un altro C. CASSII. CAMILLI. ed in un altro FRONTONIS».15
Pare che sia stata ritrovata sulle Torelle l’epigrafe tuttora murata nel Museo civico di Piedimonte Matese e che ricorda la ricostruzione delle terme dopo un terremoto.
Nel 1775 poi, «è ftata ritrovata fra molte fpezzature di fi ni marmi, una tefta di bianco alabaftro orien-tale di circa tre palmi fotterrata nel-l’argilla, quale effendoci parfa opera di fi niffi mo greco fcalpello, ne diamo anneffo il difegno, e ne forniamo quefto giudizio; cioè che nonoftante che abbia un vifo femminile, che la potrebbe far credere una Regina del-l’Egitto, o dell’Afi a, io la credo una tefta del grande Aleffandro Macedo-ne, sì per l’età fua giovanile, sì per la
fi fi onomia, che del tutto fi mile a quella, che nelle di lui medaglie efpreffa fi crede, ma foprattutto per quelle corna di montone, che porta per cimiero fopra l’elmetto [...]Vicino allo stesso luogo fu già ritrovata la medaglia di argento, con la testa di un Giove, corona-to di quercia da un lato, ed un Tempio dall’altro».16
Su questa collina negli anni sono stati rinvenuti vari oggetti: una collana for-mata da sei chicchi di terracotta a forma di fusaiole biconiche di epoca preromana, una statuetta di tipo arcaico rappresentante una donna con bambino fasciato fra le braccia, una statuetta in terracotta chiara rappresentante una fi gura femminile drappeggiata alta cm 17, una statuetta in terracotta chiara rappresentante una fi gura virile nuda alta cm 15, un vaso in terracotta di epoca romana dalle pareti sottili e lisce, un vaso in terracotta di epoca romana, avente alla base degli incavi a guisa di ornamento «molte persone affermano di aver avuto modo di osservare mosaici nell’area settentrionale.In località Quercie di don Giacomo, in pratica ai piedi delle Torelle, nel 1934 venne scavata una tomba antica che non è stata però vista da nessun esperto e pertanto non risulta datata ed il Podestà delibera pagarsi a favore del falegname una somma destinata alle [...] spese per la costruzione di un cassettino per la conservazione di resti mortali».17
Fig. 7 - La statua rinvenuta sulle Torelle (da G. Trutta).
239L’acquedotto romano Formose-Torelle e il grottino della Pincera a San Potito Sannitico
Enrico SanilloSono passati circa 200 anni, quando agli inizi dell‘800 e precisamente il 24 set-
tembre del 1820, nasce da una famiglia non nobile ma benestante, in una abitazione che si sviluppa proprio sui rami di cattura del’acquedotto romano, Enrico Sanillo.
Storia eccezionale quella di Enrico Sanillo sintetizzata nell’epigrafe che racchiu-de la sua tomba: «ricco, operoso, benefi co, nato il 25 settembre del 1820, fu ucciso da masnadieri penetrati nell’abitato la notte del 22 luglio 1865. Alfonsina Palmieri, sua moglie da 12 mesi ne raccolse il corpo piangendo inconsolabilmente».
Enrichetta, la bambina che nasce dopo la sua morte muore anch’essa prematura-mente «combusta il gentil corpo da terrestre vampa» e l’accaduto da adito a numerose ipotesi per via della successione delle proprietà.
Enrico da piccolo viene sicuramente in contatto con il primo tratto dell’acque-dotto, in quanto il palazzo di famiglia per i bisogni idrici sfrutta proprio questa con-dotta, attingendo l’acqua dai pozzi che immettono direttamente sulla conduttura principale. È probabile che il volume Dissertazioni Istoriche delle Antichità Alifane del canonico G. Trutta facesse parte della ricca biblioteca di famiglia, biblioteca oggi smembrata e impoverita a causa della vendita di buona parte dei volumi che la componevano e che Enrico ne avesse letto le pagine relative all’acquedotto. Fatto sta che ormai adulto, nel 1855, nella tenuta della Pincera, una fabbrica di laterizi di sua proprietà, Enrico Sanillo realizza un acquedotto per la cattura di alcune sorgenti superfi ciali che ricorda nella forma, nelle dimensioni e nella tecnica di costruzione l’acquedotto romano sottostante la sua dimora di via Formose.
Fig. 8 - Particolare dell’ingresso dell’acqudotto Sanillo in località Pincera
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 240
L’acquedotto Sanillo in località PinceraL’acquedotto, o meglio il grottino, come lo chiamano gli attuali proprietari, ha
uno sviluppo totale di poco superiore ai cento metri, presenta il cielo a volta, è alto mediamente m 2,30, largo m 1,10 e si compone di due rami disposti a diversa altezza, dei quali solo quello superiore è attivo, che confl uiscono su una condotta funzionale ad una grossa vasca di raccolta. A monte di entrambi i rami si trovano i pozzi indispensabili sia per l’aerazione che per la manutenzione della condotta. L’acquedotto versa in stato di abbandono e quindi presenta concrezioni soprattutto nel fondo, è ancora attivo ed ha una portata di 18 lt/minuto nel dicembre 2002 e di 5,5 lt/minuto il 7 settembre 2003. Tale sorgente è anche l’inizio del vallone detto Fosso dei Franci, che poco più a valle si approfondisce e segna, per un lungo tratto, il confi ne del comune di San Potito Sannitico con quello di Gioia Sannitica.
La vasca di raccolta delle acque, all’interno della quale nel 1911 affoga il picco-lo Angelo Lombardi a soli due anni, alcuni anni addietro è stata completamente rifatta.
La scritta sull’arco d’ingresso della condotta di cattura, la cui chiave riporta scol-pito lo stemma della famiglia Sanillo con la data 1855, ricorda che fu proprio Enrico a raccogliere le acque ed a strappare queste terre al bosco, con rime prima alterne e poi baciate:
ERAN POCHE ED OR SON MOLTED’OGN’INTORNO A FORZA D’ORO
QUI QUESTE ACQUE ORMAI RACCOLTECOL SUO GENIO A GRAN TESORO
INVERTIR DEL BOSCO UN DI’DEI SANILLO ENRICO ARDI’
Sicuramente Enrico Sanillo aveva visto e studiato i rami di cattura dell’acque-dotto romano sottostante il palazzo di sua proprietà a San Potito Sannitico e ne aveva preso suggerimento nella realizzazione dell’acquedotto per la cattura delle sorgenti nella sua tenuta della località Pincera. La cattura dell’acqua e la raccolta della stessa nella grossa vasca che si trova nelle immediate vicinanze delle sorgen-ti, oltre che indispensabile alla bonifi ca dell’area, probabilmente era funzionale all’azienda agricola e si rendeva indispensabile alla pincera, ossia nella fabbrica di tegole e mattoni che si trovava in questo luogo. Nel corpo di fabbrica centrale del grosso caseggiato dell’azienda, che presenta una stratifi cazione architettonica di duecento anni, ancora sopravvivono i forni all’interno dei quali veniva acceso il fuoco per cuocere le tegole e i mattoni. I pani di argilla da cuocere erano posti in due camere immediatamente soprastanti, comunicanti per mezzo di una struttura a salvadanaio con i forni. Il bosco di quercia di proprietà dell’azienda, che si trova
241L’acquedotto romano Formose-Torelle e il grottino della Pincera a San Potito Sannitico
nelle immediate vicinanze, forniva il combustibile indispensabile e le ghiande per i maiali18 allevati nell’azienda. Infatti, alle spalle del fabbricato sono ancora esistenti le porcilaie con solai a volta realizzati con pignatte forse prodotte in loco e scarichi utilizzanti l’acqua del grottino.
Note1 Il toponimo Formose, dal latino forma, è sicuramente legato alla presenza di sorgenti e di condotte per la cattura o il trasporto dell’acqua. Sant’Angelo in Formis è un toponimo simile, legato anch’esso alla presenza di opere idrauliche di cattura e condotta e così pure Formia.2 Il toponimo Torelle, di derivazione longobarda, sta ad indicare un’area elevata e povera di vegetazione. All’in-terno del territorio comunale di San Potito esistono le località: Torelle (area vecchio cimitero), Turegliu (zona via Starze), Via Torello (prossima alla chiesa di Santa Caterina), Torlone (nei pressi di via Aulecine) e la ‘rotta ru’ toru, così detta perché sottostante appunto ad una piccola area elevata e con vegetazione rara.3 Anche se le testimonianze archeologiche fanno registrare una grande varietà di soluzioni da un acquedotto ad un altro, la misura di cui alla nota corrisponde a circa m 0,20/Km, riferiti ad opere più imponenti e quindi ad acquedotti ben più lunghi di quello delle Torelle. 4 Gros 1997, libro VIII.5 Trutta 1776 [1976].6 Trutta 1776 [1976].7 Gros 1997, libro VIII.8 Quando l’acquedotto è andato in disuso, l’antica stradina che lo costeggiava ne ha parzialmente occupato la sede, per poi essere allargata ed asfaltata in questi ultimi anni. 9 Trutta 1776 [1976].10 Marrocco 1916, 8, nt. 2.11 Mancini 1993.12 M. Egizio, Opuscoli Volgari e Latini, 1751, 282.13 Mancini 1993.14 Trutta 1776 [1976].15 Trutta 1776 [1976].16 Trutta 1776 [1976].17 Archivio storico del Comune di S. Potito S., Delibera del Podestà n. 155, 13 ottobre 1934.18 L’allevamento del maiale è stato molto fi orente nelle aziende prossime a boschi di quercia in quanto la pre-senza di ghiande garantiva il cibo per molti mesi dell’anno. I maiali erano affi dati ai minori della famiglia o a garzoni. Sempre ad Enrico Sanillo apparteneva l’azienda Purchera, che si trova poco più a valle della Pincera. A chiarire l’attività principale dell’azienda è lo stesso toponimo.
Archeologia e lavori pubblici: l’esperienza del Treno ad Alta Velocità nell’Alto Casertano*
Gabriella Gasperetti
Le brevi note che seguono riguardano dati in buona parte noti alle comunità dell’Alto Casertano, che ha vissuto in prima persona la vicenda di una delle più im-portanti scoperte archeologiche effettuate durante i lavori per la realzzazione della linea ferroviaria ad alta velocità.
Il progetto del treno parte da una prima serie di elaborati, presentati alla So-printendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta verso la metà degli anni ’80 per il necessario nulla-osta. All’epoca l’Uffi cio era retto dalla dott.ssa Enrica Pozzi Paolini e la collega responsabile di zona, per il territorio che ci interessa, era la dott.ssa Luigia Melillo. Il primo progetto non ottenne un parere favorevole, poiché la linea ferroviaria avrebbe attraversato l’area urbana dell’antica Cales e i quartieri periferici di Teanum Sidicinum, centro che in antico era molto più esteso dell’abitato moderno.
Dopo alcuni anni e varie vicende burocratiche, il progetto del treno, sostanzial-mente modifi cato così da evitare l’impatto con gli antichi centri ausone e sidicino, acquisì la V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) preliminare dai Ministeri competenti, Ambiente e Beni Culturali, e tornò alla Soprintendenza per il defi ni-tivo nulla-osta (siamo nel 1994). Dato l’impegno dell’opera da realizzare e vista la crescita esponenziale dei dati archeologici che si andavano recuperando sul campo, sia in interventi di emergenza, sia con indagini programmate, fu necessario elabo-rare una procedura di intervento alquanto complessa, ma dai risultati eclatanti. La responsabilità del controllo dei lavori e tutta la corrispondenza relativa fu affi data dal Soprintendente Stefano De Caro ai funzionari e alle strutture periferiche terri-toriali; il coordinamento per la Soprintendenza fu affi dato all’arch. Maria Rosaria Marchetti, con il proprio nucleo di collaboratori; per interventi particolari di restau-ro e consolidamento fu interessato il Laboratorio di Restauro della Soprintendenza nella persona del dott. Ciro Piccioli, con i propri collaboratori.
Bisogna precisare che si aveva a che fare con un progetto esecutivo, i cui lavori erano stati già affi dati alle imprese concessionarie, rispettivamente: la ICLA Costru-zioni per il tratto tra Lazio e Campania e la Società Italiana Condotte d’Acqua per il tratto più a sud, a partire dal territorio comunale di Teano. Le imprese, pertanto, avevano termini ed importi prefi ssati per i lavori, che in realtà non tenevano conto del c.d. “rischio archeologico”, per quanto ridotto rispetto alla prima ipotesi pro-gettuale.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 244
Questo dato è sostanziale per comprendere tutta la vicenda delle ricerche archeo-logiche relative al Treno ad Alta Velocità, ma anche della quasi totalità delle opere pubbliche. Intervenire sul campo per eseguire prospezioni, scavi, documentazione e restauri archeologici durante la realizzazione di linee ferroviarie, autostrade, ac-quedotti, metanodotti, ecc. signifi ca avere il fi ato sul collo delle imprese appalta-trici, dover operare scelte sempre diffi cili, talvolta dolorose e criticabili, non poter contare su fi nanziamenti adeguati alle indagini e alle successive, fondamentali, fasi di catalogazione, studio e pubblicazione dei dati e dei reperti di scavo. Per quanto i paesi europei si siano accordati in linea di massima sulla necessità che le indagini archeologiche siano realizzate prima dell’elaborazione dei progetti esecutivi, di fatto i fondi necessari a realizzare tali indagini in fase progettuale, per quanto mi risulta, in linea di massima non vengono resi disponibili e quindi il “rischio archeologico” rimane per lo più un inquietante aspetto dei lavori sul campo.1
L’archeologia moderna ha derivato molte delle sue tecniche e dei suoi metodi da discipline in qualche modo affi ni; come esempio eclatante ricordiamo che alle scien-ze geologiche si deve l’impostazione di base del metodo dello scavo stratigrafi co, fatto proprio dagli archeologi con le opportune modifi che dovute al fatto di avere a che fare con strati e resti antropici, e non con stratifi cazioni naturali. Probabilmen-te, se il “rischio archeologico” per i lavori pubblici (e non solo) fosse codifi cato con strumenti normativi analoghi a quelli del rischio geologico (sismico, idrogeologico, ecc.), le condizioni di emergenza in cui si opera potrebbero essere superate.
Mi rendo conto che queste considerazioni, nella situazione di precarietà che vive il patrimonio archeologico a livello nazionale e mondiale possono sembrare velleitarie, ma ritengo che all’incuria e all’abbandono si possa rispondere solo con coscienza civile e senso di responsabilità, e sono convinta che anche i più minuti resti del passato di una popolazione possano contribuire a far nascere nelle comunità una propria coscienza civile.
In questa lunga premessa, un altro aspetto, pratico ma altrettanto importante, va considerato di tutta l’operazione “alta velocità” e in genere dell’imposizione (perché di questo si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi) delle indagini archeologiche in occasione di lavori pubblici e privati, ed è la creazione di occasioni di lavoro per personale qualifi cato e per imprese specializzate. Le prospezioni, lo scavo, la documentazione, il restauro dei beni e dei monumenti sono diretti e con-trollati dai funzionari e dai tecnici delle Soprintendenze, ma vengono solitamente condotti da professionisti, anche in forma associata, per tutti gli aspetti scientifi ci e tecnico-specialistici e da imprese specializzate nello scavo e restauro archeologico per quanto riguarda l’organizzazione dei cantieri, le forniture, la manodopera. Per le generazioni che si sono affacciate sul mondo del lavoro dopo l’epoca delle leggi sull’occupazione giovanile, ben pochi sono stati i posti disponibili nella Pubblica Amministrazione. D’altro canto, il mercato del lavoro privato per le discipline ar-
245Archeologia e lavori pubblici: l’esperienza del Treno ad Alta Velocità nell’Alto Casertano
cheologiche è estremamente precario e dipende comunque in massima parte dalla committenza pubblica.
Pertanto, in situazioni di carichi di lavoro cospicui per il personale dell’Ammini-strazione, come è il caso dei funzionari e dei tecnici della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, il ricorso a professionalità esterne è giustifi cato ed opportuno.
I lavori archeologici lungo la linea ad alta velocità si sono svolti in diverse fasi, tese a chiarire la situazione sul campo prima che potessero verifi carsi danni o oblite-razioni irreversibili ai materiali e alle strutture conservati nel sottosuolo.
La futura linea ferroviaria è stata dapprima percorsa da squadre di archeologi e rilevatori che hanno individuato, documentato e classifi cato i resti visibili in super-fi cie (aree di frammenti, macerie, resti monumentali). In tutte le aree che avevano un interesse archeologico sono stati programmati i saggi di scavo, a partire dai punti di maggiore concentrazione dei materiali in superfi cie. Laddove il sottosuolo ha restituito reperti o strutture tali da richiedere una completa documentazione, è stato eseguito lo scavo integrale sull’intero tracciato di progetto, fi no al limite dei resti archeologici in estensione e in profondità (è questo il caso del vicus di Mignano, ad esempio). Inoltre, poiché i dati di superfi cie non potevano essere esaustivi come indizi della presenza di resti archeologici nel sottosuolo, su tutta la linea i lavori di sbancamento sono stati seguiti da archeologi e rilevatori, che hanno lavorato accan-to (e spesso davanti!) alle ruspe.2
Daremo di seguito una rapida rassegna dei principali ritrovamenti. Le sigle utiliz-zate per individuare le aree di intervento sono relative al tipo di opere da realizzare: TR per trincea, RI per rilevato, GA per galleria artifi ciale, VI per viadotto.3
Come abbiamo accennato, pur senza attraversare i principali centri antichi del-l’Alto Casertano, il progetto del treno nella sua versione defi nitiva valicava i confi ni di regione in una zona di estrema importanza dal punto di vista storico-archeologi-co, ovvero la valle interna che collega il Lazio e la Campania e che si interseca con la valle del Liri (l’odierno Garigliano con i suoi affl uenti) proprio sull’attuale confi ne amministrativo, per piegare a sud verso Teanum Sidicinum e Cales e giungere alla valle del Volturno e al territorio dell’antica Capua.
La valle interna era attraversata da nord a sud da percorsi viari di epoca pre e protostorica non più individuabili, mentre dell’asse viario principale di età romana, la via Latina, è stato ricostruito l’intero percorso a cura di D. Caiazza.4 Il percorso del treno corre per lunghi tratti pressoché parallelo alla via Latina e intercetta spesso tratti di viabilità secondaria o insediamenti che sorgevano lungo la via antica, di cui il vicus di Mignano Montelungo è l’esempio più eclatante.
In comune di Rocca d’Evandro, ad esempio, lo sbancamento per una trincea, TRF2, ad ovest del corso del fi ume Peccia, ad una quota leggermente più alta del fi ume, ha rivelato una strada glareata di età romana (fi g. 1). La strada, orientata in senso est-ovest, è molto usurata, soprattutto ai margini, e misura da m 2,50 a m
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 246
3,20 max. di larghezza; è stata scavata lungo la linea per circa m 70. Oltre il tratto indagato non se ne conservano ulteriori tracce. Il piano stradale è realizzato con ciot-toli di medie e piccole dimensioni lungo una fascia leggermente più ampia rispetto alle linee di fondazione, che ne rinforzavano la parte centrale. La superfi cie presenta tracce di solchi per il passaggio di carri e di restauri antichi effettuati con accumuli di materiale costipato. Il percorso fu utilizzato a partire dall’età augustea fi no alla prima età imperiale (sopra la massicciata si è ritrovato un asse di Tiberio coniato tra il 23 e il 32 d.C.).
La strada non era pubblica, ma, con tutta probabilità, doveva servire a collegare la viabilità principale dell’area con una villa rustica individuata in ricognizione a nord, fuori dal progetto TAV e non scavata, ipotizzabile in base all’affi oramento di frammenti e materiale edilizio antico.
La regione di confi ne interessata dal Treno ad Alta Velocità ha rappresentato da sempre una zona di scambio tra l’area etrusco-meridionale e laziale e la Campania propria. Ai suoi margini si svilupparono, a sud, le colonie greche d’Occidente, men-tre da nord e dall’interno l’infl usso culturale e politico etrusco, campano, sannitico vide un complesso intrecciarsi di rapporti di alterne supremazie, attorno ai centri interni e a quelli gravitanti attorno al bacino del Liri, quali Minturnae, Vescia, Au-runca (quella che poi sarà Suessa romana).5
Il Liri non costituiva nell’antichità un confi ne, né geografi co, né politico-ammi-nistrativo. Infatti nella sistemazione augustea delle regioni d’Italia, Latium et Cam-
Fig. 1 - Rocca d’Evandro (CE), area ad ovest del fiume Peccia. Opera TRF2. Strada glareata.
247Archeologia e lavori pubblici: l’esperienza del Treno ad Alta Velocità nell’Alto Casertano
paniae costituiscono una sola regione, la I. L’unità della regione non viene spezzata fi no in età moderna: il confi ne tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontifi cio passava molto più a nord del bacino del Garigliano, a Terracina e a Ceprano. La Terra di Lavoro comprendeva, fi no agli anni venti del ventesimo secolo, anche la parte meri-dionale della provincia di Frosinone.
Questa regione era occupata in età arcaica dagli Aurunci, relitto degli Ausoni, popolazione il cui nome era per gli antichi quasi sinonimo dell’Italia, dapprima este-sa nell’Italia tirrenica, poi ristretta dagli Etruschi, dai Volsci, dai Sanniti, dai Sidicini alla zona nota appunto come regione aurunca. Il momento in cui la tradizione sto-riografi ca antica si occupa di questo popolo è legato all’espansione romana verso il sud della penisola in particolare nel IV secolo a.C., con alterne vicende culminate nella drammatica distruzione degli Aurunci (340 a.C.).6
La popolazione in epoca arcaica viveva in strutture abitative formate da materiali deperibili, capanne di legno con muri in argilla e coperture fatte di canne e terra im-pastata. Lungo la linea ferroviaria nei territori di Rocca d’Evandro, Mignano Mon-
Fig. 2 - Mignano Montelungo (CE), loc. Lupo. Opera TRF4. Tomba 1, a cassa di tufo.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 248
telungo, Teano, si sono ritrovate tracce di villaggi, di sepolture, di depositi votivi, in genere molto disturbati dagli eventi successivi.
In comune di Mignano Montelungo, la trincea TRF4 è stata realizzata su una piccola collina, sovrastante la confl uenza tra il Fosso del Lupo, a sud e a est, e il fi u-me Peccia, che culmina in un pianoro accessibile da nord. Il banco naturale è calca-reo, con numerosi affi oramenti in superfi cie. Gli strati archeologici si sono ritrovati molto erosi; dai frammenti contenuti nei piccoli accumuli residui sul banco naturale si è potuta riconoscere la fase più antica di occupazione del sito, databile al VII-VI secolo a.C. Il piano di calpestio di quest’epoca doveva essere più alto dell’attuale di almeno 50 cm, come testimoniano alcuni buchi di palo, conservati solo nella parte inferiore, che sembrano delineare ambienti grosso modo rettangolari.7 Nell’angolo nord-ovest del pianoro si sono ritrovate due sepolture relative a questa fase di vita del sito; una tomba era a cassa di tufo grigio ed era tagliata da una struttura muraria della fase medievale (fi g. 2). Il corredo era formato da: un’anforetta, un boccalino d’impasto, una fuseruola, un’armilla di bronzo e due fi bule con staffa con apofi si ter-minale a globetto ed arco in lamina del tipo a ghiande. In base ai materiali la sepol-tura, femminile, si può datare all’ultimo terzo del VII secolo a.C. La seconda tomba era adiacente alla precedente ed è stata sconvolta dagli interventi più recenti.
La tipologia dei frammenti ceramici riconduce ad ambiente domestico: fuseruo-le, rocchetti, pesi da telaio, fornelli, vasi di grandi dimensioni spesso decorati con
Fig. 3 - Mignano Montelungo (CE), loc. Lupo. Opera TRF4. Particolare dello scavo con olla a cordoni plastici in situ.
249Archeologia e lavori pubblici: l’esperienza del Treno ad Alta Velocità nell’Alto Casertano
cordoni plastici digitalati, olle di varie dimensioni e forme (fi g. 3), ciotole e bacini. Il repertorio appartiene alla “cultura della valle del Liri”, individuata e studiata da W. Johannowsky e successivamente da P. Talamo, databile tra il VII ed il VI secolo a.C.8 Una delle capanne doveva avere una decorazione architettonica, come è testimonia-to da resti di pareti in pisé e lastre fi ttili decorate con guilloche a rilievo e cavetti.
Dopo una parentesi di oltre un millennio, la collina fu utilizzata in epoca alto medievale come luogo di culto, con la costruzione di una piccola chiesa a navata unica con l’abside rivolta a sud-est (fi g. 4), con i muri laterali crollati verso est, di-strutta forse da un terremoto. Si conservano anche cospicui resti delle coperture in tegole e coppi. Le pareti della chiesa dovevano essere decorate con affreschi relativi alle vite dei santi, di cui sono conservati scarsissimi resti. Le murature sono realizzate con pietre calcaree rozzamente sbozzate, mentre gli angoli sono in blocchi di calcare e di tufo squadrati; il tufo era impiegato nelle parti superiori dell’edifi cio, per motivi statici e di maggiore rifi nitura delle pareti. L’altare era rivestito di intonaco bianco. Il pavimento era formato in parte da lastre di calcare legate con malta, in parte dal banco roccioso regolarizzato e lisciato. Come di consueto, nel pavimento della chie-sa furono ricavate numerose tombe a fossa terragna, in parte intersecantesi. A destra della chiesa si conserva una piccola struttura rettangolare in muratura piena, forse il campanile. L’area fu frequentata fi no al XVI secolo. Il sito doveva essere di parti-colare rilievo, poiché è collocato lungo la cd. valle dei santi e in vista del monastero di Montecassino.
Fig. 4 - Mignano Montelungo (CE), loc. Lupo. Opera TRF4. Chiesa alto medievale; in primo piano i resti dell’abside.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 250
In base ai dati della collinetta di Mignano e al confronto con altri siti analoghi (es. Teano, località S. Giulianeta9) si evince che l’occupazione del territorio in età arcaica avveniva mediante piccoli nuclei posti sulle alture, vicino a corsi d’acqua, in posizioni sicure, mentre nelle aree pianeggianti si svolgevano le attività pastorali e agricole necessarie alla sussistenza.
Più recente del sito di Mignano, ma ancora di epoca arcaica, un altro rinveni-mento lungo la linea ferroviaria va ricordato per la sua importanza e peculiarità, ed è la fossa votiva ritrovata in frazione Borgo Nuovo del comune di Teano, in località Masseria Cellarone (IGM Pietra Melara, F. 172 IV NE, 33TVF 239699, opera TRJ1), su un poggio fi ancheggiato dalla corsia sud dell’autostrada Roma-Napoli. I saggi hanno restituito materiali archeologici pertinenti alla frequentazione arcaica dell’area, consistente in una fossa, scavata nel terreno argilloso, di forma grosso modo rettangolare, lunga ca. m 16 per m 3,50 di larghezza, completamente riem-pita di vasellame integro o con forme intere frammentate, separate da sottili lenti di terra.
Il vasellame è formato in buona parte da forme aperte, vasi per bere, e dalle relative brocche e crateri, nonché da pochi vasi che potevano essere destinati a con-tenere derrate (cerali e simili). Si tratta di grandi olle acrome, crateri a colonnette con tracce di ingubbiatura rossastra, coppette e ciotole in impasto a superfi cie rossa (cd. bucchero rosso) e a superfi cie grezza, anforette d’impasto a superfi cie lustrata. Mentre questi prodotti rientrano perfettamente nel quadro della cultura materiale attestata nel territorio sidicino, la notevole quantità di vasellame di bucchero etru-sco-campano, generalmente a pareti spesse e superfi cie opaca, permette di stabilire un confronto diretto tra questo contesto e i centri in cui il carattere etrusco è più presente, quale Cales, o dominante, come nel caso di Capua. Tutte le forme indi-viduate rientrano pienamente nella fase V di Capua, datata tra il 570/560 e il 520
Fig. 5 - Teano (CE), loc. Masseria Cellarone. Opera TRJ1. Materiali esposti al Museo Archeologico di Teano.
251Archeologia e lavori pubblici: l’esperienza del Treno ad Alta Velocità nell’Alto Casertano
a.C., ma attestate anche in contesti posteriori al 520 a.C.10 (fi g. 5).
I numerosi confronti rinvenuti in contesti della Campania settentrionale e della regione di confi ne con il Lazio e il Molise, soprat-tutto per le forme aperte, rimandano, oltre che, ovviamente, a Capua, principale centro produttore, a materiali di Suessula, Cales, Rufrae (odierna Presenzano), Pozzilli, Larino, Alfedena, ecc.11
Le tracce di un culto celebrato sul sito sono visibili soltanto negli scarsi elementi di terra-cotta fi gurata, appartenenti ad una statuetta maschile con la mano tesa nel gesto di offrire, mentre un’altra mano reggeva uno strumento o un’arma (fi g. 6). L’unica testina miniaturi-stica, barbata, ritrovata nella fossa richiama modelli greci del tardo arcaismo (fi g. 7).
L’orizzonte culturale individuato in questo contesto, databile tra la fi ne del VI e gli inizi del V secolo a.C., collegato ad ambiente etru-sco-campano, conferma l’importanza dell’asse viario interno per lo scambio di prodotti e di modelli culturali, come è testimoniato anche dalla stipe votiva del santuario di Rufrae (Presenzano) degli inizi del V secolo a.C.
Il culto celebrato in località Masseria Cellarone doveva svolgersi in un santuario campestre, come altri privo di edifi ci di culto veri e propri, in cui le cerimonie re-ligiose si celebravano attorno a rozzi altari, all’interno di boschetti sacri o accanto ad una sorgente benefi ca, e pertanto i resti delle offerte votive, quando non erano in materiale deperibile, sono l’unica traccia archeologica pervenuta sino ai nostri giorni. Una selezione dei reperti ritrovati in località Masseria Cellarone è esposta al Museo Archeologico di Teano.
Con l’epoca delle guerre sannitiche e con la romanizzazione i dati archeologici di-ventano molto più consistenti. Dal IV secolo a.C. la tradizione storiografi ca ricorda diversi popoli in lotta per la supremazia su questo territorio: gli Aurunci, i Sidicini, i Sanniti, i Campani, ai quali si affi anca Roma, dove gli interessi di alcune famiglie senatorie spingevano verso una politica estera rivolta verso il sud dell’Italia.12
Sono in genere datate a questo periodo di confl itti le imponenti cinte fortifi cate in opera poligonale distribuite sulle sommità dei rilievi, a scopo eminentemente difensivo, come il cd. Orto della Regina a Roccamonfi na, dove gli abitanti potevano rifugiarsi in caso di pericolo.13
Fig. 6 - Teano (CE), loc. Masseria Cellarone. Opera TRJ1. Frammenti
di figura di offerente.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 252
Tra la seconda metà del IV secolo e gli ini-zi del III secolo a.C. (durante le c.d. II e III guerra sannitica) si svolse il lungo periodo di lotta per la supremazia in quest’area cardine nei rapporti con la parte meridionale della penisola. Nel 334 a.C. fu dedotta la colonia latina di Cales, nel 318 a.C. fu creata la tribù Falerna, con un’espansione diretta del territo-rio romano. Dopo alcuni anni, nel 314 a.C., dopo la sconfi tta subita dai Romani a Lau-tulae, nella seconda guerra sannitica, si ebbe una sollevazione generale alla quale presero parte gli Aurunci. La loro rivolta fu punita con la massima durezza, fi no alla distruzione dei centri di Ausona, Vescia e Minturnae (Liv., XI, 25). Un anno dopo la strage fu fondata la colonia latina di Suessa Aurunca, sulle pendici occidentali del Roccamonfi na.
La precoce e capillare romanizzazione di quest’area, successiva ai drammatici eventi militari, è documentata anche dai rinveni-menti archeologici lungo la linea ferroviaria;
in più punti si sono individuate aree di necropoli, le più antiche ad incinerazione in olle, le più recenti ancora ad incinerazione in pentole o in sepolture alla cappuccina, connesse ad impianti rurali distribuiti sul territorio.
In comune di Caianello, località Mulino (opera GA60), si sono individuati i resti di una necropoli, in cui l’unico rituale attestato è l’incinerazione. Le sepolture sono in olla deposta in fossa terragna, con riempimento formato da terreno combusto, talvolta coperte con coperchi a campana (fi g. 8). Le olle sono dello stesso tipo at-testato nella necropoli di Teano, in località Orto Ceraso, in ceramica comune, con orlo a sezione triangolare e corpo ovoide.14 Le sepolture non erano individuate da segnacoli; il corredo, spesso assente, è formato unicamente da balsamari, interni o esterni all’olla, del tipo Forti V = Haltern 30, databile alla fi ne del III secolo a.C.15 Alcune tombe appaiate indicano probabilmente un gruppo familiare. La necropoli è collocata lungo il percorso basolato della c.d. via Appia, in realtà un tratto della via Latina ancora percorribile.
Più tarde sono le sepolture ad incinerazione in pentole, probabilmente di un unico gruppo familiare, di località Borgonuovo del Comune di Teano (opera TRI9), datate tra la fi ne del I e il II secolo d.C. (fi g. 9).
Il costume funerario tipico dell’epoca romana imperiale è attestato da sepoltu-re “alla cappuccina”, quali quelle ritrovate sull’interconnessione di Cassino, opera
Fig. 7 - Teano (CE), loc. Masseria Cellarone. Opera TRJ1. Testina maschile barbata.
253Archeologia e lavori pubblici: l’esperienza del Treno ad Alta Velocità nell’Alto Casertano
RIJ7, in comune di Mignano Montelungo. Qui i defunti sono stati incinerati sul posto, secondo il rituale del bustum, tipico della cultura romana della prima età im-periale e bene attestato anche nella vicina Teano.16 La necropoli sembra posizionata lungo un percorso stradale del tipo individuato a Rocca d’Evandro (TRF2: strada glareata), di cui si conservano solo pochi frustuli. Altro rituale funerario prettamen-te romano è l’inumazione in anfora, con copertura alla cappuccina, di cui si sono ritrovati esemplari in località Colle della Castagna - Lupo, ancora sull’interconnes-sione di Cassino.
Il pieno possesso del territorio di epoca romana è segnato anche dai lavori per la sistemazione delle vie pubbliche che collegavano i principali centri urbani; la tecnica per la costruzione delle strade, illustrata da Vitruvio, trova conferma nell’ot-tima qualità delle vie basolate che attraversano la Campania settentrionale, in parte percorribili fi no ai nostri giorni.17 È questo il caso del tratto di strada Teanum-Alli-fae intercettata dalla linea ferroviaria in località Borgonuovo del comune di Teano
Fig. 8 - Caianello (CE), loc. Mulino. Opera GA60. La necropoli ad incinerazione in olle durante lo scavo.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 254
(trincea TRJ4). La strada ha conservato parte del basolato in pietra vulcanica, con profondi segni di carro. Il percorso è stato più volte restaurato ed integrato con massicciate di tessitura diversa dal rivestimento originario. A lato della strada si è ritrovato un settore di necropoli, costituito da alcune sepolture alla cappuccina, da-tabili alla seconda metà I secolo d.C., mentre, di poco anteriore, una tomba databile ad età augustea doveva essere ben visibile ai viandanti, in quanto segnata da un’alta colonna dorica di tufo locale, sormontata da un cratere egualmente scolpito nel tufo con anse applicate in piombo. La colonna si è ritrovata in crollo, e la sepoltura sottostante probabilmente era già dispersa in antico. Il tipo di monumento trova confronti molto precisi nella regione, ad es. nelle necropoli suburbane di Pompei; è esposto al Museo di Teano18 (fi g. 10). Attorno al monumento principale si sono individuate varie sepolture ad incinerazione in olla, del tipo già ben noto a Teano nella necropoli di Orto Ceraso ed individuato anche lungo la linea ad alta velocità, come si è detto. Un successivo intervento di risistemazione dell’area deve datarsi in epoca medievale, quando fu realizzato un piccolo edifi cio a margine della strada, con orientamento leggermente divergente.
All’epoca della pax augustea risale la scoperta più eclatante ed ormai famosa avve-nuta lungo il tracciato TAV di questa regione, che riepiloghiamo brevemente.
Il cosiddetto vicus, (estensione 160 x 80 metri) sorge a circa 1 km ad ovest del moderno centro di Mignano, in località Pastene, noto anche come “Starza”, su un basso pianoro delimitato a sud dal fi ume Peccia, ad ovest dal Fosso Camponi, alla
Fig. 9 - Teano (CE), loc. Borgonuovo. Opera TRI9. Sepoltura ad incinerazione in pentola.
255Archeologia e lavori pubblici: l’esperienza del Treno ad Alta Velocità nell’Alto Casertano
base del Monte Morrone. L’opera che ha intercettato questo centro antico è il rilevato RIK3, che, a causa dell’importanza dell’area archeologica, si è dovuta tra-sformare in un viadotto, con conseguenti modifi che di un lungo tratto della linea a nord e a sud dell’area. Del centro antico si è potuta ricostruire la planimetria e, con grande fatica, le principali fasi di occupazione e di fun-zione degli ambienti ritrovati, poiché le strutture murarie si sono conservate quasi esclusivamente in fondazione e sono prive dei piani pavimentali e degli elevati dei muri (fi g. 11). Questa circostanza è dovuta all’uso agricolo dell’area, sin dal XIX secolo bonifi cata dai resti antichi. L’accuratezza dello scavo ha permesso di ritrovare gli scarsi resti di una frequentazione preistorica ed il primo insediamento stabile, datato tra la seconda metà del IV e il III-II secolo a.C. in base ai frammenti ceramici asso-ciati ai brandelli di strutture murarie e piani pavimentali. Doveva trattarsi di una fattoria, i cui resti si trovano sotto le fondazioni degli ambienti del centro urbano ed hanno un orientamento diverso rispetto a quello delle insulae di epoca imperiale.
Non si hanno tracce di vita del sito tra il II e il I secolo a.C., fi no alla fondazione di un vero e proprio centro urbano, risalente alla piena età augustea. Che si tratti di una fondazione unitaria è indicato dalle fondazioni dei muri, realizzate tutte insieme e legate tra loro, e dalle infrastrutture per il rifornimento idrico e lo smaltimen-to delle acque refl ue. Il centro urbano è formato da due insulae (I a nord, II a sud), di m 43 x 43 ciascuna, deli-mitate da strade larghe 4 m che si incrociano ad angolo retto. L’area centrale, ad ovest delle insulae, era una piazza porticata, il foro. In asse con il centro dovevano essere al-cuni appezzamenti agricoli, delimitati da serie di muretti distanti ca. 9 m l’uno dall’altro ritrovati a ca. 100 m a NE del centro. La mancanza di dati epigrafi ci e di altre fonti non consentono di dare un nome al centro urbano, che dovette rientrare nella politica augustea di sistemazione di un territorio fi no ad allora organizzato per pagi.19
L’insula settentrionale, I, è delimitata dalla strada , che sbocca al centro del foro. Nella prima fase il porticato delimitava un ambulacro pubblico. Provengono proba-
Fig. 10 - Teano (CE), loc. Borgonuovo. Opera TRJ4. Il monumento funerario a colonna esposto al Museo Archeologico di Teano.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 256
bilmente da qui i frammenti di decorazioni architettoniche ritrovati nelle vicinanze, quale un epistilio in tufo ocra del Roccamonfi na decorato con fregio dorico formato da triglifi e metope con rosette a 4 petali (fi g. 12), una base di colonna corinzia di calcare locale (fi g. 13). Alle spalle del foro si riconoscono i resti di due impianti ter-mali. Il primo, più antico (I secolo d.C.), consta del praefurnium, del calidarium con abside e suspensurae, tepidarium e vasche per il frigidarium. Nel crollo che obliterava il calidarium si sono trovati frammenti di pavimento in mosaico fi gurato a tessere bianche e nere.
L’insula II, tra le strade a e b, non fu urbanizzata completamente al momento del-la fondazione, poiché a quest’epoca risalgono una fontana pubblica e una domus, di cui si sono riconosciuti alcuni ambienti: l’atrio e vestibolo, con ingresso dalla strada b, due alae o cubiculi che gravitano su una sorta di tablino di forma allungata, alle cui spalle sorgeva un cortile interno (hortus).
Durante l’età imperiale, tra I e III secolo d.C., furono migliorati i servizi del centro, con l’allaccio ad un acquedotto pubblico; dei pilastri che sorreggevano lo speco rimangono le basi a nord dell’insula I (fi g. 14), così come la parte inferiore del
Fig. 11 - Mignano Montelungo (CE), loc. Pastene. Opera RIK3. Planimetria del vicus con le diverse fasi edilizie.
257Archeologia e lavori pubblici: l’esperienza del Treno ad Alta Velocità nell’Alto Casertano
castellum aquae, consistente in una vasca di m 3 x 6, pavimentata con un solido coc-ciopesto. Nello stesso periodo furono ristrutturate le terme del foro, abbellite con la costruzione di un abside con labrum nel calidarium e protette rispetto al vento di tramontana con la costruzione di un muro di rinforzo sul lato nord.
Il lato sud del foro presenta migliorie relative al sistema di scolo delle acque piovane e la creazione di tabernae che chiudevano l’ambulacro, prima percorribile; nell’angolo sud-est della piazza fu realizzata una fontana, probabilmente rivestita in mosaico con tessere di pasta vitrea, di cui resta la base del catino semicircolare ed un canale in laterizio che immetteva in una vaschetta rettangolare (fi g. 15).
Oltre a questi interventi si registra la costruzione ex novo di un complesso termale affi ancato al precedente verso nord, quasi completamente demolito in epoca tardo antica, che doveva avere decorazioni sontuose, formate da rivestimenti in mosaico e in opus sectile, intonaci dipinti e rivestimenti marmorei alle pareti, di cui si sono ritrovati resti negli strati di riempimento. Anche in questo complesso il calidarium venne poi rinforzato da un doppio muro verso nord (fi g. 16).
A quest’epoca medio imperiale risale anche la costruzione del recinto di forma ellittica (asse maggiore m 43, asse minore m 24) che invade parte dell’insula II, provocando la sostituzione della strada γ con un nuovo percorso ad est, del tutto simile al precedente. Questo nuovo percorso viario fu dotato anch’esso di una fon-tana pubblica, all’incrocio con la strada α. La funzione del recinto non è ben chiara;
Fig. 12 - Mignano Montelungo (CE), loc. Pastene. Opera RIK3. Frammento di fregio dorico in tufo.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 258
strutture simili sono state di recente individuate in Campania, nella stessa Teano e a S. Maria a Vico, dove per la struttura è stata avanzata l’interpretazione come ludus. I recinti ellittici di Mignano e di Teano, invece, potrebbero meglio identifi carsi con fori boari.20
L’insula III è posta all’estremità sud dello scavo e presenta una serie di edifi ci sicuramente non pertinenti alla prima fase di occupazione, anche se ancora orientati lungo l’asse viario. Si tratta di un grande ambiente quadrangolare legato ad altri simili, di minori dimensioni, con muri di notevole spessore che potevano reggere il peso di volte di copertura o di un secondo piano.
Tra la fi ne del V e il VI secolo d.C. la maggior parte dei quartieri fu abbandona-ta ed il sito continuò a vivere come centro di vita cristiana con la creazione di una basilica sul lato sud della strada β, con canonica e recinto funerario. Anche negli ambienti ormai defunzionalizzati furono ricavate sepolture, ancora di tradizione romana, indici della presenza di nuclei di abitanti che probabilmente occupavano le strutture in degrado.
Per consentire la realizzazione dell’opera ferroviaria il sito, dopo lo scavo e i re-stauri, è stato reinterrato. Sulle superfi ci di sacrifi cio a protezione dei crolli murari è stato collocato un bauletto di taglime di tufo giallo, di ca. 40 cm di spessore, per favorire l’effetto schiarente sulla malta del restauro. Sul bauletto è stato posto uno strato di tessuto non tessuto, a sua volta ricoperto da uno strato di pozzolana per un’altezza di circa 110 cm dalle creste dei muri. Sulla strada α e sugli ambienti ter-
Fig. 13 - Mignano Montelungo (CE), loc. Pastene. Opera RIK3. Base di colonna in calcare.
259Archeologia e lavori pubblici: l’esperienza del Treno ad Alta Velocità nell’Alto Casertano
Fig. 14 - Mignano Montelungo (CE), loc. Pastene. Opera RIK3. Settore settentrionale dello scavo. In fondo, le basi squadrate dei pilastri dell’acquedotto.
Fig. 15 - Mignano Montelungo (CE), loc. Pastene. Opera RIK3. Resti delle tabernae e della fontana.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 260
Fig. 16 - Mignano Montelungo (CE), loc. Pastene. Opera RIK3. Panoramica dei resti dell’impianto termale settentrionale. In alto a destra, le suspensurae del calidarium e il doppio muro sul lato nord.
Fig. 17 - Mignano Montelungo (CE), loc. Pastene. Opera RIK3. Particolare del reinterro delle strutture murarie del vicus, dopo i restauri.
261Archeologia e lavori pubblici: l’esperienza del Treno ad Alta Velocità nell’Alto Casertano
mali nei quali erano ancora presenti i bipedales si è ritenuto opportuno realizzare una protezione di tessuto non tessuto prima del reinterro con taglime, mentre i pozzetti d’ispezione della rete fognaria sono stati riempiti di pozzolana compattata con acqua. Il riempimento non è stato realizzato in corrispondenza delle singole pile e delle spalle del viadotto per evitare che durante il getto dei micropali la malta di iniezione potesse cementare il materiale arido posto a protezione dei muri. La transi-tabilità dell’area a mezzi pesanti quali camion e gru è stata assicurata coprendola con una rete elettrosaldata sulla quale è stato steso un massetto di cemento (fi g. 17).21
Note* Colgo l’occasione per ringraziare gli organizzatori della manifestazione, gli allora Soprintendenti Stefano De Caro e quindi Fausto Zevi, il collega Francesco Sirano, il Comune di Mignano Montelungo ed in particolare il sig. Sindaco. Un saluto particolarmente affettuoso va al personale dell’Uffi cio Archeologico di Teano e degli Uffi ci di Mondragone e Sessa Aurunca, che negli anni ’90 ha diviso con me la fatica dei lavori sul campo ed il relativo carico burocratico e amministrativo.1 Il D. Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, c.d. Codice Urbani, così come modifi cato dal D.Lgs. 3 del 3.03.2006, prevede all’art. 28, comma 4, che, nel caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, il Soprintendente possa richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi. La norma concede la possibilità, quindi, di inter-venire con indagini archeologiche sui progetti di lavori pubblici, ma, nell’applicazione, si concretizza di solito in prescrizioni che non riguardano le fasi di progettazione. Con la legge n. 109 del 25.06.2005 – ora abrogata e sostituita dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 – è stata approvata una nuova normativa che prevede la cosiddetta “verifi ca di impatto archeologico” per le opere pubbliche già in fase progettuale.2 Per il tratto dai confi ni di regione al territorio comunale di Teano la documentazione delle indagini archeolo-giche è stata eseguita dalla cooperativa New Archaeology e dai suoi collaboratori; l’impresa specializzata che ha eseguito lo scavo e i restauri del vicus di Mignano fi no alla fi ne degli anni ’90 del XX secolo è la ditta Materazzo di Napoli. I dati qui esposti sono frutto dell’analisi, oltre che di chi scrive, dei colleghi che hanno curato lo scavo, la documentazione e la redazione delle relazioni scientifi che.3 Dei risultati degli interventi sono state date di anno in anno le notizie preliminari: De Caro 1996, 569-599, in particolare 574-576; De Caro 1997b, 403-433, in particolare 403-408; De Caro 1999a, 793-843, in particolare 799; De Caro 1999 b, 635-661, in particolare 638-639; De Caro 1999 c, 223-242, in particolare 238-239; De Caro 2001, 898-899.4 Caiazza 1995.5 Un contributo recente sui dati archeologici di età arcaica nella regione è in Gasperetti, Passaro, De Caro 1999; da ultimoSirano 2005, 302-316.6 Si vedano i saggi raccolti in E. Lepore, Origini e strutture della Campania antica, Bologna 1989. Cfr. anche F. Coarelli, Roma, gli Aurunci e la fondazione di Sinuessa, in Prospettive di memoria 1993, 17-28.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 262
7 Questa ipotesi interpretativa è in G. Gasperetti, A. Balasco, I poli archeologici nell’alto casertano come elementi di pianifi cazione dello sviluppo, in Carta archeologica e pianifi cazione territoriale, Un problema politico e metodologico, Primo Incontro di Studi (Roma marzo 1997), a cura di B. Amendolea, Roma 1999, 185-193, fi g. 1.8 Johannowsky 1983; Talamo 1987.9 E. Chiosi, Testimonianze archeologiche di età arcaica a Santa Giulianeta, in BA 22, 1993, pp. 46-47; De Caro, Miele 2001, 522-523.10 Per il sito: De Caro, Miele 2001, 521. Per il bucchero: C. Albore Livadie, Le bucchero nero en Campanie. Notes de typologie et de chronologie, in Le bucchero nero étrusque et sa diffusion en Gaule Mèridionale, Actes de la Table-Ronde d’Aix-en-Provence, 21-23 mai 1975 (Coll. Latomus, 160), Bruxelles 1979, 87-110; D. Locatelli, La più tarda produzione del bucchero in Campania. Spunti di discussione, in Produzione artigianale ed esportazione nel mondo antico. Il bucchero etrusco, Atti del Colloquio Internazionale (Milano, 10-11 maggio 1990), a cura di M. Bonghi Jovino, Milano 1993, 171-185.11 Johannowsky 1983; si vedano anche i contributi in Samnium 1991, in particolare Una società agricolo-pasto-rale: secoli VI - V a.C., 53-98.12 Salmon, 1985; una recente revisione della distribuzione tradizionale nelle tre (o quattro) guerre sannitiche è in T. Cornell, Deconstructing the Samnite Wars, an essay in historiography, in Samnium, settlement and cultural change (Archaeologia Transatlantica, 22), ed. H. Jones, Providence (R.I.) 2004, 115-131.13 Conta Haller 1978; Caiazza 1986; per l’Orto della Regina cfr. D. Caiazza, C. Passaro, Roccamonfi na, Orto della Regina, s.l., 1990.14 Da Sidicini a Romani. La necropoli di Orto Ceraso a Teano, Napoli 1995; De Caro, Miele 2001, 523-526.15 L. Forti, Gli unguentari del primo periodo ellenistico, in RendNap 37, 1962 (1963), 3-15.16 Per il rituale funerario di epoca romana in generale si veda Toynbee 1993.17 Radke 1981. Adam 1990, in particolare il capitolo: Le strade e le opere di ingegneria.18 Per il monumento funerario cfr. von Hesberg 1994, in particolare 185 segg.; De Caro, Miele 2001, 522. A Pompei un confronto preciso è nella tomba di Septumia, necropoli di Porta Vesuvio, con colonna di tipo ionico: cfr. la rassegna in Pompei oltre la vita, Nuove testimonianze dalle necropoli, Napoli 1998, con rif. bibl. ai vecchi scavi. Nel 2003 è stato completato l’intervento nell’ambito dei lavori per il Treno ad Alta Velocità.: Zevi 2004, 853-923, in particolare 880. Si veda anche il contributo di R. Sirleto e A. Petruccione, in questo stesso volume.19 Sul vicus: De Caro, Miele 2001, 517-520. Il nome di Cesennia, ricordato da Livio, IX, 44, 16, deve riferirsi ad un centro più antico e collocato in una diversa posizione strategica; suggestiva l’ipotesi di G. Conta Haller, che mette in relazione tale toponimo con la radice del nome del monte Cesima, ai piedi del quale sorge Mignano Montelungo.20 I dati recenti su S. Maria a Vico e su Teano sono in Zevi 2004, 878, 881. Ad Egnazia, un recinto ellittico po-sto ai piedi dell’acropoli, c.d. anfi teatro, è stato interpretato come piazza del mercato: cfr. S. Diceglie, Gnathia. Forma della città delineata mediante la prospezione archeologica, Bari 1981; Mare d’Egnazia, Fasano 1983, 17.21 Questa la situazione da me seguita fi no alla fi ne degli anni ’90 del secolo scorso; gli sviluppi successivi si sono svolti sotto la direzione del collega, dott. Francesco Sirano.
Rufrium sannitico e romanoDomenico Caiazza
Appena cinque sono i cenni a noi pervenuti dall’antichità su due insediamenti sannitici denominati Rufrium e Rufrae, databili tra la fi ne del IV ed il I sec. a.C., e così esigui che i problemi interpretativi e le incertezze sopravanzano i dati positivi. Ad esempio per alcuni studiosi i due nomi, singolare maschile il primo e plurale femminile il secondo, indicano un’unica città mentre per altri si tratta di centri diversi.
Da una sintetica notazione di Tito Livio (tria oppida venerunt in potestatem: Allifae Callifae Rufriumque)1 sappiamo che Rufrium era un centro fortifi cato (op-pidum) che venne in potere dei Romani nel 326 a.C., cioè all’inizio della seconda guerra sannitica. Livio ci dice subito dopo che molte terre circostanti vennero allora devastate e che per sottrarsi all’offensiva romana si affrettarono a passare dalla loro parte Lucani e Apuli. Naturalmente i primi non sono quelli della grande Lucania né i Lucani Volsci dei quali Livio parla poco prima (VIII, 19) e neppure i Lucani del Sangro, ma i Lucani della Mesogeia di Strabone, stanziati attorno al basso Calore.2 Anche gli Apuli (= Dauni) qui menzionati furono probabilmente una popolazione stanziata in area campano-sannitica.
La menzione di Allifae, della quale il sito romano è tuttora occupato dalla odier-na Alife, mentre ne sono stati scoperti i resti sannitici sul colle del Castello di S. Angelo di Ravecanina, oggi S. Angelo d’Alife,3 e di Callifae, grande città sannitica sita sul Monte Cavuto di Roccavecchia di Pratella,4 ci accerta che Rufrium era nel settore nord occidentale dell’area campano sannitica, a nord di Teanum Sidicinum, la città del casus belli della prima guerra sannitica.
Tuttavia la stringatezza di Livio è tale che non sappiamo in qual modo queste città fortifi cate entrarono nell’orbita romana. Se, cioè, vi fu conquista violenta dei capoluoghi o magari solo una scorreria nelle pianure delle tre città che travolse qual-che apprestamento difensivo, o, infi ne, come è più probabile, la stipula di patti a seguito di negoziati, poiché Livio non dice che i centri furono presi con assedio o d’assalto, per vim, ma solo che vennero nella potestà del popolo romano.
Strano anche che siano defi niti riduttivamente oppida, con Rufrium, una città come Callifae, centro di grande dimensione e complessità strutturale, dotata di una cinta di circa 6 km di mura, una acropoli di oltre 21.0000 mq con templi e teatro, ed Allifae, città pure di cospicue dimensioni e di avanzata economia tanto che bat-teva moneta da prima di Roma, altrove chiamata solo col suo nome o detta urbs da
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 266
Livio (IX, 38, 42) e per di più della quale Livio nuovamente registra la conquista nel 310 a.C. Grazie a questo ulteriore dato i dubbi aumentano: infatti non solo le modalità con le quali le tre città entrarono nella sfera di infl uenza romana non ci sono note, ma diventa opinabile anche la data dell’evento del 326 a.C.
Quindi anche sulla cronologia è discussione tra gli storici. Quanto al 326 indi-cato da Livio «ci sono buone ragioni per essere scettici, poiché Livio stesso ammette che Allifae, era ancora in mano ai Sanniti anni più tardi»5 cioè nel 310 a.C. La cronologia potrebbe abbassarsi dunque al 310 a.C., data nella quale sempre Livio rammenta la conquista di Allifae, o addirittura al 290 a.C., cioè al momento nel quale, alla fi ne della terza guerra sannitica, «i Romani s’impadronirono di terre ad ovest del Volturno. Deve essere stato questo il momento in cui la valle dell’alto e medio Volturno sostituì il Liri quale linea di confi ne tra i due stati. In altre parole la lega sannitica perse Comi-nium, Atina, Aquilonia, Casinum, Venafrum e Rufrium. Cominium e Rufrium non compaiono più nella storia, mentre Atina, Casinum e Venafrum divennero prefetture romane. Non sappiamo esattamente quando ciò avvenne, ma sembra probabile che esse smisero di essere sannite dal 290 in poi. Venafrum non poteva certamente far più parte del Sannio, se è corretta l’ipotesi che alcune monete del III secolo a.C. recanti scritte in osco ne provengano; ma ciò signifi cherebbe anche che la città era, a quell’epoca, uno stato “indipendente” e non ancora una praefectura romana. In altri termini insieme ad Aqui-num, Teanum e alle colonie latine di Cales, Fregellae, Suessa Aurunca ed Interamna essa costituiva una zona cuscinetto tra il territorio romano e quello sannita».6 Tuttavia anche sulla datazione delle monete campano sannitiche si discute7 sicché si può convenire che, al più tardi, l’assoggettamento ai Romani avvenne dopo la sconfi tta e la parten-za di Pirro quando la repressione si abbatté nuovamente sui Sanniti: eliminata ogni fi nzione di indipendenza, le città di Atina, Casinum, Venafrum, Allifae, Aufi dena furono aggregate allo stato romano con la concessione della civitas sine suffragio.
È poi certo che nel 263 a.C. la deduzione coloniale di Aesernia assicurò il nuovo confi ne coi Pentri spostato ormai dal Volturno al Sordo, l’affl uente che bagna Iser-nia. Atina, Casinum e Venafrum divennero praefecturae e furono ascritte alla tribù Teretina da poco costituita. Rufrium con Teanum ed Allifae pure fu ascritta alla Te-retina ma non è documentata né la sua aggregazione allo stato romano né lo status di praefectura. Ciò si potrebbe spiegare in due modi deteriori: la città aveva smesso di esistere, oppure esisteva ma aveva perso ogni autonomia ed era stata aggregata ad uno dei centri vicini; ed infi ne in un modo meno catastrofi co: Rufrium sempli-cemente aveva conservato lo status di civitas foederata, ipotesi questa che sarebbe ancora più probabile se ancora al tempo della invasione annibalica forniva autono-mamente truppe a Roma, come vedremo testimoniato per Rufrae.
È altresì certo che, pur lambita da importanti strade e circondata dalle città che emisero moneta, rimase estranea alla lega monetale campano-sannitica di III secolo, che unì Aquinum, Teanum Sidicinum, Cales, Suessa Aurunca e Venafrum visto che non sono conosciute monete di Rufrium. Ciò potrebbe indiziare una contrazione
267Rufrium sannitico e romano
della vivacità economica del centro che sembrerebbe contrastare con l’antica fl o-ridezza provata dalla ricca messe di vasi di importazioni ritrovati nelle necropoli sannitiche arcaiche di Presenzano. È lecito poi ipotizzare che le vicende delle guerre sannitiche provarono duramente il territorio di Rufrium-Presenzano praticamente sempre sul tragitto degli opposti eserciti,8 con conseguente regressione economica. Dalla mancata emissione monetale non si può invece evincere né la distruzione della città né uno scadimento istituzionale visto che anche altre città sannitiche di que-sta area, come Trebula e Callifae, non emisero moneta. Anzi la mancata inclusione nella lega monetale potrebbe indiziare una maggiore indipendenza, naturalmente solo formale. Tuttavia è presumibile che Rufrium alla fi ne delle guerre sannitiche fosse nel novero delle città e comunità sannitiche che si riunivano e riconoscevano per i sacra e politicamente nel complesso tempio teatro del Monte San Nicola di Pietravairano e che ne abbia seguito il destino. Ne dovevano fare parte almeno le circostanti comunità del medio Volturno e della valle di Pietramelara che dalla vista del tempio traevano motivo di coesione e protezione e quindi certo Rufrium e le sue comunità satelliti, forse Venafrum prima di divenire prefettura, Callifae, Allifae, la città sul Montauro di Vairano, probabilmente Kupelternum.
Non collegata ad eventi bellici e riferita a circostanza posteriore di alcuni secoli è la notazione di Catone (Agr. XII, 4; CXXXV, 2) che, indicando i luoghi più famosi per la produzione di frantoi, tra questi menziona «(trapeti) ad Rufri maceriam».
Gioia Conta ha proposto di riferire le “macerie” alle mura poligonali site sul Monte Castello di Presenzano9 e chi scrive ha poi rilevato da un lato che presso le mura è una cava di dura trachite, affi orante tra le rocce calcaree, ed utilizzabile per le mole da frantoio e dall’altro che Presenzano ha da secoli una fl orida coltivazione di olivi, come le vicine S. Pietro Infi ne e Venafro, città che era la prima piazza olearia in epoca romana, sicché è ben possibile che qui sia stato un fl orido luogo di pro-duzione di mole per trappeti.10 Naturalmente sino a che non siano compiute analisi petrografi che sulle lave delle macine per grano e le mole per olive rinvenute nell’area sannitica e del nord della Campania nulla si potrà affermare con certezza, ma è al-meno assai probabile che anche questa notizia si riferisca a Rufrium-Presenzano.
A Virgilio dobbiamo, invece, un cenno su un centro chiamato Rufrae, nome corradicale e tanto somigliante a quello di Rufrium che il Mommsen rubrica le iscrizioni di Presenzano sotto il nome di Rufrae. Infatti Virgilio nel catalogo dei capi dei popoli italici che accorrono in soccorso di Turno menziona Ebalo ed il fi glio Telone che dominava sui popoli sarrasti e le piane irrigate dal Sarno e su quelli che possiedono Rufrae e Batulum ed i Campi Celenni: «quique Rufras Batulumque tenet atque arva Celemnae».11
Non ci sono noti i siti di queste tre località ma per la menzione del Sarno e dei Sarrasti alcuni studiosi, come vedremo, hanno ubicato Rufrae, Batulum e Celemna nel settore sud orientale della pianura Campana, all’incirca tra Nola e Sarno e, visto anche che qualche verso prima è menzionata Abella, questa rimane l’ipotesi più pro-
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 268
babile anche se non vanno dimenticate le esigenze metriche e di rima, che possono avere condizionato l’elencazione al di là della reale contiguità fi sica.
La menzione virgiliana della forma Rufrae è poi confermata da Silio Italico che ricorda tra coloro che aiutarono Roma dopo il disastro annibalico gli abitanti delle città di Rufrae e di Aesernia: «[…] et quos aut Rufrae quos aut Aesernia quosve».12
L’etnico Rufrani, è poi testimoniato da due epigrafi di Presenzano13 che menzio-nano i Rufrani Vicani:
IMP CAESAR(i d.f.)COS. V . IMP VI
RUFRANI VICANI Q(uorum)AEDIFICIA . SUNT
databile in base alla titolatura all’anno 725 ab urbe condita, e
M . AGRIPPAE . L . FPATRONO RVFRANI . VICANIQVORVM . AEDIFICIA . SVNT
Nei Rufrani Vicani, data la prossimità di Presenzano al territorio di Allifae e Cal-lifae riconosceremo dunque i pronipoti della Rufrium interessata dai fatti del 326 a.C.
Deve poi darsi conto di una ulteriore evoluzione del nome Rufrium documentata dall’epigrafe, di poco successiva, posta dai Rupheni Vicani a Marco Volcio Sabino.
È l’iscrizione CIL X, 4833, mal letta dal Mommsen che all’ultimo rigo ha Ru-frani, da emendare in Rupheni grazie all’autopsia del cippo tuttora conservato a Presenzano nella sede dell’ex municipio:14
M . VOLCIO . M . FSABINO . TR . MIL
QVOD . AQVAM . IVLIAMPECVNIA SVA ADDVXIT
RVPHENI VICANI
Infi ne una possibile menzione alterata del nome potrebbe essere nella Tabula Peutingeriana nella quale dopo ad Flexum (piana di S. Pietro Infi ne) è segnata una località ad Rotas, che, per motivi di contiguità geografi ca, potrebbe essere una corru-zione del nome di una ipotizzabile statio ad Rufrium, poi ad Rufum, sita sulla Latina e magari continuata nel Medioevo dalla taverna di S. Felice a Rufo.15
L’evoluzione da Rufrium a Rufo indiziata dall’epigrafe è confermata anche da do-cumenti altomedievali che tramandano le forme Rufa-Rufo,16 che erano nell’uso vivo sino a qualche decennio or sono poiché nella tavoletta IGM è segnata, nella piana
269Rufrium sannitico e romano
tra l’anfi teatro e Presenzano, una Fontana Rufa, di recente disseccata, ma ancora ricordata da molti, che costituisce ulteriore attestazione del toponimo antico.
Poiché il nome Fontana Rufa equivale a Fontana Rossa potrebbe indicare che un tempo qui sgorgavano acque ferruginose e rossastre e questo potrebbe essere l’etimo dell’etnico e del poleonimo, probabile visto che siamo in zona vulcanica. Se l’etimologia è fondata, anche il nome Rufrae dovrebbe signifi care qualcosa come Acque Rosse.
In alternativa, poiché tra i calcari sopra San Felice a Rufo si notano infi ltrazioni di lave e depositi di suoli piroclastici rossastri si potrebbe pensare che il nome signi-fi chi qualcosa come le terre, le rocce rosse. L’identità dell’appellativo con il topo-nimo romano Saxa Rubra potrebbe poi suggerire una analoga etimologia: le rocce arrossate dal sangue a seguito di qualche evento bellico, ed infi ne non può escludersi che “Rosse” fosse l’appellativo delle genti che signoreggiarono queste aree, sicché il nome potrebbe derivare ai luoghi proprio dai colonizzatori.17
Tuttavia a stare ai fatti l’ipotesi che “rossa” si riferisca ad una fonte è l’unica che nell’area che esaminiamo ha un concreto riscontro con l’idronimo Fontana Rufa ed è pertanto la più probabile. Né va sottaciuto che ad est di Sarno, cioè nell’area nella quale sulla scorta di Virgilio si è ipotizzato sia esistita l’antica Rufrae, è un abitato detto Acqua Rossa. E se è vero che il nome moderno è un singolare, i vicini toponimi Fontanelle ed Acqua Fredda sembrano indiziare antichi affi oramenti un tempo collettivamente indicati come Acque Rosse, a causa di una coloritura dovuta ad elementi minerali disciolti.18
Per quanto sin qui esposto ci sembra dunque che il Rufrium presso Presenzano sia realtà in tutto diversa da Rufrae, ma ci pare doveroso rammentare che Gioia Conta ha proposto di riconoscere in Rufrium il nome antico poi evoluto in Rufrae.19
Tuttavia ci sembra insormontabile la diffi coltà di spiegare la trasformazione del nome dal singolare maschile al plurale femminile. Rufrae è infatti un poleonimo plurale come Callifae e Allifae; Rufrium invece un singolare come Venafrum, Teanum e Casinum. Entrambi sono formalmente ammissibili oltre che documentati ma è improbabile che defi niscano la stessa realtà sia pure in epoche diverse.
Se il plurale rifl ettesse realtà insediative pluricentriche indicando una serie di vici dei Rufrani, si potrebbe pensare che la mutazione da Rufrium a Rufrae indizi una frammentazione di un antico insediamento unitario, o una traduzione (sannitizza-zione?) di un nome precedente, ma siamo nel campo delle ipotesi e di norma si ten-de ad ammettere che i nomi collettivi indicano centri nati per sinecismo da abitati minori e non le “schegge” nate dalla dissoluzione di un abitato unitario dissoltosi.
È ora da rendere conto del fatto che anche in passato si è molto discusso se Ru-frium e Rufrae fossero la stessa realtà o se, al contrario, si trattasse di diverse città, e dove fossero ubicate.
Infatti, sebbene sia stato ben noto a partire dal rinascimentale codice Marucel-liano e dalle lettere dell’Holstenius al Cluverius, che le iscrizioni dei Rufrani Vicani
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 270
erano a Presenzano nella località S. Felice a Rufo, posta a ridosso della via Latina, ed oggi detta Taverna S. Felice,20 l’ubicazione del Rufrium di Livio e Catone a Pre-senzano non è stata facile né immediata, ed anzi ha richiesto un processo lungo e faticoso.
Il Cluverio nel 1524 e Ciarlanti nel 1644 collocarono Rufrium a Ruvo di Puglia o di Basilicata, fondando sull’erroneo presupposto che questi toponimi moderni fossero la continuazione del nome antico mentre invece derivano da rubus = rovo, pruno o tuttalpiù da rupes = roccia, pietra.21
A nulla giovò che nel 1635 il dotto vescovo di Teano Giovanni De Guevara aves-se fatto redigere e stampare una corografi a della diocesi di Teano22 con indicate, ai piedi della montagna di Presenzano, le diciture da sud: Hostaria di S. Felice a Rufo, a cavallo della via Latina, seguite dalla menzione erudita, di matrice o almeno sug-gestione virgiliana, di olim Rufae su un disegno dell’anfi teatro, la scritta Rufe sotto Presenzano ed altra più a nord: Rufe.23
Infatti né il Ciarlanti, che pubblicò nel 1644, poco dopo la stampa della coro-grafi a, né il Trutta, che stampò nel 1776, tennero conto della carta del De Guevara; anzi il Trutta ritenne di ubicare Rufrium presso S. Angelo d’Alife, sul presupposto che qui era un antico centro attiguo ad Allifae romana, e dunque senz’altro il Ru-frium di Livio.24
Il Beloch, nell’Ottocento, leggendo senza interpunzione i passi di Catone (che cita però Rufrium), pose Rufrae nel territorio di Nola, e precisamente in Castello Cisterna solo perché qui si fabbricavano mole.25 L’ipotesi già non molto convinta (di solito Rufra viene collocata qui) fu contrastata da Nissen e Mommsen che, ponendo una virgola dopo Nola, ubicarono Rufrae a Presenzano.
Il Philipp ritenne invece l’esistenza di due Rufrae una in territorio nolano e l’altra in ambito propriamente sannitico. Tale ipotesi sembra la più probabile visto che non vi è prova della ipotizzata reductio ad unum dei due abitati, mentre vi sono seri indizi dell’esistenza nel territorio attorno a Nola della Kelian di Diodoro ovvero di Cele-Celemna, circostanza che sembra confermare la possibile ubicazione in questa zona anche di Batulum e Rufrae.26
In pratica si dovettero attendere oltre duecento anni e l’opera di Teodoro Momm-sen per uscire dalla ridda di congetture, riabilitando, sulla base del toponimo S. Felice a Rufo inter Presenzanum et Toram e sulla scorta delle due epigrafi dei Rufrani Vicani (CIL X), la tesi del De Guevara che l’antica *Rufrae (o meglio Rufrium) fosse ubicata a Presenzano.
L’autorità del Mommsen ha reso poi canonica ed indiscussa l’ubicazione di Ru-frium nel territorio di Presenzano, ma purtroppo sotto il nome di Rufrae, preferito a quello di Rufrium riportato da Livio. E dunque lo studioso tedesco se ebbe il merito di aver affermato con la sua autorità la soluzione del problema topografi co dell’ubi-cazione dell’oppidum che Livio dice preso nel 326 a.C., già suggerita dal De Guevara nel 1635, poi ingenerò una altrettanto diffusa ed immotivata convinzione che il
271Rufrium sannitico e romano
nome esatto di questo centro fosse da emendare in Rufrae. Infatti, come ci sembra di aver dimostrato, non vi è alcuna prova positiva che Rufrium sia la stessa cosa di Rufrae ed anzi come vedremo sembra probabile il contrario.
Dal punto di vista topografi co poi, risolto un dubbio, il Mommsen ne insinuò un altro. Dichiarò infatti nella troppo sintetica prefazione alle epigrafi “rufrane” di non sapere se il territorio di Rufrae appartenesse a Teano o a Venafro, propendendo però per quest’ultima, senza spiegarne i motivi: «quo territorio pagus is comprehensus fuerit, nescio; putaverim tamen rectius ad Venafrum referri quam ad Teanum».27
Egli avrebbe facilmente potuto risolvere il dubbio se avesse considerato il fatto che il territorio sino a Presenzano ed oltre, cioè sino al Castello delle Pentime inclu-so, era da oltre un millennio in diocesi di Teano ed era anche appartenuto ai dinasti longobardi di questa città. Inoltre frettolosamente attribuì anche le epigrafi della valle di S. Pietro Infi ne a Venafrum, senza considerare che non vi era prova e neppure indizio del fatto che questa città andasse col suo territorio oltre il confi ne naturale:28 lo spartiacque che corre sul passo della Nunziata a Lungo e lungo il corso del Fiume San Bartolomeo.
Cadde ancora in errore anche affermando che S. Pietro Infi ne trae il nome dal-l’essere sul confi ne tra Lazio e Campania: «nomen traxisse videri a confi nio Campa-niae et Latii. Proprie autem terminus Campaniae et Latii fuit Venafrum et Casinum ad stationem que dicitur ad Flexum, ibi fere ubi nunc est vicus S. Pietro in fi ne ab eo ipso termino ni fallor nuncupatus».
L’ipotesi, neppure originale poiché già formulata dal Trutta,29 ma che sull’auto-rità dello studioso tedesco è divenuta dominante, è tanto universalmente accettata quanto del tutto infondata.
Infatti è da escludere che i confi ni del Lazio abbiano qualche attinenza col topo-nimo S. Pietro Infi ne che è nato per deformazione dell’attributo della ecclesia S. Petri in Flexum = chiesa di S. Pietro nella curva sulla via Latina. Già nel 1914 Ireneo Bo-nanni aveva esattamente notato che il paese di San Pietro Infi ne «prese questa deno-minazione dall’Ad Flexum divenuto ad Flia, ad Flea nel sec. XII per una ricostruzione dotta dei notai che non sapevano spiegarsi l’ad Flia quando S. Pietro divenne confi ne del territorio cassinese».30 Ed in tal senso si esprime anche il Pantoni che cita una testi-monianza del 963 d.C. della chiesa di S. Pietro sita in locu ubi nominatur in Flea, citata come S. Petrus in Flia nelle lamine bronzee del sec. XI della porta della basilica di Montecassino. L’oppidum S. Petri in Flia è ricordato anche in un documento del 1047,31 mentre la denominazione di S. Pietro Infi ne compare solo nel XII secolo. Alle testimonianze riportate dal Pantoni può aggiungersi un privilegio di Federico II del 1222, nel quale è citato Ugo de Sancto Petro Infi ne.32
Nel 1995 nel quadro della ricostruzione del tracciato della via Latina tra Ad Flexum e Teanum sono stati individuati, descritti e documentati grafi camente e fotografi camente da chi scrive sia il Flexum sia i resti dell’abside della chiesa di S. Pietro sita nella curva, ed è stata nuovamente confutata la paretimologia accettata
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 272
dal Momm sen che ingigantì l’errore dei notai e monaci cassinesi trasformando il confi ne della Terra Sancti Benedicti in quello del Lazio con la Campania.
Ma l’errore è duro a morire, data la pessima abitudine di non rivedere critica-mente le affermazioni del Mommsen anche se non siano provate o se ne sia dimo-strata l’infondatezza. Infatti, se è già sorprendente che nel 1991 il Baldacci33 abbia continuato a sostenere la paraetimologia di S. Pietro Infi ne = San Pietro sul confi ne, non può non meravigliare il fatto che, anni dopo il 1995 nel quale era stata pub-blicata la prova archeologica dell’esistenza della chiesa di S. Pietro “nella curva”, ad Flexum, correlata alle fonti storiche e documentarie che dimostravano il reale etimo, la Capini abbia potuto ancora «proporre l’attribuzione a Casinum del territorio di S. Pietro Infi ne, insieme al versante occidentale delle montagne che separano la Valle del Volturno da quella del Garigliano, riferendo così il trasparente (sic!) signifi cato del topo-nimo ricordato ai confi ni del territorio casinate piuttosto che a quelli del venafrano».34
Né può costituire una scusante il fatto che anche il Solin avesse portato alle estreme conseguenze l’attribuzione mommseniana della piana di S. Pietro Infi ne al territorio di Venafrum ampliando questo sino ad includere addirittura Rocca di Evandro,35 e che sulla sua scia il Kajava abbia attribuito Mignano a Venafrum sol perché nel castello è riutilizzata l’epigrafe di un seviro augustale di Venafro.36 Argo-mento immediato e suggestivo ma certo non risolutivo poiché nulla impediva a un venafrano di morire ed essere seppellito a qualche chilometro dalla sua patria.
D’altro canto è stato rinvenuto a Mignano anche un cippo37 di un edile della confi nante colonia di Suessa; sicché ragionando allo stesso modo si potrebbe attri-buire il territorio anche a tale città, tra l’altro più vicina. Inoltre il cippo del seviro è riutilizzato e dunque sicuramente non in giacitura primaria. Pertanto non è idoneo a provare nulla poiché può essere stato trasportato anche da lontano, date le ridotte dimensioni,38 ma, soprattutto, non si è valutato che Mignano è da sempre territorio della diocesi di Teano e dunque presumibilmente nel distretto amministrativo della città romana.39
Infatti per quanto è dato conoscere dalle fonti il confi ne nord della diocesi di Teano include ab immemorabile i territori di Presenzano, Tora e Mignano ed è altresì sicuro il fatto che se si esaminano i documenti altomedievali non si noterà mai una espansione del confi ne di Teano, ma piuttosto la sua retrocessione. Ecco la dimo-strazione del nostro assunto.
Nella bolla di Papa Celestino III dell’anno 1193 si legge che, sull’esempio dei suoi predecessori (ad istar predecessoris nostri Adriani, Alexandri, Luci, e Clementis, e sicut a Johannis XVIII Papae privilegio quod Sandrario40 Episcopo indultum est), egli, a richiesta di Teodino vescovo di Teano, confermava i confi ni della diocesi teanese così descritti: «scilicet a primo latere, sicut ingreditur aqua de Sexto fl uvium Vulturnum, e sicut ipse fl uvius descendit usque ad Montem Anezone, e quomodo ascendit terra ipsius montis et exit in fi nem de Melanico, a seconda parte quomodo vadit terra de monte, qui
273Rufrium sannitico e romano
dicitur Petra Molaria e de Monte Maione, et descendit in Decem Pondera et vadit in stafi lum et descendit, de scabello et in ipsa rigazo mittit in Sagonem».
Dunque dal tempo di Papa Giovanni XVIII (1004-1009) il confi ne della dio-cesi partiva dall’ingresso del fi ume di Sesto Campano (aqua de Sexto) nel Voltur-no, scendeva lungo questo fi ume, risaliva quindi sino alla grotta di S. Michele in Monte Melanico e sul Montemaggiore (Monte Maione), poi raggiungeva il Savone di Assano e lo seguiva per risalire lungo un rivo le pendici del Roccamonfi na sino a raggiungere il Garigliano: «ipsa rigazo mittit in fl umine de Garigliano a quarto latere est idem fl uvius et aqua quae dicitur Bantra e vadit in silicem, deinde pergit in furcam Sancti Martini, exinde vadit per ipsos montes e descendit per vallem de Almagno in supradicta aqua de sexto, intra quos fi nes Theanensis civitas et castella abentur haec: Marzana, Bairanum, Pentime, Presentianum, Minianum, Caminum, Casale Caspuli, Rocca Banterani, Cucuruzium, Mertula, Gallucium».
Dal Garigliano il confi ne risaliva il fi ume Vandra, oggi Peccia, e proseguiva in si-licem cioè lungo una via selciata, certamente la Latina nella piana di S. Pietro Infi ne, raggiungeva la Forca di S. Martino,41 oggi detta passo della Nunziata a Lungo, poi ri-saliva il Cesima e per la valle di Almagno, che è la valle dove una volta era la Fontana di Cesima ed oggi è il lago artifi ciale, ridiscendeva nel fi ume di Sesto Campano.
I territori e gli abitati di Marzano, Vairano, Pentime, Presenzano, Mignano, Ca-mino, Caspoli, Rocca di Vandra, Cucuruzzo, S. Maria di Mortula, Galluccio sono espressamente indicati in diocesi di Teano.42 Poi questa perderà il Castello delle Pen-time in favore della diocesi di Venafro, e Rocca di Vandra ed il territorio della valle di S. Pietro Infi ne dalla via selciata sino al Valico della Nunziata a Lungo in favore della diocesi di Montecassino.
Se è esatta la nostra identifi cazione della via selciata con il tratto della via Latina della quale ancora oggi è visibile il basolato nella piana di S. Pietro Infi ne ne con-segue che lo stesso abitato attorno all’ecclesia S. Petri in Flea erede e continuatore dell’antico ad Flexum, sito a sud della strada, era in diocesi di Teano.
Pertanto ancora nel XII secolo è documentata l’appartenenza a Teanum (per eredità tardoromana) del territorio di Ad Flexum-S. Pietro Infi ne, evidentemente in conseguenza dell’annessione dell’ager rufranus dopo la guerra sociale; ciò rende ammissibile l’ipotesi che la statio ad Flexum fosse uno dei vici di Rufrium, aggregati a Teanum in epoca postsillana e imperiale.
Ma poiché, a loro volta, la statio ad Flexum e le poche ville romane nel territorio di S. Pietro Infi ne documentano il trasferimento a valle dell’abitato di epoca san-nitica arroccato in collina nelle cinte megaliche S. Eustachio e Marena Falascosa se ne potrebbe dedurre che il territorio di Rufrium romana aveva ereditato dall’epoca sannitica l’intera valle di S. Pietro e le montagne a nord dell’abitato.
Di questo vi potrebbe essere ulteriore indizio nel fatto che il territorio che nel 963 d.C. faceva capo e traeva il nome dalla chiesa di S. Pietro Infi ne era assai ampio e correva dalla Forca di S. Martino, oggi Nunziata a Lungo,43 sino a dietro il Monte
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 274
Sammucro e poi scendeva lungo il vallone dell’Acqua Bianca includendo il territorio di S. Vittore e quindi le aree tutte circostanti le cinte sannitiche. Ciò potrebbe forse rendere almeno ipotizzabile che la diocesi di Teano arrivasse anticamente sino ad oltre il Monte Sammucro44 includendo le aree in antico gravitanti attorno alle cinte sannitiche, ma naturalmente non sappiamo se anche in età sannitica tali territori e insediamenti fossero riferibili all’ager dei Rufrani. A volerlo ammettere, in via d’ipo-tesi e per non lasciare inesplorata alcuna pista, anche le cinte in muratura ciclopica di Marena Falascosa e S. Eustachio potrebbero in astratto candidarsi a sedi di Ru-frium preromana, specie se si condivida l’identifi cazione dell’area archeologica di Fosso Camponi di Mignano con Rufrium romano, ma l’ipotesi ci sembra assai im-probabile poiché a togliere dal versante orientale del Monte Cesima anche Rufrium sannitica non avrebbe alcuna spiegazione l’esistenza e la persistenza dei toponimi S. Felice a Rufo e Fontana Rufa ad est del Cesima e l’abbondanza di ruderi preromani e romani nell’area di Presenzano.
È però certo che almeno la parte meridionale della valle di S. Pietro Infi ne sia stata in diocesi di Teano e quindi nel distretto di Teano, mentre è pensabile che l’am-putazione della vallata di S. Pietro dalla diocesi di Teano e l’aggregazione alla diocesi monastica cassinese della Terra di S. Benedetto sia avvenuta nei secoli IX e X-XI, allorquando, dopo le devastazioni saracene, la diocesi di Teano fu ininterrottamente retta da Vescovi monaci di Montecassino e fu, dunque, controparte debole in rap-porto alla crescente potenza della insigne Badia. Questa che già nel 963 aveva riven-dicato la proprietà fondiaria di S. Pietro Infi ne e nel 1047 fondato l’insediamento fortifi cato sito sopra la fonte di S. Maria dell’Acqua, distrutto nell’ultima guerra, successivamente fece in modo da far coincidere proprietà e giurisdizione religiosa. Comunque nella bolla data a Sandrario fi gurava ancora il possesso teanese dell’area a sud della via Latina e quindi implicitamente della ecclesia S. Petri in Flia.
Ma vi sono altri indizi, di natura geopolitica e geoeconomica di una maggiore estensione antica del territorio rufrano: sembra inverosimile che Rufrium custode in epoca preromana del Cesima, dei valichi e dei traffi ci ai piedi della montagna ne presidiasse il passo a sud, dove corre la Latina, e non quello a nord, sulla Nunziata a Lungo dove corre la via per il Sannio. Ciò avrebbe reso estremamente vulnerabile la città e si consideri anche che togliere a Rufrium le pianure ai piedi del Cesima (oggi di Mignano, Sesto, Roccapipirozzi e S. Pietro Infi ne) signifi ca, in pratica, ammettere che la città aveva solo territorio montano, visto che la piana tra Presenzano e Vairano almeno per la metà orientale doveva appartenere alla grande cinta del Montauro di Vairano. Se poi la grande selva nella piana di Presenzano, sopravvissuta sino a dopo la seconda guerra mondiale, non fosse medievale, ma più antica il suolo agrario, già esiguo, sarebbe ancora minore.
Evidentemente è assurdo pensare che i Rufrani non avessero territorio agrario, visto che le città sannitiche e poi romane avevano sempre confi ni disegnati in modo da comprendere zone montuose, tenute a boschi e a pascoli, e zone pianeggianti
275Rufrium sannitico e romano
per l’agricoltura, così da poter soddisfare le esigenze di legname, delle mandrie e della coltura dei cereali. Per queste elementari ma non trascurabili considerazioni geoeconomiche sembra improbabile affermare che la signoria antica di Rufrium non si estendesse almeno alle pianure site immediatamente ai piedi del Cesima.
Dunque il territorio dei Rufrani, nell’ipotesi più ampia e meno probabile, com-prendeva i monti retrostanti S. Pietro Infi ne, ed il territorio di Sesto con parte della pianura tra Sesto e Venafro, in quella minima e più sicura i comuni di Castello delle Pentime, Presenzano, Tora e Galluccio e Mignano, la parte meridionale di S. Pietro Infi ne e forse Rocca di Vandra.
Come detto, dopo il Mommsen la pertinenza a Rufrium, sia pure chiamata Ru-frae, del territorio presso Presenzano è divenuta canonica e non è stata più messa in discussione, sicché quando, nel 1973-74, W. Johannowskj scavò, non lontano da Presenzano, un santuario con materiali databili dal VI al II sec. a.C. con chiare tracce di incendio, poste in relazione all’invasione annibalica, e poi la necropoli di località Robbia o Arobbia,45 fu ovvio attribuire a Rufrium tali materiali.
Nel 1978, la compianta Gioia Conta pubblicò le mura megalitiche del Monte Castello di Presenzano, poste subito a monte di santuario, necropoli e del centro medievale, nel quale sono murate più epigrafi romane; poiché questa era l’unica cinta sannitica allora conosciuta, non esitò a porre qui la sede di Rufrae sannitica, ipotizzando l’unicità del sito e la parziale mutazione del nome.
L’ipotesi sembrò rafforzata dalla scoperta di chi scrive di ulteriori mura ciclopiche sul Monte Castello di Presenzano, che accrescevano l’ampiezza e la qualità delle di-fese, e delle mura e dei siti sannitici di Callifae-Roccavecchia di Pratella, e di Allifae-Castello di S. Angelo d’Alife, i quali restituiscono senso concreto e compiuto alla progressione di conquista del 326 a.C., descritta da Livio, poiché si tratta di territori immediatamente contigui.
L’ubicazione di Rufrium sul Monte Castello di Presenzano rimane ad oggi l’ipo-tesi più probabile, data anche la presenza non lontano da Presenzano dei toponimi Fontana Rufa e S. Felice a Rufo e la scoperta di necropoli ed edifi ci nella piana,46 tuttavia il ritrovamento e la documentazione, sul Cesima e nelle immediate adia-cenze del Monte Castello di Presenzano, di altri insediamenti fortifi cati sannitici ci obbliga ad un complessivo riesame di questa tesi.
Ad oggi, e la ricerca non è completata, sono stati riconosciuti altri sei centri fortifi cati: sulla Piana di Cesima, Colle Pecorino e Monte Castello; La Vedetta del Cesima sulla più alta vetta del Cesima; un’altra fortezza sul Monte S. Leonardo sulla vetta che domina da ovest il monte di Monte Castello di Presenzano; a nord dell’abi-tato di Presenzano sono i resti delle mura megalitiche del Castello delle Pentime, con subito a monte il centro satellite di Monte Alto (m 791 s.l.m.) del quale resta la fascia anulare incisa in roccia.
Le piccole cinte della Vedetta, di Colle Castello e Colle Pecorino, per dimen-sione e posizione, sono da classifi carsi come insediamenti minori (fortezze-oppida),
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 276
satelliti di un maggior centro e certo non possono ambire ad essere identifi cate con Rufrium. Lo stesso sembra di poter dire del centro di Monte S. Leonardo, che, per quanto sin qui scoperto e rilevato, sembra essere la tipica fortezza a monte del cen-tro maggiore, osservatorio e protezione delle spalle dell’abitato del Monte Castello di Presenzano. Né a tanto osta la presenza di una cappella medievale che potrebbe indiziare continuità di un culto più antico, poiché la posizione eminente si prestava a una funzione cultuale di sacralizzazione dell’area visibile dalla vetta, senza che re-stasse scemata la funzione militare. Il problema si complica un po’ con la scoperta dell’insediamento del Castello delle Pentime: ampio e con terrazzi scavati in roccia certo non medievali, con resti notevoli di tegoloni, guardato in alto dalla fortezza di Monte Alto. Pare probabile che qui fosse un importante abitato su erto pendio del tipo Lucus Angitiae, o Venafrum e, sino a che un’esaustiva ricognizione, un rilievo accurato e saggi di scavo non ne rivelino ampiezza, articolazione e tipologia, non potrà escludersi del tutto che qui fosse Rufrium preromana.
Come che sia, è certo che questi abitati dovevano schierare sulle mura un ade-guato numero di difensori e ciò di rifl esso presuppone una consistente popolazione e risorse suffi cienti al sostentamento della stessa. Poiché, come detto, almeno la metà orientale della piana tra Presenzano e Vairano-Pietravairano doveva far parte del territorio della città di Montauro di Vairano e di quella sul Monte S. Nicola è evidente che la metà occidentale non poteva essere suffi ciente al sostentamento di così numerosa popolazione. Il territorio montano del Cesima poteva fornire pascoli per il bestiame e legname ma pochissimo suolo agrario. Dunque il territorio agrario di Rufrium doveva essere attorno al Cesima e comprendeva a sud probabilmente il territorio di Marzano e certamente i territori di Tora e Mignano e magari di Rocca di Vandra. A nord in epoca sannitica dovevano essere di Rufrium i territori di Sesto e Roccapipirozzi almeno sino al fi ume S. Bartolomeo e poi alla Nunziata Lunga. Abbiamo visto che la valle di S. Pietro Infi ne che per l’età sannitica gravitava sui centri fortifi cati di S. Eustachio e Marena Falascosa in età medievale e forse anche in età romana era con ad Flexum in territorio di Teano.
Sicché, sciogliendo il dubbio del Mommsen, per la usuale corrispondenza della diocesi con il territorio della città romana e per l’assenza di ogni indizio contrario, possiamo affermare che in età romana Presenzano ed il Castello delle Pentime, Mi-gnano, Tora e probabilmente Rocca di Evandro e la valle di S. Pietro Infi ne con i territori di Sesto Campano e Roccapipirozzi erano parte del territorio di Teanum. Con ogni evidenza entrarono nell’orbita di Teanum allorquando Rufrium perse la sua autonomia di città-stato e fu ridotta a vicus, cosa probabilmente avvenuta dopo la guerra sociale.
Deve infatti pensarsi che, analogamente a quanto accaduto ad altre città san-nitiche conquistate dai Romani, dopo essere entrata nell’orbita romana, la città rimase formalmente indipendente ma legata a Roma da una alleanza, teoricamente
277Rufrium sannitico e romano
tra eguali ma di fatto non paritaria, un foedus iniquum che la vincolava alla politica estera di Roma, alla quale doveva tributi e soprattutto contingenti militari.
Sulla strada tra Sannio e Campania, Rufrium dovette essere spesso coinvolto nelle guerre sannitiche ma la sua situazione istituzionale non sarebbe mutata fi no al tem-po dell’invasione annibalica, se la città era in grado di deliberare di soccorrere Roma con truppe fresche dopo la disfatta di Canne, come dice Silio Italico. Questo, be-ninteso, a patto di attribuire a Rufrium quanto Servio dice di Rufrae, cosa che ci pare improbabile perché pensiamo che si tratti di città diverse e soprattutto perché pare improbabile che Rufrium potesse soccorrere Roma se, proprio per la fedeltà a Roma, aveva subito l’ira di Annibale come testimoniano le tracce del rovinoso incendio che distrusse nel II sec. a.C. il tempio di Masseria Perrelle e, presumibilmente, gli inse-diamenti e le masserie in pianura. Questo incendio avvenne probabilmente quando Annibale proveniente da Telesia fi nse di dirigere su Roma mentre si recò a saccheg-giare gli agri Stellate e Falerno per poi infi ne evadere dalla trappola tesagli da Fabio Massimo con l’espediente dei buoi incendiari.
Non sappiamo se oltre a fare terra bruciata nell’agro di Rufrium Annibale si spin-se anche ad assalire la città sul Monte Castello e le altre fortezze collinari nelle quali, presumibilmente, si era rifugiata la popolazione ma ciò parrebbe escluso dalla fulmi-nea velocità della marcia. In ogni caso la desolazione del territorio pare escludere che Rufrium potesse deliberare soccorsi aggiuntivi a Roma dopo la battaglia di Canne e dunque la notizia sarà da attribuire più correttamente a Rufrae-Acqua Rossa posta alle spalle di Nola e protetta, come questa, dalle truppe di Claudio Marcello e pro-babilmente non devastata.
Passata la bufera cartaginese la città di Rufrium era certo indebolita e fu forse indennizzata da Roma magari con l’aumento del territorio, ma è impensabile che in compenso della fedeltà abbia subito peggioramenti istituzionali almeno sino alla guerra sociale durante la quale probabilmente fu, al pari delle vicine Venafrum, Cal-lifae e Allifae, distrutta da Silla, sicché il suo territorio venne aggregato alla superstite Teanum Sidicinum.
Durante le guerre civili Rufrium, o quel che ne restava dopo la distruzione sillana, probabilmente parteggiò per Augusto ed ebbe poi come patrono Agrippa, ricavan-done benefi ci per i quali innalzò statue allo stesso. Questo ci è tramandato dalla base onoraria posta il 31 a.C. ad Augusto, allorquando fu imperatore per la VI volta, e ad Agrippa. Ma se in questo tempo Rufrium era in condizione di debolezza istitu-zionale per essere ridotta ad un vicus, o ad un complesso di vici, di Teanum, tuttavia non doveva essere priva di dignità visto che era titolare di edifi ci pubblici (quorum aedifi cia sunt), probabilmente quelli realizzati e donati da Augusto.
Possiamo pensare che i cippi dedicati dai Rufrani Vicani servivano a onorare i be-nefattori e a rammentare in perpetuo la proprietà degli stessi contro ogni ingerenza di Teanum, ma è certo che la mancata resurrezione dello status di città, considerato il favore del Principe, sia da imputare non a disgrazia politica, ma alla crisi demo-
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 278
grafi ca ed economica dovuta al ferro e fuoco di Silla che, probabilmente, determinò anche il collasso defi nitivo dell’insediamento fortifi cato in collina, se questo non si era già spopolato per patto bellico o per abbandono spontaneo dopo la cessazione delle guerre sannitiche.
Dunque come avvenne per le sedi sannitiche di Callifae, Allifae, Telesia, Vena-frum, Saepinum la città sannitica di Rufrium cessò di esistere al più tardi in età sillana, mentre almeno un centro demico dei Rufrani Vicani fu rifondato o incre-mentato in pianura con le provvidenze statali o private di Augusto.
Ai piedi del colle di Presenzano sorgerà poi probabilmente una villa rustica che sarà appartenuta ad un Presentius o a un Presenteius, nome portato anche da un duce della guerra sociale, verosimilmente di un antico proprietario di un latifondo dal quale deriverà poi l’attuale nome di Presenzano. Se il prediale prese il sopravvento sul nome dell’abitato difeso dalla cinta poligonale del Monte Castello di Presenzano vuol dire, infatti, che questo era già ridotto a rovina ed il poleonimo dimenticato o trapiantato altrove, sicché il successo del prediale pare “sigillare” l’abbandono del centro sannitico. Naturalmente il toponimo potrebbe essersi affermato anche in età tardoimperiale, ma trattandosi di gentilizio italico e vista la crisi documentata dallo scadimento a vicus, sembra ipotizzabile una sua affermazione già nel periodo postsillano.
Se quanto ipotizzato corrisponde al vero, al più tardi in età tardorepubblicana si ebbe il collasso dell’antico centro fortifi cato da mura poligonali sul colle del Castello di Presenzano, mentre resta da vedere dove sorse Rufrium romana, successivamente alla guerra sociale.
Naturalmente il primo pensiero è che uno degli aedifi cia delle iscrizioni dei Rufrani sia l’anfi teatro e che la città sia (ri)sorta presso l’anfi teatro, come suppose il De Guevara. Ma ciò è meno scontato di quanto sembri. Anzitutto ad oggi non vi sono resti noti di abitato presso l’anfi teatro, ma solo una terrazza a monte, forse pertinente ad un tempio, e resti di edifi ci, forse termali, di II sec. d.C., mentre il mo-desto interramento dell’anfi teatro pare escludere frane tali da aver sepolto a notevole profondità altri edifi ci. Comunque, anche ipotizzando il rinvenimento in futuro dei resti di un vicus ciò non implica necessariamente l’inesistenza di altri vici.
Inoltre, l’anfi teatro è tanto prossimo alla cappella di San Felice a Rufo da far pensare che gli edifi ci del supposto vicus, allineandosi lungo la strada (vicus a via) a collegare le due attuali zone di ruderi dell’anfi teatro e della taverna di S. Felice a Rufo, in pratica avrebbero portato Rufrium romano sulla Latina. Ma questo sembra escluso dalla Tabula Peutingeriana e dagli Itinerari nei quali abbiamo visto appare ad Flexum-S. Pietro Infi ne e non una dicitura in Rufrio e ciò sarebbe impensabile se questo vicus era a cavallo della Latina. Noi sappiamo che la statio dopo ad Flexum era proprio quella di San Felice a Rufo e che è ammissibile emendare ad Rotas in qualche cosa come *Ad Rufum (fontem, compitum?) ma proprio questa situazione di fatto esclude che qui fosse l’abitato dei Rufrani Vicani. Infatti se qui fosse stata la
279Rufrium sannitico e romano
sede dei Rufrani Vicani, la statio non sarebbe nei pressi (ad), ma nell’abitato (in) del vicus e dunque la Tabula avrebbe qualcosa come in Rufrio, locuzione esclusa anche dagli Itinerari.
L’anfi teatro sito presso il medievale San Felice a Rufo, oggi taverna San Felice, è stato datato, non senza dubbi, all’età di Augusto e potrebbe in tal caso essere uno degli edifi ci pubblici menzionati dalle iscrizioni, ma di questo non vi è ancora prova e pare strano che dopo la ipotizzata radicale distruzione sillana e la conseguente estrema prostrazione di Rufrium si pensasse a costruire per prima cosa un edifi cio non indispensabile.
Dato il toponimo Fontana Rufa, e poiché non poteva essere a cavallo della via Latina, ma nei pressi, Rufrium poteva essere più a nord dell’anfi teatro verso o sotto Presenzano, ma non oltre questo abitato, visto che i grandi scavi per il lago artifi ciale dell’ENEL non avrebbero evidenziato strutture vicane.
Ma è anche vero che la corografi a del De Guevara mostra rovine allineate in se-quenza sulla strada S. Felice a Rufo-Sesto Campano, che sicuramente è antichissima visto che sulla stessa gravitano necropoli e l’abitato munito di vallo qui di recente scoperto47 ed anche va ricordato che una potente coltre colluviale potrebbe aver co-perto i resti romani, magari smantellati in epoca medievale per la parte emergente.
Questa sequenza appare teoricamente abbastanza verosimile, ma non si spiega allora perché l’anfi teatro sorga lontano dall’abitato di Masseria Pozzo o meglio da una contigua ipotizzabile sua continuazione in età romana. Infatti a Cales e Casinum gli anfi teatri sono nel tessuto urbano, ed a Venafrum, Allifae e Teanum subito fuori le mura, e se la consuetudine fu rispettata anche qui, Rufrium dovrebbe essere non lontana e non sulla Latina, come abbiamo visto, e dunque verso Fontana Rufa.
Però qui non vi sono resti archeologici e se questo è un argumentum ex silentio è pur vero che null’altro garantisce che la Rufrium postsillana non sia risorta ad una certa distanza dall’originario sito preromano e da Fontana Rufa. Sicché sarà lecito e forse necessario cercare nel territorio storico sicuramente rufrano se vi siano tracce di qualche altro abitato di età romana con le seguenti caratteristiche: non essere sulla via Latina ma assai prossimo (ad) a questa, e con caratteristiche urbane o pseudour-bane, riconducibile ad un vicus notevole e con resti dell’età del Principato perché dotato da Augusto di strutture ed edifi ci pubblici, incluso un acquedotto, quello menzionato da M. Volcio Sabino ed abbastanza vicino per utilizzare l’anfi teatro.
Tutte queste caratteristiche, ad oggi, si ritrovano unicamente nell’abitato scoper-to in tenimento di Mignano, in località Fosso Camponi: «Da un vasto scavo eseguito a poca distanza ad occidente dell’abitato medievale di Mignano Montelungo è derivata l’eccezionale scoperta di un centro urbano fi nora del tutto ignoto e che rende più artico-lata e varia la tipologia delle forme di insediamento nel territorio di età romana.
Il sito ubicato lungo la via Latina sorge su un terrazzo naturale fi ancheggiato ad ovest dal corso d’acqua denominato Fosso Manci o Camponi. Ed a sud dal torrente Peccia, che scorre incassato nel banco tufaceo.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 280
All’interno dell’abitato, le strutture murarie si conservano al livello di fondazione, con pochi resti del piano di calpestio antico, mentre i servizi ipogei (collettore principale, impianti fognari secondari, canalizzazioni e condutture idriche in piombo) sono in buo-ne condizioni. L’analisi dei dati di scavo, seppure ancora del tutto preliminare, ha evi-denziato almeno sei fasi di occupazione, tra il IV secolo a.C. ed il VI secolo d.C., ma sono ancora da chiarire le dinamiche storiche che ne determinarono la nascita e l’evoluzione.
Sulle rovine di una villa di età repubblicana il primo intervento complessivo e programmato portò all’insediamento di un vero e proprio impianto paraurbano in età augustea – come confermano la presenza di terra sigillata italica nei riempimenti delle fosse di fondazione dei muri degli ambienti e la tecnica edilizia impiegata negli elevati, un opus reticulatum di piccolo modulo con tufelli parallelepipedi usato di solito nei can-tonali – interessato poi da un rilevante momento di ristrutturazione da porre in epoca medio imperiale.
Di strade principali, glareate orientate a 220° sud-ovest/nord-est, ne sono state al momento individuate due, che, incrociandone altrettante, creano isolati quadrangolari di m 43x43; di essi sono stati indagati, parzialmente, quelli costituenti l’insula I, situata a nord, e per intero, quelli della II, posta al margine sud-est dell’insediamento; esse sono divise dalla strada che, chiusa al traffi co carrabile da un paracarro, conduce ad una vasta area con portici da identifi carsi con il Foro. La piazza, forse pavimentata con lastroni di calcare, ha il lato orientale delimitato da una serie di colonne in laterizio intonacate e stuccate, davanti alle quali corre una canalizzazione in tufo locale, per lo scolo delle acque piovane dai tetti dei porticati, e tra cui erano collocate basi, anch’esse in laterizio, sostenenti statue.
L’insula I è occupata da tre edifi ci probabilmente tutti pubblici, il più signifi cativo dei quali è un impianto termale, con frigidarium, praefurnium e calidarium. L’insula II presenta sul lato nord-est alcune botteghe affacciate verso il Foro; due fontane pub-bliche sorgono invece lungo la strada. La parte nord-est dell’isolato rimase in un primo momento inedifi cata, mentre l’estremità opposta fu occupata da una domus, orientata nord-ovest/sud-est, con ingresso sulla strada.
Durante l’età medio imperiale continuarono in entrambi i settori gli interventi edili-zi, probabilmente ancora di committenza pubblica. Nell’insula I fu costruito un nuovo complesso termale ad ovest del precedente, costituito da vari ambienti e da un calida-rium, in origine sontuosamente decorato con mosaici in pasta vitrea e pavimenti di opus sectile. Nella stessa epoca, nell’insula II, fu realizzato un edifi cio a pianta ellittica (recin-to di bestiame e/o ludus?) che, come nel caso analogo del Foro di Egnathia, è delimitato da una struttura muraria apparentemente priva, per spessore e tecnica edilizia usata, di funzione portante. L’impianto che sembra potersi attribuire al II secolo d.C., obliterò la precedente canalizzazione della fontana e provocò lo sbarramento della strada originaria con paracarri e creazione di una nuova sede stradale con spostamento dell’incrocio, al margine del quale fu eretta un’altra fontana. Impianti per la conservazione dell’acqua, presenti in un settore dell’area scavata, appaiono in relazione con quattro basi quadrate,
281Rufrium sannitico e romano
perfettamente allineate in senso nord-ovest/sud-est, forse le fondazioni dei piloni dell’ac-quedotto cittadino.
A sud est di questo probabile vicus ulteriori resti di strutture murarie, costruite con un opus incertum molto irregolare ed aventi lo stesso orientamento del vicus sono da inter-pretare come muri di divisione e di terrazzamento dei terreni coltivati dagli abitanti.
In epoca tardo imperiale l’insediamento mostra evidenti segni di decadenza; la con-tinuità di vita nel sito è, però, documentata dalla costruzione di un edifi cio di culto cristiano. Prospiciente il lato sud della strada che delimitava l’abitato romano, fu innal-zata una piccola chiesa, a navata unica con abside al fondo, fi ancheggiata da una sorta di canonica e provvista, sul lato opposto del cortile, di un piccolo cimitero con sepolture di adulti prive di corredo. Attorno alla basilica, installato nei ruderi di epoca romana, dovette sorgere, nello stesso periodo, un piccolo villaggio, abbandonato defi nitivamente in età alto-imperiale, come sembra attestato dalla presenza, negli strati di obliterazione, di ceramica comune a bande e dalla contestuale assenza di invetriata».48
La lunga citazione dimostra che l’abitato di Fosso Camponi soddisfa, tutte le condizioni richieste: è nel territorio di Rufrium, è di epoca augustea, non siede sulla Latina, ha edifi ci pubblici: foro, terme, acquedotto49 e dunque può ben rappresenta-re l’unico o il principale vicus della fase romana postcesariana di Rufrium. Può anche legittimamente pensarsi che l’abitato, forse già danneggiato dal grande terremoto del V secolo e certo indifeso e pericolosamente vicino alla Latina sia andato distrut-to durante le invasioni barbariche o durante la guerra gotica, quando gli eserciti si mossero sulla via Latina, come testimoniato da Procopio.
Dopo l’abbandono, nonostante la fase cristiana, l’abitato è stato sistematicamen-te raso al suolo per recuperare materiali di costruzione e pertanto può ben essere il luogo di provenienza delle basi onorarie con le dediche ad Augusto e Agrippa. In-fatti queste sono state riutilizzate come materiale edilizio e nulla vieta che giungano da Fosso Camponi, distante solo 5 miglia da S. Felice a Rufo, miglia che corrono tutte in pianura e sulla Latina ancora perfettamente lastricata in epoca medievale e dunque facilmente percorribile. Nel foro di Fosso Camponi sono state rinvenute basi per cippi onorari e non meraviglierà il trasporto a qualche miglio di distanza chi consideri che le epigrafi dell’anfi teatro di Venafrum furono nel medioevo portate a San Vincenzo a Volturno.50
Si può, dunque, ipotizzare che, dopo le distruzioni sillane e le guerre civili, col fa-vore di Augusto Rufrium sia stata rifondata ex novo con la realizzazione di un nuovo impianto urbano con foro, porticus, terme, fogne e acquedotto, in un sito già in pre-cedenza utilizzato per una villa forse confi scata agli sconfi tti avversari di Augusto.
Sebbene le iscrizioni parlino di edifi ci anche l’acquedotto, in virtù dell’appella-tivo Acqua Iulia, è da ricondurre ad Augusto, adottato nella gens Iulia da C. Iulius Caesar. Giova in proposito precisare che potrebbe trattarsi anche del prolungamento dell’acquedotto augusteo di Venafro, cosa da noi proposta in passato e che tuttora non si può escludere.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 282
Ma per il fatto che ad oggi non se ne conoscono tratti diretti da Venafro ver-so Sesto-Presenzano, e poiché non vi è certezza che l’acquedotto di Venafro fosse chiamato Acqua Iulia, potrebbe anche trattarsi di un altro autonomo acquedotto realizzato su ordine di Augusto probabilmente da Agrippa. Infatti la denominazione dell’Acqua Giulia dedotta da M. Vocio Sabino, suggerisce il confronto con l’Aqua Iulia di Roma, il cui acquedotto fu costruito secondo Frontino da Agrippa nel 33 a.C., o nel 40 a.C. secondo Cassio Dione.
Né si tratta di casi isolati: la denominazione attuale di Acqua Iulia di una sor-gente sopra Sparanise potrebbe indicare il capo d’acqua dell’acquedotto per Cales e l’Acqua Giulia sopra Caserta vecchia una captazione per rifornire Calatia, mentre Capua veniva dissetata dalle Acque Giulie del Taburno.51
Dunque è ben possibile che in un quadro di realizzazione delle infrastrutture idriche della Campania Agrippa abbia realizzato un’Acqua Iulia in favore dei Rufrani Vicani e che M. Volcio Sabino ne abbia poi derivato un ramo verso altra utenza degli stessi, forse le terme presso l’anfi teatro. Questo, se era presillano potrebbe far rite-nere che non troppo lontano esistesse l’abitato che supponiamo distrutto da Silla, se postillano potrebbe essere stato realizzato non presso la ricostruita Rufrium ma in posizione baricentrica tra l’insediamento presso Mignano e gli insediamenti vicani nella piana di Presenzano.
Fu poi dotato di terme, sicché certo un acquedotto vi giungeva e, per quel che può valere, la direzione nord-ovest/sud-est dei pilastri dell’acquedotto di Fosso Camponi segue la direzione della valle di Mignano verso S. Felice a Rufo.
Anfi teatro e terme servivano la popolazione dei Rupheni o Rufrani Vicani ed an-che gli edifi ci di età repubblicana che sorgono sotto la cappella di S. Felice a Rufo e nel campo tra questo e la ferrovia, forse riferibili ad una importante taverna sulla Latina, dei quali si dovrebbero indagare le funzioni e verifi care se possano come è possibile costituire uno degli edifi ci dei quali i Rufrani rivendicavano epigrafi camen-te la proprietà.
Per questi motivi, poiché allo stato attuale non sono note evidenze archeologiche paragonabili per datazione, consistenza e qualità a quelle di Fosso Camponi, ten-diamo ad escludere che in luogo diverso sia stata Rufrium romana. Va comunque ribadito che nell’area tra Presenzano e Tora doveva abitare altra frazione dei Rufrani e che non è senza signifi cato che in questa area siano Fontana Rufa e la località Arob-bia o Robbia che sembra calco linguistico di rufus = rubeus. Va anche segnalato che l’ampliamento degli scavi di Masseria Pozzo potrebbe evidenziare in futuro tracce della presenza di un abitato romano, oggi unicamente ipotizzabile sulla base delle indicazioni del De Guevara.
Nel Medioevo, pur dopo la distruzione dell’abitato di Fosso Camponi, proprio per la struttura pluricentrica dell’insediamento, il nome di Rufrium ancora portato da qualche vicus scampato sopravvisse almeno come predicato nel nome di San Felice a Rufo. Quanto all’agiotoponimo di San Felice è da avvertire che l’attuale
283Rufrium sannitico e romano
dedicazione della nuova chiesa a San Felice di Cantalice è recentissima ed infondata, poiché la devozione già testimoniata in età longobarda è probabilmente paleocristia-na e da riferire all’omonimo santo vescovo di Nola esaltato da San Paolino da Nola, visto che questi narra che schiere di fedeli, tra i quali quelli di Atina, si recavano in pellegrinaggio a Cimitile percorrendo la via Latina oppure ad una dedica esaugurale di una antica devozione preromana, come altrove documentato.52
Note1 Liv. VIII, 25, 42 Cfr. Caiazza 2006, parte seconda, 313 segg.; D. Caiazza, Topografi a antica dei Sanniti Pentri, c.d.s.3 Per l’attribuzione ad Allifae sannitica delle mura megalitiche site sul colle di S. Angelo di Alife in luogo di quelle sul Monte Cila sopra Piedimonte d’Alife o di Castello Matese cfr. Caiazza 2001 a.4 Cfr. Caiazza 1986, cap. XIII.5 Salmon 1985, 233.6 Salmon 1985, 287.7 Cantilena 1980.8 Offensive su Alife del 310 e del 307; offensiva di Publio Decio Mure dal territorio sidicino al Sannio; con-trattacco sannitico agli agri Campano e Falerno; battaglia sul Volturno tra i Romani condotti da L. Volumnio ed i Sanniti comandati da Stazio Minacio; incursione sannita nell’agro Vescino e nelle vallate del Volturno: cfr. Caiazza 1986, cap. XIX.9 Conta Haller 1978, 38.10 Caiazza 1991.11 Virg., Aen. VII, 739.12 Sil., VIII 506.13 Rispettivamente CIL X, 4830 e 4831.14 Foto ed apografo in Caiazza 1995, 106-107.15 Caiazza 1995, 108.16 Caiazza 1995.17 Salmon 1985, 183: la pratica rituale di dipingersi il viso di rosso era molto diffusa in tutta la zona del Medi-terraneo.18 Come mi ha cortesemente riferito la prof. Claude Albore Livadie.19 Conta Haller 1978, 37.20 Data l’alta antichità dell’agiotoponimo si tratterà della devozione a S. Felice di Nola.21 Cfr. Dizionario Etimologico UTET, s.v.22 La rara carta della Diocesi di Teano è pubblicata in Caiazza 1986 e Caiazza 1995.23 La pluralità di annotazioni può spiegarsi col fatto che il presule riconobbe la sede principale di Rufrae presso le rovine più cospicue, quelle dell’anfi teatro, ma conoscendo le menzioni dei Rufrani Vicani, ritenne che con tale espressione non si dovesse intendere gli abitanti del vicus rufranus ma gli abitanti di vici rufrani. Pertanto identifi cò negli altri tre siti di rovine dei sottomultipli dell’insediamento cioè altri vici di Rufrae, in tal modo ricostruendo una realtà policentrica di più abitati – tutti dei Rufrani – allineati sulla bretella viaria che rasen-tando il piede orientale del Monte S. Leonardo collegava la via Latina e la via Teanum-Venafrum, ipotesi, come vedremo, parzialmente confermata dalle recenti scoperte.24 Trutta 1976, 242.25 Beloch 1989, 464.26 Cfr. Caiazza 2006. Va anche detto che Batulum oggi potrebbe suonare come Vatulo e si rammenti Vatolla nel Cilento.27 Magari inconsciamente suggestionato dal fatto che in Presenzano e Venafro erano state ritrovate due iscrizioni poste alla Mater Deorum da Sabidia Cornelia (CIL X, 4829 e 4844), argomento tuttavia in pratica irrilevante.28 Poiché Teanum, Casinum e Venafrum appartennero tutte alla Teretina tribus, le menzioni della tribù non sono
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 284
indiziarie e dunque ci si dovrà riferire piuttosto a limiti geografi ci naturali ed ai confi ni diocesani, ed a questa stregua sembra improbabile che Venafrum varcasse il passo della Nunziata a Lungo a ovest ed il Volturno a est, visto che alcun documento indizia lo straripare della diocesi venafrana oltre la Nunziata a Lungo. Neppure ap-pare probabile che il territorio di Casinum oltrepassasse Cervaro e la linea dei Monti Trocchio e Porchio.29 Trutta 1976, 416.30 Bonanni 1914, 19.31 Pantoni 1975, 314.32 Gaudenzi 1888, 8.33 Baldacci 1991, 13.34 Capini 1999, 9.35 Solin 1993, 367: un altro bell’esempio della estensione dell’Oufentina presenta un’iscrizione inedita ritrovata a Rocca di Evandro, che faceva probabilmente parte del territorio di Venafrum.36 Kajava 1989, 244-245.37 CIL X, 4632.38 Solin 1993, 373-374, 396.39 Questi autori infatti hanno scritto nel 1993 e nel 1989 e dunque in tempi lontani dal Bonanni ed anteriori alla puntuale ricostruzione del tracciato della via Latina pubblicata nel 1995.40 Stando a De Monaco 1957, 110, Sandrario o Sandoario fu vescovo di Teano nel 1006.41 La Vandra in pratica lambisce la via Latina sotto Taverna S. Cataldo e solo seguendo la Latina è possibile rag-giungere il Passo della Nunziata a Lungo. Ciò rende inammissibile l’ipotesi di far risalire il confi ne lungo la Van-dra-Peccia sino a Mignano. La mezzeria delle strade è spesso tuttora usata come confi ne tra territori comunali.42 Invece il castello di Rocca Pipirozzi, Sesto e S. Nazario erano in diocesi di Venafro secondo la Bolla di Papa Alessandro III del 1772: cfr. Cotugno 1824, 176 segg.43 La chiesa è detta a lungo = distante, per distinguerla da altra chiesa dell’Annunziata sita nella città di Vena-fro. 44 In origine il territorio di S. Pietro Infi ne era più ampio e correva dalla Nunziata a Lungo sino a dietro il Monte Sammucro e poi scendeva lungo il vallone dell’Acqua Bianca includendo il territorio di S. Vittore.45 Si noti che questo toponimo deriva da lat. rubeus = rufus sannitico, ma potrebbe trattarsi di un prediale de-formato o nato da cognomi come Robbio o Di Robbio, oggi assenti dall’elencio telefonico di Presenzano, ma presenti nella vicine Vairano e Pietravairano.46 F. Sirano, Presenzano-Rufrae per una nuova immagine della piana nell’antichità, in Presenzano ed il Monte Cesima, Archeologia, arte e storia di una comunità (Quaderni Campano-Sannitici, 3), a cura di D. Caiazza, Pie-dimonte Matese 2002, 61-97.47 Ora vedi pure F. Sirano, Ceramica fi gurata da Presenzano (antica Rufrae), in Pittura parietale, pittura vascolare. Ricerche in corso tra Etruria e Campania, Atti della Giornata di studio (S. Maria C.V., 28 maggio 2003), a cura di F. Gillotta, Napoli 2005, 151-171.48 De Caro, Miele 2001, 517-520. Si veda in questo stesso volume il contributo di G. Gasperetti ed in part. le fi gg. 11-17.49 Improbabile che l’acqua provenisse dalla copiosa sorgente di S. Maria dell’Acqua di S. Pietro Infi ne dalla quale partivano acquedotti diretti verso il cimitero ed anche verso l’abitato di Ad Flexum, poiché il modesto dislivello diffi cilmente avrebbe consentito di aggirare il Monte Lungo. Forse l’acqua a Fosso Camponi giungeva da sud e cioè da Fontana Teano, sita tra Campo e Colle Friello, visto che il dislivello è suffi ciente e la distanza esigua, mentre il non lontano toponimo Vaglie = bagni sembra indiziare buone risorse idriche nell’area. La pendice sud di Cesima ad oggi non ha fonti e anticamente la situazione non doveva essere diversa visto che tra la Latina e Cesima sono state rinvenute cisterne romane, cfr. Caiazza 1995, 39.50 Come dimostrato da Mike Kajava in un recente convegno di Venafro.51 La statistica del Regno di Napoli nel 1811, tomo IV, a cura di D. Demarco, Roma 1988, 129. 52 Caiazza 2005.
Le ville rustiche dell’ager Falernus: il territorio di Carinola*
Tommaso Conti
La zona oggetto del presente contributo ricade in un tratto dell’importante anti-co comprensorio dell’ager Falernus1 che, sin dal IV sec. a.C., era stato oggetto delle mire espansionistiche della potenza romana, in aperto contrasto con l’elemento sannita. La graduale presa di possesso di questo territorio da parte romana risulta signifi cativamente scandita da una serie di eventi in un periodo compreso tra la se-conda metà del IV e gli inizi del III sec. a.C.: la cessione ai Romani dell’agro Falerno da parte dei Campani alla fi ne della guerra latina (340-338 a.C.);2 la creazione nel 318 a.C. delle tribù Oufentina e Falerna;3 la brutale repressione nel 314 a.C. delle popolazioni autoctone ausoniche-aurunche;4 la fondazione nel 313 a.C.5 della co-lonia latina di Suessa Aurunca e nel 312 a.C. la costruzione della via Appia,6 prima grande via publica in grado di proiettare gli interessi politico-economici di Roma verso il sud, in un’ottica strategico-militare che intendeva lo sviluppo viario come effi cace strumento di conquista. Infi ne, nel 296 a.C., la fondazione delle colonie di Minturnae e Sinuessa7 con lo scopo di rafforzare la presenza dell’elemento romano nella zona.
Lungo il tratto della via Appia che attraversava l’agro Falerno si stabilirono, tra il III ed il II sec. a.C., piccoli insediamenti rustici presumibilmente a conduzione familiare, fi nalizzati ad una economia di autoconsumo o al commercio a breve rag-gio. Nel corso del II sec. a.C., e per tutto il secolo successivo, nella zona si registra un fl oruit di numerose strutture a carattere produttivo-residenziale8 in connessione diretta con il boom produttivo, incrementato dal largo impiego di manodopera servile. La distruzione di Cartagine e la presa di Corinto nel 146 a.C.9 segnano un momento importante per l’economia di Roma, con la possibilità di commercializ-zare i prodotti nell’intero bacino del Mediterraneo oltre a favorire l’immissione sul mercato di una grande quantità di schiavi.10 Anche nella zona compresa tra gli attuali Lazio meridionale e Campania settentrionale fu utilizzato un gran numero di schia-vi, come testimonia Orosio,11 il quale ci informa che in seguito alle rivolte scoppiate in Sicilia nel 133 a.C. «a Minturno furono crocifi ssi 450 schiavi ed a Sinuessa quasi 4000 furono annientati […]». Questo insieme di cause permise, nel corso del II sec. a.C., lo svilupparsi di un modello economico basato sulla produzione dell’olio e particolarmente del vino e sul loro commercio, anche se a breve distanza. Ulteriore prova di tale attività commerciale è fornita dalla presenza in zona di fornaci che pro-
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 288
ducevano anfore di tipo “greco-italico”, contenitore per il vino Falernum di ottima qualità già nel II sec. a.C.,12 ma che fu ritenuto il migliore dei vini italici durante il se-colo successivo,13 divenendo un vino di lusso con denominazioni di origine. Intorno al 135 a.C., le anfore “greco-italiche” sono sostituite dalle anfore di tipo Dressel 1,14 considerate il contenitore vinario italico tardo repubblicano per eccellenza, simbolo del dominio del vino italico in Occidente.15
Tra la fi ne della repubblica e gli inizi dell’impero si assiste ad una parziale trasfor-mazione dell’organizzazione territoriale, preludio dell’impianto dei grossi latifondi e dello spostamento delle fornaci dalla costa verso l’interno, e contestualmente alla sostituzione delle Dressel 1 con le Dressel 2-4, contenitore molto meno diffuso del precedente, anche in relazione alla crisi del vino italico a partire alla fi ne del I sec. a.C., soppiantato dalle più economiche produzioni provinciali.16 Nella crisi generale del settore, la creazione nel 95 d.C. della via Domitiana, che permetteva un percor-so diretto con Puteoli ed il conseguente dirottamento dei commerci verso la zona costiera,17 costituisce un ulteriore, notevole danno per l’economia della zona; per cui, tra la fi ne del II e gli inizi del III sec. d.C. buona parte dei siti pedemontani e collinari vengono gradualmente abbandonati. Il dato trova confronti nel panorama generale italico, dove si assiste alla chiusura del 40% circa delle villae presenti nel territorio, mentre le restanti saranno gradualmente abbandonate nei secoli successi-vi.18 Come diretta conseguenza dell’impoverimento del commercio vinario tirrenico ed adriatico verso il 130 d.C. si assiste, inoltre, alla scomparsa dell’anfora Dressel 2-4.19
La villa rusticaLe strutture individuate, tutte nell’attuale comune di Carinola (CE), sono per
la gran parte insediamenti caratterizzati dalla presenza di uno o più muri di terraz-zamento in opera poligonale, quadrata o incerta, su cui insisteva l’abitazione vera e propria, allo scopo di preservare le fondamenta dell’edifi cio dal dilavamento e dalle frane.20 Questo tipo di tecnica costruttiva accomuna tutte le strutture rustiche del-l’area centro tirrenica. Dai testi dei tre più importanti gromatici latini giunti sino a noi21 apprendiamo che il termine villa rustica è riferito ad un’azienda agricola di medie e grandi dimensioni con una precisa articolazione interna, comprendente: la pars urbana riservata al padrone (dominus), alla sua famiglia e agli ospiti; la pars rustica costituita prevalentemente dagli alloggi per il fattore (vilicus), per gli schiavi ed i loro sorveglianti (monitores), oltre alla pars fructuaria composta da tutti i locali necessari per la lavorazione e la conservazione dei prodotti coltivati nei terreni della villa oltre che dagli spazi produttivi per olio, vino, ceramica, laterizi. I più importan-ti ambienti produttivi erano il locale che ospitava il torchio (torcularium), la vasca per la fermentazione del mosto (lacus), la cella vinaria dove si trovavano i dolia per la conservazione del vino ed infi ne la macina olearia (trapetum).
289Le ville rustiche dell’ager Falernus: il territorio di Carinola
I sitiGrella: la struttura occupa il pianoro alla sommità di una collina sul versante
meridionale del Massico, sulla strada di collegamento Carinola-Cascano, interes-sando un’area di ca. 2500 mq, limitata sui lati nord, ovest e sud da lunghi muri di terrazzamento costruiti con piccole pietre calcaree legate con malta. Questi muri, che presentano sulla faccia esterna contrafforti a distanza regolare (ca. 3,90 m), sembrano databili in un periodo compreso tra l’età tardo antica ed alto medievale.22 Queste opere di terrazzamento probabilmente sono da riferirsi ad un ampliamen-to del complesso rustico, in quanto abbracciano un perimetro maggiore rispetto a quello delimitato da un terrazzamento interno realizzato in opera reticolata,23 proba-bile prolungamento di una struttura in opera incerta individuata lungo il lato est del complesso. Della stessa tecnica muraria è un ulteriore muro di terrazzamento sud al quale sono addossate due cisterne lunghe ca. 11 m con volta a botte. Il connotato produttivo della struttura è attestato dalla presenza di una pietra di ancoraggio in calcare per la sucula (argano) del torchio oleario o vinario. Le fasi di vita della strut-tura di epoca romana sembrano quindi coprire un arco cronologico compreso tra il II sec. a.C. (per la presenza di resti in opera incerta) ed il IV sec. d.C. (termine fi ssato dalla presenza tra i reperti di superfi cie di sigillata africana24).
Masseria La Starza:25 fornace a pianta orizzontale (lungh. 3,10 m, largh. 1,68m) conservata per un’altezza massima di 1,40 m. La luce all’imbocco è di 1,06 m con muri laterali realizzati in opus incertum profondi entrambi 0,31 m e volta spessa 0,33 m. Verso sud è visibile un basso muro (lungh. ca. 10,30 m, largh. 1,23 m, h. 0,65 m) che doveva costituire il recinto dell’area produttiva terminante con un ulteriore muro elevato in altezza di ca. 1,90 m e largo 3,50 m. La fornace è pre-sumibilmente da collegare ad una struttura rustica. A tale proposito è utile notare come, durante lavori edili eseguiti nei pressi, furono messi in luce nel 1980 resti di un impianto abitativo. La ceramica rinvenuta comprendeva un gran numero di frammenti ipercotti da rapportarsi quasi sicuramente alla fornace.26 Fra i materiali ceramici si segnalano ceramica comune, lucerne, anfore inquadrabili in età repub-blicana (II-I sec. a.C.), mentre i materiali più recenti sono costituiti da un’ansa di forma Dressel 2-4 (I-II sec. d.C.), imitazioni locali delle forme Hayes 196 e 197 in africana da cucina datate tra il II ed il III sec. d.C.27 ed una moneta bronzea di Probo (276-282 d.C.).28
S. Lorenzo: all’altezza del Cimitero di Casanova di Carinola in località S. Lo-renzo, immediatamente ad ovest della strada Casanova-Falciano, su una serie di tre terrazze sostruite con poderosi muri in opera incerta (lungh. massima ca. 32 m, h. 3,50 m) (fi g. 1) si attesta una struttura rustica estesa per ca. 1700 mq, della quale sono chiaramente percepibili solo lacerti murari nella terrazza inferiore larga ca. 23 m, ed una cisterna nella terrazza mediana larga ca. 30 m. La cisterna, lunga 6,80 m
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 290
e conservata per un’altezza di ca. 1,75 m in quanto interrata, conserva il condotto di adduzione (largh. ca. 0,62 m, h. 1,22 m) visibile per una lunghezza di ca. 10 m. Datata tra il II ed il I sec. a.C., trova confronto con un’analoga struttura presente nel territorio di Falciano, in località Masseria Le Mura,29 con terrazzamento realizzato nella stessa tecnica costruttiva.
Masseria San Salvatore: 30 muri in opera poligonale creano una triplice serie di terrazze sulle quali s’impianta una villa rustica, sviluppata su ca. 3000 mq, che sfrutta ulteriori sostruzioni in opera incerta funzionali ad un ampliamento della terrazza superiore. Le mura poligonali della terrazza inferiore (Tav. 23), larga ca. 21 m, si conservano per un piccolo tratto di 6 m nell’angolo sud-est. Le sostruzioni della terrazza mediana, larga in origine ca. 35 m, sono conservate verso est per un tratto di ca. 17 m ed un’altezza di 1,60 m (5 assise di blocchi) e verso sud per un tratto di ca. 26 m. La superiore è invece sostruita da mura poligonali, inglobate nel monastero dedicato a S. Salvatore,31 per una lunghezza di 3,10 m ed un’altezza di 2,10 m (6 assise di blocchi). Il complesso per la tecnica costruttiva si data tra il III e il I sec. a.C.
Cambierti-Masseria Zannini: 32 in un’area in prossimità di un salto di quota, a sud della strada Casanova-Falciano del Massico, si conservano tre cisterne parallele
Fig. 1 - Carinola, loc. S. Lorenzo: muro di terrazzamento in opera incerta.
291Le ville rustiche dell’ager Falernus: il territorio di Carinola
con volta a botte. Costruite con le mura perimetrali in comune, dello spessore di ca. 1,00 m, sono lunghe 12,80 m, larghe 2,10 m e conservate per un’altezza, in quanto interrate, di ca. 1,20 m. La cisterna mediana conserva il foro rettangolare di adduzione (0,70 x 0,50 m) a circa 4 m dall’ingresso. Esternamente il paramento del muro della cisterna settentrionale risulta essere costruito in opera incerta. Le cister-ne sono probabilmente da riferirsi ad una struttura produttiva presente nella zona, come sembra attestare lo spargimento di frammenti riferibili ad anfore Dressel 2-4 su un’area di ca. 6000 mq.
La conferma dell’esistenza di una struttura produttiva nell’area viene dal rinve-nimento, in un saggio di scavo effettuato nei pressi da parte di Arthur nel 1980,33 di uno scarico di fornace datato ad età tiberiano-claudia. Il sito copre un arco cronolo-gico databile tra il II sec. a.C. ed il II sec. d.C.
Piantagione-Macerone: 34 la struttura, occupante un’area di ca. 1350 mq in località Piantagione presso la Casella Paolella, si organizza su una serie di terrazze sostruite da muri in opera quadrata pseudoisodomici a giunti asimmetrici in calcare (fi g. 2). La sostruzione inferiore si conserva sui tre lati. Di questi quello meridionale è il meglio preservato (lungh. 24,70 m, h. massima 3,15 m, spess. 0,96 m, per un totale di 6 assise di blocchi visibili), seguito da quello orientale (lungh. 21 m, h. massima 2,60 m, spess. 0,96 m, per un totale di 5 assise di blocchi visibili) e da quello occidentale (lungh. 18,30 m, h. massima 1,10 m, spess. 0,96 m, per un totale di 3 assise di blocchi). Queste sostruzioni creano una terrazza larga 13,40 m, sulla quale non sono visibili strutture. Il secondo terrazzamento conserva, al di sotto della Casella Paolella, solo due blocchi meridionali (lungh. 2 m, h. 0,55 m, spess. 0,30 m) e parte della chiusura orientale (lungh. 11,80 m, h. 0,55 m, spess. 0,50 m, per una sola assise). La stessa Casella insiste su strutture precedenti delle quali è conservato un pozzo del diametro di 0,70 m, aperto su cisterne non ispezionabili. Un ulteriore allineamento di blocchi chiude a nord la struttura, creando una terza terrazza larga 28 m. A ca. 6 m a NO di quest’ultima si trovano i resti di una grossa fornace a pianta verticale (diam. 6,20 m, h. 3,20 m) scavata nel banco di calcare, con un praefurnium lungo 7,30 m e largo 2,60 m. All’interno della fornace si conservano i resti dei due piedritti (h. 1,20 m, largh. 0,85 m) su cui si impostava il piano forato per la cottura di anfore o laterizi. Il carattere produttivo della struttura è confermato dalla presenza di un blocco di calcare sul quale lo scalpellino aveva appena accennato l’innesto per le basi degli arbores di un torchio.35 Il sito sembra coprire un arco cronologico data-bile tra il III sec. a.C. e il I sec. d.C.36
Proprietà Piantagione-Simeone: 37 a una distanza di ca. 100 m in direzione nord dal complesso in località Macerone, è situato un altro terrazzamento in opera poligonale del quale si conserva un tratto discontinuo, con solo qualche blocco chiaramente distinguibile, lungo ca. 29 m. Parallelamente a quest’ultimo e distanti
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 292
Fig. 2 - Carinola, loc. Piantagione-Macerone: muro di terrazzamento in opera quadrata.
293Le ville rustiche dell’ager Falernus: il territorio di Carinola
ca. 40 m, in direzione nord-est ad una quota superiore, si conservano tratti di un ulteriore muro di terrazzamento del quale sono visibili solo alcuni blocchi che rag-giungono una lunghezza complessiva di ca. 16 m. La datazione è compresa tra il III e il II sec. a.C.
Valle delle Conche-La Romita: 38 situata in località Valle delle Conche la strut-tura, che occupa un’area di ca. 2250 mq, s’imposta su di una terrazza sostruita su tre lati da mura in opera poligonale delle quali si conservano brevi tratti, al massimo di due assise, per un’altezza di ca. 0,90 m. La terrazza così defi nita, ampia ca. 1000 mq, accoglie una serie di evidenze delle quali le più signifi cative sono le tracce di un pa-vimento in cocciopesto con motivi fl oreali (rosette) e geometrici (rombi, meandri, ogive) resi da piccole tessere calcaree.39 Ad ovest di queste tracce di pavimentazioni, si conserva un blocco calcareo (1,10 x 0,70 m) interpretabile come base per l’arbor di un torchio, evidenza che porta a considerare la zona occidentale della struttura come pars fructuaria. A conferma di tali ipotesi si segnala la presenza, nel salto di quota sottostante verso sud-ovest, di un’altra base per arbor riutilizzata come abbeveratoio, oltre ad alcuni ambienti, presumibilmente connessi alle attività produttive, e a due cisterne parallele con volta a botte per la raccolta dell’acqua. Delle due, quella me-ridionale si conserva parzialmente in crollo, ma le dimensioni della settentrionale (lungh. 8,60 m, largh. 2,40 m) ne fanno comunque percepire l’andamento plano-
Fig. 3 - Carinola, Monte Finocchiaro: muro di terrazzamento in opera poligonale.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 294
volumetrico. Nell’angolo nord-ovest della terrazza s’imposta invece una piccola struttura (lungh. 3,60 m, largh. 3,80 m ca.) che presenta un paramento in opera reticolata e che, per tecnica costruttiva, si connota come l’elemento più tardo del-l’impianto. Completano l’insieme una piccola grotta naturale che presenta quattro rientranze absidate con funzione e cronologia dubbie e, nell’angolo nord-est, una calcara o fornace verticale del diametro di 6,30 m e della profondità di ca. 3,40 m. La datazione del complesso si pone nell’ambito di un range cronologico compreso tra il III sec. a.C. e il I sec. d.C.
Masseria Vaglie: su di un’ampia superfi cie di ca. 2500 mq, si rinvengono no-tevoli materiali ceramici, fi ttili e dolia, oltre a tracce di murature in cementizio ed in opera quadrata e parte della pietra di ancoraggio per la sucula dell’argano di un torchio. Sul sito, Johannowsky 40 avrebbe individuato una fornace per la produzione, tra l’altro, di ceramica a vernice nera ed anfore Dressel 2-4. Datazione: tra il II sec. a.C. e il II sec. d.C.
Monte Finocchiaro: 41 nel sito è presente una struttura, sviluppata su un’area di ca. 2200 mq, che s’imposta su una triplice serie di terrazze in opera poligonale. La terrazza inferiore, larga 19,30 m, è sostruita da un muro di terrazzamento in opera poligonale (fi g. 3) lungo 34 m e conservato per un’altezza di ca. 2,40 m (6 assise di
Fig. 4 - Carinola, frazione di Ventaroli: complesso di cisterne in opera cementizia.
295Le ville rustiche dell’ager Falernus: il territorio di Carinola
blocchi) in direzione sud, mentre verso ovest e verso est lo stesso risulta essere, tran-ne che negli angoli, meno visibile. La terrazza intermedia, larga ca. 18 m, è sostruita a sud da un muro in opera poligonale, lungo ca. 13,40 m, visibile per tre assise alte ca. 1,30 m e spesse 0,53 m. Tra queste due, un’ulteriore piccola terrazza di ca. 3 m è creata da un altro muro in opera poligonale conservato per una singola assise di altezza rilevabile di 0,34 m e spessa 0,90 m. La terrazza superiore, anch’essa sostruita da un muro in opera poligonale visibile per una lunghezza di 14 m con due assise di blocchi conserva, alla distanza di ca. 33 m da quest’ultimo terrazzamento, una pla-tea rettangolare (7,60 x 6,80 m) in blocchi di calcare di incerta datazione. Parte della struttura è stata riutilizzata per scopi di culto con l’impianto, nell’angolo est della terrazza mediana, di una chiesetta a pianta rettangolare absidata, al cui interno, ora non più visibile, era un tratto di pavimentazione a piccoli rombi, datata ad epoca tardo antica o alto medievale.42 Accanto all’interpretazione della struttura come villa rustica terrazzata, è possibile ipotizzare per lo stesso complesso una funzione di area sacra. Tale interpretazione potrebbe essere confermata dalla presenza della platea ret-tangolare in blocchi di calcare, oltre che dalla strategica posizione di controllo della vallata sottostante che permette una visione perfetta dal Monte Massico al Vesuvio. Se la presenza di materiale ceramico di uso comune, di ceramica a vernice nera, di sigillata italica e tardo italica, di anfore Dressel 2-4 e di un arbor del torchio43 non sembra essere in contrasto con ambienti di servizio di un santuario, l’interpretazione in tal senso del complesso trova però come limite la totale assenza in superfi cie di materiali votivi. Datazione: tra la fi ne del III sec. a.C. e il II sec. d.C.44
Gran Celsa: 45 la piccola chiesa di S. Maria della Gran Celsa o de Monte Excel-so,46 si innesta su un complesso di epoca romana. La struttura è caratterizzata da un lungo muro di terrazzamento in opera incerta (lungh. 26,5 m, h. 3,33 m, spess. 0,84 m) con due aperture interpretabili come il tratto terminale di due canali di adduzione per l’acqua (largh. 0,63 m, h. 1,79 m) sia per la presenza di rivestimento in signino che per la costruzione formale.47 Avanzato verso sud-ovest di ca. 1,50 m è un altro muro in opera incerta lungo ca. 4,60 m, che si collega ad un precedente muro in opera poligonale in blocchi di calcare conservato per una lunghezza di ca. 15,50 m e per un’altezza di ca. 4,50 m. Nel 1980 P. Arthur avrebbe individuato, a seguito della demolizione di parte del muro in opera incerta, lo scarico di una for-nace visibile nelle vicinanze.48 Per la presenza nello strato di forme imitanti la Hayes 8 in sigillata africana, il medesimo scarico sarebbe da datarsi ai primi decenni del II sec. d.C.49 L’intero complesso sembra potersi datare tra la fi ne del III sec. a.C. e la metà del II sec. d.C.
Carinola-Ventaroli: nella zona è presente un sistema di raccolta delle acque,50 costruito in opera cementizia con rivestimento in opus signinum51 lisciato con una scialbatura di calce, costituito da una cisterna orientale (fi g. 4) collegata a due cister-
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 296
ne parallele occidentali tramite un condotto, lungo 6,30 m e largo 1,10 m. La ci-sterna orientale (lungh. 8,50 m, largh. 5 m, h. 3,60 m) è internamente divisa in due navate tramite tre arcate centrali con piedritti d’appoggio larghi 0,85 m. La cisterna presenta una copertura a botte, solo parzialmente conservata, che si impostava sui muri perimetrali e sul sistema di piedritti centrali. Le cisterne parallele occidentali sono lunghe 7,30 m, larghe 7 m e con un’altezza massima di 3,20 m, mentre la co-pertura è costituita da una volta a botte a tutto sesto impostata ad un’altezza di 2,40 m ed appoggiata sulle pareti perimetrali. Lo spessore dei muri laterali del sistema di cisterne è uniformemente di 0,70 m. Questo sistema, pur rientrando nei parametri classici delle cisterne con volta a botte e con camere parallele, se ne differenzia per il corridoio di collegamento tra le due.
Nell’area si conservano altre due cisterne parallele, non comunicanti, lunghe ca. 8,70 m, larghe ca. 2,50 m ed alte 2,83 m, con muri laterali spessi ca. 0,70 m. Poiché la cisterna orientale risulta essere ingombra di materiali, delle due si è potuto rilevare l’interno solo di quella occidentale. Questa, a doppia navata di dimensioni diverse l’una dall’altra, s’imposta su una serie di triplici arcate con base di 0,90 m ed interco-lumnio variabile tra 2,25 e 2,49 m. Da notare nella volta la presenza dell’imbocco di due canali di adduzione. All’altezza dell’imposta della volta (h. 1,80 m) si segnalano le tracce dei cagnoli della centina che di norma venivano asportati dopo il getto.52 Entrambe le cisterne sono coperte da una volta a botte a tutto sesto. Tale sistema, così complesso ed articolato, apre nuove ipotesi sulla struttura di riferimento, la quale potrebbe non essere, per le dimensioni e la portata della raccolta d’acqua delle medesime cisterne, solo una semplice villa rustica ma un pagus o addirittura il sito di Forum Claudii 53 localizzabile nei pressi. Il complesso è databile genericamente in epoca repubblicana.
Note* Si desidera in questa sede ringraziare il Funzionario Responsabile dell’Uffi cio per i Beni Archeologici di Teano, dott. F. Sirano, per la possibilità di pubblicazione offerta al sottoscritto, oltre che la dott.ssa V. D’Avino ed il dott. A. Guarino per aver costituito validissimo aiuto in questa ricerca sul campo. Le strutture rinvenute sono frutto di una parziale indagine operata sul territorio tra gennaio e marzo 2002, fi nalizzata alla redazione di sche-de MA (Monumento Archeologico) e CA (Complesso Archeologico), condotta su incarico della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta.1 Utile specifi care come l’ager Falernus avesse a nord un confi ne naturale costituito dal Massico, e che la zona tra il monte e l’attuale Garigliano costituisse il saltus Vescinum, luogo menzionato da Livio (X, 21, 8) il quale afferma come Sinuessa fosse stata fondata in saltu Vessino, al confi ne tra questo e l’agro Falerno. 2 Càssola 1991, 104. Per le fonti cfr. Liv. VII, 11, 13-15 che parla di cessione alla plebe romana di tre iugeri più un quarto di iugero per compensare la distanza.3 Liv. IX, 20, 6.4 Liv. IX, 25.5 Liv. IX, 28, 7. Secondo Velleio Patercolo nel 312 a.C. (Ad M. Vinicium I, 14, 4).6 Frontin., Aq. 5: «viam Appia a porta Capena usque ad urbem Capuam muniendam curavit»; Liv. IX, 29; D. S., XX, 36, 2; Pomp., Dig. I, 2, 2, 36. 7 Liv. X, 21, 8.8 Per le problematiche generali collegate allo sviluppo delle ville rustiche nella zona si vedano: Vallat 1983b;
297Le ville rustiche dell’ager Falernus: il territorio di Carinola
Guadagno 1987; Chouquer et al. 1987; Arthur 1991; Prospettive di memoria 1993.9 Per il problema storico della distruzione di Cartagine e della fi ne dell’indipendenza greca si veda Giannelli 1983, 282 segg.10 Calcolati in 250.000 tra la fi ne del III e la prima metà del II sec. a.C. ed in circa 1 milione nella metà del I sec. a.C. (Pucci 1985, 18). 11 Storico cristiano attivo all’inizio del V secolo d.C.: Hist. V, 9.12 Plb. XXXIV, 11, 1. Concetto sviluppato da Tchernia (Tchernia 1986, 63-64) che vede la coincidenza dello sviluppo dei vini italici con l’arrivo di schiavi orientali, molto più esperti dei coloni romani come vignaioli e vinifi catori.13 Plin., nat., XIV, 97; Str., V, 3, 6; 4, 3.14 Crimaco 1993, 37.15 A riprova di questo dominio la grande quantità di anfore italiche rinvenute in Gallia (Panella 1981, 55-80), che in alcuni casi superano addirittura quelle provenienti dalla zona di Marsiglia ed il rinvenimento di numerosi relitti trasportanti anfore di tale tipo. Per le problematiche generali dello sviluppo del vino italico si vedano Carandini 1988; Carandini 1989.16 Frederiksen 1981. 17 Frederiksen 1959.18 Settefi nestre 1985, 20 e bibliografi a di riferimento.19 Carandini 1988, 115.20 Per un esame della tecnica dei terrazzamenti cfr. Giuliani 1990, 112-118.21 Cato, Agr.; Varr. Rust.; Colum. Per un inquadramento più ampio del problema cfr. Settefi nestre 1985 e Ca-randini 1988.22 Nel 1982 fu proposto dalla dott.ssa Giuliana Tocco un vincolo archeologico ai sensi della Legge 1089/1939, dopo due successivi sopralluoghi effettuati in data 27.02 e 03.03.1982 da parte del prof. N. Allegro (Uffi cio Archeologico di S. Maria Capua Vetere), del geom. A. Parente (Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta) e del prof. M. Villucci (Ispettore Onorario della Soprintendenza), in una relazione indirizzata all’allora Soprintendente Archeologo dott.ssa Enrica Pozzi Paolini (cfr. Archivio della Soprintenden-za per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, al numero C 6/46, s.v. Carinola). 23 La struttura caratterizzata dalla policromia dei tasselli ed è inquadrabile in un periodo compreso tra età augu-stea e fl avia cfr. Adam 1990, 192-197, g. 306; 314-315; 317.24 Piatto di forma Hayes 50 (Hayes 1972, 69-73).25 Riguardo al toponimo “Starza” e suoi derivati, esso connota quasi sempre in Campania una zona con resti antichi (cfr. tra gli esempi maggiormente noti “La Starza” presso il cimitero di Mondragone e la “Starza” presso Ariano Irpino). Tipico del dialetto napoletano con il signifi cato di “fattoria, vasto podere” (cfr. Andreoli 1887, s.v. Starza), se ne trova menzione già nel XII secolo (cfr. Du Cange 1887).26 Zannini 2001, 39. 27 Hayes 1972, 208-209.28 Arthur 1987, 60 e fi g. 1, 6.29 Zannini 2001, 61. 30 Zannini 2001, 52-57. 31 Poche sono le notizie su questo monastero perché Menna (Menna 1848) non sa a chi fosse appartenuto, mentre Johannowsky (Johannowsky 1975, 36-37) e Torriero (Torriero 1987, 85-96) non offrono nessuna indi-cazione a proposito. Con sicurezza sappiamo che la struttura appartenne ai Padri Serviti (cfr. Zannini 1997, 32, nt. 71) sin dal 1577 o 1578, anche se già nel 1592 il monastero non compare più nei documenti dell’ordine.32 Zannini 2001, 62.33 Arthur 1991, 16, 120; Arthur 1987, 59-60. 34 Zannini 2001, 46-47.35 Zannini 2001, 38, fi g. 45. 36 Termine fi ssato dalla presenza di frammenti di sigillata italica (Ceramica romana 1994, 107). 37 Zannini 2001, 46. 38 Zannini 2001, 58-59. 39 Confronto signifi cativo è la pavimentazione della villa di San Rocco a Francolise (Cotton, Metraux 1985). Per la datazione della pavimentazione al II-I sec. a.C. cfr. de Vos 1979.
40 Johannowsky 1975, 29; Zannini 2001, 50, didascalia fi gg. 69-70. 41 Zannini 2001, 50-51.42 Zannini 2001, 50.43 Segnalato da Arthur ma allo stato attuale non più visibile (Arthur 1991, 119, S62).44 Termine fi ssato dalla presenza di frammenti di sigillata italica e tardo italica (Ceramica romana 1994, 107; 115).45 Arthur 1991, 111-123, S37 e S38.46 Identifi cata dal Menna (Menna 1848) come monastero databile approssimativamente tra il XIV ed il XV secolo.47 Questa interpretazione trova conferma in Gasperetti 1997, 248. 48 Fra le forme più antiche prodotte dalla fornace vi è una coppa (Arthur 1987, fi g. 2, 1), che spesso reca deco-razioni a rotella, confrontabile con la forma Marabini LXIII datata a partire dall’età claudia (Marabini 1973, 252-253).49 L’imitazione della Hayes 8 in africana A (Hayes 1972, 33-35) ed altro materiale vicino ad oggetti rinvenuti a Pozzuoli (Garcea et al. 1984) permettono di arrivare ad una datazione intorno ai primi decenni del II sec. d.C.50 La cisterna costituisce, sin da tempi remoti, un tipo di soluzione comune per il rifornimento di acqua dei nuclei residenziali. Sia in Vitruvio (VIII, 7) che in Plinio (Nat. XXXVI, 52) si trovano regole per la costruzione di cisterne.51 Per la tecnica cfr. Giuliani 1990, 172-174.52 Per la tecnica cfr. Giuliani 1990, 98-103.53 Per i problemi storici connessi alla tradizione foroclaudiense si veda il contributo di Guadagno (Guadagno 1987, 17-57).
La via Domitiana antica nel territorio di LiternumPatrizia Gargiulo
Delle tre grandi vie della Campania settentrionale, la Domitiana è quella che non ha origine da Roma. Essa, com’è noto, staccandosi dall’Appia, della quale è da considerarsi il tronco costiero, nasceva con un arco di trionfo1 a Sinuessa; lungo il suo percorso attraversava le colonie romane di Volturnum e Liternum e la città di Cuma per poi raggiungere Puteoli, dove si raccordava con la preesistente via Puteolis-Neapolim, che ne divenne la continuazione.
Della Domitiana, oltre ai pochi ma monumentali resti delle opere, quali l’Arco Felice di Cuma e il ponte sul Volturno, resesi necessarie rispettivamente per valicare monti e scavalcare fi umi, sopravvivono ancora, soprattutto tra Lago Patria e Cuma, cospicui tratti della pavimentazione in basoli che, talvolta affi oranti, ne segnano l’antico tracciato attraverso la fascia costiera degli attuali Comuni di Mondragone, Castelvolturno, Giugliano in Campania e Pozzuoli, seguendo pressappoco il percor-so della omonima Strada Statale.2
Le caratteristiche geo-morfologiche dei territori paludosi che questo asse stradale dovette attraversare ne giustifi cano la tardiva realizzazione, promossa alla fi ne del I secolo d.C. dall’imperatore Domiziano che per la audace e meritoria impresa verrà celebrato ed elogiato dal poeta Stazio nel libro IV delle Silvae.3
L’iniziativa di Domiziano in realtà non nasceva dal nulla: se sotto l’aspetto tecni-co egli intendeva assicurare e monumentalizzare un percorso viario di cui è attestata la preesistenza,4 da un punto di vista ideale egli realizzò un sogno di Nerone, il quale, dovendo stabilire un più diretto collegamento tra Roma e il Portus Julius di Puteoli, piuttosto che alla costruzione di una strada litoranea aveva pensato allo scavo di un canale navigabile da realizzare sfruttando la serie quasi ininterrotta di lagune costiere presenti tra Lazio e Campania.
Nell’opera, mai compiuta e nota col nome di Fossa Neronis,5 va riconosciuta più che un’ennesima stravaganza neroniana quella naturale tendenza e capacità dei Ro-mani di sfruttare le caratteristiche morfologiche dei luoghi, che aveva suggerito ad Augusto analogamente di creare gallerie e trafori nell’area fl egrea.
L’attenzione in questa sede è rivolta all’area gravitante intorno al Lago Patria e in parte corrispondente al territorio dell’antica Liternum, dove negli ultimi anni al-cuni interventi di tutela hanno offerto l’occasione sia di effettuare verifi che lungo il tracciato già abbastanza noto della Domitiana6 a sud di Liternum, sia soprattutto di conoscere il percorso a nord della città mai in precedenza individuato e indagato.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 300
Il tratto sud compreso tra Liternum e Cuma, da Varcaturiello fi no al Casino reale di Licola,7 indicato anche sulla Tabula Peutingeriana,8 fu posto in luce agli inizi del Novecento dall’Associazione Nazionale Combattenti9 per alcuni chilometri di basolato di lava leucitica, che ancora si preserva integro e quasi affi orante in diversi punti, con i paracarri che delimitano la sede stradale della larghezza di m 4,50, pari a 15 piedi romani, come è stato possibile riscontrare a sud di via Ripuaria (Tav.24, n. 1; fi g. 1). Recenti interventi di tutela, infatti, hanno consentito di se-guirne nuovamente il tracciato,10 anche dove esso non è più visibile, e di verifi care, talvolta, uno stato di conservazione ancora buono della strada nel sottosuolo. Un breve segmento, con tracce dei solchi dei carri, si è avuta l’opportunità di rilevare due metri al di sotto del piano stradale dell’attuale via Ripuaria che vi si sovrappone perpendicolarmente (Tav. 24, n. 2).
Poco più a nord, in occasione di lavori infrastrutturali sull’attuale Strada Statale, è stata intercettata per un lungo tratto l’antica via nel punto in cui essa, piegando verso nord-ovest, è stata intersecata dalla strada moderna (Tav. 24, n. 3), sotto la quale corre trasversalmente ad appena m 0,50 di profondità rispetto al calpestio attuale. A tale quota, è stato possibile esplorare la porzione occidentale di carreg-giata sopravvissuta integralmente con il basolato per soli m 5, mentre si conserva-no per la lunghezza di ca. m 30 i sottostanti strati preparatori. La sezione che si è potuto occasionalmente osservare mostrava la tipica sagoma a schiena d’asino con pavimentazione (summa crusta) in basoli di trachite leucitica di forma irregolare di media grandezza (m 0,40-0,60 x 0,30-0,40) allettati nel nucleus (spess. m 0,20), rappresentato da uno strato di terra limo-sabbiosa, contenente scaglie di trachite e frammenti di tufo, il quale ricopre la ruderatio; questa è costituita da una platea in opera cementizia (spess. m 0,30 ca.) formata da conci di tufo giallo allettati in malta fl uida,11 anch’essa a schiena d’asino, sul sottostante strato di sabbia su cui è fondata. Non si riscontra in questo caso la canonica massicciata (statumen), che caratterizza generalmente il sistema di fondazione delle strade romane. L’inaspettato e curioso rinvenimento di una piccola fi bula in bronzo – evidentemente smarrita durante la preparazione del nucleus della strada – richiama alla mente la quasi frenetica fatica delle migliaia di uomini, ricordata nei celebri versi di Stazio, al quale si deve l’unica descrizione dettagliata di tutte le fasi di costruzione di una strada antica.
Più oltre, a sud del canale detto Lingua di Cane (Tav. 24, n. 4), in occasione di interventi fi nalizzati al rifacimento del sistema di canalizzazione delle acque, sia pure sommersa dalla falda acquifera, la sede stradale della Domitiana è apparsa an-cora delimitata dai margines formati da blocchi di tufo ben connessi (umbones), tra i quali sono confi tti i cd. paracarri.12 Questi lastroni rettangolari, in realtà destinati soprattutto a contenere il nucleo superiore della massicciata stradale, erano denomi-nati gomphi per il loro profi lo a forma di chiodo.13 All’esterno del margines è visibile anche il piano della ruderatio, con un paramento esterno in reticolato, sulla quale è fondato il lastricato con le crepidines (il sistema del summum dorsum) (fi g. 2).
301La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Non lontano, prima che la strada si immettesse da sud nella città di Liternum, la plaga marmorata, come Stazio defi nisce la superfi cie lastricata, è riemersa ancora lungo i bordi del canale detto delle Acque Alte, che ne ha tagliato trasversalmente il tracciato asportandone anche tutti gli strati preparatori (Tav. 24, n. 5; fi g. 3).
Procedendo verso nord, della Domitiana si perdono le tracce, che andrebbero ricercate nelle ormai poche aree lasciate libere dall’edifi cazione nella tenuta Varcatu-riello, dove essa lambiva la necropoli monumentale di Liternum.14
La strada proseguiva poi verso nord-ovest, lambiva l’ingresso principale del-l’anfi teatro15 e, per la rampa prospiciente la villa d’Antona,16 si immetteva nell’area
Fig. 1 - Un tratto del basolato nei territori dell’ex Opera Nazionale Combattenti (foto N. Severino).
Fig. 2 - Restituzione grafica della tecnica costruttiva della Domitiana (grafica V. Ingravallo).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 302
urbana, attraversando il foro in direzione sud nord; una parte del basolato (fi g. 4) sopravvive nel settore settentrionale della piazza, da cui usciva e, seguendo un percorso in parte attestato17 e in parte da ricostruire idealmente, raggiungeva la sponda sinistra del Lago Patria, per guadagnare quella opposta in località Ponte del Diavolo.
Oggi unico elemento superstite di questo ponte è una pila, denominata Pietra Alta (Tav. 24, n.6), che emerge a ca. m 50 dalla riva, ma negli anni Trenta del secolo scorso «in corrispondenza di essa e, fi n verso la riva sinistra del canale di Patria, in fondo ad esso, si osservavano, affondati nella melma copiosi avanzi di costruzioni con sopra-stanti lastroni di silici, circostanza che ha fatto per lungo tempo erroneamente credere all’esistenza di un’antica città sommersa».18 Sull’altra riva, detta Ponte del Diavolo,19 vie-ne indicato un «ammasso indistinto di massicce opere murarie, che si protraevano verso la sponda destra del lago in direzione quasi della Pietra Alta».20 Questa testimonianza sembra non lasciare dubbi sul fatto che questo fosse il punto in cui la Domitiana
Fig. 3 - Varcaturiello, tratto dell’antica Domitiana tagliato da un canale di bonifica (foto N. Severino, SBANC).
303La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
scavalcava il canale, pur non essendosi ancora in grado di defi nire l’esatta direzione del ponte, nonostante le recenti ricerche, come si dirà più avanti.21
In questa zona di confi ne tra Giugliano e Castelvolturno,22 a partire dal 2004,23 per esigenze di tutela sono state condotte indagini archeologiche e geologiche che, oltre ad aver consentito di seguire un tratto poco noto della Domitiana e di acqui-sire nuovi e particolari elementi sulla sua tecnica di costruzione, hanno soprattutto rivelato una geo-morfologia dei luoghi affatto diversa da quella attuale (fi g. 5).
La ricerca archeologica, condotta mediante alcuni saggi di scavo praticati perpen-dicolarmente all’attuale asse stradale, ha consentito di seguirne l’andamento per ca. m 450, lungo il segmento compreso tra la strada che conduce allo Stadio del Remo
Fig. 4 - Avanzi della Domitiana nell’area settentrionale del foro di Liternum (foto N. Severino).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 304
Fig. 5 - Aerofotogrammetria dell’area oggetto delle indagini archeologiche e geologiche (elaborazione grafica L.M. Rendina, soc. Xenia).
e il punto in cui la Domiziana moderna ancora una volta interseca quella romana, che punta verso nord-ovest nella pineta di Castelvolturno (Tav. 24, n. 7).
Il cattivo stato di conservazione di questo tratto si è rivelato utile occasione per osservarne ancora una volta il sistema di fondazione e in particolare gli espedienti tecnico-costruttivi adottati dai Romani per far fronte ai problemi imposti dalla
305La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
natura incoerente dei suoli sabbiosi e dal fenomeno dell’impaludamento, ancora oggi particolarmente accentuato in quest’area a nord di Liternum. Anche la generale assenza di basoli fa pensare ad una sistematica spoliazione e asportazione dovuta, piuttosto che all’attività di bonifi ca agraria, a precedenti recuperi miranti a riutiliz-zare l’antico lastricato quando esso non fu più praticabile.24
Infatti, al di sotto del sottile strato di terreno vegetale, in alcuni saggi archeologici appare visibile la ruderatio, larga ca. m 6,10 e spessa m 0,20, formata da scapoli di tufo legati con malta pozzolanica ricca di grumi di calce; anche in questi saggi si è potuto verifi care che essa posa direttamente sulla sabbia e ricopre i poderosi muri laterali, interpretabili come riempimento dei solchi tracciati dai costruttori,25 insie-me ai quali costituisce un’ampia e solida platea di fondazione atta a ricevere lo strato superiore della pavimentazione;26 i muri di delimitazione sono realizzati general-mente in cassaforma mediante fi lari di conci irregolari allettati in abbondante malta e disposti su tre assise orizzontali, sì da raggiungere l’altezza di ca. m 0,40. Questo poderoso sistema di sostruzione, adottato in luogo di quello tradizionale in cui gli elementi orizzontali e quelli verticali non sono incatenati tra loro,27 nasceva eviden-temente dalla necessità di tenere ben saldi i muri, considerata la natura altamente cedevole dei suoli, onde evitare che potessero inclinarsi sprofondando e facendo cedere tutto l’impianto superiore.
L’indagine in questo tratto, ha evidenziato, in corrispondenza del saggio B, due metri ad est della sede stradale della Domitiana, qui rinvenuta in gran parte distrutta, un battuto stradale, largo ca. 3 m e dello spessore medio di m 0,30 ca., che in vari punti presenta ben leggibili i solchi dei carri a tratti colmati da gettate di detriti per livellarne il piano stradale. Di questo battuto è stato possibile seguire il tracciato rile-vando che, a differenza della Domitiana la quale piega verso nord-ovest, esso prosegue diritto verso nord per ca. m 500, delimitato ad est per un breve tratto, da un muro costruito con materiale di recupero; a sud, in corrispondenza del successivo saggio C, esso invece piega verso sud-ovest, avvicinandosi al tracciato della Domitiana, fi no ad esserne ricoperto, per ricomparire di nuovo ad ovest di essa e fi nire verosimilmente sulla sponda del canale di foce all’epoca più largo (cfr. infra). L’estensione del tratto stradale esplorato potrebbe indurre a identifi care in esso un tratto di quel più antico percorso viario, che prima della costruzione della Domitiana e probabilmente sin dall’epoca arcaica, aveva consentito gli spostamenti lungo la costa.28
Le indagini effettuate hanno evidenziato anche come, procedendo verso sud, la palude avanzi verso ovest; infatti mentre nei saggi posti più a nord la Domitiana è all’asciutto, in quelli più a sud la falda gradualmente la lambisce, poi la ricopre per inondarla scavalcandola di qualche metro, come indicano gli strati di limo sempre più avanzati verso ovest e sempre più potenti di spessore, dai quali si potrebbe rico-struire la forma del fronte di avanzamento della palude.29
In defi nitiva, la strada in questo tratto doveva correre non lontano da un’area di fl uttuazione della palude la quale, in un certo periodo che non è possibile precisare,
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 306
ha cominciato a invaderla fi no a sommergerla del tutto determinandone evidente-mente l’abbandono. E sin dall’epoca della costruzione la maggiore o minore distan-za dalla palude sembra aver indotto le maestranze ad usare differenti soluzioni tec-niche. Infatti, sebbene tali aspetti richiedano ulteriori approfondimenti di indagine – peraltro diffi cili a causa dell’affi oramento della falda acquifera – in alcuni saggi è apparso chiaro che, mentre il muro di delimitazione verso occidente è stato costrui-to in cassaforma, sul lato orientale rivolto verso il lago, il sistema di contenimento della strada è stato realizzato, invece, mediante gettate cementizie direttamente nella palude,30 nella quale evidentemente non era stato possibile fi ssare le tavole di arma-tura della fondazione e dove, forse in un momento successivo, si era reso addirittura necessario rinforzare l’argine realizzato a guisa di scarpata con scaglie di trachite a secco, come si è evidenziato nei saggi D, F, G (fi g. 6 e 7).
Procedendo verso sud il fenomeno dell’impaludamento appare sempre più ac-centuato, come mostra il saggio G che, al di sotto di un potente strato di argilla (m 0,40), segno di una vera e propria inondazione, presenta in situ due soli basoli del lastricato e, ben leggibili sul nucleus, le impronte scure di quelli asportati evidente-mente prima dell’allagamento. Su entrambi i lati si evidenziano per l’altezza di m 0,40 livelli di fondazione dei muri (che delimitano la sede stradale), dai quali spicca un paramento in opera reticolata costituito da tre fi lari di cubilia coperti dalla rude-ratio. Il reticolato, che non si riscontra nei segmenti esplorati più a nord in terreno asciutto, è da interpretarsi come elemento a vista di una rampa, dovuta alla necessità di innalzare il piano della sede stradale.
Infatti, si è rivelato che nel procedere verso sud-est con andamento leggermente curvilineo l’impianto stradale è costituto da un terrapieno poggiante, per una lun-ghezza di m 25, su una platea di fondazione in opera cementizia con paramento laterale in accurata opera reticolata, atta a ricevere ulteriori platee di fondazione31 (fi g. 8) contenute da un muro trasversale, nonché i successivi altri strati di prepara-zione incoerenti, costituiti prevalentemente di sabbia mista a materiale tufaceo e a ignimbrite, fi no a raggiungere lo strato più superfi ciale di allettamento dei basoli. Questa sorta di aggere va a raccordarsi alla testata settentrionale di un piccolo ponte, costituita da una cortina in opera reticolata. È questo uno dei sistemi cui si ricorse
Fig. 6 - Sezione della strada antica nel saggio D (grafica V. Ingravallo, SBANC).
307La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
nel mondo romano per attraversare paludi e suoli cedevoli.32 In molti casi il terrapie-no è fondato sopra una palifi cata di legno33 che nel nostro caso, sembrerebbe essere stata sostituita dalla platea in cementizio, il cui uso, a nostra conoscenza, non risulta attestato altrove.34
La strada in questo tratto conserva lembi di basolato costituito da blocchi di roccia leucitica, alcuni di colore grigio chiaro molto duri e compatti, altri di co-lore grigio molto scuro, più friabili, di consistenza granulosa e con grossi nuclei quarzosi; esso è delimitato ad ovest da un muro in opera reticolata, lungo m 44 e largo m 0,50, che nella sua porzione più settentrionale, alla quale si appoggia un paracarro ancora in situ, è realizzato in opera laterizia e presenta sulla faccia esterna un rivestimento d’intonaco idraulico. Lungo il margine orientale si è trovato, inve-ce, un muro in opera cementizia che, in considerazione dello spessore di m 0,75 e della quota inferiore a quella del muro opposto, è da interpretarsi come la platea di fondazione del corrispondente muro di delimitazione che, su questo versante della strada, non si è conservato. La distanza tra i due muri è di m 10, ma la larghezza massima residua del manto stradale basolato raggiunge m 6,35, ed è diffi cile dire quale fosse l’effettiva larghezza della carreggiata tenuto conto dell’eventuale presenza di marciapiedi.
Il ponticello, cui la strada si raccorda è orientato nord-ovest/sud-est, ed è del tipo a due fornici con aspetto cunicolare (luce m 2,20, h. in chiave m 1,10 ca.); esso ha profi lo longitudinale orizzontale ed è da ritenersi un traforo del terrapieno sopra de-scritto (fi g. 9), del quale ha identica larghezza di m 10 ca.,35 e altrettanta lunghezza di m 10, oltre i quali l’estradosso presenta un’ampia frattura. La costruzione è realizzata in opera cementizia, appare priva di ogni sovrastruttura, compresa la pavimentazio-
Fig. 7 - Superficie della ruderatio del saggio D (foto N. Severino, SBANC).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 308
Fig. 8 - Veduta delle platee di fondazione del basolato e del ponte (foto L.M. Rendina, soc. Xenia).
ne che doveva essere anch’essa lastricata, visto il gran numero di basoli recuperato dall’acquitrino circostante.36 Gli archi di testata lasciano intravedere all’estremità dell’estradosso una fi la di cunei in tufo tenuti assieme da malta, talora intramezzati da laterizi. Le ghiere degli archi, in laterizio, di cui si conservano le impronte in ne-gativo nel conglomerato cementizio, erano verosimilmente composte da bipedales, mentre i muri di testa hanno paramento in opera mista, con reticolato angolare e larghe fasce di mattoni spezzati messi in opera per la lunghezza di m 0,62, visibili fi no alle reni dell’arco.37 Tale tecnica, che esprime quella sapiente ricerca di policro-mia tipica dell’ambiente campano, si riscontra in due ponti viadotto dell’area fl egrea realizzati pressappoco nello stesso periodo sulla via Puteolis-Neapolim.38
Per quanto sia stato possibile indagare in una situazione di rapido allagamento, si è constatato che il ponte è fondato su una più ampia platea cementizia della quale, tuttavia, non è stato possibile rilevare lo spessore, né verifi care se la stessa sia stata poggiata su una palifi cata di costipamento, come è documentato che avvenisse in aree di palude.39
Appena a nord del ponte, il tracciato della Domitiana appare interrotto da due superfetazioni murarie costruite con scapoli di tufo sciolti, verosimilmente di reimpiego, che rappresentano i limiti superstiti di un ambiente edifi cato sulla parte occidentale del basolato, evidentemente quando la strada non era più in uso: periodo che i dati di scavo non consentono di precisare ma che, per analogia con altre costruzioni realizzate sulla sede stradale, può essere indicato in età tardo antica.40
309La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Appare chiaro che per motivi di stabilità si volle sfruttare la quota più elevata, quella del basolato, oltre il quale l’area circostante venne ricoperta da una platea in malta dura per uniformarne il livello di calpestio a quello interno all’ambiente.
Questa platea ha obliterato, in parte, altre strutture che si estendono al di là del margine occidentale della strada. Si tratta di due vasche allineate, di modeste dimen-sioni, rivestite in cocciopesto, sottoposte alla quota della strada e costruite utilizzan-do in parte il muro di delimitazione di essa e in parte una struttura muraria ad L in opera cementizia che vi si addossa, e impiegando per la chiusura dei rimanenti lati blocchi di tufo o di trachite messi in opera senza malta. A nord-est di queste struttu-re, quindi, un po’ più lontano dal ciglio della strada, è stato individuato il perimetro di un vasto ambiente a pianta quadrangolare (mq 240 ca.), con paramenti murari in opera mista, accessibile dal lato occidentale, mentre sul lato orientale comunica per mezzo di una doppia apertura con altri ambienti, probabilmente due, a pianta quadrangolare, chiusi verso la strada da un muro, sul cui lato interno, sono realizzate vasche quadrangolari rivestite con malta idraulica. Considerate le dimensioni del-l’ambiente, benché non sia stato possibile indagarlo nella sua intera estensione, esso potrebbe essere interpretato come il cortile centrale di una stazione di sosta,41 atta a garantire attività commerciali e/o di ristoro presso il ponte, in un punto nevralgico dell’arteria prima dell’ingresso nella città di Liternum.42 La presenza di una struttura ricettiva potrebbe costituire una spiegazione della eccezionale larghezza che la strada raggiunge in questo punto.
A sud del ponte non è stato possibile proseguire lo scavo archeologico per la pre-senza di una strada moderna e per la natura palustre/lacustre del terreno; tuttavia, dati utili anche se estremamente indicativi circa l’andamento della strada sono stati forniti da una serie di carotaggi effettuati lungo la direttrice suggerita dall’andamen-to del ponte (fi g. 5).
Mentre il sondaggio So2 bis, a sud del ponte e sulla scarpata della strada moder-na, ha rivelato una struttura in opera cementizia dello spessore di m 2,50 riferibile alla platea di raccordo ipotizzabile, analoga e speculare a quella esplorata a nord del ponte, nei successivi carotaggi So3, So3 bis, So4, So5, So8 non si è avuto riscontro ulteriore della suddetta platea, lasciando presupporre che la strada dopo il ponte piegasse bruscamente43 verso sud-est, in direzione della pila che emerge in prossimità della sponda orientale del canale. Tale tracciato, pur intuibile per la presenza della pila, sembra tuttavia attualmente solo indiziato dal rinvenimento, nei carotaggi So17, So6, So7 bis, di rado materiale lapideo e malta che potrebbe far pensare ai resti di una massicciata o di un terrapieno apprestati per consentire che la strada valicasse una vasta area di palude.44
L’ipotesi sembra avvalorata dai suddetti carotaggi i quali hanno anche rivelato che il canale, in antico, aveva un’ampiezza maggiore di quella attuale, come si desu-me dai frammenti malacologici presenti nei livelli più profondi dei campioni geolo-gici, a dimostrazione che l’area era, probabilmente, un sistema lagunare aperto verso
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 310
il mare.45 Tale sistema ha permesso la deposizione di un potente deposito di sabbie, soggette a dinamica costiera e al rimescolamento delle acque provenienti dal mare con quelle provenienti dal corso d’acqua che si immetteva nella laguna. L’analisi dei carotaggi ha consentito di delimitare spazialmente tale sistema, come evidenziato nella aerofotogrammetria (fi g. 5) dove, in corrispondenza del sondaggio So15, si rinvengono al di sotto della quota dell’antica Domitiana depositi di ambiente duna-re, mentre in corrispondenza del sondaggio So13, sulla sponda opposta del canale, nei pressi della città di Liternum, si riscontra la presenza di ignimbrite campana. Lo spazio compreso tra questi due punti è caratterizzato da sabbie di ambiente a me-dia energia; e, in particolare nei sondaggi Sa4, Sa5, Sa6, Sa7, Sa8 più prossimi alla sponda orientale, le sabbie sono alternate a livelli ricchi di resti lignei, alghe e semi che caratterizzano un ambiente di battigia. Tale regime paleo-morfologico aperto verso il mare permane almeno fi no ad un periodo compreso tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., in relazione al rinvenimento, in So16, di una moneta in bronzo di età augustea in un deposito di ambiente sommerso. Siffatto processo di sedimentazione sembra essere variato già nel periodo di costruzione del ponte relativo alla via Domitiana (fi ne del I sec. d.C.). Infatti, il canale di foce, così largo e aperto verso il mare, tende progressivamente a ridursi analogamente a quanto sembra essere accaduto, nella stessa epoca, per il lago di Licola.46
Mentre, infatti al centro dell’attuale canale, permane un regime di sedimenta-zione a media energia, nell’area del Ponte del Diavolo, tra i punti So1 e So2 bis, il regime deposizionale presenta caratteristiche di un ambiente a più bassa energia
Fig. 9 - Prospetto delle arcate del ponte (foto N. Severino, SBANC).
311La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
con la conseguente formazione di aree con acque semi-stagnanti che permettono la crescita di una fl ora palustre.47 È questo lo scenario paleo-ambientale nel quale si inserisce la costruzione della strada di Domiziano che, ancor prima di scavalcare il fi ume Liternus con un vero e proprio ponte dovette, probabilmente per mezzo di un lungo sistema di sostruzione stradale, superare una vasta area di palude come sopra accennato.
L’esito dei carotaggi suggerisce novità di notevole interesse sulla topografi a di Liternum, in particolare sulla ubicazione del porto, anche se i dati, assolutamente preliminari, necessitano di ulteriori indagini. La struttura muraria intercettata nei sondaggi So11 e So12, alla quota di m 5,15 dal piano di calpestio attuale può es-sere, verosimilmente, riferita a una banchina che corre parallela al canale di foce e rappresenta una fascia di limite tra le probabili strutture portuali, indiziate dai piani pavimentali riscontrati verso l’entroterra nel sondaggio So13, e lo specchio d’acqua antistante la città, come dimostrano i sondaggi So10, So14 che hanno restituito livelli di spiagge sommerse. Questo dato geologico conferma l’ipotesi che i due am-bienti voltati messi in luce, durante recenti scavi nell’area a nord ovest del foro, siano da interpretarsi come magazzini, aperti verso il lago.48
La geo-morfologia dei luoghi, alla luce di quanto fi nora detto, induce a ritenere che la colonia romana, ferma restando la sua fondazione ad ostium Literni,49 occu-passe una posizione più aperta verso il mare rispetto a quella dell’attuale sito archeo-logico, in considerazione del fatto che non si era ancora formata la duna costiera, la quale solo successivamente avrebbe chiuso il bacino lagunare a seguito degli apporti di sedimenti clastici da nord/nord-ovest verso sud/sud-est, provenienti dai fi umi Garigliano e Volturno che hanno provocato nei secoli una progradazione della linea di costa.50
Per motivi di carattere paleo-morfologico va riconsiderata, altresì, la cronologia del ponte, la cui arcata superstite è visibile sotto il moderno cavalcavia della Do-mitiana. Esso sembra occupare una posizione troppo avanzata rispetto a quella che doveva essere la linea di costa nell’età imperiale romana,51 quando essendo il canale di foce largo m 400 ca., come le ricerche geologiche hanno dimostrato, lo spazio su cui realizzare la strada per raggiungere il ponte doveva essere occupato dalle acque marine e di foce. Considerata la dinamica geologica del litorale domizio connesso alle variazioni paleo-climatiche, caratterizzata sia dall’accumulo di sedimenti eolici sia dal deposito di livelli alluvionali, si può ipotizzare che la graduale chiusura del canale sia avvenuta progressivamente nei secoli. Un utile termine di riferimento cronologico è rappresentato dalla Torre di Patria la cui costruzione nel XV-XVI secolo52 potrebbe avere determinato o quanto meno favorito il ripristino di un asse di collegamento viario costiero, quale la Domitiana, mediante la realizzazione di un nuovo ponte, posto53 più a sud di quello domizianeo, probabilmente danneggiato e defunzionalizzato a causa di fenomeni quali la subsidenza e l’impaludamento.54
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 312
Vorrei concludere con qualche nota relativa ai problemi connessi alla diffi cile tutela dell’antica Domitiana, quotidianamente minacciata da distruzioni e oblitera-zioni, paradossalmente soprattutto in quel tratto a sud di Liternum perfettamente conservato e semi-affi orante all’interno dei terreni dell’ex Opera Nazionale Com-battenti, che bonifi cò questi territori all’inizio del secolo scorso.55
Il tipico paesaggio agrario che testimoniava i suddetti interventi di bonifi ca, ca-ratterizzato dalle case coloniche di colore rosso con davanti l’aia e la tipica palma (fi g. 1) e, intorno, il podere da coltivare, si è dissolto in un generale e diffuso stato di degrado del territorio.
Oggi le attività agricole sono state soppiantate da quelle estrattive, edilizie o turistico-commerciali, spesso abusive, che pongono seri problemi di tutela e di con-servazione per la Domitiana antica e l’ambiente circostante.
L’antico lastricato in trachite leucitica, conservatosi intatto per chilometri, viene ora occupato da costruzioni abusive, che ne interrompono il tracciato, ora divelto e sfi orato da costruzioni di muri o da fronti di nuovi edifi ci, ora lambito da vaste cave per l’estrazione di sabbia, ora asfaltato e utilizzato per il transito di mezzi pesanti.
Il vincolo ex lege 1089/1939, in vigore ormai da anni, a tutela del tracciato del-l’antica strada e delle adiacenti fasce di rispetto della larghezza di m 20, non vale purtroppo ad impedire abusi e violazioni della legge e conseguenti danni al manu-fatto archeologico.
È forse allora il caso di cominciare a perseguire, accanto a quelle istituzionali, forme di tutela attive, propositive, eminentemente volte a realizzare interventi di valorizzazione e ad offrire nuove e più incisive possibilità di fruizione e di uso del territorio nel rispetto di tutti i valori presenti in esso.
Sulla base di specifi che analisi delle situazioni di fatto, si dovrebbe prevedere un programma di ripristino della continuità del tracciato della Domitiana mediante: restauro e ricostruzione dei tratti mancanti anche mediante la costruzione di ponti in legno per scavalcare i canali di bonifi ca, abbattimento di alcuni manufatti abusivi ricadenti nell’area vincolata, esproprio delle aree adiacenti il tracciato viario, restau-ro ambientale con creazione di un sistema di recinzione e piantumazione lungo il tracciato, sistemazione dei laghetti artifi ciali risultanti dalle attività estrattive. Detti interventi consentirebbero la realizzazione di un itinerario pedonale e/o ciclabile della via Domitiana antica, opportunamente inserito in spazi verdi attrezzati, con aree di sosta e ristoro, punti di divulgazione, aree di accoglienza, da collegare alle già esistenti strutture turistico alberghiere compatibili con la tutela e il decoro del tracciato antico.
Il decreto regionale del luglio 1995, che istituisce ai sensi della legge regionale 33/1993 la Riserva Naturale “Foce Volturno-Costa di Licola”, in difesa delle caratte-ristiche geo-morfologiche, faunistiche, vegetazionali e naturalistico-ambientali della zona va nella direzione adesso indicata.
313La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Nell’area destinata a riserva risulta fi nalmente incluso il percorso dell’antica Do-mitiana, già non compreso nelle aree vincolate ai sensi della ex legge 1497/1939, in quanto costituisce una delle presenze storico-culturali più importanti di questo territorio, sicuramente da salvare e recuperare nell’ambito di un più ampio piano urbanistico-territoriale, da elaborare mediante iniziative congiunte di Enti locali, Regione e Soprintendenze.
Note1 Stat., silv. IV, 3, 97-100; Mart. epig. l, 8, 65. 2 In occasione dell’apertura della nuova Domiziana all’inizio degli anni Cinquanta del secolo scorso, il Maiuri evoca (Maiuri 1954, 568-579), con la prosa dai toni suggestivi che gli è propria, gli stretti confronti tra il vecchio e il nuovo asse stradale non solo in relazione all’accidentato e quasi parallelo percorso, ma soprattutto per le analoghe diffi coltà costruttive che rendono grande e lodevole l’impresa italiana al pari di quella domizianea.3 Stat., silv. IV, 3, 20-26: «costui mal tollerando le lente vie di comunicazione del suo popolo e quei campi che im-pedivano qualsiasi viaggio, sopprime tutti quei lunghi giri e con una nuova gittata di materiale pietroso consolida quelle sabbie che appesantivano il cammino, lieto di rendere più vicine ai sette colli la dimora della Sibilla Euboica, le insenature del Gauro e l’infocata Baia» (trad. a cura di A. Traglia, G. Arico, Torino 1984).4 Cfr. infra e nt. 27. 5 L’ambizioso progetto fu abbandonato, per motivi politici più che tecnici, non senza tuttavia avere provocato distruzioni e sbancamenti, riconoscibili oltre che nella zona fl egrea (cfr. da ultimo Caputo 2006, 127-128 con precedente bibliografi a sull’argomento) anche lungo il litorale domitio, dove almeno fi no a Cuma si ritiene che la Domitiana avesse occupato l’argine interno del canale. Una traccia di esso sembra potersi riconoscere anche a nord di Liternum nella pineta di Castelvolturno, in un’ampia trincea, situata a breve distanza e ad ovest del tracciato domizianeo laddove esso attraversa la strada moderna, leggibile anche dalle foto aeree. 6 Maiuri 1928, 181-185; Maiuri 1938, 69-84; Maiuri 1951, 45-46; Maiuri 1954, 568-579; Maiuri 1981; Cor-rado 1927, 28-42. Particolare interesse rivestono le descrizioni puntuali e inedite dello storico locale e Ispettore Onorario Giacomo Chianese, confl uite in parte nel volumetto dal titolo Liternum (Chianese 1978) dedicatogli dal fi glio Domenico. Sull’intero percorso e sui problemi di carattere generale riguardanti la Domitiana cfr. da ultimo Longobardo 2004, 277-290.7 Qui fu collocato un cippo celebrativo iscritto sormontato da una colonna.8 In questo itinerario cartografi co pictum, redatto in epoca tardo antica sulla base di un precedente modello, il tratto è compreso tra i punti Literno VI e Cuma III del segmento V (Bosio 1983, tav. 40).9 L’iniziativa rientra nelle attività svolte nella zona dal regime fascista, che promosse una nuova bonifi ca di questi territori (Bertarelli 1922), successiva a quella seicentesca diretta da Domenico e Giulio Cesare Fontana, e a quella borbonica (Fiengo 1988, 1-4), e la conseguente ridistribuzione dei terreni. 10 Rilevabile anche dalla cartografi a IGM.11 L’uso della malta negli strati preparatori delle strade è piuttosto raro (cfr. Adam 1990, 301 e nt. 117). 12 Margini e paracarri similmente lavorati si riscontrano in un tratto di strada rimesso in luce recentemente, a nord di Cuma, nella zona della necropoli monumentale (cfr. Brun et al. 2000, fi g. 23).13 Maiuri 1928, 183.14 Mancano indagini in quest’area. Tuttavia, Giacomo Chianese (Chianese 1937), seguendone il percorso, riferi-sce che «la Domitiana ai limiti della tenuta di Varcaturiello è fi ancheggiata a sinistra da un esteso complesso di ruderi non del tutto scoperti e più oltre è, per vari metri, interrotta dalle rovine di una basilichetta cristiana» costruita con materiale di spoglio (cfr. Pagano 1989, 179-188); continua poi affermando che più innanzi, «da scavi eseguiti per lavori agricoli, nel terreno di Varcaturiello, poco prima di raggiungere le rovine dell’anfi teatro sono, infatti, affi orati per il passato a più riprese, non pochi sepolcri del periodo romano. Va fra l’altro ricordato un ipogeo con due sepolture a inumazione incavate nel piano e varie cellette cinerarie lungo le pareti di esso». Il recente recupero da parte del sig. Giuseppe Barleri, che qui si ringrazia, di una epigrafe funeraria, nel podere n. 1 dell’ex Opera Nazionale Combattenti condotto dai sigg. Creuso, con la scritta DEXIAE RUFAE EX TESTAMENTO ARBITRATU C.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 314
CANINI FORTUNATI (inv. 244079), conferma che la Domitiana, prima di raggiungere la città, da sud, era fi ancheggiata da monumenti funerari. Probabilmente da questa zona provengono altre due epigrafi funerarie, già nell’ex villa d’Antona (poi hotel Le Palme), ora al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. 237374-237375; Pagano 1980, 279 segg.). Nel suddetto podere si rinvenne nel 1950 una sepoltura in anfora: A(rchivio) C(orrente) S(oprintendenza) A(rcheologica) di N(apoli) P2/1.15 Chianese 1937.16 Nel novembre del 1940, durante i lavori relativi alla costruzione della Domiziana moderna, all’altezza del-l’allora villa d’Antona, vennero in luce tracce dell’antica Domitiana e blocchi di tufo squadrati non in opera (ACSAN P19). 17 Nel 1982, dallo sbancamento realizzato per la costruzione di una villetta abusiva, a ca. m 200 a nord del foro, l’assistente Nicola Severino della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle provincie di Napoli e Caserta rilevava nelle sezioni esposte, meridionale e orientale, alla profondità di m 1 dal piano di calpestio attuale, la presenza di un piano basolato e, in quella settentrionale, resti di una tomba a tegole. 18 Chianese 1937.19 Il toponimo fa pensare che il manufatto romano era ancora ben riconoscibile nel Medioevo, quando si diffuse l’uso di denominare Ponte del Diavolo anche ponti d’età romana, evocando la leggenda del diavolo architetto che costruisce in una notte sola il ponte, chiedendo ad un santo o a un credente di pagare con un’anima, ma ri-maneva sempre scornato per la sostituzione con un animale, di solito un cane (Galliazzo 1995, nt. 196 e 207).20 Chianese 1937. 21 Degli avanzi di costruzione riferiti al Ponte del Diavolo nulla oggi rimane a causa, evidentemente, dei note-voli interventi di dragaggio, fi no a quattro metri di profondità (Rigillo Troncone, De Rosa 1993, 46-55), e di riarginatura realizzati nel lago per la costruzione dello Stadio del Remo per le gare di canottaggio dell’Olimpiade del 1960, quando una cospicua porzione della riva destra fu asportata, come si rileva anche dalla cartografi a antecedente. Recenti carotaggi, eseguiti in prossimità della pila emergente, cd. Pietra Alta, non hanno altresì rivelato resti riferibili al ponte, pur non potendosi escludere che future e più sistematiche indagini potrebbero consentire di riscontrare ulteriori resti.22 Desidero in proposito ringraziare vivamente la dott.ssa V. Sampaolo, all’epoca Soprintendente, che con libe-ralità mi ha consentito di estendere l’indagine anche nel territorio di sua competenza.23 Ringrazio con l’occasione i colleghi della Soprintendenza, in primo luogo il dott. N. Severino che ha seguito e documentato costantemente la prima campagna di scavi, l’arch. V. Ingravallo per la documentazione grafi ca, le società: Xenia, che ha curato la seconda campagna di scavi e tutti i rilievi topografi ci, e Tecno In, che ha ef-fettuato i carotaggi geo-archeologici.24 Pur essendo un fenomeno generalmente diffuso quello di riutilizzare la pavimentazione in selce delle strade antiche, una prova certa a proposito della Domitiana è fornita da una lettera di Girolamo Vollaro al Sig. Mar-chese Cavalcante, luogotenente della Regia Cancelleria della Sommaria, dalla quale risulta che venivano cavati «vasoli e sassi nel luogo del pantano di Valcaturo sull’antica strada Appia» per conto del «padre Abbate del tipo dei Benedettini residente nel Convento di S. Lorenzo di Aversa»; è evidente che l’autore confonde la Domitiana con la via Appia (Fondo Processi Antichi, pandetta B RCS, busta 32, f. 740, anno 1776).25 Stat., silv. IV, 3, 40: hic primis labor incohare sulcos. 26 Stat., silv. IV, 3, 44: et summo gremium parare dorso. 27 La tecnica adottata, almeno a giudicare da quello che è emerso nei tratti esplorati, sembra paradossalmente non corrispondere alla descrizione di Stazio: non vi sono segni di quel profondo scavo tra i due solchi paralleli di delimitazione di cui parla il poeta (Hic primis labor incohare sulcos et rescindere limites et alto egestu penitus cavare terras) e che di solito si riscontra nella costruzione delle strade antiche, nelle quali la trincea viene riempita con almeno quattro strati di materiali che costituiscono la fondazione della strada (la successione e le caratteristiche di tali strati si desumono tradizionalmente da Vitr. 7,1 e da Plin., Nat. 36, 186). Sulla tecnica stradale romana cfr. Radke 1981, Quilici 1990, Quilici Gigli 1992.28 L’esistenza di esso, già desumibile dalle fonti letterarie (Liv. III, 3; D. C. LXVII, 14.), è apparsa sempre più comprovata da recenti studi e considerazioni di carattere storico, archeologico e topografi co (Ostrow 1977, 38 e nt. 82; Crimaco 1991, 38; Catucci, Jannelli, Sanesi Mastrocinque 2002, 85-92), e da ultimo anche da evidenze dirette rilevate a Cuma. Le due strade in battuto, una che uscendo dalla porta cd. mediana prosegue verso nord (d’Agostino, D’Andrea 2002, 58), l’altra che invece, dopo pochi metri dalla porta, piega verso ovest seguendo un percorso quasi parallelo e incidente con quello della futura Domitiana (Brun et al. 2000, 150-151), pur
315La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
avendo svolto forse primariamente funzione di strade extraurbane al servizio della città, potrebbero essere traccia di due assi stradali che in epoche diverse e prima di Domiziano hanno assicurato i collegamenti costieri. 29 Un termine di riferimento cronologico per l’impaludamento della strada potrebbe ricavarsi dalla sua de-funzionalizzazione: per questa i dati cronologici sono assenti o discordanti. Infatti, se da un lato alcuni edifi ci costruiti al di sopra della strada appaiono privi di elementi datanti, come a Cuma (cfr. Brun et al. 2000, 150) e a Liternum (cfr. infra), dall’altro una basilichetta paleocristiana sorta sull’antico tracciato presso Liternum viene tradizionalmente datata al V sec. d.C. (Chianese 1978, 20) mentre il rinvenimento di una moneta gotica nel selciato della Domitiana a Cuma ne indicherebbe l’utilizzo almeno fi no alla metà del VI sec. d.C. Per le carat-teristiche e le dinamiche connesse al fenomeno dell’impaludamento nell’area domizio-fl egrea cfr. d’Agostino, D’Andrea 2002, 89-105.30 Stat., silv. IV, 3, 54-55: hi siccant bibulas manu lacunas et longe fl uvios agunt minores (questi prosciugano con le mani gli spazi vuoti imbevutisi d’acqua e la spingono lontano in piccoli rivi). 31 Già il Maiuri (Maiuri 1928, 184) ipotizzava un’«altra più ampia massicciata a scarpata per notevole altezza» sulla base dei versi di Stat., silv. IV, 3, 45: ne nutent sola, ne maligna sedes, et pressis dubium cubile saxis. 32 Per una classifi cazione e descrizione di tali tipi di strutture e apprestamenti noti come pontes longi cfr. Gal-liazzo 1995, 170 segg.33 Vitruvio consiglia di solidifi care il terreno per mezzo di palafi tte. Esempi di applicazioni di tale tecnica sono: la via Ostiense nella zona delle saline, costruita su palafi tte di quercia che sostenevano la massicciata con il ba-solato contenuti da due muraglioni in opera quadrata (Quillici Gigli 1992); la via Appia, nel tratto delle paludi Pontine, il cui attraversamento dall’età augustea fu garantito, come si desume dalle fonti (Hor. I, 5, 11; Str. V, C 233) da un canale navigabile poi sostituito da Traiano con un terrapieno, noto come Decennovium, lungo m 19 e alto m 3-4 (Gualandi 1990, 205). 34 A causa della falda non è stato possibile approfondire l’indagine onde verifi care se il sistema di sostruzione avesse previsto, al di sotto della platea, anche l’impiego di pali lignei, come era stato ipotizzato dalla Quilici Gigli 1992 per la Domitiana.35 La larghezza media dei ponti è compresa tra i 16 e i 25 pedes (m 4,74-7,40), su cui cfr. Galliazzo 1995, 498-513, non mancano tuttavia esempi di ponti aventi larghezza maggiore. In questo caso la misura è da ritenersi conseguente alla larghezza della strada, che a circa m 70 a nord del ponte, aumenta notevolmente. 36 È attestato che, soprattutto in caso di strade in rilevato ed extraurbane, la massicciata stradale e il relativo man-to di protezione fossero i medesimi sia sul ponte sia sulla strada che lo valicava. D’altra parte, non c’è motivo per ritenere che la pavimentazione del ponte fosse diversa da quella della strada, considerato che tale tipo di manto stradale caratterizza la maggior parte dei ponti romani, che la Domitiana era un’importante via publica e da ultimo che questo tratto era molto vicino alla città di Liternum. Appare, invece, più diffi cile defi nire la effettiva larghezza della carreggiata (iter) sul ponte, la quale considerata l’ampiezza complessiva dell’estradosso doveva essere fi ancheggiata da marciapiedi e parapetti (Galliazzo 1995, 475-481).37 L’opus mixtum è ampiamente attestato nei Campi Flegrei e in particolare sotto Domiziano quando si diffuse l’uso prevalente dei mattoni, soprattutto nelle parti inferiori dei muri per preservarli dall’umidità (cfr. Lugli 1957, 516 segg.). Considerata la disposizione dei lateres ai lati dell’arco, si può ipotizzare, nonostante non sia stata possibile una verifi ca diretta a causa del livello di falda, che tale caratteristica ricorra anche nel nostro caso, analogamente al ponte viadotto sulla via Puteolis-Neapolim presso le Terme di Agnano (Galliazzo 1995, cat. 234). Sul lato orientale i piedritti delle spalle e della pila centrale presentano, almeno fi n dove si è riusciti a prosciugare, uno spesso strato di intonaco idraulico, riscontrato in questo lato anche sul paramento in reticolato della rampa di raccordo al ponte. 38 Galliazzo 1995, cat. 233-234.39 Sul problema delle fondazioni cfr. Galliazzo 1995, 333-348.40 Rinvenimenti di edifi ci costruiti sulla Domitiana si sono verifi cati sia nel territorio di Cuma (Brun et al. 2000), dove sussistono analoghi problemi di datazione per la mancanza di materiale associato, sia a sud di Liter-num, in località Varcaturiello (cfr. nt. 28).41 Purtroppo il carattere limitato dell’esplorazione, imposto dallo stato dei luoghi e da motivi contingenti, non ha permesso di verifi care le dimensioni dell’impianto e di defi nirne lo sviluppo e le caratteristiche in merito alla tipologia funzionale del complesso. Tuttavia, la distinzione tra statio, mutatio e mansio resta di diffi cile interpretazione per il signifi cato diverso che i termini hanno assunto nel tempo (sulle mansiones cfr. Mezzolani 1992, 103-113); stando all’evidenza, l’impianto, considerate le sue caratteristiche, sembra potersi ascrivere alla
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 316
tipologia delle mutationes. 42Adam 1990, 311-313; Gualandi 1990, 210-212.43 Anche se le strade romane di lunga percorrenza avevano un andamento generalmente rettilineo (Quilici 1990, 20-22), tuttavia, la notevole deviazione è in questo caso spiegabile, probabilmente, per le caratteristiche geo-morfologiche dei luoghi, analogamente a quanto si riscontra a Cuma, dove la stessa Domitiana, uscendo dalla porta nord, piega bruscamente verso ovest, seguendo i margini del lago di Licola, come recenti ricerche hanno dimostrato (Brun et al. 2000). Né d’altra parte la presenza del piccolo ponte poteva costituire un ostacolo, con-siderato che sono attestati vari tipi di allineamento tra ponti e strade (Galliazzo 1995, 298-299). 44 Del rilevato potrebbe non essere rimasta traccia apprezzabile sul terreno a causa delle radicali opere di boni-fi ca realizzate nel secolo scorso, e d’altra parte non è da escludere che ulteriori indagini nel sottosuolo possano suffragare tali ipotesi con nuove evidenze.45 Il Lago Patria, come il lago Fusaro e il lago di Licola, rientra nel sistema dei laghi costieri che hanno origi-ne dalla rapida formazione di barre-cordoni di sabbia lungo tratti di costa non ancora rettifi cati e dalla loro conseguente unione con la terraferma. Questa e tutte le osservazioni di carattere geologico sono desunte dagli elaborati prodotti dalla società Tecno In del 5.10.2004, prot. 24905.46 Nell’ambito del progetto “Kyme” sono state eseguite dal Centre J. Bérard ricerche geo-archeologiche a nord dell’acropoli di Cuma, fi nalizzate alla localizzazione del porto greco della città. Per i risultati preliminari si cfr. Morhange et al. 2002, 153-165. 47 La riduzione del canale potrebbe essere legata a eventi paleoclimatici quali le mutazioni temporanee da periodi di clima caldo arido a periodi caratterizzati da un clima freddo umido. Nel periodo compreso tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C. il clima è evoluto verso un periodo caldo arido con una diminuzione della piovosità che ha causato un minore apporto degli immissari del lago con un conseguente restringimento del canale di foce e la temporanea e/o parziale emersione di aree che prima erano sommerse.48 Gargiulo 2000, 20-24. 49 Liv. XXXIV, 45.50 Mancano dati precisi in merito per difetto di ricerca sul cordone dunare. Un utile indizio in questa sede sembra, tuttavia, offerto dal sondaggio So15 che ha rivelato nei suoi livelli più profondi a m 7,20 e m 10,00, depositi di ambienti emersi di battigia; lo strato, pur se allo stato attuale delle ricerche non è databile, risponde alla dinamica di avanzamento della linea di costa ben riconosciuta lungo il litorale domizio (Cocco et al. 1983, 58, 1-11). D’altra parte, per analogia con il litorale cumano, potrebbe ipotizzarsi una duna più antica, che corre parallela alla sponda occidentale del Lago Patria e un’altra più recente, che avrebbe portato al restringimento del canale di foce (cfr. Bats et al. 2000, 101).51 Sui documenti che attestano la vicenda di questo ponte cfr. Longobardo 2004, 284-285.52 Da fonti antiquarie (Minieri Riccio 1877, 108) si desume che la Torre di Patria già esisteva negli anni 1419-1420, quando si parla di un custode della struttura; e, inoltre, al 1421 viene riferita la costruzione di essa da parte degli Aversani che l’avrebbero poi ricevuta in dono da Ferdinando D’Aragona nel 1467 (Parente 1858 [1986]). Sembra invece meno convincente farne risalire la costruzione al periodo vicereale, in particolare ad un’ordinanza di Don Pedro di Toledo del 1532 a seguito della quale sarebbero state costruite la Torre di Patria e quella di Gaveta (Santoro 1990, 11-15). In realtà questa discordanza cronologica potrebbe essere indicativa di varie fasi edilizie della Torre di Patria, sorta probabilmente su una preesistente struttura difensiva ben più antica delle date storicamente tramandate, secondo quanto viene ipotizzato generalmente per tutto il sistema difensivo costiero che si fa risalire al periodo normanno-svevo e fi no a quello altomedievale (cfr. Annecchino 1960, 193; Russo 1989, 28).53 A questo nuovo ponte è verosimilmente da riferirsi la notizia dei vari restauri avvenuti negli anni 1550, 1575, e quella dei nuovi successivi danneggiamenti registrati nel 1581. Resta il problema dell’epoca della costruzione di questo nuovo passaggio. Mancando elementi probanti in merito, si può azzardare qualche ipotesi solo in base a considerazioni di carattere storico connesse al superamento delle divisioni politiche tra Longobardi e Bizantini, dei cui territori il Lago Patria fungeva da confi ne, e all’avvento di una unica monarchia (Normanno-Sveva e Angioina) nel corso dei secoli XII-XIII.54 Probabilmente al Ponte del Diavolo allude la notizia del capitolare di Sicardo, il quale parla di un ponte che collegava le due sponde, ma che nel l’832 risultava distrutto, sicché il passaggio avveniva mediante una scafa. 55 Cfr. Faggella 1959, 5-10.
Tav. 2 - Fotogrammetria del fornice 10 (gentile concessione della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Pompei, modificata dall’Autore).
Tav. 1 - Ricostruzione al computer dell’antica città di Ercolano (P.P. Petrone, L. Fattore; foto di G. Mastrolorenzo).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 320
Tav. 3 - Cuma (Pozzuoli): parete est della tomba osca, dipinta con scena di banchetto funerario, al momento della scoperta (foto Antonio Morello).
321Tavole colore
Tav. 4 - Cuma (Pozzuoli ): parete nord della tomba osca, dipinta con scena di suonatore di doppio flauto e due danzatrici, in corso di restauro (foto Antonio Mannillo).
Tav. 5 - Cuma (Pozzuoli): parete sud della tomba osca, dipinta con scena di suonatrice di doppio flauto e due danzatori ai lati, in corso di restauro (foto Antonio Mannillo).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 322
Tav. 6 - Sessa Aurunca, teatro romano: veduta da nord della porticus post scaenam.
Tav. 7 - Sessa Aurunca, teatro romano: pianta ricostruttiva della latrina pubblica e della basilica nord.
323Tavole colore
Tav. 8 - Mondragone, località Triglione: strutture lungo la via Appia, tecniche costruttive.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 324
Tav. 10 - Le due fasi della strada.
Tav. 9 - Mondragone, Località Triglione: strutture lungo la via Appia, planimetria. In evidenza gli ambienti esaminati (elaborazione grafica G. Fiorentino, V. Petito).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 326
teatro
foro
terme
castellumaquae
postierla
postierla
postierla
postierlapostierla
pontetora
l e g e n d a
circuito murario
torrente Rio Maltempo
saggi
foro
fabbricati attuali
monumenti
porta
porta
mura rilevate (rilievo topografico)
(rilievo topografico)
(rilievo topografico)
(rilievo topografico - aerofotogrammetria)
(da mappa storica)
(da mappa storica)
(aerofotogrammetria)
6448
0
58130
6511
2
58130
57235
6448
0
57235
6511
2
rilievo topografico-georeferenziazione-elaborazioni digitali P. Cifone
471.67
481.24
446.63
457.42
448.30 441.05
445.20
454.63
477.70
452.33
497.45
438.92
427.55
429.60
428.21
431.09
427.77
429.06
426.56
424.80
419.31
419.36
415.29
438.39
412.98
399.49
416.54 446.35
440.60421.72
394.89
392.73
392.90
395.15
391.14
391.26
394.05391.25
391.62
387.14
387.96
388.13384.68
383.92
396.80
429.22
399.38393.84390.02
389.71380.21
380.98
379.99
381.02378.19
378.42
377.80
377.59387.90
386.27
383.43
386.53
387.41
390.52355.48
390.48
389.08385.92
386.82
389.18
386.47
389.40
451.46
469.82
444.74
458.92
436.61 422.30
433.81428.28
395.45
428.79 449.30
409.08403.16
388.95391.31
394.94
378.02
385.73
399.41
395.71
368.42
369.51
376.70
384.07
387.65
391.77 389.40
388.71 384.02
382.63
383.44
372.36
382.28
358.91
379.56
376.11 374.43362.16
367.07
357.92
369.61
372.56
373.16
359.28355.63369.10
360.57
355.25
358.43363.19
367.09
365.65
366.80
369.34
370.54369.71
361.35 363.02
366.98
365.14368.42
368.24 367.56
376.16
379.87369.77370.01
374.87
370.54
370.52
384.87
392.99
394.18
388.79
373.38377.50
381.15
389.02
373.69
375.71
383.38
391.48
Tav. 12 - Trebula, pianta della città (da Caiazza 1986).
327Tavole colore
Tav. 15 - Teano, area sacra di località Loreto. Pianta delle evidenze archeologiche. In rosso le struttu-re rilevate da W. Johannowsky; in grigio risultati delle indagini geofisiche.
Tav. 13 - Località Loreto, tempio (US 7), testa (Inv. Gen. 306455), (foto L. Spina).
Tav. 14 - Località Loreto, tempio (US 7), testa (Inv. Gen. 306455), vista laterale (foto L. Spina).
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 328
Tav. 16 - Teano, loc. Torricelle, tomba 50: l’interno al momento del rinvenimento (foto SBANC).
329Tavole colore
Tav. 17 - Teano, Fondo Gradavola: tomba 69, lebete a figure rosse (Inv. Gen. 132444).
Tav. 18 - Teano, Fondo Gradavola: tomba 69, lebete a figure rosse (Inv. Gen. 132444).
Tav. 19 - Lipari, Contrada Diana: tomba 1883, lekane a figure rosse.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 330
Tav. 20 - Alife, via Erennio Ponzio, proprietà Amato-Rea: affresco in II stile.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 332
Tav. 22 - Planimetria delle principali reti idriche derivanti dalle sorgenti dell’area Centro: acquedotto romano Formose-Torelle, oggi inattivo; rete idrica derivante dalle sorgenti di via Formose, oggi inattiva; percorso dell’acquedotto medioevale proveniente dalle
sorgenti Aulecine; condotte della località Porta Agricola.
333Tavole colore
Tav. 23 - Carinola, Masseria S. Salvatore: muro di terrazzamento in opera poligonale.
Tav. 24 - Ortofotopiano del Lago Patria con il territorio attraversato dalla Domitiana (foto L.M. Rendina, soc. Xenia).
Bibliografia
Le abbreviazioni delle riviste adottano il sistema in uso nell’Archäologische Bibliographie; per i titoli che non vi compaiono e per i repertori valgono le seguenti abbreviazioni:
AJPhA American Journal of Phisical AnthropologyAnnAssSanAl Annuario dell’Associazione Storica del Sannio AlifanoAnnAssStMedioVolturno Annali dell’Associazione Storica del Medio VolturnoAnnIst Annali dell’Istituto di Corrispondenza ArcheologicaAnnRA Annual Review of AnthropologyArchStProvNap Archivio Storico delle Province Napoletane ArchStSanAl Archivio Storico del Sannio Alifano e contrade limitrofeAtti Terra di Lavoro Atti della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti di
Antichità e Belle Arti nella Provincia di Terra di LavoroBollettino ICR Bollettino dell’Istituto Centrale del RestauroBTGC Bibliografi a Topografi ca della Colonizzazione Greca nell’Italia meridionale
e nelle Isole tirrenicheBullBArt Bulletin de la Classe des Beaux ArtsBullInst Bullettino dell’Istituto di Corrispondenza ArcheologicaBullVolc Bullettin of VolcanologyCIL Corpus Inscriptionum Latinarum
FSI Fonti per la Storia d’Italia, edite dall’Istituto Italiano per il Medio EvoEAA Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale ILS Inscriptiones Latinae SelectaeIntNumNewsletter International Numismatic Newsletter IntJA International Journal of AnthropologyJNeuro Journal of NeurophysiologyNatGeo National GeographicNZZ Neue Zürcher ZeitungRE RealencyklopädieRivStAnt Rivista di Storia Antica e Scienze affi niFScInt Forensic Science International
Adam 1990 - J.P. Adam, L’arte di costruire presso i romani (trad. it.), Milano 19902.Adam 1994 - J.P. Adam, Le temple de Portunus au Forum Boarium, Roma 1994.Adriani 1930 - A. Adriani, Veio - Scavi nella necropoli degli alunni dell’anno 1926-1927 del corso di Topografi a dell’Italia Antica dell’Università di Roma, in NSc 6, 1930, 46-56.Adriatico tra IV e III sec. a.C. 2000 - Adriatico tra IV e III secolo a.C. Vasi alto-adriatici tra Piceno Spina e Adria, Atti del Convegno di studi (Ancona, 20-21 giugno 1997), a cura di M. Landolfi , Roma 2000.Ager Allifanus 2004 - Ager Allifanus. La piana alifana alla luce delle recenti ricerche archeologiche, a cura di F. Miele, F. Sirano, Piedimonte Matese 2004.Ager Campanus 2002 - La storia dell’Ager Campanus. I problemi della limitatio e sua lettura attuale, Atti del Convegno internazionale (Real sito di S. Leucio, 8-9 Luglio 2001), a cura di G. Franciosi, Napoli 2002.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 336
Albore Livadie 1984 - C. Albore Livadie, Calvi Risorta, provincia di Caserta, loc. La Costa, in RScPreist, Notiziario 39, 1-2, 1984, 364-365.Albore Livadie 1990 - C. Albore Livadie, Testimonianze preistoriche nel territorio alifano-matesino, in Il territorio alifano 1990, 7-17.Albore Livadie 1991-1992 - C. Albore Livadie, Pontelatone (Caserta), Frazione Treglia, località Monte Castello. Fornace tardoarcaica, in BA 11-12, 1991-1992, 149-151.Alciati, Fedeli 1983 - G. Alciati, M. Fedeli, Grado di fertilità e perdite dentarie patologiche in antiche donne egiziane, in Quaderni di anatomia pratica 39, 1983, 127-139.Alife romana 1982 - Alife romana, a cura dell’Archeoclub d’Italia - sede di Alife, Alife 1982. Amato, Guataferri, Lupia 2002 - L. Amato, C. Guataferri, A. Lupia, Prospezioni geo-archeologiche nell’area delle fortifi cazioni di Cuma: rifl essioni preliminari, in Cuma. Nuove forme d’intervento per lo studio del sito antico, a cura di B. d’Agostino, A. D’Andrea, Napoli 2002, 89-105.Ambrosini, Michetti 1994 - L. Ambrosini, L.M. Michetti, “Sostegni” a testa femminile in ceramica argentata. Analisi di una produzione falisca a destinazione funeraria, in ArchCl 46, 1994, 109-168.Andreassi, Cocchiaro 1986 - G. Andreassi, A. Cocchiaro, Necropoli d’Egnazia, Fasano 1986.Andreoli 1887 - R. Andreoli, Vocabolario Napoletano-Italiano, Torino 1887.Angel 1975 - J.L. Angel, Paleoecology, paleodemography and health, in Population, ecology and social evolution, ed. S. Polgar, The Hague, Chicago, Aldine 1975, 167-190.Angel et al. 1987 - J.L. Angel, J.O. Kelley, M. Parrington, S. Pinter, Life stresses of the free black community as represented by the First African Baptist Church, Philadelphia, 1823-1841, in AJPhA 74, 1987, 213-229.Annecchino 1960 - R. Annecchino, Storia di Pozzuoli e della zona fl egrea, Pozzuoli 1960.Arslan 1998 - E. Arslan, Il tesoro di monete normanne e francesi di Alife (Campania XII sec. d.C.), in IntNumNewsletter 30, 1998, 29-30. Arslan 2001 - E. Arslan, Longobardi e Carolingi nell’Italia meridionale, in Museo Archeologico Nazionale 2001, 109-111. Arte e artigianato 1996 - I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, a cura di E. Lippolis, Napoli 1996Arthur 1987 - P. Arthur, Produzione ceramica ed agro falerno, in Guadagno 1987, 59-68.Arthur 1991 - P. Arthur, Romans in northern Campania: settlement and land-use around the Massico and the Garigliano Basin (Archaeological Monographs of the British School at Rome, 1), London 1991.Atlante 1981 - Atlante delle forme ceramiche, I. Ceramica fi ne romana nel bacino del Mediterraneo, Suppl. EAA, Roma 1981.Autieri 1993 - C. Autieri, La ceramica medioevale di Palazzo Mazziotti, in BA 22, 1993 (1996), 61-63.Baglione 1986 - M.P. Baglione, Il Tevere e i Falisci, in Il Tevere e le altre vie d’acqua 1986, 124-142.Baglione, De Lucia 1997 - M.P. Baglione, M.A. De Lucia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in Le necropoli arcaiche di Veio. Giornata di studio in memoria di M. Pallottino, a cura di G. Bartoloni, Roma 1997, 145-171.Bailey 1988 - D.M. Bailey, Catalogue of the lamps in the British Museum, II. Roman provincial lamps, London 1988. Bailo Modesti, Cerchiai et al. 2005 - G. Bailo Modesti, L. Cerchiai, V. Amato, M. Mancasi, D. Nigro, A. Rossi, M. Viscione, A. Lupia, I santuari di Pontecagnano: paesaggio, azioni rituali e offerte, in Spazio del rito 2005, 193-214.Baldacci 1991 - O. Baldacci, I termini della regione in età storica in Storia e civiltà della Campania 1991, 13-24.Balty 1985 - J.C. Balty, L’espace dans la peinture funéraire étrusque, in BullBArt 67, 1985, 165-168.Barberis 2004 - V. Barberis, Rappresentazioni di divinità e di devoti dall’area sacra urbana di Metaponto. La coroplastica votiva dalla fi ne del VII all’inizio del IV secolo a.C., Firenze 2004.Barra Bagnasco 1996 - M. Barra Bagnasco, Locri Epizefi ri, in Arte e artigianato 1996, 217-228.Barresi, Valastro 2000 - S. Barresi, S. Valastro, Vasi attici fi gurati, vasi sicelioti, Catania 2000.Bartoloni 1972 - G. Bartoloni, Le tombe da Poggio Buco al Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972.Bartoloni 1992 - G. Bartoloni, Le terrecotte votive, in Pyrgi 1992, 65-68.Bats et al. 2000 - M. Bats, M. Morhange, M. Pasqualinì, P. Poupet, Cuma: Il progetto Kyme. Gli scavi del Centre Jean Bérard. Lavori di ricerca del porto di Cuma, in Nova antiqua phlegraea. Nuovi tesori archeologici dai Campi Flegrea, a cura di C. Gialanella, Napoli 2000, 101-102.Baxter 1990 - P.J. Baxter, Medical effects of volcanic eruptions. I. Main causes of death and injury, in BullVolc 52, 1990, 532-544.Beazley 1943 - J.D. Beazley, Groups of Campanian red-fi gure, in JHS 63, 1943, 66-111.
337La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Beazley 1963 - J.D. Beazley, Attic red-fi gure vase-painters, 2° ed., Oxford 1963.Bellelli 2002 - V. Bellelli, Artigianato del bronzo e contesti produttivi. Bilancio etrusco campano, in Orizzonti 3, 2002, 29-52.Beloch 1880 - K.J. Beloch, Der Italische Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig 1880. Beloch 1926 - K.J. Beloch, Römische Geschichte, Berlin-Leipzig 1926. Beloch 1989 - K.J. Beloch, Campania, Napoli 1989.Benassai 2001 - R. Benassai, La pittura dei Campani e dei Sanniti, (Atlante tematico di topografi a antica. Supplementi, 9) Roma 2001.Benassai 2003 - R. Benassai, Architetture dipinte, in Atti del Convegno sulla pittura, S.M. Capua Vetere 2003, c.d.s.Bernabò Brea, Cavalier 1965 - L. Bernabò Brea, M. Cavalier, Meligunìs Lipara II, La necropoli greca e romana nella contrada Diana, Palermo 1965.Bernabò Brea, Cavalier 1986 - L. Bernabò Brea, M. Cavalier, La ceramica policroma liparese di età ellenistica, Milano 1986.Bernabò Brea, Cavalier 1991 - L. Bernabò Brea, M. Cavalier, Meligunìs Lipara V, Scavi nella necropoli greca di Lipari, Roma 1991.Bertarelli 1922 - L.V. Bertarelli, Terra promessa. Le bonifi che di Coltano, Sanluri, Licola e Varcaturo dell’Opera Nazionale per i Combattenti, Milano, 1922. Berti, Desantis 2000 - F. Berti, P. Desantis, I crateri alto-adriatici di Spina, in Adriatico tra IV e III sec. a.C. 2000, 97-104.Bini, Caramella, Buccioli 1995 - M.P. Bini, G. Caramella, S. Buccioli, I bronzi etruschi e romani, Roma 1995.Bisel 1991 - S.C. Bisel, The human skeletons of Herculaneum, in IntJA 6,1, 1991, 1-20.Blake 1947 - M.E. Blake, Ancient roman construction in Italy from the prehistoric period to Augustus, Washington 1947. Boehlau 1900 - J. Boehlau, Die Grabfunde von Pitigliano im Berliner Museum, in JdI 15, 1900, 155-195. Bohnert et al. 1997 - M. Bohnert et alii, Fractures of the base of the skull in charred bodies: post-mortem heat injuries or signs of mechanical traumatisation?, in FScInt 87, 1997.1, 55-62.Bohnert et al. 1998 - M. Bohnert et alii, The degree of destruction of human bodies in relation to the duration of the fi re, in FScInt 95, 1998.1, 11-21.Bonanni 1914 - I. Bonanni, L’antica rete stradale nella regione dell’alta valle del Volturno, Agnone 1914.Bonfante 1997 - L. Bonfante, Nursing mothers in classical art, in Naked truths. Women, sexuality, and gender in classical art and archaeology, ed. A.O. Loloski-Ostrow, Cl.L. Lyons, London 1997, 174-196.Borghi Jovino 1965 - M. Bonghi Jovino, Terrecotte votive. Catalogo del Museo Provinciale Campano. I. Teste isolate e mezzeteste, Firenze 1965.Bonghi Jovino 1971 - M. Bonghi Jovino, Terracotte votive. Catalogo del Museo Provinciale Campano, II. Le statue, Firenze 1971.Bonifay 1998 - M. Bonifay, Sur quelques problèmes de datation des sigillées africaines à Marseille, in Ceramica in Italia 1998, 71-83.Borriello, De Simone 1985 - M.R. Borriello, A. De Simone, La stipe di S. Aniello, in Napoli antica 1985, 159-170.Bosio 1983 - L. Bosio, La Tabula Peutingeriana, Rimini 1983.Bouma 1996 - J.W. Bouma, Religio votive: the archaeology of Latial votive religion. The 5th- 3rd c. B.C. votive deposit south west of the main Temple at “Satricum”, Borgo Le Ferriere. III. Corpus of Latial cult places, Gröningen 1996.Bouma 1996 a - J.W. Bouma, Religio votive: the archaeology of Latial votive religion. The 5th- 3rd c. B.C. votive deposit south west of the main Temple at “Satricum”, Borgo Le Ferriere. I, Gröningen 1996.Bracco 1978 - V. Bracco, Volcei (Forma Italiae, regio III, vol. II), Roma 1978.Brands 1988 - G. Brands, Republikanische Stadttore in Italien, (British archaeological reports. International Series, 458), Oxford 1988. Broccoli 1821 - M. Broccoli, Teano Sidicino antico e moderno, Napoli 1821.Brothwell, Higgs 1969 - D.R. Brothwell, E. Higgs, Scientifi c studies in archaeology, in Science in archaeology. A survey of progress and research, ed. D.R. Brothwell, E. Higgs, Bristol 1969, 23-24.Brown et al.1993 - F.E. Brown, E. Hill Richardson, L. Richardson Jr, Cosa III. The buildings of the Forum (MemAmAc, 37), Roma 1993.Brun et al. 2000 - J.P. Brun et alii, Alla ricerca del porto di Cuma. Relazione preliminare sugli scavi del Centre Jean Bérard, in AnnOrNap n.s. 7, 2000, 131-155.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 338
Brunt 1971 - P.A. Brunt, Italian manpower, 225 B.C. - A.D. 14, Oxford 1971. Buonamici 2003 - M. Buonamici, Volterra. L’acropoli e il suo santuario. Scavi 1987 - 1995, Pisa 2003.Caiazza 1986 - D. Caiazza, Archeologia e storia antica del Mandamento di Pietramelara e del Montemaggiore, I, Preistoria ed età sannitica, Pietramelara 1986. Caiazza 1990 - D. Caiazza, Il territorio alifano in età sannitica, in Il territorio alifano 1990, 19-70. Caiazza 1991 - D. Caiazza, Ager Rufranus: centri fortifi cati preromani del Monte Cesima, in Insediamenti fortifi cati in area centro-italica, Atti del Convegno di studi, Università degli Studi di Chieti (11 aprile 1991), Chieti 1995, 85-113.Caiazza 1995 - D. Caiazza, Archeologia e storia antica del Mandamento di Pietramelara e del Montemaggiore, II, L’età romana, Pietramelara, 1995.Caiazza 1997 a - D. Caiazza, Il territorio tra Matese e Volturno. Note di topografi a storica, in Il territorio tra Matese e Volturno 1997, 18-49.Caiazza 1997 b - D. Caiazza, Il Ponte Latrone, in Il territorio tra Matese e Volturno 1997, 67-104.Caiazza 2001 a - D. Caiazza, Ager Alifanus. Fortifi cazioni preromane e medievali di S. Angelo d’Alife. Note preliminari, in S. Angelo di Ravecanina 2001, 5-82.Caiazza 2001 b - D. Caiazza, Oppidum Sancti Angeli cognomento Rabicanum. Dalla grotta sacra alla fortezza, storia ed etimo di un toponimo, in S. Angelo di Ravecanina 2001, 83-94.Caiazza 2002 a - D. Caiazza, Le torri di Alife. Un castello normanno, in In fi nibus Alifanis 2002, 81-145. Caiazza 2002 b - D. Caiazza, Modifi cazioni geoambientali nella piana del Volturno dal I sec. a.C. La crescita dei suoli ad Allifae, Casilinum ed Urbana, in I torrenti assassini 2002, 17-32.Caiazza 2002 c - D. Caiazza, I diluvi del versante meridionale del Matese, in I torrenti assassini 2002, 33-53.Caiazza 2005 - D: Caiazza, Mefi tis Regina Pia Iovia Ceria. Primi appunti su iconografi a natura competenze divinità omologhe e continuità cultuale della Domina italica, in Italica ars. Studi in onore di Giovanni Colonna per il Premio I Sanniti, a cura di D. Caiazza, Piedimonte Matese 2005, 129-217.Caiazza 2006 - D. Caiazza, I Caudini. Contributo preliminare per la topografi a antica del Sannio Caudino, in Samnitice Loqui. Studi in onore di Aldo L. Prosdocimi per il Premio I Sanniti, a cura di D. Caiazza, Piedimonte Matese 2006, 313-380.Caiazza et al. 1998 - D. Caiazza, F. Ortolani, G. Guadagno, S. Pagliuca, Variazioni climatico-ambientali e rifl essi socio-economici nell’alta Terra di Lavoro tra antichità ed età di mezzo, in Le scienze della terra ed archeometria, Atti del Suor Orsola Benincasa, Napoli 1998, 66-74.Caiazza, Passaro 1996 - D. Caiazza, C. Passaro, Allignano (Caserta). Località Cacciapulli. Bronzetto di Ercole e lamina bronzea con menzione di due edili e di un bosco sacro dal territorio di Cubulteria, in BA 37-38, 1996, 32-35.Caiola et al. 1986 - A.F. Caiola, A.M. Marra, G. Messineo, A.R. Staffa, Via Tiburtina, Settecamini, in BCom 91.2, 1986, 678-690.Camodeca 1990 - G. Camodeca, Problemi di storia sociale in Alife romana, in Il territorio alifano 1990, 123-143. Cantilena 1980 - R. Cantilena, Problemi di emissione e circolazione monetale, in Sannio. Pentri e Frentani dal VI al I sec. a.C., Atti del Convegno (Campobasso, 10-11 Novembre 1980), Matrice 1984, 65-98.Capini 1999 - S: Capini, Molise. Repertorio delle iscrizioni latine. Venafrum VII, Campobasso 1999.Capini 2003 - S. Capini, Il santuario di Ercole a Campochiaro, in Santuari e luoghi di culto 2003, 233-250.Caputo 1959 - G. Caputo, Il teatro di Sabratha e l’architettura teatrale africana, (Monografi e di archeologia libica, 6) Roma 1959.Caputo 1987 - G. Caputo, Il teatro augusteo di Leptis Magna - Scavo e Restauro (1937-1951), (Monografi e di archeologia libica, 3) Roma 1987.Caputo 2006 - P. Caputo, Ricerche sul suburbio meridionale di Cuma, in La forma della città 2006, 107-134Carandini 1988 - A. Carandini, Schiavi in Italia, Urbino 1988.Carandini 1989 - A. Carandini, La villa romana e la piantagione schiavistica, in Storia di Roma, IV, Caratteri e morfologie, a cura di E. Gabba, A. Schiavone, Torino 1989, 104-192.Cardosa 2002 - M. Cardosa, Il dono di armi nei santuari delle divinità femminili in Magna Grecia, in Le Arti di Efesto. Capolavori in metallo dalla Magna Grecia, Catalogo della mostra (Trieste, 8 marzo-28 luglio), a cura di A. Giumlia-Mair, M. Rubinich, Trieste 2002, 99-103.Carignani et al. 1986 - A. Carignani, A. Ciotola, F. Pacetti, C. Panella, Roma. Il contesto del tempio della Magna Mater sul Palatino, in Società romana e impero tardoantico, III, a cura di A. Giardina, Bari 1986, 27-43.
339La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Carroccia 1989 - M. Carroccia, Strade ed insediamenti del Sannio in epoca romana nel segmento V della Tabula Peuntingeriana, Campobasso 1989.Caruso 1993 - I. Caruso, in Scavi e scoperte, in StEtr 58, 1993, 563-566.Cascella 2002 - S. Cascella, Il teatro romano di Sessa Aurunca, Marina di Minturno 2002.Cascella 2006 - S. Cascella, Il teatro romano e la topografi a di Sessa Aurunca, in La forma della città 2006, 79-105.Cassimatis et al. 1991 - H. Cassimatis, R. Etiènne, M.-Th. Le Dinahet, Les autels. Problèmes de classifi cation et d’enregistrement des donées, in L’éspace sacrifi ciel dans les civilisations méditerranéennes de l’antiquité, Acte du Colloque (Lyon 4-7 juin 1988), éd. R. Etiènne, M.-Th. Le Dinahet, Paris 1991, 267-276.Càssola 1991 - F. Càssola, La conquista romana. La regione fi no al V secolo d.C., in Storia e civiltà della Campania 1991, 103-150.Castagnoli 1956 a - F. Castagnoli, Ippodamo di Mileto e l’urbanistica a pianta ortogonale, Roma 1956. Castagnoli 1956 b - F. Castagnoli, Tracce di centuriazioni nei territori di Nocera, Pompei, Nola, Alife, Aquino, Spello, in RendLinc s. 8, 11, 1956, 374-378. Castagnoli 1958 - F. Castagnoli, Le ricerche sui resti della centuriazione, Roma 1958. Cateni 1993 - G. Cateni, Il teatro romano di Volterra, Firenze 1993.Catucci, Jannelli, Sanesi Mastrocinque 2002 - M. Catucci, L. Jannelli, L. Sanesi Mastrocinque, Il deposito votivo dall’Acropoli di Cuma (Corpus delle stipi votive in Italia, 16), Roma 2002, 85-92.Cavalier 1976 - M. Cavalier, Nouveaux documents sur l’art du Peintre de Lipari, Naples 1976.Cazzella 1973 - A. Cazzella, Proposte per una ricerca topografi ca sull’eneolitico nell’Italia tirrenica a sud del Tevere, in DialA 8, 1973, 192-212. Ceramica degli Etruschi 1987 - La ceramica degli Etruschi. La pittura vascolare, a cura di M. Martelli, Novara 1987.Ceramica in Italia 1998 - Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di John W. Hayes (Roma, 11-13 maggio 1995), a cura di L. Saguì, Firenze 1998.Ceramica romana 1994 - Ceramica romana. Guida allo studio, 1. Il catalogo. L’argilla. Ceramica a vernice nera. Ceramica a vernice rossa di periodo repubblicano. Terra sigillata italica e nord italica. Terra sigillata sud gallica e centro gallica. Terra sigillata ispanica, Roma 1994.Ceramica romana e archeometria 1994 - Ceramica romana e archeometria: lo stato degli studi, Atti delle Giornate internazionali di studio (Castello di Montegufoni - FI, 26-27 aprile 1993), a cura di G. Olcese, Firenze 1994.Cerchai 1995 - L. Cerchiai, I Campani, Milano 1995.Cerulli Irelli 1965 - G. Cerulli Irelli, Alife. Tombe sannitiche in località Croce S. Maria, in NSc, 1965, 274-287. Chianese 1937 - G. Chianese, Scipione l’Africano. Memorie di ricognizioni e scavi, Villaricca 1937 (diario inedito).Chianese 1978 - D. Chianese, Liternum, Napoli 1978.Chiesa 1995 - F. Chiesa, Aspetti dell’orientalizzante recente in Campania. La tomba 1 di Cales, Milano 1995.Chiosi 1991-1992 a - E. Chiosi, Saggio 4, in BA 11-12, 1991-1992, 147.Chiosi 1991-1992 b - E. Chiosi, Le fornaci di età ellenistica, in BA 11-12, 1991-1992, 119-121. Chiosi 1993 - E. Chiosi, I santuari ellenistici, in Prospettive di memoria 1993, 000-000.Chouquer et al. 1987 - G. Chouquer, M. Clavel-Lévêque, F. Favory, Structures agraires en Italie centro-meridionale. Cadastres et paysages ruraux, Rome 1987.Chouquer et al.1985 - G. Chouquer, M. Clavel-Lévêque, F. Favory, Catasti romani e sistemazione dei paesaggi rurali antichi, in Misurare la terra 1985, 39-49. Chouquer, Favory 1983 - G. Chouquer, F. Favory, Cadastrations antiques de Campanie, du Latium méridional et de Romagne, in Cadastres et espace rural. Approches et réalités antiques, Actes de la Table ronde (Besançon, mai 1980), éd. M. Clavel-Lévèque, Paris 1983, 318-321. Chouquer, Favory 1987 - G. Chouquer, F. Favory, Description des cadastres antiques de l’aire latio-campanienne, in Chouquer et al.1987, 00-00.Chronicon Vulturnense - Il “Chronicon Vulturnense” del monaco Giovanni, a cura di V. Federici, 1925-1938, in FSI 58-60, Roma 1925. Ciaccia, Passaro 1993 - G. Ciaccia, C. Passaro, Caiazzo (Caserta), Via Umberto I. Caiatia, Scavo a Palazzo Mazziotti, in BA 22, 1993 (1996), 58-61.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 340
Ciaccia, Passaro 1996 - G. Ciaccia, C. Passaro, Calvi Risorta (Caserta). Località Il Migliaro, Cales: la necropoli dall’orientalizzante recente all’età sannitica, in BA 37-38, 1996, 36-41.Ciaccia, Passaro 2000 - G. Ciaccia, C. Passaro, Cales: la necropoli dall’orientalizzante recente all’età ellenistica, in Studi nell’Italia dei Sanniti, Milano 2000, 20-25.Ciaccia, Passaro 2001 - G. Ciaccia, C. Passaro, La fanciulla di Cales, in I Sanniti. Museo Archeologico Antica Capua, a cura di S. De Caro, V. Sampaolo, S.M. Capua Vetere 2001, schede I-II.Ciaghi 1993 - S. Ciaghi, Le terrecotte fi gurate da Cales del Museo Nazionale di Napoli. Sacro. Stile. Committenza, Roma 1993.Ciarlanti 1664 [1992] - G.V. Ciarlanti, Memorie historiche del Sannio, chiamato hoggi principato Ultra, Isernia 1644 (Campobasso 1832), rist. anast., Alife 1992. Cielo 1984 - L.R. Cielo, La cattedrale di Alife, Piedimonte Matese 1984. Cielo 1990 - L.R. Cielo, S. Maria in Cingla. Un’abbazia di prestigio in età longobardo-normanna, in Il territorio alifano 1990, 185-199.Cielo 2000 - L.R. Cielo, Fondazioni monastiche e incastellamento nel Matese Campano tra Longobardi e Normanni, in Monastero e castello nella costruzione del paesaggio, Atti del I Seminario di geografi a storica (Cassino, 27-29 ottobre 1994), a cura di G. Arena, A. Riggio, P. Visocchi, Perugia 2000, 127-143.Cielo 2001 - L.R. Cielo, Il castello di S. Angelo nella realtà insediativa strategica della terra alifana, in S. Angelo di Ravecanina 2001, 95-110.Cielo 2002 a - L.R. Cielo, L’incastellamento nel Matese Campano. L’area Alifana, in In fi nibus Alifanis 2002, 41-64.Cielo 2002 b - L.R. Cielo, Il castello di Alife. La documentazione in età medievale, in In fi nibus Alifanis 2002, 65-79.Cifarelli 2003 - F.M. Cifarelli, Il tempio di Giunone Regina sull’acropoli di Segni. Storia, topografi a, decorazione architettonica, Roma 2003.Cipriani 1996 - M. Cipriani, Poseidonia tra VI e IV secolo a.C., in Arte e artigianato 1996, 207-214. Cipriano 1982 - C. Cipriano, Teano, Teano 1982.Cipriano 1997 - C. Cipriano, Teano antica, Teano 1997.Civiltà degli Etruschi 1985 - Civiltà degli Etruschi, Catalogo della mostra (Firenze, 16 maggio- 20 ottobre), a cura di M. Cristofani, Milano 1985.Civiltà dei Romani 1990 - Civiltà dei Romani. La città, il territorio, l’impero, a cura di S. Settis, Milano 1990Coarelli 1976 - F. Coarelli, Architettura e arti fi gurative a Roma: 150-50 a.C., in Hellenismus in Mittelitalien 1976, 21-51.Coarelli 1996 - F. Coarelli, Il complesso pompeiano del Campo Marzio e la sua decorazione scultorea, in Id., Revixit Ars. Arte e ideologia a Roma. Dai modelli ellenistici alla tradizione repubblicana, Roma 1996, 360-381.Coarelli 1999 - F. Coarelli, s.v. Spes, aedes, in Lexicon Topographicum Urbis Romae, IV, a cura di E.M. Steinby, Roma 1999, 336-337.Cocco et al. 1983 - E. Cocco, G. Castaldo, M.A. Demagistris, T. De Pippo, G. D’Iorio, Dinamica ed evoluzione del litorale Campano Laziale: Settore a sud del fi ume Volturno, Atti del IV Congresso dell’Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia (Chiavari, 1-3 dicembre 1980), Genova 1983, 00-00Cohen, Armelagos 1984 - M.N. Cohen, G.J. Armelagos, Paleopathology at the origins of agriculture, New York 1984.Colini 1914 - G.A. Colini, Vetralla - Necropoli di Poggio Montano, in NSc 1914, 297-362.Colletta 1996 - T. Colletta, Le cinte murarie di Sessa Aurunca e la storia della città: il largo S. Giovanni tra le fortifi cazioni medievali e quelle tardo-quattrocentesche, in Le cinte murarie urbane della Campania: Teano, Sessa Aurunca, Capua, a cura di T. Colletta, Ercolano 1996, 000-000Colonna 1973 a - G. Colonna, in Scavi e scoperte, in StEtr 41, 1973, 548.Colonna 1973 b - G. Colonna, Ricerche sull’Etruria interna volsiniese, in StEtr 41, 1973, 45-72.Colonna 1984 - G. Colonna, I templi del Lazio fi no al V secolo compreso, in Archeologia Laziale 6, Sesto incontro di studio del Comitato per l’archeologia laziale, (QuadAEI, 8), Roma 1984, 396-411.Colonna 1986 - G. Colonna, Il Tevere e gli Etruschi, in Il Tevere e le altre vie d’acqua 1986, 90-97.
341La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Colonna 1986 a - G. Colonna, Urbanistica e architettura, in M. Pallottino et alii, Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, Milano 1986, 371-530.Colonna1987 - G. Colonna, Il maestro dell’Ercole e della Minerva. Nuova luce sull’attività dell’offi cina veiente, in OpRom 16, 1987, 7-41.Colonna 1991 - G. Colonna, Le civiltà anelleniche, in Storia e civiltà della Campania 1991, 25-67.Colonna 1992 - G. Colonna, Gli Etruschi, in La Campania fra il VI e il III sec. a.C., Atti del XIV Convegno di studi etruschi e italici, (Benevento 1981), Galatina 1992, 65-72.Colonna 1992 a - G. Colonna, Altari e sacelli. L’area sacra di Pyrgi dopo otto anni di ricerche, in RendPontAc 64, 1991-1992, 63-115.Colonna 1997 - G. Colonna, Un Ercole sabellico dal Vallo di Adriano, in ArchCl 49, 1997, 65-100.Colonna 2000 - G. Colonna, Il santuario di Pyrgi dalle origini mitistoriche agli altorilievi frontonali dei Sette e di Leukotea, in ScAnt 10, 2000, 251-336.Colonna 2000 a - G. Colonna, La scultura, in Gli Etruschi 2000, 365-391.Colonna 2001 - G. Colonna, Portonaccio, in Veio, Cerveteri, Vulci 2001, 37-44.Colonna 2002 - G. Colonna, Le vicende e l’interpretazione dello scavo, in Il santuario di Portonaccio 2002, 133-159.Comella 1981 - A. Comella, Tipologia e diffusione dei complessi votivi in Italia in epoca medio- e tardo-repubblicana. Contributo alla storia dell’artigianato antico, in MEFRA 93, 1981.2, 717-798.Comella 1986 - A. Comella, I materiali votivi di Falerii, Roma 1986.Comella, Stefani 1990 - A Comella, G. Stefani, Materiali votivi del santuario di Campetti a Veio. Scavi 1947 e 1969, Roma 1990.Compatangelo 1991 - R. Compatangelo, Catasti e strutture agrarie regionali del Sannio, in La romanisation du Samnium 1991, 139-147.Conta Haller 1978 - G. Conta Haller, Ricerche sui centri fortifi cati in opera poligonale in area campano sannita (Valle del Volturno - territorio tra Liri e Volturno), (Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti di Napoli. Monumenti, 3), Napoli 1978.Coppa 1991 - A. Coppa, Lo studio della dieta e degli stress nutrizionali nelle antiche popolazioni, in Ecologia e alimentazione, Atti del terzo Convegno Nazionale S.I.E.U., Firenze 1991, 159-188.Corrado 1927 - G. Corrado, Le vie romane da Sinuessa e Capua a Literno, Cuma, Pozzuoli, Atella e Napoli, Aversa 1927.Cotton 1979 - M.A. Cotton, The late repubblican villa at Posto, London 1979.Cotton, Metraux 1985 - M.A. Cotton, G.P.R. Metraux, The San Rocco villa at Francolise, London 1985.Cotugno 1824 - G: Cotugno, Storia di Venafro, Venafro 1824.Cozza 1894 - A. Cozza, Scavi di antichità nel territorio falisco, in MonAnt 4, 1894.Cozza 1975 - L. Cozza, Le tredici are. Struttura e architettura, in Lavinium II. Le tredici are, a cura di F. Castagnoli et alii, Roma 1975, 89-174.Cozza, Pasqui 1887 - A. Cozza, A. Pasqui, Civita Castellana - Scavi nella necropoli falisca in contrada “La Penna”, in NSc 3, 2, 1887, 170-176.Crimaco 1991 - L. Crimaco, Volturnum, Roma 1991.Crimaco 1991-1992 a - L. Crimaco, Scavi in proprietà Amato - Rea, in BA 11-12, 1991-1992, 136-137.Crimaco 1991-1992 b - L. Crimaco, Allignano (Caserta). Località S. Ferdinando. Indagine archeologica nell’area dell’antica Compulteria, in BA 11-12, 1991-1992, 144-146.Crimaco 1993 - L. Crimaco, Il territorio di Sinuessa tra storia e archeologia, in Prospettive di memoria 1993, 29-58.Crimaco 2002 - L. Crimaco, Dal vicus al castello. Genesi ed evoluzione del paesaggio agrario tra antichità e Medioevo. Il caso della Campania settentrionale, in Culture del passato. La Campania settentrionale tra antichità e Medioevo, a cura di L. Crimaco, F. Sogliani, Napoli 2002, 00-00.Crimaco, Proietti 1993 - L. Crimaco, L.M. Proietti, I risultati degli scavi, in BA 22, 1993 (1996), 51-54.Cristofani 1992 - M. Cristofani, L’Atena di Roccaspromonte, in Prospettiva 66, 1992, 2-9.Cristofani 2000 - M. Cristofani †, I culti di Caere, in ScAnt 10, 2000, 395-425.Crogiez 1990 - S. Crogiez, Le stationes du cursus pubblicus en Calabre: un état de la recherche, in MEFRA 102, 1990, 389-431.Croissant 1983 - F. Croissant, Les protomés féminines archaïques. Recherches sur les représentations du visage dans la plastique grecque de 550 à 500 av. J. C., Paris 1983.d’Agostino 1974 - B. d’Agostino, La civiltà del Ferro nell’Italia meridionale e nella Sicilia, in Popoli e civiltà dell’Italia antica, 2, Roma 1974, 11-91.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 342
d’Agostino 1994 - B. d’Agostino, La Campania e gli Etruschi, in Magna Grecia, Etruschi e Fenici 1994, 431-448.d’Agostino, D’Andrea 2002 - B. d’Agostino, A. D’Andrea, Prospezioni geoarcheologiche nell’area delle fortifi cazioni di Cuma, in Cuma nuove forme d’intervento per lo studio del sito antico, Atti della Giornata di studio (Napoli, 12 febbraio 2001) Napoli 2002, 89-105.D’Alessandro, Capasso, Bartoli 2000 - A. D’Alessandro, S. Capasso, F. Bartoli, Indagini sulla paleodieta in due necropoli abruzzesi dell’Età del Ferro: Alfedena e Bazzano (AQ), in Rivista di Antropologia 78, 2000, 151-158.d’Ambrosio, Borriello 2001 - A. d’Ambrosio, M. Borriello, Arule e bruciaprofumi fi ttili da Pompei, Napoli 2001.D’Ercole 1990 - M.C. D’Ercole, La stipe del Belvedere a Lucera, Roma 1990.De Angelis d’Ossat 1973 - G. De Angelis d’Ossat, I criptoportici quali elementi basamentali nella tipologia compositiva dell’architettura romana, in Les cryptoportiques 1973, 45-49. De Benedittis 1995 - G. De Benedittis, San Vincenzo al Volturno. Dal Chronicon alla storia, Isernia 1995.De Caro 1986 - S. De Caro, Saggi nell’area del tempio di Apollo a Pompei. Scavi stratigrafi ci di A. Maiuri nel 1931-32 e 1942-43 (AnnOrNap. ArchStAnt. Quadrni, 3), Napoli 1986 FRANCESCODe Caro 1991 - S. De Caro, Arte e artigianato artistico nell’Italia antica, in Storia e civiltà della Campania 1991, 293-410.De Caro 1992 - S. De Caro, Appunti sull’Atena della Punta della Campanella, in Il santuario di Punta della Campanella, Atti della Giornata di studio, (Napoli 1991) AnnOrNap 15, 1992, 173-178.De Caro 1993 - S. De Caro, L’attività archeologica della Soprintendenza di Napoli e Caserta nel 1992, in Sibari e la Sibaritide, Atti del XXXII Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 7-12 ottobre 1992), Napoli-Taranto 1993, 669-693.De Caro 1994 - S. De Caro, L’attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta nel 1993, in Magna Grecia, Etruschi e Fenici 1994, 648-670. De Caro 1996 - S. De Caro, Attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta nel 1995, in Eredità della Magna Grecia, Atti del XXXV Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 6-10 ottobre 1995), Napoli-Taranto 1996, 569-599.De Caro 1997 a - S. De Caro, L’attività archeologica della Soprintendenza di Napoli e Caserta nel 1994, in Corinto e l’Occidente, Atti del XXXIV Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 7-11 ottobre 1994), Napoli-Taranto 1997, 669-703. De Caro 1997 b - S. De Caro Attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta nel 1996, in Mito e storia in Magna Grecia, Atti del XXXVI Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto 4-7 ottobre 1996), Napoli-Taranto 1997, 403-433.De Caro 1999 a - S. De Caro, L’attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta nel 1997, in Confi ni e frontiera nella Grecità d’Occidente, Atti del XXXVII Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 3-6 ottobre 1997), Napoli-Taranto 1999, 793-843.De Caro 1999 b - S. De Caro, L’attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta nel 1998, in L’Italia meridionale 1999, 635-661.De Caro 1999 c - S. De Caro, Dati recenti sul tardo antico nella Campania settentrionale, in L’Italia meridionale 1999, 223-242.De Caro 2000 - S. De Caro, L’attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta nel 1999, in Magna Grecia e Mediterraneo, Atti del XXXIX Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 1-5 ottobre 1999), Napoli-Taranto 2000, 618-641. De Caro 2001 - S. De Caro, L’attività archeologica della Soprintendenza di Napoli e Caserta nel 2000, in Problemi della chora coloniale dall’Occidente al Mar Nero, Atti del XL Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 29 settembre-3 ottobre 2000), Napoli-Taranto 2001, 866-904.De Caro 2002 a - S. De Caro, L’attività archeologica della Soprintendenza di Napoli e Caserta nel 2001, in Taranto e il Mediterraneo, Atti del XLI Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 12-16 ottobre 2001), Napoli-Taranto 2002, 635-675. De Caro 2002 b - S. De Caro, Pontelatone, località Treglia (Caserta), Iscrizione osca dall’abitato di Trebula Balliniensis, in StEtr 65-68, 2002, 495-497.De Caro 2003 - S. De Caro, L’attività archeologica della Soprintendenza di Napoli e Caserta nel 2002, in Ambiente e paesaggio, Atti del XLII Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 5-8 ottobre 2002), Napoli-Taranto 2003, 569-622.
343La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
De Caro, Greco 1981 - S. De Caro, A. Greco, Campania (Guida archeologica Laterza, 10), Roma-Bari 1981.De Caro, Miele 2001 - S. De Caro, F. Miele, L’occupazione romana della Campania settentrionale nella dinamica insediativa di lungo periodo, in Modalità insediative e strutture agrarie nell’Italia meridionale in età romana, a cura di E. Lo Cascio, A. Storchi Marino, Bari 2001, 501-581. de Cazanove 2004 - O. de Cazanove, Un nouveau temple à Civita di Tricarico (Lucania), in MEFRA 116,1, 2004, 249-291.De Filippis 1995 - A. De Filippis, Ceramica a decorazione policroma da Cuma, in Studi sulla Campania preromana, a cura di M. Cristofani, F. Zevi, Roma 1995, 81-97.De Filippis 1998 - A. De Filippis, Da Lipari a Cuma: un itinerario tra Sicilia, Campania e Isole Eolie, in RIA 54, (s. 3, 19-20), 1996-1997 (1998), 21-47.De Filippis, Svanera 1996 - A. De Filippis, S. Svanera, Di alcuni corredi della necropoli di Teano - Fondo Gradavola, in BA 37-38, 1996, 127-144.De Gennaro, Santoriello 2003 - R. De Gennaro, A. Santoriello, Dinamiche insediative nel territorio di Volcei (Tekmeria, 4), Paestum 2003.De Miro 1990 - E. De Miro, La scultura in pietra, in Lo stile severo 1990, 107-116.De Miro 2000 - E. De Miro, Agrigento. I. I santuari urbani. L’area sacra tra il tempio di Zeus e Porta V, Roma 2000.De Monaco 1957 - A. De Monaco, Glorie nostre, Teano 1957.De Monaco 1960 - A. De Monaco, Teano osco e romano, Teano 1960.De Rosa, De Poli 1983 - S. De Rosa, F. De Poli, Dinamica di un fenomeno di moria ittica in una laguna salmastra Campana (Lago Patria), in Inquinamento 9, 1983, 00-00de Vos 1979 - M. de Vos, Pavimenti e mosaici, in Pompei 79, a cura di F. Zevi, Napoli 1979, 161-164.de’ Franciscis, Pane 1957 - A. de’ Franciscis, R. Pane, Mausolei romani in Campania, Napoli 1957.Degrassi 1959 - A. Degrassi, L’amministrazione della città, in Id., Guida allo studio della civiltà romana antica, Napoli 19592.Del Treppo 1953-1954 - M. Del Treppo, Franchi e papato in due secoli di storia volturnense, in ArchStProvNap 73, 1953-1954, 37-59.Del Treppo 1955 - M. Del Treppo, La vita economica e sociale di una grande abbazia del Mezzogiorno. San Vincenzo al Volturno nell’alto Medioevo, in ArchStProvNap 74, 1955, 31-110.Deliciae Fictiles 2006 - Deliciae Fictiles. 3, Proceedings of the International Conference held at the American Academy in Rome (November 7-8, 2002), ed. I.E.M. Edlund-Berry, G. Greco, J. Kenfi eld, Oxford 2006.Della Corte 1928 a - M. Della Corte, Esplorazioni archeologiche, in NSc, 1928, 229-237.Della Corte 1928 b - M. Della Corte, Alife: ruderi di una domus, in NSc, 1928, 238-240.Di Cosmo 1985 - L. Di Cosmo, Presenze di epoca romana nel territorio di Sant’Angelo d’Alife e Raviscanina, a cura del Gruppo Archeologicum Rufrium, Sant’Angelo d’Alife 1985, 7-24.Di Cosmo 1990 - L. Di Cosmo, Nota preliminare su materiale proveniente dal criptoportico in località Taverna Starze, in Il territorio alifano 1990, 171-179.Di Cosmo 1997 - L. Di Cosmo, Torcino. Insediamento agricolo tra periodo tardo-repubblicano ed alto-Medioevo, in Il territorio tra Matese e Volturno 1997, 123-128.Di Cosmo 2001 - L. Di Cosmo, Considerazioni su edifi ci religiosi di alcuni villaggi medievali dell’alifano, in S. Angelo di Ravecanina 2001, 111-128.Di Dario1940 - B. Di Dario, Notizie storiche della città e diocesi di Caiazzo, Caiazzo 1940.Di Gennaro 1988 - F. Di Gennaro, Primi risultati degli scavi nella necropoli di Crustumerium. Tre complessi funerari della fase IV A, in Archeologia Laziale 9 (QuadAEI 16), Roma 1988, 114-116.Di Giovanni 1991-1992 - V. Di Giovanni, Calvi Risorta (Caserta), località Pezzasecca. Scavi nell’area dell’antica città di Cales: saggi 1-3, in BA 11-12, 1991-1992, 146-147.Die Welt der Etrusker 1988 - Die Welt der Etrusker, Catalogo della mostra (Berlin, Oktober-Dezember 1988), Berlin 1988.Dressel 1884 a - E. Dressel, La necropoli presso Alife, in AnnIst 56, 1884, 219-268. Dressel 1884 b - E. Dressel, Numismatische Beiträge aus dem Grabfelde bei Piedimonte d’Alife (Allifae, Phistelia), in Historische und philologische Aufsätze Ernst Curtius zu seinem siebenzigsten Geburtstage am zweiten September 1884 gewidmet, Berlin 1884, 247-258.Du Cange 1887 - Ch. Du Cange, Glossarium mediae et infi mae latinitatis, Parigi 1887.Ducati 1937 - P. Ducati, Le pitture delle Tombe delle Leonesse e dei Vasi Dipinti, (Monumenti della pittura antica scoperti in Italia), Roma 1937.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 344
Elia 1962 - O. Elia, Culti familiari e privati della Campania. Le arule fi ttili pompeiane, in Hommages à A. Grenier, (Collection Latomus, 58), éd. M. Renard, Bruxelles 1962, 559-566.El-Najjar 1978 - M.Y. El-Najjar, Patterns of prehistoric epidemiology and human paleopathology, in MVC Quarterly 14, 1978, 3-9.Enea nel Lazio 1981 - Enea nel Lazio, Catalogo della mostra (Roma, 22 settembre-31 dicembre), Roma 1981.Fabbricotti 1974 - E. Fabbricotti, Osservazioni sulle lucerne a perline, in Cenacolo 4, 1974, 25-30. Faggella 1959 - R. Faggella, Un esempio di Bonifi ca integrale, in Rassegna del Mezzogiorno 3, 1959.Faraone 1878 - G. Faraone, Scavi di Treglia, in BullInst 1878, 51-53.Faraone 1899 - G. Faraone, Notizie storiche e biografi che della città e diocesi di Caiazzo, Napoli 1899.Fattore, Petrone 1997 - L. Fattore, P.P. Petrone, Indicatori dentari di stress in popolazioni di età imperiale dell’area fl egrea (II sec. d. C., Italia meridionale), in Antropologia contemporanea, Atti del XII Convegno A.A.I. Storia del popolamento del Mediterraneo: aspetti antropologici, archeologici e demografi ci, Palermo-Alia 1997, 00-00Femiano 1990 - S.R. Femiano, Linee di storia, topografi a e urbanistica dell’antica Cales, Maddaloni 1990.Fentress 2004 - E. Fentress et alii, Cosa in the Republic and Early Empire, in Cosa V: an intermittent town. Excavations 1991-1997, ed. E. Fentress (MemAmAc, Suppl. II), Ann Arbor 2004, 13-62.Fiengo 1988 - G. Fiengo, I Regi Lagni e la bonifi ca della Campania Felix durante il Viceregno spagnolo, Firenze 1988.Finelli 1928 [1985] - F.S. Finelli, Città e diocesi di Alife. Cenni storici, Scafati 1928, rist. anast., Alife 1985. Fiorelli 1876 - G. Fiorelli, Piedimonte d’Alife, in NSc, 1876, 101-102.Fiorelli 1880 - G. Fiorelli, Alife, in NSc, 1880, 83-84. Fiorelli 1881 - G. Fiorelli, Alife, in NSc, 1881, 168-170. Frederiksen 1959 - M. Frederiksen, Republican Capua, a social and economic study, in BSR 27, 1959.Frederiksen 1981 - M. Frederiksen, I cambiamenti delle strutture agrarie nella tarda Repubblica: la Campania, in Società romana e produzione schiavistica 1981, 265-287.Frederiksen 1984 - M. Frederiksen, Campania, Roma 1984. Gabba 1985 - E. Gabba, Per un’interpretazione storica della centuriazione romana, in Misurare la terra 1985, 20-27.Gabba 1989 - E. Gabba, Sui sistemi catastali romani in Italia, in Athenaeum 67, 1989, 567-570 Gabba, Pasquinucci 1979 - E. Gabba, M. Pasquinucci Strutture agrarie e allevamento transumante nell’Italia romana: III-I sec. a.C., (Biblioteca di studi antichi, 18) Pisa 1979.Gabrici 1910 - E. Gabrici, Necropoli di età ellenistica a Teano dei Sidicini, in MonAnt 20, 1910, 5-152.Gabrici 1912 - E. Gabrici, Corchiano - Scavi in contrada Fratta, in NSc 1912, 82-83. Gabrici 1913 - E. Gabrici, Cuma, in MonAnt 21, 1913.Galliazzo 1995 - V. Galliazzo, I ponti romani, Treviso 1995.Garcea et al. 1984 - F. Garcea, G. Miraglia, G. Soricelli, Uno scarico di materiale ceramico di età traianeo-antonina da Cratere Senga, in Puteoli 7-8, 1984, 245-285.Gargana 1929 - A. Gargana, La necropoli rupestre di S. Giuliano, in MonAnt 33, 1929, 299-444.Gargiulo 2000 - P.Gargiulo, Il litorale domitio e l’antica Liternum, in Ripensando il litorale domitio, Seminario internazionale di progettazione (Catalogo della mostra), a cura di F. Escalona et al., Giugliano in Campania 2000, 20-24.Gasperetti 1993 - G. Gasperetti, Problemi di topografi a urbana, in Prospettive di memoria 1993, 00-00.Gasperetti 1997 - G. Gasperetti, Testimonianze archeologiche delle infrastrutture idrauliche di età romana tra il Garigliano ed il Massico, in Uomo acqua e paesaggio, Atti dell’Incontro di studio sul tema “Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico”, S. M. Capua Vetere 22-23 novembre 1996 (Atlante tematico di topografi a antica. Supplementi, 2) Roma 1997, 239-252.Gasperetti, Passaro, De Caro 1999 - G. Gasperetti, C. Passaro, S. De Caro, Novità dal territorio degli Ausoni, in Progetto strategico C.N.R.: il Sistema Mediterraneo. Origine e incontri di culture nell’antichità. Magna Grecia e Sicilia. Stato degli studi e prospettive di ricerca, a cura di M. Barra Bagnasco, E. De Miro, A. Pinzone, Messina 1999, 145-158.Gatti 1995 - S. Gatti, Anagni (Frosinone). Località S. Cecilia.- Indagini nel santuario ernico: il deposito votivo arcaico, in NSc 1994-1995 (serie IX, V-VI, 1996), 5-153.Gaudenzi 1888 - Ignoti monachi cisterciensis S. Mariae de Ferraria Chronica, a cura di A.Gaudenzi, Napoli 1888.Gazzetti 1985 - G. Gazzetti, La valle di Baccano in età romana, in BdA 70, s. 6, 29, 1985, 39-46.
345La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Gazzetti 1986 - G. Gazzetti, La mansio di Vacanas al XXI miglio della Cassia, in Archeologia nella Tuscia, 2, Atti degli Incontri di studio (Viterbo 1984), Roma 1986, 155-165.Gejvall 1969 - N.G. Gejvall, Cremations, in Science in Archaeology, ed. D. Brothwell, E. Higgs, G. Clark, London 1969, 468-479.Gentile 1955 - A. Gentile, La romanità dell’agro campano alla luce dei suoi nomi locali, 1, Tracce della centuriazione romana, Napoli 1955.Geraci et al. 2002 - ?. Geraci et alii, Le analisi paleogenetiche, in Vesuvio 79 A.D. 2002, 00-00.Giannelli 1983 - G. Giannelli, Trattato di storia romana, Bologna 1983.Giglioli 1924 - G.Q. Giglioli, Vignanello - Nuovi scavi nella città e nella necropoli, in NSc 1924, 179-228.Giuliani 1990 - C.F. Giuliani, L’edilizia nell’antichità, Roma 1990.Gli Etruschi 2000 - Gli Etruschi, Catalogo della mostra (Venezia), a cura di M. Torelli, Venezia 2000.Goodman et al. 1984 - A.H. Goodman, J. Lallo, G.J. Armelagos, J.C. Rose, Health changes at Dikson Mounds, Illinois (A.D. 950-1300), in Paleopathology at the origins of the agricolture, ed. M.N. Cohen, G.J. Armelagos, New York 1984, 271-305.Goodman, Armelagos, Rose 1980 - A.H. Goodman, G.J. Armelagos, J.C. Rose, Enamel hypoplasias as indicators of stress in three prehistoric populations from Illinois, in Human Biology 52, 1980, 515-528.Gore 1984 - R. Gore, The dead do tells tales at Vesuvius, in NatGeo 165, 1984.5, 557-613.Grassi 2000 - B. Grassi, Vasellame e oggetti di bronzo. Artigiani e committenza, (Capua preromana, 8), Pisa-Roma 2000.Gros 1981 - P. Gros, L’organizzazione dello spazio pubblico e privato, in Società romana e produzione schiavistica 1981, 133-142. Gros 1990 - P. Gros, L’urbanizzazione dopo la guerra sociale, in Storia di Roma 1990, 831-855. Gros 1996 - P. Gros, L’architettura romana dagli inizi del III sec. a.C. alla fi ne dell’alto impero, 1. I monumenti pubblici, Milano 1996.Gros 1997 - M. Vitruvio Pollione, De Architectura, a cura di P. Gros, Torino 1997.Grose 1989 - D.F. Grose, The Toledo Museum of Arts. Early ancient glass, New York 1989.Guadagno 1976 - G. Guadagno, Vie commerciali, preistoriche e protostoriche in Terra di Lavoro, in Antiqua 2, 1976, 55-68.Guadagno 1987 - Storia economia ed architettura nell’ager falernus, Atti delle Giornate di studio (febbraio-marzo 1986), a cura di G. Guadagno, Minturno 1987.Guadagno 1993 - G. Guadagno, Quell’ottobre del ’43. Alife tra guerra e dopoguerra, Alife 1993.Gualandi 1990 - M.L. Gualandi, Strade, viaggi, trasporti e servizi postali, in Civiltà dei Romani 1990, 199-214.Guarino 2002 - ?. Guarino, Le analisi paleoistologiche sugli scheletri delle vittime, in Vesuvio 79 A.D. 2002, 00-00.Guzzo 1993 - P.G. Guzzo, Antico e archeologia. Scienza e politica delle diverse antichità, Bologna 1993.Hadzisteliou Price 1978 - Th. Hadzisteliou Price, Kourotrophos. Cults and representation of the Greek nursing deities, Leiden 1978.Harari 2000 - M. Harari, Modelli etnico-culturali e ceramografi a. I vasi alto-adratici, in Adriatico tra IV e III sec. a.C. 2000, 161-169.Harden 1981 - D.B. Harden, Catalogue of Greek and Roman glass in the British Museum, 1. Core- and rod-formed vessels and pendants and Mycenean cast objects, London 1981.Hayes 1972 - J.W. Hayes, Late Roman pottery, London 1972.Hayes 1977 - J.W. Hayes, North African fl anged bowls: a problem in fi fth century chronology, in Roman pottery studies in Britain and beyond: Papers presented to John Gillam, ed. J. Dore, K. Greene (British archaeological reports, Supplementary series, 30), Oxford 1977.Hayes 1980 - J.W. Hayes, Supplement to Late Roman pottery, London 1980.Hayes 1998 - J.W. Hayes, The study of Roman pottery in the Mediterranean: 23 years after Late Roman pottery, in Ceramica in Italia 1998, 9-21.Hellenismus in Mittelitalien 1976 - Hellenismus in Mittelitalien, Kolloquium in Göttingen vom 5. bis 9. Juni 1974, hrsg. P. Zanker, Göttingen 1976.Heurgon 1942 - J. Heurgon, Recherches sur l’histoire, la religion et la civilisation de Capoue preromaine, Paris 1942.Hillson 1986 - S. Hillson et alii, Teeth, ed. S. Hillson, Cambridge1986, part. 283-323.Hodges 1995 - R. Hodges, San Vincenzo al Volturno. The 1980-1986 excavations, I-II, London 1995.Hodges 1998 - W. Hodges, Hill fortifi cation, luogo 1998.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 346
Hodges, Marazzi 1995 - R. Hodges, F. Marazzi, San Vincenzo al Volturno: sintesi di storia e archeologia, Roma 1995.Hofter 1985 - M.R. Hofter, Untersuchungen zu Stil und Chronologie der mittelitalischen Terrakotta-votivköpfe, Bonn 1985.Holck 1986 - P. Holck, Cremated bones: a medical and anthropological study of an archaeological material on cremation burials, PhD thesis, Anatomical Institute, University of Oslo 1986.Holden et al. 1985 a - J.L. Holden, P.P. Phakey, J.G. Clement, Scanning electron microscope observations of incinerated femoral bone: a case study, in FScInt 74, 1985, 1-2, 17-28.Holden et al. 1985 b - J.L. Holden, P.P. Phakey, J.G. Clement, Scanning electron microscope observations of heat-treated human bone, in FScInt 74, 1985, 1-2, 29-45.Holloway 1965 - R.R. Holloway, Convention of Etruscan painting in the Tomb of Hunting and Fishing at Tarquinii, in AJA 69, 1965, 341-347.Humbert 1978 - M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale, Rome 1978.I Greci in Occidente 1996 - I Greci in Occidente. La Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Napoli 1996.I luoghi degli dei 1997 - I luoghi degli dei. Sacro e natura nell’Abruzzo italico, Catalogo della mostra (Chieti, 16 maggio-18 agosto 1997), a cura di A. Campanelli, A. Faustoferri, Pescara 1997.I torrenti assassini 2002 - I torrenti assassini del Matese meridionale, Atti del Convegno sulle alluvioni catastrofi che recenti negli insediamenti urbani: il rischio e la prevenzione dopo il disastro del Sarno, (Piedimonte Matese, 31 ottobre 1998), a cura di D. Caiazza, Piedimonte Matese 2002.Iannelli 1878 - G. Iannelli, Relazione sul nuovo scavo ed antichi monumenti di Trebula, in Atti Terra di Lavoro 9, Caserta 1878, 19-22, 45-53.Il santuario di Portonaccio 2002 - Il santuario di Portonaccio a Veio, a cura di G. Colonna (MonAnt 58, s. misc VI.3), Roma 2002.Il territorio alifano 1990 - Il territorio alifano. Archeologia, arte, storia, Atti del Convegno (Sant’Angelo d’Alife, 26 aprile 1987), a cura di L. Di Cosmo, A.M. Villucci, Minturno 1990.Il territorio tra Matese e Volturno 1997 - Il territorio tra Matese e Volturno, Atti del I Convegno di studi sulla storia delle foranie della diocesi di Isernia-Venafro. La forania di Capriati al Volturno (Capriati al Volturno, 18 giugno 1994), a cura di D. Caiazza, Castellammare di Stabia 1997. Il Tevere e le altre vie d’acqua 1986 - Il Tevere e le altre vie d’acqua del Lazio antico, Archeologia Laziale 7, 2. Settimo incontro di studio del Comitato per l’archeologia laziale (QuadAEI 12), Roma 1986In fi nibus Alifanis 2002 - In fi nibus Alifanis, Atti del Convegno, a cura di D. Caiazza, L.R. Cielo, (Alife 2000), Piedimonte Matese 2002.Isler 1970 - H.P. Isler, Johann Jacob Eggs Antikenschenkungen zur Geschichte der archäologischen Sammlungen, in NZZ, n. 454, 30 Sept. 1970.Isler 1973 - H.P. Isler, CVA Schweiz 2, Zürich 1, 8, Bern 1973.Italia omnium terrarum parens 1989 - Italia omnium terrarum parens, a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano 1989Italica ars 2005 - Italica ars. Studi in onore di Giovanni Colonna per il premio I Sanniti, a cura di D. Caiazza, Piedimonte Matese 2005.Izzo 1994 - D. Izzo, Nuove testimonianze sul culto di Pupluna da Teanum Sidicinum, in Ostraka 3, 2, 1994, 277-284.Johannowsky 1961 - W. Johannowsky, Relazione preliminare sugli scavi di Cales, in BdA 46, 1961, 258-268.Johannowsky 1962 - W. Johannowsky, Modelli di edifi ci da Teano, in BdA 47, 1962, 63-68.Johannowsky 1963 - W. Johannowsky, Relazione preliminare sugli scavi di Teano, in BdA 48, 1963, 131-164.Johannowsky 1965 - W. Johannowsky, Problemi di classifi cazione e cronologia di alcune scoperte protostoriche a Capua e Cales, in StEtr 28, 1965, 685-698.Johannowsky 1972 - W. Johannowsky, Nuove tombe dipinte campane, in Le genti non greche della Magna Grecia, Atti dell’XI Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto 1971), Napoli 1972, 375-382.Johannowsky 1973 - W. Johannowsky, Note sui criptoportici pubblici in Campania, in Les cryptoportiques 1973, 142-165. Johannowsky 1975 - W. Johannowsky, Problemi archeologici campani, in RendNap 50, 1975, 3-38.Johannowsky 1976 - W. Johannowsky, La situazione in Campania, in Hellenismus in Mittelitalien 1976, 267-299.
347La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Johannowsky 1981 - W. Johannowsky, Testimonianze materiali del modo di produzione schiavistico in Campania e nel Sannio Irpino, in Società romana e produzione schiavistica 1981, 299-309. Johannowsky 1983 - W. Johannowsky, Materiali di età arcaica dalla Campania, Napoli 1983.Johannowsky 2000 - W. Johannowsky, Considerazioni sul rapporto tra ceramica alto-adriatica e ceramica campana, in Adriatico tra IV e III sec. a.C. 2000, 147-00Johannowsky 2004 - W. Johannowsky, Materiale di età arcaica e classica da Rufrae, S. Agata dei Goti, Circello, Casalbore, Carife, Castel Baronia, Bisaccia, Morra de Santis, in Safi nim 2004, 275-282.Jolivet, Marchand 2003 - V. Jolivet, Fr. Marchand, L’affaire du Bachanal. Nouvelles réfl exions sur le sanctuaire bachique du Poggio Moscini à Bolsena, in Santuari e luoghi di culto 2003, 35-51.Jurgeit 1999 - F. Jurgeit, Die etruskischen und italischen Bronzen sowie Gegenstände aus Eisen, Blei und Leder im Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Pisa-Roma 1999.Jurmain 1977 - R.D. Jurmain, Stress and etiology of osteoarthritis, in AJPhA 46, 1977, 353-366.Jurmain 1980 - R.D. Jurmain, The pattern of involvement of appendicular degenerative joint disease, in AJPhA 53, 1980, 143-150Jurmain 1990 - R.D. Jurmain, Paleoepidemiology of a central California prehistoric population from CA-ALA-329: II. Degenerative disease, in AJPhA 83, 1990, 83-94.Kajava 1989 - M: Kajava, Un seviro da Venafro, in Epigraphica 51, 1989, 244-245Karakasi 2001 - K. Karakasi, Archaische Koren, München 2001.Keppie 1983 - L. Keppie, Colonisation and veteran settlement in Italy (47-14 B.C.), Hertford 1983.Klepinger 1984 - L.L. Klepinger, Nutritional assessment from bone, in AnnRA 13, 1984, 73-96.Knight 1996 - B. Knight, Forensic pathology, London 1996.L’Italia meridionale 1999 - L’Italia meridionale in età tardo antica, Atti del XXXVIII Convegno di studi sulla Magna Grecia, (Taranto 2-6 ottobre 1988), Napoli - Taranto 1999.La forma della città 2006 - La forma della città e del territorio, 3 (Atlante tematico di topografi a antica, 15), a cura di L. Quilici, S. Quilici Gigli, Roma 2006, 107-134La Motte, Campbell 1978 - R.H. La Motte, J.N. Campbell, Comparison of responses of warm and nociceptive C-fi ber afferents in monkey with human judgments of thermal pain, in JNeuro 41, 1978, 509-528.La Regina 1970 - A. La Regina, Note sulla formazione dei centri urbani in area sabellica, in Studi sulla città antica, Atti del Convegno di studi sulla città etrusca e italica preromana (Bologna 1966), Bologna 1970, 191-207.La Regina 1976 - A. La Regina, Il Sannio, in Hellenismus in Mittelitalien 1976, 219-244.La Regina 1989 - A. La Regina, I Sanniti, in Italia omnium terrarum parens 1989, 301-432. La Regina 1999 - A. La Regina. Istituzioni agrarie italiche, in La civiltà della transumanza. Storia, cultura e valorizzazione dei tratturi e del mondo pastorale in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata, a cura di E. Petrocelli, Isernia 1999, 3-18. La romanisation du Samnium 1991 - La romanisation du Samnium au IIeme et Ier siécles av. J.C., Actes du colloque (Naples, 4-5 Novembre 1988), Naples 1991.Laforgia, De Filippis 2002 - E. Laforgia, A. De Filippis, Centuriazione a Gricignano di Aversa, in Ager Campanus 2002, 00-00.Lambert et al. 1979 - J.B. Lambert, C.B. Sputznar, J.E. Buikstra, Chemical analysis of excavated human bone from Middle and Late Woodland Sites, in Archaeometry 21, 1979, 115-129.Lambert et al. 1983 - J.B. Lambert, G. Simpson, J.E. Buikstra, D. Hanson, Electron microprobe analysis of elemental distribution in excavated human bone from Middle and Late Woodland Sites, in AJPhA 59, 1983, 131-140.Lambert, Sputznar, Buikstra 1979 - J.B. Lambert, C.B. Sputznar, J.E. Buikstra, Chemical analysis of excavated human bone from Middle and Late Woodland Sites, in Archaeometry 21, 1979, 115-129.Landolfi 1997 - M. Landolfi , Vasi antichi con teste femminili tra Astrattismo e Pop Art, in Classico Anticlassico, Vasi alto-adriatici tra Piceni, Spina e Adria, Palazzo Ferretti, Museo Archeologico Nazionale delle Marche (Ancona, 20 aprile-13 settembre 1997), Bologna 1997, 5-10.Landolfi 2000 - M. Landolfi , Vasi alto-adriatici del Piceno, in Adriatico tra IV e III sec. a.C. 2000, 111-129.La penna 1997 - S. Lapenna, Il santuario italico di Schiavi d’Abruzzo, in I luoghi degli dei 1997, 81-85.Les cryptoportiques 1973 - Les cryptoportiques dans l’architecture romaine, Actes de la rencontre (Rome, 19-23 avril 1972), Rome 1973.Levi 1916 - A. Levi, Alife. Statuetta di bronzo rappresentante Eracle bibace trovata nel territorio di Alife, in NSc, 1916, 111-116. Levi 1972 - L. Levi, Stress and distress in response to psychosocial stimuli, Oxford 1972.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 348
Lista, Ziviello 1991 - M. Lista, C. Ziviello, Necropoli di Alife, in AnnPisa serie 3, 21,1, 1991, 31-65.Liverani 1987 - P. Liverani, Termini muti di centuriazione o contrappesi di torchi?, in MEFRA 99, 1987, 111-127.Lo stile severo 1990 - Lo stile severo in Sicilia. Dall’apogeo della tirannide alla prima democrazia, Catalogo della mostra (Palermo, 10 febbraio-30 settembre), Palermo 1990.Lo Porto 1991 - F. Lo Porto, Timmari. L’abitato, le necropoli, la stipe votiva, Roma 1991.Loffreda 2001 - D. Loffreda, La necropoli a Serra S. Croce di San Gregorio Matese, in Sannio Pentro Alifano 2001, 27-76.Lombardi et al. 2004 - N. Lombardi, S. Capasso, L. Santagata, Le origini del paese, in San Potito Sannitico. Da villaggio rurale a città del parco, a cura di N. Lombardi, Piedimonte Matese 2004, 15-22.Longobardo 2004 - F. Longobardo, Problemi di viabilità in Campania: la via Domitiana, in Viabilità e insediamenti nell’Italia antica (Atlante tematico di topografi a antica, 13), Roma 2004, 277- 290.Luckacs 1989 - J.R. Luckacs, Dental paleopathology: methods for reconstruction of dietary patterns, in Reconstruction of life from the skeleton, New York 1989, 261-286.Lugli 1957 - G. Lugli, La tecnica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e nel Lazio, Roma 1957. Maaskant-Kleinbrink et al. 1992 - M. Maaskant-Kleinbrink et alii, Settlement excavations at Borgo Le Ferriere “Satricum”. II (The campaigns 1983, 1985 and 197), Gröningen 1992Maddalena, Angelotti 1988 - A. Maddalena, M. Angelotti, I manufatti litici di Prata Sannita nel contesto del Musteriano di tecnica levallois, in Atti del I Convegno dei Gruppi Archeologici dell’Italia meridionale (Prata Sannita, 25-27 aprile 1986), Isernia 1988, 41-65.Maggiani 1998 - A. Maggiani, Sulla paleografi a delle iscrizioni di Spina, in Spina e il delta padano. Rifl essioni sul catalogo e sulla mostra ferrarese, Atti del Convegno internazionale di studi (Ferrara 1994), Roma 1998, 277-234.Maggiani 1999 - A. Maggiani, Pitigliano, in Insediamenti preistorici e città etrusche nella media valle del fi ume Fiora. Guida al Museo Civico Archeologico di Pitigliano, a cura di E. Pellegrini, Pitigliano 1999, 55-60.Maggiani 2003 - A. Maggiani, La media valle del Fiora, in Tra Orvieto e Vulci 2003, 77-80.Magna Graecia 2005 - Magna Graecia. Archeologia di un sapere, Catalogo della mostra (Catanzaro, 19 giugno-31 ottobre), a cura di S. Settis, M.C. Parra, Milano 2005.Magna Grecia, Etruschi e Fenici 1994 - Magna Grecia, Etruschi e Fenici, Atti del XXXIII Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 8-13 ottobre 1993), Taranto 1994.Maioli, Mastrocinque 1992 - M. G. Maioli, A. Mastrocinque, La stipe di Villa di Villa, Roma 1992.Maiuri 1927 - A. Maiuri, Iscrizione funeraria. Antico tratturo. Statuetta di bronzo, in NSc, 1927, 450-460. Maiuri 1928 - A. Maiuri, Nuovi tratti messi in luce della “Via Domitiana” , in NSc,1928, 181-185.Maiuri 1929 - A. Maiuri, Resti di mura in opera poligonale e avanzi preistorici dal monte Cila, in NSc, 1929, 33-38.Maiuri 1930 - A. Maiuri, Treglia: ricognizioni nell’agro Trebulano, in NSc, 1930, 214-228.Maiuri 1938 - A. Maiuri, Passeggiate campane, I, Milano 1938.Maiuri 1951 - A. Maiuri, Itinerarium Phlegraeum, in Tenet nunc Parthenope, Torino 1951, 45-46.Maiuri 1954 - A. Maiuri, Lungo la via Domitiana, in Le vie d’Italia, Milano maggio 1954, 00-00Maiuri 1981 - A. Maiuri, I Campi Flegrei, Roma 19815.Manacorda 2000 - D. Manacorda, Il teatro e la crypta di Balbo, in Museo Nazionale Romano. Crypta Balbi, Milano 2000.Mancini 1975 - N. Mancini, Altre iscrizioni inedite di Allifae, in AnnAssSanAl 60, 1975, 108-113.Mancini 1993 - N. Mancini, Allifae, Piedimonte Matese 1993.Marabini 1973 - M.T. Marabini, The Roman thin-walled pottery from Cosa, Roma 1973.Marazzi 1996 - F. Marazzi, San Vincenzo al Volturno: cultura, istituzioni, economia, Montecassino 1996. Marazzi 2001 - F. Marazzi, Rupe Canina (Sant’Angelo d’Alife-Raviscanina - CE). Note introduttive su un progetto di archeologia medievale, in S. Angelo di Ravecanina 2001, 129-143.Marazzi 2002 - F. Marazzi, San Vincenzo al Volturno, introduzione ad un cantiere di archeologia medievale, Napoli 2002.Marconi 1994 - C. Marconi, Selinunte. Le metope dell’Heraion, Modena 1994.Marrocco 1916 - R. Marrocco, Le Terme d’Ercole in S. Potito Sannitico, in ArchStSanAl 1,2, 1916, 8-13. Marrocco 1917 - R. Marrocco, Un’antica zecca in Alife durante i primi tempi dell’Evo antico, in ArchStSanAl 2, 1917, 11-15.Marrocco 1918 - R. Marrocco, Il colombario Alifano, in ArchStSanAl 3, 1918, 36-39.Marrocco 1920 - R. Marrocco, Le mura di Alife e l’iscrizione in onore di Fabio Massimo. Un celebre falso epigrafi co, in ArchStSanAl 5, 1920, 3-12.
349La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Marrocco 1926 - R. Marrocco, Memorie storiche di Piedimonte d’Alife, Piedimonte d’Alife 1926. Marrocco 1951 - D.B. Marrocco, L’antica Alife, Piedimonte Matese 1951. Marrocco 1964 - D.B.. Marrocco, L’arte nel medio Volturno, Piedimonte Matese 1964. Marrocco 1969 - D.B. Marrocco, Topografi a di Alife romana, in La Rassegna Storica dei Comuni, 1, 1, 1969, 3-8.Marrocco 1980 - D.B. Marrocco, Piedimonte Matese, Piedimonte Matese 1980.Marrocco 1985 - D.B. Marrocco, Guida al medio Volturno, Piedimonte Matese 1985.Martelli 1977 - M. Martelli, Per una defi nizione archeologica della Sabina: la situazione storico-culturale di Poggio Sommavilla in età arcaica, in Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere, 3. Rilettura critica della necropoli di Poggio Sommavilla, a cura di P. Santoro, Roma 1977, 00-00.Martelli 2005 - A. Martelli, Titolo mummiano nel tempio di Apollo a Pompei: l’iscrizione Vetter 61, in Nuove ricerche archeologiche a Pompei ed Ercolano, Atti del Convegno internazionale (Roma, 28-30 novembre 2002), a cura di P.G. Guzzo, M.P. Guidobaldi, Napoli 2005, 383.Martin, Goodman, Armelagos 1985 - D.L. Martin, A.H. Goodman, G.J. Armelagos, Skeletal pathologies as indicators of quality and quantity of diet, in The analysis of prehistoric diets, ed. R. Gilbert, J. Mielke, New York 1985, 227-279.Massai Dräger 2000 - C. Massai Dräger, Crateri alto-adriatici fi gurati ed ideologia funeraria, in Adriatico tra IV e III sec. a.C. 2000, 103-109.Mastrolorenzo et al. 1998 - G. Mastrolorenzo et alii, Volcanology, archaeology and anthropology: an interdisciplinary approach to the effects of the A.D. 79 eruption of Vesuvius (Italy), in Tephrocronologie et co-existence Hommes Volcans, INQUA COT/UISPP 31, Brives-Charensac, France 1998, 110-111.Mastrolorenzo et al. 1999 - G. Mastrolorenzo et alii, A.D. 79 Eruption of Vesuvius (Italy): emplacement mechanisms of pyroclastic fl ows and related effects on structures and people, in 24th General Assembly Nonlinear Geophysics and Natural Hazards, European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Den Haag, Nederland 1999, 856.Mastrolorenzo et al. 2001 a - G. Mastrolorenzo et alii, Herculaneum victims of Vesuvius in A.D. 79, in Nature 410, 2001, 769-770.Mastrolorenzo et al. 2001 b - G. Mastrolorenzo et alii, Studio interdisciplinare degli effetti dell’eruzione pliniana del 79 d.C. sulle cose e sulle persone: nuovi dati vulcanologici, archeologici, antropologici, in Pompei: scienza e società, Atti del Convegno internazionale (Napoli 1998), Napoli 2001, 212; 234.Mastrolorenzo et al. 2001 c - G. Mastrolorenzo et alii, The 79 A.D. Vesuvius Plinian eruption at Herculaneum and its impact on the people, in Tephras, chronology, archaeology, ed. E. Juvigné, J.P. Raynal, Cderad 2001, 183-189.Mastrolorenzo et al. 2002 - G. Mastrolorenzo et alii, Effects of the A.D. Vesuvius Plinian eruption in the buried sites of Herculaneum, Oplontis and Stabiae from an integrated volcanological, anthropological and archaeological study, in Montagne Pelée 1902-2002. Explosive volcanism in subduction zones, Saint Pierre, Martinique 2002.Mastrolorenzo, Petrone 2000 - G. Mastrolorenzo, P.P. Petrone, Studi scientifi ci sull’eruzione e i suoi effetti, in Gli antichi Ercolanesi. Antropologia, società, economia, a cura di M. Pagano, Napoli 2000, 51-59.Mastrolorenzo, Petrone 2002 - G. Mastrolorenzo, P.P. Petrone, Effects of Plinian eruptions of Somma-Vesuvius on people, animals, structures and objects: inferences from Avellino (3760 YR b.p.) and Pompeii (79 A.D.) events, in 27th General Assembly of the European Geophysical Society, Nizza 2002.Matteucig 1951 - G. Matteucig, Poggio Buco. The necropolis of Statonia, Berkeley - Los Angeles 1951.Melchiorri 1619 - O. Melchiorri, Descrittione dell’antichissima città di Caiazzo, S.M. Capua Vetere 1619.Mengarelli 1901 - R. Mengarelli, Veio (territorio di Formello) - Nuove indagini nell’area della necropoli veientana, in NSc, 1901, 238-246.Menna 1848 - L. Menna, Saggio istorico della città di Carinola, 1, Aversa 1848.Mennone 1894 [1997] - G. Mennone, Riassunto storico dell’antico Sannio, 1894, rist. anast., Alife 1997. Merolla 1964 - M.I. Merolla, Allifae: le mura e il criptoportico, in ArchCl 16, 1964, 39-48.Mertens 1993 - D. Mertens, Der alte Heratempel in Paestum und die archaische Baukunst in Unteritalien, Mainz 1993.Messineo 1987 - G. Messineo La via Tiburtina a Settecamini, in Archeologia Laziale, 8. Ottavo Incontro di studi del Comitato per l’archeologia laziale (QuadAEI, 14), Roma 1987, 135-138.Mezzolani 1992 - A. Mezzolani, Appunti sulle mansiones in base ai dati archeologici, in Tecnica stradale romana 1992, 105-117.Miele 1991-1992 a - F. Miele, Pratella (Caserta). Frazione Roccavecchia. Località Palombiscio. L’insediamento, in BA 11-12, 1991-1992, Roma 1994, 117-119.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 350
Miele 1991-1992 b - F. Miele, Alife (Caserta), Aspetti della topografi a e dell’edilizia domestica in Alife romana, BA 11-12, 1991-1992, Roma 1994, 130-136.Miele 1997 a - F. Miele, Raviscanina. Rinvenimento di ceramica dell’età del Bronzo in località Le Starze, in RScPreist 47, (1995-1996), 1997, 447.Miele 1997 b - F. Miele, Rinvenimenti di età ellenistico-romana, in Il territorio tra Matese e Volturno 1997, 51-66.Miele 1997 c - F. Miele, Rinvenimenti di pitture parietali in Allifae romana, in I temi fi gurativi nella pittura parietale antica (IV sec. a.C.-IV sec. d.C.), Atti del VI Convegno dell’Associazione Italiana di Pittura Murale Antica (Bologna, 20-23 settembre 1995), a cura di D. Scagliarini Corlaita, Bologna-Imola 1997, 245-247. Miele 2001 - F. Miele, Monete del XII secolo in Campania: il tesoretto di Alife, in Museo Archeologico Nazionale 2001, 119-121. Miele 2002 a - F. Miele, La cinta muraria romana di Alife alla luce delle recenti indagini archeologiche, in In fi nibus Alifanis 2002, 13-39. Miele 2002 b - F. Miele, Edifi ci a carattere religioso di epoca tardo-antica e alto-medievale nel territorio del Matese Casertano, in Atti del II Convegno di studi sulla storia delle foranie della diocesi di Isernia e Venafro. La forania di Capriati al Volturno (Capriati al Volturno, 7 dicembre 2002), c.d.s.Miele 2003 - F. Miele, Allifae, in Lo sguardo di Icaro. Le collezioni dell’Aerofototeca Nazionale per la conoscenza del territorio, Catalogo della mostra (Roma, ICCD, 27 giugno - 8 luglio 2003), a cura di M. Guaitoli, Roma 2003, 424-427.Miele 2004 a - F. Miele, Recenti rinvenimenti di epoca sannitica nel territorio alifano, in Safi nim 2004, 195-235.Miele 2004 b - F. Miele, L’età romana dalla Repubblica all’Impero. Alife e il suo territorio in età romana e tardo-antica, in Ager Allifanus 2004, 75-91.Miele 2004 c - F. Miele, Una chiesa rurale e alcuni insediamenti a carattere religioso di epoca tardo-antica e alto-medievale nel territorio del Matese Casertano, in Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale, Atti del I Seminario sul tardo antico e alto Medioevo (Foggia, 11-13 febbraio 2004), c.d.s.Miele, Chiosi 1994 a - F. Miele, E. Chiosi, Ceramica a vernice nera nell’Alto Casertano: ipotesi di lavoro. Roccavecchia di Pratella (CE), località Palombiscio, Scavo di fornaci: 1992, in Ceramica romana e archeometria 1994, 257-259.Miele, Chiosi 1994 b - F. Miele, E. Chiosi, Insediamenti produttivi nella media valle del Volturno. Roccavecchia di Pratella (CE), località Palombiscio. Fornaci di epoca ellenistica, in Ceramica romana e archeometria 1994, 308-312.Milanesio Macrì 2005 - M. Milanesio Macrì, Il thesmoforion di contrada Parapezza a Locri Epizefi ri, in Magna Graecia 2005, 229-230.Miller Ammerman 2002 - R. Miller Ammerman, The sanctuary of Santa Venera at Paestum II. The votive terracottas, Ann Arbor (Michigan) 2002.Mingazzini 1938 - P. Mingazzini, Il santuario della dea Marica alla foci del Garigliano, in MonAnt 37, 1938, 693-956.Minieri Riccio 1877 - C. Minieri Riccio, Notizie storiche tratte da 62 Registri Angioini dell’Archivio di Stato di Napoli, Napoli 1877.Miniero 2002 - P. Miniero, Il deposito votivo in località Privati presso Castellammare di Stabia. Nota preliminare, in L’iconografi a di Atena con elmo frigio in Italia meridionale, Atti della Giornata di studio (Fisciano, 12 giugno 1998), (Quaderni di Ostraka, 5), Napoli 2002, 11-36.Miniero et al.1997 - P. Miniero et alii, Il santuario campano in località Privati presso Castellammare di Stabia. Osservazioni preliminari, in RStPomp 8, 1997, 11-56Misurare la terra 1985 - Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano, Catalogo della mostra, Modena 1985.Mitchell, Hansen 2001 - J. Mitchell, I.L. Hansen, San Vincenzo al Volturno, 3. The fi nds from 1980-1986 excavations, Spoleto 2001.Mommsen 1883 - Th. Mommsen, s.v., CIL IX, Roma 1883, 214-227, 674. Mommsen 1908 - Th. Mommsen, in Gesammelte Schriften V, Berlin 1908.Morel 1976 - J.P. Morel, Le sanctuaire de Vastogirardi (Molise) et les infl uences héllénistiques en Italie centrale, in Hellenismus in Mittelitalien 1976, 255-266.Morel 1981 - J.P. Morel, Céramique campaniènne: les formes, Roma 1981 (1994
2).
351La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Morel 1990 - J. P. Morel, Aspects économiques d’un sanctuaire (fondo Ruozzo à Teano, Campanie), in Anathema. Regime delle offerte e vita dei santuari nel Mediterraneo antico, Atti del Convegno (Roma, 1989), ScAnt 3-4, 1989-1990, 507-517.Morel 1992 - J.P. Morel, Ex-voto par transformation, ex-voto par destination (à propos du dépôt votif de Fondo Ruozzo à Teano), in Mélanges Pierre Lévêque. 6. Réligion, éd. M.M. Mactoux, E. Geny, Paris 1992, 221-232.Morel 1998 - J.P. Morel, Les cultes du sanctuaire de fondo Ruozzo à Teano, in I culti della Campania antica, Atti del Convegno internazionale di studi in ricordo di Nazarena Valenza Mele (Napoli, 15-17 maggio 1995), a cura di S. Adamo Muscettola, G. Greco, Roma 1998, 157-167.Morhange et al. 2002 - Ch. Morhange et alii, Il problema della localizzazione del porto antico di Cuma: Nuovi metodi e risultati preliminari, in Cuma. Nuove Forme di intervento per lo studio del sito antico, Atti della Giornata di studio (Napoli, 12 febbraio 2001), in AnnOrNap, Quad. 14, Napoli 2002.
Moscatelli 1990 - U. Moscatelli, A proposito di alcune recenti ricerche sulle divisioni agrarie in Italia centromeridionale, in AnnMacerata 22-23, 1989-1990, 659-677. Museo Archeologico Nazionale 2001 - Museo Archeologico Nazionale di Napoli. La collezione numismatica, per una storia monetaria del Mezzogiorno, Napoli 2001.Nagy 1988 - H. Nagy, Votive terracottas from the Vignaccia, Cerveteri, in the Lowie Museum of Anthropology, Roma 1988.Napoli antica 1985 - Napoli antica, Catalogo della mostra (Napoli, 28 settembre 1985-15 aprile 1986), Napoli 1985.Naso 1996 - A. Naso, Architetture dipinte. Decorazioni parietali non fi gurate nelle tombe a camera dell’Etruria meridionale (VII-V sec. a.C.), Roma 1996.Neudecker 1994 - R. Neudecker, Die Pracht der Latrine. Zum Wandel öffentlicher Bedürfnisanstalten in der kaiserzeitlichen Stadt, (Studien zur antiken Stadt, 1) München 1994.Nissen 1883 - H. Nissen, in Italische Landeskunde, II, Berlin 1883-1902. Oakley 1995 - S.P. Oakley, The hill-forts of the Samnites (Archaeological Monographs of the British School at Rome, 10), London 1995 .Ødegrd 1997 - K. Ødegrd, Drainage and colonization. The case of Cales, in Uomo, acqua e paesaggio. Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico, Atti del Convegno (S.M. Capua Vetere, 22-23 novembre 1996), a cura di A. De Vivo, G. Franciosi, S. Quilici Gigli, Roma 1997, 213-224.Ohnesorg 2005 - A. Ohnesorg, Ionische Altäre. Formen und Varianten einer Architekturgattung aus Insel- und Ostionien, Berlin 2005.Olbrich 1979 - G. Olbrich, Archaische Statuetten eines Metapontiner Heiligtums, (Studia archaeologica, 23), Roma 1979.Orlandini 1966 - P. Orlandini, Lo scavo del thesmophorion di Bitalemi e il culto delle divinità ctonie a Gela, in KOKALOS 12, 1966, 8-35.Ortalli 1984 - J. Ortalli, La tecnica di costruzione delle strade di Bologna tra età romana e Medioevo, in AMediev 1984, 379-394.Osanna, Sica 2005 - M. Osanna, M.M. Sica, Articolazione dello spazio e pratiche rituali nel santuario lucano di Torre di Satriano, in Spazio del rito 2005, 125-139.Ostrow 1977 - E. Ostrow, Problems in the topography of Roman Puteoli. A dissertation submitted in partial fulfi llment of the requirements for the degree of doctor of Philosophy (Classical art and Archaeology), University of Michigan 1977.Pacichelli 1703 - G. B. Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici province, I, Napoli 1703. Pagano 1980 - M. Pagano, Schede epigrafi che, in Puteoli 4–5, 1980, 279 segg. (nn. 12-13).Pagano 1989 - M. Pagano, La Basilica di Santa Fortunata a Liternum, in RACr 65, 1989, 179-188.Pagano 1990 - M. Pagano, Problemi della centuriazione di Alife, in Il territorio alifano 1990, 95-101. Pagano 1998 - M. Pagano, Storia e archeologia di Caiazzo. Dalla Preistoria al Medioevo, Boscotrecase (Na) 1998.Pagano 2002 - M. Pagano, L’antica Ercolano, in Vesuvio 79 A.D. 2002, 00-00.Pagano et al. 1997 - M. Pagano et alii, The coast in the area of the Herculaneum excavations at the time of the Romans, in Geotechnical engineering for the preservation of monuments and historic sites, a cura di C. Viggiani, Rotterdam 1997, 759-766.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 352
Pagano et al. 2005 - M. Pagano, A. Ceccarelli, A. D’Andrea, D. Monaco, M. Moretta, M. Raddi, D. Sepio, D. Wiks, La ripresa delle esplorazioni e degli scavi nel santuario italico di Vastogirardi (IS), in Italica ars 2005, 451-505.Pais 1923 - E. Pais, Storia della colonizzazione di Roma antica, I Prolegomeni. Le fonti: i libri imperiali regionum, Roma 1923. Pallottino 1982 - M. Pallottino, Rifl essioni sul concetto di Villanoviano, in Miscellanea archaeologica T. Dohrn dedicata (Archaeologica, 26), Roma 1982, 67-71.Panella 1981 - C. Panella, La distribuzione e i mercati, in Società romana e produzione schiavistica 1981 a, 55-80.Pantoni 1975 - A. Pantoni, S. Pietro Infi ne, in Bollettino Diocesano 4, 1975, 314.Pantoni 1980 - A. Pantoni, Le chiese e gli edifi ci di S. Vincenzo al Volturno, Montecassino 1980. Papadopoulos 2003 - J.K. Papadopoulos, La dea di Sibari e il santuario ritrovato. Studi sui rinvenimenti dal Timpone Motta di Francavilla Marittima, II. 1. The archaic votive metal objects (BdA, vol. Speciale), Roma 2003.Parente 1858 [1986] - G. Parente, Origini e Vicende Ecclesiastiche della Città di Aversa, Napoli 1858, rist. anast., Aversa 1986.Paribeni 1905 - R. Paribeni, Civitella S. Paolo - Scavi nella necropoli capenate, in NSc 1905, 301 segg.Parma 1990 - A. Parma, Note di epigrafi a alifana, in Il territorio alifano 1990, 103-117.Passaro 1986 - C. Passaro, in E. Pozzi, L’attività archeologica nelle province di Napoli e Caserta - 1986, in Lo Stretto crocevia di culture, Atti del XXVI Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto-Reggio Calabria, 9-14 ottobre 1986), Napoli-Taranto 1987, 558-578. Passaro 1987 - C. Passaro, in E. Pozzi, Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta. Attività di scavo, tutela e valorizzazione - 1986-1987, in Poseidonia-Paestum 1987, 699-746. Passaro 1990 - C. Passaro, in E. Pozzi, La Campania. L’attività archeologica nelle province di Napoli e Caserta - 1989, in La Magna Grecia e il lontano Occidente, Atti del XXIX Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 6-11 ottobre 1989), Napoli-Taranto 1990, 497-527. Passaro 1993 a - C. Passaro, Calvi Risorta (Caserta), località Calvi Vecchia. Scavi nell’area di parcheggio Cales nord dell’Autosole, in BA 22, 1993 (1996), 49-51.Passaro 1993 b - C. Passaro, Calvi Risorta (Caserta), località Ponte delle Monache. Cales: Il Santuario di Ponte delle Monache, in BA 22, 1993 (1996), 54-57.Pautasso 1996 - A. Pautasso, Terrecotte arcaiche e classiche del museo civico del Castello Ursino a Catania, Catania 1996.Pellegrini 1989 - E. Pellegrini, La necropoli di Poggio Buco. Nuovi dati per lo studio di un centro dell’Etruria interna nei periodi orientalizzante e arcaico, Firenze 1989.Pellegrini 2003 - E. Pellegrini, Nuove ricerche nei centri etruschi di Pitigliano e Poggio Buco, in Tra Orvieto e Vulci 2003, 00-00. Pena 1989 - M.J. Pena, Infl uenze etrusche sulla coroplastica della Campania settentrionale: la stipe arcaica di Fondo Ruozzo (Teano), in Secondo Congresso Internazionale Etrusco (Firenze, 1985), II, Roma 1989, 741- 745.Pendolino 1978 - G. Pendolino, Sclavia-Trebula-Saticula-Plistica. Storia, tradizioni e leggende, Marigliano 1978.Petrone 1994 - P.P. Petrone, Indicatori bioculturali: analisi dei dati di patologia dentaria e scheletrica in comunità di età sannitica (VI - IV sec. a.C., Molise), in BPI 85, 1994, 493-507.Petrone 1999 - P.P. Petrone, San Paolo Belsito: una fi nestra sul passato, in Un’eruzione vesuviana 1999, 73-75.Petrone et al. 1999 - P.P. Petrone et alii, The A.D. 79 eruption of Vesuvius: thermal injuries and death of the people of Herculaneum, in Atti del XIII Convegno degli Antropologi Italiani, Roma-Sabaudia 1999, 184-185.Petrone, Fattore, Monetti 2002 - P.P. Petrone, L. Fattore, V. Monetti, Alimentazione e malattie ad Ercolano, in Vesuvio 79 A.D. 2002, 75-83.Petrone, Fedele 1996 - P.P. Petrone, F. Fedele, Un’eruzione di 4000 anni fa, in Le Scienze 56, 1996, 22-23.Poccetti 1979 - P. Poccetti, Nuovi documenti epigrafi ci italici a complemento del manuale di E. Vetter, Pisa 1979.Poseidonia-Paestum 1987 - Poseidonia-Paestum, Atti del XXVII Convegno di studi sulla Magna Grecia, (Taranto- Paestum, 9-15 ottobre 1987), Taranto-Napoli 1988.Prayon 1975 - F. Prayon, Frühetruskische Grab- und Hausarchitektur, Heidelberg 1975.
353La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Proietti 1991-1992 - L.M. Proietti, Pontelatone (Caserta), località Ceravarecce. Resti di un complesso artigianale di età romana, in BA 11-12, 1991-1992, 151-153.Proietti 1993 - L. Proietti, Le ville rustiche del territorio. Alcuni esempi, in Prospettive di memoria 1993, 00-00.Prosdocimi 1989 - A. Prosdocimi, Le religioni degli Italici, in Italia omnium terrarum parens 1989, 477-545.Prospettive di memoria 1993 - Prospettive di memoria. Testimonianze archeologiche dalla città e dal territorio di Sinuessa, a cura di L. Crimaco, G. Gasperetti, Gaeta 1993.Pucci 1985 - G. Pucci, Schiavitù romana nelle campagne. Il sistema della villa nell’Italia centrale, in Settefi nestre 1985, I, 15-21.Pyrgi 1970 - Pyrgi. Scavi del santuario etrusco (1959-1967), NSc 24, 1970 (II Suppl.), Roma 1970.Pyrgi 1992 - Pyrgi. Scavi nel santuario etrusco (1969-1971), NSc 42-43, 1988-1989 (II Suppl.), Roma 1992.Quilici 1990 - L. Quilici, Le strade. Viabilità tra Roma e Lazio, Roma 1990.Quilici 1994 - L. Quilici, Centuriazione e paesaggio agrario nell’Italia centrale, in Landuse in the Roman empire, ed. J. Carlsen, P. Ørsted, J.E. Skydsgaard, Rome 1994, 127-133.Quilici Gigli 1970 - S. Quilici Gigli, La valle del Sacco nel quadro delle comunicazioni tra Etruria e Magna Grecia, in StEtr 37, 1970, 363-366.Quilici Gigli 1986 - S. Quilici Gigli, Scali e traghetti sul Tevere in epoca arcaica, in Il Tevere e le altre vie d’acqua 1986, 71-89.Quilici Gigli 1992 - S. Quilici Gigli, Opere di bonifi ca in relazione a tracciati viarii, in Tecnica stradale romana 1992, 73-81.Radke 1973 [1981] - G. Radke, Viae publicae Romanae, in RE, suppl. XIII, 1973; Bologna 1981.Radke 1981 - G. Radke, Viae publicae Romanae, trad. it., Bologna 1981.Reinhold 1972 - J.G. Reinhold, Phytate concentration of leavened and unleavened Iranian breads, in Ecology of food and nutrition 1, 1972, 187-192.Ridgway 1974 - D. Ridgway, Rapporti dell’Etruria meridionale con la Campania: prolegomena pithecusana, in Aspetti e problemi dell’Etruria interna, Atti dell’VIII Convegno di studi etrusco-italici (Orvieto, 27-30 giugno 1972), Firenze 1974, 281-292.Rescigno 1998 - C. Rescigno, Tetti Campani, Roma 1998.Rescigno 2003 - C. Rescigno, Antefi sse a testa giovanile dal Museo Provinciale Campano, in Santuari e luoghi di culto 2003, 221-231.Rigillo Troncone, De Rosa 1993 - M. Rigillo Troncone, S. De Rosa, Analisi ambientale di una laguna litoranea campana. Il Lago Patria, in Inquinamento 7-8, 1993, 46-45.Rizzello 1980 - M. Rizzello, I santuari della Media Valle del Liri IV-I sec. a.C., Sora 1980.Rocco 1951 - A. Rocco, Oggetti fi ttili votivi provenienti da San Potito Sannitico, in Samnium 24, 3, 1951, 133-136. Rocco 1952 - A. Rocco, La dedica ad Eracle Gallico in un’iscrizione del territorio dell’antico Sannio, in Samnium 25, 1, 1952, 53-55. Rolfo 1999 - P. Rolfo, Realizzazione del calco in vetroresina della donna, in Un’eruzione vesuviana 1999, 73-75.Rolley 1987 - C. Rolley, La sculture de Poseidonia, in Poseidonia-Paestum 1987, 191-215.Romanelli 1938 - P. Romanelli, Le pitture della tomba “della caccia e pesca”, (Monumenti della pittura antica scoperti in Italia), Roma 1938.Romanelli 1986 - R. Romanelli, Necropoli dell’Etruria rupestre. Architettura, Viterbo 1986.Romeo 1999 - E. Romeo, Il restauro Ottocentesco di Alife come esempio di città ideale restaurata, in Falsi restauri. Trasformazioni architettoniche e urbane nell’Ottocento in Campania, a cura di S. Casiello, Bari 1999, 97-109.Romito 1995 - M. Romito, I cinturoni sannitici, Napoli 1995.Ruggi d’Aragona, Sampaolo 2003 - M. R. Ruggi d’Aragona, V. Sampaolo, L’Appia dal Garigliano al Volturno, in La Via Appia. Iniziative e interventi per la valorizzazione da Roma a Capua (Atlante tematico di topografi a antica, 11), Roma 2003, 00-00.Ruggiero 1888 - M. Ruggiero, Scavi di antichità nelle provincie di Terraferma dell’antico Regno di Napoli dal 1743 al 1876, Napoli 1888.Russo 1989 - F. Russo, La difesa costiera del Regno di Napoli dal XVI al XIX sec., Roma 1989.Russo Tagliente 1995 - A. Russo Tagliente, Armento. Archeologia di un centro indigeno (BA 35-36, 1995), Roma 2000.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 354
S. Angelo di Ravecanina 2001 - S. Angelo di Ravecanina. Un insediamento Medievale nel Sannio Alifano, a cura di L. Di Cosmo (Quaderni Campano-Sannitici, 2), Piedimonte Matese 2001.Safi nim 2004 - Safi nim. Studi in onore di Adriano La Regina per il premio “I Sanniti”, a cura di D. Caiazza, Piedimonte Matese 2004. Salmon 1969 - E.T. Salmon, Roman colonization under the Republic, London 1969.Salmon 1985 - E.T. Salmon, Samnium and the Samnites, Cambridge 1967, trad. it. Torino 1985. Samnium 1991 - Samnium. Archeologia del Molise, Catalogo della mostra, a cura di S. Capini, A. Di Niro, Roma 1991 Sampaolo, Grassi 2006 - V. Sampaolo, B. Grassi,000000000000, in Deliciae Fictiles 2006, 000-000.Sannibale 1998 - M. Sannibale, Le armi della Collezione Gorga al Museo Nazionale Romano, Roma 1998.Sannio Pentro Alifano 2001 - D. Loffreda, Sannio Pentro Alifano, Napoli 2001.Sannio, Pentri e Frentani 1980-1981 - Sannio, Pentri e Frentani dal VI al I sec. a.C., Catalogo della mostra, Roma-Napoli 1980-1981. Sannio, Pentri e Frentani 1984 - Sannio, Pentri e Frentani dal VI al I sec. a.C., Atti del Convegno (Campobasso, 10-11 novembre 1980), Campobasso 1984. Santoro 1967 - L. Santoro, Le torri costiere della Campania, in Napoli Nobilissima 4, 1967, 38-49.Santoro 1990 - L. Santoro, Case-torri del Cinquecento nel Vicereame di Napoli, in Napoli Nobilissima 29, 1990, 11-16.Santuari d’Etruria 1985 - Santuari d’Etruria, Catalogo della mostra (Arezzo), a cura di G. Colonna, Milano 1985.Santuari e luoghi di culto 2003 - Santuari e luoghi di culto nell’Italia antica (Atlante tematico di topografi a antica, 12), a cura di L. Quilici, S. Quilici Gigli, Roma 2003.Schmiedt 1989 - G. Schmiedt, Atlante aerofotografi co delle sedi umane in Italia, III. La centuriazione romana, Firenze 1989.Scott 1992 - R.T. Scott, The decorations from the Temples of Cosa, in La coroplastica templare etrusca fra il IV e il III secolo a.C., Atti del XVI Convegno di studi etruschi (Orbetello 1988), Firenze 1992, 91-98.Settefi nestre 1985 - Settefi nestre. I-III, Una villa schiavistica nell’Etruria Romana, a cura di A. Cardini, A. Ricci, Modena 1985.Sguaitamatti 1984 - M. Sguaitamatti, L’offrante de porcelet dans la coroplatie gélénne. Etude typologique, Mainz 1984.Sherwin White 1973 - A.N. Sherwin White, The Roman citizenship, Oxford 1973. Sigurdsson et al. 1985 - ?. Sigurdsson, ?. Carey, ?. Cornell, ?. Pescatore, XXXXXXXXX 1985, 00-00.Sillen-Kanavagh 1982 - M. Sillen-Kanavagh, Strontium and paleodietary research: a review, in AJPhA 25, 1982, 67-90.Sirano 2004 a - F. Sirano, Presentazione e sintesi sui ritrovamenti avvenuti nel corso dei lavori del consorzio di bonifi ca del Sannio Alifano, in Ager Allifanus 2004, 21-31.Sirano 2004 b - F. Sirano, Dalla conclusione delle guerre sannitiche alla colonia. La piana di Alife nel contesto della romanizzazione tra Sannio e Campania, in Ager Allifanus 2004, 59-73. Sirano 2006 a - F. Sirano, Sistemi di copertura campani di età arcaica da Teanum Sidicinum. Contesti e architetture, in Deliciae Fictiles 2006, 331-348.Sirano 2006 b - F. Sirano, Il museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum, Napoli 2006.Sirano 2006 c - F. Sirano, Le terrecotte da Teanum Sidicinum come segno di identità culturale, in Ritratti rituali , Catalogo della mostra (Napoli- Roma), Milano 2006, 68-77. Società romana e produzione schiavistica 1981 - Società romana e produzione schiavistica, I, L’Italia: insediamenti e forme economiche, a cura di A. Giardina, A. Schiavone, Bari 1981.Società romana e produzione schiavistica 1981 a - Società romana e produzione schiavistica, II, Merci mercati e scambi nel Mediterraneo, a cura di A. Giardina, A. Schiavone, Bari 1981Solin 1993 - H. Solin, Le iscrizioni antiche di Trebula, Caiatia e Cubulteria, Caserta 1993.Sommella 1971 - P. Sommella, Per uno studio degli insediamenti nelle valli del Sacco e del Liri in età preromana, in StEtr 39, 1971, 393-407.Sommella 1978 - P. Sommella, Città romane in Italia: tipologia e inquadramento storico, in Le città di fondazione, Atti del II Convegno internazionale di storia urbanistica (Lucca, 1977), Lucca-Venezia 1978, 13-25.Sommella 1979 - P. Sommella, Finalità e metodi della lettura storica in centri a continuità di vita, in AMediev 6, 1979, 105-128.Sommella 1988 - P. Sommella, Italia antica. L’urbanistica romana, Roma 1988.
355La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Sommella 1991 - P. Sommella, Città e territorio nella Campania antica, in Storia e civiltà della Campania 1991, 151-191.Soricelli 1994 - G. Soricelli, Terra sigillata della prima, media e tarda età imperiale, in Il complesso archeologico di Carminiello ai Mannesi, Napoli (Scavi 1983-1984), a cura di P. Arthur, Galatina 1994, 109-168Spazio del rito 2005 - Lo spazio del rito. Santuari e culti in Italia meridionale tra indigeni e greci, Atti delle Giornate di studio (Matera, 28-29 giugno 2002) (Siris, Suppl. I), a cura di M.L. Nava, M. Osanna, Bari 2005.Staccioli 1973 - R.A. Staccioli, Sulla destinazione e l’uso dei criptoporitici, in Les cryptoportiques 1973, 57-66.Stefani 2000 - G. Stefani, Una particolare iconografi a pompeiana: Bona dea a banchetto, in Ostraka 9, 2, 2000, 419-443.Steingräber 1981 - S. Steingräber, Etrurien. Städte, Heiligtümer, Nekropolen, München 1981.Steingräber 1985 - S. Steingräber, Catalogo ragionato della pittura etrusca, Milano 1985.Steingräber 2000 - S. Steingräber, Arpi, Apulien, Makedonien. Studien zum unteritalischen Grabwesen in hellenistischer Zeit, Mainz 2000.Stopponi 1968 - S. Stopponi, ????????????? etruschi, in BdA 53, 1968, 60-62.Stopponi 1983 - S. Stopponi, La tomba della scrofa nera, Roma 1983.Storia di Roma 1990 - Storia di Roma, II.1 L’Impero mediterraneo. La Repubblica, a cura di G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba, Torino 1990.Storia e civiltà della Campania 1991 - Storia e civiltà della Campania, I. L’evo antico, a cura di G. Pugliese Carratelli, Napoli 1991.Svanera 2001 - S. Svanera, Kernoi da Teano, in RIA 54 (s. 3, 22), 1999, 7-22.Tagliamonte 2001 - G. Tagliamonte, Frammenti di archeologia Matesina, in Sannio Pentro Alifano 2001, VII-XVII.Tagliamonte 2004 - G. Tagliamonte, L’età preromana e sannitica. Le necropoli preromane nell’ambito della cultura sannitica nel territorio Alifano, in Ager Allifanus 2004, 47-58. Tagliamone 2004 a - G. Tagliamonte, Processi di strutturazione e di autoidentifi cazione etnica. Il caso dei Sanniti, in Safi nim 2004, 133-151.Tagliamonte 2005 - G. Tagliamonte, I Sanniti. Caudini, Irpini, Pentri, Carricini, Frentani, Milano 20052Tagliamonte, Esposito 2002 - G. Tagliamonte, R. Esposito, Nuovi dati sulla fortifi cazione medievale di Alife, in In fi nibus Alifanis 2002, 183-191.Tagliamonte, Miele 2002 - G. Tagliamonte, F. Miele, L’Ager Allifanus, in Ager Campanus 2002, 191-199.Tagliente 2005 - M. Tagliente, Il santuario lucano di San Chirico Nuovo (PZ), in Spazio del rito 2005, 115-123.Talamo 1987 - P.F. Talamo, L’area aurunca nel quadro dell’Italia centromeridionale. Testimonianze archeologiche di età arcaica (British archaeological reports. International Series, 384), Oxford 1987.Talamo 2004 - P.F. Talamo, Nuove scoperte di età Eneolitica e del Bronzo nell’ambito della preistoria del territorio Alifano, in Ager Allifanus 2004, 33-45. Taylor 2002 - R. Taylor, Temples and terracottas at Cosa, in AJA 106, 2002, 59-83.Tchernia 1986 - A. Tchernia, Le vin de l’Italie romaine, Roma 1986.Tecnica stradale romana 1992 - Tecnica stradale romana, Atti dell’Incontro di studio (Bologna 1991), a cura di L. Quilici, S. Quilici Gigli, (Atlante tematico di topografi a antica, 1), Roma 1992Tinè Bertocchi 1971 - F. Tinè Bertocchi, Scavi a San Pietro di Albisola (antica Alba Docilia), in RIngIntem 26, 1971, 64-66.Tinè Bertocchi 1976 - F. Tinè Bertocchi, Albisola, in Archeologia in Liguria. Scavi e scoperte 1967-1975, Genova 1976, 113-122.Tinè Bertocchi 1978 - F. Tinè Bertocchi, Alba Docilia (Albisola), in Restauri in Liguria, Catalogo della mostra, Genova 1978, 00-00.Tocco Sciarelli 1977 - G. Tocco Sciarelli, L’anfi teatro di Alife, in AnnAssStMedioVolturno 5, 1977, 301-00. Tocco Sciarelli 1984 - G. Tocco Sciarelli, in E. Pozzi, L’attività della Soprintendenza Archeologica nelle province di Napoli e Caserta – 1983, in Crotone, Atti del XXII Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 7-10 ottobre 1983), Napoli-Taranto 1984, 473-506.Tocco Sciarelli 1984 - G. Tocco Sciarelli, Alife, in BTCG III, Pisa-Roma 1984, 173-184.Toneatto 1994-1995 - L. Toneatto, Codices Artis Mensoriae. I manoscritti degli antichi opuscoli latini d’agrimensura (V-XIX sec.), I-III, Spoleto 1994-1995.Torelli 1984 - M. Torelli, Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio tra archeologia e storia, Roma 1984.Torelli 1987 - M. Torelli, Paestum romana, in Poseidonia-Paestum 1987, 33-115.
In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 356
Torelli 1990 a - M. Torelli, La formazione della villa, in Storia di Roma 1990, 123-132. Torelli 1990 b - M. Torelli, Il modello urbano e l’immagine della città, in Civiltà dei Romani 1990, 43-64.Torelli 1996 - M. Torelli, La romanizzazione del Sannio, in La Tavola di Agnone nel contesto italico, Atti del Convegno di studi (Agnone, 13-15 aprile 1994), Firenze 1996, 27-44.Torriero 1987 - G. Torriero, L’architettura religiosa, in Guadagno 1987, 85-96.Tortorella 1998 - S. Tortorella, La sigillata africana nel VI e nel VII secolo d.C.: problemi di cronologia e distribuzione, in Ceramica in Italia 1998, 41-70.Toynbee 1993 - J.M.C. Toynbee, Morte e sepoltura nel mondo romano, Londra 1971, trad. it., Roma 1993.Tra Orvieto e Vulci 2003 - Tra Orvieto e Vulci, Atti del X Convegno internazionale sulla storia e l’archeologia dell’Etruria (Annali Faina, 10), Roma 2003Trendall 1967 - A.D. Trendall, The red-fi gured vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford 1967.Trotta 1991 - F. Trotta, I culti non greci e i culti greci in epoca sannitica e romana, in Storia e civiltà della Campania 1991, 271-291.Trutat 1879 - E. Trutat, La photographie appliqué à l’archéologie, Paris 1879.Trutta 1776 - G. Trutta, Dissertazioni istoriche dell’antichità alifane, Napoli 1776.Trutta 1776 [1976] - G.F. Trutta, Dissertazioni istoriche delle antichità Alifane, Napoli 1776, rist. anast., Alife 1976. Un’eruzione vesuviana 1999 - Un’eruzione vesuviana di 4000 anni fa, a cura di F. Fedele, P.P. Petrone, Napoli 1999.Vagnetti 1971 - L. Vagnetti, Il deposito votivo di Campetti a Veio, Firenze 1971.Valenti 0000 - M. Valenti, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, in XXXXXXXXXXXXXXX, 00-000.Vallat 1981 - J.-P. Vallat, Centuriazione, assegnazioni, regime della terra in Campania alla fi ne della repubblica e all’inizio dell’Impero, in Società romana e produzione schiavistica 1981, 289-297. Vallat 1983 a - J.-P. Vallat, Ager publicus, colonies et territoire agraire en Campanie du Nord à l’époque républicaine, in Cadastres et espace rural. Approches et réalités antiques, Actes de la Table ronde (Besançon, mai 1980), éd. M. Clavel-Lévèque, Paris 1983, 187-193.Vallat 1983 b - J.P. Vallat, Architecture rurale en Campanie septentrionale di IV siècle av. J.-C. au I ap. J.-C., in Architecture et sociéte de l’archaisme grec à la fi n de la rèpublique romaine, Actes du Colloque International organisé par le Centre Nationale de Recherche Scientifi que et l’Ecole française de Rome (Coll. EFR, 66), Roma 1983, 72-89.Valletrisco 1977 - A. Valletrisco, Note sulla topografi a di Suessa Aurunca, in RendNap 52, 1977, 59-73.Veio, Cerveteri, Vulci 2001 - Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, Catalogo della mostra (Roma, 1 ottobre-30 dicembre), a cura di A.M. Sgubini Moretti, Roma 2001Verzár-Bass 1991 - M. Verzár-Bass, Il teatro romano di Trieste, Roma 1991.Vesuvio 79 A.D. 2002 - Vesuvio 79 A.D. Vita e morte ad Ercolano, a cura di F. Fedele, P.P. Petrone, Napoli 2002Vighi 1935 - R. Vighi, Veio - Scavi nella necropoli, degli alunni dell’anno 1927-1928 del corso di Topografi a dell’Italia Antica dell’Università di Roma, in NSc 11, 1935, 39-00.Villa D’Amelio 1963 - P. Villa D’Amelio, San Giuliano - Scavi e scoperte nella necropoli dal 1957 al 1959, in NSc 17, 1963, 6-12.Villani 1993 - R.U. Villani, La terra dei Sanniti Pentri, Curti 1993.Villucci 1981 - A.M.Villucci, Presenze romane nel territorio di Sinuessa e Suessa Aurunca, in Primo Convegno dei Gruppi Archeologici della Campania, (Pozzuoli 19-20 aprile 1980), Roma 1981, 156-162.Villucci 1995 - A. M. Villucci, Sessa Aurunca storia ed arte, Minturno 1995.von Duhn 1896 - F. von Duhn, Delineazione di una storia della Campania preromana secondo i risultati delle più recenti scoperte archeologiche, in RivStAnt 1, 3, 1896, 49-00. von Duhn 1924 - F. von Duhn, Italische Graberkunde, I, Heidelberg 1924. von Hesberg 1994 - H. von Hesberg, Monumenta. I sepolcri romani e la loro architettura, trad. it., Milano 1994.Xavis 1949 - C.G. Yavis, Greek altars. Origins and typology, Saint Louis, Missouri 1949.Ward Perkins, Staccioli 1963 - J. Ward Perkins, R.A. Staccioli, Veio (Isola Farnese). Scavi in una necropoli villanoviana in località “Quattro Fontanili”, in NSc 17, 1963, 85-86.Weber 1976 - T. Weber, Bronzekannen, Frankfurt am Main-Bern 1976.Weege 1909 - F. Weege, Oskische Grabmalerei, in JdI 24, 1909, 69-162.Wells 1960 - C. Wells, A study on cremation, in Antiquity 34, 1960, 29-37.Whitehouse et al. 1982 - D.B. Whitehouse, G. Barker, R. Reece, The Schola Praeconum I, The coins, pottery, lamps and fauna, in BSR 50, 53-101.
357La via Domitiana antica nel territorio di Liternum
Woods 1986 - R.J. Woods, Biomechanics and degenerative joint disease in humans, gorillas and chimpanzees, M.A. Thesis, Kent State University 1986.Zaccagni 1978 - P. Zaccagni, Gabii. La città antica e il territorio, in Archeologia Laziale 1. Incontro di studio del Comitato per l’archeologia laziale, (QuadAEI, 1), Roma1978, 42-46.Zannini 1997 - U. Zannini, San Martino eremita. Vita e culto di un santo attraverso le falsifi cazioni medievali, in U. Zannini, G. Guadagno, S. Martino e S. Bernardo, Minturno 1997, 15-45.Zannini 2001 - U. Zannini, Indagini storico-archeologiche in Campania settentrionale: il territorio di Falciano del Massico, Caserta 2001.Zevi 1980 - F. Zevi, Le attività della Soprintendenza di Napoli e Caserta nel 1980, in Siris e l’infl uenza ionica in Occidente, Atti del XX Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 12-17 ottobre 1980), Taranto 1981, 257-272.Zevi 1981 - F. Zevi, Le attività della Soprintendenza di Napoli e Caserta nel 1981, in Megále Hellás. Nome e immagine, Atti del XXI Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 2-5 ottobre 1981), Taranto 1982, 325-358.Zevi 2004 - F. Zevi, L’attività archeologica della Soprintendenza di Napoli e Caserta nel 2003, in Alessandro il Molosso e i condottieri in Magna Grecia, Atti del XLIII Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto - Cosenza, 26 - 30 settembre 2003), Napoli 2004, 853-923.