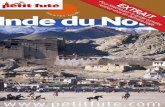Venti anni di ricerche archeometallurgiche in Italia del nord (2012)
-
Upload
multiagent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Venti anni di ricerche archeometallurgiche in Italia del nord (2012)
ACTA MINERARIA ET METALLURGICAStudi in onore di Marco Tizzoni
a cura di
COSTANZA CUCINI
Comune di Bergamo
4
Periodico di Archeologia del Civico Museo Archeologico di Bergamofondato da Stefania Casini
Tutti i diritti riservatiComune di Bergamo, Museo Archeologico
La responsabilità di quanto riportato nel testo, nonché di eventuali errori e omissioni,rimane esclusivamente degli Autori.
Autorizzazione del Tribunale di Bergamo, n. 32 del 27.11.1993
Direttore responsabile: Stefania Casini
Segreteria di redazione: Cristina Longhi
Sede: Civico Museo Archeologico di Bergamo, piazza Cittadella 9, 24129 BergamoProprietà: Comune di BergamoStampato da: Grafo s.r.l., Palazzago, Bergamo - novembre 2012
ISSN: 1127-2155
5
SOMMARIO
Marco TizzoniMaila Chiaravalle - Chiara Rota p. 7
À Marco fragments de souvenirs 1990-2010Michel Mangin avec la collaboration de Maryse Mangin » 17
MINIERE E METALLURGIA: STUDI REGIONALI
Attività mineraria e metallurgica nell’Italia centrale durante l’età del rameDaniela Cocchi Genik » 27
Venti anni di ricerche archeometallurgiche in Italia del nordCostanza Cucini » 39
La sidérurgie ancienne dans la région de Franche-Comté:trente années de recherches pluridisciplinaires sur la réductiondirecte dans l’Est de la France (1981-2011)Hervé Laurent - Sylvie Laurent Corsini - Michel Mangin » 57
Vingt années de recherches sur la sidérurgie ancienne dans le Jura:les vestiges de l’Âge du Fer et de l’Époque romaineLudwig Eschenlohr » 79
The production of ferrum Noricum.Largescale Roman iron production in Hüttenberg (Austria)Brigitte Cech » 91
The role of Celts in popularising iron smelting in the Polish territoriesSzymon Orzechowski » 107
Characterising vegetation changes in former mining and metalworking areasduring prehistoric and Roman timesTim Mighall - Simon Timberlake - Frank M. Chambers - William O’Brien » 117
Les Pyrénées, terre d’élection de la réduction directedu minerai de fer (XVIIe-XIXe siècles)?Jean Cantelaube » 131
L’exploitation et la réduction du fer à haute altitude dans les Alpesdu Sud-Ouest: Massifs du Mercantour et de l’Ubaye(Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, France)Patrick Rosenthal - Denis Morin » 159
ARCHEOMETALLURGIA: CONTESTI E ANALISI
Riflessioni sulla metallurgia fenicia dell’argento nella Penisola IbericaMartina Renzi - Salvador Rovira-Llorens - Ignacio Montero Ruiz » 185
An archaeological and archaeometrical approach of ferrous semi-product:tipology, quality and circulationPhilippe Fluzin - Marion Berranger - Sylvain Bauvais - Gaspard Pagès - Philippe Dillmann » 195
6
Un’officina di bronzista e la produzione di ottone e di specchia Mediolanum nel I-II secolo d.C.Anna Ceresa Mori - Costanza Cucini » 205
La riduzione del rame in Val Lanterna (Sondrio) nella prima età del Ferro:studio petrografico delle scorie silicaticheCostanza Cucini - Bruno Messiga- Gisella Rebay - Maria Pia Riccardi » 225
ARCHEOLOGIA, STORIA E ARTE
Le figure di armi della roccia 23 di Foppe di Nadro (Valcamonica):elementi per la cronologia delle incisioni dell’età del BronzoStefania Casini » 243
Note sulla gestione politica della produzione minerariadell’Italia settentrionale (secoli XII-XIV)Patrizia Mainoni » 255
L’uso della polvere da sparo nelle miniere lombarde d’età moderna(con un documento)RaffaelloVergani » 265
In viaggio da Londra a GlasgowAlba Osimo » 271
Altoforni, castelli e miniere nell’Orfeo e Euridice di TizianoOrietta Pinessi » 277
39
Venti anni di ricerche archeometallurgiche in Italia del nordCostanza Cucini
Introduzione
A oltre dieci anni dalla prima redazione di un bilancio delle conoscenze, ci sembra sia giunto ilmomento di fare di nuovo il punto sullo stato della ricerca archeometallurgica in Lombardia1.Come si è già avuto modo di precisare “in corso d’opera”, l’approccio scelto da me e MarcoTizzoni è stato pluridisciplinare, a 360 gradi: studio ed edizione di migliaia di documenti d’archivioinediti, prospezioni sul campo, studio geologico dei giacimenti minerari, studio delle tecniche diestrazione mineraria, analisi dei minerali, scavi archeologici in quota, analisi di scorie e scartimetallurgici da siti produttivi, analisi polliniche e paleobotaniche. Il tutto in un territorio aspro emontano, spesso ad altitudini elevate, la cui esplorazione è durissima; tuttavia, per l’archeologiamineraria nulla può sostituire il controllo diretto sul terreno2. E solo ad alta quota e in zoneimpervie di montagna è ancora possibile rintracciare miniere antiche senza successivi, distruttivisfruttamenti, e antichi impianti metallurgici. Abbiamo così avuto l’opportunità di trovare siti dieccezionale interesse in straordinario stato di conservazione, in zone remote e quasi inaccessibili,dove spesso si era perduta del tutto anche la memoria di passate attività estrattive e metallurgiche.
Nella zona alpina italiana, ed in misura minore anche negli Appennini settentrionali, vi sononumerosi giacimenti di minerali ferrosi. Ricchezza non paragonabile a quella dei giacimentid’oltralpe, certo, tuttavia apprezzabile e storicamente importante. In particolare, i giacimenti diferro del tipo “Alpi lombarde”, contenenti un’alta percentuale di manganese, hanno svolto unruolo eccezionale nello sviluppo tecnologico dell’area e nella precoce invenzione dell’altoforno.Molto meno ingenti sono invece i giacimenti di minerali non ferrosi.
In questi venti anni di ricerche abbiamo potuto datare per la prima volta in modo scientificonumerose miniere e impianti metallurgici. Le sorprese non sono mancate, anzi: tecniche di estrazionemineraria apparentemente arcaiche sono risultate databili al basso Medioevo, mentre sofisticatisfruttamenti effettuati con un’ottica moderna sono da riferire alla preistoria. Abbiamo dovutosfatare leggende consolidate, ma ancora dure a morire, schivato erronee impostazioni storiografichee false problematiche che hanno spesso fuorviato la ricerca. Di conseguenza, molti dei tradizionalischemi evolutivi e storiografici sono saltati, lasciando spazio a sorprendenti quanto inattese conclusioni.
L’età preromana
I giacimenti di rame non sono molto abbondanti nelle Alpi lombarde, tuttavia – comesottolinearono i metallurgisti dell’Ottocento – le parti superficiali dei filoni di ferro della zonacontenevano rame nativo e solfuri di rame anche in concentrazioni apprezzabili, nonché di facilesfruttamento. Per questo motivo è stato possibile documentare una facies di attività minerarie emetallurgiche concernenti questo metallo risalenti alla Prima Età del Ferro.
I siti si trovano tutti ad alta quota e sono ubicati nelle valli Lanterna e Grigna, diramazioni
Notizie Archeologiche Bergomensi, 20, 2012, pp. 39-56ISSN: 1127-2155
1) CUCINI TIZZONI 2001. In questa sede passeremo inrassegna solo le aree indagate da chi scrive, insieme a MarcoTizzoni, senza nessuna pretesa di completezza. Inoltre, perragioni di spazio, ci limiteremo al ferro e al rame: le miniere ela metallurgia dell’argento meritano un discorso a parte, cheesula però dai confini di questo studio.
2) Talvolta cavità di origine naturale sono state interpretatecome scavi minerari e viceversa.
40
laterali rispettivamente della Val Malenco e della Val Camonica3 (fig. 1).Le miniere di Silter di Campolungo-Baita Cludona di Fondo, sulla riva sinistra del torrente
Grigna (1493-1800 m s.l.m.)4, sfruttarono uno dei maggiori giacimenti di rame della Lombardia; ifiloni di quarzo con calcopirite, tracce di tetraedrite e sfalerite contengono anche elettro e non sipuò dunque escludere che vi fosse una zona di arricchimento di minerali auriferi nella partesuperficiale del giacimento. A Cludona di Fondo, ubicata su un terrazzo fluviale quasi pianeggiante,i lunghi filoni paralleli erano ben visibili in superficie e furono sfruttati tramite scavi minerarisuccessivi discendenti a partire dall’affioramento. Lo scavo interessò soltanto la mineralizzazionee la ganga, senza toccare la roccia incassante. La profondità di queste strette coltivazioni è misurabilesino a 12 m, ma nel sottosuolo i lavori dovevano essere congiunti da gallerie ora ostruite einaccessibili, che permettevano l’aerazione degli scavi. Gli antichi minatori lavorarono per molte stagioni;le depressioni oggi visibili sul terreno corrispondono ai resti di diversi pozzi di estrazione disposti conregolarità: lo sfruttamento era quindi organizzato in modo razionale direttamente sul versante.
La miniera di Campolungo, datata col C14 dalla prima metà dell’VIII agli inizi del IV sec. a.C.5,ci ha posto di fronte ad una problematica molto complessa6, ma è stato possibile ricostruirne conprecisione la dinamica di sfruttamento. Dopo aver individuato in superficie i filoni mineralizzatisul versante dirupato lungo il torrente Grigna, gli antichi minatori asportarono la pietraia che loricopriva e lo lavarono deviando l’acqua della soprastante torbiera (hushing); in questo modo lamineralizzazione dovette risultare ben evidente in superficie. L’attività mineraria ebbe inizioattaccando i due filoni, uno più a monte molto ricco e l’altro poco potente a valle, verso il torrente;lo scavo a cielo aperto seguì i due filoni scavandoli col fuoco finché i lavori divennero più profondi,incontrando problemi di allagamento: a questo punto i minatori non avevano altra scelta cheproseguire lo sfruttamento in profondità, anche se la gestione dei lavori sotterranei in una rocciarelativamente dura, avendo come utensili solo picconi di quarzo, doveva essere problematica.Bisognava dunque stimare il tenore e l’importanza economica dei filoni mineralizzati: per l’epoca,una vera sfida! È evidente che gli antichi minatori di Campolungo dominavano perfettamente letecniche di estrazione, infatti pianificarono la realizzazione di una lunga galleria in traverso-banconella roccia sterile, a partire dalla falesia lungo il torrente. La traiettoria del traverso-banco tenneconto dell’asse dei filoni e della direzione degli strati della roccia incassante; la pendenza, chesegue uno strato di roccia più tenero e più facile da attaccare con cunei e leve, è debole, masufficiente a far scolare permanentemente il flusso d’acqua che allagava i lavori soprastanti.
A 51 m dall’entrata il traverso-banco incrociò il filone a valle, che venne attaccato con unagalleria orizzontale e un pozzo usando la tecnica col fuoco: a questo scopo fu necessario scavareuna stretta galleria d’aerazione per eliminare i fumi. Poi il traverso-banco proseguì e raggiunse ilfilone a monte a 85 m dall’entrata, per poi continuare alla ricerca di mineralizzazioni più profonde,finché a 115 m dall’entrata la galleria venne inondata da una corrente d’acqua. Alla fine, a 135 mdall’entrata, i minatori sfruttarono il filone a monte con una grossa coltivazione ed infine con unacoltivazione in rimonta. Qui non si è trovato alcun collegamento con la superficie.
I lavori in sotterraneo erano rischiarati da torce: abbiamo ritrovato centinaia di frammenti dikinspännen, bacchette di legno resinoso (abete bianco, Abies alba) che dovevano essere assemblatein fascette7. Il trasporto sotterraneo del minerale denota una grande innovazione: per la prima
3) I siti della lavorazione del rame ubicati in Val Lanterna sonooggetto di uno studio specifico in questo stesso volume, siveda il contributo di chi scrive con M. Riccardi, B. Messiga eG. Rebay. Sulla Val Grigna e la sua diramazione Val Gabbia siveda più avanti, nota 29.
4) Su queste miniere si rimanda all’ampio studio conclusivo inMORIN-TIZZONI 2009, con bibliografia e riferimenti.
5) Datazioni eseguite dai laboratori del British Museum: BM-3106datazione cal. 770-390 a.C., con un massimo di probabilità fra 770e 680 a.C.; BM-3054 datazione cal. 820-540 a.C. con un massimodi probabilità fra 700 e 540 a.C. I carboni di legno datati sono statiprelevati in depositi sigillati, che non lasciano alcun dubbiosull’antichità dei lavori. Le datazioni al C14 si riferiscono ai lavoriin sottosuolo, quelli a cielo aperto potrebbero essere più antichi.
6) Lo studio di questa miniera, che si sviluppa in totale in 187m di lavori sotterranei, ha richiesto tre campagne di esplorazionee rilevamento, lavori di pompaggio di zone allagate per accederealle parti profonde, imponenti lavori di disgaggio della galleriain traverso-banco che è stata in parte disostruita e il suo depositosetacciato accuratamente. L’esplorazione sotterranea si è svoltain condizioni spesso difficili e pericolose dovute alle pienerovinose del torrente Grigna, dato che l’unico ingresso attuale,quello del traverso-banco, si apre direttamente sulla falesia chene delimita il corso. Essa è stata realizzata grazie al lavorocongiunto delle équipe archeominerarie di M. Tizzoni e di D.Morin con l’appoggio dei tecnici francesi specializzati inspeleologia.
7) Per confronti e bibliografia MORIN-TIZZONI 2009, p. 122.
41
volta in Europa è documentato l’uso di slitte di legno ricavate da un mezzo tronco d’albero scavato.Un tale complesso minerario sviluppato in sottosuolo comportava una serie di installazioni
annesse di superficie. Davanti all’entrata del traverso-banco, il minerale estratto era lavato in unpiccolo bacino realizzato in un meandro artificiale tagliato nella roccia nel letto del torrente Grignae poi trasportato a breve distanza, sulla sponda opposta del corso d’acqua, nell’area adibita acernita, frantumazione e triturazione. Qui lo spazio di lavoro si svolgeva sotto un riparo e dovevaesservi un abitato temporaneo per gli operai, che lavoravano con mortai e martelli in pietra. Ilrinvenimento di poche scorie della riduzione del rame indica che forse qui avevano fatto solo delleprove di riduzione. In tutta la zona mineraria non si sono trovati veri e propri abitati, poichéimponenti frane hanno sconvolto l’area anche in tempi recenti. A Campolungo è stato calcolatoche la produzione del filone a monte sia stata di circa 400 tonnellate di minerale, cioè 100 tonnellatedi rame (se si assume un rendimento del 25%). Molto minore la produzione del filone a valle, circa80 tonnellate di minerale: non fu certo questo a spingere gli antichi minatori ad aprire un lungotraverso-banco e una galleria di aerazione nello sterile, lavori dispendiosi e improduttivi, difficilida mettere in opera, col rischio di mancare la congiunzione coi filoni nel sottosuolo. Se poi l’ipotesidella presenza in superficie di minerale aurifero è corretta, è ancor più chiara la motivazioneeconomica che sta alla base di questi enormi lavori.
Fig.1: Carta della Lombardia con l’indicazione delle valli alpine indagate e delle principali località citate nel testo. 1)Piani d’Erna; 2) Miniere del Varrone; 3) Miniere del passo di S. Marco; 4) Miniere del Manina; 5) Paludina
(Schilpario); 6) Val Grigna e Val Gabbia (Bienno).
42
Come si vede, siamo di fronte a strutture minerarie eccezionali dal punto di vista tecnico, a cuisottende una complessa organizzazione. Dopo i primi lavori sugli affioramenti dei filoni, venneadottato un piano di sfruttamento in sotterraneo che venne seguito e coordinato per almeno due-trecento anni, allo scopo di raggiungere un filone in profondità e sfruttarlo nel modo più razionalepossibile. Ciò sottintende conoscenze di topografia sotterranea rimarchevoli per un’epoca cosìremota. La galleria in traverso-banco fu tracciata con calcoli e processi di misurazione elaborati edi grande precisione, nonché una affinata conoscenza del contesto geologico e geomorfologico. Ilconcetto stesso di galleria in traverso-banco fa qui la sua prima apparizione in Europa.
A Cludona di Fondo e a Campolungo i minatori preistorici seppero adattarsi alle differentisituazioni ed elaborare strategie differenziate di sfruttamento. Per poter funzionare per alcunisecoli8, le attività estrattive dovevano essere ben coordinate con le attività complementari connesse:ubicazione spazialmente razionale delle enormi discariche, taglio e preparazione della legna perimpalcature, slitte e torce, trasporto del minerale negli atelier di fondovalle e trasporto alla minieradelle derrate agricole e di tutto il necessario per gli addetti, realizzazione di infrastrutture idrauliche– deviazione del torrente, lavaggio dei versanti, e così via9. Com’è noto, l’estrazione mineraria èun’attività tradizionalmente a rischio e, soprattutto nelle fasi iniziali dello sfruttamento, esige unenorme investimento di risorse e mezzi dando un rendimento minimo. Un sistema integrato ditale ampiezza, in cui convivono minatori sulla montagna e manodopera specializzata nella metallurgiaa valle, implica l’esistenza di un potere centralizzato, forse ad un livello tribale molto gerarchizzato,dotato di infrastrutture economiche e capacità organizzative sviluppate, analogo a quelli dellazona culturale hallstattiana. Un potere politico e militare era indispensabile anche per far sì che leattività estrattive e metallurgiche si svolgessero in un ambito protetto.
Sia a Campolungo, sia nelle vicine località di Sesa e Ponte di Val Gabbia III, presso Piazzalunga,sono state rinvenute piccole concentrazioni di scorie di rame con caratteristiche peculiari einconfondibili, analoghe a quelle prodotte negli impianti di riduzione della Prima Età del Ferrodella Val Lanterna, circa 60 km più a nord.
Tuttavia, mentre a Campolungo-Cludona di Fondo si deve pensare ad un’intera comunità conalle spalle una struttura organizzativa complessa dotata di un apposito ordinamento gerarchico edi un capitale, nei siti della Val Lanterna siamo di fronte a precari accampamenti stagionali dipiccole squadre di persone che eseguivano tutte le operazioni, dallo sfruttamento “di rapina” deifiloni mineralizzati alla produzione di matta di rame. In ogni caso, è evidente che il metallo per laproduzione di beni di lusso della cultura di Golasecca poteva provenire almeno in parte da qui.
Dalle Alpi meridionali centrali ci spostiamo sul Mediterraneo e in un contesto protourbano:Genova10. Qui, nell’oppidum preromano sulla collina di Castello, sono state documentate attivitàmetallurgiche a partire dalla prima metà del V sec. a.C. in S. Maria in Passione e dal 450 a.C. in S.Silvestro. In entrambi i contesti11 siamo in presenza di scorie di forgia, per lo più a calotta piano-convessa, riferibili prevalentemente all’ultima fase siderurgica, quella dell’elaborazione di oggettifiniti; in S. Maria in Passione alcuni scarti potrebbero essere stati prodotti nel corso dell’affinazionedei blumi sul focolare di forgia. Nessuna traccia della prima riduzione del minerale grezzo di ferroè stata rinvenuta. Viene dunque a cadere l’interpretazione tradizionale, talora assunta acriticamentequasi come un assioma, secondo la quale nell’oppidum genuate si sarebbero svolte attività di riduzionedel minerale grezzo di ferro dell’isola d’Elba12. Anche la struttura di S. Silvestro interpretata a suo
8) Oltre allo studio della miniera, la durata dell’attività estrattivaè dimostrata dai diagrammi pollinici, MIGHALL et Al. 2003;essa ebbe poche conseguenze per la vegetazione.
9) Uno sfruttamento analogo dovette interessare anche la partesuperficiale della grande miniera di ferro di Piazzalunga, circa7 km a N-O di Campolungo, tuttavia la millenaria coltivazioneper l’estrazione del ferro ha cancellato ogni traccia più antica,si veda più avanti, nota 29.
10) I dati provengono dagli scavi degli anni ’70-’80 condotti aS. Silvestro e dagli scavi recenti condotti in S. Maria in Passione,
anch’essa sulla collina di Castello, MELLI 2004 con bibliografiae riferimenti.
11) Le analisi sono state effettuate da chi scrive per laSoprintendenza Archeologica della Liguria, dott.ssa P. Melli, eparzialmente edite in CUCINI TIZZONI-TIZZONI 2004,sebbene, a causa di fraintendimenti con la redazione del volume,il testo risulti sdoppiato e poco comprensibile.
12) MILANESE 1987. Fra i materiali di Genova analizzati dachi scrive, non ci sono evidenze di riduzione fino al I sec. a.C.
43
tempo dallo scavatore come impianto di riduzione potrebbe essere quanto resta di un fucinale diforgia. I pochi frammenti di minerale grezzo di ferro rinvenuti nelle stratigrafie dell’oppidum potevanoessere impiegati nella riduzione di minerali cupriferi, provata dalla presenza di scorie: il ferro èinfatti il miglior fondente del rame13.
È evidente che a Genova giungevano blumi o semilavorati di ferro da altre aree produttive, chei fabbri locali trasformavano in manufatti ed utensili; del resto, era economicamente più convenientetrasportare barre o lingotti di ferro commerciale, che non minerale grezzo da ridurre, che necessitavadi ingenti quantità di combustibile. Le maestranze genuati lavoravano accuratamente, con unabuona tecnologia e notevole padronanza tecnica, ad esempio sapevano usare decapanti per effettuarelavorazioni specialistiche come saldature, non sprecavano metallo, erano in grado di realizzarelamine di ferro a partire da lingotti ben depurati ed erano abili nei trattamenti termodinamiciimpiegando la tempera del metallo per realizzare ferro di notevole durezza. Il loro livello specialisticomolto elevato sembra proprio di maestranze provenienti dall’Etruria, all’epoca fra le più specializzatenella siderurgia. Se i fabbri potevano essere etruschi, non ci sono invece elementi scientifici asostegno della fabbricazione dei semilavorati con minerale dell’Elba. Tale tradizionale teoria nontiene conto dei giacimenti di ferro situati in aree più vicine e di facile accesso dall’oppidum diGenova, come quelli di Noli, Punta Bianca, S. Stefano d’Aveto e, soprattutto, il grande giacimentodi Ferriere in Val Nure14. A livello d’ipotesi, si potrebbe pensare ad esperti prospettori minerarietruschi che esploravano la zona appenninica alla ricerca di giacimenti e mineralizzazioni da sfruttare.
Tornando alla Cisalpina, il II sec. a.C. si apre con un profondo mutamento nel mondo celtico15.Finite le grandi migrazioni, ha inizio un periodo di consolidamento che vede l’incremento delleproduzioni locali, fra cui quelle metallurgiche. Si assiste inoltre ad un sempre maggiore assorbimentoculturale dei Celti da parte dei Romani, che corteggiavano le élite insubri e che si guardarono benedal sostituire la classe dirigente locale con una latina o romana. Il conformarsi al modello romanofu incoraggiato dagli stessi conquistatori e innescato e potenziato anche dai numerosi mercantilatini e romani che frequentavano le ricche zone della pianura Padana, nonché dai numerosimercenari celtici che avevano combattuto nelle varie guerre delle potenze del Mediterraneo. Questoprocesso si compì nell’81 a.C., quando la Cisalpina divenne provincia, e soprattutto nel 49 a.C.,quando i suoi abitanti ottennero la cittadinanza romana. E tra gli uomini d’affari latini e romaniattivi in Cisalpina tra il II e il I sec. a.C. ve ne erano anche di interessati al ricco potenziale minerarioe metallurgico dell’area alpina, per far fronte alle enormi forniture di metallo che richiedevanol’esercito e la flotta romani.
È in questo contesto che si inserisce l’atelier siderurgico dei Piani d’Erna (Lecco), che costituisceattualmente un unicum nel panorama della zona alpina italiana16, poiché per l’epoca celtica e romanarepubblicana non sono finora noti impianti comparabili. Il sito è eccezionale perché qui avevaluogo la riduzione primaria del ferro: mentre sono numerosi i luoghi dove i semilavorati eranoelaborati in prodotti finiti, cioè le semplici forge da fabbro, necessarie in qualunque abitato di unacerta entità, esse vanno ben distinte dai siti produttivi come quello di Erna.
L’impianto (situato a 1291 m s.l.m.) sorse ai piedi del monte Resegone su una falesia chedomina l’attuale città e il lago di Lecco. I locali giacimenti di solfuri di ferro, zinco e piombo inganga baritica avevano un ricco cappellaccio di limonite che fu sfruttato nell’antichità perché, purnon essendo di ottima qualità, era facilmente estraibile17. La zona mineraria principale era situataall’estremità sud del Pizzo d’Erna, presso lo strapiombo sulla falesia, e sul versante est; purtroppo
13) Sarebbe interessante vedere che rapporto c’era nellaprotostoria e anche in epoca storica fra la Repubblica e losfruttamento del grande giacimento di rame del MonteRamazzo, situato oggi alla periferia della città.
14) Su quest’ultimo giacimento TIZZONI 2001, pp. 292-293.
15) Per tutto ciò si veda CUCINI TIZZONI-TIZZONI c.s.
16) TIZZONI-CUCINI-RUFFA 2006.
17) A differenza dei minerali del tipo “Alpi Lombarde”, lalimonite dei Piani d’Erna è quasi priva di manganese. Altraparticolarità è la notevole presenza di bario (in media il 9,80%),poiché questo minerale deriva dall’alterazione meteorica disolfuri ed è quindi intimamente mescolato alla barite che nonforma, come negli altri giacimenti ferriferi lombardi, dei bendistinti e separabili filoni; ciò impedì una efficace cernitamanuale tra i due minerali. Nelle scorie dei Piani d’Erna il bariorisulta dunque uno degli elementi marcatori assieme ad arsenico,stronzio e zinco, perché passa abbondantemente nella scoria(con punte sino al 12%), dove forma dei silicati come la celsianae l’andremeyerite, CUCINI TIZZONI-TIZZONI 2006-a.
44
la maggior parte degli scavi antichi è collassata. Parte di una delle miniere antiche è stata rilevata;la sua caratteristica principale è che si dilata in continuazione, sia in orizzontale che in verticale,con scavi di forma sferoidale-lenticolare che seguono l’andamento del filone. Lo scavo fu eseguitocol fuoco e in parte tramite punteruoli piramidali e mazze. L’avanzamento era effettuato da unsolo minatore che seguiva il filone mineralizzato asportando quanta meno roccia sterile possibilefino a raggiungere le tasche sferoidali dove il minerale era concentrato in ammassi.
A circa 500 m di distanza in linea d’aria dalla miniera è stata individuata e scavata un’areaproduttiva in cui il minerale di ferro veniva ridotto e trasformato in ferro metallico commerciale.Questo atelier (estensione mq 100 circa) era un vero e proprio sito “industriale”, non vi è infattitraccia di un abitato ed esso non costituiva un quartiere artigianale inserito in un contesto abitativo.
L’atelier dei Piani d’Erna sorse ex novo come impianto siderurgico nel corso del II sec. a.C.; laconsistenza del deposito archeologico e alcune datazioni al C 14 mostrano che la sua vita fu breve,poco più di due secoli.
Il primo periodo produttivo (II-I sec. a.C.) vide l’impianto e il funzionamento di grandi fornia cupola celtici, costruiti interamente in argilla; essi si componevano di una camera di riduzionecircolare a fondo piatto di grandi dimensioni, munita di un avancorpo dove si apriva l’imboccatura,tramite la quale gli addetti operavano all’interno e recuperavano il blumo. La cupola sovrastanteera leggera, in argilla. Il forno non evacuava la scoria durante il processo produttivo, se non inpiccola quantità, ed era alimentato dai mantici. Date le grandi dimensioni è probabile che ognibassofuoco servisse per più operazioni.
Questi più antichi forni dei Piani d’Erna si inseriscono in una precisa categoria di strutture diriduzione di tradizione celtica impiegate in Europa occidentale e centrale dal periodo Hallstatt/LaTène antico per tutto il periodo La Tène. Si tratta di forni monumentali, ma di difficilefunzionamento, poiché come sembrano indicare alcune sperimentazioni, si crea al loro interno una“zona morta” centrale in cui la carica è solo parzialmente ridotta. La resa non doveva essere quindiottimale. Tuttavia ciò non impedì che questo tipo d’impianto fosse in uso per lungo tempo in una vastaarea. Sino ad ora in Italia questo tipo di forno a cupola non era mai stato rinvenuto o riconosciuto.
Non sappiamo chi fossero le genti che impiantarono l’atelier dei Piani d’Erna, un sito che sipone tra il mondo celtico romanizzato della pianura e quello montano, ancora per molti aspettiindigeno; non sono stati trovati materiali indicanti l’appartenenza etnica o culturale dei fabbri.Invece la tecnologia che essi impiegavano indica con precisione un ambito culturale (ma nonnecessariamente etnico) celtico; si potrebbe ipotizzare la gestione del sito da parte di un vicinovillaggio che seguiva la tradizione celtica. Questi forni vennero repentinamente ed intenzionalmentesmantellati intorno al 40 a.C.
La romanizzazione
Ai Piani d’Erna, dopo la rapida distruzione dei grandi forni celtici, si provvide a regolarizzarel’area con uno spesso riporto di argilla plastica con la quale e sulla quale vennero realizzate numerosenuove strutture di riduzione.
Questi forni del secondo periodo produttivo, più piccoli dei precedenti, venivano distrutti insitu al termine di ciascuna operazione e altri analoghi erano edificati al di sopra o accanto ad essi.Anche questo nuovo tipo di forno era totalmente costruito in argilla, aveva fondo piatto o appenaconcavo a pianta ellittica. La parete era inizialmente svasata per poi chiudersi a formare unacampana che si restringeva ancora più al collo e alla bocca superiore (fig. 2). La struttura evacuavala scoria nel corso del processo di riduzione ed era alimentata da mantici.
Questa tipologia di forni, finora poco nota dai resti archeologici, costituisce un’evidenteevoluzione tecnologica della precedente. La forma rimase sostanzialmente la stessa, dopol’abolizione dell’avancorpo, ma le ridotte dimensioni ovviavano agli inconvenienti dei forni celticimigliorando la resa e riducendo il consumo di combustibile. Tuttavia lo scavo non ha registratoesperimenti o forni di transizione fra i due tipi.
Erano inizialmente collegati a questi nuovi forni due focolari-fossa, cioè delle forge rudimentaliscavate nel terreno. Successivamente, via via che le attività siderurgiche si susseguivano a un ritmopiù incalzante, si assiste a una razionalizzazione spaziale/funzionale dell’impianto siderurgico
45
tramite la costruzione di un carbonile e una capanna-forgia. All’interno di quest’ultima, distruttada un movimento franoso, è stato fatto un ritrovamento eccezionale: due blumi di ferro del pesodi 33 e 38 kg, cioè due grossi blocchi metallici che costituivano il prodotto della riduzione e cheerano stati epurati nella forgia stessa. Essi erano costituiti interamente da ferrite18. In associazioneai resti degli ultimi bassofuochi sono stati trovati gli unici frammenti ceramici rinvenuti nel sito,pertinenti ad un’anfora Dressel 6A. L’abbandono dell’atelier va collocato verso la fine del I sec. d.C.
Grazie allo studio archeometrico dei due blumi e di oltre 1200 kg di scorie e scarti di riduzioneè stato possibile stimare che la resa del minerale era del 29% e che nell’atelier dei Piani d’Ernafurono prodotte circa due tonnellate di metallo riducendo 7 t di minerale (pari a 1750 mc). È statoanche possibile ricostruire con precisione la procedura operativa: il forno veniva acceso e riscaldatocon il solo carbone, quindi caricato con minerale mescolato a combustibile. Il processo di riduzioneera così avviato e procedeva sino alla formazione di circa un terzo del blumo con continue piccolericariche. A questo punto la scoria liquida era troppo abbondante e rischiava d’intasare gli ugelli,perciò veniva fatta colare all’esterno dalla porta. Concluso il deflusso della scoria si provvedeva aricaricare il forno e si proseguiva fino al compimento di un’altra sequenza. Entrambi i blumirinvenuti mostrano che questa serie di operazioni venne ripetuta tre volte prima di interrompere ilprocesso recuperando la massa di metallo prodotta. La condotta dell’operazione era quindistandardizzata ed eseguita secondo lo stesso saper fare tecnico.
Fig. 2: Piani d’Erna (Lecco). Ricostruzione del bassofuoco del Periodo II, con posizionamento del blumo metallico(da TIZZONI-CUCINI-RUFFA 2006, fig. 86 b).
18) FLUZIN 2006.
46
Una simile produzione doveva essere destinata all’esportazione, non certo verso l’area montana,dove si trovano ben più importanti giacimenti di quelli dei Piani d’Erna, bensì verso l’alta pianura,in particolare la zona di Lecco e degli abitati lungo il corso del fiume Adda. È probabile che ilferro venisse messo in commercio in masse metalliche simili a quelle rinvenute nello scavo e nonin veri e propri semilavorati strutturati come i lingotti o le currency bar. È stato dimostrato19 che iltrattamento di prima epurazione si svolse in atmosfera riducente, quindi all’interno del bassofuocoancora caldo al termine della riduzione. I blumi erano di metallo di ottima qualità, pronto peressere utilizzato, avevano subito una prima sgrossatura e un compattamento, erano molto omogeneie abbastanza standardizzati come peso. Nelle forge degli abitati di pianura questi semilavoratierano trasformati prima in lingotti o barre e poi elaborati in oggetti di ferro.
I frammenti di anfora Dressel 6A ci informano sui circuiti commerciali in cui questa localitàcosì fuori mano era inserita e la rete di comunicazioni fluviali e terrestri dell’epoca. Il grandeforno a cupola più antico, di origine celtica, si sviluppò in ambito sub-regionale: la sua evoluzionemorfologica e tecnologica ebbe luogo in epoca romana, intorno alla metà del I sec. a.C. Si puòipotizzare che gli antichi metallurgisti dei Piani d’Erna o delle vicine vallate alpine modificasserola struttura di riduzione che impiegavano, ben collaudata da secoli in una vasta area, per renderlapiù efficiente e limitare le perdite di metallo e combustibile.
Non si può tuttavia escludere che questo mutamento sia collegato all’arrivo di un imprenditoreche avrebbe apportato cambiamenti gestionali nell’insediamento produttivo: la gestione diretta diun imprenditore romano o cisalpino romanizzato che, oltre a investire capitali, introdusseinnovazioni tecnologiche forse apprese altrove. È ben noto l’investimento di capitali romani inimprese manifatturiere in Cisalpina nel I sec. a.C., inoltre i giacimenti minerari alpini non sfuggironocertamente all’interesse di Roma. Come ha notato Marco Tizzoni, a Introbio, nel ricco bacinominerario della Valsassina a breve distanza dai Piani d’Erna, si intravede forse un impianto urbanoromano e una micro-centuriazione della valle (TIZZONI 1986, pp. 204-205). Ai Piani d’Erna sipotrebbe pensare ad una piccola impresa privata, forse facente parte di un gruppo regionale piùampio gestito da una compagnia importante, che impiegava manodopera “indigena” romanizzatae che controllava una serie di miniere e di forni tramite intendenti. Una grande impresa – forse dipubblicani - poteva avere una sorta di sede centrale ubicata in un centro urbano, da cui venivacoordinata la gestione dei singoli impianti e organizzato il commercio del metallo prodotto.Impossibile risalire allo statuto di questo sfruttamento: se il terreno dove si trovano le miniere era agerpublicus si dovrebbe pensare ad un affittuario operante con una locatio censoria, oppure se si trattava di unproprietario, esso doveva pagare un tributo allo stato20. Va sottolineata in ogni caso la concomitanza frail cambiamento di gestione e la concessione della cittadinanza romana ai Cisalpini nel 49 a.C.
Quello dei Piani d’Erna è quindi un sito produttivo gallo-romano specializzato nella siderurgia,abbandonato verso la fine del I sec. d.C. forse a causa dell’impatto ambientale dei forni e ildisboscamento conseguente, o della scoperta di giacimenti di ferro ben più ricchi nelle alte vallilecchesi, bresciane e bergamasche.
Proprio in quest’ultima zona, nel I-II sec. d.C. è attestato lo sfruttamento dei ricchi giacimentidi zinco della Valle del Riso, che andavano a rifornire le officine produttrici di ottone della Milanoromana21. Ne abbiamo conferma da Plinio il Vecchio (Nat. Hist. XXXIV, 2), che parla delritrovamento della cadmea … nunc et in Bergomatium agro extrema parte Italiae.
Il periodo romano: la pianura e i centri urbani
Negli ultimi anni in Italia settentrionale si è assistito ad un grande sviluppo delle indaginiarcheologiche stratigrafiche nei centri urbani di origine celtica o romana. Un po’ ovunque, inLombardia, Piemonte e Veneto i cantieri edili hanno portato alla luce resti anche monumentali
19) FLUZIN 2006.
20) Sono gli stessi interrogativi che sono stati posti per le minierede La Loba nella Betica, BLÁZQUEZ MARTÍNEZ et Al. 2002,pp. 394-404.
21) Si veda in questo stesso volume il contributo di chi scrivecon A. Ceresa Mori.
47
delle civitas romane ampliandone la conoscenza dal punto di vista urbanistico, dell’edilizia residenzialee dei quartieri produttivi-funzionali. In Gallia Cisalpina si è osservato tuttavia un curioso fenomeno:la presenza di scarsi o scarsissimi resti della lavorazione siderurgica. In altre parole, nelle stratigrafieantiche ci sono poche scorie metallurgiche.
Se prendiamo ad esempio il caso di Milano22, solo per citare un centro urbano oggetto diindagini archeologiche ampie ed esemplari, in un arco di tempo di quasi duemila anni il quantitativototale di scorie recuperate ammonta a circa due quintali. Si tratta di una quantità evidentementeirrisoria se consideriamo che Milano era una città importante, capitale dell’impero romano dal 286al 402 d.C. Sappiamo da un’epigrafe del 242 d.C.23 che vi erano in età tardo imperiale delle fabbriched’armi e quindi sarebbe logico aspettarsi una gran quantità di scarti metallurgici nelle coevestratigrafie. Questo dato in negativo non sembra al momento di facile interpretazione. Non èpossibile pensare, ad esempio, che le smaltissero portandole via per motivi di “nettezza urbana”,poiché i residui di altre lavorazioni ben più fastidiosi, come l’osso e il corno, venivano senzaproblemi abbandonati in giro.
Non è possibile nemmeno che le scorie venissero usate come drenaggio, infatti i numerosidrenaggi attestati a Milano vennero eseguiti con anfore, né come materiale da costruzione – inerti.Un probabile indizio sul loro destino viene da Novara, dove le scorie vennero utilizzate per riempirele buche scavate per l’estrazione dell’argilla per gli usi dell’abitato. Ma ciò che più sorprende è ilfatto che gli scarti metallurgici venissero accuratamente raccolti, infatti a Novara, a parte nellesuddette buche, non ne sono state trovate altre negli scavi urbani. Si deve quindi desumere che lescorie ritrovate a Milano siano le poche sopravvissute di un’accurata raccolta le cui motivazioni almomento ci sfuggono.
A Milano si tratta esclusivamente di scorie pertinenti alle ultime fasi siderurgiche, quelle dellaforgia per l’elaborazione di oggetti e utensili o per la loro riparazione, senza particolaricaratterizzazioni. Non si notano nelle scorie milanesi di epoca romana e altomedievale dellecaratteristiche che denotino un mutamento nelle tecniche di forgiatura, almeno fino al XV sec. d.C.
Dall’età romana all’alto Medioevo: la montagna
Come si è sopra accennato, le miniere dei Piani d’Erna sono una rarità dal punto di vistamineralogico, nel panorama minerario della Lombardia. Dall’età romana è infatti provato losfruttamento dei ricchi giacimenti di ematite, siderite e goethite altamente manganesifere, che perduemila anni hanno dato un’impronta originale alla storia economica delle valli alpine lombarde24.
Il ferro prodotto era di ottima qualità grazie anche al fatto che i minerali del tipo “Alpi Lombarde”hanno un elevato contenuto di manganese e un basso tenore in zolfo25, come quelli dell’Austria,della Germania, dei Pirenei o del Galles. Questo tipo di minerali si riduce a temperature inferiori diquelli non manganesiferi dando luogo alla formazione di ghise bianche. Per importanza storico-economica, volume produttivo e qualità del metallo ottenuto, le miniere lombarde stanno quindi abuon diritto alla pari con quelle del Norico e della Penisola Iberica, regioni queste ultime ben piùnote nella storiografia siderurgica.
Le attività di sfruttamento interessarono distretti minerari di notevole estensione e complessitàrispetto alle Alpi, finora poco esplorati26. Ubicati nelle Alpi bergamasche e bresciane nelle remote
22) M. Tizzoni ha in corso un ampio studio sulla metallurgiaantica a Milano.
23) TIZZONI s.d.
24) Ciò non esclude certo che i filoni di ferro manganesiferofossero già sfruttati in età protostorica; significa solo che finoad oggi non ne abbiamo la “prova provata”.
25) Come hanno mostrato le analisi effettuate da S. Leroy ePh. Dillmann, i minerali del tipo “Alpi Lombarde” hanno uncontenuto di Fe maggiore del 40%, di Mn dell’1-6%, meno del2% di Na, Ca e K, mentre è del tutto assente il fosforo, così
dannoso per la lavorazione del ferro. Fra gli elementi in traccequelli più elevati sono Ti, Sr e Ba, quest’ultimo eccezionalmenteelevato; per una sintesi preliminare si veda LEROY et Al. c.s.Storicamente, il minerale lombardo era ritenuto molto duttilee molto adatto a produrre acciaio.
26) Tali aree risultano talmente imponenti ed articolate che,senza nessuna enfasi o esagerazione, sarebbe necessario almenoun decennio di ricerche ad opera di un’équipe specializzata inspeleologia e archeologia mineraria, operante per molti mesiall’anno, per definirne sviluppo planimetrico-cronologico etecniche di estrazione.
48
e impervie alta Valsassina, alta Val Brembana27, alta Val Seriana e Val di Scalve28 e Val Grigna29, igiacimenti furono intensamente sfruttati almeno dall’età Flavia. Nel I sec. d.C. nel mondo romanole condizioni economiche erano favorevoli allo sviluppo su scala “industriale” delle attività minerariee ciò dovette coinvolgere anche la Cisalpina. Sembra dunque ipotizzabile un intervento direttodelle compagnie di pubblicani, o comunque di potenti società ben organizzate che dovevanocontrollare lo sfruttamento su vasta scala dei giacimenti alpini e inserire il metallo in ampi circuiticommerciali30.
Siamo di fronte a bacini minerari con una produzione notevole e a grandi siti di riduzione delminerale in semilavorati di ferro metallico. Inoltre le valli alpine lombarde erano ricoperte da fitteforeste di conifere, che fornivano abbondante combustibile per le attività siderurgiche31. Possiamoragionevolmente ipotizzare che l’alta specializzazione tecnologica delle valli bergamasche e brescianenella prima fase della catena operativa della siderurgia, documentata storicamente, abbia originimolto antiche32. Ciò sottintende una netta divisione “regionale” del lavoro: mentre le alte vallierano specializzate nella riduzione del minerale grezzo in blumi e semilavorati, la loro trasformazionesulla forgia in manufatti finiti avveniva altrove.
In età tardo imperiale è logico pensare che il ferro prodotto nelle alte valli andasse almeno inparte a rifornire le grandi fabbriche d’armi sotto il controllo governativo, dislocate nelle città delNord Italia. Quelle elencate nel IV sec. d.C. dalla Notitia Dignitatum33 sono, da est ad ovest: Concordia,Verona, Mantova, Cremona, Pavia. Tutte queste città risultano ubicate lungo fiumi navigabili: èevidente che le vie d’acqua erano fondamentali per la commercializzazione dei prodotti finiti, cioèper le forniture militari all’esercito romano. Se la Notitia Dignitatum è davvero attendibile, laspecializzazione e la divisione della produzione nella siderurgia romana – almeno per quantoconcerne gli armamenti – era puntuale e quasi maniacale. Si doveva trattare di fabbriche benorganizzate, che impiegavano tecnologie standardizzate e ben collaudate. In questo contesto leinnovazioni tecnologiche non avevano senso di esistere: la produzione su larga scala non permettevasperimentazioni.
Nel periodo di transizione fra Tardoantico e alto Medioevo i distretti siderurgici montanisembrano proseguire indisturbati le loro attività. Essi paiono in controtendenza rispetto a quantoviene di solito affermato per quest’epoca, e cioè che il crollo dell’economia globalizzata romanaavrebbe causato l’interruzione o comunque la crisi dello sfruttamento su vasta scala e la continuitàsolo a livello locale o regionale della produzione siderurgica34.
27) Ad esempio l’enorme zona mineraria di Ca’ S. Marco, pressol’omonimo passo, a quota 1850-1990 m s.l.m. Per l’altaValsassina e le grandi miniere del monte Varrone, a quota 1500-2000 m s.l.m., TIZZONI 1998.
28) La Valle di Scalve, o Valle del Dezzo, la romana Vallis Decia,è ubicata fra la Val Seriana e la Val Camonica, sul confine dellaValtellina; essa è racchiusa tra alte e aspre montagne, adeccezione che allo sbocco del Dezzo, affluente di destradell’Oglio; oltre al ferro, ha giacimenti di rame, piombo, zincoe pare anche d’oro e argento, MAIRONI DA PONTE 1819,III, pp. 83-85, 182-188, 227-230. I giacimenti di ferro spaticodel Manina in alta Val Seriana e della Val di Scalve (contigui,con gallerie minerarie comunicanti) sono probabilmente i piùimportanti della Lombardia, ZOPPETTI 1873, p. 6. Sulleminiere e i forni dell’alta Val Brembana, CUCINI TIZZONI1994 e TIZZONI 1997.
29) La Val Grigna, con la sua diramazione laterale della ValGabbia, è afferente alla Val Camonica. Qui è stata studiata lagrande miniera di ferro di Piazzalunga, MORIN 1999,sviluppata lungo un filone sub verticale di 540 m di lunghezzadi ematite e idrossidi. I lavori, a quota 1330-1635 m s.l.m., viderol’attacco preliminare della roccia col fuoco e poi l’abbattimentodel minerale con cunei e punte secondo il metodo dei gradinirovesci montanti. Lo sfruttamento dovette proseguire peralmeno un millennio, dal V sec. d.C. al Quattrocento.
30) Sull’amministrazione delle miniere imperiali, si veda quantoavveniva nella Spagna romana nell’ampio ed esaustivo studiodi DOMERGUE 1990, pp. 279-333. Per le Alpi italiane, appareevidente che il Senatus consultum che secondo Plinio il Vecchio(Nat. Hist. III, 138) proibiva lo scavo di miniere venisse ignoratoo quantomeno aggirato.
31) Per la Val Gabbia in particolare, si rimanda allo studiopaleoecologico di MIGHALL et Al. 2003. Le foreste eranocostituite prevalentemente da abete bianco e abete rosso.L’osservazione di LAVAN 2007, p. xx, stupisce per la totalemancanza di conoscenza dei luoghi.
32) TIZZONI 1997, p. 27.
33) SEECK 1876, Notitia Dignitatum p. occ., IX, 29, vengonospecificate le produzioni di armamenti per ogni centro.Concordia: sagittaria; Verona: scutaria et armorum; Mantova:loricaria; Cremona: scutaria; Pavia: arcuaria.
34) È questa la tesi storiografica tradizionale, che negli ultimianni viene messa in discussione da più parti. Si vedano da ultimole considerazioni di GIANNICHEDDA 2007, pp. 188-190, 193,199, 203, anche se le mie conclusioni tecnologiche sonodivergenti. Chi scrive non vuole negare il generale collasso dellestrutture economiche romane, come anche una tendenzagenerale alla recessione: ma il contesto alpino italiano vainquadrato a mio avviso in modo un po’ diverso.
49
Fig. 3: Ponte di Val Gabbia III (Bienno, Brescia), planimetria del sito. A-L, X, Y) saggi di scavo; 1) sentiero diaccesso; 2) carbonaia (XI-XIII sec.); 3) fonte; 4) torrente di Val Gabbia; 5) scivolo per il carbone; 6) capanna-forgia
semisotterranea (V-VI sec. d.C.) e capanna semisotterranea (XII-XIII sec.). I bassofuochi tardo antichi-altomedievalierano ubicati fra il sentiero e i saggi H, F, I e L. L’altoforno “primitivo” (XI-XIII sec.) era ubicato in
corrispondenza del saggio Y. Lo sviluppo totale è di oltre 60 m lineari, su un dislivello fra la zona più alta occupatadalla carbonaia e quella più bassa dove si trova la fonte di 18 m, pari a una pendenza del 17% (da CUCINI
TIZZONI-TIZZONI 2006-b, fig. 3).
50
Certo il controllo centrale sulle attività minerarie e metallurgiche dovette diminuire fino ascomparire: ma più in generale tutto il controllo “regio” del territorio montano doveva essere difatto impraticabile35. È allora che emergono peculiari soluzioni: la millenaria storia delle miniere e dellaproduzione metallurgica delle vallate alpine lombarde è una storia di autonomia, di fuga dal poterecentrale, di autogestione delle risorse, di sacche indipendenti che sfuggivano ad ogni controllo istituzionale,politico ed economico da parte del potere centrale o di quel che lo andò a sostituire. È questo il filologico che lega lo sfruttamento dei metalli in Lombardia dall’età tardoromana al periodo spagnolo.
Se per il V-VI secolo si osserva la distribuzione geografica dei castelli tardoantichi e altomedievalidella Lombardia36 si nota che essi sono ubicati sulle prime propaggini prealpine o su modestirilievi fluviali e lacustri. Le grandi aree minerarie delle impervie vallate alpine sono invece tuttedecisamente più a nord: finora sono noti solo pochi castelli, ad esempio quello di Vilminore diScalve37, eretti a protezione delle miniere e degli impianti metallurgici. Tuttavia i giacimenti mineraridella Val di Scalve, come della vicina Val Grigna, sono ubicati in zone sperdute, ma difesenaturalmente da strapiombi e precipizi vertiginosi. È qui che la siderurgia, oltre a continuare indisturbatagrazie alla localizzazione remota, poté svilupparsi tecnologicamente. Le complesse innovazioni cheportarono al passaggio dal metodo diretto a quello indiretto della produzione del ferro ebbero luogo inepoca tardoantica-altomedievale in questi posti sperduti, ben protetti da una natura ostile38.
Si deve sottolineare quindi che la continuità fisica e geografica dei luoghi rispetto alla tradizionesiderurgica romana, non significa anche continuità tecnologica: ci fu anzi evoluzione e sviluppo,come dimostra l’alto grado di innovazione tecnica raggiunto nel V-VI sec. d.C. a Ponte di ValGabbia. Qui il ferro veniva ridotto in tre distinti impianti. Nel sito di Ponte di Val Gabbia III,datato al C14 fra il 410 e il 600 d.C., i bassofuochi erano collegati ad una capanna-forgiasemisotterranea dove le maestranze decarburavano i blocchi di ghisa bianca prodotti dai forni perrealizzare manufatti finiti (fig. 3). Le scorie rinvenute sono del tipo laitiers à grenaille, un verofossile-guida per quanto concerne il processo indiretto. La produzione volontaria di ghisa e laprecocissima padronanza delle tecniche di decarburazione collocano questa valle alpina italiana alprimo posto in Europa per le origini dell’altoforno39. I siti di Ponte di Val Gabbia II e III sono dipoco successivi, databili rispettivamente fra il 590 e il 680 d.C. e fra il 560 e il 760 d.C., in pienaepoca longobarda; la presenza di prodotti carburati nelle scorie non è tuttavia associata a laitiers àgrenaille, dunque si continuava a produrre il ferro secondo il metodo diretto. L’indagine paleobotanicacondotta in Val Gabbia ha messo in luce un periodo di disturbo nella foresta a partire dal 500 d.C.connesso alle attività di lavorazione del ferro.
Senza dubbio il più grande sito siderurgico di epoca romana rinvenuto sino ad oggi è quello diPaludina presso Schilpario (Bergamo), in alta Val di Scalve (quota 1155 m s.l.m.), che nell’estate2008 è stato oggetto di un’indagine congiunta italo-francese40. Al rilievo complessivo dell’area èseguita l’indagine paleomagnetica (fig. 4) e lo scavo di due limitati sondaggi allo scopo di saggiareil potenziale archeologico dell’impianto. Inoltre sono state realizzate sul posto centinaia di analisialla microsonda di campioni delle scorie affioranti; esse sembrano riferibili per la maggior partealla riduzione del minerale secondo il metodo diretto, sono stati rinvenuti pochi laitiers à grenaille.
Le stratigrafie sono costituite da spessi accumuli di scorie alternati a livelli di frammenti diforno (figg. 5-6). Le indagini paleomagnetiche hanno localizzato la presenza di alcuni bassofuochinello strato di scarti siderurgici, tuttavia le strutture non sono state indagate archeologicamente.
35) Come è stato rilevato da TIZZONI 1997, pp. 22-24 eMAINONI 2001, p. 451. Attribuisco qui al termine “regio” ilsignificato di “potere centrale”.
36) Da ultimo BROGIOLO-CHAVARRIA ARNAU 2005, pp.69-78.
37) L’insediamento è stato rinvenuto e segnalato da M. Tizzoni,sulla scorta del Maironi da Ponte. Per i sondaggi eseguiti dallaSoprintendenza Archeologica si veda FORTUNATI-GHIROLDI 2006. Si tratta di un grande abitato fortificatocon case semisotterranee, analoghe a quelle rinvenute in ValGabbia, circondate da mura munite almeno di una torre.L’abitato si trova a breve distanza da una grande miniera diferro e da alcune miniere di rame.
38) Per riprendere, e rispondere in modo affermativo aGIANNICHEDDA 2007, p. 189, l’enorme potenziale per leinnovazioni tecnologiche esistente cominciò ad esseresviluppato e messo in pratica in età tardoantica.
39) Per un compendio dei ritrovamenti – strutture, laitiers àgrenaille, scorie a calotta da decarburazione della ghisa, oggettiforgiati – si veda da ultimo CUCINI TIZZONI-TIZZONI2006-b, pp. 23-27.
40) L’équipe di Ph. Dillmann e S. Leroy ha messo a punto eapplicato a Paludina un approccio analitico adattato per lo studiodella provenienza del ferro usato per la produzione di oggetti,LEROY et Al. c. s.
51
Fig. 4: Paludina (Schilpario, Bergamo). Studio geofisico e magnetico redatto dall’équipe di Ph. Dillmann.
Le grandi dimensioni di questo sito e l’imponenza del deposito di scarti indicano che le attivitàsiderurgiche ebbero una durata lunga e intensa, come è evidenziato dal fatto che non vi sono livellidi abbandono nelle sezioni del giacimento. Le analisi al C14 hanno fornito una cronologia del sitocompresa fra l’80 e il 610 d.C. In questi lunghi secoli di sfruttamento minerario e di produzionesiderurgica le attività sembrano concentrate in due periodi principali: il primo va dall’età adrianea all’etàseveriana e oltre; il secondo va dagli inizi del V sec. fino a tutto il VI sec. d.C.
È stato osservato che le fabbriche d’armi tardo-imperiali rimasero in attività almeno sino alle guerregotiche e forse anche in piena età longobarda, seppure producendo secondo modelli diversi; da quantoemerso dagli scavi della Crypta Balbi a Roma, in epoca bizantina e longobarda i metalli, come altremerci strategiche o di lusso, dovettero continuare ad essere commerciati su lunga distanza e fragruppi etnici diversi fra il nord e il centro della penisola41. Possiamo ipotizzare un’attività pressochéininterrotta di estrazione mineraria e produzione di semilavorati di ferro commercializzati attraversouna rete di scambi in continuità con l’epoca romana42. La zona alpina italiana sembra confermarsidunque come produttrice di ferro anche in epoca tardoantica e altomedievale.
41) RICCI 1997, pp. 256, 268-270. RICCI 2001, pp. 79-80,85. Nell’atelier della Crypta Balbi non è stato rinvenuto perònessun indicatore di attività siderurgiche, GIANNICHEDDA-
MANNONI-RICCI 2001, p. 333.
42) Si veda anche GIANNICHEDDA 2007, p. 195.
52
Il Medioevo: alle origini dell’altoforno
Il ruolo di primo piano nella produzionesiderurgica altomedievale e dei secoli centrali delMedioevo svolto dalle valli alpine lombarde – inparticolare quella di Scalve – è confermato dauna serie di documenti d’archivio43.
Nel 774 Carlo Magno donava moltipossedimenti e miniere situati nelle valliCamonica, Seriana e di Scalve ai canonici di S.Martino di Tours, a cui furono confermatinell’887 da Carlo il Grosso. Quegli stessi benifurono oggetto di una permuta nel 1026 traReginerio preposto di S. Martino di Tours eAmbrogio vescovo di Bergamo; ma il tentativod’ingerenza del presule bergamasco nelle attivitàminerarie scalvine ebbe vita breve. Già al 1047risale infatti il famoso monumento del libero commerciodel ferro con cui l’imperatore Enrico III confermavaagli uomini di Scalve il privilegio di vendere il loroferro in tutto l’impero senza pagare nessun dazio,corrispondendo il solo tributo annuale di 1000libbre di ferro alla corte regia di Darfo in ValCamonica. Si trattava della conferma di un privilegioantico, del tempo dell’imperatore Ottone44.
In questo modo gli Scalvini avevano ottenutonel X secolo una totale autonomia gestionale e
commerciale; ed il quantitativo di metallo corrisposto alla corte di Darfo è esorbitante rispetto aquelli che vengono di solito considerati gli standard produttivi del tempo45. Se gli Scalvini potevanopermettersi di pagare un tributo annuo di 800 kg di ferro come se fosse una facilitazione e unosgravio, è evidente che la produzione totale della valle doveva essere enorme per l’epoca. Purtroppoi documenti non specificano sotto quale forma il metallo era corrisposto, ma per analogia conquanto avveniva più tardi nella vicina alta Val Brembana, si può forse pensare a ferro “cotto”, cioèferro ottenuto dalla decarburazione della ghisa e forgiato in semilavorati46. Ciò significa anche cheogni anno veniva scavata quasi una tonnellata e mezzo di minerale solo per pagare questo censo47.
Fig. 5: Paludina (Schilpario, Bergamo), Saggio 1, sez.US 6: sterile; US 5: carbone di legna anche in grossa
pezzatura; US 4: terreno limoso rossastro con sabbia eghiaino; US 3: scorie, frammenti di forno, carbone,
sabbia limosa, lenti argillose; US 2: scorie; US 1: humus.
43) Per i riferimenti bibliografici e documentari MAINONI2001, pp. 426, 431, 444-445; si veda anche ANTONUCCI 1926e GRASSI DI SCHILPARIO 1899, pp. 9-11, 15-17.
44) Secondo quanto affermato da Lupi, che aveva edito ildocumento, MAIRONI DA PONTE 1825, pp. 131-132. Si risalecosì al X secolo. Sulla peculiare autonomia della Valle di Scalve v.SCHARF 2007, pp. 25-27, nota 15, con esaustiva bibliografia.
45) Come termini di paragone si considerino i dati seguenti.Nel IX sec. al monastero di S. Giulia di Brescia venivanocorrisposti vari censi annuali in ferro da una serie di corti:Borgonato 20 libbre, Casivico 30, Griliano 100, Vuassaningus 130,mentre tutta la Val Camonica corrispondeva complessivamente60 libbre di ferro. Sul polittico di S. Giulia di Brescia si veda daultimo ARCHETTI 2006, pp. 45-46. Nel X sec. la corte diLimonta, sul lago di Como, corrispondeva un censo di 100libbre di ferro al monastero milanese di S. Ambrogio. Dal 1236al ’500 i Baroncelli-Cattanei di Valleve, in alta Val Brembana,corrispondevano ai monasteri bergamaschi di Astino prima edi Pontida poi mezzo centenaro di ferro in semilavorati (tagliolie vergella). Per tutto ciò CUCINI TIZZONI 2001, p. 38, nota13 e CUCINI TIZZONI 1994, pp. 80-85, con riferimentiarchivistici e bibliografici e calcolo delle produzioni; i documentianalizzati per l’alta Val Brembana forniscono nel 1236
l’equivalenza di mezzo centenaro con 30 libbre grosse e contre pesi. La libbra bergamasca è pari a gr 812,822. Pur con tuttele cautele del caso, il quantitativo di ferro pagato dagli Scalvini allacorte di Darfo si aggira quindi attorno agli 800 kg.
46) La dicotomia fra ferro crudum e coctum, cioè ghisa e ferrodecarburato, conferma l’evidenza degli altoforni attestati neidocumenti d’archivio dal XIII sec. nelle valli alpine lombarde,CUCINI TIZZONI 1994, pp. 85-87; EADEM 2001, pp. 38-42.
47) Non disponiamo di dati per quest’epoca così remota sul calodel minerale e della ghisa durante la lavorazione. Solo a titoloindicativo – e per difetto – si può tentare un calcolo basandosi suidati forniti da ZOPPETTI 1873, pp. 5-9, 71-72, 129-139. Egliosservò approfonditamente la situazione delle valli alpine lombardein epoca post-unitaria: allora la resa del minerale negli altofornidella Valle di Scalve era del 45%; il calo della ghisa durante ladecarburazione era del 20% secondo il Metodo della bassa e altaVal Camonica. Un minore calo si otteneva col Metodo Bergamascopropriamente detto; non abbiamo notizie sul metodo utilizzato inVal di Scalve. Si dovrebbe forse aggiungere un altro 20% di calodel minerale se si considerasse la torrefazione nelle reglane, a boccadi miniera. Ma non è certo che nei secoli centrali del Medioevoessa venisse effettuata. Nel complesso si giunge quindi ad unastima minima di 1400 kg di minerale per produrre 800 kg di ferro.
53
Ancora nel 1222 il vescovo di BergamoGiovanni Tornielli infeudava la Val di Scalve aiCapitanei di Scalve riservandosi i diritti sulleminiere che deteneva nella valle e corte di Scalvee nella corte di Palodo: ma già nel 1231 i Capitaneidovettero cedere al comune e universitas di Scalvei diritti feudali concessi dal vescovo per 2400lire imperiali. È facile riconoscere nella corte diPalodo il nostro sito di Paludina, doveevidentemente le attività siderurgichecontinuavano ininterrotte. Infine nel 1311l’imperatore Enrico VII rinnovava e confermavail monumento del libero commercio del fer ro ,svincolando del tutto gli Scalvini dai tentativid’imposizione del teloneo fatti dal comune diBergamo e rendendoli completamenteautonomi48.
Il caso della val di Scalve è forse estremonella sua esasperata autogestione, ma nondoveva essere del tutto isolato49. Ci sembra chequesta consuetudine di attività minerarie emetallurgiche svolte in autonomia possaaffondare le sue radici proprio nel periodo tardoantico-altomedievale: fu questa la risposta deicomprensori siderurgici lombardi al collassodell’economia centralizzata e globalizzataromana. Il punto di arrivo di questo processopuò essere emblematicamente considerato il1599, quando Rocco Fondra, uno dei principaliproprietari di miniere e forni della Valsassinafece testamento: fu solo allora che il governospagnolo del Milanese scoprì che in Valsassinasi scavavano miniere da tempo immemore senzapagare alcuna tassa50.
In questo peculiare contesto si inquadra l’innovazione che farà da propulsore all’enorme sviluppo“classico” della siderurgia lombarda, quella dell’altoforno, ovvero il passaggio dal metodo diretto aquello indiretto di produzione del ferro. Dobbiamo quindi, ancora una volta, tornare in Val Gabbia.
Qui, a Ponte di Val Gabbia III51, nell’XI-XIII secolo era in funzione un altoforno “primitivo”associato ad una capanna semisotterranea e ad una carbonaia (fig. 3). La cronologia di questiimpianti indicata dal C 14 è fra il 1030 e il 1260-1270 d.C. al 95% di probabilità (GU-10620; GU-10621). Il forno fusorio era sagomato internamente, con un restringimento tra sacca e presura,aveva una camicia interna in argilla, evacuava la ghisa fusa su un letto di sabbia fluviale. Questoprototipo di forno rimanda evidentemente ad un modello preciso di struttura siderurgica, l’altoforno
Fig. 6: Paludina (Schilpario, Bergamo), Saggio 2, sezione.US 6: sterile; US 5: piccole pietre, scorie frantumate in
piccoli pezzi, sabbia e ghiaino; US 4: scorie sciolte anchein grossa pezzatura, carbone, ghiaino; US 3: lente
rossastra, scorie sciolte con sabbia e ghiaino rossastro;US 2: limo nero con raro carbone e scorie di medie
dimensioni; US 1: humus.
48) MAINONI 2001, p. 444. Il privilegio fu riconfermato piùvolte dai Visconti e dagli Sforza e, dal 1428, dalla repubblica diVenezia, GRASSI DI SCHILPARIO 1899, p. 17. Fino al 1808,prolungato poi fino al 1857, il diritto di scavare liberamente ilminerale era attribuito per la sola qualità di essere valligiani diScalve, con l’unica limitazione della potenza di ciascun bancomineralizzato e nel rispetto dei lavori altrui, ZOPPETTI 1873.Dopo l’Unità, fu per molti anni quasi impossibile estendere lalegislazione mineraria nazionale alla Valle di Scalve per lenumerose proteste e liti.
49) Non è questa la sede per ripercorrere tutte le attestazionidocumentarie in tal senso, si rimanda quindi a MAINONI 2001,
ad esempio per il caso di Ardesio, pp. 432-434, o per le varieribellioni a gabelle e controlli, pp. 444-447, 451.
50) TIZZONI 1998, p. 37.
51) Si tratta dello stesso sito dove, in epoca tardoantica è statadocumentata la più antica decarburazione volontaria della ghisa,si veda sopra, testo corrispondente alla nota 41. L’altofornovenne impiantato poco più a monte dei bassofuochi precedenti,CUCINI TIZZONI-TIZZONI 2006-b, pp. 27-39. Lacronologia al C14 della capanna associata all’altoforno è tra il1170 e il 1280 d.C. al 95% di probabilità (BM 3053).
54
a base quadrata e sezione interna a doppio tronco di piramide, la cui diffusione in buona parted’Europa ad opera di maestranze bergamasche è documentata a partire dal Quattrocento52. Laventilazione era assicurata da mantici, di cui restavano tracce del bilico. Non sono state trovatecanalizzazioni per l’adduzione dell’acqua del torrente, ma non si può escludere la presenza di uncanale in legno sospeso su pali, del tipo di quello che attraversa ancora oggi il centro storico diBienno, il Vaso Re, e che un tempo alimentava le fucine del borgo. Il problema dell’esistenza omeno di una soffieria idraulica non è quindi risolto. Il forno giungeva ad una temperatura superiorea 1600° C e produceva esclusivamente laitiers à grenaille, cioè le scorie vetrose ma ricche in ferrotipiche del processo indiretto “arcaico”.
Allo stato attuale della ricerca, sembra questo il punto di partenza della grande tradizionedell’altoforno lombardo53. La continua deforestazione della Val Gabbia, evidenziata dalle analisipaleobotaniche dal 500 al 1300 d.C., toccò le sue punte massime attorno all’800-880 d.C. esoprattutto al 1150-1250. Mentre si può collegare quest’ultimo periodo all’altoforno “primitivo”suddetto, nulla sappiamo finora del IX secolo.
Le ricerche più recenti ci permettono comunque di restringere la “forchetta cronologica”rispetto a dieci anni fa: i primi altoforni sono documentati dall’archeologia nell’XI secolo, ma nonsembrano ancora diffusi all’inizio del VII, quando continua a essere documentato il processodiretto. Si può realisticamente ipotizzare che le sperimentazioni e innovazioni del V-VI secoloabbiano prodotto cambiamenti tecnologici in tutta la zona alpina lombarda e che i secoli VIII-Xsiano quindi cruciali per lo sviluppo del metodo indiretto di produzione del ferro.
Costanza CuciniMetallogenesi s.a.s.
via Pria Forà 4I-20127 Milano
Summary
Twenty years of metallurgical researches in Northern Italy. The Author presents a summary of all herresearches with M. Tizzoni about early copper and iron mining and metallurgy in Lombardy. The large copper, andpossibly electrum, mines of Campolungo and Baita Cludona di Fondo in Grigna Valley are taken into considerationfor the prehistoric period (first half of the 8th, beginning of the 6th centuries BC). Mainly at Campolungo the mine isexceptional under a technological point of view, large open air and underground exploitations, a 135 m long crosscutdug into the sterile rocks in order to reach the ore bodies, ventilation and exploitation galleries, ore washing area, oresorting and crushing places. All these structures underlie a complex organization and a centralized power. After aquick glance at the new data from the Vth century BC ligurian oppidum of Genoa, the IInd century iron working site ofErna, near Lecco (Lombardy) is presented. Here the celtic large domed furnaces were used, around the year 40 BCthey were abandoned in favour of a smaller low furnace which is an evolution from the previous ones. In the forge hutat Erna two large iron blooms were found. Possibly this technological change can be related to the arrival of a romanentrepreneur. Slags are quite scarce in roman towns, while iron metallurgy greatly increased in the alpine valleys in theFlavian period. The inhabitants of large mining districts where the manganese rich iron ore of the so called “LombardAlps type” was mined were specialized in its reduction. An early pig iron intentional decarburization was practiced inVal Gabbia in late Antiquity. For the period 80-610 BC, the iron smelting site of Paludina near Schilpario was investigated.In early medieval times a peculiar type of self-management of mineral resources is documented. In these valleys thebergamasque blast furnace had an early development at least since the XI century.
52) ZOPPETTI 1894. Si è assunto di proposito, nel testo, lanomenclatura delle varie parti interne dell’altoforno allabergamasca.
53) L’ultimo atto della storia millenaria della siderurgia in ValGrigna è stato documentato in Valle delle Forme, località piùbassa e più accessibile della vicina Val Gabbia: qui nel XIV-XVsecolo era attivo un altoforno “maturo” collegato ad una fucinagrossa e a un pestaloppe, CUCINI TIZZONI 2008.
55
Riferimenti bibliografici
ANTONUCCI G.1926 I Capitani di Scalve, in Atti Ateneo di Bergamo
n.s., I, vol. XXVII, pp. 10-17.
ARCHETTI G.2006 Ferro e miniere nelle valli bresciane. Il “Centro di
documentazione per la storia e l’arte del ferro” e lastoriografia recente, in P.P. POGGIO-C. SIMONI(a c. di), Musei del ferro in Europa e in Italia, Attidel convegno (Brescia 24-25 settembre 2004),Brescia, pp. 43-56.
ARENA M.S.-DELOGU P.-PAROLI L.-RICCI M.-SAGUÌ L.-VENDITTELLI L.2001 (a c. di), Roma dall’antichità al Medioevo. Archeologia
e storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi,Milano.
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ J.M.-DOMERGUE C.-SILLIÈRES P.2002 (eds.), La Loba (Fuenteobejuna, Cordoue, Espagne).
La mine et le village minier antiques, Bordeaux.
BROGIOLO G.P.-CHAVARRIA ARNAU A.2005 Aristocrazia e campagne nell’Occidente da Costantino a
Carlo Magno, Firenze.
CUCINI TIZZONI C.1994 Miniere e metallurgia in alta Val Brembana-Bergamo
(secoli XII-XVI), in Bergomum, 2, pp. 47-98.2001 Dieci anni di ricerche sulla siderurgia lombarda: un
bilancio, in Ph. BRAUNSTEIN (ed.), La sidérurgiealpine en Italie (XIIe-XVIIe siècle), École Françaisede Rome, Roma, pp. 31-48.
2008 Il maglio, la fucina, i forni e il pestaloppe della Valledelle Forme (Bienno, Brescia) , in NotizieArcheologiche Bergomensi, 16, pp. 205-226.
CUCINI TIZZONI C.-TIZZONI M.2004 La lavorazione del ferro, in R.C. DE MARINIS-G.
SPADEA (a c. di), I Liguri. Un antico popolo europeotra Alpi e Mediterraneo, Milano, V.2.45, pp. 328-330.
2006-a I forni di riduzione e le forge. Gli scarti della produzionesiderur gica: le scorie, i frammenti metallici, inTIZZONI-CUCINI-RUFFA 2006, pp. 73-128.
2006-b Alle origini dell’altoforno: i siti della Val Gabbia e dellaVal Grigna a Bienno in Valcamonica, in P.P.POGGIO-C. SIMONI (a c. di), Musei del ferro inEuropa e in Italia, Atti del convegno (Brescia 24-25 settembre 2004), Brescia, pp. 21-42.
c.s. Early Iron Working in Northern Italy: a review of theEvidence, in B. CECH (ed.), Early Iron Working inEurope. Prehistoric, roman and medieval IronProduction, International Conference (Hüttenberg,Carinthia, Austria, 8th-12th September 2008).
DOMERGUE C.1990 Les mines de la péninsule ibérique dans l’antiquité
romaine, Collection de l’École Française de Rome,127, Roma.
FLUZIN Ph.2006 Premier résultats des études métallographiques concernant
les masses de metal brutes, in TIZZONI-CUCINI-RUFFA 2006, pp. 129-146.
FORTUNATI M.-GHIROLDI A.2006 Vilminore di Scalve (BG). I siti del Monte Tornone e la
Pieve di S. Pietro, in Notiziario SoprintendenzaArcheologica Lombardia, pp. 44-48.
GIANNICHEDDA E.2007 Metal production in late Antiquity: from continuity of
knowledge to changes in consumption, in D. LAVAN-E. ZANINI-A.C. SARANTIS (eds.), Technologyin transition: AD 300-650 , Late AntiqueArchaeology, 4, 2006, Leiden, pp. 187-209.
GIANNICHEDDA E.-MANNONI T.-RICCI M.2001 Ricerche sui cicli produttivi nell’atelier della Crypta
Balbi, in ARENA et Al. 2001, pp. 331-334.
GRASSI DI SCHILPARIO G.B.1899 Alcune notizie sulla valle di Scalve, Bergamo.
LAVAN L.2007 Explaining technological change: innovation, stagnation,
recession and r eplacement , in D. LAVAN-E.ZANINI-A.C. SARANTIS (eds.), Technology intransition: AD 300-650 , Late AntiqueArchaeology, 4, 2006, Leiden, pp. XX-XL.
LEROY S.-DILLMANN Ph.-TEYREGEOL F.-TIZZONI M.-CODINA O.-VERNA C.-FLUZIN Ph.c.s. Chemical signature determination for ferrous products
diffusion studies, in B. CECH (ed.), Early Iron Workingin Europe. Prehistoric, roman and medieval Iron Production,International Conference (Hüttenberg, Carinthia,Austria, 8th-12th September 2008).
MAINONI P.2001 La politica dell’argento e del ferro nella Lombardia
medievale, in Ph. BRAUNSTEIN (ed.), La sidérurgiealpine en Italie (XIIe-XVIIe siècle), École Françaisede Rome, Roma, pp. 417-453.
MAIRONI DA PONTE G.1819 Dizionario odeporico o sia storico-politico-naturale della
provincia bergamasca, Bergamo, rist. anast., Bologna,1972.
1825 Sulla geologia della provincia Bergamasca, Bergamo.
MELLI P.2004 Genova. Dall’approdo del Portofranco all’emporio dei
Liguri, in R.C. DE MARINIS-G. SPADEA (a c.di), I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi eMediterraneo, Milano, pp. 285-297.
MIGHALL T.M.-TIZZONI M.-CUCINI TIZZONI C.-O’BRIEN C.2003 The impact of Iron Age copper mining on vegetation:
palaecological evidence from Campolungo, Bienno, LombardAlps, Northern Italy, in Notizie ArcheologicheBergomensi, 11, pp. 253-271.
MILANESE M.1987 Scavi nell’oppidum preromano di Genova (S. Silvestro
1), Roma.
MORIN D.1999 La miniera di ferro di Piazzalunga, in C. CUCINI
56
TIZZONI-M. TIZZONI (a c. di), La minieraperduta. Cinque anni di ricerche archeometallurgiche nelterritorio di Bienno, Breno, pp. 49-60.
MORIN D.-TIZZONI M.2009 Aux origines des techniques minières. L’exploitation d’un
gisement filonien au Premier Âge du Fer. Les mines deSilter di Campolungo et de Baita Cludona di Fondo(Val Camonica, Alpes lombardes, Italie), in Bulletinde la Société Préhistorique Française, 106/1, pp.109-141.
RICCI M.1997 Relazioni culturali e scambi commerciali nell’Italia centrale
romano-longobarda alla luce della Crypta Balbi in Roma,in L. PAROLI (a c. di), L’Italia centro-settentrionale inetà longobarda, Ascoli Piceno, pp. 239-273.
2001 La produzione di merci di lusso e di prestigio a Roma daGiustiniano a Carlomagno, in ARENA et Al. 2001,pp. 79-87.
SCHARF G.P.G.2007 L’autonomia “alla prova del fuoco”. Bergamo di fronte alle
sue valli nella gestione dei diritti minerari dal XIII a metàdel XIV secolo, in Archivio Bergamasco, Quaderni,I, pp. 13-29.
SEECK O.1876 Notitia Dignitatum accedunt Notitia urbis
Constantinopolitanae et Latercula provinciarum, Berlin.
TIZZONI M.1986 La romanizzazione dei territori alpini: continuità della
tradizione preromana in area alpina, in La Lombardiatra protostoria e romanità, Atti del 2° convegnoArcheologico Regionale (Como,13-15 aprile1984), Como, pp. 199-205.
1997 Il comprensorio minerario e metallurgico delle valliBrembana, Torta ed Averara dal XV al XVII secolo,Bergamo.
1998 Il comprensorio minerario e metallurgico valsassinese,Materiali IX-X, Monografie Periodiche dei MuseiCivici di Lecco, Lipomo.
2001 Tomaso Moroni da Rieti e le ferriere del Piacentino nelXV secolo, in Ph. BRAUNSTEIN (ed.), Lasidérurgie alpine en Italie (XIIe-XVIIe siècle), ÉcoleFrançaise de Rome, Roma, pp. 289-325.
s.d. L’officina fusoria, in A. CERESA MORI (a c. di),Dal cantiere alla storia. Lo scavo di via Puccini a Milano,Milano, scheda 5.
TIZZONI M.-CUCINI C.-RUFFA M.2006 (a c. di), Alle origini della siderurgia lecchese. Ricerche
archeometallurgiche ai Piani d’Erna, Lecco.
ZOPPETTI V.1873 Stato attuale dell’industria del ferro in Lombardia e cenno
sul possibile sviluppo della siderurgia in Italia, Milano.1894 Manuale di siderurgia, Milano.