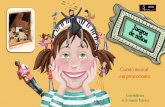Prosecuzione delle ricerche al teatro
Transcript of Prosecuzione delle ricerche al teatro
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento di Archeologia
Missione Archeologica in Albania
Istituto Archeologico AlbaneseDipartimento di Antichità
PHOINIKE IVRapporto preliminare sulle campagne
di scavi e ricerche 2004-2006
a cura di
Sandro De Maria e Shpresa Gjongecaj
ESTRATTO
Il Progetto Phoinike e le attività della Missione Archeologica Italiana sono sostenuti dalMinistero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Direzione Generale per laPromozione e la Cooperazione Culturale.
Volume realizzato con il contributo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Redazione scientifica: Simone Rambaldi
Le traduzioni dall’albanese dei capitoli 3c, 5c, 8 sono di Julian Bogdani.
www.phoinike.com
© 2007 Ante Quem soc. coop.© 2007 Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna
Ante Quem soc. coop.Via C. Ranzani 13/3, 40127 Bolognatel. e fax +39 051 4211109www.antequem.it
redazione e impaginazione: Valentina Gabusiimpianti: Color Dimension, Villanova di Castenaso (Bo)
ISBN 978-88-7849-029-1
5
IndIcE
Introduzione 7Sandro De Maria
1. Ricerche, ricognizioni e saggi stratigrafici nella città alta 13Julian Bogdani, Enrico Giorgia. Ricognizioni e rilievi nel settore occidentale (mura e area D) 13b. Saggi stratigrafici nelle mura (aree A 39, B 13-17) 18
2. La basilica paleocristiana 31Albana Meta, Marco Podini, Michele Silania. La situazione dell’edificio dopo le ricerche precedenti (1926-2003) 31b. Le nuove indagini (2004-2006) 32Appendice. Le foto da aquilone con il sistema KAP: il caso della basilica di Phoinike 54
3. Prosecuzione delle ricerche al teatro 59Sandro De Maria, Dhimiter Çondi, Anna Gamberini, Marco Podini, Riccardo Villicicha. Conclusione delle ricerche nell’edificio scenico: frontescena e pulpitum 59Appendice. Caratteri della decorazione architettonica 66b. L’orchestra e l’analemma orientale 71c. L’altare dell’orchestra 74d. La base onoraria cilindrica 75e. I saggi nella cavea 78f. Il terrazzamento e il percorso superiore 79g. Considerazioni sui materiali rinvenuti 81h. Le fasi costruttive del teatro 83
4. Il saggio nel terrazzo superiore al teatro (area A 37) 85Marco Podini
5. La necropoli e le aree limitrofe 89Antonio Curci, Anna Gamberini, Giuseppe Lepore, Belisa Mukaa. Conclusione delle ricerche nell’area S 5 della necropoli: l’edificio 38 89b. L’area meridionale (S 18): il tempietto 6, i monumenti vicini e l’area scoperta 92c. Ricerche nel settore sud-orientale della necropoli: le tombe ellenistiche
dell’area S 16 e i percorsi interni 102d. Dati preliminari su corredi e materiali rinvenuti 106e. Osservazioni sui resti faunistici 110f. Considerazioni generali 117
6. Osservazioni sulle stele funerarie ellenistiche di Phoinikee note sulla produzione epigrafica 121Sandro De Maria, Enrico Gurini, Gianfranco Pacia. Premessa ed elenco delle stele note e documentate 121b. Collocazione, morfologia e decorazioni delle stele funerarie 127c. Incisione e formulazione del testo epigrafico 130d. Analisi sulle superfici delle stele funerarie 135
7. La “città bassa” ai piedi della collina 143Julian Bogdani, Enrico Giorgi, Giuseppe Leporea. Il saggio nell’area S 1 143b. L’identificazione di nuovi siti 145
8. Il sito fortificato di Malçani e il koinòn dei Caoni 149Dhimiter Çondi
9. Terra sigillata orientale e italica a Phoinike: risultati preliminari 157 Eduard Shehi
10. La circolazione delle monete a Phoinike 167Shpresa Gjongecaj
11. Testimonia Urbis Phoenices, III. Lo Pseudo-Michele Nepote e i viaggiatori in Epiro (secoli XI-XX) 177Simone Rambaldi
12. Caratterizzazione minero-petrografica del materiale lapideo utilizzato nelle costruzioni di età ellenistica e romana 213Gian Carlo Grillini, Enrico Gurini, Vanna Minguzzi
13. Interventi conservativi nei settori C 10, C 1 e A 23 (2004-2006) 223Michele Ricciardone
14. Appendice. Les Chaones et l’Épire, de l’indépendance à l’association (Ve-IIe siècles avant J.-C.) 227Pierre Cabanes
Bibliografia 239
Elenco delle figure e referenze fotografiche 251
6
59
a. conclusione delle ricerche nel-l’edificio scenico: frontescena e
pulpitum
In ambito archeologico, ogni nuova campa-gna di scavo che si somma alle precedenti costi-tuisce un’ulteriore tappa verso il completamen-to di quel mosaico il cui fine ultimo è ilprocesso conoscitivo di un sito antico e le cuitessere sono i singoli indizi. Così, anche nel casodegli scavi del teatro di Phoinike (Fig. 3.1),ormai giunti alla fase culminante, i nuovi datiemersi nel corso delle ultime tre campagne
hanno permesso di fare chiarezza sull’interomonumento, trasformando in ragionevoli cer-tezze quelle che erano solo ipotesi o, come sug-gerito poco prima, indizi1.
Sono stati raggiunti, in particolare, risultatideterminanti per la comprensione delle fasicostruttive del teatro e dei passaggi cronologiciche ne hanno scandito la lunga vita. Questoaspetto sarà trattato diffusamente di seguito,nella sezione consuntiva e riepilogativa di questoquarto rapporto preliminare sul teatro diPhoinike (Fig. 3.2). Inevitabilmente, nelle ultimecampagne, le risorse maggiori sono state desti-
3. Prosecuzione delle ricerche al teatro
Villicich); Phoinike II, pp. 53-62 (R. Villicich);Phoinike III, pp. 67-87 (R. Villicich, J. Bogdani, G.Giannotti).
1 In riferimento alle precedenti campagne di ricognizio-ne e di scavo nell’area del teatro, rimando ai seguentirapporti preliminari: Phoinike I, pp. 49-54 (R.
3.1. Planimetria generale del teatro alla conclusione della campagna di scavo 2006 (rilievo e rielaborazione J. Bogdani, R. Villicich).
nate allo scavo dell’orchestra (Fig. 3.3), che hariservato inaspettate e fortunate sorprese sia peril buono stato di conservazione delle strutture,sia per i dati cronologici acquisiti. Le ricerche sisono incentrate, inoltre, nel settore orientale delteatro, dove sono stati parzialmente riportati inluce l’analemma e la parodos. Saggi conoscitivisono stati effettuati nella cavea, con lo scopo diindividuare lo stato di conservazione delle gradi-nate che precedenti indizi suggerivano forte-mente degradate se non completamente spoglia-te. Allo stesso tempo, ha preso avvio lo scavo delsettore nord-occidentale della sommità del tea-tro, in coincidenza di alcune strutture murarieaffioranti, già individuate nel corso della campa-gna di ricognizioni del 2000; grazie a questointervento, preceduto da un intenso lavoro dipreparazione e di pulitura, è emerso dalla terraun lungo tratto di muro, con andamento curvi-lineo, che potrebbe corrispondere alla strutturamuraria che delimitava la “schiena” del koilon,alloggiata in una delle ampie conche della colli-
na di Phoinike. Infine, sono stati portati a com-pimento gli scavi della frontescena e del pulpi-tum, entrambi oggetto di un primo, tempestivo,intervento di consolidamento e restauro.
Nonostante le indagini archeologiche in que-st’ultimo settore potessero dirsi grosso modoconcluse già nella campagna del 20032, le ulti-me ricerche hanno fornito un ulteriore contri-buito per la conoscenza dell’intero edificio sceni-co, soprattutto della sua fase ellenistica, per ovvimotivi meno intelligibile rispetto alla successivafase romana, che la sostituirà in modo radicale.Della ricostruzione romana della frontescena, dainquadrarsi, con tutta probabilità, nei primidecenni del III sec. d.C., restavano da chiariresolo pochi aspetti, prevalentemente di carattereinterpretativo (Fig. 3.4). Ricapitolando, è ormai
2 Per le fasi ellenistiche dell’edificio scenico si vedaPhoinike III, pp. 73-76 (R. Villicich); per la fase roma-na ibid., pp. 76-80 (J. Bogdani).
riccardo Villicich
60
3.2. Veduta panoramica del teatro da est.
prosecuzione delle ricerche al teatro
61
3.3. Planimetria del settore centrale del teatro; in evidenza
le fa
si dell’o
rchestra e dell’ed
ificio scenico (rilievo e rielab
oraz
ione J. B
ogda
ni).
certo che la scaenae frons presentasse tre ingressi econsistesse in un lungo diaframma murario,movimentato da nicchie con semicolonne lateri-zie. L’ingresso centrale era di poco sopraelevatorispetto ai due laterali ed era l’unico che consen-tisse un accesso diretto al piccolo, basso e ano-malo pulpitum antistante, di dimensioni talmen-te ridotte, se raffrontato alla lunghezza del murodella frontescena, da essere interdetto alle duevalvae hospitales, delegate ad un ruolo più acces-sorio che funzionale, almeno nel caso di rappre-sentazioni teatrali. La frons pulpiti, oltre ad esse-re evidentemente sottodimensionata in altezza,era una struttura molto semplice e modesta(sulla falsariga della frontescena), vivacizzatasulla fronte da quattro nicchie semicircolari. Ilpulpitum, costituito con tutta probabilità da unassito ligneo, doveva presentare un elevato com-plessivo non superiore ai cm 40 rispetto al pianodell’orchestra. Diversi punti interrogativi sussi-stono sulla reale fisionomia del postscaenium; benpoco si può aggiungere a quanto già ipotizzato,anche perché il muro che chiudeva a meridionel’edificio scenico di età romana, impostato sullefondazioni della precedente struttura ellenistica,è crollato a valle fino all’ultima pietra (e matto-ne), a seguito del collasso del sistema di terraz-zamento.
Interessanti novità per l’età romana proven-gono dallo scavo nel settore immediatamente alevante del pulpitum, quasi di fronte alla porta
orientale della frontescena. Si tratta di dati edelementi utili per comprendere quelli chepotremmo definire i “secoli bui” del teatro, coin-cidenti con i primi due dell’impero. Con questaespressione si intende non tanto un compartocronologico di manifesta decadenza, quanto unperiodo archeologico “velato” dalla mancanza difasi costruttive significative, ad eccezione dilimitati interventi di routine, funzionali alla con-servazione e alla riqualificazione delle struttureprecedenti. In quest’ottica, la scoperta di unbasamento cilindrico destinato a sostenere unastatua, con evidenti tracce di riutilizzo dopo unaprobabile damnatio memoriae, potrebbe inqua-drarsi nel periodo suddetto ed essere ricondottoalla presenza di Nerone in Grecia3. La naturalepropensione ad abbellire e migliorare i proprimonumenti simbolo, da parte di una comunità,non necessariamente si traduce in radicali inter-venti architettonici, ma frequentemente si esau-risce in semplici aggiustamenti volti a valorizza-re quanto già esistente, attraverso ilpotenziamento e il rinnovamento della paruredecorativa.
I livelli d’uso del piano in “battuto” dell’or-chestra costituiscono un’ulteriore fonte di indiziin riferimento alle fasi non strutturali e di pas-saggio del teatro. Alcuni saggi, di cui si è dettonel volume precedente4, effettuati subito amonte della frons pulpiti, evidenziano un’orche-stra pluristratificata, dove la sovrapposizione disottili strati di I e II secolo d.C., “tagliati” dallafondazione del muro del pulpitum di inizi IIIsecolo, costituiscono la prova della presenza diinterventi di sistemazione e di accrescimento deipiani di calpestio.
In senso assoluto, le scoperte più interessantie inaspettate riguardano la scena di età ellenisti-ca; mi riferisco, soprattutto, al rinvenimento dialcuni capitelli e basi di colonna reimpiegatiall’interno della frons pulpiti, grazie ai quali sonosempre più numerosi i dati per la ricostruzionedell’impianto scenico preromano (Fig. 3.5). Nelpiccolo muro del pulpitum sono stati rinvenutitredici5 elementi di decorazione architettonica:
3 Per una descrizione dettagliata del basamento cilindri-co e per un suo inquadramento cronologico, rimandoal contributo di S. De Maria, in questo stesso capitolo.
4 Si veda Phoinike III, pp. 80-81 (J. Bogdani).5 Sono stati riconosciuti come certi solo i pezzi reimpie-
gati nel paramento in vista del piccolo muro. Non è
riccardo Villicich
62
3.4. I resti della frontescena romana.
sei basi, sei capitelli e un pezzoincerto (forse una base, forse unframmento di fusto). Si tratta, evi-dentemente, di basi e capitelli desti-nati a completare le semicolonne delproskenion oppure della skenè6.Confrontando le sei basi certe conquella dell’unico pilastro con semi-colonna in situ, appartenente consicurezza al proskenion ellenistico, delquale costituiva l’elemento conclusi-vo nel suo limite occidentale (Fig.3.6), si sono riscontrate evidentisimilitudini, ma anche alcune diffor-mità. Se le misure sembrano compa-tibili, anche se non proprio identi-che7, altri particolari creanoperplessità, suggerendo la possibilitàche i frammenti rinvenuti siano per-tinenti all’ordine superiore dell’im-pianto scenico, costituito da unaskenè (forse con tyromata), movimen-tata da una serie di semicolonneioniche. Le basi di colonna e i capi-telli reimpiegati nel muro romano,infatti, presentano caditoie per lasaldatura con i pezzi contigui e lestesse basi hanno un foro centralepredisposto per l’inserimento delperno destinato a legarle con il bloc-co superiore, mentre nella base insitu non sembrano riscontrarsi nessu-no dei due sistemi di assemblaggio,sulla falsariga di un lungo frammen-to di pilastro con semicolonna (Fig.3.7), rinvenuto, non in posto, nelcorso di una delle campagne di scavoprecedenti8. La parte terminale ditale blocco, che pur fortemente dete-riorato si può attribuire con certezzaalla facciata del proskenion, presenta
un evidente incasso predisposto per l’alloggia-mento del pezzo sulla sommità di una delle basi(andate perdute) dell’ordine inferiore dell’edifi-cio scenico ellenistico. Anche in questo caso,sono assenti fori e caditoie per favorire la con-giunzione fra fusto e base, che doveva esseregarantita esclusivamente dal peso dell’elementolapideo soprastante9. Si tratta, in ogni caso, di
9 Due cavità per la colata metallica sono presenti, inve-
escluso che nel conglomerato interno della struttura,oppure nella fondazione inferiore, vi siano altri fram-menti o elementi integri.
6 Per un’analisi più approfondita degli elementi didecorazione architettonica pertinenti all’edificio sceni-co di età ellenistica, si veda, di seguito, la trattazionedi M. Podini.
7 Va tenuto presente, a questo proposito, che gli ele-menti di decorazione architettonica reimpiegati nelmuro romano sono molto più deteriorati e consuntirispetto all’unica base con semicolonna ancora in situ.
8 Si veda Phoinike III, pp. 74-75, Fig. 5.9 (R.Villicich).
prosecuzione delle ricerche al teatro
63
3.5. Tre basi ioniche reimpiegate nel muro del pulpitum dietà romana, attribuibili alla skenè ellenistica.
3.6. Base ionica, ancora in situ, sormontata da frammentodi pilastrino con semicolonna, appartenente al proskenion dietà ellenistica.
riscontri che necessitano di futuri approfondi-menti, in modo tale da poter attribuire con cer-tezza i suddetti elementi architettonici alla fac-ciata del proskenion o a quella della presumibileskené. Certamente il materiale lapideo (arena-ceo10) e la tipologia (basi e capitelli ionici) di
tutti gli elementi architettonici, reimpiegati ein posto, coincidono, suggerendone, quindi, lamedesima fase costruttiva.
Dai dati in nostro possesso, come si è detto,appare sempre più intelligibile la fisionomia diquello che doveva essere l’edificio scenico di etàellenistica, anche se della facciata del proskenion,integralmente sostituita dal muro della fronte-scena romana, non resta null’altro se non la baseionica di cui si è detto prima11, sormontata daun frammento di fusto di pilastrino con semico-lonna scanalata, conservato per un’altezza dicirca cinquanta centimetri. Il blocco lapideoquadrangolare di calcare bianco sopra cui è col-locata la base di semicolonna costituisce, eviden-temente, un residuo dello stilobate destinato asostenere la fronte architettonica dell’edificioscenico. Sotto la scaenae frons romana, sovrappo-sta al precedente proskenion, non si riconosconoaltri evidenti resti dello stilobate ellenistico, senon per un corso inferiore di pietre pertinentialla fondazione (Fig. 3.8). È del tutto plausibileche i bei blocchi di forma quadrangolare desti-nati a sostenere la teoria di pilastrini con semi-colonna del proscenio ellenistico siano stati spo-gliati e riutilizzati durante il rifacimentoromano del III secolo, quale bene prezioso dautilizzarsi anche per la ricostruzione di altrimonumenti di Phoinike, forse limitrofi al teatrostesso12. Nel corso degli ultimi scavi, tuttavia, èvenuto in luce un tratto della seconda parodos delteatro, in prossimità dell’analemma orientale, cuisi appoggiava. Si tratta, come vedremo successi-vamente, della parodos traslata circa tre metri adoriente, rispetto alla sua sede originaria, nelcorso dei lavori di ingrandimento e di monu-mentalizzazione del teatro, riconducibili ad unaseconda fase ellenistica. In questo frangente,anche l’edificio scenico dovrebbe essere statoprolungato di qualche metro, sia ad est che adovest13, per simmetria con la nuova orchestra,più grande rispetto alla precedente. Nella pros-sima campagna di scavo sarà di primaria impor-tanza individuare l’angolo che congiunge laparodos orientale alla fronte di pilastrini consemicolonne. Nella peggiore delle ipotesi, pre-
ce, nella sommità del blocco suddetto, per favorire laconnessione con il segmento di fusto direttamentesuperiore.
10 Per una prima campionatura del materiale lapideo uti-lizzato per la costruzione del teatro di Phoinike, riman-do a Phoinike III, pp. 181-186 (E. Gurini).
11 Si veda Phoinike III, pp. 73-76 (R. Villicich).12 Si veda, a questo proposito, quanto già ipotizzato ibid.,
p. 75. 13 Sicuramente ad oriente, ma con tutta probabilità
anche ad occidente.
riccardo Villicich
64
3.7. Segmento inferiore di un pilastrino con semicolonna delproskenion, rinvenuto fra il materiale architettonico erratico.
3.8. Resti della frontescena di età romana; in evidenza i bloc-chi lapidei sottostanti, appartenenti alla fondazione del pro-skenion ellenistico.
supponendo di non trovare in situ altri elementiarchitettonici della facciata del proskenion nel suolimite orientale, sarà ugualmente possibile defi-nire la lunghezza effettiva dell’edificio scenico dietà ellenistica, ipotizzando anche ad est la stessadistanza che intercorre fra l’angolo occidentale eil primo pilastro con semicolonna del proskenion.Immediatamente ad est del limite orientale dellafrontescena romana, tra l’altro, è stato rinvenutoancora in situ, lungo lo stesso allineamento, unblocco di calcare bianco facente parte dello stilo-bate ellenistico, assolutamente speculare a quel-li ancora in posto rinvenuti verso il limite occi-dentale del proscenio. Come già osservato, ipilastrini con semicolonna dell’ordine inferioredell’edificio scenico sostenevano il piano sopra-stante del logheion, sul quale recitavano gli atto-ri. La presenza del sistema con logheion e skenèretrostante è confermata non solo dalla scopertadei suddetti elementi architettonici, reimpiega-ti nel muro del pulpitum di età romana, ma anchedal rinvenimento, nelle campagne di scavo pre-cedenti, di alcuni blocchi lapidei recanti l’allog-giamento per l’incastro dei portanti su cui sireggeva il piano rialzato14. Sulla base dei dati innostro possesso, comunque, non è possibile ipo-tizzare se il pavimento del logheion fosse di pie-tra, come a Priene, oppure consistesse in un assi-to ligneo. Era pratica comune, nella maggiorparte dei casi, privilegiare l’uso di pavimentazio-ni lapidee, meno deperibili, evidentemente,rispetto a quelle lignee. La tipologia di edificioscenico con logheion15, di cui il teatro di Prienecostituisce uno dei modelli meglio conservati,trova riscontro nella maggior parte degliimpianti di area illirico-epirota (fra cui Dodona,Byllis, Kassope, Apollonia e Nikaia16) e, più ingenerale, pur con diverse varianti, costituisce lasoluzione più diffusa nei teatri del mondo grecodurante l’età ellenistica: ricordo, fra i tanti esem-pi, oltre al già citato caso di Priene17, i teatri di
Oropo18 ed Eretria19 in Grecia e quelli diAfrodisia20 ed Arykanda in Asia21. La completadistruzione della skenè, avvenuta già in età roma-na, ne rende complessa qualsiasi restituzioneipotetica, ma il rinvenimento dei già citati capi-telli e basi di colonna, se appartenenti al secon-do ordine dell’edifico scenico, come si suppone,confermerebbe una scena articolata in thyromata,scanditi da una serie di semicolonne ioniche.Della skenè di età ellenistica resta, comunque,una flebile traccia nel lungo muro di fondazione,con andamento est-ovest, composto da un filaredi blocchi lapidei accostati e messi in opera asecco, sul quale in epoca romana verrà costruitoil muro di chiusura del postscaenium.
Nel suo complesso, a Phoinike l’edificio sceni-co di età ellenistica sembra vantare caratteristi-che di eccezionalità per due aspetti: le dimensio-ni e la scelta degli ordini architettonici, che necostituiscono la parure decorativa.
È ipotizzabile che il solo proskenion raggiun-gesse i 33 metri di lunghezza (la frontescena dietà romana, di minori dimensioni, misura esat-tamente m 31 e cm 20). Mentre tutta la facciatadell’intero edificio scenico, dall’angolo con laparodos occidentale all’angolo con quella orienta-le, conta una lunghezza complessiva di 36 metri.Si tratta di dimensioni che fanno del teatro diPhoinike uno dei più grandi dell’Epiro almenoper quanto riguarda l’impianto scenico, dalmomento che a Kassope e a Nikaia il logheion nonsupera i 12 metri, mentre nel caso di Byllis siattesta sui 20 metri. Solo il logheion del grandeteatro di Dodona si avvicina sensibilmente aquello di Phoinike, vantando una lunghezza di 31metri e 20 centimetri22. Il secondo aspettoriguarda la scelta dell’ordine ionico anche per ilproskenion, come sembra dimostrato dall’unicabase di semicolonna ritrovata in situ. Saremmo difronte, quindi, ad un prospetto scenico, articola-
pp. 27-31; DE BERNARDI FERRERO 1970, pp. 9-20.18 ARIAS 1934, pp. 66-69; NEPPI MODONA 1961, p. 31,
figg. 27-28; ISLER 1994a, pp. 227-228.19 Per il teatro di Eretria si vedano NEPPI MODONA
1961, pp. 36-39; ISLER 1994b, pp. 215-216.20 Sul teatro di Afrodisia rimando, in generale, a ERIM
1974, pp. 162-165; DE CHAISEMARTIN, THEODORESCU
1991, pp. 29-69.21 Sul teatro di Arykanda si vedano DE BERNARDI
FERRERO 1974, pp. 155-161; ISLER 1994c, p. 370. 22 Si veda BAÇE 2002-2003, p. 396. La lunghezza del
logheion del teatro di Dodona equivale a quella dellafrontescena romana del teatro di Phoinike.
14 Si confronti Phoinike III, pp. 74-75, Fig. 5.10 (R.Villicich).
15 Per quanto concerne il sistema del logheion e gli edifi-ci scenici in età ellenistica rimando a NEPPI MODONA
1961, pp. 27-40, DE BERNARDI FERRERO 1974, pp.48-52. Sui teatri di età ellenistica in generale, si veda,da ultimo, FREDERIKSEN 2000, pp. 135-175.
16 Sui teatri dell’Epiro in generale, si confronti, da ulti-mo, BAÇE 2002-2003, pp. 365-411. Sul teatro diDodona si vedano anche CEKA 1993, pp. 130 (tav. IVC) e 132; ISLER 1994, pp. 200-202.
17 Sul teatro di Priene si vedano NEPPI MODONA 1961,
prosecuzione delle ricerche al teatro
65
to in due ordini architettonici, skenè e proskenion,entrambi di ordine ionico. È più frequente, inve-ce, la scelta del dorico per il proskenion e delloionico per la skenè23.
Allo stato attuale delle ricerche, non è ancoradel tutto certo se gli elementi architettonici rin-venuti, in situ e riutilizzati all’interno del muroromano, siano da attribuirsi alla prima fase dell’e-dificio scenico, databile con tutta probabilità nellaprima metà del III secolo a.C., o facciano partedell’imponente fase di ristrutturazione del secolosuccessivo. Il materiale lapideo, arenarie e calcare-niti, di qualità non eccelsa, farebbe propendere,tuttavia, per la prima ipotesi, dal momento che,nella seconda fase, è documentato l’uso pressochéesclusivo di un bel calcare bianco sicuramentesuperiore al materiale utilizzato in precedenza. Lostudio dei capitelli e delle basi conferma, comun-que, un orizzonte cronologico di III secolo a.C.24.È del tutto probabile, quindi, che la decorazionedella scena sinora rinvenuta appartenga alla faseoriginaria del teatro e che sia rimasta in uso anchedopo i massicci lavori di ristrutturazione dellaseconda fase ellenistica25. Si tratta, in ogni caso,come detto precedentemente, di un’ipotesi assaiprobabile, ma ancora in attesa di conferma.
Riccardo Villicich
aPPendice. caratteri della decora-zione architettonica
Il ritrovamento di una serie di elementi archi-tettonici, riconducibili sostanzialmente a treforme (schede 1-3), consente alcune riflessionicirca l’apparato decorativo del teatro e di conte-stualizzarlo, almeno nelle sue linee generali, sottoil profilo cronologico e stilistico. Si tratta di unabase in calcare rinvenuta in situ nell’ordine infe-riore della frontescena (scheda 1)26 e di una decinadi frammenti in arenaria reimpiegati come mate-riale edilizio nel muro del pulpitum di età romana.Questi ultimi constano di almeno sei capitelli,
tutti uguali (scheda 2), anche se per lo più fram-mentari, e di altre quattro basi di tipo identico(scheda 3), queste pure molto mal conservate. Allostato delle conoscenze attuali, i materiali in que-stione sono fra i più antichi rinvenuti a Phoinike.
1. Base ionica di semicolonna addossata a pila-stro (Fig. 3.9)
Phoinike, frontescena del teatro, in situ.Scheggiature e abrasioni presenti sia sul toro
inferiore che superiore. Si conservano ancheparte della semicolonna e del pilastro annessi.
Calcare27. Base: alt. cm 11; larg. (diam. toroinferiore) cm 35,5; profond. cm 18; diam. torosup. cm 32. Semicolonna: alt. mass. cm 31; larg.cm 27. Pilastro: alt. mass. cm 35.
La base è costituita da un plinto circolare acui segue un cavetto non particolarmente alto esuperiormente delimitato da un tondino, coro-nato a sua volta da un secondo plinto, a mo’ ditoro, ma più piccolo rispetto al primo.L’imoscapo presenta nove scanalature e duesemiscanalature ai lati. La semicolonna era dun-que intagliata secondo il modello peloponnesia-co, contraddistinto cioè da venti scanalature28.Base e semicolonna sono addossate a un massic-cio pilastro con, nella parte posteriore, un incas-so destinato originariamente ad accogliere unabalaustra (di cui però non è rimasta traccia).
L’elemento deriva dal tipo più antico di basepeloponnesiaca29 e trova un buon confronto conla base della parodos del teatro di Epidauro30.
2. Capitello ionico con collarino di semicolonnaaddossata a pilastro (Fig. 3.10)
Phoinike, magazzino della Missione Archeo-logica Italiana (Saranda), reimpiegato comemateriale edilizio nel muro del pulpitum di faseromana.
Abbastanza ben conservato, solo lo spigolofrontale destro dell’abaco si presenta spezzato,così come la parte inferiore delle due volute(soprattutto quella destra). Piccole scheggiature
23 L’ordine dorico per il proskenion è attestato con sicurez-za in diversi teatri di area greca ed asiatica, fra cuiPriene, Afrodisia e Oropo.
24 Per la cronologia del materiale architettonico del teatro siveda il contributo di M. Podini in questo stesso capitolo.
25 Forse con qualche integrazione, dal momento cheanche l’edificio scenico sembra essere stato ingrandito.
26 Phoinike III, p. 74, fig. 5.8 (R. Villicich).
27 Le analisi petrografiche identificano questo calcarecome biocalcarenite a grana fine. La presenza al suointerno di dolomite (carbonato di calcio e magnesio)ha fatto pensare a un’origine non locale. Cfr. PhoinikeIII, pp. 182-183 e 186 (E. Gurini).
28 ROUX 1961, pp. 334-336.29 WESENBERG 1994, p. 608.30 HODGE HILL 1966, p. 33, fig. 6.
riccardo Villicich-Marco Podini
66
e abrasioni coinvolgono anche i fianchi (stelo delcalice sinistro) e alcuni tratti dell’abaco. Lasuperficie appare non rifinita o molto dilavata.
Arenaria. Alt. cm 14; larg. cm 28; profond. cm14; diam. voluta cm 9,3. Inv. PH 05 C1 21 3.
Il capitello, apparentemente non rifinito,mostra un echino interamente liscio e palmetteangolari piatte che scaturiscono dall’avvolgi-mento superiore del nastro delle volute. Anche ilcanale si presenta perfettamente liscio, mentre lasua forma è contraddistinta da un profilo accen-tuatamente arcuato e dalla conseguente contra-zione delle volute verso il fusto. Questo accorgi-mento accentua, lungo le estremità, la massa
cubica dell’abaco, coronato alla sommità da unasemplice modanatura a leggerissima gola rove-scia compresa fra due sottili listelli. Ai lati, lametà del pulvino è avvolta posteriormente da uncalice non rifinito e collegato a uno stelo che sipiega ad arco immediatamente sotto al pulvino,delimitandolo lungo il margine inferiore e pro-seguendo a mo’ di tondino sulla fronte, dovedefinisce superiormente il collarino.Quest’ultimo presenta nove scanalature con ter-minazione ad archetto, più altre due semiscana-lature lungo i margini laterali del fusto31. Le
31 Ciò in piena conformità con la tipologia di colonna
prosecuzione delle ricerche al teatro
67
3.9. Disegno della base ionica di tipo “peloponnesiaco” rinvenuta ancora in situ; ordine inferiore della frontescena (rilievo A.Marini).
3.10. Fronte e fianco di capitello ionico con pulvino a calice; l’elemento era originariamente addossato a pilastro (ordine superioredella frontescena).
dimensioni relativamente piccole e la distinzio-ne di questo capitello rispetto alla tipologia tra-dizionale sembrano escludere, per la realizzazio-ne del pezzo, l’applicazione di un rigorososistema modulare. Anziché l’esistenza di unmodulo fisso, si osservano però alcuni importan-ti accorgimenti metrici: in linea con la tradizio-ne ermogeniana tramandataci da Vitruvio32, lalarghezza del capitello corri-sponde al doppio dell’altezza e ilsemiabaco (la cui profonditàequivale alla metà della larghez-za) rimanda al tipo quadrato; lafronte è stata suddivisa in treparti identiche, destinando cia-scuna di esse rispettivamentealle due volute e alla larghezzadell’echino.
Il capitello appartiene a unatipologia di origine greco-pelo-ponnesiaca (infra). Rispetto allamaggior parte degli esempi notidi questa tipologia33, il capitellodel teatro di Phoinike presenta,tuttavia, due particolarità degnedi considerazione. La prima, come si è visto, è rap-presentata dalla forma arcuata del canale; l’altradal fatto che i pulvini sono in asse con le estremitàdell’abaco. Queste caratteristiche, derivanti dalleforme più antiche del capitello peloponnesiaco(infra), sono presenti anche negli esempi di capi-telli a calice provenienti da Apollonia, con cuiquesto esempio trova un ottimo confronto34.
Il frammento si colloca cronologicamente nelIII a.C., verosimilmente entro la prima metà35.
Altri cinque esemplari, diversamente frammen-tati, sono riutilizzati allo stesso modo.
3. Base ionica di semicolonna (Fig. 3.11)Phoinike, magazzino della Missione
Archeologica Italiana (Saranda), reimpiegatocome materiale edilizio nel muro del pulpitum difase romana.
Spezzati il toro superiore e soprattutto quelloinferiore, al punto che il profilo appare difficil-mente ricostruibile. La superficie è molto dilava-ta mentre abrasioni e scheggiature coinvolgonotutto l’imoscapo rendendo difficilmente leggibi-le la sequenza delle scanalature.
Arenaria. Alt. cm 11,5; larg. (diam. toro infe-riore) cm 33,5; profond. 16,7; diam. toro sup.cm 29,5. Inv. PH 05 C1 21 6.
Il cattivo stato di conservazione rende piutto-sto difficile l’analisi di questo elemento. La baseè sagomata con un plinto circolare a cui segue uncavetto, forse delimitato superiormente da unlistello e coronato da un sottile toro. In pienasintonia con le tipologie di colonne peloponne-
peloponnesiaca a 20 scanalature. Cfr. ROUX 1961, pp.334-336.
32 De Arch. III 5, 5-7.33 WEICKERT 1944, pp. 205 s.34 Negli esempi di Apollonia si osservano altri due ele-
menti estremamente interessanti. Il primo è rappre-sentato dalla presenza di volute aggettanti verso l’e-sterno (fronte concava), tratto anche questoriconoscibile nelle forme più antiche di capitelli pelo-ponnesiaci. Il secondo è invece costituito da una deco-razione floreale sempre presente al centro del canale. Sitratta di un elemento che sembra riflettere un gustodecorativo tutto locale e che trova larga diffusione econtinuità nell’area circostante, come mostrano gliesempi di Byllis. Cfr. REY 1927, p. 13, figg. 11-13;DERENNE, REY 1928, p. 15, figg. 9-11.
35 Alcuni dati formali e metrici sembrano ulteriormenteconfermare una cronologia alto-ellenistica. In primoluogo, il fatto che la linea immaginaria che congiungegli occhi delle volute tagli l’echino al centro; in secon-
do luogo, il fatto che il rapporto fra il diametro dellevolute e la larghezza massima del capitello (0,332)rimandi, secondo le tabelle metriche del Thedorescu,a valori ancora “classici”. Questi dati vanno tuttaviapresi con grande prudenza e considerati significativisolo in quanto eventuale espressione di un adegua-mento dei capitelli di piccole dimensioni e di tipolo-gia non tradizionale (come questo) ai modelli dellatradizione ufficiale. Un altro elemento importante peruna cronologia alta è rappresentato dal fatto che que-sto capitello sta insieme a basi di tipo peloponnesiaco.Cfr. THEODORESCU 1980, pp. 35 s.
Marco Podini
68
3.11. Base ionica di semicolonna (ordine superiore della fron-tescena).
siache36, l’imoscapo presenta nove scanalature edue semiscanalature ai lati (per un totale di ventia giro intero di colonna). Sul piano superiore siosservano due cavità, una nella parte posterioredi forma rettangolare (foro di incasso contro laparete), l’altro posto al centro e di forma circola-re (per il fissaggio della semicolonna superiore).L’elemento è realizzato in arenaria, di un tipoidentico a quello usato per intagliare i capitelliionici rinvenuti nel medesimo contesto (cfr.scheda 2) e appartengono certamente allo stessoapparato decorativo (ordine superiore della fron-tescena dell’edificio teatrale).
Come la base dell’ordine inferiore della fron-tescena (scheda 1), l’elemento deriva dal tipo piùantico di base peloponnesiaca. Contestuale aicapitelli ionici visti sopra (scheda 2), la base sidata al medesimo periodo (prima metà del IIIsecolo a.C.). Altri tre esemplari si trovano nellamedesima situazione di reimpiego.
Le schede dei materiali architettonici permet-tono di considerare, più in profondità e sotto varipunti di vista (tecnico, stilistico, tipologico…),alcuni aspetti specifici dell’apparato decorativodel teatro di Phoinike. Il primo dato importanteriguarda il materiale utilizzato per la realizzazio-ne dei pezzi, anche e soprattutto in rapporto allaposizione che questi ultimi occupano sulla fron-tescena: calcare nell’ordine inferiore, arenaria inquello superiore. Emerge, in tal senso, una preci-sa scelta decorativa, connessa a effetti cromatici eplastici37. L’arenaria, infatti, pietra morbida efacile da lavorare, ben si adattava alle esigenzedecorative dell’ordine superiore, di norma con-traddistinto (anche per ovviare alla minore visibi-lità del suo apparato architettonico) da una spic-cata esuberanza e da un più vivace plasticismo (daciò forse la scelta di una tipologia particolare dicapitello, quello ionico con pulvino a calice). Unelemento interessante, a questo proposito, è rap-presentato dal fatto che i capitelli ionici rinvenu-ti (scheda 2), pur di elevato livello tecnico, man-chino di plasticità, soprattutto sulla fronte, dovei singoli elementi costituitivi (canale, echino, pal-mette angolari e listelli di delimitazione) si pre-sentano poco o per niente rilevati e con profilo
completamente piatto. Trattasi, dunque, o di ele-menti non rifiniti o, più probabilmente, di capi-telli in cui la componente pittorica deteneva lafunzione decorativa primaria (come ampiamentedocumentato, per citare esempi geograficamentevicini, nelle architetture di facciata delle tombeipogee macedoni38). In via ipotetica, inoltre, nonpossiamo escludere l’uso, almeno in forma parzia-le, dello stucco, con finalità sia protettive (comerivestimento di materiali facilmente degradabili,quali appunto l’arenaria), sia estetiche, conferen-do maggiore “intensità” decorativa alle partiturearchitettoniche39.
Un altro aspetto, certamente il più significa-tivo ai fini dell’inquadramento stilistico e crono-logico dell’apparato decorativo della frontescenadel teatro di Phoinike, riguarda l’origine deimodelli architettonici prescelti. In particolare,l’analisi dei materiali ha permesso di identifica-re due tipologie ben definite: le c.d. “basi pelo-ponnesiache” (schede 1 e 3) e i capitelli ionicicon pulvino a calice (scheda 2). La prima risultachiaramente documentata in Illiria meridionalee nell’Epiro del nord40, sia in contesti pubbliciche privati. Si tratta di una fra le più antichetipologie di base attestate nella regione e certa-mente indicativa di un rapporto privilegiato conla Macedonia, dove queste sono ben attestate(Pella, Verghina)41, e più in generale colPeloponneso, dove ne fu elaborato il prototipo.
38 MILLER 1972, p. 23.39 A questo proposito, H. Lauter ha sottolineato l’im-
portanza, in età ellenistica, e nell’ambito geograficodella Macedonia e del Peloponneso (i cui modelli,come abbiamo visto, influenzarono in maniera signifi-cativa l’Epiro del III secolo a.C.), dello “stile dellostucco” che conferiva alle architetture una maggioreintensità decorativa. Cfr. LAUTER 1999, pp. 227, 229e, in particolare, 248.
40 Durante il lavoro di schedatura e studio dei materialiarchitettonici dell’Epiro del nord e dell’Illiria meri-dionale, effettuato da chi scrive come tesi di dottorato(e di prossima pubblicazione), è stato possibile ricono-scere, oltre a quelli attestati nel teatro di Phoinike,anche altri esempi di basi peloponnesiache, comequelli della casa a pastàs ad Antigonea (Caonia, Epirodel nord) o quello inedito conservato nei magazzinidel Museo dell’Istituto di Archeologia di Tirana e pro-veniente da Dimalë (Illiria meridionale). L’accesso aimagazzini e la possibilità di visionare i materiali iviconservati mi sono stati possibili per gentile conces-sione del Prof. M. Korkuti e della Prof.ssa S.Gjongecaj, che qui colgo l’occasione di ringraziarevivamente.
41 MILLER 1972, pp. 18-20 (tipo 3); ID. 1973, pp. 194-197; WESENBERG 1994, p. 608.
36 Cfr. n. 31.37 Sull’utilizzo di tipologie di pietre diverse finalizzate a
produrre voluti effetti cromatici nel teatro di Phoinike,cfr. Phoinike III, p. 186 (E. Gurini).
prosecuzione delle ricerche al teatro
69
Questa particolare forma di base è costituita daun plinto circolare, a cui segue un cavetto (ori-ginariamente piuttosto alto) coronato, a suavolta, da un toro relativamente basso e sottile. Iltipo fu in uso già a partire dall’epoca tardo-clas-sica a Basse (certamente uno dei primi esempinoti), ma si diffuse soprattutto in età alto-elleni-stica, diramandosi velocemente in tutto ilPeloponneso (Perachora, Sicione, Epidauro,Tegea, Nemea)42. Basi peloponnesiache sononote anche in ambito magno-greco, come aTaranto43 e a Paestum44, così come in altre e piùdistanti realtà del bacino mediterraneo45.
La seconda tipologia, rappresentata dai capi-telli ionici con pulvino a calice, appare pure bendocumentata nella regione (infra) ed è attestata aPhoinike anche in contesti privati46. Questaforma fu interpretata da Weickert come un pro-dotto di elaborazione magno-greca47, ipotesi poirivista da Roux, che documentò l’origine greco-peloponnesiaca del modello, riconoscendo la suacomparsa, per la prima volta in forma compiuta(anche con lo stelo), nel Ginnasio di Epidauro frala fine del IV e l’inizio del III secolo a.C.48. Inparticolare, Roux osservò come i primi passi
verso l’elaborazione di questa forma fossero rico-noscibili nei capitelli ionici del tempio di AthenaPronaia a Delfi; l’aggiunta dello stelo e dell’or-namentazione vegetale avrebbero costituito,invece, uno sviluppo in senso decorativo propriodell’ambito peloponnesiaco e, in particolare,dell’Argolide, dove prevalse uno stile ionico“fiorito”. Capitelli ionici come quelli a calice, oa quattro facce, veri e propri “non-sensi” a livel-lo di logica architettonica, non potevano nascereche in una regione priva di una tradizione ioni-ca e che aveva adottato quest’ordine soprattuttoper le sue valenze decorative. Roux considerò ladiffusione del capitello a calice come una spiadell’influenza dell’architettura peloponnesiacasu quella greco-occidentale, macedonica ed epi-rota e non condivise, come invece R. Martin (chesi appellava a Weickert), l’origine “occidentale”del motivo49. Il capitello ionico con pulvino acalice è attestato soprattutto nell’area centraledel bacino mediterraneo a partire dai territoripiù prossimi alla Caonia, come l’Illiria meridio-nale50 o l’Epiro del sud51, fino alla Macedonia52,alla Grecia, come a Olimpia53 e a Delos54, e arealtà ancora più distanti, come l’Italia meridio-nale55 e l’Egitto56.
Un tratto peculiare dei capitelli ionici con pul-vino a calice del teatro di Phoinike è rappresentatodal fatto che essi appaiano chiaramente influenza-ti, a livello formale, dai modelli peloponnesiaci di“primo tipo” (cioè quelli più antichi)57, da cuiriprendono alcune specifiche caratteristiche(come il canale superiormente ricurvo, la conse-guente contrazione delle volute lungo il fusto e inasse con le estremità dell’abaco e l’aspetto massic-cio e cubico di quest’ultimo) e di cui vengono acostituire una sorta di sottocategoria. A questoproposito, va rilevato come in Illiria meridionale
42 Roux definisce queste come “basi di stile libero” e osser-va come esse siano sempre associate alle tipologie piùantiche (o di “primo tipo”) di capitelli ionici pelopon-nesiaci. Non sembra dunque casuale che i capitelli ioni-ci a calice dell’ordine superiore del teatro di Phoinike, ecorrispondenti appunto a basi di questo tipo, non solosiano anch’essi di origine peloponnesiaca, ma presenti-no caratteristiche stilistiche e compositive molto simi-li ai capitelli ionici di primo tipo (infra). Cfr. ROUX
1961, pp. 336-339; HODGE HILL 1966, pp. 31-33, fig.6, tav. X; WESENBERG 1994, p. 608.
43 Dove però predominano forme assai più decorative.Cfr. KLUMBACH 1937, pp. 77 s., tav. 26 e Beilage D.
44 Il tempio nel foro di Paestum mostra basi di colonnecon plinti circolari decisamente alti. I capitelli sonodel tipo a echino distinto dalla zona delle volute cherichiamano, sebbene molto da lontano, tipologiedocumentate anche a Byllis. Cfr. KRAUSS, HERBIG
1939, p. 26, tavv. 3-5.45 Un esempio, pur con qualche lieve differenza rispetto
al prototipo (dovuta senza dubbio a fattori locali), èstato identificato nei magazzini del Museo diAlessandria e proviene da Canopo (Aboukir). Cfr.PENSABENE 1993, p. 473, nr. 700B, tav. 80.
46 Altri tre capitelli (ancora inediti) della medesimatipologia, ma di dimensioni decisamente inferioririspetto a quelli del teatro, sono stati rinvenuti(entrambi purtroppo in giacitura secondaria) aPhoinike: uno nella Casa dei due peristili, gli altri duenella necropoli.
47 WEICKERT 1944, pp. 205 s.48 ROUX 1961, pp. 350-353.
49 MARTIN 1953, p. 227; ROUX 1961, p. 352.50 Relativamente numerosi sono i semicapitelli ionici
con pulvino a calice provenienti da Apollonia. Questisi caratterizzano per la presenza, al centro del canale,del tipico motivo floreale. Cfr. REY 1927, p. 13, figg.11-13; DERENNE, REY 1928, p. 15, figg. 9-11.
51 Capitelli ionici con pulvino a calice sono, per esempio,attestati a Cassope. Cfr. DAKARIS 1952, pp. 354-355,figg. 39-40.
52 HEERMANN 1986, pp. 382-395 e 528-529, figg. 23s-b.53 WEIKCERT 1944, pp. 214 s., fig. 3.54 VALLOIS 1923, pp. 90 s., figg. 127-128, 135-137 e 143.55 DELBRÜCK 1912, pp. 161-162, fig. 105.56 PENSABENE 1993, pp. 86-87 e 338, scheda nr. 112.57 ROUX 1961, pp. 336-339.
Marco Podini
70
e in Epiro non siano attestati, almeno a conoscen-za di chi scrive, capitelli ionici peloponnesiaci di“secondo tipo” (più recenti e contraddistinti dauna sostanziale commistione con le tipologie atti-che, in cui l’elemento di novità più evidente è rap-presentato dall’andamento rettilineo del cana-le)58. Le ragioni di questo fenomeno vannoricercate probabilmente nel carattere marginaledi questa regione, in cui sembrano protrarsi leforme peloponnesiache più antiche, mentre siosserva una maggiore riluttanza nell’accogliere leevoluzioni più recenti di questa tipologia.
Quanto sino ad ora constatato ci permette diavanzare alcune considerazioni generali al fine dimeglio contestualizzare l’apparato decorativo delteatro di Phoinike. In termini di “cultura archi-tettonica”, va rilevato, anzitutto, come la pre-senza di capitelli ionici a calice e di basi pelo-ponnesiache – di cui abbiamo visto le aree dimaggior diffusione – confermi il pieno inseri-mento di questo edificio nel quadro di una piùampia koinè di ambito ionico-adriatico e dimatrice culturale essenzialmente greca59. In par-ticolare, l’adozione di queste tipolo-gie pare indicare, da parte dellacommittenza, una precisa volontàdi adesione a modelli più “interna-zionali”. L’uso di un linguaggioarchitettonico ampiamente condi-viso diviene così uno strumento diidentità e di auto-riconoscimentoculturale, e ciò soprattutto per unarealtà “emergente” (in termini poli-tici, economici e militari) comel’Epiro della prima metà del IIIsecolo a.C. A questo proposito, varilevato come vi sia una significati-va corrispondenza fra i dati stilisti-ci e decorativi dei materiali esami-nati e quelli storici. Come è noto,infatti, l’Epiro s’impose sulla scenapolitica e militare come potenzaautonoma a partire dall’istituzionedella symmachia epirota e, in particolare, sottoPirro (281-272 a.C.), quando il regno raggiunsela sua massima estensione (è in questa fase, inol-tre, che la tribù dei Caoni – la terza più grandedella regione e amministrata da Phoinike – entrò
a far parte della confederazione60). Che si trattas-se di un impero di fatto effimero ha, ai fini delnostro discorso, un valore relativo. Ciò che vainvece rilevato è il fatto che questo, seppurbreve, allineamento rispetto alle grandi potenzeellenistiche dovette comportare anche un rinno-vamento culturale e l’acquisizione di nuovi e piùaggiornati modelli architettonici, come conse-guenza di un’intensa, e ben documentata intutta la regione, promozione edilizia. È dunquein questa fase, e presumibilmente sotto il regnodi Pirro o poco dopo, che sembra possibile collo-care la costruzione del primo teatro di Phoinike el’elaborazione del suo apparato architettonico.
Marco Podini
b. l’orchestra e l’analemma orien-tale
Grazie alle indagini nell’orchestra (Fig. 3.12),nel corso delle campagne di scavo 2004-2006, èstato possibile confermare come l’ampio spazio
semicircolare, che vanta un diametro di circaventi metri, non sia lastricato o pavimentato, masi limiti ad un piano in terra battuta, così comeipotizzato in precedenza. Penso si possa esclude-re la possibilità di una spogliazione integrale di
60 CABANES 1976, p. 183.58 Ibid., pp. 348 s.59 CEKA 1987, p. 145, n. 46; ID. 1993; LOMAS 1993, p. 73.
prosecuzione delle ricerche al teatro
71
3.12. Veduta del settore occidentale dell’orchestra.
un ipotetico pavimento lapideo, anche perchél’assenza di un vero e proprio piano pavimentalenell’orchestra è fenomeno abbastanza frequentein area epirota e in generale nel mondo greco. Inprimo luogo si può affermare, non senza soddi-sfazione, che gran parte del diazoma inferiorerisulta ben conservato, così come la canaletta checorreva immediatamente a monte del piano del-l’orchestra, detta euripo, destinata ad accoglierele acque piovane provenienti dalle gradinate e aconvogliarle in un sistema di scarico che prose-guiva esternamente al teatro. L’euripo consiste inuna profonda canaletta (circa 60 cm), costruita inblocchi di buon calcare di colore chiaro, utilizza-to sia per le spallette che per il fondo (Fig. 3.13).
La notevole profondità dell’euripo è giustificatadalle imponenti dimensioni del teatro e, di con-seguenza, dalla grande massa d’acqua che dovevadefluire verso il basso lungo le ripide gradinate.A monte dell’euripo, è proseguito anche lo scavodel camminamento anulare inferiore, conservatoquasi integralmente (ad eccezione di qualchelacuna), consistente in lastre lapidee di calcarebianco, dallo spessore di una decina di centime-tri. Una lunga lacuna, corrispondente forse ad unsistema di transennatura, divide il cammina-mento suddetto dal diazoma inferiore, anch’essocostituito da bianche lastre lapidee. Fra cammi-namento e diazoma esiste un dislivello di circa50-60 centimetri, che suggerisce il netto “stac-co” fra la proedria e l’orchestra vera e propria. Una
serie di lastre a mo’ di transenna o altri blocchidovevano colmare il dislivello fra i due ordini. Laspogliazione integrale degli elementi lapidei diraccordo fra proedria (Fig. 3.14) e orchestra hacomportato problemi di ordine statico per ilpiano lastricato del diazoma, non più sostenutodall’originario parapetto. Per proteggere le lastreè stato necessario un primo intervento di restau-ro, grazie al quale è stata ideata una sorta di cen-tinatura, così da impedire che le stesse si frantu-massero nel corso delle operazioni di scavo.
Lo scavo dell’orchestra, peraltro ancora in viadi completamento, ha evidenziato, senza piùalcun dubbio, la presenza di due fasi strutturaliben distinte di età ellenistica.
La scoperta più importante per la compren-sione delle fasi cronologiche del teatro consistenel rinvenimento di resti (la spalletta a valle e ilfondo) di un euripo appartenente alla prima fasedel teatro, sostituito, poi, da quello attualmentevisibile e in uso fino al momento dell’abbando-no del grande edificio (Fig. 3.15). La canalettapiù antica era costruita in arenaria locale, men-tre quella più recente, come si è detto, è costi-tuita da blocchi di calcare bianco. Per far postoal nuovo euripo, più largo, al nuovo cammina-mento e al ricostruito diazoma inferiore sonostate sacrificate la proedria e le gradinate inferio-ri della prima fase. Un’altra conferma importan-te, che ci viene dall’acquisizione di questi nuovidati, riguarda la natura del tipo di pietre utiliz-zate per la costruzione dell’edificio; è ormai evi-dente, infatti, come per tutti gli elementi archi-tettonici del teatro di prima fase (euripo,analemmata, edificio scenico) si sia fatto ricorsoesclusivamente a materiale lapideo di tipo arena-
riccardo Villicich
72
3.13. Particolare delle “spallette” e del fondo dell’euripodella seconda fase ellenistica.
3.14. Uno dei sedili della proedria, rinvenuto capovolto nelsettore occidentale dell’orchestra.
ceo, mentre la seconda fase sia chiaramentecaratterizzata dal largo impiego di calcare bian-co (proveniente, probabilmente, da cave nonmolto distanti). Per comodità, durante l’ingran-dimento dell’orchestra, una gran parte dell’euri-po più antico è stata lasciata in posto senza esse-re asportata (è stata asportata solo la spalletta amonte) e la vecchia canaletta è stata successiva-mente riempita con materiale di scarto (Fig.3.16). Uno strato di terra battuta ha poi sigilla-to tutto il semicerchio dell’orchestra. Alla lucedella situazione estremamente favorevole si è
deciso di effettuare un paio di saggi nel riempi-mento fra l’euripo più vecchio e quello piùrecente, al fine di acquisire ulteriori dati sullefasi ellenistiche (Fig. 3.17). Anche se il materia-le ceramico rinvenuto nello strato di riempi-mento fra euripo di prima e seconda fase, per ilnumero esiguo di frammenti e per la tipologiascarsamente indicativa, risulta poco attendibileal fine di una cronologia assoluta, non è indiscussione l’orizzonte cronologico di età elleni-stica. Uno dei saggi ha confermato, particolarecurioso, che al momento della costruzione del-
l’euripo di seconda fase non vennesfruttata la canaletta precedente in cuidefluiva l’acqua raccolta dall’euripooriginario. Si decise, infatti, nellaseconda fase, forse perché l’area adoccidente del teatro venne occupata daaltri edifici, di far scolare l’acqua soload oriente. Scelta confermata dallapendenza progressiva verso est delfondo dell’euripo di seconda fase, cheinvece potrebbe aver sfruttato, per loscarico dell’acqua piovana, la canalettaorientale del sistema di deflusso diprima fase. Si è poi proceduto allosvuotamento di un breve tratto delriempimento dell’euripo di secondafase. Appare logico, in questo caso, cheil riempimento del profondo canale dideflusso si sia stratificato durante lefasi di abbandono del teatro.
La prosecuzione dello scavo nel set-tore orientale del teatro ha consentito
prosecuzione delle ricerche al teatro
73
3.15. Uno dei saggi nel settore ovest dell’orchestra. Si puòosservare come l’euripo di seconda fase sostituisca e in parteobliteri quello originario della prima fase, di cui si conserva-no la spalletta a valle e il fondo.
3.16. Particolare dello strato, in scaglie lapidee ed argilla,con cui è stato riempito l’euripo della prima fase, al momentodell’ingrandimento dell’orchestra e della costruzione del secon-do canale di scolo.
3.17. Immagine ravvicinata del saggio effettuato nel settoreoccidentale dell’orchestra. Si può osservare la pavimentazionedell’euripo di prima fase, a sinistra, in lastre di arenaria equella dell’euripo di seconda fase, a destra, in calcare.
che riemergesse dalla terra, per un trattodi circa 5 metri anche l’analemma est (Fig.3.18). Il muro si presenta in discrete con-dizioni e appare conservato per un’altezzaprogressiva, in direzione est, di almenoquattro o cinque corsi sovrapposti.L’analemma è costruito integralmente inarenaria, particolare che lo differenzia dalsuo gemello occidentale, che invece è statoparzialmente ricostruito con blocchi dicalcare bianco, durante gli interventi dellaseconda fase del teatro. Ai piedi dell’ana-lemma è stato scoperto un frammento diiscrizione di età ellenistica, attualmentein corso di decifrazione e studio (Fig.3.19). Durante le fasi di abbandono delteatro il muro che fungeva da analemmaorientale del teatro venne utilizzato comeparete di fondo di una sorta di casupola.Sono stati rinvenuti, infatti, i resti di unfocolare e di un muretto tardo, costruitocon materiale di reimpiego, che costituivala parete frontale dell’improvvisatacostruzione (Fig. 3.20). Al contrario del-l’analemma occidentale, che sfruttava ilbanco roccioso come fondazione, la strut-tura orientale è interamente costruita.Allo stesso modo anche la cavea orientale,almeno nel suo tratto inferiore, non èappoggiata sul banco roccioso, ma soste-nuta da una sostruzione, composta dablocchi, scaglie lapidee e muretti radialiciechi, del tutto simile al sistema di ter-razzamento meridionale.
Riccardo Villicich
c. l’altare dell’orchestra
L’altare (Figg. 3.21-22) è stato rinve-nuto nell’area dell’orchestra, vicino alcanale dell’euripo di seconda fase (II seco-lo a.C.). Ha forma cilindrica ed è di pietracalcarea, con superficie giallastra, dellostesso materiale con il quale sono statecostruite anche altre parti del teatro, adesempio alcuni blocchi dell’analemmaoccidentale.
Oltre alla rottura in due frammentinella parte superiore, secondo una linea difrattura obliqua, la superficie conserva
riccardo Villicich-dhimitër Çondi
74
3.18. Il tratto dell’analemma orientale riportato in luce nelcorso della campagna del 2006.
3.19. Frammento di iscrizione in greco, rinvenuta ai piedidell’analemma orientale.
3.20. Veduta dell’orchestra da oriente. In primo piano l’ana-lemma orientale, di fronte al quale sono riconoscibili i restidel muro di età tarda, costruito con materiale di reimpiego.
tracce di varie scheggiature e colpi subiti. Visono tre tracce di incastri per la presa e la collo-cazione sul posto. Due dei fori laterali hannoforma rettangolare di cm 5 x 5 x 3 e proseguonoverso l’orlo dell’altare, con un piccolo canaleprofondo cm 1,5 e largo altrettanto. Il foro cen-trale è di cm 6,5 x 6,5 x 4,5. Per quanto riguar-da le dimensioni, l’altezza è di m 0,81, con undiametro di m 0,7. È limitato sia nella partesuperiore sia in quella inferiore da due listellipiatti, che sporgono di cm 1 e sono alti cm 7quello inferiore e cm 6 quello superiore.Nell’area racchiusa dai listelli la superficie èstata lisciata con cura, ma sono ancora visibili letracce dello scalpello.
L’altare è decorato da ghirlande d’alloro scol-pite a bassorilievo, fissate in tre punti con nodi
piatti, ornati da motivi floreali. I puntipiù bassi delle ghirlande si trovano a cm29 dall’estremità superiore. Esso rientrafra le caratteristiche are poste nell’orche-stra dei teatri: rimanendo nella regionelimitrofa un esemplare simile è stato sco-perto a Butrinto. In quest’ultimo caso,nella superficie piatta, invece delle ghir-lande decorative sono state scolpite alcu-ne maschere e una piccola anfora. Talealtare, però, è di marmo. Anche i listelliche delimitano l’altare sono leggermentediversi, in quanto quelli di Butrinto sonopiù elaborati e lavorati con maggiorecura61. Piccoli altari di questo tipo, però,possono avere anche funzioni e colloca-zioni diverse: per esempio, in ambitofunerario. Essi sono diffusi dal tardo elle-nismo all’età imperiale romana. I piùnoti sono quelli di Rodi62.
Per quanto riguarda la datazione, l’altare diPhoinike può essere datato, su basi stilistiche, allafase romana del teatro (fra la fine del II e i primidecenni del III sec. d.C.).
Dhimitër Çondi
d. la base onoraria cilindrica
Nel corso degli scavi condotti nel tratto cen-trale dell’edificio scenico, tra la valva regia e ilmuro del pulpitum, e nel tratto centrale e centro-orientale del canale dell’iposcaenium dell’edificiodi età romana, nel settembre del 2004 si è rin-venuta una grande base cilindrica destinata asorreggere una statua onoraria (Fig. 3.23). Labase deve essere caduta o piuttosto deve esserestata rovesciata all’interno del canale dell’iposcae-nium nel corso del periodo di abbandono del tea-tro e della sua spogliazione: giaceva infatti river-sa a una quota di poco inferiore a quellaoriginaria dell’attigua orchestra, dunque essacadde quando il canale dell’iposcaenium era giàabbondantemente interrato. La sua collocazione
61 L’altare si trova esposto nel teatro di Butrinto. Permaggiori dettagli si veda GILKES 2003, pp. 243-244,fig. 8.48.
62 In FRASER 1977, pp. 24-25, si trova una cospicua seriedi questi monumenti, che dal punto di vista tipologi-co sono molto simili al nostro.
prosecuzione delle ricerche al teatro
75
3.21. L’altare rinvenuto verso il limite settentrionale dell’or-chestra, probabilmente in situ.
3.22. Fasi di documentazione dell’altare.
originaria doveva essere ovviamente nei pressi,data l’estrema difficoltà di un eventuale sposta-mento, sia per le sue dimensioni notevoli che peril suo peso rilevante. Probabilmente si deve pen-sare all’aditus (o parodos) orientale, al pari di altriesempi d’età ellenistica e romana, che vedonoqui la presenza di basi per statue celebrative63.
Si tratta di una base di forma cilindrica, altam 0,85, con un diametro di m 0,75; il materia-le è un calcare bianco compatto (biocalcareniteall’analisi petrografica)64, lo stesso impiegatoanche per alcuni segnacoli funerari della necro-poli (Fig. 3.24). La parte inferiore aveva in ori-gine un basso listello rilevato, ma in un secondomomento questo fu scalpellato, quando l’interaparte inferiore fu rilavorata, probabilmente perridurla di dimensioni. La rilavorazione fu lascia-ta grezza e a vista, perché con ogni probabilitànascosta da un basso plinto nel quale la base fuin quella occasione alloggiata. Anche la partealta reca evidenti segni di rilavorazione, soprat-tutto nella faccia superiore, che doveva alloggia-re la scultura (Fig. 3.25). Qui infatti si osservaun bordo levigato, largo cm 4, che corre tutt’at-torno alla circonferenza, mentre l’interno èuniformemente ribassato e lasciato grezzo, dun-que doveva essere nascosto alla vista, evidente-mente perché coperto dalla base circolare della
scultura che doveva sormontare la base e che cer-tamente era una statua di pietra o di marmo.Successivamente, eliminata questa, nella partecentrale della faccia superiore della base cilindri-ca furono ricavati gli incassi per i due piedi diuna seconda scultura, che andò a sostituire laprima e che doveva essere evidentemente dibronzo, per la presenza degli incavi per i piedi(lunghi cm 28, larghi 12, profondi 4)65. Le
63 Vedi essenzialmente SCHWINGENSTEIN 1977 (per ilperiodo ellenistico: pp. 104 ss.); FUCHS 1987.
64 Per i riscontri analitici del materiale lapideo vediinfra, il Cap. 12. 65 Nelle impronte per i piedi della seconda scultura
sandro de Maria
76
3.23. La base in corso di scavo.
3.24. La base con l’iscrizione erasa.
3.25. Particolare degli alloggiamenti per statue nella facciasuperiore della base.
impronte fanno intuire qualcosa della posizionedella scultura: doveva trattarsi di una statuastante, con entrambe le piante dei piedi ben ade-renti al suolo, la gamba destra leggermenteavanzata, quella sinistra arretrata e con leggeroscarto verso sinistra. Dunque è possibile chetutta la figura fosse leggermente volta a sinistra.Sulla superficie esterna della base non si notanotracce di iscrizione in rapporto a questa effigie(nella sua parte frontale), viceversa si notanochiari segni di un’iscrizione erasa un poco decen-trata, ovvero non immediatamente sottostantealla scultura di bronzo. L’iscrizione doveva dun-que essere in rapporto con la statua originaria,quella probabilmente di pietra o marmo, come siè visto, ed essere collocata al di sotto della suaparte frontale (Fig. 3.24).
L’iscrizione fu incisa direttamente sulla pie-tra, verso l’alto, e non era riquadrata. Le letteregreche, accuratamente erase così da renderlequasi completamente illeggibili, occupavanouno spazio alto cm 18, per una lunghezza massi-ma di cm 56. L’iscrizione si disponeva su quat-tro linee: le prime tre lunghe appunto cm 56, laquarta, centrata, lunga soltanto cm 25. L’altezzadelle lettere è difficilmente ricostruibile, ma dicirca cm 3-4. L’erasione, molto accurata eprofonda, rende impossibile una qualsiasi rico-struzione del testo; si riconoscono soltanto pochelettere: una ni nella prima l., un sigma come ulti-ma lettera della terza; probabilmente tois nell’ul-tima. È certo che si tratti dell’iscrizione dedica-toria dell’effigie del personaggio raffiguratonella prima delle due sculture, quella di marmoo di pietra, collocate sulla base.
Le vicende dunque di questo monumentodevono essere state le seguenti: originariamentela base con una prima scultura, di pietra o marmo,munita di un suo plinto circolare inserito allasommità del basamento di calcare, dovette esserecollocata nei pressi dell’aditus o parodos orientaledel teatro. A questa fase appartenne l’iscrizione dicui si sono rinvenute le tracce. Successivamente laprima scultura venne tolta, l’iscrizione fu erasa ela base alloggiò una nuova immagine, probabil-
mente una figura maschile stante, di dimensionivicine al vero (per le dimensioni dei suoi piedi),certamente di bronzo. Non restano tracce di unaseconda iscrizione, che possa aver sostituito laprecedente, eliminata.
Non è possibile definire con precisione itempi e i caratteri nelle procedure di dedica diqueste statue, la prima certamente onoraria, laseconda di soggetto incerto. È comunque possi-bile proporre qualche ipotesi. La base restò nelteatro fino al suo abbandono, quando cadde o fugettata nel canale dell’iposcenio, già di moltointerrato. Essa dunque fece certamente parte diun intervento abbastanza tardo rispetto al lungoperiodo d’uso del teatro, probabilmente già dietà romana imperiale. L’erasione dell’iscrizioneoriginaria e la sostituzione del personaggio raffi-gurato nella statua inducono a ipotizzare cheesso fosse un imperatore romano, colpito da abo-litio memoriae. Fra le diverse possibilità il pensie-ro corre inevitabilmente a Nerone, sia per i suoirapporti col mondo di cultura greca in generale,sia soprattutto perché si deve pensare a un qual-che legame particolare di questi con Phoinike.Egli è infatti uno dei pochissimi principes roma-ni ai quali la zecca della città dedicò una serie diconi monetali (66-67 d.C.): oltre a Nerone sol-tanto Traiano e, forse, Claudio66. Dunque un’ef-figie di Nerone nel teatro di Phoinike si collo-cherebbe in un contesto storico e di rapporti conRoma, prima dell’istituzione della provinciad’Epiro, che non sono attestati dalle fonti stori-che né da quelle epigrafiche, che peraltro man-cano interamente per questo periodo, ma chealtre considerazioni inducono a credere altamen-te possibili.
Nessuna congettura è invece lecita circa laseconda figura, che andò a sostituire quella ori-ginaria (forse, appunto, Nerone). Il fatto chetutto lasci pensare all’assenza di una nuova iscri-zione dedicatoria, di cui non resta traccia, porte-rebbe a escludere che si trattasse di un personag-gio storico o di un altro imperatore (ad es.Vespasiano). Dunque poteva trattarsi di unafigura ideale, di una divinità o di un eroe, chenon necessitasse di un’iscrizione, neppure espli-
66 Vedi Phoinike III, pp. 163 s., 177, nrr. 334-337 (Sh.Gjongecaj). È interessante sottolineare che nelle duemonete nrr. 336-337, coniate e ritrovate a Phoinike, ilritratto di Nerone è accuratamente e completamenteeraso.
mancano segni evidenti lasciati da eventuali perni difissaggio, come solchi quadrangolari, elementi metal-lici o tracce dell’impiombatura, ma la pietra, attorno,ha una colorazione rossastra, assai viva, che è il segnodell’ossidazione del materiale ferroso che a lungo deveessere stato a contatto con le impronte stesse.
prosecuzione delle ricerche al teatro
77
cativa. Ma ogni ipotesi per la seconda scultura èdavvero improponibile.
Sandro De Maria
e. i saggi nella cavea
Il koilon del teatro di Phoinike costituisce, tut-tora, un punto interrogativo in attesa di unarisposta definitiva; soprattutto sono del tuttoipotetiche le reali dimensioni, il numero e ladisposizione di diazomata e kerkides, nonché l’a-spetto delle gradinate.
Se gli scavi dei due analemmata laterali e dellungo muro semicircolare in summa caveadovrebbero garantire a breve tempo, unitamentea quelli già in possesso, dati determinanti per lasoluzione del primo interrogativo, per quel cheriguarda gli altri due quesiti, allo stato attualedelle ricerche, è possibile contare solo su labiliindizi. I pochi elementi in nostro possesso sonostati acquisiti grazie a due piccoli saggi circo-scritti (saggio 2 e saggio 6), avviati e conclusinella cavea. Il saggio 2 (circa m 4 x 3) è statoeffettuato nel settore della cavea mediana, unaventina di metri più a nord rispetto all’analemmaoccidentale; il saggio 6 (m 3 x 3), invece, è statointrapreso nel settore est della cavea, in prossi-mità di quello che potrebbe essere il limite supe-riore dell’ima cavea orientale.
Il primo dei due saggi ha consentito di por-tare interamente in luce una serie di grossi bloc-chi lapidei, in parte affioranti, pertinenti ad unastruttura muraria di cui si conserva solo un breve
tratto del corso inferiore (Fig. 3.26). Non siesclude, nonostante l’area ristretta del saggio e lafisionomia lacunosa del muro, che possa trattar-si dei resti di una precinzione. Non restano trac-ce dell’ipotizzabile diazoma sottostante, crollatoa valle con il sistema di gradinate che lo soste-nevano. I pochi blocchi della struttura murariaancora in posto sono alloggiati direttamente nelbanco roccioso, precedentemente intagliato eregolarizzato per la loro messa in opera. Il mate-riale lapideo dal quale sono ricavati i blocchi(arenaria e calcarenite di provenienza locale), è lostesso utilizzato per il muro del terrazzamento eper i due analemmata. È presumibile, quindi, cheil suddetto muro sia effettivamente ciò che restadi una precinzione, appartenente, tra l’altro, allaprima fase del teatro. Allo stato attuale dellericerche non si può aggiungere altro, così comesarebbe del tutto precoce ipotizzare se si tratti omeno del muro di precinzione che divideva l’imacavea dall’ordine immediatamente superiore. Lastratigrafia del saggio 2 è del tutto inconsisten-te e poco significativa: subito a valle dei blocchi,sotto uno strato di circa cm 40 di limo, materia-le ceramico eterogeneo e macerie, corrisponden-te all’accumulo di età moderna, affiora il bancoroccioso, a conferma che i piani d’uso e i livellidi frequentazione antichi, dalle fasi ellenistiche aquelle di abbandono, sono progressivamente col-lassati e dilavati verso la cavità dell’orchestra.
Se il saggio 2 ha confermato come in quel set-tore della cavea il banco roccioso affiori diretta-mente sotto una quarantina di centimetri diterra mista a detriti, nell’area del saggio 6 l’in-terro è apparso decisamente più consistente.
Sotto uno strato di cm 30-40 di humus,si è depositato nel corso dei secoli uncospicuo livello di terra e macerie accu-mulatosi a causa del dilavamento (circa1 metro). Tale strato, proveniente dallasommità del teatro e dai settori abita-tivi e pubblici soprastanti, sedimenta-tosi in modo incoerente in età medie-vale e moderna nella cavea del teatro, ècomposto da limo, materiale lapideo,laterizio e ceramico assolutamente ete-rogeneo, per cronologia e tipologia.Più in basso, sono apparsi subito evi-denti i livelli di abbandono e di spo-gliazione delle gradinate (Fig. 3.27), incui sono stati ritrovati resti organici(ossi) e ceramici (di età romana ed elle-
sandro de Maria-riccardo Villicich
78
3.26. Veduta panoramica del Saggio 2. Sono visibili i gran-di blocchi lapidei accostati, forse pertinenti ad una precinzio-ne del teatro.
nistica). Erano presenti, inoltre, numerose sca-glie lapidee di calcare pertinenti, con tutta pro-babilità, ai sedili delle gradinate distrutte e spo-gliate. Anche in questo caso non sono staterinvenute le gradinate e sotto lo strato di distru-zione è affiorato senza ombra di dubbio il bancoroccioso, a dimostrazione che i sedili della cavea,in questo breve tratto indagato, sono stati com-pletamente asportati. Allo stato attuale dellericerche, quindi, permangono diversi dubbicirca la reale fisionomia dei posti a sedere nellacavea. Sembra certo, in ogni caso, che gli stessinon fossero intagliati direttamente nella roccia,sia per motivi estetici, sia per la cattiva qualitàdel banco roccioso presente nella collina diPhoinike. Analizzando parte dei blocchi lapideierratici, rinvenuti fuori contesto nel corso diqueste campagne di scavo, consistenti prevalen-temente in blocchi squadrati e lastre di calcare,ritengo plausibile, in via ancora ipotetica, che isedili della cavea non fossero monoliti intagliati(come quelli della proedria), ma consistessero inpiù pezzi assemblati (blocchi squadrati e lastre),apparecchiati nel banco roccioso regolarizzato,come nei sedili del teatro di Goumani67 in Epiro,oppure quelli di Prusias ad Hypium e di altri tea-tri dell’Asia Minore68.
Riccardo Villicich
f. il terrazzaMento e il Per-corso suPeriore
Nella campagna del 2006, datiinteressanti sono stati acquisiti dallavoro di pulizia e di scavo nel settoreoccidentale della summa cavea. Le inda-gini, in particolare, hanno permesso diriportare in luce un lungo tratto, circa50 metri, della struttura muraria,costruita in opera trapezoidale pseu-doisodoma, che sembra delimitare lasommità del teatro, già riconosciuta eposizionata, in quanto parzialmenteaffiorante, nelle ricognizioni del200069. Lo stesso tratto di muro, di cuisono riconoscibili almeno tre corsi diblocchi nel punto meglio conservato,fu visto sia dal Leake70 che daUgolini71, che, tuttavia, non lo identi-
fica quale muro del teatro, ma come segmentodella cinta meridionale dell’acropoli72. Pur rite-nendo errata l’ipotesi espressa da Ugolini, non èancora chiaro se la lunga struttura muraria inquestione sia da identificarsi con la praecinctio insumma cavea, disegnando così un teatro didimensioni veramente impressionanti, oppuresia semplicemente un muro di contenimento diun terrazzo superiore. È indubbio, comunque,che il lungo muro abbia un andamento curvili-neo, così come è altrettanto certo che ai piedi delsuddetto muro, precinzione superiore o terrazza-mento che sia, ancora si riconoscano le tracceevidenti del camminamento o sentiero sotto-stante, in terra battuta di colore grigiastro e pie-trisco, sfruttato, con tutta probabilità, in etàellenistica e romana (Fig. 3.28). In diversi trattiè possibile osservare la cosiddetta “risega di fon-dazione” della struttura muraria ellenistica, cor-
Magnesia e Tralles, i sedili erano assemblati grazie adun sistema di tre pezzi distinti che ricoprivano i gra-dini di roccia regolarizzata, permettendo così di ripie-gare all’indietro le gambe. A Pergamo e ad Efeso ilnucleo centrale di calcare fu rivestito con due lastre dimarmo. In altri casi, come a Cibyra, Termessos e Kaunosi sedili erano costituiti da blocchi monolitici, scalpel-lati in modo da lasciare una rientranza sottostante peralloggiare i piedi. Si veda DE BERNARDI FERRERO
1974, p. 45.69 Si veda Phoinike I, pp. 50-52 (R. Villicich).70 LEAKE 1835, p. 66.71 UGOLINI 1932, p. 76.72 Phoinike I, p. 50 (R. Villicich).
67 Si confronti BAÇE 2002-2003, p. 368.68 Nei teatri ellenistici della Ionia, fra cui Priene,
prosecuzione delle ricerche al teatro
79
3.27. Il Saggio 6. Sono identificabili le fasi di interro dellacavea, riconoscibili nella sequenza stratigrafica della paretenord del saggio, e quelle di distruzione delle gradinate (illivello con frammenti lapidei su cui poggia la lavagnetta).
rispondente al punto da cui si dipartiva l’elevatodel muro, che ci fornisce un’idea precisa dellaquota del camminamento immediatamente avalle. Se è giusta l’ipotesi che il lungo muro cur-vilineo sia effettivamente la struttura che deli-mitava il koilon del teatro, il percorso ai suoipiedi potrebbe essere ciò che resta del diazomasuperiore. Il sentiero, tuttavia, appare conserva-to solo nel tratto limitrofo alla struttura, per unalarghezza massima di circa un metro; il resto èfranato a valle, contestualmente al crollo delsistema costruttivo che lo sostruiva. È presumi-bile, comunque, che anche il diazoma superiorefosse pavimentato con lastre di calcare, come ilcamminamento anulare ai piedi della proedria.
Un futuro saggio stratigrafico all’interno delcamminamento a valle del muro, dovrebbe for-nire decisivi dati di ordine cronologico, sulla fasecostruttiva della struttura muraria e sui livelli difrequentazione in rapporto ad essa.
Il lungo muro curvilineo è perlopiù mal con-servato. In alcuni punti si possono osservareanche tre corsi lapidei di elevato, ma in preva-lenza si conserva in situ solo l’assisa inferiore. Èevidente, inoltre, come la struttura sia collassataverso valle e in diversi punti i blocchi lapidei,anche quelli della fondazione, siano traslati inavanti di quasi mezzo metro, rispetto alla posi-zione originale. Si è potuto constatare, in ognicaso, come il sistema degli incastri e la tecnicacostruttiva siano del tutto simili a quelli utiliz-zati per il grande muro di terrazzamento meri-dionale del teatro.
Sempre nello stesso settore della summa cavea,si è rivelato di particolare interesse un saggio
effettuato verso il limite di scavo, una quindici-na di metri prima del possibile centro del koilon.Quasi a contatto con la suddetta presunta pre-cinzione, sono venuti in luce i resti di una pic-cola struttura tardoromana o bizantina di formacircolare (Fig. 3.29), di cui sono ancora visibili
alcuni lacerti della pavimentazione in laterizirubefatti e anneriti dalla vicinanza ad una fontedi calore. Non è ancora chiaro se si tratti dei restidi un forno oppure di una piccola capanna, conpareti conservate per un’altezza massima di circacm 40-50; è certo, invece, che la struttura è statacostruita con materiale laterizio e lapideo direimpiego legato con terra. Lo scavo del riempi-mento all’interno della piccola costruzione circo-lare, consistente soprattutto in terra concottata eframmenti laterizi, non ha restituito repertimobili significativi per una datazione più circo-stanziata.
Purtroppo, metà della struttura è franata avalle, dopo i cedimenti del muro curvilineo, delcamminamento sottostante e di un presumibilesistema di sostruzione inferiore. La forte penden-za della cavea e il terreno scosceso, tra l’altro,rendono assai arduo il lavoro di scavo in questosettore. Subito ad occidente della struttura appe-na descritta, sono riemersi, in modo evidente, icorsi lapidei del lungo muro curvilineo del tea-tro, che sembrerebbe caratterizzato in questopunto da una rientranza, come se fosse previstauna sorta di nicchia. Pochi metri prima dellasuddetta rientranza, tra l’altro, la strutturamuraria curvilinea non è più riconoscibile acausa della presenza di grandi massi smossi ivi
riccardo Villicich
80
3.28. Un tratto del lungo muro curvilineo, in opera trapezoi-dale, venuto in luce sulla sommità della conca che accoglievail koilon del teatro.
3.29. I resti di una struttura di forma circolare, pertinentealle fasi di abbandono del teatro, venuta in luce nei pressidella summa cavea.
accumulatosi, difficili e pericolosi da spostare.Per questo motivo, allo stato attuale dei lavori,la sequenza fisica fra i due tratti di muro, appa-rentemente disassati, non è percepibile in modochiaro, lasciando campo a diverse ipotesi e inter-pretazioni.
A contatto del muro, all’interno della rien-tranza, è stato localizzato e scavato uno stratocoerente caratterizzato da consistente presenza direperti ceramici di età ellenistica, fra cui vasella-me in vernice nera (alcuni pezzi sono quasi inte-gri). Sembrerebbe trattarsi, in questo caso, diuno scarico di materiale, dal momento che uni-tamente ai frammenti ceramici sono presentinumerose valve di telline e ossa animali.L’orizzonte cronologico del materiale ceramicoproveniente da questo strato, che indubbiamen-te appare integro e non rimaneggiato, rimandaal III-II secolo a.C.73. Per ora, tuttavia, la faseancora incompleta dello scavo rende azzardatoavanzare ipotesi troppo circostanziate sulle stra-tificazioni riscontrate in questo breve saggio.
Riccardo Villicich
g. considerazioni sui Materiali
rinVenuti
Gli scavi del teatro, intrapresi ormai dadiversi anni, fin dalle prime indagini hannorestituito una notevole quantità di materiali, cheda un lato offrono il quadro finora più completodelle classi ceramiche attestate sulla sommitàdella collina, dall’altro, quando rinvenuti in con-testi stratigrafici affidabili, già in una prima fasedi studio hanno permesso di avanzare ipotesirelative alle fasi di vita dell’edificio74. Sulla basedi questi primi studi era stata individuata unaoriginaria fase ellenistica (fine III-II secolo a.C.)sulla quale si sarebbe impiantato, a partire dallafine del II-inizi III secolo d.C., il teatro di etàromana, la cui vita sembrerebbe essersi definiti-vamente conclusa in età tardo-antica. Le indagi-ni condotte negli ultimi anni, concentratesoprattutto nell’area dell’orchestra e in prossi-mità del muro di chiusura della cavea, hanno
portato ad avanzare nuove ipotesi che in partemodificano quanto proposto precedentemente,soprattutto in relazione alla cronologia della faseellenistica75. I risultati di queste indagini sonoperò apprezzabili soprattutto in relazione allestrutture rinvenute e ai rapporti fra di esse, sullabase dei quali si è reso necessario distinguere duefasi ellenistiche (vedi infra). Per quanto riguardainvece il materiale ceramico, la preliminarietàdegli studi in corso e i dati quantitativi dei reper-ti pongono problemi nella proposizione di crono-logie assolute, a eccezione dei resti della decora-zione architettonica. È difatti stato riscontratonel corso degli scavi come ad una discreta abbon-danza di reperti motivata dalla posizione e dallaconformazione dell’edificio scenico, interessatodai continui dilavamenti degli strati superiori edunque coperto da un grande interro ricco direperti, corrisponda una relativa scarsità di mate-riali negli strati relativi alla vita dell’edificio.
Le due fasi ellenistiche sono attestate dal rin-venimento di due euripi, localizzati nel settoreoccidentale dell’orchestra, paralleli l’uno all’al-tro. Il loro svuotamento, peraltro non concluso,non ha ancora restituito materiali ceramici dia-gnostici. Né gli strati di riempimento dell’orche-stra coevi alla costruzione dell’euripo di primafase (US 232-233), né lo strato che documenta ilmomento in cui tale struttura venne interrata infavore di un secondo euripo (US 231) offrono datiche permettano di andare oltre alla loro genericapertinenza ad un sicuro orizzonte ellenistico.Scarsi sono anche i dati relativi ai riempimenti delsecondo euripo (US 229), al cui interno è ricono-scibile solo un piatto in terra sigillata orientaleforse riferibile alla produzione di Çandarli, cheper il momento non è stato datato con certezza76.
Ha restituito invece frammenti più riconosci-bili la US 242, scarico ricco di materiali estrema-mente omogeneo rinvenuto in prossimità delmuro di contenimento del teatro in summa cavea.Insieme ad una notevole quantità di vasellame avernice nera, il reperto di più grande interesse ècertamente un’ansa a gomito bollata, certamente
75 In relazione all’originario impianto del teatro risultadi particolare interesse il recente studio dei capitelli edelle basi di colonna reimpiegati nel muro del pulpi-tum di età romana, verosimilmente pertinenti al teatrostesso e datati con certezza agli inizi del III secolo a.C.(vedi supra, i contributi di M. Podini e R. Villicich).
76 Cfr. il contributo di Eduard Shehi in questo stessovolume (nr. 29, Fig. 9.3).
73 Per una datazione dei materiali ceramici provenientida questo strato rimando al contributo di A.Gamberini, infra.
74 Cfr. Phoinike III, pp. 82-87 (G. Giannotti).
prosecuzione delle ricerche al teatro
81
rodia (Fig. 3.30)77. Il bollo, in cartiglio rettango-lare (cm 3,6 x 1,5), si sviluppa su tre righe e con-serva il nome dell’Eponimo preceduto da ejpiv eseguito da un nome al genitivo del quale sono leg-gibili solo le ultime lettere, forse riferibile al mese:
EPI IASIKRATEUS[AGRI]ANIOU.
Esso può essere trascritto jEpiv Iasikratevu"(...)aniou e tradotto «sotto Iasicrate, nel mesedi -?-».
Nel Pergamon Deposit, contesto sul cui studio sibasa la cronologia dei bolli rodii, l’eponimoIasikrathv" compare in un unico bollo che si svi-luppa su due righe (una contenente il nomedell’Eponimo, l’altra il mese al genitivo:dalivou)78, mentre l’esemplare fenichiota presen-ta la separazione del nome su due di tre righe. Taledifferenza non influisce tuttavia sull’identifica-zione dell’Eponimo, dal momento che è statodimostrato come in occasione di ogni cambio delmese venisse rielaborato lo schema di entrambi ibolli impressi sulle due anse, tanto su quello con-tenente il nome del mese stesso, quanto sull’altro,contenente il nome del fabbricante79. Per quanto
riguarda il nome del mese, anche se dellaterza riga è leggibile con certezza solo l’ul-tima parte, tuttavia la desinenza ANIOU ècompatibile solo con il mese ajgriavnio"80.Quanto invece alla datazione, nell’ultimapubblicazione del deposito tale bollo è rife-rito al “ periodo III”, che sarebbe compresotra gli ultimi decenni del terzo e i primidecenni del II secolo a.C.81, datazione cherecentemente si è proposto di abbassarenell’ambito della prima metà del II secoloa.C.82 Sulla base della cronologia presenta-ta da Finkielsztejn l’eponimo Iasikrathv"si daterebbe all’anno 190 a.C.83.
La presenza di quest’ansa nello stratoin questione fornisce un termine cronolo-gico per gli altri materiali rinvenuti inassociazione con essa, con particolare rife-
rimento al vasellame a vernice nera. Tale indica-zione non contrasta con la generale datazione ditale vasellame (all’interno del quale sono ricono-scibili frammenti di lucerne a becco quadrango-lare e balsamari fusiformi), ma soprattutto èutile a precisare il termine basso di produzione ediffusione di una particolare forma, che si è pro-posto di identificare con i Cyma Kantharoi rinve-nuti a Corinto. Sono difatti riconducibili a taleforma diverse pareti decorate a baccellatura eanse sormontate da aletta rettangolare. Diversiesemplari analoghi sono già stati rinvenuti neglianni passati in altri due contesti fenichioti riferi-bili su base stratigrafica al periodo compreso trala fine del IV e la metà del III secolo a.C. Si trat-ta dello strato relativo alla prima fase di costru-zione della Casa dei due peristili e di un contestotagliato al momento di edificazione delle muradella città. Pur essendo necessario un approfon-dimento della questione, la situazione stratigra-fica dei contesti citati da un lato e la datazionedel bollo rodio dall’altro renderebbero plausibilesupporre un lungo periodo di utilizzo della
77 Inv. PH 06 C1 242 534. Al dott. MicheleRicciardone, che da anni collabora con la Missione inqualità di restauratore, va il mio ringraziamento per ilpaziente lavoro di pulitura che ha reso leggibile ilbollo in questione.
78 BÖRKER, BUROW 1998, p. 29, nr. 202, tav. 8.79 GRACE, SAVVATIANOU-PÉTROPOULAKOU 1970, p. 294.
80 La successione dei mesi rodii pone ancora difatti qual-che problema (BÖRKER 1978).
81 Gli editori del deposito, in particolare, propongonouna datazione al 205-175 a.C. (BÖRKER, BUROW
1998, pp. 13-17).82 Per una rassegna delle diverse cronologie proposte
dagli anni Cinquanta ad oggi si vedano GARLAN 2000(p. 142, n. 29) e LAWALL 2002 (pp. 296-297), che pro-pone di porre il termine basso di tale periodo fra lafine degli anni Sessanta e gli inizi degli anniCinquanta del II secolo a.C. (pp. 295-297).
83 FINKIELSZTEJN 2001, pp. 185-187, 190-193.
anna gamberini
82
3.30. Ansa di anfora rodia con bollo in cartiglio rettangola-re dall’US 242, nella cavea.
forma, compreso fra la prima metà delIII84 e i primi decenni del II secolo a.C.
Anna Gamberini
h. le fasi costruttiVe del tea-tro
Sulla base dei dati finora in nostro pos-sesso, per il teatro di Phoinike emerge unquadro d’insieme composto da tre impor-tanti fasi costruttive: una prima fase di etàellenistica risalente alla prima metà del IIIsecolo a.C.; una seconda fase, sempre di etàellenistica, inquadrabile nella secondametà del II secolo a.C. e una terza fase di etàromana, databile ai primi decenni del IIIsecolo d.C. Si tratta, in tutti e tre i casi, diinterventi strutturali, a carattere monu-mentale, che nei due ultimi casi stravolgo-no in modo evidente la precedente fisiono-mia del teatro (o almeno una parte di esso).I primi due interventi sono caratterizzatidallo slancio dinamico di una fase “costrut-tiva” pianificata, frutto della volontà dellacomunità cittadina o di un’autorità supe-riore, in un contesto di sviluppo e benesse-re economico; il terzo intervento è “rico-struttivo” e indirettamente “subito”, qualeconseguenza di un probabile evento trau-matico, che provocò il collassamento delprecedente edificio scenico.
La prima fase di età ellenistica, data-bile alla prima metà del III secolo, ècaratterizzata dall’impiego, come mate-riale da costruzione, di pietra arenariagrigio-giallastra proveniente direttamen-te dalla collina. A questo periodo, cui si devel’impianto generale del teatro, sono riconducibi-li, sicuramente, il sistema di terrazzamento (Fig.3.31), il muro ad andamento curvilineo che deli-mitava in sommità il koilon, tutto l’analemmaorientale, parte dell’analemma occidentale, lapossibile precinzione nel settore occidentale delkoilon, l’euripo più antico, diversi elementiarchitettonici (fra cui le basi e i capitelli prece-dentemente citati) del proskenion e della skenè.
Nella seconda fase di età ellenistica furonoricostruiti integralmente l’orchestra, la proedria,l’intero percorso anulare del diazoma inferiore e,probabilmente, gran parte dell’ima cavea. Furonoinoltre ricostruiti parzialmente: l’edificio sceni-co, che diventò più grande, le parodoi, che ven-nero adattate al nuovo, più lungo, edificio sceni-co e l’analemma occidentale (Fig. 3.32). Questafase è contraddistinta da una maggior profusio-ne di mezzi e dall’utilizzo massiccio del calcarebianco di buona qualità, proveniente, plausibil-mente, da cave non distanti da Phoinike.
La terza e ultima fase, di età romana, consistenel rifacimento pressoché integrale dell’edificio
84 Sulla datazione di questa forma a Phoinike cfr.GAMBERINI c.d.s.
prosecuzione delle ricerche al teatro
83
3.31. Un tratto del sistema di terrazzamento del teatro. Sonoevidenti le tracce di un restauro del muro di contenimento avalle, con la presenza di blocchi di minori dimensioni.
3.32. L’analemma occidentale.
scenico; un intervento databile ai primi decennidel III secolo d.C., a seguito di un probabileevento catastrofico di grande portata. Potremmoessere di fronte, infatti, ad un evento traumati-co85, che causò non solo la distruzione di partedel teatro originario, ma anche di altri comples-si pubblici e privati della città. Anche se si trat-ta solo di un’ipotesi, non escluderei, tra l’altro,che la distruzione del vicino teatro di Butrintopossa essere riconducibile allo stesso periodo eallo stesso avvenimento catastrofico che pose fineall’edificio scenico del teatro di Phoinike. Nelcaso di Phoinike, tuttavia, il teatro fu ricostruito(anche se con mezzi modesti), mentre a Butrintono, scelta che decretò la fortuna degli scavi diUgolini nel teatro medesimo.
Sulla base di quanto detto, e tenendo in con-siderazione la ristrettezza di mezzi (dato il perio-do storico) con cui venne ripristinato l’edificioscenico, è possibile che parte del materiale lapi-deo del teatro, soprattutto i blocchi di calcarebianco di forma quadrangolare, siano diventatiun bene prezioso, da utilizzarsi per la ricostru-zione di altri monumenti di Phoinike, forse limi-trofi al teatro stesso, oppure per produrre calce.La lunghezza della scena di età ellenisticacostrinse gli architetti di età romana a progetta-re un edificio anomalo e sostanzialmente adatta-to alla struttura precedente, caratterizzato dauna lunga frontescena e da un pulpitum didimensioni ridotte. Si tratta, in questo caso, diuna soluzione resa necessaria per evitare che fos-sero ridotti drasticamente entrambi gli analem-mata nel loro tratto conclusivo, operazione cheavrebbe comportato il conseguente sacrificio diun vasto settore dell’ima cavea. Questo teatro“rinnovato” non sembra abbia goduto di unalunga vita; le evidenze archeologiche lascianopresumere che già a partire dalla seconda metàdel IV secolo d.C. la struttura iniziò ad esserespogliata e utilizzata come cava di materiale.
Alla luce di quanto esposto, i dati di scavo ele strutture riemerse dalla terra propongono pro-blematiche stimolanti, soprattutto se immagi-nate e interpretate in funzione della storia dellacittà. È lecito chiedersi, in prima analisi, qualifossero la fisionomia e la statura politica dellacittà di Phoinike al momento della costruzionedel primo teatro della città. Le imponenti
dimensioni del teatro lasciano supporre che neiprimi decenni del III secolo a.C., durante ilregno di Pirro, la città di Phoinike costituisse unarealtà urbana consolidata e in espansione, con lafunzione determinante di centro di riferimentoper un ampio territorio86. Come si è detto, unaltro “passaggio storico” decisivo avviene nellaseconda metà del II secolo a.C. In questa fase, ilteatro fu ingrandito e abbellito, dal punto divista scenografico e strutturale, grazie all’impie-go di materiale più pregiato e resistente. È vero-simile che questa disponibilità di mezzi coinci-da con gli eventi storici successivi alla battagliadi Pidna, quando a Phoinike ebbero inizio leprime emissioni monetali con il nome dellacittà, chiaro indizio un ruolo politico di primopiano in Caonia. Un altro dato interessante, chemerita di essere considerato nel corso dei prossi-mi studi, riguarda la longevità dell’edificio sce-nico di età ellenistica (circa tre secoli e mezzo),rimasto in uso fino al III secolo d.C., senza evi-denti rifacimenti nel I o II secolo d.C., contra-riamente a quanto attestato nel caso di diversiteatri della Grecia e dell’Asia minore.
Interessanti sono, infine, le fasi di abbandonoe di spogliazione delle pietre del teatro; questeultime “finanzieranno” per secoli gran partedelle nuove costruzioni di età bizantina.
Le tracce di frequentazione di alcuni settoridel teatro, successive al suo abbandono, sonoapparse evidenti; non è ancora chiaro se si trattadi focolari, capanne di fortuna e ripari da porsi inrelazione all’utilizzo del grande edificio pubbli-co come cava naturale di materiale da costruzio-ne oppure se si tratti di vere e proprie abitazioniricavate in un periodo più tardo, sfruttando lestrutture murarie in rovina del vetusto monu-mento. È certa, in ogni caso, la presenza di restidi focolari, muri (costruiti con tecnica approssi-mativa, materiale di recupero e malta di pessimaqualità), alloggiamenti per pali e vere e propriepiccole strutture (forse abitative o produttive).
Riccardo Villicich
85 Probabilmente un terremoto.
86 Il dato trova conferma nella cronologia del tratto cen-trale delle mura nord e dell’impianto del quartiereabitativo cui appartenne la Casa dei due peristili.
riccardo Villicich
84


































![Notizie degli scavi e delle ricerche archeologiche nel Modenese (2012), Modena 2014 [a cura di Donato Labate]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6319da6dbc8291e22e0f4d0d/notizie-degli-scavi-e-delle-ricerche-archeologiche-nel-modenese-2012-modena-2014.jpg)