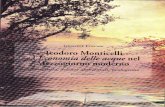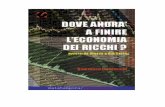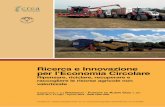L'economia delle relazioni
-
Upload
wwwuniroma1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'economia delle relazioni
L'economia delle relazioni
Abstract.
La chiusura delle imprese, la deregolamentazione del mondo del lavoro e l'alta percentuale di
precarietà sono la prova del fallimento del sistema capitalistico e dei suoi principi. Tale disfatta
rende sempre più esplicita la necessità di un nuovo sistema economico e produttivo.
Bisognerebbe, come sostiene Magatti, ritornare a fare economia nel senso etimologico del termine,
di “oikos-nomos”, ovvero uscire dalla convinzione che la crescita possa procedere a prescindere da
qualsiasi limite e tornare ad usare diversamente e meglio le risorse che abbiamo a disposizione. Tra
queste il territorio. Ne emerge la necessità di ripensare ad un sistema di produzione alternativo
incentrato su una concezione del territorio diversa da quella del passato che ne prevedeva un uso
esclusivamente strumentale e che è stata causa, a lungo termine, del fenomeno di de-
territorializzazione (Raffestin, 1984) .
Oggi appare essenziale ristabilire una relazione sinergica fra crescita economica e sociale mettendo
in atto un processo di inversione rispetto a quello di deterritorializzazione che sia incentrato sulla
produzione di territorialità attraverso l’agire collettivo (Governa, 1999), inteso come un' alleanza
guidata da un bisogno comune.
Tuttavia il sistema capitalistico ha imposto per anni meccanismi che hanno fortemente indebolito il
concetto di agire collettivo a vantaggio invece di un forte individualismo.
Nonostante ciò esistono delle strategie in grado di rompere la sfera individualistica e di (ri) generare
nuovamente l'agire collettivo? Come è possibile attivarle?
Questo capitolo contiene le linee teoriche, nate sia dalla ricerca bibliografica sia dall'esperienza “sul
campo”, su cui si basa il ragionamento secondo il quale le condizioni di precarietà diffusa connesse
alla necessità di ottenere migliori condizioni di lavoro (e di vita) possono rappresentare quei
presupposti atti a favorire strategie generatrici di un nuovo agire collettivo volto a contrastare il
processo di deterritorializzazione.
1. L'ECONOMIA DELLE RELAZIONI.
Parlare di “economia delle relazioni” potrebbe portare erroneamente a pensare ad una
monetizzazione delle stesse. Ma non è così. Questa definizione funge da supporto alla tesi secondo
la quale, con la crisi economica e finanziaria che ci ha investiti, generata dal fallimento
dell’applicazione del modello economico unico e globale e dei suoi principi (come quello della
flessibilizzazione), si sta facendo sempre più forte il bisogno di una nuova economia che non sia
indifferente ai contenuti sociali.
Un’economia basata su relazioni sociali oltre che economiche, lontana da quel modello in cui la
massimizzazione del profitto, l’accumulazione della ricchezza monetaria, la crescita infinita del
consumo di merci diventavano le sole logiche regolatrici all'interno della società.
Con questo non si vuole inneggiare al ritorno a sistemi di produzione obsoleti o a principi di
decrescita latouchiani, in quanto non possiamo cancellare i livelli di sviluppo raggiunti. Inoltre chi
rinuncerebbe a tutte le comodità che ogni giorno la tecnologia ci offre?
Non si tratta quindi di rinunciare ai processi di produzione di ricchezza, ma come dice Magatti
(2012): “si tratta di ritornare a fare economia nel senso etimologico del termine, di oikos-nomos”,
ovvero uscire dalla convinzione che la crescita possa procedere a prescindere da qualsiasi limite
tornando ad usare diversamente e meglio le risorse che abbiamo a disposizione. In questo modo si
può parlare di crescita sostenibile, capace di tornare a confrontarsi con la realtà non solo economica
ma anche sociale, umana ed ambientale. Dall'altra parte bisogna tornare ad interrogarsi sugli
obiettivi della crescita, orientandoli maggiormente verso i bisogni piuttosto che verso i desideri.
Da quanto detto emerge l'importanza di ripensare ad un sistema di produzione alternativo incentrato
su una concezione del territorio diversa da quella del passato che ne prevedeva un uso
esclusivamente strumentale e che ha portato, a lungo andare, ad una rottura tra modalità di
produzione e risorse socio-culturali proprie dei territori stessi. Si è generato così un processo di
liberazione dal territorio detto “deterritorializzazione” (Raffestin, 1984), sostenuto dallo sviluppo
tecnologico e portatore dell’ipotesi diffusiva del modello occidentale a livello mondiale (Alpini,
2010), che ha decisamente alterato le relazioni fra economia e società.
La prima, nel nuovo ordine globale, diventa un’economia di rete che si espande a livello mondiale.
Poiché la rete rappresenta l’insieme di connessioni necessarie che gli spazi ed i gruppi sociali
devono realizzare per avere accesso al sistema mondiale, essa genera una società a due velocità: chi
è in grado di agganciarsi ad essa e ricadere all’interno della sfera delle possibilità che questa
connessione offre loro, e chi non è in grado e rimane completamente isolato ed al di fuori di ogni
opportunità.
1
Se all’inizio il processo di deterritorializzazione ha coinciso con la crescita di un discreto benessere,
in un secondo momento, come vedremo nel corso di questo capitolo,in particolare a partire dagli
anni 70/80 “il segno di questo processo imperiale si è invertito, costruendo, anziché ricchezza,
nuove povertà” (Alpini, 2010).
Queste povertà sono conseguenza di una forte condizione di precarietà che, nata dalla
trasformazione delle condizioni di lavoro legate all'introduzione della tecnologia e del principio di
flessibilità , si abbatte su tutto il vivere sociale.
Oggi appare essenziale introdurre un nuovo concetto di sviluppo capace di annullare (o almeno
ridurre) le condizioni di precarietà' , ristabilendo una relazione sinergica fra crescita economica e
sociale.
Tutto questo richiede un processo di inversione rispetto a quello della deterritorializzazione, che sia
incentrato sulla produzione di territorialità attraverso l’agire collettivo (Governa, 1999), inteso
come un' alleanza guidata da un bisogno comune quale quello di produrre in termini non più neo
liberisti e generatori di precarietà.
Per produrre territorio sarebbe però prima necessario ricreare quelle condizioni che (ri)generino
l'agire collettivo all'interno di un contesto prettamente individualistico alimentato per anni dal
mercato capitalista. Come fare?
Questo paper contiene le linee teoriche, nate sia dalla ricerca bibliografica sia dall'esperienza “sul
campo”, su cui si basa il ragionamento secondo il quale le condizioni di precarietà diffusa connesse
alla necessità di ottenere migliori condizioni di lavoro (e di vita) rappresentano quella spinta
necessaria a creare presupposti tali da favorire l'alleanza e, dunque, l'agire collettivo.
L'azione dell' alleanza diventa quella di ricostruire una catena di valori all'interno dei processi di
produzione che tengano così conto non solo dei fattori economici e finanziari, ma anche delle
criticità connesse allo stato dell'ambiente naturale (inquinamento, consumo di risorse...) e di quello
sociale (condizioni di lavoro e occupazionali..). In questo senso, il gioco delle alleanze diviene
quella contro-azione necessaria per contrastare la deterritorializzazione sviluppando i presupposti
per una nuova economia più vicina al territorio1 ed alle esigenze di chi lo vive.
2. LA GENESI DELLA PRECARIETA'.
Secondo i dati ISTAT, a luglio 2014 il numero dei disoccupati era pari a 3 milioni e 220 mila 2, un
numero quasi pari agli abitanti dell'area metropolitana della città di Roma e continuamente in
1 Attivatrice, dunque, di un processo di territorializzazione inteso come la ricostruzione dei rapporti fra l'ambiente produttivo e quello sociale.
2 Fonte:http://www.istat.it/it/archivio/130452
2
crescita. Il target di riferimento utilizzato è solo quello del lavoro subordinato, mentre non vengono
quasi prese in considerazione le dinamiche della precarietà relative al lavoro autonomo e
subordinato per cui altre fonti (Cnel3 e Isfol4) dicono che l’incidenza dell’intermittenza lavorativa e
i livelli di subalternità e ricattabilità sono maggiori, soprattutto nell’ambito dei “lavoratori della
conoscenza”5 . Tutto questo mette in risalto due tendenze: l'aumento di contratti di lavoro “atipici”,
che stanno sempre di più sostituendo quelli standard ed il proliferare del lavoro part time, dovuto al
fatto che molte persone accettano il lavoro ad orario ridotto non riuscendo a trovare alcuna
occupazione a tempo pieno.
Il numero dei precari aumenta ulteriormente se si aggiungono i lavoratori in cassa integrazione che
l'ISTAT considera come “occupati”. In questo caso il numero dei disoccupati reali risulta superiore a
5,5 milioni, con un tasso di disoccupazione pari al 19,6%6.
Per ben comprendere come si sono sviluppati questi fenomeni di forte precarietà e disoccupazione,
è necessario fare una breve analisi storica sulle trasformazioni del ciclo produttivo e sugli effetti che
esse hanno avuto sul tessuto sociale.
Il precariato è il prodotto della crisi economica e finanziaria che ci ha globalmente investiti, la cui
origine è attestabile a partire dagli anni del secondo dopoguerra, quando prese il via l'epoca della
“libertà di massa” (Magatti, 2012), che raggiunse il suo apice intorno agli anni 60 . Un'epoca che
offriva a (quasi) tutti quello che le generazioni precedenti avevano sempre sognato: la libertà,
l'autonomia ed un'ampia libertà di scelta, soprattutto grazie alla presenza contemporanea di tre
condizioni (Magatti, 2012) :
a. un'economia basata sul compromesso fordista- welfarista, reso possibile dall'applicazione di
politiche keynesiane, che aveva creato condizioni diffuse di sicurezza e di benessere;
b. una politica basata sulla piena accettazione delle democrazie come unico modello istituzionale
possibile, soprattutto a seguito della sconfitta rovinosa delle dittature;
c. un pluralismo culturale reso possibile soprattutto dall'avvento dei mass-media7.
La libertà era diventata un fenomeno di massa. Tuttavia essa portava in sé una forte dose di
individualismo. Dal punto di vista culturale, furono due i filoni, che seppur in conflitto fra loro,
seppero meglio interpretare e portare avanti il bisogno di soggettività che nasceva dalla condizione
di libertà diffusa.
Il primo fu il movimento studentesco del '68 , che manifestando per il “diritto-dovere di ciascuno a
3 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro4 Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori5 Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it6 Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it7 Con il tempo l'accesso a queste tre condizioni si rivelò tutt'altro che stabile ed omogeneo per i gruppi sociali e
l'affermazione della libertà iniziava a far nascere una forte domanda di soggettività , rivelando i suoi effetti collaterali.
3
essere se stesso” (Magatti, 2012), portava avanti un'idea assoluta di autodeterminazione ed
individualismo connessa al rifiuto verso qualsiasi forma di autorità. Pur essendo nato all'interno dei
circoli giovanili, negli anni successivi al '68, questi ideali finirono per coinvolgere tutti. Questo
avvenne perché, come sosteneva Maslow (1968) “una volta soddisfatti gli aspetti materiali, ne
emergono altri immateriali e maggiormente legati all'affermazione del sé e all'auto realizzazione”:
soffocati dal benessere raggiunto e dall'ordine sociale, in quegli anni, si fece sempre più forte da
parte di tutti l'esigenza di esprimersi con maggiore libertà “colorando l'esistenza di quella peculiare
tonalità” (Magatti, 2012) associata alla singola personalità. Dal grande movimento del '68 si generò
una forte domanda di soggettività che implicava il rifiuto di qualsiasi autorità potesse limitare lo
spazio di autoaffermazione dell'individuo.
Negli anni successi, il secondo filone, anche se in termini del tutto diversi e opposti al primo, fu
rappresentato dalla corrente neoliberista, la quale rifiutava ogni forma di intervento statalista. L'idea
di fondo era la seguente: noi siamo tanto più liberi quanto più possiamo scegliere. Il pensiero
neoliberista interpretava bene questa necessità di libertà come un processo crescente che per
manifestarsi aveva bisogno di un incremento incessante del numero di opportunità disponibili.
Questo filone vedeva nell'intero sistema delle istituzioni un fattore limitante nella scelta
individualistica delle opportunità. Da qui la necessità di ridurre, fino a smantellarla, la presenza
dello Stato in quanto “solo la scelta individuale soddisfa gli standard morali implicati dalla natura
libera dell'essere umano” (Magatti, 2012) e di restituire lo scettro decisionale esclusivamente nelle
mani del singolo individuo.
Questi anni segnarono un passaggio decisivo.
Il sistema fordista welfarista, nel giro di due decenni, era riuscito a saturare i mercati e a rendere le
economie che li animavano mature, “intendendo con questo termine che gli spazi di crescita non
avrebbero più potuto essere così ampi come nel recente passato “ (Magatti,2012). Quale sarebbe
stato il passo successivo?
Si iniziò a parlare della fine dell'era industriale e dell' inizio dell' epoca post-industriale. Essa
portava con sé grandi cambiamenti. Come già Rostow (1983) anticipò: “nella fase più evoluta della
crescita economica, i mercati dei beni durevoli e dei servizi sarebbero stati centrali”.
Il passaggio dall'era industriale a quella post industriale, o dei servizi, sancì sul mercato il passaggio
dalla produzione dei beni materiali a quella di beni immateriali: un processo, questo, che venne
definito di “smaterializzazione della produzione”.
Per chiarire questo concetto bisogna far riferimento agli studi di André Gorz (2003)8, secondo il
8 In questo caso si fa particolare riferimento al suo libro: “L'immateriale. Conoscenza, valore e capitale”,Bollati Boringhieri, Torino,2003.
4
quale mentre nell'era industriale la fonte principale del lavoro era stata la produzione di oggetti
materiali, nell' epoca post-industriale la capacità di produrre oggetti, essendo ormai generica e
diffusa, non costituisce più un fattore di differenza strategica9. Si passa dunque ad una maggiore
attenzione verso la produzione del valore immateriale (come marketing pubblicitario, operazioni di
design), che nonostante sia più difficilmente calcolabile e sfugga dalla logica capitalistica degli
investimenti, negli ultimi anni sta subendo una crescita esponenziale.
E' il passo cruciale che porta all'attuale crisi economica.
Ne nasce un'economia prettamente basata sul “capitale d'informazione” (Arriola, Vasapollo, 2005) e
portatrice di una trasformazione radicale della strategia d'impresa. Quest'ultima tende sempre di più
a basarsi “sulla produzione e consumo di nuove risorse, utilizzando la comunicazione diretta ed il
marketing sociale per raccogliere e fare circolare capitale d'informazione allo scopo di generare un
ampio condizionamento sociale che attraversa il momento direttamente produttivo per invadere il
territorio con tutte le relazioni sociali connesse” (Arriola, Vasapollo, 2005:110).
Nel processo di trasformazione della produzione, a partire dagli anni '90, interviene anche il
fenomeno di terziarizzazione che consiste nella progressiva minore incidenza del settore industriale
sulla formazione del PIL e sull'occupazione, a vantaggio del settore terziario, in particolare di quello
più avanzato che comprende i servizi alla produzione ed alle imprese, caratterizzate da un continuo
sviluppo delle tecnologie informative ed informatiche10.
L'esistenza di queste condizioni, oltre a provocare una completa trasformazione del sistema
produttivo, porta come conseguenza la generazione di nuove modalità di organizzazione del lavoro,
molto diverse da quelle dell'epoca fordista e plasmate soprattutto su obiettivi di qualità (presunta) e
di flessibilità.
3. LA RIVOLUZIONE DEL MONDO DEL LAVORO: LA NASCITA DELL'UOMO
PRECARIO.
Il concetto classico del lavoro viene messo in crisi dalle condizioni di flessibilità imposte dal
mercato post-fordista. La flessibilità segna il passaggio da organizzazioni sociali ed imprenditoriali
fortemente gerarchiche ad altre esclusivamente basate sul decentramento delle funzioni e su nuove
forme di lavoro flessibile e con scarsissimo contenuto di garanzie (Arriola, Vasapollo, 2005).
9 In molti settori, come ad esempio quello della moda, il valore manifatturiero del prodotto costituisce ormai una
percentuale minima, ed in continua decrescita, del valore del bene. Si dà infatti molta importanza alle componenti
immateriali, quelle più strettamente dovute al lavoro dell'intelletto, come il design e la campagna pubblicitaria.
10 Fonte: www.treccani.it
5
Le condizioni di lavoro cambiano radicalmente. Vi è una differenza fondamentale tra la maniera di
lavorare fordista e post-fordista: questa è nella composizione, forma e maniera di organizzare la
forza lavoro. Mentre nel sistema fordista era necessaria una forza di lavoro specializzata, abituata
al lavoro di routine e a contratti a tempo indeterminato con orari pieni, nel sistema post-fordista
esiste una domanda di forza lavoro con un elevato grado di adattabilità ai cambi di ritmo e di
funzione e che sappia stare al passo con il mercato. Cambiano anche le modalità di applicazione dei
diritti sociali dei lavoratori: nel sistema fordista essi avevano una validità universale ed erano
protetti per legge mentre nel sistema post-fordista sono le leggi del mercato ad imperare,
imponendo condizioni di lavoro sempre più costrittive e senza garanzie (Arriola, Vasapollo,2005).
Da questa situazione scaturisce l'esigenza di una figura lavorativa che operi senza garanzie e
all'interno di un continuo stato di provvisorietà, che sia caratterizzata da un elevato grado di
poliedricità ovvero che sia capace di adattarsi e di spostarsi continuamente da un'azienda all'altra e
da una mansione all'altra. La figura del lavoratore precario risponde pienamente a queste esigenze e,
poiché queste condizioni sono ormai comuni all'interno del mercato, diventa la tipologia di
lavoratore preponderante.
La condizione di precarietà non incide solo sulla sfera lavorativa: l'intermittenza delle prestazioni
caratterizzata da orari atipici e flessibili influisce sull'intero vivere sociale “in un contesto di
dominio sociale flessibile da parte dell'impresa capitalista che contamina di sé, del proprio modo di
essere e di proporsi […] tutto il territorio” (Arriola, Vasapollo, 2005: 197).
Il lavoratore precario perde ogni senso di collettività all'interno di un contesto perennemente
provvisorio, in cui è costretto a passare da un luogo di lavoro ad un altro.
Gli alti livelli di tecnologia che caratterizzano la nostra epoca, inoltre, non fanno altro che aggravare
questa situazione. Si pensi, per esempio, ai Paesi più sviluppati in cui il telelavoro sta diventando
una realtà sempre più diffusa (Arriola, Vasapollo, 2005). Ognuno lavora a casa propria e con il
proprio terminale. Questa situazione come si può immaginare ha delle forti ripercussioni sia
sull'interazione con altri individui, sia nel modo stesso di abitare il territorio.
E' la flessibilità che plasma oggi l'intera società e che trova nella precarizzazione del lavoro un
elemento centrale nell'attuazione dell'accumulazione flessibile.
Siamo di fronte ad un precariato diffuso, generato da due tipologie di flessibilità (Gallino, 2001):
1. flessibilità quantitativa o numerica o esterna: permette all'impresa di variare il numero dei
suoi occupati in relazione alle oscillazioni del ciclo produttivo
(licenziamento/occupazione) ;
2. flessibilità qualitativa o funzionale o interna: permette all'impresa di modulare direttamente i
parametri della prestazione d'opera dei dipendenti (salari, orari, luoghi, mezzi, ecc.).
6
I costi umani che queste due tipologie di flessibilità comportano possono essere sintetizzate in tre
tipi di precarietà:
• una precarietà esistenziale, dovuta alla limitata o nulla possibilità di formulare previsioni o
progetti per il futuro;
• una precarietà sociale, infine, in quanto la rimozione degli aspetti di stabilità spaziale e
relazionale del lavoro mina alla base l'identità e l'integrazione sociale della persona.
Oltre che:
• una precarietà professionale, legata all'impossibilità di accumulare esperienze lavorative
trasferibili da un lavoro all'altro;
In questo modo tutto l'intero vivere viene precarizzato. Il lavoratore non ha alcun orario, costruisce
il più delle volte la sua vita in funzione del lavoro, è sempre meno tutelato e spesso sopporta
passivamente la sua situazione in quanto è ciò che il mondo del lavoro oggi offre. Egli è cosciente
della difficoltà di rientrare in questo mercato una volta espulso: la precarietà si pone come unica
alternativa alla disoccupazione. Si creano delle circostanze in cui la disponibilità alla precarietà
diventa fondamentale per l'accesso al mondo del lavoro. Ne scaturisce una specie di servilismo del
lavoro per cui coloro i quali ne hanno uno devono essere disposti a rinunciare ai loro diritti,
sottomettendosi alle leggi di mercato.
Tutto questo non ha fatto altro che disarticolare la resistenza sociale. La flessibilità ha accelerato il
processo di frammentazione di quella che un tempo era la classe operaia (che oggi non esiste quasi
più) e di conseguenza delle sue capacità di associazione o di alleanza: in un'impresa in cui, in base
ai principi di flessibilità, i lavoratori cambiano continuamente risulta molto difficile organizzarsi ed
allearsi per dar vita ad un'azione contro il sistema capitalista
4. IL PRECARIATO COME PROMOTORE DELLA NASCITA DI UNA NUOVA
ALLEANZA.
Nell'ottica di sviluppare una forza antagonista al processo di deregolamentazione e destrutturazione
del mondo lavoro apportato dall' applicazione dei principi del sistema capitalistico, sorge il
problema dell'organizzazione dei lavoratori precari .
Alcuni autori come Magatti (2012), Vasapollo (2005), Arriola (2005) e Alpini (2010) hanno messo
in luce l'importanza nonché la necessità di trovare nuove forme di coalizione per lo sviluppo di
un'azione sovversiva in termini di ribaltamento delle condizioni sociali ed economiche imposte dal
7
sistema capitalista.
Questa operazione appare tutt'altro che semplice, viste soprattutto le condizioni soggettive del
lavoratore che si sono venute a creare a causa della trasformazione capitalistica dei sistemi di
lavoro. Le nuove condizioni di lavoro, come già visto nell'analisi fatta nei precedenti paragrafi,
influiscono non solo sull'attività lavorativa del soggetto, ma anche sulla sua disponibilità alla
ribellione. La caratteristica principale del lavoratore precario è la sua difficoltà a considerarsi parte
di una collettività e portatore di diritti oltre che di doveri. A partire da questa condizione è
necessario dunque individuare modelli organizzativi “che sappiano rompere la gabbia
dell'individualismo e che offrano strumenti collettivi” (Arriola, Vasapollo, 2005). Ma come fare? Da
dove partire?
Per rispondere a questa domanda, un nodo centrale è una presa di coscienza generale delle
condizioni lavorative e sociali attuali che dovrebbe spingere tutto il mondo del lavoro, occupati11 e
disoccupati, a pretendere i propri diritti al lavoro, del lavoro ed alla tutela giuridica attraverso
l'organizzazione comune di tutte le forme diverse di precarietà. In tal caso alla rottura della
condizione individuale ed alla necessità di individuazione di nuove forme di organizzazione, si
aggiunge la necessità della costruzione di un'identità collettiva. Bisogna iniziare a combattere quelle
battaglie generali fondate sui diritti “che possono offrire al lavoratore precario una capacità di
lettura del mondo che non lo isoli nella sfera individualistica della sua condizione” (Arriola,
Vasapollo, 2005).
L'intero processo di riconoscimento di un agire collettivo (dalla rottura della sfera di individualismo
alla formazione di un'identità collettiva) può generarsi dunque a partire dalla condizione diffusa di
precariato e dalla formazione di un senso di uguaglianza precaria.
L'attuale forma di precariato si presenta del tutto diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati:
non si tratta più di un fenomeno giovanile e transitorio, ma di una condizione strutturale e diffusa
all'interno del mercato del lavoro. La precarietà colpisce tutti e per la prima volta anche gli
occupati. Il suo essere una condizione generale può creare quei presupposti in grado di rompere le
sfere dell'individualismo e generare un processo di alleanza partendo da un obiettivo comune: il
bisogno di lavoro e dei diritti del lavoro.
Prescindendo da atti di autocommiserazione e di rassegnazione, le condizioni diffuse di precarietà
possono rappresentare quel fenomeno capace non solo di mettere in luce quelle contraddizioni
economico-sociali del modello di sviluppo capitalista, ma anche di rivitalizzare i processi di
socializzazione.
Questi processi possono dar vita a nuove alleanze capaci di rilanciare una nuova fase del conflitto
11 E' un fenomeno questo che riguarda anche gli occupati
8
capitale-lavoro, che potrebbe portare al superamento del modo di produzione capitalista e alla
formazione di un sistema di produzione alternativo.
5. GLI ORIENTAMENTI PER LA FORMAZIONE DI UN'ALLEANZA.
La realizzazione di un'alleanza non è parte di un automatismo: essa non nasce a partire da qualsiasi
processo di socializzazione. La sua concretizzazione può dipendere dall'adozione di una serie di
orientamenti, molti dei quali rimettono in discussione il significato di alcuni concetti che sono stati i
pilastri della società capitalistica.
1. Una libertà come cura.
La realizzazione di un'alleanza non è mai facile, specie in quanto essa presuppone il difficile
passaggio dall'individualismo a forme di agire collettivo.
L'epoca in cui viviamo ha sancito più che mai il trionfo dell'individuo e l'economia capitalistica
incentrata sul consumismo non ha fatto altro che alimentare il pensiero solipsistico. Alla base di
questo pensiero vi è un concetto di libertà fine a sé stessa , slegata da qualsivoglia precondizione:
“una libertà individuale senza progetto sociale” (Magatti, 2012: 182). L'individuo si chiude in sé
stesso e finisce per rifiutare la realtà circostante in quanto ritenuta espressione di un autoritarismo
limitante. All'interno della propria sfera personale, non coltiva alcun “progetto orientato a custodire
la socialità, a promuovere la giustizia, a migliorare le condizioni sociali, umane ed eco-sistemiche
di porzioni sempre più consistenti della popolazione” (Magatti, 2012:183).
Non si pensi però che tutto questo coincida con uno stato di quiescenza che, come sappiamo, la
nostra epoca (in particolare il mercato che la domina) non permette. Pur nella propria sfera
individuale ognuno si muove seguendo un percorso di vita esclusivamente incentrato sull'apertura
di nuove possibilità. Non che questo sia sbagliato, anzi esso diventa l'unica condizione del vivere (e
lavorare) possibile, ma è un movimento che si relaziona con il vuoto prescindendo dal contesto,
dalla storia e dai rapporti con qualcuno o qualcos'altro.
Se ci si ferma a riflettere ci si accorge come il “rinchiudersi” all'interno del proprio spazio di libertà
ed il rifiuto della realtà, coincida con un'elusione del concetto del limite. Non esistono limiti, la
nostra libertà li scavalca, o meglio, il nostro pensiero di libertà li camuffa. Lo sviluppo tecnologico
in questo caso è stato d'aiuto: esso non ha fatto altro che allargare il campo d'azione e di auto-
affermazione di ciascun individuo. E' proprio in quest'ultimo passaggio che può essere inteso come
9
il processo capitalistico, promotore di un livello di tecnologia sempre più avanzato, non abbia fatto
altro che alimentare questo pensiero di superamento del limite.
All'improvviso però il meccanismo si è rotto mettendo in evidenza le falle dell'intero sistema che
aveva contribuito allo sviluppo di un concetto di libertà e dell'io slegati da qualsiasi realtà.
La consapevolezza dell'Io si forma sempre in relazione a “ciò che è Altro da sé” (Magatti, 2012) e
che gli sta intorno. Di conseguenza la sua libertà non può essere concepita come una scala illimitata
di possibilità da seguire e che si sviluppa a prescindere da un contesto.
La libertà si genera in uno spazio, fatto di contenuti materiali ed immateriali (come sentimenti,
storia, memoria), e si orienta sempre rispetto ad un qualcosa (Magatti, 2012). Di conseguenza la
libertà per essere realmente tale ha bisogno di una dimensione reciproca anche nel suo essere
soggettiva in quanto appena un individuo traccia la propria libertà, nello stesso momento forgia
quella di un altro.
Il processo di riconoscimento dell'altro non deve intendersi come un qualcosa di fortemente
limitante per il soggetto o che lo faccia ricadere in uno status anonimo all'interno del mondo, ma
come un processo che esalta le peculiarità di ciascuno ponendolo in una condizione di maggiore
relazionalità con il mondo circostante.
Tale concezione di libertà mette in evidenza due aspetti: l'esistenza degli spazi e quella delle
relazioni di reciprocità, da cui essa non può prescindere.
Uno degli orientamenti auspicabili per dar vita ad un'alleanza sta proprio nel ricostruire questo tipo
di libertà spaziale e reciproca.
Per essere liberi all'interno di un contesto è necessario prendersi cura delle sue componenti:
l'ambiente storico, l'ambientale naturale e l'ambiente relazionale12.
La cura dell'ambiente storico implica non solo il recupero ed il mantenimento della memoria ma
anche una differente concezione del tempo che rompe l'istantaneità che fino ad oggi l'aveva
caratterizzato. Siamo vissuti in una condizione di libertà illusoria all'interno di un contesto in cui le
nostre vite erano vincolate da una vera e propria frenesia impostaci dal mercato. Essere flessibili
significava (e significa) essere mutevoli e la mutevolezza non ha tempi lunghi, essa esige
l'immediatezza. Attraverso una rimodulazione della dimensione temporale si offre ad ognuno la
possibilità di “stare dentro le relazioni” (Magatti, 2012) e di scambiare esperienze e ricordi che
aiutino a trasformare gli spazi in luoghi di senso e di memoria.
La cura dell'ambiente presuppone, invece, un uso responsabile delle sue risorse allo scopo di
rispettare e non oltrepassare i suoi limiti. Per anni la corsa verso una tecnologia sempre più raffinata
che permettesse agli individui di raggiungere ed ampliare la loro libertà virtuale e fittizia, ha
12 Per maggiori approfondimenti sul tema si legga l'opera di Magatti : “La grande Contrazione” (2012)
10
sfruttato al massimo le risorse disponibili senza preoccuparsi del loro esaurimento in natura, né
delle conseguenze che questo portava con sé. Fortunatamente la crisi ambientale ed energetica che
si è manifestata negli ultimi anni ha generato una presa di coscienza generale sullo stato
dell'ambiente . Da qui nascono nuove proposte di approccio alle risorse: già negli anni ottanta il
Brundtland Report mette in risalto il concetto di sviluppo sostenibile che di lì a poco si sarebbe
diffuso all'interno del dibattito politico. Ne nascono, da una parte, linee d'azione discutibili che
sebbene si generino dalla preoccupazione ambientale generale finiscono per ricadere all'interno di
sfere d'interesse individuale13. Tali dinamiche, a volte poco efficaci, portate avanti e gestite da forti
sistemi imprenditoriali “si scontrano con forti proteste di coloro i quali hanno la capacità di
indignarsi e far sentire la propria voce” (Magatti, 2012). In molti casi queste proteste provenienti da
una forte preoccupazione ambientale, non restano solo azioni fine a sé stesse, ma si convertono in
nuove piccole esperienze che fanno del rispetto per l'ambiente il loro punto di forza. Gli esempi,
dunque, già esistono ma sono ancora troppo deboli: bisognerebbe partire da queste modeste realtà
per generare un processo di cura dell'ambiente, che vada al di là dell'interesse dei pochi e sia invece
vissuto come una responsabilità globale.
Infine la cura delle relazioni che ci apre verso la conoscenza dell'Altro da Sé (Magatti, 2012). La
condizione sociale in cui siamo risulta facilmente comprensibile se ci si sofferma ad analizzare
quelli che sono sempre stati i “grandi contenitori di socialità” (Magatti, 2012): le città.
Queste, ormai completamente alla mercé del sistema di mercato, sono diventate dei luoghi di
possibilità in transito e di funzioni mettendo da parte le caratteristiche di socialità. In molto casi
sembra quasi che la città sia stata concepita per ostacolare l'aggregazione di individui mantenendoli
segregati e distanti. Queste condizioni hanno favorito la permanenza di ognuno all'interno della
propria sfera di libertà e di realtà, atrofizzando pian piano il concetto dell'Altro da sé e
seppellendolo sotto una sempre più forte convinzione di auto realizzazione. E' necessario ricreare
all'interno delle città quei luoghi che ci permettono di coltivare la relazione con gli altri.
Questa analisi che verte su un ripensamento del concetto di libertà, vuole mettere in evidenza la sua
imprescindibile dimensione relazionale e spaziale che la rende reale ovvero efficacemente
realizzabile. Per contro quella libertà a cui eravamo abituati , caratterizzata da un individualismo
virtuale ed illimitato, è effimera e la crisi in atto ce lo dimostra. Non si può vivere la nostra libertà
prescindendo da un contesto che esiste e di cui dobbiamo prenderci cura perché la libertà di ciascun
individuo finisce dove inizia quella di un altro.
13 Sono critiche mosse, in particolare, al sistema flessibile di acquisizione dei crediti di emissioni (Clean Development Mechanism, Joint Implementation, Emissions Trading) nato dal Protocollo di Kyoto. Poiché essi possono essere scambiati fra i Paesi firmatari, si pensa che si stia creando un “mercato dei crediti di emissione” che non faccia altro che aggirare gli obiettivi di abbattere l'inquinamento imposti dal Protocollo stesso.
11
2. Dal desiderio al bisogno.
Una delle ragioni che rendono duratura un'alleanza è senz'altro la natura del suo obiettivo.
Qualora esso coincida con il desiderio consumistico non può perdurare nel tempo. Il desiderio nella
sua illimitatezza appare fortemente mutevole e astratto e può rompere lo spirito di aggregazione
iniziale a seguito della sua realizzazione.
Un'alleanza che ha come obiettivo la realizzazione del desiderio , una volta che l'obiettivo viene
raggiunto, tende a sgretolarsi in una serie di altre alleanze ciascuna delle quali seguirà il desiderio
successivo in una dinamica a catena tendente al singolo individuo. Per capire meglio il concetto, si
pensi, come ultimo tassello di questa catena, al desiderio incentrato sui prodotti personalizzati : essi
sono portatori di esclusività che “separa” il singolo dalla massa e fautori, così, di un altissimo
livello di individualismo.
L'epoca consumistica ci ha abituati al desiderio fornendoci continuamente mezzi utili per poterlo
realizzare mentre, contemporaneamente, ne creava altri sempre nuovi e più appetibili. Si veniva
così a creare un vortice all'interno del quale l'individuo si muoveva seguendo solo la sua smania.
Poiché l'abitudine al desiderio ci spinge verso l'individualità è necessario sovvertirla creando quelle
condizioni di possibile convergenza verso il bisogno, meno mutevole ed astratto. Il bisogno può
rappresentare qualcosa che va oltre gli schemi economici convenzionali ed assume invece
un'essenza maggiormente sociale, soprattutto se condiviso.
Poiché è auspicabile che la soddisfazione del bisogno duri nel tempo , l'alleanza non dovrebbe
sciogliersi una volta raggiunto l'obiettivo, ma dovrebbe durare al fine di vigilarne il mantenimento.
3. Autonomia e reciprocità dell'alleanza
Per reciprocità si intende la qualità che rende ogni relazione umana simmetricamente e
mutualmente scambievole ed ognuno dei partecipanti ugualmente importante.
Qualora si realizzino le condizioni di reciprocità, si gettano i presupposti per l'instaurarsi di una
solida alleanza.
Credo sia opportuno prendere in considerazione le idee di Piaget (1988). Egli sosteneva che una
vera alleanza fosse quella basata sull'autonomia, ovvero capace di rifuggire le condizioni di anomia
e di eteronomia, strutturando un'attività auto disciplinata come risposta all'inerzia e all'azione
forzata. Affinché sia raggiunta l'autonomia, che figura come lo stato di equilibrio tra le due
condizioni suddette, è necessario:
12
• l'esistenza di un sistema condiviso di simboli e valori in grado di rendere praticabile
l'interazione tra i soggetti che prendono parte all'alleanza;
• il mantenimento della validità di determinati accordi raggiunti durante l'interazione e che
vanno a costituire la base di appoggio per la prosecuzione dell'interazione stessa ed ai quali
riferirsi quando necessario;
• l'esistenza del principio di reciprocità tra le parti che garantisce i vari soggetti nel corso
dell'interazione (Rizza, Sermasi, 2008).
Qualora sopraggiungano delle lacune, la condizione di equilibrio (l'autonomia) non si realizza e
l'intera struttura finisce per scivolare all'interno dello stato di anomia o in quello di eteronomia.
All'interno della condizione di eteronomia si crea un falso equilibrio ovvero un equilibrio imposto
dall'esterno basato sulla coercizione che nega il realizzarsi della reciprocità. In questo caso si
accetta tutto quello che viene imposto dalla controparte, in virtù della sua autorità (Rizza, Sermasi
2008). Le interazioni sono dettate quasi esclusivamente in maniera uni direzionale. L'azione
dell'impresa capitalista ne è un chiaro esempio.
L'anomia invece è quella condizione in cui non si raggiunge il costituirsi di rapporti di
cooperazione. Ciò può essere principalmente dovuto al fatto che14:
a. non si condivide lo stesso sistema di valori. Questo può avvenire15 quando l'alleanza si divide tra
chi considera prioritario il benessere individuale e chi persegue in primo luogo cambiamenti politici
profondi;
b. dopo un certo tempo non si considera più valido il percorso intrapreso rispetto agli ideali stabiliti
in un primo momento;
c. quando cade o non si realizza il principio di reciprocità.
Il perfetto equilibrio fra questi due stati porta all'autonomia che struttura l'alleanza e nel tempo
stesso è portatrice di un eterogeneo processo di uguaglianza in cui i rapporti di coalizione attenuano
eventuali asimmetrie e possono mettere in crisi le forme di gerarchia capitalistica.
4. I confini permeabili dell' alleanza.
Come sostiene Magatti (2012), l'alleanza ha bisogno di un limite, ovvero essa “ va suggerita in
rapporto ad un confine che, stabilendo un dentro, si pone in rapporto con un fuori” (Magatti, 2012).
14 Per approfondimenti sul tema: Rizza R., Sermasi J., 2008, Il lavoro recuperato. Imprese e autogestione in Argentina, Mondadori, Milano.
15 Molto comune all'interno delle fabbriche recuperate studiate
13
L'alleanza presuppone un luogo e, in un discorso pluralistico, si può dire che se più alleanze
presuppongono più luoghi, queste alleanze creano territori.
Quando si parla di alleanza in questa tesi, non si vuole far riferimento ad un'azione di coalizione che
comporti una chiusura regressiva e conflittuale verso l'esterno bensì ad un'apertura sensata e
sostenibile verso il mondo circostante. I limiti di cui ciascun gruppo necessita per riconoscersi tale,
non sono delle mura rigide e impermeabili che lo sigillano trasformandolo in un' enclave, ma sono
confini attivi che gli permettono di comunicare con l'esterno e nello stesso tempo mantenere le
proprie caratteristiche proprio come il bordo di una membrana cellulare che è “sia poroso che
resistente” (Sennett, 2011:15) dove “le cose fluiscono dentro e fuori” (Sennett, 2011:15) pur
conservando la sua struttura.
Allearsi significa anche “creare le condizioni che permettono di scambiare con cerchie più ampie
senza perdere la propria consistenza interna” (Magatti, 2012) e, in un'ottica multi livello, questo
concetto non esclude la partecipazione ad altre alleanze tra attori diversi e lontani.
Non deve mai essere perso di vista il fatto che ormai viviamo all'interno di un mondo
completamente globalizzato, che non possiamo né distruggere né ignorare, ma con cui dobbiamo
(se pur forzatamente) rapportarci per andare avanti. Questo implica la necessità imprescindibile di
relazionarsi con le infrastrutture ed con i linguaggi del mondo globale.
Sotto queste condizioni il rapporto fra alleanze coincide con la ricostruzione di un territorio
relazionale non fine a sé stesso. Il territorio creato dalle alleanze e dalle loro relazioni reciproche, si
inserisce nello spazio a-contestuale e ineluttabile della tecnologia e del mercato, connettendolo
quanto possibile alle proprie esigenze e peculiarità.
Credo che tali orientamenti, se intrapresi, potrebbero rappresentare quelle condizioni alla base di un
processo di alleanza o di agire collettivo (rottura dell'individualismo, realizzazione di modelli di
organizzazione e costituzione di un'identità collettiva), potenzialmente capace di un'azione di
opposizione al sistema capitalistico.
6. VERSO NUOVE ALLEANZE E NUOVE FORME DI PRODUZIONE.
Le condizioni di precariato che caratterizzano l'epoca in cui viviamo, creano una forte e diffusa
esigenza di lavoro. Questa assume le caratteristiche di un vero e proprio bisogno che non si esprime
solo attraverso la necessità di trovare un posto di lavoro, ma anche e soprattutto attraverso
l'esigenza di migliorare le condizioni di lavoro. Da qui la tesi secondo la quale: la necessità e la
diffusione di questo bisogno (di diritto al lavoro e del lavoro) possono creare i presupposti efficaci
14
per la formazione di un'alleanza .
La nascita della consapevolezza del fallimento del modello capitalista e del mito della libertà senza
limiti da esso proposto, nasce da coloro i quali non sono più disposti al “vivere ad intermittenza”.
I lavoratori della conoscenza e i lavoratori altamente specializzati sono i soggetti più sensibili alla
nascita di tale consapevolezza in quanto, oggigiorno, essi rappresentano le due fette più grandi della
realtà precaria (soprattutto in Italia). Da loro potrebbe generarsi quell'azione il cui obiettivo
dovrebbe essere non solo quello di trovare nuovi posti di lavoro per ciascuno dei membri che forma
l'alleanza, ma anche quello di agire per un bene comune e duraturo.
In questa logica il fine dell'azione diventerebbe quello di ristabilire una catena di valori all'interno
dei processi di produzione. Questa catena di valori, come sostengono Porter e Kramer (2011),
influenza e viene influenzata da numerose criticità sociali che vanno dallo sfruttamento delle risorse
naturali fino all'inquinamento ed alle condizioni generali del lavoro generatrici di precarietà.
Proprio l'importanza e l'influenza di questa catena di valori sulla società rendono importante il fatto
che l'alleanza non si chiuda in se stessa ma interagisca con gli altri soggetti, le altre alleanze oltre
che con l'intera impalcatura infrastrutturale costruita negli anni dal capitalismo.
Facendo riferimento a Dematteis (2001) e considerando la territorialità come un mediatore
simbolico di connessione tra la materialità delle risorse immobili presenti e le strategie degli attori
impegnati nei processi di sviluppo, si può pensare che l'azione dell'alleanza suddetta sia
interpretabile come un'azione di territorializzazione che si contrappone a quella de-territorializzante
del mercato capitalista.
La dimensione relazionale così ritrovata rimetterebbe il territorio nuovamente al centro dei processi
di produzione. In queste condizioni si creerebbero i presupposti per la nascita di un mercato
alternativo che diventerebbe il teatro di un agire economico basato sulla reciprocità, in cui gli
scambi non sono dissociabili dai rapporti umani in quanto appartengono ad un processo produttivo
in cui ognuno è “portatore di diritti nei confronti non solo della qualità del prodotto ma anche del
processo produttivo che conduce a quel prodotto” (Bruni, Zamagni, 2004). Dall'adozione di questa
prospettiva nasce quella che Butera (2009) definisce “impresa integrale”, fondata su un nuovo tipo
di organizzazione capace di:
• valorizzare le risorse umane;
• preservare le risorse naturali;
• realizzare la produzione ed il rafforzamento del legame sociale e delle risorse relazionali.
Secondo questa teoria l'impresa così fatta proporrebbe un ripensamento del vecchio concetto
15
mutualistico proponendone uno nuovo che travalicando i confini dell'impresa stessa , si diffonde sul
territorio circostante. E' un mutualismo nato dalla condizione diffusa di precarietà e da un senso di
uguaglianza essenziali per gettare le basi ad un processo di formazione di alleanza.
In quest'ottica teorica il precariato può essere dunque letto come attivatore di processi di
aggregazione sociale potenzialmente capaci di mettere in atto un'azione antagonista nei confronti
del mercato capitalista, gettando le basi per la formazione di un nuovo modello di economia che
presupponga in sé l'esistenza di valori non solo economico/finanziari ma anche sociali.
Questo nuovo modello economico andrebbe a rianimare quei territori e quelle persone “ferite” dalla
rete del mercato globale. Si prenderebbe cura di loro, magari non secondo principi assistenzialistici
ma in un'ottica di ri-attivazione, dando loro lo spazio sufficiente per auto-organizzarsi e per creare
alleanze economiche e sociali, al fine di riconnettersi nuovamente al mondo del mercato globale.
7. UN'ANALISI CONCLUSIVA SUI PROCESSI DI ALLEANZA.
Come già accennato nell'introduzione, questo capitolo contiene alcune linee di ragionamento che
saranno ampliate nel corso della tesi. Mi è sembrato importante mettere in luce il concetto di
precarietà, prima attraverso un'analisi del processo storico che ha decretato la sua diffusione
all'interno del mondo lavorativo (precarietà lavorativa) e sociale ( precarietà esistenziale e sociale),
poi all'interno di un discorso incentrato sulle sue potenzialità generative. In letteratura sono molti gli
autori (da Magatti a Gallino, da Alpini a Zamagni) che a partire dall'analisi delle condizioni di crisi
che stiamo vivendo reputano necessaria l'adozione di un nuovo modello di produzione. Ma come
nasce questo modello? Esso può avere origine solo da una forza antagonista a quella dei mercati
attuali. Nelle teorie degli autori suddetti il modello alternativo viene ampiamente descritto. Tuttavia
dalla critica dell'attuale sistema di produzione alla teorizzazione di uno nuovo ed alternativo, credo
manchi sempre quel tassello che consiste nell' individuazione degli artefici che possono rendere
possibile tale passaggio. In questo “vuoto”, nel mio ragionamento, ho inserito il mondo dei
lavoratori precari e non, presupponendone un'alleanza che nasca da una lotta per l'ottenimento del
diritto al lavoro e del lavoro16.
Tuttavia in questo capitolo non deve essere letta una volontà di teorizzare il processo che va dal
precariato all'alleanza come un automatismo bensì deve essere letta una volontà di guardare ad esso
in un'ottica di potenzialità. Sono stati suggeriti degli orientamenti che “indirizzandolo” potrebbero
renderlo realizzabile.
16 Quest'ultimo maggiormente legato alle condizioni d'impiego e che permetterebbe il coinvolgimento anche degli
occupati
16
Nella realtà sono molti i fattori di resistenza alla sua concretizzazione.
Primo fra tutti il meccanismo del cooperativismo classico. Tentativi di realizzazione del processo di
alleanza a partire dal precariato all'interno della sfera lavorativa si sono già avuti. Essi hanno
portato alla nascita, per esempio, del fenomeno del Worker's buyout17 (WBO). In tal caso i
lavoratori si istituiscono in cooperativa per acquisire (comprare o affittare) la fabbrica (o parte di
essa) appellandosi alla Legge 49 del 1985 (detta Legge Marcora). La cooperativa viene inglobata da
una delle Federazioni Centrali delle Cooperative18 esistenti in Italia. Tali federazioni sostengono le
cooperative dei lavoratori attraverso l'erogazione di un fondo finanziario (commisurato in base al
numero dei dipendenti ed alle condizioni dell'impresa) accompagnato da una clausola di
restituzione nei 10 anni successivi, figurando così come soci finanziatori e partecipando attivamente
ai processi decisionali delle cooperative stesse19 . A lungo andare si instaura così all'interno delle
cooperative una condizione di eteronomia legata alla presenza delle Federazioni per cui la loro
azione diviene finalizzata solo al guadagno, allo scopo di poter restituire quanto dovuto alla
federazione finanziatrice. Nella maggioranza dei casi, i WBO coinvolti in questo processo, “si
chiudono” nella loro attività di produzione senza dar vita ad alcuno scambio relazionale con gli altri
attori presenti sul territorio. In questo caso, vengono meno gli orientamenti di autonomia e di
permeabilità dell'alleanza. Il WBO finisce per operare alla stregua di un'impresa classica.
Cosa si può fare affinché ciò non avvenga? Esiste una struttura alternativa a quella della cooperativa
che escluda qualsiasi forma di eteronomia ?
In realtà da un'analisi della situazione attuale in Italia si può dire che esistono alcune realtà, come
quelle delle fabbriche recuperate studiate in questa tesi, che esercitano già una forma di ribellione al
sistema di produzione capitalistico ed a quello cooperativo classico. Tuttavia, sebbene esse abbiano
abbandonato il sistema cooperativistico dei WBO a cui si sono aspirate, possono effettivamente
essere le esecutrici di una sovversione efficace al sistema come è avvenuto per le fabbriche
17 Il wbo è un'operazione di acquisto di una società realizzato dai dipendenti dell'impresa stessa. È una tipologia dioperazione diffusa soprattutto negli Stati Uniti. Nel nostro Paese, a seguito della crisi economica del 2008, il fenomenodei workers buyout ha cominciato a coinvolgere anche le nostre aziende spesso in seguito alla messa in liquidazione oal fallimento dell'azienda. In questo caso i lavoratori, al fine di crearsi un'alternativa occupazionale e di salvaguardareil know how acquisito, si riuniscono in cooperativa e si propongono di prendere in affitto o acquisire l’azienda dalliquidatore o dal curatore fallimentare, a volte anche dal datore di lavoro stesso. Per farlo utilizzano propri risparmi el’indennità di mobilità, se l’INPS riconosce la possibilità di erogare l’anticipo dell’indennità stessa per destinarla allacapitalizzazione da parte dei soci Il WBO si distingue dall'attuale fenomeno delle fabbriche recuperate in quantoall'interno di esso il procedimento di acquisizione da parte dei lavoratori avviene legalmente molto spesso attraverso unaccordo prestabilito tra lavoratori e ex-proprietario. Il WBO a differenza delle fabbriche occupate non contempla ilprocesso di occupazione dell'impresa da parte dei lavoratori.
18 In Italia le maggiori sono Legacoop, ConfCooperative e AGCI.
19 In realtà il voto della Federazione è pari a circa 1/3 del voto di un lavoratore della cooperativa (Fonte: Alessandro Viola, CFI – Cooperazione Finanza Impresa).
17
recuperate in Argentina?
E' difficile, visto che “i livelli” di crisi sono molto diversi.
Ulteriori fattori che rendono difficile il processo teorizzato riguardano l'esistenza della classe media
e del sistema di welfare assistenzialista italiano.
Come è storicamente dimostrabile, il “livello” di crisi raggiunta è proporzionale allo “spessore” del
ceto medio esistente all'interno della società. Le trasformazioni della scala gerarchica sociale
rappresentano sempre la cartina di tornasole dello stato economico e finanziario di un paese. In
Italia, anche se le classi medie sono sempre più vulnerabili difronte alla crisi in atto, non hanno
ancora cessato di esistere20 . La loro presenza riesce ancora a scongiurare il crollo dell'intero sistema
sociale, come invece è avvenuto in Argentina. Un ulteriore fattore, che con la (r)esistenza della
classe media allontana il crollo, è rappresentato dalla presenza di una logica assistenzialista italiana
basata sull'uso di ammortizzatori sociali (tutele in costanza di rapporto di lavoro, assicurazione
sociale per l'impiego, strumenti di gestione degli esuberi strutturali) e di un sistema di leggi anti-
crisi (come appunto la Legge Marcora per le cooperative) che in paesi come l'Argentina non sono
mai esistiti o non sono quasi mai stati applicati21. Questi sistemi non fanno altro che creare una
“classe di disoccupati retribuiti” e, di conseguenza, alimentare il grado di servilismo al sistema
capitalista.
Si tratta di cure palliative contro la crisi in atto. Tuttavia la loro esistenza e quella delle altre
suddette condizioni, getta l'intera società in un limbo in cui le logiche capitalistiche (soprattutto
quelle legate all'individualismo) tendono ancora a prevalere rendendo difficile l'instaurarsi di un
processo efficiente di alleanza “sovversiva”.
In ultimo vorrei mettere in luce il ruolo della città all'interno del processo di alleanza. In questo
capitolo si teorizzano le dinamiche attraverso le quali tale processo non va a coinvolgere solo quei
soggetti aventi un'allocazione specifica ed esclusiva (ad esempio: solo gli operai all'interno di una
fabbrica o solo gli studenti all'interno dell'Università), ma si presenta invece come un processo
potenzialmente in grado di interessare tutti (o quasi) gli abitanti della città.
Allo scopo di favorire l'alleanza, alla città spetterebbe il compito di agevolare l'incontro tra i
soggetti che potrebbero prendervi parte. L'urbano, in particolare la sua organizzazione spaziale e
politica, risulterebbe fondamentale all'interno di quella catena potenziale che porta all'alleanza.
Considerando nuovamente la definizione di città come contenitore di socialità, che si era data in
precedenza, in base alle considerazioni emerse nel corso del capitolo sembra necessario riprenderla
20 In Argentina con la crisi del 2001, che segna anche la nascita delle fabbriche recuperate, si è avuta una drastica diminuzione della classe media.
21 Nel 1995 in Argentina fu promulgata la “Ley de Concursos y de Quiebra” avente lo scopo di “salvare” i lavoratori delle imprese in fase di fallimento. Nonostante la sua esistenza questa legge fu applicata solo in casi davvero straordinari.
18
ed ampliarla. Poiché la socialità va alimentata e sostenuta, in quanto, come abbiamo visto, esistono
processi che tendono a soffocarla, la città non dovrebbe essere solo un semplice contenitore ma
dovrebbe agire rivitalizzando quelle dinamiche relazionali che sono alla base della socialità. Solo in
queste circostanze possono verificarsi quelle condizioni che danno la possibilità a ciascun individuo
di mettersi continuamente in relazione con gli altri, prendendo così coscienza delle condizioni
comuni.
Una città siffatta può diventare un efficace contesto generativo di un sistema di relazioni (e di
alleanze)22 attorno al quale è possibile costruire un' economia alternativa a quella capitalista.
BIBLIOGRAFIA
Alpini S., 2010, Economia, territorio e istituzioni: lo sviluppo locale auto sostenibile, Ed Felici,
Ghezzano (PI).
Arriola J., Vasapollo L., 2005, L'uomo precario nel disordine globale, Ed. Jaca Book, Milano.
Bruni L., Zamagni S.,2004, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Ed. Il Mulino,
Bologna.
Butera F., 2009, L'impresa integrale: teoria e metodi. L'integrazione fra gestione economica e
responsabilità sociale nelle imprese costruite per durare: un percorso governabile, in
“Sviluppo&Organizzazione”,pp. 18-38.
22 “dal basso”.
19
Dematteis G., Per una geografia della territorialità attiva e dei valori territoriali, in SLoT
quaderno 1, a cura di P. Bonora, Bologna 2001, pp. 11-30
Gallino L.,2001, Il costo umano della flessibilità, Ed. Laterza, Roma-Bari.
Ginsburg H., Opper S.,1988, Piaget's Theory of Intellectual Development,Prentice-Hall
Gorz A., 2003, L’immateriale. Conoscenza, valore e capitale. Trad. it. di A. Salsano, , Ed. Bollati
Boringhieri (Temi), Torino.
Governa F., 1999. Il milieu urbano. L'identità territoriale nei processi di sviluppo, Ed. Franco
Angeli, Milano.
Magatti M., 2012, La grande contrazione. I fallimenti della libertà e le vie di riscatto , Feltrinelli
Ed. Milano.
Magnaghi A., 2006, Il Progetto Locale, Ed. Bollati Boringhieri, Torino.
Maslow A., 1971, Verso una psicologia dell'essere, Ubaldini, Roma.
Raffestin C.,1984, Territorializzazione, deterritorializzazione, riterritorializzazione e informazione
in A. Turco (ed.), Regione e regionalizzazione, Ed. Franco Angeli, Milano.
Rizza R., Sermasi J.,2008, Il lavoro recuperato. Imprese e autogestione in Argentina, Bruno
Mondadori, Milano.
Rostow W.W., 1983, Prospects for the World Economy, National Bank of Egypt, Cairo.
Sennett, R., 2011, Idee circa il mondo in cui vogliamo vivere, Roger Scruton, Zygmunt Bauman,
Richard Sennett, in “Vita e pensiero”, 5.
20