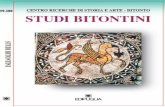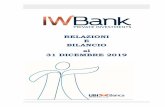Gli inganni della tradizione. Una silloge di Gregorio Magno nel quadro delle relazioni fra Carolingi...
-
Upload
unimarconi -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Gli inganni della tradizione. Una silloge di Gregorio Magno nel quadro delle relazioni fra Carolingi...
Gli inganni della tradizione*.
Una silloge del Registrum di Gregorio Magno nei rapporti fra Carolingi e
papato e nel dibattito sulle immagini sacre.
I.
Nel 1987 Francis Clark pubblicò la monografia The Pseudo-Gregorian
Dialogues, in cui intendeva dimostrare che i Dialogi non furono scritti da
Gregorio Magno ma da un membro della cancelleria pontifica intorno alla fine
del secolo VII, periodo a cui risalgono le prime attestazioni di quest’opera. La
tesi di Clark è stata oggetto di scrupolose smentite. Non è stato invece possibile
contestare la risultanza storico-culturale che emergeva dalle sue ricerche, ossia
la scarsa considerazione dedicata alla figura di Gregorio, in particolare nella
penisola italica, fra la fine del secolo VII e il secolo VIII. Più di recente Alan
Thacker e Conrad Leyser hanno ribadito l’assenza in Roma di memorie
biografiche e cultuali relative a Gregorio almeno fino al pieno secolo IX,
localizzandone invece il persistere e poi il proliferare nelle isole britanniche e in
Gallia. Un fenomeno che per gli scritti gregoriani trova validi riscontri negli
studi di Bruno Judic sulla diffusione della Regula Pastoralis e del Registrum,
dalla morte di Gregorio fino alla fine del secolo VIII. Ugualmente da segnalare
è la rilettura proposta da Yitzhak Hen del progetto pipinide-carolingio di
riforma della liturgia franca in senso romano-gregoriano che Hen ritiene, a mio
parere con qualche forzatura, di carattere esclusivamente propagandistico.
Considerate in una prospettiva di aggiornamento storiografico queste
ricerche hanno avuto il pregio di affrontare il problema della trasmissione della
tradizione gregoriana prescindendo da teleologismi interpretativi e mettendone
piuttosto in luce il carattere discontinuo. La ricerca qui presentata vuole
arricchire lo spettro delle problematiche ora ricordate. Nelle pagine che seguono
prenderò in esame una silloge tratta dal Registrum epistolarum di Gregorio
Magno di cui analizzerò anzitutto genesi e struttura (parr. II-III). Ne considererò
successivamente il significato nell’ambito del processo « d’émulation autour de * L’articolo, comprensivo di note, sarà pubblicato nel numero cinquantasei (2015) di Studi Medievali. Desidero ringraziare la Redazione di Studi Medievali per il consenso ad anticiparne la lettura su www.academia.edu.
l’oeuvre de Grégoire » che coinvolse il papato e i Carolingi alla fine del secolo
VIII, in particolare nella disputa intorno alla funzione delle immagini sacre
(parr. IV-VII).
II.
Con l’eccezione delle sei epistole inserite da Beda nell’Historia
Ecclesiastica Gentis Anglorum la Collectio Pauli è la più antica silloge tratta dal
Registrum che ci sia pervenuta. La Collectio costituisce la prima unità
codicologica del miscellaneo SANKT-PETERBURG, Publicnaja Bibliotheka im.
M. E. Saltykova Shchedrina, F. v. I. 7. Riporta cinquantaquattro epistole ‒ di cui
una in versione interpolata, l’Ep. 148 [147] e una copiata due volte ‒ ed è così
denominata in ragione del suo compilatore, Paolo Diacono. Per
l’identificazione dell’autore ci si è basati sulla lettera di dedica della silloge, che
contiene suggestioni ricorrenti nelle opere del dotto longobardo. La lettera ci
consente inoltre di conoscere il committente della Collectio, il potente abate di
Corbie e consigliere di Carlo Magno Adalardo, e di ricavare informazioni sulle
vicissitudini e sui criteri che ne hanno accompagnato la stesura e la correzione.
In apertura il Diacono si rammarica di non aver potuto incontrare Adalardo
l’estate precedente, durante un viaggio compiuto nella regione in cui l’amico
risiede. Spiega inoltre che la scarsità di risorse e a una malattia protrattasi da
settembre fino a Natale, gli hanno impedito di procedere nel compito
affidatogli. Ora tuttavia la raccolta è pronta ma nell’inviarla Paolo chiede ad
Adalardo di adottare alcune cautele. Egli ha potuto rileggere ed emendare solo
trentaquattro lettere, in alcune delle quali sono ancora presenti delle lacune
segnalate con una notazione a margine. Sarà dunque compito dell’abate di
Corbie integrarle ed emendare le lettere restanti. Infine Paolo invita l’amico a
vigilare affinché la Collectio non sia diffusa senza controllo.
Questi riferimenti, le caratteristiche grafiche del manoscritto, gli interventi
di correzione e la strutturazione del materiale epistolare hanno originato diverse
ipotesi su dove, quando e in quali circostanze sia avvenuta la stesura del SANKT-
PETERBURG, Publicnaja Bibliotheka im. M. E. Saltykova Shchedrina, F. v. I. 7.
Gli studiosi che hanno dato maggior peso ai contenuti della lettera di dedica
hanno proposto come localizzazione o un’istituzione religiosa transalpina, con
datazione agli anni del soggiorno del Diacono presso la corte di Carlo Magno
(782-786/7), oppure Montecassino nei primi anni settanta del secolo VIII.
Coloro che hanno privilegiato i criteri paleografico-codicologici tendono invece
a situare in Friuli, o comunque nel nord Italia, il luogo di compilazione della
Collectio e a datarne la composizione intorno al 787 e comunque non più tardi
della fine del secolo VIII. Un sostanziale accordo riguarda invece la
responsabilità di Paolo Diacono nella scelta del materiale tratto dal Registrum e
il riconoscimento della sua come una delle due mani che intervengono a
correggere il manoscritto.
Alla luce di un lungo e minuzioso lavoro preparatorio, nella sua
introduzione all’edizione critica del Registrum per il C. C. S. L., Dag Norberg
ha proposto una terza e più radicale ricostruzione, affermando che la Collectio
nacque dalla fusione di tre raccolte diverse, P1 (Epp. nn. 1-37 della raccolta),
P2 (Epp. nn. 38-51) e Appendix (Epp. nn. 52-54), di cui solo la prima è
attribuibile a Paolo Diacono. Non mi risulta che la tesi di Norberg sia stata
sottoposta a un’accurata disamina nonostante sia stata accolta anche dai
successivi editori del Registrum. Prima di procedere in questo senso è tuttavia
opportuno stabilire alcuni punti fermi rispetto alle ricostruzioni fin qui
considerate.
Anzitutto possiamo scartare una localizzazione transalpina e l’arco
temporale che ne consegue. A ingannare gli studiosi è stato l’accenno nella
lettera ad Adalardo al viaggio compiuto da Paolo illis in partibus vale a dire, si
è pensato, verso Corbie. Va tuttavia ricordato che Adalardo, nel decennio 781-
790, periodo che travalica l’arco di anni trascorso da Paolo nel regno franco
(782-786/7), visse nel regno italico in veste di tutore del giovane re Pipino. Un
incontro fra i due aveva quindi più probabilità di avvenire dopo il ritorno di
Paolo in Italia (786/7) piuttosto che prima di tale data. Ed è ugualmente molto
più plausibile che la meta del viaggio di Paolo fosse l’Italia nord-orientale, forse
davvero il Friuli, con un itinerario che lo avrebbe portato vicino alle sedes
regiae di Pavia e Verona, dove Adalardo prevalentemente risiedeva. Se
accettiamo questa ipotesi, inoltre, è possibile far collimare le risultanze
paleografiche e temporali generalmente più accreditate e le notizie contenute
nell’epistola di dedica. La presenza del Diacono in un ente religioso dell’Italia
del nord al momento della stesura e della revisione della Collectio spiegherebbe
infatti le caratteristiche grafiche del manoscritto, l’altezza cronologica della sua
compilazione ma altresì la difficoltà di Paolo, in quanto ospite, nel reperire
risorse per procedere più speditamente nel lavoro.
Per quanto riguarda Montecassino e gli anni settanta del secolo VIII
questa ipotesi si fonda sulla congettura che nel periodo in cui vi si era ritirato
Adalardo possa aver conosciuto Paolo. Per contro occorre osservare che nel
manoscritto della silloge non sono rilevabili caratteristiche grafiche che possano
rimandare allo scriptorium del monastero. È infine alquanto singolare che a
fronte di un presunto interesse pregresso verso Gregorio e i suoi scritti, non vi
siano accenni o eco di questi nella produzione del Diacono anteriore al ritorno
in Italia e che invece egli dia rilievo alla figura del papa, citando tra l’altro le
sue epistole, nelle sue ultime opere: la Vita sancti Gregorii Magni (B. H. L.
3639) e l’Historia Langobardorum.
Da questa prima discussione risulta dunque ribadita la collocazione nel
nord Italia dello scriptorium in cui fu compilata la silloge e ulteriormente
circoscritto l’arco temporale: fra il 786/7, ritorno di Paolo in Italia, e il 790,
anno in cui Adalardo ritornò a Corbie portando con sé la silloge, come dimostra
la nota di possesso del manoscritto.
Veniamo alla ricostruzione proposta da Norberg. La tesi del filologo
svedese si fonda sulle seguenti discrepanze fra il primo gruppo di lettere (P1) e
gli altri due (P2 e Appendix): che in ventinove epistole di P1 la datazione è
posta in calce; che la maggior parte delle epistole in P1 sono riportate in ordine
cronologico; che quasi tutte le lettere di P2 presentano, dopo il titulus, un breve
regesto del contenuto; che in tre casi in P2 il destinatario è indicato con
l’accusativo; che, sempre in P2, alcuni tituli presentano una formulazione
diversa da quelli di P1. Secondo Norberg dunque a Paolo deve essere attribuito
solo il primo gruppo di lettere, che mostra un più alto indice di coerenza
formale e strutturale.
Ora, mentre le epistole contenute in P1 sono tratte dai libri V e XI del
Registrum, quelle contenute in P2 provengono tutte dal libro II. Non si può
quindi stabilire con certezza se la presenza dei regesti, l’uso dell’accusativo e la
formulazione dei tituli siano da attribuirsi al presunto compilatore di P2 oppure
a iniziative del/dei redattore/i del libro II del Registrum a cui Paolo si è
semplicemente adeguato nella sua trascrizione. Anche le due argomentazioni
più forti di Norberg presentano alcuni limiti. La datazione in calce alle epistole
dovrebbe essere assunta come criterio dirimente se rilevabile esclusivamente in
P1, ma così non è. Essa è in effetti presente, seppure con incidenza minore,
anche in P2 e ciò implicherebbe l’adozione di una medesima prassi da parte di
due compilatori diversi che avrebbero operato in tempi e circostanze diversi. Si
consideri inoltre che la somma di tali occorrenze, trentatré, è vicinissima al
numero di epistole che Paolo dichiara di aver riletto ed emendato, trentaquattro.
Si può allora pensare che proprio l’inserimento della datazione in calce facesse
parte delle correzioni apportate durante la revisione della Collectio.
Altre osservazioni riguardano l’ordinamento cronologico. In P1
quest’ultimo è rispettato nelle prime ventisei lettere, viene però meno nelle
successive tre per poi essere nuovamente ripristinato e infine ancora disatteso.
Ma un andamento non dissimile è constatabile anche in P2. Diversamente da
Norberg possiamo ritenere che proprio il carattere discontinuo di queste
sequenze, quando vengano messe a confronto con i contenuti e i destinatari
delle relative epistole, ci indichi quale fu il criterio-guida adottato da Paolo
Diacono nella sua trascrizione. E cioè che mentre consultava il Registrum egli
abbia proceduto a selezionare le missive per argomento e destinatario, seguendo
le indicazioni di Adalardo, e mantenendo inalterata la cronologia laddove
gruppi di lettere coerenti rispetto a tali parametri lo fossero anche per datazione.
Consideriamo ad esempio le prime sedici lettere della Collectio (tutte del 594-
595) indirizzate, tranne una, a personaggi appartenenti alle élites bizantine. Qui
la successione cronologica viene per così dire ‘a traino’ di quello che è il filo
conduttore delle missive: le relazioni tutt’altro che serene di Gregorio con
l’imperatore, i vescovi orientali e gli ufficiali bizantini. Analogamente si può
dire per le epistole nn. 17-19 (del 795), nn. 22-26 e nn. 30-34 (del giugno 601) –
che documentano i rapporti di collaborazione fra il papa, l’episcopato e i
prìncipi franchi –; delle epistole nn. 43-46, (del 591-592) in cui, a fronte della
latitanza imperiale, Gregorio assume il controllo delle milizie bizantine; e delle
epistole nn. 47-51 (del 592) che riguardano l’attività amministrativa e
giurisdizionale svolta sui patrimonia e sulle diocesi poi confiscate alla chiesa di
Roma dall’imperatore Leone III nel 732. Analizzato in questa prospettiva
l’intero corpus della Collectio Pauli si rivela estremamente coerente, poiché la
ripartizione per macro-tematiche ora rilevata corrisponde a quella dei libri del
Registrum consultati da Paolo. Dal libro V egli ha tratto le missive di argomento
‘bizantino’, dall’XI quelle di argomento ‘franco’, dal II quelle relative alle
incombenze amministrative, militari e giurisdizionali, a cui ha infine aggiunto,
attingendo a una fonte diversa, le Epp. IX, 148 interpolata e XI, 10 in cui
Gregorio discute sulla funzione delle immagini sacre.
Altri due argomenti a favore di questa ricostruzione sono ricavabili
dall’epistola ad Adalardo. Nel manoscritto della Collectio il signum vitii, la cui
presenza indica trattarsi di epistole sicuramente rilette ed emendate da Paolo, è
rilevabile a margine delle Epp. V, 30, 36, 38, 39, 40, 42, 49, 63 e XI, 36 e 52.
Dunque, nella sua pur incompleta revisione, egli ha ancora una volta adottato un
criterio tematico, concentrandosi in prevalenza sulle missive relative ai rapporti
fra Gregorio e le élites bizantine. Consideriamo infine la raccomandazione a
vigilare sulla diffusione della silloge. Non credo possa trattarsi di un ulteriore
scrupolo filologico, poiché Paolo distingue chiaramente i loca in quibus minus
habetur, ossia i passaggi lacunosi, da altri (aliqua) di cui è meglio che i minus
idonei non vengano a conoscenza. Ma nella Collectio è proprio fra le missive
contenute in P2 e Appendix che troviamo affermazioni o passaggi in grado di
destare qualche perplessità. Ad esempio l’Ep. II, 28 [33], in cui Gregorio ordina
ai magistri militum Maurizio e Vitaliano di prendere ostaggi e saccheggiare i
territori intorno a Narni come rappresaglia contro i Longobardi, e l’Ep. II, 50
[33], dove suggerisce ai conduttori dei patrimonia di Sicilia di corrompere gli
ufficiali addetti alla leva. Altri fraintendimenti potevano infine essere generati
dalla versione interpolata dell’Ep. IX, 148, la cui natura e i cui contenuti
meritano un esame approfondito.
III.
Il destinatario è il monaco longobardo Secondino. La lettera originale
inizia con un breve speculum sulla vita monastica in cui Gregorio si sofferma
sulle tentazioni della carne, a cui lo stesso Secondino si dice sottoposto, seguito
da una discussione sulle cause dello scisma tricapitolino e sul destino
ultraterreno dei bambini morti prima di ricevere il battesimo.
Nell’interpolazione quest’ultimo passo è soppresso e sono sviluppati altri due
argomenti.
Il primo concerne il reintegro nell’ordinamento ecclesiastico dei sacerdoti
lapsi, prassi verso la quale Gregorio viene presentato come favorevole, a patto
che abbiano sostenuto un’adeguata penitenza. Nello sviluppare le sue
argomentazioni l’interpolatore si ispira con buona probabilità a motivi
autenticamente gregoriani. Se a un primo sguardo la condiscendenza attribuita a
Gregorio poteva risultare incompatibile con la severa censura che di norma egli
applicava agli ecclesiastici indegni è vero che in altre circostanze, in particolare
nei confronti di monaci e abati, egli tendeva a mostrarsi più conciliante. Così ad
esempio nell’Ep. V, 4 Gregorio acconsentiva a reintegrare Giorgio, presbitero e
abate di San Teodoro, « in monasterio locoque suo » poiché « longa hic est apud
nos paenitentia afflictus ». In questa prospettiva la posizione attribuita a
Gregorio dall’interpolatore poteva essere fatta passare come autentica in quanto
risultante dell’estensione, anche al clero, di prassi già adottate per le istituzioni
monastiche.
La seconda parte dell’interpolazione riguarda le immagini sacre e presenta
Gregorio come un fervente iconodulo. Egli loda la devozione di Secondino
verso le immagini e la fomenta inviandogli due icone con i ritratti di Cristo e
della Vergine e di san Pietro e san Paolo. Sottolinea come attraverso la memoria
le immagini sappiano incentivare la tensione verso Cristo e ne giustifica
l’adorazione ‒ altro punto che poteva suscitare perplessità, dal momento che
nell’epistola successiva della Collectio (XI, 10) tale pratica era vietata.
Nell’interpolazione, per contro, l’adorazione delle immagini era giustificata in
ragione del suo carattere transitivo, dalla rappresentazione al prototipo: « nos
quidem non quasi ante divinitatem ante ipsam (l’immagine) prosternimur, sed
illum adoramus quem per imaginem aut natum aut passum vel in throno
sedentem recordamur ».
Anche in questa sezione è individuabile un riferimento a un originale di
Gregorio. L’espressione « ipsa pictura quasi scriptura » rimanda chiaramente
alla dottrina sviluppata per correggere gli eccessi iconoclasti di Sereno di
Marsiglia (Ep. XI, 10), che indicava nelle immagini il corrispettivo cognitivo
per gli illetterati di ciò che la scrittura rappresentava per i dotti. Se poi la
consideriamo in una prospettiva più articolata è lecito affermare che questa
parte dell’interpolazione sia stata volutamente costruita come complemento
dell’ epistola a Sereno di Marsiglia, per dimostrare che in favore del culto delle
immagini già Gregorio Magno si era espresso con argomentazioni simili a
quelle sostenute dal papato durante la prima disputa iconoclasta.
Nell’interpolazione, lo status socio-culturale e le relazioni intrattenute dai
due interlocutori consentivano di ‘nobilitare’ la funzione delle immagini. Di
dimostrare che, diversamente da quanto affermato nella lettera a Sereno, esse
non erano solo destinate a irrobustire la fede di idioti, ignorantes, imperiti e
nescientes ma potevano essere oggetto della devozione di un monaco zelante e
di un papa e doctor ecclesiae. Considerazioni analoghe valgono per le
argomentazioni in favore delle immagini. Nell’epistola a Sereno la funzione
memorativa delle immagini era sottesa piuttosto che enunciata e si accennava
solo brevemente alla loro capacità di sollecitare la compunctio. E ciò poiché a
Gregorio interessava dimostrare che la presenza nelle chiese di immagini e cicli
narrativi era parte integrante di un percorso pedagogico-didattico ‘guidato’, con
lo scopo di rappresentare avvenimenti e personaggi sul cui significato i fedeli
illetterati erano già stati edotti attraverso la pastorale e la liturgia. La
connessione immagine-memoria (recordatio, recordari, ad memoriam
reducere), per contro, costituisce il nerbo dell’interpolazione, in quanto da essa
procedono sia la capacità delle immagini di infiammare (inardescere,
recalescere) nel fedele l’amore per Cristo sia, dal momento che tale
connessione è agganciata unicamente alla figura di quest’ultimo, di giustificare
la forma di ossequio a esse tributato (adorare).
Ne risulta, come per la questione dei sacerdoti lapsi, una rielaborazione
che se da un lato era costruita per risultare coerente con il pensiero di Gregorio,
in quanto ne riprendeva nuclei sostanziali (il rapporto scriptura-pictura) e ne
amplificava altri (la memoria e la compunctio), dall’altro se ne discostava su
alcuni punti importanti. Gregorio collocava l’esperienza cognitiva indotta dalle
immagini in un contesto pubblico, la chiesa, e la subordinava all’acquisizione
da parte degli indocti di preconoscenze che erano state impartite loro dal clero.
Nell’interpolazione tale mediazione veniva invece a mancare per indicare
piuttosto, in linea con quanto affermato dagli iconoduli nel secolo VIII, la liceità
di un culto privato e di un rapporto personale fra icona e fedele. Un altro scarto
sostanziale riguardava la possibilità di adorare le immagini.
Questa affermazione, più che come effetto di una scelta consapevole
dell’interpolatore, risale alla tendenza a distinguere sempre meno, nella prassi
come nel lessico, la devozione che poteva essere tributata solo alla divinità
(adoratio/adorare) da quella che si poteva rendere alle immagini
(veneratio/venerari). Per quanto concerne il lessico possiamo constatare che
nell’Occidente latino tale fenomeno è innescato da due attitudini strettamente
concomitanti. La prima è legata alla dottrina del transitus dell’omaggio,
inizialmente ammessa solo nei confronti di Cristo e progressivamente estesa ad
altre entità celesti. Una dottrina tra l’altro spesso giustificata associando le
immagini a oggetti effettivamente passibili di adorazione, quali la croce e le
reliquie. La seconda riguarda invece la traduzione in latino dei testi in lingua
greca che costituivano il nucleo più rilevante delle auctoritates citate in favore
del culto delle immagini. Nelle versioni in latino di questi testi, almeno già a
partire dal concilio romano del 731, la prassi era di tradurre con adorare verbi
di significato diverso e senza distinguere a quale tipo di ossequio essi si
riferissero. Entrambe queste componenti sono presenti nella lettera interpolata a
Secondino in cui l’oggetto dell’adorazione è Cristo, i doni inviati da Gregorio
comprendono, oltre alle due icone, una croce e una reliquia di san Pietro, e la
giustificazione dell’adorazione delle immagini appare ricalcata su un’auctoritas
greca citata in traduzione negli atti dei concili romani del 731 e del 769: la
Quaestio XXXIX dello Pseudo Atanasio.
Cerchiamo infine di stabilire dove e quando fu redatta l’interpolazione.
Come terminus ante quem è sempre stata accettata una dichiarazione di papa
Adriano I secondo la quale la lettera fu esibita dal vescovo Erulfo di Langres
durante il concilio del 769. Come vedremo anche più avanti questa
affermazione, che suggeriva una localizzazione geografica oltre che temporale
dell’interpolazione, solleva alcuni dubbi. Va infatti notato che a proposito della
convocazione dei vescovi franchi al concilio del 769 il Liber Pontificalis,
particolarmente dettagliato a riguardo, riporta che Stefano III « direxit Franciae
partes ad excellentissimos viros Pipinum, Carulum et Carulomannum (…)
Sergium antedictum, secundicerium (…) deprecans atque adhortans (…) ut
aliquantos episcopos gnaros et in omnibus divinis scripturis atque sanctorum
canonum institutionibus eruditos ac peritissimos dirigerent ad faciendum in
hanc Romanam urbem concilium pro eadem impia novi erroris ac temeritatis
praesumptione, quam antefatus Constantinus apostolicae sedis pervasor ausus
est perpetrare ». Nessun accenno dunque alla possibiltà che nel concilio si
intendesse deliberare anche sul culto delle immagini: considerazione
comprovata dal fatto che se ne discusse solo in coda alla terza sessione,
limitandosi a ratificare le risoluzioni del 731. Il che induce a chiedersi quale
ragione potesse avere Erulfo di Langres di portare con sé la lettera interpolata.
Di maggior aiuto può essere invece una ricostruzione dei riferimenti
testuali a cui l’interpolatore si ispira. Si è già detto sopra della lettera di
Gregorio a Sereno di Marsiglia e della Quaestio XXXIX dello Pseudo Atanasio,
entrambe presenti nei florilegia di parte iconodula e citate, unitamente
all’assimilazione fra immagine, croce e reliquie, nei concili del 731 e 769. Lo
stesso vale sia per la locuzione « ab re non facimus si per visibilia invisibilia
demonstramus », che rimanda a due passi di Dionigi l’Areopagita circa la
possibilità di rappresentare con la pittura le cose celesti, sia per l’affermazione
che e, attraverso la memoria, le immagini erano in grado di suscitare la
compunctio. L’interpolatore conosce infine un altro testo presente nei florilegia:
gli Actus Silvestri. Ciò è dimostrabile a partire dalla singolare espressione,
surtaria, usata nell’interpolazione per definire le icone che Gregorio invia a
Secondino. Stando a Du Cange surtaria è una corruzione della parola scutaria,
usata per indicare immagini a mezzo busto, raffigurate su un supporto rotendo,
dette anche thoracida/thoracicla. Grazie alle ricerche di Wilhelm Levison e
Horst Fuhrmann sappiamo che nella versione B degli Actus proprio con
thoracicla erano indicati i ritratti di san Pietro e san Paolo che papa Silvestro
mostra all’imperatore Costantino affinché vi riconosca i due apostoli che gli
erano apparsi in sogno. Ma possiamo anche andare oltre la semplice sinonimia.
L’unica altra fonte indipendente dalla lettera interpolata in cui sia presente la
parola surtaria è il falso noto come Revelatio Stephani, composto intorno
all’830 dall’abate di Saint-Denis Ilduino. Nella Revelatio papa Stefano II
racconta che mentre si trovava nel regno franco era caduto malato. I medici
ormai disperavano di salvarlo quando, prostrato in orazione nella chiesa di
Saint-Denis, gli erano apparse tre figure: « et vidi ante altare (…) Petrum et (…)
Paulum, et nota mente illos recognovi de illorum surcariis et ter beatum
domnum Dyonisium », dietro intercessione del quale a Stefano è promessa la
guarigione. Il passo ricalca senza dubbio la prima parte degli Actus Silvestri
nella versione B2, con cui ha in comune il verbo recognoscere e la procedura di
identificazione delle apparizioni. Stante la loro indipendenza, l’uso della parola
surtaria nell’Ep. IX, 148 interpolata e nella Revelatio si può spiegare a partire
dall’esistenza di una fonte comune, gli Actus Silvestri nella versione B2, in cui
surtaria era usato come variante di thoracicla. Da notare infine che
nell’interpolazione viene introdotta la figura del diacono Dulcidio al quale,
sempre sulla falsariga degli Actus, è affidato il compito di trasmettere le icone.
Gli elementi fin qui raccolti ci permettono dunque di formulare un’ipotesi
sulla stesura dell’interpolazione diversa da quella tradizionalmente accettata.
Che Erulfo di Langres, o comunque un franco, fosse in grado di produrre un
testo così aderente alle posizioni del papato lo si può escludere, poiché prima
del 769 il clero franco risulta poco informato sulle linee guida papali in materia
di culto delle immagini e poiché per tutto il secolo VIII i florilegia su cui tali
linee si fondavano non ebbero alcuna circolazione al di fuori di Roma. Più
verosimilmente l’interpolatore era un membro dell’équipe incaricata di
raccogliere, o come in questo caso di creare ex novo, la documentazione con cui
il papato intendeva dimostrare la liceità del culto delle immagini. Più difficile è
stabilire una datazione precisa per la redazione. Gli elementi fin qui raccolti
imporrebbero di considerare il 731 come terminus post quem e come terminus
ante quem l’arco di anni in cui si colloca la compilazione della Collectio Pauli.
D’altra parte se l’affermazione sopra ricordata di papa Adriano risulta
pretestuosa riguardo l’origine dell’interpolazione, potrebbe invece non esserlo
del tutto per quanto concerne la datazione. È possibile che la lettera sia stata
effettivamente preparata nelle immediate vicinanze del concilio del 769 e poi
inserita nel florilegium, ampliato in due occasioni (770 e 774/775), su cui
Adriano basò le argomentazioni contenute nella sinodica inviata in occasione
del secondo concilio di Nicea (785) e nell’Hadrianum, lo scritto in cui ribadiva
la correttezza dogmatica di Nicea II contro le critiche dei teologi franchi. Da
questo florilegium, e non dal Registrum, infine Paolo Diacono trascrisse le due
lettere di Gregorio concernenti il culto delle immagini, il che spiega la presenza
nella Collectio dell’Ep. IX, 148 interpolata in luogo della versione originale.
IV.
All’origine della Collectio Pauli sono dunque rilevabili due forme di
manipolazione: una consapevole, la selezione per temi operata da Paolo
Diacono, e una inconsapevole, l’inserimento dell’Ep. IX, 148 nella forma
interpolata. Le implicazioni di quest’ultima risulteranno chiare più avanti,
quelle relative alla prima le ho esaminate in un’altra sede. Ne riprendo qui
l’argomentazione centrale integrandola con alcuni aggiornamenti.
La compilazione della Collectio dimostra la volontà dei Carolingi di
sfruttare la tradizione gregoriana anche per fini politici puntuali. I nuclei che la
strutturano infatti replicano e giustificano, proiettandolo nel passato, il
complesso di impegni assunti nei confronti del papato: difesa da Longobardi e
Bizantini; esistenza, per contro, di un legame preferenziale fra i vertici delle
istituzioni franche e il vicario di san Pietro; sostegno fornito alle rivendicazioni
papali sui patrimonia e le giurisdizioni sottratte da Leone III. Assunti di tanto
più urgente irrobustimento se consideriamo che la committenza della Collectio
avviene in concomitanza con la terza discesa di Carlo Magno in Italia, volta a
intervenire contro Arechi di Benevento e i suoi alleati bizantini e quindi
potenzialmente capace di modificare gli assetti geo-politici della penisola.
Elaborata come strumento per sostanziare le rivendicazioni nei confronti di
determinati avversari, la Collectio Pauli ci indica altresì in quale direzione si
stessero evolvendo i rapporti fra gli alleati.
Secondo Judic questa « émergence carolingienne de l’épistolaire gregorien
», di cui la Collectio Pauli costituisce un momento genetico, trova la sua
collocazione naturale fra altri due testi-chiave per gli sviluppi politico-culturali
della prima età carolingia. La Dionysio-Hadriana, raccolta di canoni fatta
compilare da Adriano I per Carlo Magno e il Codex Carolinus, che riporta le
missive inviate dal papato ai Pipinidi-Carolingi e le cui prime lettere esprimono
« une association qui évoque furieusement la correspondance de Grégoire le
Grand ». A ben vedere, tuttavia, solo in apparenza la compilazione di questi tre
testi rispecchia un’effettiva continuità nei rapporti franco-papali. Mentre infatti
l’acquisizione della Dionysio-Hadriana rientra ancora nell’ambito di un
paradigma in cui è il papa, a cui è stata affidata la custodia della tradizione
cristiana, a trasmettere i testi che ne sono fondamento, la Collectio Pauli è
invece frutto di un accesso diretto ai documenti su cui quella tradizione si
fondava. Sempre nel contesto della spedizione del 787 sono rilevabili due
iniziative analoghe: la riforma dell’omiliario in senso gregoriano e la richiesta
di una copia della Regula Benedicti da parte di Carlo Magno che, dopo aver
messo in fuga Arechi, aveva posto sotto il suo controllo Montecassino. Se la
compilazione della Collectio Pauli aveva in prima istanza uno scopo
strumentale, all’insieme di queste iniziative possiamo attribuire un significato
simbolico e progettuale. Simbolico poiché al riconoscimento del papato e del
monachesimo benedettino come istituzioni-cardine della cristianità si
accompagnava la facoltà di Carlo Magno, loro protettore in quanto capo militare
vittorioso, di attingere a quelle tradizioni, che erano pur sempre ‘ricchezze’,
senza alcuna mediazione. Progettuale in quanto comportava lo spostamento e il
successivo sfruttamento di tali ricchezze al di là delle Alpi, nel quadro della
riforma ecclesiastico-culturale intrapresa dai Pipinidi-Carolingi. Questo
orientamento, che mirava a ribadire quali fossero i rapporti di forza che in quel
tempo innervavano l’alleanza franco-papale, implica due importanti corollari.
Il primo concerne il rapporto tra chi elabora la propaganda e chi ne è
l’oggetto. Nelle lettere di Gregorio Magno e in quelle dei suoi successori
l’oggetto della propaganda papale sono i Franchi, di cui si vuole ottenere l’aiuto
e la collaborazione. Nella Collectio Pauli e nel Codex Carolinus, costruiti a
partire dallo stesso materiale, questo rapporto viene invece invertito, al punto
che nessuna delle due raccolte dovrebbe essere considerata come una fonte
‘romana’ ma come strumento della propaganda politica, culturale e militare
franca avente per oggetto il papato.
Il secondo riguarda il ruolo del papa come caput ecclesiae e i presupposti
che giustificavano tale concezione. Fin dai tempi dell’attività missionaria di
Wynfrith/Bonifacio (716-754), periodo a cui risale il consolidamento delle
relazioni fra Pipinidi-Carolingi e papato, il riconoscimento del primato del
vicario di san Pietro si era fondato su un processo che Klaus Schatz ha definito
di progressiva ‘sacralizzazione’ della tradizione romano-cristiana di cui al papa
era stata affidata la custodia. Secondo Schatz tale concezione derivava da una
archaische Religionsverständnis peculiare delle popolazioni barbare
convertitesi al cristianesimo, in cui era la perfetta adesione formale ai riti e alla
liturgia a determinarne l’efficacia. Da qui la necessità di trovare un garante
ultimo delle norme di fede. Benché io ritenga che questa concezione abbia ben
poco di arcaico, essendo variamente declinata da tutte le istituzioni
altomedievali, papato compreso, concordo pienamente con Schatz quando ne
esamina le conseguenze ultime. E cioè che per i Franchi il primato del papa era
di carattere consultivo rispetto a un complesso di testi, norme e dogmi, ma non
implicava alcun riconoscimento al vicario di san Pietro di interpretare quella
tradizione o intervenire nel governo della chiesa in veste di autorità suprema.
In questo gioco di ruoli, il cui protocollo era stato fissato quando tra i
Franchi e Roma esisteva ancora l’‘intercapedine’ rappresentata dal regno
longobardo, le iniziative intraprese da Carlo Magno intorno al 787 immettono
una regola nuova ma fondata su un presupposto collaudato. Il radicalismo della
tradizione che i Franchi avevano posto a giustificazione della funzione svolta
dal papato apriva la strada alla possibilità di derogare alla mediazione svolta da
quest’ultimo, stante la possibilità di accedere direttamente alla documentazione
originale. Il ricorso agli scritti di Gregorio Magno, che erano insieme tradizione
romana e ortodossia cristiana, è un indicatore importante di questo mutamento
di equilibri. In particolare l’introduzione nella Collectio Pauli della lettera a
Sereno di Marsiglia e dell’Ep. IX, 148 interpolata dimostra la volontà dei
Carolingi di dotarsi degli strumenti con cui intervenire in prima persona nella
disputa sulle immagini a fianco del papa, se non in sostituzione o persino in
opposizione a esso. « Quod contra beati Gregorii instituta sit imagines adorare
seu frangere, et quia vetus et novum testamentum et poene omnes precipui
doctores ecclesiae consentiunt beato Gregorio in non adorandis imaginibus »,
questo il principio programmatico enunciato nel capitolo L del Capitulare
Adversus Synodum, un elenco di ottantacinque contestazioni alle deliberazioni
di Nicea II, inviato ad Adriano I intorno al 790 e poi sviluppato nell’Opus
Caroli Regis Contra Synodum (Libri Carolini).
V.
Nel rifiuto da parte dei Carolingi di riconoscere la validità di Nicea II si
accavallano ragioni e implicazioni molteplici. Rispetto al nostro ambito di
indagine le più importanti sono: che tipo di funzione fosse attribuita alle
immagini e in quali termini vada intesa la ricusazione di Nicea II nell’ambito
delle relazioni franco-papali.
La tesi dei teologi franchi era che la presenza delle immagini nelle chiese
avesse esclusivamente un fine esornativo. In quanto create dalla mano
dell’uomo, nella gerarchia degli oggetti del culto cristiano esse non potevano
che collocarsi all’ultimo posto, poiché non possedevano né la funzione salvifica
delle Sacre Scritture, né la potenza simbolico-spirituale della croce e delle
particole eucaristiche, né la materialità sacrale delle reliquie. Le immagini non
erano dunque in grado di aprire alcun canale fra mondo celeste e mondo terreno
né di ingenerare un processo di elevazione spirituale nello spettatore. Né era
pensabile, in ragione del loro carattere fittizio, che a esse si potesse tributare una
qualche forma di devozione. Non solo. Carol Heitz ha rilevato l’esistenza di una
‘eclissi’ nella rappresentazione di Cristo nelle miniature a partire dal 780,
dunque prima dell’accendersi della disputa con il papato, che si protrae fino
all’810. E sempre per i decenni a cavallo fra i secoli VIII e IX Matthias Exner
ha dimostrato il persistere di un disinteresse per la pittura murale, in particolare
per i cicli figurativi, disinteresse che viene meno solo a partire dal secondo
quarto del secolo IX. Questi orientamenti nei confronti dell’iconografia sacra, a
cui non erano estranee preoccupazioni di natura pastorale, dimostrano che con il
Capitulare Adversus Synodum e l’Opus Caroli si volle codificare anche sul
piano teorico un atteggiamento variamente diffuso nella prassi.
Per quanto attiene i rapporti con il papato si è cercato di dimostrare che
all’origine del Capitulare e dell’Opus Caroli vi fu un fraintendimento e che
comunque in nessun caso, con quegli scritti, Carlo Magno intendesse minare
l’autorità del vescovo di Roma. Si tratta di un’argomentazione che tuttavia si
scontra con una premessa ineludibile, e cioè che negare la validità di Nicea II
implicava di per sé contestare il papa. Che poi per garantire un minimo spiraglio
di mediazione si sia evitato di attaccare la persona di Adriano è vero, ma ciò
non toglie che i contenuti della sinodica del 785 furono sottoposti ad aspra
critica, che nel Capitulare il re e il clero franco abbiano assunto una posizione
chiaramente autonoma rispetto al papa e alla chiesa di Roma e che Adriano
fosse ben consapevole di essere l’oggetto delle obiezioni in esso contenute.
Tanto più che ancora nell’825 i religiosi che su ordine di Ludovico il Pio
stilarono un libellus sulle immagini nel quadro della seconda disputa iconoclasta
non esitarono ad attribuire ad Adriano le deviazioni dottrinali di Nicea II e a
condannarne la pervicace difesa contro le obiezioni sollevate da Carlo Magno.
Nel Capitulare Adversus Synodum l’adozione della lettera di Gregorio a
Sereno di Marsiglia come unico referente in grado di esprimere l’ortodossia in
materia di immagini – i teologi franchi non citano, verosimilmente perché
ancora non ne conoscono i contenuti, l’Ep. IX, 148 interpolata – avviene in
linea con l’esplicitarsi degli orientamenti fin qui descritti. Sul piano dottrinale,
aderendo in toto al principio secondo il quale le immagini non dovevano né
essere distrutte né adorate, la chiesa franca dichiarava la propria autonomia
nello scegliere la via regia, la strada maestra da percorre per non cadere negli
eccessi iconoclasti e iconoduli verificatisi in Oriente. Nei confronti di Adriano
essa si poneva come sorta di compromesso, in quanto riconoscimento esplicito
della superiorità della tradizione romano-papale, ma altresì come potenziale
deterrente, in quanto l’eventuale ricusazione delle posizioni franche avrebbe
implicato anche quella dell’autorità di Gregorio.
VI.
Questa dunque la prospettiva franca. Per quanto concerne quella di
Adriano I va anzitutto ricordato che intorno alle immagini si erano andati
sviluppando due discorsi convergenti. Uno più circostanziato geograficamente,
legato alla committenza iconografica come parte integrante delle iniziative con
cui il papato aveva voluto ribadire la propria centralità nella vita della città di
Roma intesa come complesso urbano e sociale. L’altro di più ampio respiro,
essendovi coinvolto l’impero, in cui istanze dottrinali e politiche finivano
necessariamente per sovrapporsi. Occorre allora fare un passo indietro e partire
dalla sinodica inviata a Costantino VI e alla madre Irene. Nell’825 si dirà che
conteneva « testimonia (…) valde absona et ad rem, de qua agebatur, minime
pertinentia », giudizio in buona sostanza confermato da alcuni studiosi
contemporanei. Le testimonianze in favore delle immagini addotte da Adriano
sono in effetti il risultato di una spigolatura di prammatica del florilegium
approntato all’inizio del suo pontificato, e fungono più che altro da cerniera
rispetto alle articolazioni principali della lettera, che contengono una serie di
rivendicazioni di carattere politico.
Nella convocazione del concilio di Nicea è indubbio che Adriano avesse
intravisto l’occasione di riaffermare la centralità della chiesa di Roma in seno
alla cristianità universale. Da qui un’azione che era stata di sganciamento dalla
tutela sempre più pervasiva esercitata da Carlo Magno, unico motivo
ragionevole, questo, del perché Adriano nemmeno lo informò della
convocazione del concilio, e di apertura a un riallineamento istituzionale e
religioso con l’impero. Lo scopo della sinodica era indicare agli imperatori i
presupposti necessari affinché ciò fosse possibile.
Nella sezione iniziale Adriano afferma che con il ripristino della
venerazione delle immagini i nomi di Costantino VI e Irene saranno associati a
quelli di Costantino I ed Elena « qui fidem hortodoxam promulgaverunt atque
sanctam catholicam et apostolicam spiritualem matrem vestram Romanam
ecclesiam exaltaverunt et cum ceteris horthodoxis imperatoribus utpote caput
omnium ecclesiarum venerati sunt ». Se la prima urgenza di Adriano è
affermare il primato della chiesa romana, l’evocazione di Costantino e della
madre costituisce anche il dispositivo attraverso il quale egli intende dimostrare
che tale primato si collega intimamente alla funzione svolta dalle immagini
negli exordia della chiesa di Roma. Questa asserzione si sviluppa a partire dalla
conversione di Costantino com’è narrata negli Actus Silvestri.
Negli Actus l’imperatore è ammalato di lebbra e i sacerdoti pagani,
incapaci di guarirlo, gli consigliano di immergersi in una vasca colma di sangue
di neonato ma egli, di fronte allo strazio delle madri, rifiuta. Quella stessa notte
gli appaiono in sogno san Pietro e san Paolo, che su mandato di Cristo lo
invitano a chiedere l’aiuto di papa Silvestro e gli ingiungono di convertirsi al
cristianesimo dopo aver ottenuto la guarigione. Costantino convoca Silvestro al
quale « percunctabatur qui isti essent dii Petrus et Paulus, qui illum visitarent
(…). Silvester respondit: “Hi quidem dii non sunt, sed idonei servi Christi et
apostoli (…)”. Cumque haec et his similia augusto diceret papa, interrogare
coepit augustus, utrumnam istos apostolos haberet aliqua imago expressos, ut ex
pictura disceret hos esse quos revelatio docuerat. Tunc sanctus Silvester misso
diacone imaginem apostolorum exhiberi praecipit. Quam imperator aspiciens
ingenti clamore coepit dicere ipsos esse quos viderat nec debere iam differe
episcopum ostensionem piscinae, quam istos promisisse suae saluti memorabat
».
In questa narrazione in cui, con numerosi tagli rispetto alla versione
originale, la conversione e il battesimo di Costantino avvengono
immediatamente dopo aver riconosciuto san Pietro e san Paolo, l’ostensione
delle immagini comporta una serie di implicazioni. Anzitutto esse sono in grado
di modificare la natura dell’esperienza vissuta da Costantino durante la notte ‒
non si è trattato di un semplice sogno ma di una vera e propria revelatio ‒ e di
quella delle due apparizioni: non dei, come da lui creduto, ma apostoli di Cristo.
Questa presa di coscienza da parte dell’imperatore è possibile poiché gli sono
mostrati i veri ritratti degli apostoli, nei quali le sembianze raffigurate
corrispondono a quelle celesti e il cui possesso dimostra che è papa Silvestro a
detenere i veri e originali fondamenti della tradizione apostolica. Nel
raggiungere tale consapevolezza Costantino compie un percorso di
apprendimento molto simile a quello descritto da Gregorio Magno. Costantino
infatti, ricordando le fisionomie che gli sono apparse, impara (discere) ciò che
la revelatio voleva in effetti insegnargli (docere), ossia che fino a quel momento
ha creduto in idola, rappresentazioni materiali di cose che non esistono. Per
contro san Pietro e san Paolo sono storicamente esistiti, lo provano i loro ritratti,
ed esistono ancora nel mondo ultraterreno, lo prova la revelatio: la religione
cristiana è quindi l’unica fede autentica. Consapevolezza questa che innesca in
lui la decisione di farsi battezzare. « Ecce » prosegue Adriano « ut praemissum
est, sanctorum figurae ab ipsis sanctis fidei nostrae rudimentis apud omnes
fuerunt christianos atque in ecclesiis (…) quatinus gentilitas paganorum (…) ab
idolorum cultura et daemonum simulacris ad verum christianitatis lumen atque
amoris dei culturam verti deberet », enunciazione a suggello della quale viene
citata l’epistola di Gregorio a Sereno di Marsiglia.
L’assioma costruito da Adriano afferma dunque l’esistenza di una
tradizione, quella delle immagini in quanto oggetto di venerazione (per
Silvestro e i cristiani) e strumento di conversione (per Costantino), posta a
fondamento della nascita della chiesa di Roma e dunque delle relazioni fra
papato e impero. Da questa tradizione gli imperatori iconoclasti si erano
discostati nonostante gli appelli dei predecessori di Adriano. Le implicazioni dei
binomi Costantino I-Costantino VI ed Elena-Irene risultano a questo punto
chiare, poiché al lustro che quell’assimilazione poteva inizialmente suggerire si
sovrappone, alla luce del brano degli Actus Silvestri, lo svelamento della
condizione di necessità in cui in entrambi i casi l’istituzione imperiale si era
trovata nei confronti del papato. Per Costantino I si era trattato di guarire dalla
lebbra e sfuggire al castigo ultraterreno, per Costantino VI e Irene di ottenere la
partecipazione di Adriano a Nicea II e la sua successiva approvazione. E ciò
implicava riconoscere che quella romana era l’unica hortodoxa fides, senza
aderire completamente alla quale il concilio non sarebbe stato riconosciuto
come ecumenico, sancendo il rientro di Bisanzio nell’alveo della cristianità
universale.
A partire da questa posizione di forza Adriano detta una serie di
condizioni a cui è subordinata la partecipazione della chiesa di Roma a Nicea II.
Ancora una volta il riconoscimento del primato petrino, la pubblica
sconfessione del concilio di Hieria, garanzie sulla salvaguardia dei legati papali
e la restituzione dei patrimonia e delle giurisdizioni usurpati dagli imperatori
iconoclasti. Quest’ultima richiesta si ricollega al tentativo di sganciamento nei
confronti di Carlo Magno. All’autonomia istituzionale rivendicata da Adriano
attraverso la partecipazione a Nicea II (a Carlo egli scriverà che il concilio si era
svolto sotto la direzione e il patrocinio del papato), si accompagnava il tentativo
di agire indipendentemente anche sul piano politico, cercando di riottenere
direttamente dall’impero ciò che l’alleato franco non era riuscito ad acquisire in
dieci anni di presenza nella penisola italiana.
È stato osservato che la partecipazione di Adriano I al dibattito sul culto
delle immagini avvenne sempre in risposta a iniziative altrui, prima degli
imperatori bizantini poi di Carlo Magno. Mentre tuttavia nella sinodica Adriano
muoveva, o pensava di muovere, da una posizione di vantaggio,
nell’Hadrianum, redatto fra il 790 e il 792 per contestare le tesi del Capitulare
Adversus Synodum, egli si trova costretto ad assumere una posizione che era al
contempo di difesa di Nicea II e del papa come caput ecclesiae e interprete della
tradizione romano-cristiana.
Per far fronte a entrambe queste esigenze Adriano ricorre ampiamente
agli scritti di Gregorio Magno. Nella difesa delle deliberazioni di Nicea II è
tuttavia constatabile la stessa limitatezza di approccio presente nella sinodica.
Nell’Hadrianum in effetti l’incapacità dei redattori di prescindere dal
florilegium su cui per decenni si era basata la difesa del culto delle immagini si
sommava a quella, non sappiamo quanto volontaria, di comprendere il senso di
molti dei capitula stabiliti dai teologi franchi. Da qui una serie di risposte che
sono spesso inconsistenti, pretestuose o addirittura eccentriche. Nel cap.
XXXVI, per esempio, alla contestazione che gli apostoli non hanno mai
promosso l’adorazione delle immagini Adriano replica che a quel tempo visse
Dionigi l’Areopagita e che costui scrisse in favore delle immagini. Nel cap.
XLIX, alla domanda su quale sia la differenza fra « imago et similitudo sibe
aequalitas », il papa controbatte affermando che si tratta di un sofisma e che « in
sancta vero (…) ecclesia humilibus datur gratia ». Il cap. LIII afferma che «
mulier in synodo docere non debet », in riferimento agli interventi di Irene nel
corso dell’ultima sessione di Nicea II. Adriano risponde con gli esempi di Elena
nella discussione fra papa Silvestro e i dodici savi ebrei contenuta negli Actus
Silvestri e della principessa Pulcheria, a cui papa Leone I inviò le sue lettere
durante il concilio di Calcedonia. Esempi non pertinenti in quanto in entrambe
le occasioni le donne si limitarono a presiedere alle riunioni senza mai prendere
la parola.
Più efficace è invece la polemica che ruota intorno al rapporto fra
immagini, tradizione gregoriana e primato papale. Qui Adriano ha buon gioco
nello sfruttare una debolezza implicita nella scelta dei teologi franchi di
assumere la lettera a Sereno di Marsiglia come unico riferimento normativo. Le
numerose citazioni di scritti gregoriani che costellano l’Hadrianum intendono
dimostrare che sull’argomento il doctor et pater si è espresso in circostanze e
forme diverse, con una complessità di cui invece non si è colpevolmente tenuto
conto. Nell’assumere una posizione dottrinale, è il messaggio di Adriano, non
basta poter accedere direttamente alla tradizione, occorre anche saperla
esaminare e interpretare.
Per quanto concerne l’adorazione delle immagini il fulcro delle
argomentazioni è ovviamente l’Ep. IX, 148 interpolata. Nel citarla per la prima
volta, come si è detto, Adriano afferma che fu portata a Roma nel 769 da Erulfo
di Langres e che era indirizzata a Secondino servus Dei inclausus Galliae. La
precisa collocazione cronologica, l’identità del latore e l’etnia “franca” di
Secondino sono espedienti con cui Adriano intende denunciare il voltafaccia
dell’episcopato franco, che pure aveva partecipato al concilio del 769 e ne aveva
sottoscritto gli atti e rimarcare l’incapacità degli autori del Capitulare Adversus
Synodum, che non erano stati in grado di vagliare a fondo nemmeno la
documentazione che li concerneva direttamente dal punto di vista etnico-
territoriale. Ma sull’autorità di Gregorio si fonda altresì la dimostrazione che le
immagini non hanno solo una funzione esornativa, ma possono rappresentare le
vere sembianze dei santi e permettere il loro riconoscimento in sogni e visioni –
asserti alla base dei contenuti politici della sinodica – e sollecitare la pietà dello
spettatore attraverso la memoria, come stabilito nella lettera a Secondino, nei
concili del 731 e del 769, nella sinodica del 785 e a Nicea.
Su questo nesso di secolare continuità e coerenza dell’azione papale si
sviluppa la responsio di Adriano più vibrante per toni e impianto ideologico.
Alla domanda « ut scientes nos faciant, ubi in veteri vel novo testamento aut in
sex synodalibus conciliis iubeatur imagines facere vel factas adorare » Adriano
risponde con veemenza che « nos quidem infra scientes facimus, sicuti iam
fecimus, quia et in veteri et in novo testamento sive in sex synodalibus conciliis
semper venerandas fuerunt sacras imagines et factas inter sancta sanctorum
titulabantur ». Le ragioni di questa consapevolezza sono dispiegate, con una
chiara elusione rispetto al nocciolo della domanda, enumerando tutte le
iniziative di promozione e committenza iconografica sostenute dai papi in
coincidenza con i primi sei concili ecumenici a cui segue una serie di
ammonimenti destinati a Carlo Magno. I concili, afferma Adriano, sono sempre
stati riuniti per fronteggiare l’eresia. Quelli convocati dai suoi immediati
predecessori, così come Nicea II, intendevano rimediare a un torto originato
dall’arroganza degli imperatori orientali che avevano preteso di deliberare in
materia di fede andando contro la chiesa catholica et apostolica. Contestando il
secondo concilio di Nicea Carlo si accingeva a compiere un uguale sopruso ma
doveva sapere che Adriano non si sarebbe lasciato piegare: « nequaquam nobis
quispiam terminos patrum nostrorum transgredi facere valebit neque novitatem
vocum inponere, sed in ea orthodoxam fidem, quam suscepimus, manentes et
olitana traditione amplectentes (…). Nullum qualibet iam exinde contrarium
sermonem suscipientes, neque ratione reddentes ». Inoltre il re dei Franchi
faceva bene a ricordare quale autorità fosse stata concessa ai sacerdoti. Come
aveva scritto Gregorio l’incremento nella conoscenza delle Sacre Scritture era
prerogativa esclusiva dei sancti doctores, che divoravano i propri nemici e ne
abbattevano la superbia con sassi scagliati dalla fionda, « quid namque per
fundam, nisi sancta ecclesia figuratur? ».
Stante la radicalità delle rispettive posizioni – dei teologi franchi nel
negare l’adorazione e la correttezza di Nicea II, di Adriano nel sostenerne i
contenuti e il ruolo svolto dal papato nel dibattito sulle immagini – l’ultima tesi
del Capitulare Adversus Synodum e la risposta corrispondente dimostrano che
in fin dei conti anche il dibattito dottrinale era sottoposto alle leggi della
Realpolitik. Il capitulum si apre con una dichiarazione perentoria. Il papa e la
chiesa di Roma devono sapere che sulle immagini il re e il clero franco
riconoscono unicamente l’autorità di Gregorio Magno nella forma della lettera a
Sereno di Marsiglia « quia sensum sanctissimi Gregorii sequi in hanc epistolam
universalem catholicam ecclesiam Deo placitam a indubitanter libere profitemur
». Perciò Carlo Magno permetterà di creare le immagini, « adorare vero eas
nequaquam cogimus, qui noluerint ». Un’affermazione quest’ultima
particolarmente importante. In primo luogo ci illumina sulle implicazioni
politiche insite nella contestazione di Nicea II. Al di là delle ricadute religiose e
cultuali, recepire il deliberato che costringeva i fedeli ad adorare le immagini
significava per Carlo imporre ai Franchi una norma costrittiva stabilita
dall’impero, il che era un fatto inaccettabile. In secondo luogo poiché comporta
un piccolo cedimento nei confronti del papato. Nessuno sarà obbligato ad
adorare le immagini, se non vuole, ma se volesse farlo per libera scelta non gli
sarà impedito.
L’andamento della risposta di Adriano si sforza di reiterare questo gioco
di rigidezza e condiscendenza con risultati decisamente più contraddittori.
In chi ha sostenuto una tesi così sacra et veneranda – tesi accusata di
incongruenza nel c. L – Adriano non può che riconoscere la persona
dell’ortodosso re dei Franchi, a cui l’ennesimo elenco di citazioni non viene
indirizzato per insegnargli qualcosa – sempre in precedenza, cc. XVI e X (70),
era stato insinuato il contrario – ma per ricordargli i capisaldi della dottrina
gregoriana. La costruzione di questa piattaforma di convergenza per le istanze
di entrambe le parti si porta dietro una mirabile rilettura del senso della sinodica
del 785 e di Nicea II. È stato assumendo il pensiero di Gregorio come unica
linea guida che Adriano ha composto la sinodica e raccolto le auctoritates in
essa contenute. E quando Irene e Costantino l’avevano letta immediatamente
avevano convocato il concilio « et sic synodum istam secundum nostram
ordinationem fecerunt (…). Et sicut pro eisdem imaginibus sancti Gregorii
sensum et nostrum continebatur, ita et ipsi in eadem synodo definitionem
confessi sunt ». Il ruolo svolto dalla patristica greca, dai teologi e dal clero
bizantini in sessant’anni di discussioni sul culto delle immagini viene cancellato
in un colpo. Anche se si è tenuto in Oriente Adriano intende dimostrare che
l’autorità istituzionale su impulso della quale Nicea II si era svolto e la
tradizione che lo aveva informato risiedevano in Occidente: « et ideo ipsam
suscepimus synodum ». Lo stesso a questo punto potrebbe fare Carlo a cui
veniva offerta, se non la prova definitiva della legittimità di Nicea II,
quantomeno la scappatoia formale per accettarne le deliberazioni, che non
avevano nulla di ‘greco’ ma risultavano dalla totale adesione del papa, degli
imperatori e del clero bizantino al sensum sancti Gregorii.
Tuttavia, conoscendo il proprio interlocutore Adriano vuole premunirsi
contro ogni evenienza, anche a costo di smentire quanto ha sostenuto con
dispiego di energie e testimonia. Subito dopo aver proclamato la paternità
gregoriano-papale di Nicea II Adriano sembra fare retromarcia. È vero, ha
accolto il concilio, ma vi è stato costretto in ragione dei suoi doveri pastorali nei
confronti delle tot milia animae orientali cadute nell’eresia. A Carlo, che non è
sottoposto a tale vincolo, è dunque lasciata aperta anche la strada di proseguire
nella sua contestazione. Tanto più che Adriano, implicitamente rafforzando
l’idea che a Nicea non tutto si fosse svolto correttamente, afferma di non aver
ancora ratificato il concilio. In linea di principio poiché teme una ricaduta di
Bisanzio nell’eresia, di fatto poiché non è stata ancora assolta una delle
condizioni imposte nella sinodica: il reintegro di Roma nel possesso dei
patrimonia e delle giurisdizioni. In caso di mancata convergenza intorno alla
piattaforma ‘gregoriana’ ne viene dunque immediatamente prospettata un’altra,
su cui Carlo e Adriano potevano collaborare: richiamare fermamente
l’imperatore a restituire beni e diocesi sotto pena di scomunica. Eventualità
questa che avrebbe consentito a Carlo di permanere nel suo ruolo di unico re
ortodosso di una dominazione di respiro universale.
Fare dei patrimonia l’oggetto di un negoziato bilaterale con l’impero e il
re dei Franchi, con la giustificazione che il primato petrino non poteva essere
pieno se la chiesa di Roma non rientrava in possesso di ciò che le spettava di
diritto la dice lunga sulle priorità di Adriano, nonostante egli affermi di preferire
la salvezza delle anime e la stabilità della fede, che non possedere beni terreni. «
Era vero proprio l’incontrario » ha scritto Girolamo Arnaldi.
VII.
Se lo guardiamo in una prospettiva di esercizio dell’autorità e nell’ambito
delle relazioni fra papato e Carolingi l’itinerario che abbiamo seguito fin qui
trova il suo punto di arrivo nel concilio di Francoforte del 794 dove, alla
presenza dei legati papali, il secondo concilio di Nicea fu ufficialmente
condannato. Carlo Magno si arrogò dunque il diritto di deliberare in materia di
fede anche in disaccordo con il papato, un’acquisizione che trasmetterà a
Ludovico il Pio, suo figlio e successore. Nell’825, all’atto di intervenire nella
seconda disputa iconoclasta, non solo furono denunciate le responsabilità di
Adriano nello svolgimento di Nicea II ma, sulla scorta di quel precedente,
l’imperatore franco insistette, presso i suoi rappresentanti a Roma, affinché
blandendo papa Eugenio II lo convincessero ad aderire alla dottrina elaborata
dall’episcopato franco. Rispetto al padre Ludovico aveva imparato solo un po’
più di diplomazia.
Una rivincita tuttavia Adriano la ottenne. L’assunzione di Gregorio
Magno come autorità assoluta nel Capitulare Adversus Synodum costrinse i
teologi franchi a recepire almeno una parte delle sue obiezioni e a ricalibrare le
proprie tesi in base ai contenuti dell’Ep. IX, 148 interpolata, un falso nato in
ambiente romano e confluito involontariamente nella Collectio Pauli.
Senza voler istituire un nesso di consequenzialità rigida fra influsso
esercitato dalla lettera interpolata, orientamenti iconografici di età carolingia, ed
esperienza delle immagini vorrei almeno segnalare due possibili prospettive di
ricerca.
Abbiamo visto che la scarsa rilevanza delle immagini nelle pratiche
devozionali e il loro essere relegate a una funzione meramente decorativa
scaturivano anche da orientamenti concretamente operanti nei decenni a cavallo
fra i secoli VIII e IX. Ma proprio in conseguenza del dibattito sulle immagini
tali orientamenti iniziarono a modificarsi. In virtù dell’acquisizione dell’Ep. IX,
148 interpolata occorreva riconoscere alle immagini almeno un’altra funzione,
quella memorativa. Anche se non viene citata esplicitamente l’influsso della
lettera a Secondino è individuabile già nell’Opus Caroli e che la si considerasse
un testimonium autentico lo dimostra il fatto che fu inserita fra quelli citati
nell’assemblea dell’825. Clelia Chazelle ha dimostrato l’incidenza esercitata
dall’Opus Caroli sui trattati in tema di immagini composti nel secolo IX, trattati
in cui era riconosciuta la funzione memorativa delle immagini in relazione alla
devozione. Varrebbe dunque la pena indagare se questa trasformazione da una
concezione ‘statica’ a una ‘dinamica’ del rapporto fra immagine e spettatore
possa aver influenzato anche le iniziative iconografiche e decorative che si
svilupperanno nel secolo IX.
Sempre sul tema immagine-memoria un altro percorso può essere
sviluppato a partire dalla seguente considerazione. Se ciò che distingue
un’immagine sacra da una qualsiasi altra è il fatto che di fronte alla prima si
compiono una serie di gesti, va notato che in linea di principio questa
performance avviene in senso unidirezionale, cioè dal fedele verso l’immagine
e attraverso di essa al soggetto raffigurato. Ma il conferimento alle immagini
della capacità di insegnare agli illetterati, di sollecitare la pietà attraverso il
ricordo e modificare il significato di certe esperienze cognitive dimostrava che il
flusso fra mondo terreno e celeste incanalato dalle rappresentazioni era
bidirezionale. Anche il fedele diveniva infatti oggetto di una performance.
Thomas Noble ha rilevato la scarsità di attestazioni di immagini miracolose in
Occidente fino alla fine del secolo VIII. Anche in questo caso si può pensare
che la dottrina elaborata in risposta a Nicea II possa aver influenzato gli sviluppi
successivi, nella direzione di una moltiplicazione delle possibili performance
esercitate da entità celesti sul fedele per tramite dell’immagine, miracoli
compresi.
Un ultimo ordine di considerazioni riguarda la tradizione, la sua
manipolazione e la sua trasmissione.
Se la compilazione della Collectio Pauli e il successivo contrasto con
Carlo Magno avevano dimostrato ad Adriano i rischi insiti nella possibilità che
altri, per di più se politicamente eminenti, si rivolgessero dirattamente alle fonti
della tradizione romana, gli avevano fornito anche un suggerimento. In
concomitanza di quel frangente Adriano fece approntare una raccolta (R nelle
edizioni critiche) di 686 epistole tratte dal Registrum. All’inizio vi fece copiare
il Credo di Gregorio, fornendo a quelle lettere la forza di decreti. A fronte
dell’impossibilità di impedire l’accesso all’epistolario gregoriano era possibile
almeno veicolarne un accoglimento ‘controllato’ e ideologicamente orientato ‒
R era pur sempre il risultato di una cernita intenzionale da parte della curia
romana ‒ e ribadire chi ne fosse il legittimo depositario. La possibilità di
accedere a una collezione che era al tempo stesso ampia e più maneggevole
dell’originale ne determinò la fortuna e la diffusione a danno dell’originale
corpus epistolare gregoriano, poiché da quel momento in avanti R sostituì il
Registrum come fonte delle raccolte successive. Da R nell’876 Giovanni
Immonide copiò le missive inserite nella Vita Gregorii [B. H. L. 3641-3642] e a
quest’ultima, come ha dimostrato Ovidio Capitani, attinsero Pier Damiani e
Gregorio VII nell’ambito della riforma ecclesiastica e della polemica con
l’impero. Per quanto riguarda il ricorso all’autorità di Gregorio Magno
attraverso le sue missive esiste dunque un nesso causale, alla cui origine si pone
una catena di manipolazioni, che lega un’iniziativa dei Carolingi ad alcuni degli
orientamenti espressi dal papato nella seconda metà del secolo XI.
Per Carlo Magno, al contrario, il radicalismo della tradizione si era
rivelato un’arma a doppio taglio. Se infatti a partire da esso si poteva mettere in
discussione quanto stabilito dal papa in carica, ci si trovava obbligati a
sottostare a quanto aveva sostenuto uno dei fondatori di quella tradizione, anche
se in realtà non l’aveva detto. Su questo dispositivo, in cui tradizione e autorità
collimavano, si fondava la possibilità di elaborare un falso e fornirgli credibilità,
ma altresì quella di ricomporre antinomie e contraddizioni. Quando all’inizio
del secolo IX la Collectio Pauli cominciò a essere trasmessa insieme con una
raccolta che conteneva la versione originale dell’Ep. IX, 148 i copisti non
avvertirono alcuna incongruenza nel fatto che esse presentassero due redazioni
diverse: furono trascritte entrambe. Lo stesso vale sessant’anni più tardi per
Incmaro di Reims quando, nell’Opusculum LV Quaestionum, affermò che nella
lettera a Sereno di Marsiglia e in quella a Secondino papa Gregorio Magno
aveva scritto che le immagini non dovevano essere né adorate né distrutte.
Spostiamoci ancora più avanti. Nel 1990 Hans Belting ha scritto: « in tutte le
fonti medievali ricorre sempre il lemma memoria. Ma a quale memoria ci si
riferisce? Già Gregorio Magno disse che, “come la scrittura”, la pittura ci
conduce al ricordo. (…). Nella celebre nona lettera, lo stesso Gregorio dice
concisamente che si venera colui “che l’immagine richiama alla memoria da
neonato o da morto, ma sempre nella sua gloria celeste” (aut natum aut passum
sed et in throno sedentem) ». Sulla funzione delle immagini nel pensiero di
Gregorio Magno l’anonimo interpolatore del secolo VIII è riuscito a ingannare
anche uno dei più autorevoli fra i ‘moderni’.