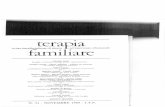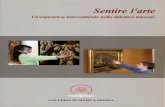Dialogo familiare, governo diocesano, «negotio publico»: la corrispondenza romana di Gregorio...
Transcript of Dialogo familiare, governo diocesano, «negotio publico»: la corrispondenza romana di Gregorio...
RICE,RCHE DI STORIA SOCIALE E RE,LIGIOSAA. XXXIX, Nuueno 77 - Nuova, SeruE - GENNaro-GrucNo 2010
Sotr,ttuanto
GmupaoloDANonna, PerGabrieleDeRosa...... 7
ANrONarra MAzZoN, ll più antico inuentario dei documenti del conuento
agostiniano romano di San Trifune-SantAgostino '.............'.. D
Isaegrra GAGLtAnoI, <<Seruono Dio con le sue mani>>. Le fficine gesuate
come segno di aita apostolica nel Tardo Medioeuo e nella prirna
Età Moderna 65
Gtusnppn PERnI, fJn nuorto documento sul ruolo della Nunziatura
Apostolica nella forrnazione della politica italiana nei confronti
degli ebrei stranieri durante il II conflítto mondiale..... 87
FrrrsEnro AcosrrNt, Insediamento e organizzazione delle giunte
municipali nel Veneto della trarusizione. Ilesperienza della prouincia
diPadoua,194t'1946.... r01
Manto CASELLA, Iianno santo del 1-950, lAzione Cattolica e Ia'6ociata
del gran ritorno'. Lettere e relaZioni da diocesi e parrocchie dell'Italia
meridionale 199
Nors
ANroruro MrNrunt Ipporrro - ANtoNgn ABARZAZT,Un nuouo aolume
della corrispondenza di Gregorio Barbarigo: due letture a confronto 255
SOMMARIO
AruroNto MENNrrr Imouto, Gregorio Barbarigo alla Corte di Roma (1676-1650).
Note sul corpo di lettere familiari e di gwerno recentemente pubblicate............. 256
ANroNErra BAxzAzt,Dialogo familiare, gouerno diocesano, <negotio publico>:la corrispondeftza roTnana. di Gregorio Barbarigo (1676-1650) .. 266
GENNano MrRoLrA, Società, politica e religione in Basilicata nel secondodopoguerra. ll contributo dei fratelli Rocco e Mons. Angelo MazzaronediTricarico .....:............. 279
Grussppe Port, A proposito di storia delle Chiese di Puglia 299
Grussppr Acocrrt.A, Ricordo di Diomede luone (1935-2005) . . ".... . )tl
Recgrusrolr
Pierantonio Piatti, Il moaimento femminile agostiniano nel Medioeuo,mornenti di storia dell'Ordine eremitano, Roma, Città Nuova, 2007(Alfonso Marini); Peter Godm an, Hitler e il Vaticano. Dagli archiui segretiuatícani la uera storia dei rapporti fra il nazismo e la Chiesa (AssuntaEsposito); Vincenzo Cesareo, Italo Yaccarini, La libertà responsabile.Una discussioze (Nicola Srizzolo); Giovanni De Luna, Le ragioni di undecennio 1969-1979. Militanza, uiolenza, sconfitta, rnentoria (GiuseppeFresolone); Luigi Ambros\ La riuolta di Reggio (Giuseppe Fresolone) ..... )D
Ansrnacrs
Nouzmnro
343
347
266 ANTONELLA BARZAZI
DIALOGO EAMILIARE, GOVERNO DIOCESANCJ, <NEGOTIOPUBLICO>: LA CORRISPONDENZA ROMANA DI GREGORIO
BARBARIGO (1676-1680)
La pull,blicazione di questo nuovo volume delle lettere di Gregorio Barbarigo
- il più corposo tra quelli finora usciti - rappresenta una tappa importante nel pro-getto di edizione coordinato con tenacia da Liliana Billanovichl. Gtazie alTa curarigorosa di Pio Pampaloni, risulta ora puntualmente documentata una fase centraledel percorso biografico del vescovo di Padova, fin qui poco nota, che si snoijò nelquadro di una particolare congiuntura dei rapporti diplomatici tra la Repubblicadi Venezia e Roma2.
La disponibilità a stampa di una parte ancora minoritaria, ma cospicua, anchedal punto di vista qualitativo, della corrispondenza barbadiciana consente ormaiqualche considerazione d'insieme su questo corpus epistolare, fonte di primbrdinesull'attività e il ruolo di un cardinale e vescovo italiano del secondo Seicento. Unafonte tanto più importante nel caso di una figura come quella di Barbarigo che,sottoposta a una precoce stilizzazione nel quadro del processo canonico di beatiÎicazione, ci ha lasciato ben pochi scritti al di fuori di quelli inerenti al mandatoepiscopale e alle funzioni istituzionali e pastorali connesser. Il volume curato daPampaloni suggerisce inoltre alcune direzioni d'indagine ancora poco sondate, purffa il tanto che è stato fatto sul presule padovano e sul suo mondoa.
Se guardíamo all'epistolario nel suo complesso, ci viene spontaneo rifletteresulla lunga fedeltà di Barbarigo allo scriver lettere, una pratica che lo accompagnòper tutta la vita, rimanendo un appuntamento fisso nelle sue giornate, pur arrraver-so il mutare delle circostanze e degli impegni. Nel saggio introduttivo al volumedelle Lettere ai farniliari, relative in massima parte al primo soggiorno a Roma nelL656-57, Pierantonio Gios ci inmoduce con alcune pagine molto fini agli esordi
I P. Pampaloni, Gregorio Barbarígo alla corte di Rorna (1676-1650). Lettere famílíari e digouerno, Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana,2009 (San Gregorio Barbarigo.Fonti e ricerche. VI).
2 Di una <<zona d'ombra>> nella vicenda del cardinale veneziano aveva parlato, con rife-rímento a questi anni romani, A. Menniti Ippolíti, Il processo di canonizzazione di GregorioBarbarigo. Riflessioni su un uolume recente, <<Rivista di storia della Chiesa in Italiu, LVII(2001), in part.pp. 187-189.
r P. Giovannucci, Il processo di canonizzazione del card. Gregorio Barbarigo, Roma,Herder,2001.
a Basti qui ricordare i due volumi degli atti del convegno del 1996, Gregorio Barbarigopatrizio ueneto, uescouo e cardínale nella tarda controliforrna (1625-16g7),a cura di L. Billanoviche P. Gios, Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1999 (San Gregorio Barbarigo.Fonti e ricerche,IIUl-2), un punto fermo nella bibliografia su Barbarigo e negli studi sul tardoSeicento ecclesiastico.
DIALOGO FAMILIARE, GOVERNO DIOCESANO, <NEGOTIO PUBLICO> 267
della scrittura epistolare di Gregorid. Scrittura subito precisa, la sua, estremamen-
te metodica ed esauriente nelle registrazioni, che rivela per un verso I'influenza
- assorbita in una famiglia dedita ai raffici mercantili - delle coruispondenze d'af-
fari, per I'almo ci appafe come I'esito dell esperienza al seguito dell'ambasciatore
veneziano in Vestfalia e della precoce consuetudine con il dispaccio diplomatico.
La precisione, il rigore dellbsservazione si accompagnano tuttavia a una spiccata
îmmediatezza. Indidzzate per lo più al padre, Gianfrancesco, le lettere romane diGregorio si rivolgono di fatto a tutti i membri della famiglia, vengono a volte lette e
godute in comune. Tramiti d'informazione, ma anche del mantenimento del legame
affettivo, devono conservafe la spontaneità con cui sono uscite dalla penna. Non
vanno perciò rilette: <<piacciono più tosto lunghe e mal ordinate, che brevi e con
tutte le loro forme>>6. Una modalità, questa, che Barbarigo avrebbe rivendicato inpiù occasioni e in tempi diversi. Eccolo allora ammonire il padre: <<Non si metta
la cattiva usanzà di rilegger le lettere, perché io non le rileggo mai>>. E ancora'
nell'agosto 1677: <Ho scfitto tanto che non mi basta I'animo di rileggere; ma è
vero che mai lo faccio>7. La matrice dell'epistolario come <<diario>>, <<giornale dibordo>> - secondo le espressioni di Gios -, come autobiografia - potremmo anche
dire - tenderà a conservarsi nel tempo, all'interno díun corpus che pure va incontro
a metamorfosi profonde. Dalla freschezza, da77a dimensione ariosa delle lettere del
primo soggiorno a Roma - specchio degli interessi e delle curiosità dellècclesiasti-
co trentenne che scruta il mondo ecclesiastico romano, attratto dalla città, dalle sue
botteghe di libri, preso dagli obblighi anche minuti legati alla sua nuova veste dicuriale -, sprofondiamo così via via verso la cupa, sfiduciata laconicità delle ultime
missive a Cosimo III de'Medici8.Tra i due esrremi le Lettere farniliari e di gouerno edite da Pampaloni, nelle quali
i caratteri originari della scrittura epistolare barbadiciana si declinano in maniera
peculiare. A ventànni di distanza dal precedente soggiorno nella capitale pontifi-
.iu, lo rgrru.do di Barbarigo è mutato: risretto agli ambienti curiali che quotidia-
namente frequenta, si esercita in uno scenario fatto quasi esclusivamente d'interni.Giunto a Roma carico dei problemi dí governo della diocesi lasciati alle spalle, delle
controversie annose, sempre aperte, con i monaci di S. Giustina e con il capitolo
della cattedrale, il vescovo di Padova ha intravisto nel prolungamento della perma-
5 P. Gios, Ilitinerario biografico di Gregorio Barbarigo dal contesto familiare all'episcopa-
to. Lettere ai familiari (1655-1657), Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana,1996
(San Gregorio Barbarigo. Fonti e ricerche, II), pp' 16-20.6 lbid., p. 19.7 lbid., p. l7n; il passo della lettera, del 14 agosto, si legge ora in Pampaloni, Gregorio
Barbarigo alla corte di Roma, p. 15).8 Lettere di Gregorio Barbarigo a Cosirno III de' Medicí (1650'1697), a cura di P. Gios,
con un saggio inroduttivo di G. Greco, Padova, Istituto per la Storia ecclesiastica padovana,
2001 (San Gregorio Barbarigo. Fonti e ricerche, V).
268 ANTONELLA BAPZAZI
neîzaín Curia lbpportunità per imprimere a queste ultime una svolta risolutivae.Da semplice cardinale conclavista si è così trasformato prima ín fíduciarío del papa,quindi in ambasciatore di fatto, nel quadro della sopraggiunta rottura diplomaticatra la Sede Apostolica e la Repubblica di Venezia e della vicenda senza precedentiche ne seguì, con le relazioni diplomadche veneto-pontificie tenute per ben quattroanni dai cardinali veneziani, Barbarigo, appunto, quindi Pietro Basadonna e il piùassiduo Pietro Ottobonil0. Quello relativo al periodo tra I'estate 1676 e la prima-vera 1680 s'impone così come il segmento cronologico in cui la cortispondenza vaincontro a un processo di netta 'professionalizzazione', con la drastica riduzionedello spazio riservato all'espressione affetttva e alla drvagazione erudita, la rinunciaa notazioni descrittive di uomini e vicende non strettamente funzionali al disbrigodei vari 'negozi', mentre la platea dei destinatari vede affiancatsi, al padre e alfratello Antonio, il vicario generale della diocesi diPadova Alessandro Mantovani,il doge Alvise Contarini, il procuratore di San Marco Giulio Giustinian, il Senatoe gli Inquisitori di Stato. Più conrollata, rigidamente selettiva, la comunicazioneepistolare di Barbarigo amplifica le potenzialità analitiche e la variabilità dei regi-sffi imposti - volta a volta - dalla cura delle situazioni domestiche e patrimoniali,dalle esigenze di amministrazrone e governo a distanza di una grande diocesi, dagliimperativi di una funzione diplomatica semiufficiale svolta con scrupolo e dedizio-ne. I continui cambi di regismo si raducono per lo più in cambi di ritmo: incalzantequando vengono impartite a famlliaú e collaboratori disposizioni su questionispecifíche, la scrittura diventa lenta e prolissa quando Barbarigo dà conto fin neiminuti particolari delle udienze con il papa e con altre personalità della cerchiapontificia. Un andamento decisamente dilemmatico catàttetizza invece la discgs-sione delle vettenze padovane che accompagnano - imisolte - il soggiorno romano,così come la rassegna delle alternative di fronte allo stallo del <<negotio publico> e
al deteriorarsi della posizione in Cutia del cardinale di Padova. Solo sullo scorciodel volume il lettore rileva facilmente una decisa accelerazione del passo, riflessodel sollievo che - malgtado il nulla di fatto su turri i versanrí - pervade Barbarigoal profilarsi del rientro in patria.
Il volume curato da Pampaloni documenta in maniera puntuale le intuizioni diLiliana Billanovich sul ruolo della famiglia nel governo episcopale, sull'agire dellacasa come <<unità coordinata con il vescovo>>1l. Anche in questa tranche dell'epi-
e Cfr. le lettere al padre del 2 gennaio e del 27 marzo 1677 in Pampaloni, GregorioBarbarigo alla corte di Roma, pp. 105 e 109. Le differenti versioni offerte dai biografi sullascelta di Barbatigo di rimanere a Roma sono ricordate in P. Giovannu cci, Gregorio Barbarigoalla corte di Innocenzo XI, <<Srudia Patavinà>, 56 (2009), p. l8l.
10 G. Cozzi, Dalla riscoperta della pace all'ínestinguibile sogno di dominio, in Storia divenezia- Dalle origini alla caduta della Serenissima, \rr, La Venezia barocca, a cura di G.Benzoni e G. Cozzí, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997 , pp. 50-51.
11 L.Billanovich, lntornoalruolodella'casa'nelgouernodiunuescououeneziano:dallelettere di Grcgorio Barbarigo ai familiari, in Cbiesa società e stato a Venezia. Miscellanea di
DIALOGO FAMILIARE, GOVERNO DIOCESANO, <NEGOTIO PUBLICO> 269
stolario i destinatari della maggior parte delle lettere restano il padre e il fratello.È al primo che Gregorio affida I'ultima parola sulla gestione del seminariol2. Conlui discute problemi squisitamente ecclesiastici come quello delle ordinazioni sacre
conferite, contro le regole canoniche, fuori della diocesi d'appartenenza degli aspi-
fanti, un fenomeno segnalato anche da altre parti in questi anni, che vedono I'avviodi un aumento del numero degli ecclesiastici destinato a toccare i suoi massimi nel
Settecentolr. Ed è ancora il padre a raccogliere quella dichiarazione, pure valoriz-
zatà a súo tempo da Billanovich, circa il fondamento della residenza del vescovo,
<<de iure diuino, come io credo>>, scrive Barbarigola.
All'anziano Gianfrancesco spetta anche soprintendere all'attività del vicariogenerale, Alessandro Mantovani, mentre Antonio, íl fratello del vescovo, veglia
sulla gestione economica dellèpiscopio. Le comunicazioni da Roma con i due più
stretti congiunti evidenziano la scarsa stima e la limitata fiducia riposta nel vicarioda Barbarigo e dalla sua famiglia. Ecco quindi che il padre diventa destinatario
delle lettere indíùzzate al Mantovani e decide quali consegnare e quali trattenerelt.
Quanto alla corrispondenza diretta del vescovo con la massima autorità in loco
della curia padovana, ci si presenta essenzialmente come un elenco di disposizioni
da eseguire. Sarà ancora il padre comunque, nel 1679, a tfattenefe Gregorio dal
sostituire il Mantovani con il fidato canonico Camillo Varotto, sostenitore, nel
capirolo, delle ragioni del vescovo. Il vicario in carica disponeva in ogni modo -spiegherà Gianfrancesco - del <<coraggio>> necessario per I'esercizio della funzione e
in particolare per <<levar i disordini del seminario>>16. Bersagliato, lungo tutto I'arco
della cotrispondenza romana, da epitetí poco lusinghieri - <<lùbrico di linguo>,
<<poltrone>> -, tacciato d'infido nelle <<cose economiche>> e d'inadempiente rispetto
a incombenze essenziali, Mantovani ricoprì comunque I'ufficio per un quindicen-
nio - dal 1675 alla morte, nel 1690 -, assai più a lungo dei suoi predecessori e ben
studi in onore di Siluio Tramontin, a cura di B. Bertoli, Venezia, Studium cattolico veneziano,
1994,pp.151-lT 0a cit. da p.152).12 <<Ho gusto che V.E. abbia le mani nel seminario>>, scríve il7 gennaio 1679 (Pampaloni,
Gregorio Barbarigo alla corte di Rorna, p. 310).rr I richiami alle singole lettere di Barbarigo ibid., pp. CI-C[. A partire dal 1660 denun-
ce di analoghi <<disordini>> nelle promozioní al sacerdozio si susseguono nelle relationes
ad lirnina del patriarca di Yenezta Giovanni Francesco Morosini (Arch' Segr' Vaticano,
Congregazione del Concilio, Relationes Dioecesium, 860/A); sull'incremento, nel secondo
Seicento, del clero secolare nella diocesi padovana, cfr. F, Caffagni,Clero curato e benefici
parroccbiali nella diocesi di Padoua' quadri statistici e linee di tendenza nel XVI secolo, in
G re gori o B arb ari go p a tl izio u e n e to, I, pp. 7 Ú -7 22.ra Nella lettera del 25 giugno 1.678 (Pampaloni, Gregorio Barbarigo alla corte di Rorna,
p.249); cfr. L. Billanovrch, Ilepiscopato padouano (1664-1697): indirizzi, rìforme, gouerno, in
Gregorío Barbarigo patrizio ueneto,I, p. 414.lt Pampaloni, Gregorio Barbarigo alla corte di Roma, pp. CX-CXI, con i relativi rinvii
alle lettere.t6 lbid., p. 666, lettera del 16 dicembrc 1679.
270 ANTONELLA BARZAZT
oltre il rientro da Roma del vescovo. La sua lunga permanenza in carica fu dunquedovuta - viene da chiedersi - al semplice tratto caratteriale energico e risoluto, piut-tosto che a competenze e capacità giuridico-amministrative? Quale spazio d'azioneautonoma il vicario poté ritagliarsi, tra le ptescrizioni dei congiunti del vescovo? Equali rapporti fu in gtado di stabilire con il resto delT'organizzazione diocesana?
Si tratta di questioni di rilievo, che vanno al di là degli aspetti umani e soggettividel rapporto di Barbarigo con il Mantovani. Come ci ha insegnato Claudio Donati,il ruolo dei vicari generali, così come l'otganizzazione di curie e cancellerie e latenuta degli archivi, sono indicatori importanti per valutare la consistenza delleistituzioni diocesane, per cogliere i processi d'irrobustimento del potere vescovileche hanno luogo tra Sei e SettecentolT. Occorrerà, dunque, tornare ancora sull'ap-parente delsolezza della figura istituzionale del vicario, posto sotto la tutela dellacasa, alla luce dei numerosi elementi forniti da questo volume delle Lettere, maanche di una più ampia îicognizione degli atti prcdotti dall'ufficio vicariale. Credoche all'interno di un quadro più preciso e cronologicamente esteso dell'attivitàarnministîativa e giudiztatia della curia padovana potranno essere meglio compresepeculiarità, punti di fona e debolezze di un progetto di governo episcopale comequello di Barbarigo, incenrato sulle visite pastorali e su una rete di vicariati foraneidirettamente controllata dalla forte personalità del vescovo, ma sostenuto - secondole ricostruzioni più recenti e autorevoli - da un ,apparato burocratico cenffale pocosviluppato, assai più esile comunque rispetto al modello della curia milanesels.
Letichetta adottafa da Pampaloni, Lettere familiari e di gouerno, rendeefficacemente la peculiare impronfa dell'epistolario, non riconducibile a :ur,adicotomia pubblico-privato, anacronistica per il tempo. Tende tuttavia a lasciarenell'ombra Taterza dimensione della corrispondenza edita, attinente alf impegnodiplomatico di Barbarigo, il cosidetto <<negotio publico>>. Saldamente intreccia-
17 C. Donati, Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'etàrnoderna: percorsi di ricerca, in Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e relígiosa d'Europa:XV-XVIII secolo, a cura di C. Nubola e A. Turchini, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 2ú -229 ;
ld., Chiesa italiana e uescoui d'Italia. Tra interpretazioni storiografíche e prospettiue di rícerca,<<Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento>>, XXX (2004), pp. )75389.
r8 Billanovich, L'episcopato padouano, pp.460-468. Nella prospettiva di un collegamenrotra dimensione pastorale e attività amministrativa e giudiziaria della curia padovana sarebbedel massimo interesse un approfondimento del rapporto fra il vescovo, con il suo tribunale, e
I'Inquisizione, p.ure tematizzato a suo tempo da L. Billanovich, con riferimento agli interventidi Barbarigo su uno dei tanti episodi tardoseicenteschi di direzione spirituale di stampo 'con-templativo' (Esperíenze religiose negate nel tardo Seicento: il parroco e le deuote di Alano frauescouo e comunità rurale, in Studi in onore di Angelo Gambasin. Dagli allieui in rnemoria, a
cura di L. Billanovich, Vicenza, Neri Pozza, 1992, pp. ll4-115n).I-imeperibilità - qui ricor-data - delle carte del Sant'Ufficio di Padova è tra I'altto compensata ora dalla disponibilitàdell'archivio romano dell'Inquisizione. Per la curia ambrosiana mi limito a rinviare al recentebilancio critico di D. Zaúín, La curia arciuescouíle al tempo del cardinal Federico, <<Studia
borromaico>, 1l (20ú), pp. 3 l-56.
DIALOGO FAMILIARE, C,OVERNO DIOCESANO, <NEGOTIO PUBLICO>
ta alle alme, questa terza dimensione contribuisce a sua volta ad amplificare ilruolo di riferimento e di supporto svolto dal gruppo familiarc, presente e attivodietro I'intero spettro dell'attività del cardinale. Quando, il l1 dicembrc 1678,
Barbarigo riceve incarico di ossequiare il papa a nome della Repubblica - un'in-combenza riservata di norma all'ambasciatore -, ha già inviato il primo dei suoidispacci al Senatole. Pampaloni ha scelto, ragionevolmente, di non pubblicare ilcarteggio con il governo veneziano conservato nelle seríe dellArchivio di Stato
di Yenezia2o. I temi di quest'ultimo debotdano però di continuo nelle letterealla casa, occupandovi ampio spazio. Non solo: ai familiari - pdma al padre, poíprevalentemente al fratello - è demandato il compíto delicato di filtrare e cor-
reggere la corrispondenza pubblica. Il curatore segnala, nel saggio infroduttivo,1l post scripturu della citata lettera al padre del 17 dicembre 1678: qui Barbarigo,che esordisce nell'incarico di negoziatore, avverte di aver aggiunto un fogliobianco <<se volessero mutar qualche cosa nella lettera publica>. E capita che ilcardinale di Padova, prima di prendere un'iniziativa o affrontare un'udienza con
il papa scriva <<avanti>> al padre o al fratello per sondare il gradimento che il suo
agire o gli orientamenti che si profilano a Roma possono attendersi a Venezia.
Non si ratta del resto di una fotzatura della prassi negoziale. E InnocenzoXI stesso a irtdftizzarlo su questa sttada, nell'auspicio di un riavvicinamentoveneto-pontificio che sembra sulle prime dietro I'angolo2l. S'istituisce così una
fitta rete di rimandi e d'intrecci tra <<negotio publico>>, interessi familiari e
questioni riguardanti la diocesi. Con il rischio che la trattativa per la riaperturadell'ambasci ata a Roma e le <<contese padovane>>, di cui Barba úgo vagheggia la
conclusione, finiscano per interferire e pregiudicarsi a vicenda. <<Per li negotii diPadova - scrive accoratamente il cardinale al fratello nel febbraio 1679 - pregola
tener saldo perché non precipitino i publici, e non si può dire quanto male hannofatto li monaci al publico co'l protestarsi qui al papa e a mons. De Luca>>22.
Nel suo recerite Scriuere lettere, Armando Petrucci distingue i prodotti episto-
lari spontanei e liberi - oggetto del suo interesse - dai caîfeggi diplomatici, che
cataloga ffa le testimonianze documentarie2r. Opportuna e pressoché obbligata inuna sintesi rivolta a una vicenda <<plurimillenaria>> e aftenta agli aspetti soprattuttografici e formali della scrittura epistolare, la netta linea di demarcazione ttacciata
da Petrucci tra le due categorie di corrispondenza appare assai più ftastagliata dal
re Cfr. la lettera al padre del 17 dicembre in Pampaloni, Gregorio Barbarigo alla corte diRoma, pp.296-299.
20 Per i dispacci al Senato cfr. Archivio di Stato di Venezia, Dispacci degli antbasciatori alSenato. Indice, Roma, Ministero dell'Interno, 1959, p.240.
2r Per tale vralpapa lo incoraggerà, nell'aprile 1679, a render note le sue intenzioni disostenere l'offensiva diYenezia contro i turchi. Pampaloni, Gregorio Barbarigo alla corte diRona, p. LIII.
'z2 lbid., p. )4g.UaJJusione è naturalmente alla disputa con i cassinesi di Santa Giustina.2' A. Petrucci, Scriuere lettere. Una storia plurinillenarza, Roma-Bari,Laterza,2008, p. K.
271
272 ANTONELLA BABZAZT
punto dbsservazione di queste Lettere fanuiliari e di gouerno, un epistolario insiemedomestico, ecclesiastico e diplomatico, che coniuga modelli comunicativi e finalitàprofondamente diversi. Autobiografia di un principe della Chiesa, ritratto di unafamiglía del patríziato veneziano alle prese con il mantenimento del proprio presti-gio, con la divisione dei ruoli e delle carriere, con la gestione degli awicendamentigenerazionali, sotto I'egida di un padre longevo e accentratofe, la corríspondenzaromana di Barbarigo ci offte insieme uno spaccato di aspetti strutturali del rap-porto tra due Stati italiani sempre meno importanti sullo scenario europeo. Ancheper questo il corpus delle lettere batbadiciane merita un posto di rilievo nel quadrodell'esplosione quantitativa e tipologica che investe la comunicazione epistolare trala fine del Seicento e il pdmo Settecento.
Movimentata fu la vicenda postuma dellèpistolario di Barbarigo, dipanatasinell'ambito del processo dibeatíficazíone. Prelevari dall'archivio di famiglia ne! 1746,insieme ad altre carte relative alle cause affrontate dal vescovo di Padova, i 28 volumidell'epistolario 'privato' passarono al vaglio della Congreg zione dei riti, per dispo-sizione di Benedetto XIV'?4. Presumibilmente l'entourage del cardinale Rezzonico,deciso a favorite in tutti i modi I'esito della beatificazione, operò in via preliminareuna serie di selezioni e manomissioni volte a contenere - come ha puntualmentedocumentato Giovannucci - gli effetti negativi di quel groviglio di controversie con icorpi ecclesiastici cittadini, la cui ombra si proiettava inevitabilmenre sull'immaginedi Barbarigo. Appariva innegabile che le liti con il capitolo e con i monaci, il susse-guirsi dei ricorsi ai tdbunali ecclesiastici e alle magistratute veneziane, avevarìo avutopesanti ricadute sulla vita cittadina, provocando una frattura profonda nell'alto clero,mettendo in gioco la dignità episcopale e il decoro della chiesa padovana. Ijaccusalanciata dai canonici al vescovo di esser <<nemico del politico governo>> rischiava didiventare il terribile suggello di un'intera esperienza pastomle2t.
La controversia con il capitolo, più ancora di quella con i monaci di SantaGiustina, fu in effettí per Barbarigo un rovello costante, ossessivamente presentenell'epistolario romano, <<la maggior persecutione>>, che <<dà occasione di calunniealla casa>96. Ricorrente quanto illusorio il sogno di terminarla una volta per tutte.Un sogno che detta alcuni di quei passi dilemmatici ed ellittici frequenti nellelettere, vetgati sul filo di un ragionamento interiore che erompe quando Barbarigosi trova a tu per tu con il padre: <<o i canonici accettano di Íinit tutto, ed è un granguadagno, o non accettano ed io niente perdo, perché io ho mostrato I'animo mioben disposto; io non ho parlato con canonici, onde niente di me possono dire. Si faconoscer la protervia degli stessi canonicifT. Un anno e mezzo dopo prevale però
2a Giovannuccí, Il processo, pp. 5 15-5 L6.2t A. Menníti lppolíto, La curia romana al ternpo di Gregorío Barbarígo, in Gregorío
Barbarigo patrizio ueneto,I, p. 144n.26 Cfr., rispettivamente, le le$ere al padre del 10 ottobre 1676 e del 20 marzo 1677 in
Pampaloni, Gregorio Barbarigo alla corte di Rorna, pp. 39 e 108.27 Così Gregorio si esprime nella lettera aI padre del2'7 mano 1677 , ibid., p. 109 .
DIALOGO FAMILIARE, C.O\,IERNO DIOCESANO, <NEGOTIO PUBLICO> 27)
la sfiducia. <<Questo negotio resterà sempiternamente acceso; e non occorre pensaredi mai più in vita nostra finirlo>. Eppure: <<il finírlo anche malissimo è meglio assaidi ogni altra cosa. E come gli aversari credono suo gran bene il non finido, cosìnoi dobbiamo credere nostro gran bene finirlols. È all'interno di questo gioco,in cui nessuna delle due parti mette vera volontà di chiudere, che va collocata lareiterazione da parte di Barbarigo al papa, nel corso dell'ultima udienza, dellarichiesta di poter accordare al capitolo la prerogativa, di alto valore simbolico, del<<pararsi all'altare>>. Innocenzo XI opponà un rifiuto, giudicando inopportuna laconcessione ai canonici padovani di privilegi non goduti dai <<capitoli di Germaniatanto maggiori>>2e.
Sullo sfondo dell'accanita vertenza con il corpo privilegiato dei canonici, nellaquale il vescovo sarà risucchiato poco dopo il rienfto aPadova,l'attenzione del let-tore dellèpistolario è attirata dall'atteggiamento di Barbaúgo di fronte alle vicen-de, per certi versi analoghe alle sue, del patriarca di Venezia Giovanni FrancescoMorosini. Nel 1678 Morosini - giunto alla fine del suo lungo patriarcato, iniziatonel t644 - si trovava immerso, ancora una volta, in una disputa con 1o strato supe-riore del clero veneziano, costituito da parroci e preti di quelle chiese collegiatecittadine che il patriarca non esitava a definire, per le loro larghe autonomíe, <<quasi
episcopales>10. Si trattava di ecclesiastici che raramente provvedevano di persona
ai doveri dell'ufficio parrocchiale: a quest'ultimo cumulavano a volte la dignità dicanonici della cattedrale o della basilica palatina di San Marco, ma potevano ancheaffiancarc lèsercizio della funzione di awocati del foro ecclesiastico o d'incarichinella cancelleria patriarcale e nelle curie di diocesi limimofe, forti di studi giuridicie, in più d'un caso, di una laurea in utroque iurelt.Uno di loro era il paroco diS. Maria Zobenigo Alvise Barutti, ripetutamente nominato nella corrispondenzada Roma come fiduciario a Venezia di Barbarigo e da tempo attivo in vari ruolial servizio del vescovo di Padovar2. Gli aspri contasti esplosi nel 1649-50 ra talevariegato mondo clericale, srenuo difensore dei proprí privilegi, e il patriarcaerano stati sedati grazie alla mediazione del Senato, ma si erano riaperti a quasitrent'anni di distanza, nel 1678, in seguito alla decisione del Morosini di sottoporre
28 lbid.,pp.285-286,1ettera al padre del 12 novembre 1678.2e Il richiamo a <<un capitolo di Getmania, ch'è qualche cosa di più del capitolo di
Padova> si ritrova anche nel resoconto dei contatti va il, datano e i canonici, nella precedentelettera al padre del J settembre 167I (íbid., p. 269) .
r0 Così nella visita ad limina del 1649, in Arch. Segr. Vaticano, Congregazione delConcilio,Relationes Dioecesium,S60/A; sul Morosini, olre al profilo di A. Niero, lpatriarchidi Venezia. Da Lorenzo Giustiniani ai nostri giorni,Yenezía, Studium cattolico veneziano,
L961, pp. L27 -DO, cfr. Cozzi, Dalla riscoperta della pace, pp. 61-62.r1 Si veda i. Secondo catalogo dei dottori che sono nel clero di Venetia, in appendice a
Francesco Sansovino, Venetia città nobílissima et singolare ... Con aggiunta di tutte le cose
notabili ... fatte et occorse sino al presente 1663, da d. Giustiniano Martinioni, Venezia,Stefano Crrtí, 1663, pp. 1 1-14.
r2 Gios, Ilitinerario biografico, pp. 109-110.
274 ANTONELLA BARZAZ]
a conferma i confessori ogni quattro mesi. Tra i protagonisti della resistenza alla
risoluzione paliarcale si era distinto proprio il Baratti, il quale - a tenore delle
rimostranze fatte pervenire a Barbarigo da Morosini - sèra fatto <<far capo del
clero>>lr. Immediato, nel vescovo di Padova, un moto d'istintiva identificazione:
<<non mi par bene - scriveva infatti al padre - far perder d'avantaggio la reputatione
alli prelatLy'a. Un mese dopo però, chiamato in causa dal fedele <<piovan Barattl>,
Barbaúgo si mostrava più critico nei confronti del patriarca: ne stigmatizzava la
úgidezza eccessiva e le pretese <<impratticabilil>, opponendo una linea di condottapiù duttile, attenta alla reputazione e alle qualità dei singoli confessori e predicato-
ri. <<Onde io per me crederei che ci volesse la carità e la desterità dell'una e I'alftaparte>>, concludeva, con un sussiego che suona un po'paradossale sullo sfondo delle
implacabili <<contese padovane>>it.
Nell'agosto 1678, alla morte di Morosini, il Senato designerà patriarca di Venezia
il senatore Alvise Sagredcf6. Lultima elezione, nella storia della Repubblica, di unpaúízio proveniente dalla carrieta politica sarà ratificata da| papa con una rapiditàe una condiscendenza che, nel progressivo deteriorarsi delle relazioni veneto-
pontificie, suonerà come gesto di disponibilità nei confronti della Repubblica.
Barbarigo terrà a sottolinearlo, senza lasciar petalÚo trasparire il proprio pensiero
in merito a una consuetudine radicata nella tradizione veneziana, la cui estrema
ripresa doveva provocare reazionimolto negative negli ambienti di Curia'7. Ma nonè forse azzardato ritenere che nella rìuova veste di negoziatore diplomatico avesse
provato sollievo di fronte alla scelta di una figura di presule certamente sensibile
alle ragioni del <<governo politico>>, dopo la lunga fase di tensioni incrociate tra leistituzioni ecclesiastiche veneziane che aveva segnato il patriarcato del Morosini.
Un alto problema relativo aYenezia che Barbarigo si trovò ad affrontare nel
corso del soggiorno a Roma fu quello della nomina dell'arcivescovo di Filadelfia,massima autorità spirituale della comunità greca della capitale. La designazione,
alla fine del1617, del deposto arcivescovo di Costantinopoli Metodio Maroni aveva
riaperto polemiche annose sulla condizione dei sudditi greci della Repubblica,sulla tutela e le autonomie giurisdizionali loro gatantite di fronte alle pressioni
romane per una sottomissione degli ortodossi al papa, divenute più forti dopo ilconcilio di Trentds. Grazie anche a17a capacità di mediazione del nuovo patriarc'à.
tJ Ck. la lettera del L2 marzo 167 8, in Pampaloni, Gregorio Barbarigo alla corte di Ronra,
pp.212-21).34 Ibíd.
'5 lbid.,lettera al padre del 16 aprile 1678, p.224.16 Niero, I patriarchi di Venezia, pp. I3l-l)).)7 Pampúoni, Gregoio Barbarigo alla corte di Roma,pp. LIII e 3]6 (lettera di Barbarigo
al fratello Antonio del 28 gennaio 1679).rs B. Cecchettí, La Republica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione,
Venezia, Naratovich, 1874, II, pp. )53)54. Sulle questioni qui sommariamente richiamate
mi limito a rinviare aY.Peri,Il<inuedibile risguardo>> e l'<incredibile destrezza>>. La resistenza
di Venezia alle iniziatiue postridentine della Santa Sede per i greci dei suoi domini, it Venezia
DIALOGO FAMILIARE, C.OVERNO DIOCESANO, <NEGOTIO PUBLICO> )7s
Sagtedo, non aveva avuto seguito la richiesta rivolta dal nunzio pontificio CafloFrancesco Airoldi al governo veneziano che I'eletto fosse allontanato da Venezia inquanto <<scismatico>>. Ma all'indomani della morte del Moroni, nel settembre 1679,le rinnovate istanze del papa per la nomina di un ecclesiastico greco di garantitafede cattolica erano andate a complicare ulteriormente I'accidentato percorso del<<negotio publico>>. Per tempo Barbarigo, scrivendo al fratello, si era augurato chelhprirsi di una questione tanto delicata e spinosa portasse a un ristabilimento deirapporti diplomatici ordinari ftaYenezia e Roma, consentendo di evitare le secchedi una diatdba dottrinale e disciplinare intorno a un <<negotio che già è discusso>>re.
La vertenza doveva in realtà sancire l'isolamento in Curia di Barbarigo e la suadefinítiva sostituzione, nel negoziato, da parte di Ottoboni. Il cardinale di Padovasarà infatti costretto a sottoscrivere una lettera al doge rcdattaproprio da Ottoboni,nella quale allèsposizione dettagliata delle ragioni e delle richieste di InnocenzoXI in materia di celebrazione di matimoni e di governo della chiesa dei greci,faceva seguito il preannuncio di un breve sulla materia. Tenterà comunque Io stessogiorno, in una missiva inàiúzzata personalmente al doge, di dissociarsi da77a piegaimpressa allaftatf.ativadal rivale, assecondato dal terzo porporato veneziano, PietroBasadonna. E rivendicherà fermamente la validità della propria linea, più consonaai <<prudentissimi dettam|> ricevuti da Y eneziaao .
Al di 1à della rivalità con Ottoboni, viene anche qui da chiedersi quale fosseil reale pensiero di Barbarigo su una questione come quella in discussione, cheand^va caricandosi - sullo scorcio del Seicento - di nuove implicazioni, nel climadi rilancio missionario alimentato dalle vittorie cristiane contro i turchi, tra nuoveprospettive di assimilazione di popolazioni e gruppi dirigenti aperte dalla con-quista veneziana della Moreaal. Fatto sta che dieci anni dopo la conclusione del
centro di rnediazione tra Oriente e Occidente Gecoli XV-XVI). Aspettí e problemi, a cura diH. G. Beck, M. Manoussacas, A. Pertusi, Firenze, Olschki, 1"971 ,I, pp.599-625, e al piùrecente contributo di Z, N. Tsirpanlis, La posizione della comunità greco-ortodossa rispettoal patriarcato ecumenico di Costantinopoli (XV-XWil secolo), in I Greci a Venezia, Atti delconvegno internazionale di studio, Venezia,5-7 novembre 1998, a cura di M. F. Tiepolo e E.Tonetti, Yenezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,2002, pp. 124-149.
re Pampaloni, Gregorio Barbarigo alla corte di Roma,lettera del 9 settembre 1679, p.587 .
<<So - scriveva Barbarigo (ibid,) - che qualched'uno da Congregatione del Sant'Offítio sta
assai sopra questo negotio>>. <Il papa ci sta assai sopra questo negotio e la Congregatione delSant'Offitio vi preme molto>>, ripeteva al fratello una settimana dopo (ìbid., p. 595).
as Labozza della lettera dei re cardinali e il messaggio di Barbarigo al doge, enrambiin data 16 settembre 1679, sono ibid., pp.601-606. Il sospetto nei confronti di Ottobonie Basadonna pervade quasi ossessivamente le lettere di questi ultimi mesi romani. Per gliinterventi di Ottoboni sulla questione dei greci cfr. A. Menniti Ippolito, Politica e carriereecclesiastiche nel secolo XVIL I uescoui ueneti fra Rorna e VeneTia, Bologna, il Mulino, 1991,pp.230-2)5.
a1 G. Cozzi, La Repubblíca di Venezia in Morea. Un diritto per il flaouo regno, in La socie-tà oeneta e íl suo diritto,Yenezia, Marsilio, 2000, pp. 261 -il}.
216 ANTONELLA BI,BZAZI
soggiorno romano, ritroviamo il vescovo di Padova, il nuovo pattiarca di Venezia
Giovanni Badoer e il nunzio pontificio Filippo Archinto riuniti a convegno, nelle
vicinanze della casa veneziana dei padri dell'Oratorio a Santa Maria della Fava,
insieme all'allora arcivescovo greco di Filadelfia Melezio Tipaldoa2' Ospitato anche
in altre occasioni aPadova da Barbarigo, Tipaldo efa stato designato nel 168t alla
guida spirituale dei greci di Venezia e consacrato da due vescovi appositamente
giunti dal Levante. Aveva tuttavia manifestato, nel giro d'alcuni anni, un animo
accesamente filocattolico, che l'aveva spinto a moltiplicare i contatti con la cufia
romana e a pfomuovele il passaggio al cattolicesimo di membri di spicco del mondo
ortodosso veneziano4r. Uattivismo di questa figura controversa doveva scatenare
contrasti e profonde divisioni tra i greci di Venezia, mettendo in crisi i precari equi-
libri e i compromessi politico-religiosi su cui si reggeva la tadizionale linea della
Repubblica nei confronti della <<nazione greca>>. Trail1706 e il 1708 - ignorando
le protesre della comunità contro le limitazioni delle proprie prerogative in materia
ecclesiastica - il Senato demanderà ai Capi del Consiglio dei Dieci la vigilanza sui
cappellani greci, il cui credo cattolico, espressamente dichiarato in una professione
di fede, sarebbe stato comprovato da un esame del patiarca o del suo vicarioaa.
Qualcosa era dunque definitivamente cambiato nel modo della Repubblica edella chiesa veneziana di guardare alla minoranza gÍec . E c'è un filo - all'internodi questo mutamento di rotta - che ci conduce a Batbatigo. Del resto particolar-mente sttetto fu il rapporto tra questi e il patriarca di Venezia Giovanni Badoet,
succeduto nel 1688 al Sagredo, I'ultimo presule laico. Era stato il vescovo di Padova,
poco dopo il rientro dal soggiorno a Roma, a ordinare sacerdote Badoer e ad acco-
glierlo quindi nel capitolo padovano. E come discepolo e seguace di Barbatigo nella
diocesi lagunare Badoer è presentato puntualmente nelle testimonianze biografiche
settecentescheat. Ijinfluenza del modello episcopale barbadiciano si espresse in luinello sforzo di plasmare un clero diocesano più omogeneo e 'disciplinato', di piùalto livello culturale e morale, nello scrupolo delle visite pastorali, nei richiami a
una spiritualità salesiana e boromaica, nell'impegno posto nella conversione di<<qualche eretico o maometano, o giudeo o scismatico>>a6. Nella vigilanza antiquie-tistica inflessibile e accorta, infine, che esercitò tanto a Yenezia che a Brescia, dove
a' G. Fedalto, Il cardinale Gregorio Barbarigo e l'Oriente, in Gregorio Barbarigo patrizio
ueneto,If, p. 999; Niero, I patriarchi dí Venezía, p. 134.ar Oltre a Tsirpanlis, La posizione della comunità greco-ortodossa, pp. L$-L46, cfr. E.
Birtachas, Un <<secondo>> uescouo a Venezia: il netropolita di Filadelfia Gecoli XVLXVII),pure nel volume citato I Greci a Venezía, pp. 1.0)-121, e Cecchetti, La Republica dí Venezia,
II, pp.354-357.44 lbid.,l, pp. 469-470.at G. Torcellan, Badoer, Giouanni Alberto, in Dizionario Bíografico degli ltaliani,5,
Roma, Istituto della Enciclopedialtaliana, 1963, pp. 119-I20;Niero,I patriarchi diVenezìa,
pp. r33-ú6.a6 La oita del cardinale Giouanni Badoaro uescouo di Brescia, Brescia, per li figliuoli del
q. Giuseppe Pasini, 1766, p. 8.
DIALOGO FAMILIARE, GOVERNO DIOCESANO, <NEGOTIO PUBLICO> 277
nel 1706 fu trasferito - preventivamente nominato cardinale -, con il mandato distroncare un nuovo pericoloso rigurgito di pelaginismo.
Ormai più di dieci anni fa Gaetano Cozzi, con la sua straordinaúa sensibilitànel cogliete le grandi direzioni della politica e della religione, nel loro muruo inrrec-ciatsi, aveva voluto riservare uno spazio apposito a Barbarigo nel suo contributo alvolume VII della.lro ria di Venezia edita da Treccani, intitolandone uno dei parugta-fi conclusivi Riflessi ueneziani di una grande personalità religiosa: Gregorío Barbarígo,oescouo di Bergamo, poi di PadouaaT. La fîgwa del prelato veneziano - messa a
confronto con quella del nonno omonimo, esperto diplomatico e vicino a PaoloSarpi - pareva a Cozzi compendiare in maniera esemplare la parabola percorsa dalsentire religioso del ceto dirigente della Repubblica dal primo al secondo Seicento,e insieme l'imporsi di un nuovo volto della chiesa veneta e di quella veneziana inparticolare. Una chiesa che, pur continuando a rivendicare peculiarità devozionalie consuetudini di convivenza con altre fedi, avevain parte ricomposto le divergenzedei tempi dell'interdetto e ridotto il solco ra Dominante e Dominio, raggiungendoun grado d'integrazione assai maggiore all'interno del cattolicesimo romano.
Tra lo scorcio del Seicento e i primi anni del nuovo secolo lbpera svolta aYenezia da un patriarca seguace del vescovo di Padova contribuirà a consolidaretaleindiúzzo Ma ahrettanto importanti saranno - da un punto di vista sostanzialee simbolico - due atti compiuti da papa Alessandro VIII Ottoboni nel 1690: Iacanonizzazione di Lorenzo Giustiniani, primo pariarcavenezianq e Ia concessio-ne di una bolla alla chiesa palatina di San Marco, che ne confermava e ampliava iprivilegi, dal giuspamonato del doge all'immunità dalla giurisdizione patiarcaleas.A fronte della rivendicazione da patte della Repubblica del carattere originariodell'autonomia della cappella ducale, nata all'atto della fondazione della città edemblema di un'antica concezione sacrale del potere, c'era ora un espresso ricono-scimento papale a legittimare prerogative ed esenzioni giurisdizionali della basilicamarciana. Anche fa principale peculiarità della chiesa della capitale, il dualismo trapatriarca e primicerio di San Marco, veniva così ricondotta all'autorità pontificia.
Vale la pena di sottolineare che, almeno in quest'ambito,l'azione e I'influenzadei due gtandi avvemari - Barbarigo e Ottoboni - andavano nella stessa direzione,quella di un'omologazione'romana' delle istituzioni ecclesiastiche veneziane.
Arurorusrra Bnxztzr
Università degli Studi di Padova
a7 Cozzí, Dalla riscoperta della pace, pp. 6-64.a8 Cfr. ibid., pp. 5t-fi; 56-62; inoltre G. Cozzi, Giuspatronato del doge e prerogatiue
del primicerio sulla cappella ducale di San Marco Gecoli XVLXVDI). Controuersie con iProcuratorí dí San Marco de supra e i patriarcbi di Vene7,ia, Atti dell'Istituto Venero di ScienzeLerrere ed Arti, CLI (L992-199j),pp. L-69.