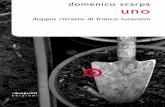2015. Affetti da adozione. Uno studio antropologico della famiglia post-familiare in Italia
Transcript of 2015. Affetti da adozione. Uno studio antropologico della famiglia post-familiare in Italia
Rossana Di Silvio
Affetti da adozioneuno studio antropologico della famiglia
post-familiare in Italia
Alpes Italia srl - Via Romagnosi 3 - 00196 Romatel./fax 0639738315 - e.mail: [email protected] - www.alpesitalia.it
© Copyright Alpes Italia srl - Via G. Romagnosi, 3 – 00196 Roma, tel./fax 06-39738315
I edizione, 2015
Rossana Di Silvio: (PhD, Università di Milano-Bicocca) è Cultrice di Antropologia della Parentela presso l’Università di Milano-Bicocca ed è psicologa-psicoterapeuta presso l’Asl di Milano1. Si occu-pa delle nuove forme di parentela e famiglia nelle società euro-americane contemporanee ed ha con-dotto ricerche in Italia e in Ucraina (Oblast di Odessa) con una prospettiva etno-antropologica. Ha pubblicato una monografia sulla parentela adottiva (Ombre Corte, 2008), contributi in collettanei (Morlacchi, 2012; Carocci, 2013) e articoli in lingua inglese. Attualmente sta lavorando sulle tra-sformazioni e le sfide della genitorialità, e in particolare della paternità, nelle società del Sud-Europa.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Tutti i diritti letterari ed artistici sono riservati.È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, di quest’opera.
Qualsiasi copia o riproduzione effettuata con qualsiasi procedimento (fotocopia, fotografia, microfilm, nastro magnetico, disco o altro) costituisce una contraffazione passibile delle pene
previste dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633e successive modifiche sulla tutela dei diritti d’autore
III
Indice
Prefazioni .......................................................................................................... V Barbara Yngvesson ......................................................................................... V Claudia Mattalucci ........................................................................................ IX
Ringraziamenti ................................................................................................. XV
Introduzione ..................................................................................................... XVII
Un (qUasi) Prologo L’abbinamento, tra chimica dell’incontro e ingegneria sociale .......................................................................................... 1
Parte Prima “Vado a prendere mio figlio!” l’economia di Un incontro Pre-destinato ...... 21
Capitolo I – Il peso dell’orfano sociale.Sofferenti, soccorritori ed emozioni operative ..................................................... 27
Capitolo II – “Making the strange familiar”: rendere familiare l’estraneo.Il lavorìo delle narrazioni visuali nel presente progressivo dell’incontro adottivo .......................................................................................... 37
Capitolo III – Tra passato imperfetto e futuro plurale.Tempo, memoria e narrazione nella “storiella” della nuova famiglia ..................... 55
Parte seconda
la famiglia come volontà e come Pratica qUotidiana ...................................... 69
Capitolo I – Criticità di una congiuntura “vitale”. La natura sdrucciolevole del futuro possibile ....................................................... 75
Capitolo II – “Kin is what kin does”: i parenti sono ciò che i parenti fanno.L’evidenza di essere parenti .............................................................................. 83
Capitolo III – Figli che crescono i genitori.Spazio domestico, intimità familiari e altri apprendimenti ................................... 95
IV
Affetti da adozione
Capitolo IV – “Tu conosci mio fratello?” Cedimenti digitali di parentele a tensione analogica .............................................................................................. 117
Parte terza
vita ordinaria di singolari border-crossers .................................................... 135
Capitolo I –L’affannosa scolarizzazione dei figli adottivi. Pratiche di conformazione, esercizi di distinzione e tattiche resistenti di una congiuntura “vitale” ................................................................................. 141
Capitolo II – Investimenti e ri-capitalizzazioni.La scuola come arena dell’economia emozionale della famiglia .......................... 159
Capitolo III – “If a relationship does not exist, then one can be created”: se una relazione non esiste, allora se ne può creare una. Magie, incantamenti e trucchi nell’organizzare l’estraneità dentro il cerchio del “noi” .......................... 171
Capitolo IV – Elogio dell’inquietudine. Le politiche della differenza e il mondo terzo dell’adolescente (adottivo) ............. 187
Un (qUasi) ePilogo Piccoli adottivi crescono. Come sentirsi a casa in questo fragile, frammentato tempo di transizione ................................................................... 209
conclUsioni ....................................................................................................... 233
BiBliografia ....................................................................................................... 241
filmografia, sitografia ..................................................................................... 254
V
Prefazioni
Barbara YngvessonHampshire CollegeAmherst, Massachusetts, USA
In questo volume denso, teoricamente brillante ed etnograficamente ricco, Rossana Di Silvio presenta una fine esplorazione della costruzio-ne (e decostruzione) della famiglia italiana contemporanea, focalizzandosi sulle profonde modalità con cui l’adozione transnazionale/transrazziale ha modellato questo processo di fabbricazione. Sostenuta anche dalla propria formazione come psicologa e psicoterapeuta che ha lavorato per molti anni con famiglie adottive in Italia prima di completare la laurea magistrale e il dottorato in antropologia, Di Silvio attinge a quattro anni di lavoro sul campo (2010-2014) con quindici famiglie e dieci giovani adottivi tra il milanese e la Gallura, sviluppando un’analisi convincente delle contraddi-zioni e delle tensioni al centro della vita delle famiglie adottive. Il titolo del suo libro, “Affetti da adozione”, cattura queste tensioni nello slittamento di senso (in Italiano) di “affetto” come “affezione” e come “afflizione” (con le sue implicazioni di malattia); un doppio senso simile è presente anche in Inglese, dove “affetto” implica sia amore e sentimenti affettuosi ma è anche una radice della parola “affezione” che si riferisce sia all’amore che a una condizione corporea o malattia (un’afflizione).
Di Silvio esplora le tensioni tra affezione e afflizione nella famiglia adot-tiva su diversi registri. Un tema centrale è la complessità del mandato asse-gnato ai/assunto dai genitori adottivi, cioè che il bambino da adottare sia legalmente e socialmente considerato “come se” fosse nato dagli stessi ge-nitori adottivi, benché il terreno fondante la famiglia, in Italia come nella maggior parte dei paesi europei e nordamericani, sia quello di una connes-sione genitore-figlio culturalmente concepita come “naturale” in quanto definita dal sangue e dunque impossibile da rimuovere (diversamente dal rapporto giuridico tra marito e moglie). Da questa prospettiva, il figlio adottato può essere visto come una “afflizione”, qualcuno che risente delle condizioni in cui sia i genitori adottivi che il figlio adottato violano un “na-turale” codice di condotta che sottende una interpretazione convenzionale della vita familiare “normale”. Un’interpretazione che permane nell’Italia odierna, nonostante il suo ruolo energico di nazione adottiva nel corso delle ultime decadi.
VI
Affetti da adozione
Con tatto e sensibilità, Di Silvio esplora le molteplici occasioni in cui il discorso etico del bambino come creatura innocente e vulnerabile, bi-sognoso solo del sostegno “disinteressato” dei genitori adottivi, rifluisce nel contesto di una retorica verosimilmente più potente dove il bambino adottato, i suoi nuovi genitori e persino la società di arrivo sono “a rischio” di violare un ordine naturale delle cose con l’incorporazione di un figlio di estranei – particolarmente estranei nel caso dei cosiddetti paesi “in via di sviluppo”. Il concetto di parentela adottiva come rischio è esso stesso in conflitto con un immaginario in cui il bambino adottabile viene indi-viduato come vulnerabile e bisognoso di “una casa” e delle cure che “una famiglia” può dare. Di Silvio suggerisce che questa tensione fondamentale sia alla radice del recente aumento di “rotture” famigliari e di restituzioni di bambini adottivi alle istituzioni, un problema che si osserva non solo in Italia ma anche in altre nazioni di accoglienza.
Un particolare punto di forza del libro di Di Silvio è la capacità dell’au-trice di muoversi fluidamente tra ciò che può essere inteso come un registro “esterno” di fatti sociali, immaginari culturali e bio-tecnologia e un registro “interno” di emozioni potenti attraverso cui la genitorialità adottiva viene avvertita come “controcorrente” nei confronti di un sistema pervasivo di credenze e pratiche secondo cui la “vera” genitorialità viene definita dal le-game di sangue. L’autrice fa riferimento alla letteratura sull’“assemblaggio” come forma globale, sostenendo che l’adozione può essere compresa come una “zona tecnologica” (il termine è di Andrew Barry, 2001), uno spazio interattivo individuato da specifiche forme di tecnologia, circuiti di inte-razione e competenze professionali. In questo spazio, le identità soggettive sono intese a partire da una prospettiva bio-medica, con i genitori definiti dalla propria incapacità di procreare e i figli dal loro essere abbandonati, e allo stesso tempo ognuno di loro rappresenta un “capitale” sia per i paesi di provenienza che per quelli di arrivo. Un aspetto fondamentale di questa zona tecnologica sono le associazioni di famiglie adottive che forniscono un supporto tra pari ai futuri genitori che attendono l’assegnazione e l’arri-vo del figlio adottato. All’interno delle associazioni, genitori con maggiore esperienza forniscono modelli di “buona genitorialità” per i futuri genitori, e Di Silvio sostiene – in modo convincente – che il loro supporto fornisce all’arrivo del nuovo figlio una certa protezione verso la società in senso generale, un sostegno che può essere visto come significativo nella produ-zione dell’habitus e delle pratiche di genitorialità adottiva, poiché connette le associazioni di genitori adottivi ai processi burocratici dello Stato.
I contributi più intensi di Di Silvio sulla costruzione delle relazioni genitori-figli in adozione sono il risultato della sua profonda immersione nelle pratiche quotidiane di vita familiare. Quando l’autrice fornisce una
VII
Prefazioni
chiara spiegazione del registro discorsivo, con la sua enfasi sull’orfano so-ciale, il bambino sofferente e il ruolo ideologicamente centrale dell’amore dei genitori nel colmare la differenza esperita tra genitori e figlio, non per-de mai di vista le complesse emozioni in gioco sia per i genitori che per figli adottivi, e i modi in cui gli assunti fondamentali riguardo somiglianza e differenza possono essere creativamente rimodellati all’interno degli spazi relazionali intimi. Per esempio, scopre che le differenze somatiche – consi-derate importanti in situazioni pubbliche dove l’appartenenza è individua-ta alla luce della somiglianza somatica – potrebbero essere reinterpretate dai nuovi genitori “al di fuori dall’ombrello di senso offerto dal principio del sangue, suggerendo modalità alternative per creare un sentimento di genitorialità e filiazione [che siano] egualmente “veri” e “duraturi””.
Particolarmente efficaci nello sviluppare le sue argomentazioni sulla soggettività del genitore adottivo sono le ampie interviste che Di Silvio ha condotto con i genitori adottivi, i quali si confrontano con le dimensioni etiche e morali della politica del “clean break” che sottende l’adottabilità nell’adozione internazionale o con le questioni di cosa costituisca il “mi-glior interesse” di un bambino. Una delle sue interlocutrici, che ha infine adottato due figli dal Brasile e dall’Etiopia, descrive il “tormento” provato nel conciliare le contraddizioni di una pratica dove il genitore potrebbe essere visto come colui che “sottrae” furtivamente il bambino, come se “rubasse il futuro di quel Paese”, pur convinta che, se lei e suo marito non avessero adottato i loro due figli, questi sarebbero sicuramente mor-ti a causa delle condizioni in cui vivevano. Mentre Di Silvio sottolinea con attenzione che pochi tra i genitori intervistati hanno manifestato il profondo malessere espresso da questa donna, allo stesso tempo sostiene che altri genitori sono tormentati dalla sensazione che le proprie azioni infliggano una “ingiustizia” – e quindi, che il discorso del “bambino come dono”, ampiamente utilizzato dalla retorica dell’adozione internazionale e che sembrerebbe giustificare i genitori adottivi in una arena transnazio-nale, non può, alla fine, essere considerato come una “accordo equo” tra il bisogno (di “una casa”) e il desiderio (di un figlio), ma piuttosto come una transazione molto meno definita e potenzialmente immorale. Qui vedia-mo l’emergere di una nuova “verità narrabile” sull’adozione internazionale, una verità ampiamente diffusa in anni recenti tra gli adottivi internazionali ormai adulti.
Il capitolo finale di “Affetti da adozione” guarda alle esperienze di alcuni di questi adulti, attingendo alla letteratura prodotta dagli adottivi adulti e da altri ricercatori, così come alla ricerca etnografica dell’autrice stessa. Di Silvio ritorna sulla tensione tra identità e differenza, tema centrale della letteratura sull’adozione più in generale, per investigare come l’auto-rifles-
VIII
Affetti da adozione
sione degli adottivi adulti che sono ritornati per periodi più o meno lungi nei loro Paesi di nascita, possa fare luce sulle questioni di appartenenza. Di nuovo, Di Silvio fornisce una fine analisi dei racconti dei suoi interlo-cutori, rivelando gli intricati effetti del ritorno sull’incessante processo di nascita dei soggetti adottati ed evidenziando come questi viaggi possano potenzialmente dare vita a nuove forme di legame finora bloccate dalle relazioni necessarie a fabbricare una “casa” italiana compiuta.
IX
Prefazioni
Claudia MattalucciUniversità di Milano-Bicocca
Il termine adozione deriva dal latino ad-optare e designa l’istituto giuri-dico con cui s’instaura un rapporto di filiazione tra persone non consangui-nee. Come ricorda la sua etimologia, questo legame costruito dalla legge e assimilato negli effetti a un vincolo di sangue, discende da una scelta anzi-ché dalla “natura”. Si tratta di un istituto antico, diffuso, in forme diverse, in tutte le società. Secondo Jack Goody (1969), uno dei primi antropologi che si sono occupati di adozione in una prospettiva comparativa, tre sono le funzioni che questo istituto ha assunto nelle società euro-asiatiche: dare una casa agli orfani, ai trovatelli o ai bastardi; consentire alle coppie senza figli di avere una discendenza; e, infine, dare agli individui o alle coppie che ne erano privi, degli eredi cui trasmettere le loro proprietà.
Come emerge da questo studio, in passato, in Europa, l’adozione aveva principalmente finalità economiche e politiche, come garantire la conti-nuità delle linee di discendenza o mantenere intatti i patrimoni. Oggi, al contrario, le finalità dell’adozione sono innanzi tutto di ordine psicologico. Le convenzioni internazionali e le normative nazionali mettono al centro il benessere dei bambini.1 Le ricerche etnografiche sull’adozione nei paesi eu-ropei e nord-americani, d’altra parte, mostrano come per le coppie infer-tili, che sono la maggioranza dei genitori adottivi, l’adozione rappresenti uno strumento per diventare una famiglia “normale”. Per i genitori, i figli adottivi hanno un valore emotivo ed espressivo: sono una fonte di appa-gamento, uno strumento di realizzazione di sé, il mezzo per emanciparsi dalla condizione di senza figli (Modell 2002; Selman 2004; Howell, Marre 2006; Howell 2006).
Mentre in Europa occidentale e in Nord America la domanda di ado-zione è progressivamente cresciuta, e con essa il numero delle famiglie adottive, le rappresentazioni correnti di questa pratica hanno subito poche variazioni. Nel sentire comune la parentela adottiva resta sostanzialmente una seconda scelta: sia la condizione dei genitori che quella dei figli sono considerate svantaggiate, perché richiedono un investimento maggiore per realizzare ciò che nella filiazione biologica si ritiene sia dato dalla “natura” e
1 La Convenzione dell’Aja (1993), per esempio, afferma che la famiglia d’origine è l’ambiente più idoneo per crescere i bambini; che i bambini che non possono crescere in tale ambiente hanno comunque diritto ad avere una famiglia; che l’adozione, specialmente internazionale, va considerata come ultima possibilità; e che nel superiore interesse del bambino i genitori adottivi devono consentirgli di conoscere e preservare la sua identità. Gli Stati Uniti non hanno ratificato questa convenzione.
X
Affetti da adozione
perché si suppone mantengano, nonostante tutto, una fragilità intrinseca, sempre pronta rivelarsi nelle fasi della crescita considerate difficili, come l’adolescenza (Terrell, Modell 1994; Telfer 1999). Le criticità attribuite all’adozione contemporanea sono acuite dal fatto che, almeno in Europa, essa è quasi esclusivamente transnazionale. Le differenze somatiche tra ge-nitori e figli rivelano la natura costruita del legame che li unisce, rendendo ardua la mimesi della filiazione adottiva con quella biologica, che continua a rappresentare il modello di tale relazione.
Negli studi classici di antropologia della parentela l’adozione ha a lungo occupato un posto marginale. Ha invece ricevuto un’attenzione crescente nelle recenti analisi della relazionalità parentale (Carsten 2000). Come è accaduto più in generale per gli studi di antropologia della parentela pub-blicati dopo gli anni Novanta del XX secolo, ad occuparsi di adozione sono state soprattutto delle donne. Mentre alcune antropologhe hanno studiato le pratiche di adozione e di affido (fosterage) in contesti non occidentali, altre hanno studiato l’adozione transnazionale nei paesi dell’Europa occi-dentale e del Nord America, dove tale fenomeno presenta evidenti somi-glianze ma anche significative differenze (Howell 2009).
Gli studi sulle pratiche di adozione e circolazione dei bambini nei pa-esi non occidentali hanno rivelato quanto fuorviante sia guardare a questi arrangiamenti attraverso le lenti dell’adozione occidentale. In molti luoghi in cui l’adozione e l’affido sono frequenti, infatti, la parentela non è pensa-ta come condivisione di un patrimonio biogenetico che si dà attraverso il concepimento e la nascita, ma come esito di performance e condotte che, reiterate nel tempo, trasformano le relazioni e le sostanze di cui sono “fatte” le persone. La condivisione del cibo, di una casa, la prossimità emotiva, il vivere insieme determinate esperienze, la comunicazione, la cura, l’affetto e il rispetto di obblighi reciproci sono soltanto alcune delle esperienze che rendono parenti. Gli studi sull’adozione in contesti non occidentali hanno evidenziato come, nei luoghi in cui sono le pratiche a fare la parentela, i figli adottivi non siano considerati sostanzialmente diversi da quelli bio-logici (tra gli altri, Carsten 1995; Weismantel 1995).In molti dei contesti in cui l’adozione e l’affido sono estensivamente praticati, inoltre, diversa-mente da quanto accade nei Paesi europei o nord-americani, l’affidamento dei bambini ad adulti che non siano i loro genitori di nascita è considerato come un’opportunità vantaggiosa sia per gli adulti, sia per bambini (Silk 1980; Goody 1982; Alber 2003). Molti di questi arrangiamenti adottivi, inoltre, non presuppongono che la genitorialità sia una funzione esclusi-va: l’affido può essere un modo per far fronte a situazioni critiche e non comportare una rinuncia definitiva alla custodia dei figli; l’adozione, d’al-tra parte, non necessariamente porta all’interruzione di ogni rapporto con
XI
Prefazioni
i genitori biologici (tra gli altri, Fonseca 2005). Infine, diversamente da quanto mediamente si suppone accada nei paesi europei e nordamericani, l’adozione non è unicamente riconducibile alla scelta degli adulti; i bam-bini, in effetti, possono avere un ruolo attivo nel processo che li porta a diventare parte di un gruppo domestico diverso da quello dei loro genitori di nascita (Wardle 2004).
Se gli studi sull’adozione e l’affido nei contesti non occidentali han-no rivelato l’etnocentrismo intrinseco alle rappresentazioni dell’adozione e della parentela che informano le convenzioni che normano quest’istituto a livello internazionale,2 le etnografie condotte in Europa occidentale e Nord America hanno analizzato la costruzione della famiglia adottiva at-traverso creativi processi di naturalizzazione dei legami parentali. Hanno inoltre fatto luce sulla formazione dell’identità degli adottivi transnaziona-li, mostrando come questa dipenda, tra l’altro, dalle politiche della razza e dell’etnicità nei paesi di accoglienza e da quelle dei paesi d’origine, in par-ticolare quando, come la Corea, incentivano viaggi di conoscenza delle ori-gini per coloro che un tempo sono stati bambini dati in adozione (Howell 2002; Kim 2010; Yngvesson 2005). Diversi studi, infine, hanno criticato l’adozione transnazionale evidenziandone le collusioni con l’economia di mercato e denunciando le profonde diseguaglianze tra paesi donatori e paesi riceventi, che possono indurre a considerare questa pratica una for-ma di neocolonialismo. Mentre la retorica dominante nei paesi riceventi è quella del dono, nei paesi cosiddetti donatori spesso si ricorre a quella della predazione (Yngvesson 2010).
La ricerca che Rossana Di Silvio ha condotto in Italia dal 2004 a oggi si colloca in questa cornice e dialoga produttivamente con una ormai vasta letteratura antropologica sull’adozione. Si tratta di un’etnografia di lunga durata che ha consentito all’autrice di osservare da vicino le trasformazioni che nell’ultimo decennio l’adozione transnazionale ha subito in Italia, in particolare come conseguenza dell’arrivo di bambini progressivamente più grandi e non di rado portatori di bisogni particolari o speciali. Già prima di iniziare questa ricerca, la pratica adottiva era per Di Silvio un oggetto familiare. La sua esperienza professionale come psicologa in quella che sa-rebbe diventata la asl di Milano1, l’aveva portata ad occuparsi di adozioni quando queste erano soprattutto nazionali. Misurarsi con un’etnografia della pratica adottiva ha richiesto all’autrice un non evidente lavoro di intenzionale presa di distanza dalle categorie cognitive e dagli strumenti metodologici attraverso i quali aveva, in precedenza, osservato e co-costru-ito questa pratica: un’operazione che ha portato avanti con successo e che l’ha progressivamente condotta a elaborare una riflessione critica sul potere
2 Cfr. nota 1.
XII
Affetti da adozione
normativo che il discorso psicologico detiene sull’adozione e più in genera-le sulle relazioni familiari. Nel suo primo libro, Parentele di confine, frutto di un’indagine condotta tra le associazioni di genitori adottivi del milane-se, che a oggi resta l’unico studio antropologico dell’adozione in Italia, Di Silvio (2008) ha analizzato il percorso normativo attraverso cui la famiglia adottiva viene istituita. Ha descritto i riti che lo scandiscono, come l’otte-nimento dell’idoneità; proposto un’analisi critica dei suoi dispositivi, come il clean break;3 e analizzato le forme simboliche attraverso cui la nascita della famiglia adottiva viene rappresentata, come le storie preparate dai genitori per raccontare al bambino la sua origine. Se da un lato l’autrice ha discusso analiticamente il lavoro degli enti e delle associazioni, dall’altro ha ugualmente individuato gli scarti tra retoriche istituzionali e motivazioni, discorsi e pratiche delle coppie. L’ultimo capitolo di questo libro affrontava la delicata questione dei fallimenti adottivi.
Affetti da adozione è un testo complementare a quello precedente. La ricerca etnografica da cui scaturisce è stata estesa geograficamente, ma si è soprattutto spostata dai luoghi più pubblici e istituzionali dell’adozio-ne transnazionale a quelli più intimi della socialità familiare, per seguire da vicino la costruzione quotidiana della relazionalità adottiva. La grande maggioranza delle storie delle famiglie adottive, infatti, nonostante si di-spieghi per cammini impervi e costellati da ostacoli, ha un esito positivo. L’ambizioso obiettivo che l’autrice si è data nell’iniziare il lavoro di ricerca di cui questo libro rappresenta il brillante risultato, è comprendere e re-stituire al lettore come l’alterità del bambino abbinato alla coppia venga progressivamente ridotta e si produca tra genitori e figli (ma anche tra nonni e nipoti, zii e nipoti o fratelli e sorelle non biologici) quella “re-ciprocità dell’essere” che, secondo Marshall Sahlins (2013), la parentela è. Scopriamo così che, anche in un universo sociale in cui la biologia è il codice dominante per pensare e dire la parentela, a fare i parenti siano la condivisione di pietanze e di gusti alimentari, di spazi abitativi progressi-vamente adattati alle esigenze di chi li occupa, di memorie di eventi vissuti insieme o soltanto ascoltati nel racconto di altri, di modalità espressive e di uno “stile” identificabile come distintivo di quella particolare famiglia. Scopriamo ugualmente che i materiali di cui le relazioni sono fatte non provengono soltanto dalla storia della famiglia che accoglie il bambino, ma anche da quella che questo estraneo, venuto a occupare il posto d’ono-re della parentela euroamericana contemporanea, porta con sé. Modalità
3 Il dispositivo del clean break (taglio netto) è stato per decenni dominante nel campo dell’adozione naziona-le. Proprio mentre su questo terreno veniva superato dall’adozione aperta, è riapparso su quello dell’adozione transnazionale. Gli adottivi transnazionali, infatti, sono formalmente separati da tutto ciò che costituisce la loro precedente identità. Il loro passato viene “tagliato via” in modo che i bambini possano essere più facilmente integrati alla nuova famiglia, al nuovo luogo di residenza e alla nuova nazione.
XIII
Prefazioni
interattive, competenze sociali e saperi pratici che i bambini adottivi, in particolare i più grandi, hanno appreso nei contesti di origine partecipano alla tessitura della relazionalità parentale. Queste risorse, assemblandosi a quelle acquisite dopo l’arrivo, consentono ai giovani adottivi di interagire efficacemente con i pari e con gli adulti che popolano il loro nuovo univer-so intra ed extra-familiare, come per esempio l’ambiente scolastico. Come nei già citati studi sull’apparentamento adottivo in contesti non occiden-tali, inoltre, anche nell’etnografia di Di Silvio ai bambini adottivi è rico-nosciuto un ruolo attivo nella produzione della relazionalità parentale. Un altro elemento d’interesse di questa fine etnografia, è la sottolineatura che spesso i bambini più grandi non sono unicamente portatori di competenze e saperi, ma anche di legami con i propri parenti di nascita. A dispetto di un dispositivo che tende a escluderli, nelle loro memorie e nei loro affetti ci sono anche altri. Non sempre i genitori biologici sono le figure più presenti nelle complesse trame relazionali che compongono la parentela degli adot-tivi. Nelle storie che Di Silvio restituisce i nonni e soprattutto i fratelli sono figure che rivestono un ruolo importante. La relazione tra fratelli non è un tema cui l’antropologia della parentela in generale né quella dell’adozione in particolare hanno prestato grande considerazione. L’attenzione per que-ste relazioni, suggerita a Di Silvio dagli incontri sul campo, rappresenta un altro punto di forza di questo lavoro.
Come il titolo di questo libro suggerisce, per coloro che ne sono “affet-ti” l’adozione è dunque molto di più di un istituto giuridico: è un processo che mette in gioco sentimenti, emozioni, saperi e pratiche, e che produce effetti trasformativi profondi e spesso inattesi sui luoghi, sulle relazioni e sulle soggettività. Seguire da vicino il farsi dell’apparentamento adottivo attraverso le parole e i gesti dei genitori, dei figli e dei nonni che Di Silvio ha incontrato, consente al lettore di comprendere le dinamiche messe in gioco della pratica adottiva e, più generalmente, di riflettere su ciò che la parentela (non soltanto adottiva) è e ciò che la parentela fa nella società italiana contemporanea.
XV
ringraziamenti
Questo libro è frutto di una ricerca condotta tra il 2010 e il 2014 e co-
stituisce un approfondimento di una precedente indagine pubblicata nel 2008. Il testo ha visto una prima, parziale stesura nella scrittura della tesi di dottorato in Antropologia della Contemporaneità: Etnografia delle Di-versità e delle Convergenze Culturali, Università di Milano-Bicocca, ma il suo contenuto attuale è inedito e originale. Pur utilizzando gli strumenti d’indagine e la prospettiva teoretica forniti dall’etno-antropologia, questo testo non è indirizzato al solo dibattito accademico. Spero infatti che pos-sa contenere stimolanti suggestioni anche per coloro che, a vario titolo, sono impegnati nella costruzione e nel “governo” della parentela adottiva, rivelandosi un utile strumento di riflessione multidisciplinare su un tema tanto complesso e articolato.
Il fenomeno dell’adozione e la sua esperienza privata e sociale sono pro-fondamente mutati nel corso degli ultimi anni e sono tutt’ora esposti ad un’intensa fluidità. Il libro racconta la realtà delle esperienze delle famiglie adottive nello spazio domestico e sociale, attraverso la descrizione di alcuni segmenti significativi della loro vita quotidiana. Lo sforzo è stato di resti-tuire le loro voci, lasciando spazio ai racconti di coloro che vivono perso-nalmente questa esperienza e cercando di far emergere non solo le pratiche e le azioni, ma anche i sentimenti che li accompagnano e i modi con cui hanno articolato i loro saperi incorporati con le prospettive di un legame di famiglia inusuale, da creare intenzionalmente. Le questioni messe in cam-po dall’apparentamento adottivo vengono analizzate dalla prospettiva delle riflessioni suscitate dai recenti studi critici della parentela e dal dibattito sulla famiglia “post-familiare”. Di parentela adottiva si parla spesso come parentela fittizia e famiglia di seconda scelta, lasciando che la differen-za alienante con il modello biologico opacizzi una realtà privata e sociale molto ricca e articolata, fatta di esperienze, posizioni, identità, sentimenti e soprattutto di un movimento incessante e fecondo tra ciò che è dato e ciò che deve essere creato. In queste pagine, ho cercato di restituire la sog-gettività dei parenti “per legge” e la specificità delle loro famiglie, provando a superare l’idea della “mancanza” – del legame di sangue, della capacità di procreare, della famiglia di nascita – e illustrando gli effetti - faticosi, audaci, ma spesso emozionalmente appaganti - di un’agency concertata dei parenti “estranei” sul processo di fabbricazione della loro famiglia.
Questo libro non sarebbe stato possibile senza il generoso sostegno, la guida, l’incoraggiamento e il confronto che mi hanno riservato molte
XVI
Affetti da adozione
persone. Desidero innanzitutto ringraziare con grande affetto e simpatia Barbara Yngvesson, docente all’Hampshire College di Amherst, per l’ami-cizia e la stima professionale con cui ha sostenuto il mio lavoro e stimola-to le mie riflessioni; Claudia Mattalucci, mia pazientissima mentore negli anni trascorsi all’Università di Milano-Bicocca; Ugo Fabietti che in molte occasioni e pur tra i mille impegni ha sempre avuto tempo e attenzione da dedicarmi; la storica Oksana Dovgopolova e la filosofa Irina Potapova dell’Università Mechnikov di Odessa, per aver accompagnato con grande disponibilità e amicizia la mia permanenza nella loro città e facilitato l’ac-cesso alle informazioni in parte contenute in queste pagine.
Un ringraziamento sincero e profondo va a Simonetta Grilli per il coin-volgente confronto intellettuale sulla seconda parte del manoscritto, a Le-onardo Piasere per avermi restituito con grande disponibilità osservazioni preziose sulla prima parte, a Pier Paolo Viazzo che ha letto la prima stesura del testo, incoraggiandomi con suggerimenti e idee, a Elisabetta Di Gio-vanni per il sostegno fornito da un diverso punto di vista, che ho apprez-zato molto.
Sono molto riconoscente a Giulia Spano, Patrizia Todde, Giuseppina Cuccui, Luigi Guiso, Liliana Pascucci, Maria Carmen Ghiani, Salvatore Spano, Maria Busia e a tutti i responsabili e gli operatori dei servizi per le adozioni della Gallura che con la loro cordiale partecipazione hanno reso possibile questa stesura del libro.
Un grazie particolare va Francesca Nicola per aver condiviso idee, con-siderazioni e osservazioni durante il nostro comune percorso e a Chia-ra Freschi che ha curato il progetto grafico in copertina, restituendo con grande estro una sintesi iconografica delle idee che scorrono tra le pagine nel testo. Soprattutto, questo libro è dedicato a tutte le famiglie che mi hanno accolto nelle loro case con ospitalità, simpatia e affetto, alle adottive e agli adottivi con cui ho stretto un rapporto che, in gran parte dei casi, è proseguito oltre la ricerca, a tutti loro devo un profondo ringraziamento per il tempo che mi hanno dedicato e per aver condiviso molti aspetti della loro quotidianità. E un ricordo speciale va alle vite straordinarie di coloro che sono venuti a mancare durante la ricerca: certamente queste pagine non rendono loro giustizia, ma spero che restituiscano almeno in parte un poco della loro ricchezza.
*** Tutte le citazioni dei testi in lingua inglese e non tradotti in edizione italiana sono stati tradotti dall’autrice. Nei testi citati in formato Kindle le pagine si riferiscono alle posizioni sul dispositivo.
°°° Il presente lavoro è scritto secondo le vigenti norme sulla privacy e sul copyright.
XVII
introdUzione
Ma davvero agli uomini intressa qualcos’altro che vivere? Tonino e Gra-ziella si sposano. Del loro amore essi sanno che è amore […] Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli.
(Pasolini 1963)
Sotto l’ombrellone una giovane donna sta raccontando ad un amico i problemi con i parenti di lei e del marito.“Conta solo tuo figlio … e il tuo compagno, tuo marito, perché ci vivi insieme”, commenta l’uomo a conclusione della confidenza. “Nessuna famiglia è perfetta!” conclude con un sospiro la donna.
(Gallura 2013)
Nel 1972 l’editore Einaudi pubblicò “La morte della famiglia” dello psichiatra inglese David Cooper. Quando mia madre vide il libro in giro per casa cominciò a strillare come una forsennata che volevo distruggere la famiglia (in generale, e la “sua” in particolare). In realtà, la sua vivace reazione non era del tutto fuori luogo visto l’impegno che gran parte della mia generazione (me compresa) aveva investito in questa direzione. Ma la famiglia, ovviamente, non è affatto morta. Anzi, sembra godere di ottima salute, per quanto mia madre (a volte) stenti davvero a riconoscerla. Ma pare meno preoccupata di un tempo, quasi sia velatamente consapevole che “le nuove idee possono svilupparsi solo dai loro antecedenti” (Stra-thern 1992a, 11), e dal suo punto vista ormai non è così importante in che modo viene fatta la famiglia - per quanto una certa tradizionale “corrispon-denza” non guasti - l’importante è riconoscere di cosa è fatta, come dire che la tradizione può essere reinventata ad ogni cambiamento (Ibidem).
Se la famiglia è un’idea, come le affermazioni di mia madre sembrano indicare, allora lei ha progressivamente operato una diversa naturalizzazio-ne degli elementi che fanno o non fanno la famiglia (cfr. Schneider 1980, 3), trasformando così la sua precedente rappresentazione Uno sforzo non trascurabile – mia madre ha vissuto la sua vita familiare e la sua iniziale esperienza matrimoniale in un sistema rurale patrilocale –, ma come gran parte della sua generazione si è conformata ai cambiamenti sociali e alle di-verse ideazioni condivise che si sono stratificati nel corso di cinquant’anni in una nuova comunità di vita e in una “nuova” famiglia nucleare forgiate
XVIII
Affetti da adozione
dalla migrazione, dall’industrializzazione e dalla crescente statalizzazione di alcuni ruoli familiari (cfr. Segalen 1986; Barbagli 1984).
Tuttavia, nella progressione delle trasformazioni che l’hanno coinvolta, una condizione ideazionale è rimasta saldamente in piedi: perché la sua azione di riconoscimento della famiglia si manifesti è necessaria la presenza (fenomenologica) di un figlio. Questa visione è così diffusa che molte cop-pie, clinicamente istituite come sterili, sono fortemente inclini a cercare un figlio del tutto “estraneo” pur di appagare l’intenso desiderio di creare una famiglia. E non solo, o non più, per acquisire un abito sociale conforme (Bourdieu 1996), ma per vivere l’amore di un figlio, poiché il valore stru-mentale dei figli è stato ampiamente sostituito dal loro “valore espressivo” (expressive value) (Scheper-Hughes, Sargent 1998, 12): diventati economi-camente inutili per i loro genitori, oggi essi sono inestimabili in termini di valore psicologico (cfr. Gauchet 2010).
Questo libro è un modesto contributo al dibattito, sempre rinnovato, di cosa sia – e cosa stia diventando - la famiglia in Italia. Utilizzando la lente dell’apparentamento adottivo, un’indagine etnografica minuta e una prospettiva antropologica, cercherò di illustrare come, a partire dall’idea di procreazione, la famiglia possa essere descritta per la sua “misteriosa effi-cacia” relazionale (Viveiros de Castro 2009, 247) che rende i parenti sim-bolicamente ed emozionalmente capaci di compenetrare l’uno l’esistenza dell’altro. L’attenzione è dunque rivolta al processo di creazione delle re-lazioni transpersonali dell’essere e dell’esperienza restituito dal punto di vista delle persone che ne sono direttamente coinvolte, all’interno di una relazione di parentela ontologicamente connotata dall’iniziale completa estraneità tra coloro che sono resi parenti “per legge”.
Se la procreazione è stata lungamente individuata come “la proprietà” che “fa” la parentela (cfr Schneider 1980), è anche vero che non tutte le società - e nella società euro-americana odierna non tutte le persone - as-segnano a questo evento, e alle idee ad esso correlate, un significato me-ramente biologico (Sahlins 2013). Di conseguenza, questa è la sfida che si è posta agli studi della parentela negli ultimi trent’anni, ovvero come analizzare i fatti sociali che si presentano agli occhi degli studiosi sottofor-ma di famiglie “ricomposte”, di parentela adottiva, di maternità surrogata, di viaggi della fertilità, di tecnologie e/o azioni commerciali di creazione della famiglia, e molto altro. “Fatti” attraverso cui molte persone “fanno” famiglia, per quanto distanti possano apparire dalla biologia.
La deriva verso gli attributi sociali della parentela non dovrebbe sor-prendere, dal momento che nelle società occidentali l’idea stessa di paren-tela è un “ibrido” fatto di sangue, sentimento e condotte che possiede la capacità di connettere i due ambiti, della biologia e del sociale, o meglio di
XIX
Introduzione
produrre un fatto della società radicato nei fatti di natura (Strathern 1992, 16-7; cfr. anche Sahlins 2011; Franklin, Ragonè 1998). Le indagini e le ri-flessioni scaturite dalla corrente di pensiero dei cosiddetti Critical Kinship Studies1 hanno mostrato che se per molto tempo l’ideologia dominante ri-guardo i legami di parentela ha reso il sangue più denso dell’acqua, oggi le persone sono più orientate a fare esperimenti di parentela e di vita cercan-do costantemente una coerenza significativa tra ciò che è dato per scontato e ciò che è intenzionalmente fabbricato e inventando soluzioni creative attraverso cui modellare la propria soggettività di parenti che consenta loro di riconoscersi ed essere riconosciuti come tali all’interno della comunità di appartenenza.
Gli elementi che sembrano accomunare questi esperimenti sono la for-te intenzionalità degli attori nel fare famiglia e il (consapevole) carattere negoziale delle relazioni di parentela così create (cfr. Weeks et al. 2001; Weston 1991). Attributi costitutivi della famiglia “post-familiare”, la loro presenza, sempre più diffusa, informa che il modello ordinario di famiglia ha perduto la sua precedente posizione dominante: al suo posto ora ci sono diverse idee di normalità familiare, in competizione tra loro, ma tutte ugualmente impegnate a conquistare ed asserire una loro legittimità sociale (cfr Beck-Gernsheim 2013). Sono forme di famiglia fondate sulle relazioni elettive che le persone praticano e sentono e che scaturiscono non tanto, o non soltanto, dalla costrizione giuridica (o biologica) ma da una affinità di bisogni e da una “mutualità dell’essere” (Sahlins 2011, 2013) attraverso cui possono dar vita ad innumerevoli sfumature all’interno o all’esterno della tradizionale rete di connessioni che individua la famiglia.
Il movimento delle rappresentazioni e delle pratiche quotidiane che sot-tende questi nuovi arrangiamenti di famiglia viene a collocarsi all’interno di una cornice globale che cattura persone, idee, tecnologie, denaro, infor-mazioni e le connette in modi finora sconosciuti (cfr. Ong, Collier 2005). Aspetti particolarmente significativi quando si parla di apparentamento adottivo, laddove lo stravolgimento dell’ordine della domanda e dell’of-ferta tra aspiranti genitori e bambini disponibili in molti paesi occidentali, primo fra tutti l’Italia, ha imposto di ri-orientare la richiesta di figli verso altri paesi, resi inclini a rinunciare a parte del loro “futuro” demografico da complesse relazioni ed esercizi di potere tra Nord e Sud del mondo2.
1 Penso, nello specifico, a quella corrente di pensiero che, raccogliendo in parte l’eredità intellettuale dell’an-tropologia femminista, si è mostrata particolarmente attenta nel riesaminare la cornice teoretica attraverso cui comprendere le trasformazioni attuali della famiglia e della parentela: tra gli altri cfr. Bamford, Leach 2009; Carsten 2004, 2000a; Franklin, McKinnon 2001; Franklin, Ragonè 1998; Strathern 1992a; Collier,Yanagisako 1987.2 Mi riferisco ad un Nord e un Sud ideologico e non geografico. D’altro canto tra i paesi che esportano bambini vi sono grandi differenze (ad esempio riguardo i tassi di natalità), ma tutti condividono una qualche forma di subalternità politico-economica verso i paesi che importano bambini.
XX
Affetti da adozione
Oggi gran parte del cosiddetto trasferimento adottivo si produce attra-verso un flusso unidirezionale transnazionale tra paesi “donatori” e paesi “riceventi”, e il tradizionale carattere di “circolazione” con cui molte so-cietà, anche europee, avevano individuato il movimento dei bambini da uno spazio domestico ad un altro (cfr. Bowie 2004, 3 e ss.) è stato rivestito di pratiche e significati del tutto diversi, più conformi all’attuale ideolo-gia neo-liberista della transazione consumistica (cfr. Faubion, Hamilton 2007). Un movimento che, tuttavia, conserva la capacità di un “processo formale specifico […] che in egual misura crea nuove relazioni e ridefinisce le reti di parentela” (Brady 1976, 64).
Tra il 1948 e il 2012 l’adozione transnazionale ha spostato da una parte all’altra del mondo oltre un milione di bambini, registrando valori nume-rici molto importanti nel periodo 1992-2008 che hanno definitivamente svelato la sua natura di “migrazione silenziosa”3. Naturalmente l’intrinseca fluidità del fenomeno ha stimolato e favorito nel tempo numerose, rilevan-ti trasformazioni (cfr. Howell 2009), rendendo effettivamente “geopoliti-co” il personale quotidiano dei parenti “per legge”.
Uno degli aspetti trasformativi più efficace riguarda la normatizzazione della “circolazione” transnazionale dei bambini la cui pratica viene sottrat-ta all’azione personale (degli aspiranti genitori, degli intermediari, delle famiglie biologiche) per essere governata attraverso il reticolato delle di-sposizioni legislative internazionali e locali. Dal 1993, anno di istituzione della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (hcch), (quasi) tutti i paesi di acco-glienza e i paesi di provenienza si sono conformati o sono stati costretti a conformarsi alle sue raccomandazioni sovranazionali (cfr. Di Silvio 2008). Questa operazione normativa, imposta nel nome della tutela del bambino, ha significato in modo importante la traduzione e l’imposizione globale del principio fondante il dispositivo dell’adozione (nazionale) occidentale, il cosiddetto “clean break” (Duncan 1993, 52), ovvero la rescissione com-pleta dei legami di nascita, andando di fatto a scardinare in molti paesi (di origine) le tradizionali pratiche di circolazione dei bambini tra spazi domestici diversi.
Un secondo aspetto, altrettanto rilevante, riguarda la correlazione tra adozione internazionale e autodeterminazione dei paesi coinvolti nel tra-sferimento. Le possibilità di accesso ai bambini, infatti, sono progressiva-mente mutate man mano che i paesi di origine acquisivano una maggiore autorevolezza economica e dunque un maggior peso nella scacchiera ge-opolitica globale. Nel campo adottivo questo diverso posizionamento si 3 Gli studi di Peter Selman (2013, 2012a, 2012b, 2009a, 2009b) forniscono un’accurata disamina del fe-nomeno dal punto di vista della demografia sociale. Per uno sguardo storico cfr. Kane 1993. Sulla specificità italiana cfr. Di Silvio 2008.
XXI
Introduzione
è declinato sia in una limitazione del numero di bambini resi disponibili al trasferimento internazionale, sia (e soprattutto) nella individuazione (o esercizio di scelta) di una particolare tipologia dei bambini da offrire alle coppie occidentali, segnatamente bambini poco accattivanti per soddisfa-re il desiderio di filiazione delle aspiranti coppie adottive locali: bambini grandi, con fratelli, di carnagione scura, con disabilità più o meno rever-sibili4.
Infine, anche le coppie che decidono di adottare mostrano i segni un progressivo cambiamento. Per quanto risoluti, questi aspiranti genitori ap-paiono più consapevoli dell’intrigo globale in cui è preso in mezzo il loro desiderio di fare famiglia. Il loro disincanto traspare nel decremento delle richieste, registrato di recente in tutti i paesi riceventi (ma non così signi-ficativo in Italia) (cfr. Selman 2012b, 2009a), nella preoccupazione sulle condizioni del bambino che andranno ad affiliare, nella diffidenza verso gli intermediari autorizzati, in definitiva nella cognizione (fenomenologica) che il bambino quale “dono gratuito”, istituito dalla perdurante retorica adottiva occidentale, si è velocemente trasformato in “dono ingannevole” poiché segue apertamente la più classica delle regole del mercato secondo cui la “merce” più rara possiede un valore (e un prezzo) maggiore (cfr. Briggs 2013).
L’improvviso, veloce incremento dell’adozione transnazionale ha ri-svegliato l’interesse dell’antropologia sull’argomento, andando a colmare quella lacuna che aveva lungamente marginalizzato le pratiche adottive all’interno degli studi classici di parentela, laddove venivano intese come strumenti di fabbricazione di una parentela “fittizia” (cfr. Bowie 2004; Go-ody 1968).
Il dibattito, molto ricco ed articolato, si è focalizzato soprattutto sugli effetti che un “assemblaggio” (Ong, Collier 2005, 117) familiare di que-sta natura5 produce nei paesi di arrivo sul processo di riconoscimento e legittimazione sociale della famiglia così creata. Una famiglia istituita in definitiva come un “as-if ”, un “come se” (cfr. Di Silvio 2008; Briggs, Marre 2009; Modell 1994), con cui (ri)affermare la (presunta) analogia tra fami-glia adottiva e biologica. All’interno di questo focus più generale, alcuni
4 Ad esempio, Russia e Cina, che a partire dalla fine del XX secolo hanno sostituito i tradizionali serbatoi adottivi di Brasile (America Latina) e India, non solo hanno progressivamente contratto le loro disponibilità ma hanno anche imposto regole proprie sulla “qualità” delle coppie richiedenti e dei bambini disponibili. Infatti, non è un caso che oggi gran parte dei (pochi) bambini piccoli e sani provengano da quei paesi in cui l’istituzione dell’adozione nazionale è ancora un miraggio, come ad esempio i paesi del Sud-Est asiatico e i paesi africani.5 Esplorando i cambiamenti associati alla globalizzazione, le autrici sostengono che una specifica gamma di fenomeni quali le tecno-scienze, i circuiti di scambio leciti e illeciti, i sistemi di governance e i regimi etico/valoriali – tutti fenomeni molto attivi nella transazione adottiva globale - sono articolati in situazioni particolari , o territorializzati in assemblaggi, che diventano ambiti in cui le forme e i valori dell’esistenza individuale e collettiva sono problematizzati o comunque messi in gioco.
XXII
Affetti da adozione
ricercatori hanno maggiormente esplorato le questioni relative all’intreccio razziale tra genitori e figli e ai suoi effetti sul piano personale e sociale (cfr. Yngvesson 2010, 2004, 2000; Dorrow 2006; Gailey 2000); altri hanno indagato i modelli condivisi di costruzione della famiglia da parte degli attori sociali coinvolti (segnatamente operatori sociali e aspiranti genito-ri), caratterizzati da un elevato livello emozionale spesso accompagnato da “pensiero magico” e dall’idea di “destino” (cfr. Howell 2007; Howell, Mar-re 2006; Yngvesson 2005); altri ancora hanno analizzato in termini criti-ci l’azione messa in campo dal dispositivo adottivo occidentale, dai suoi principi e dalle sue norme sovranazionali (cfr. Smolin 2010; Briggs, Marre 2009; Hübinette 2004a; Briggs 2003), e più di recente hanno analizzato le questioni connesse alle origini e alle identità transnazionali degli adottivi (cfr. Di Silvio 2013a; Howell, Melhuus 2007). Infine alcune voci estre-mamente stimolanti hanno esplorato il punto di vista delle comunità di provenienza dei bambini (cfr. Hübinette 2006b; Fonseca 2004, 2002), ri-marcando l’esercizio “neo-colonialista” messo in atto dall’imposizione ege-monica del dispositivo adottivo occidentale (cfr. Hübinette 2004a), laddo-ve la soddisfazione del desiderio delle coppie comporta il dislocamento di numeri considerevoli di bambini istituiti come adottabili (cfr. Swain 2012) e la rescissione definitiva di tutti i legami di origine, familiari e nazionali, secondo il principio del “clean-break”. Lo “svuotamento” sociale così pro-dotto rende la condizione del bambino assimilabile a quella dei suoi futuri genitori e al loro “vuoto” generativo, un’analogia che consente di assegnare un valore simbolico molto alto al concetto fondante l’adozione euro-a-mericana contemporanea di “seconda nascita, unica nascita” e, allo stesso tempo, di riaffermare una visione del bambino come “tabula rasa”, tuttora dominante benché discorsivamente defilata.
Pur illustrando uno scenario molto ricco e stimolante, gran parte degli studi condotti sull’adozione transnazionale restituiscono una prospettiva etica del fenomeno, ovvero una sua rappresentazione dal punto di vista del ricercatore, mentre i contributi che illustrano “il punto di vista del nativo” utilizzando una prospettiva emica dell’oggetto/soggetto di studio appaio-no decisamente più sporadici. E anche laddove alcune ricercatrici hanno raccolto osservazioni interessanti dall’“interno” della famiglia utilizzando il proprio sguardo di madri adottive, illustrando in tal modo uno scenario molto più complesso di quanto altrove tratteggiato (cfr. Yngvesson 2010; Howell 2007, 2006), la loro elevata (e inevitabile) densità empatica con luoghi e persone sembra, in alcuni passaggi, opacizzare lo sforzo riflessivo condotto sull’esperienza (auto)etnografica (cfr. Taylor 2011; Okely, Cal-laway 1992).
XXIII
Introduzione
In Italia l’adozione è un dispositivo normativo che ha lo scopo di assicu-rare ad ogni bambino una famiglia6: adottare non è un diritto degli adulti - che possono semplicemente dichiararsi disponibili e sottoporsi, a questo scopo, all’accertamento della propria idoneità - ma risponde al diritto di ogni bambino di avere (e non, si badi bene, di crescere in) una famiglia. L’accesso all’idoneità è un aspetto particolarmente rilevante dell’esperienza di vita degli aspiranti genitori italiani: oltre al possesso di specifici pre-re-quisiti (età, convivenza/matrimonio rigorosamente eterosessuale, reddito) è loro richiesto di sottoporsi ad un lungo e impegnativo “percorso adot-tivo” (così denominato dagli operatori sociali e per estensione dalle stesse coppie) che prevede approfondite indagini riguardo lo spazio intimo della relazione coniugale, la casa e la posizione socio-economica della coppia - finalizzate a delineare una sorta di predittività del futuro apparentamento - e uno specifico addestramento alla genitorialità adottiva sotto la supervi-sione dei servizi e/o delle agenzie (enti o associazioni di famiglie) preposti allo scopo.
La ratifica della Convenzione dell’Aja (1998) ha portato all’istituzio-ne della Commissione per le Adozioni Internazionali (cai) che, in modo significativo, fa capo direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Mini-stri7. Sul piano locale la cai governa e monitora la domanda transnazionale di figli adottivi attraverso specifiche istituzioni pubbliche appropriatamen-te professionalizzate, di cui incentiva la costante formazione, primi fra tutti i Tribunali per i Minorenni e i servizi psico-sociali territoriali che sono chiamati a valutare la “disponibilità” all’adozione delle coppie e a sancire la loro idoneità di futuri genitori adottivi. Sul piano globale la commis-sione stringe accordi bilaterali con nuovi “fornitori” di bambini o integra in senso “etico” accordi già in essere - ad esempio laddove vi siano dubbi di trasparenza o di trafficking (cfr. Gilioli 2007) -, raccoglie e organizza il materiale statistico inerente il quadro dell’adozione internazionale in Italia e soprattutto individua e istituisce, secondo specifici criteri, gli interme-diari adottivi, in Italia denominati enti autorizzati, i quali esercitano in via esclusiva l’indispensabile attività di mediazione tra le istituzioni dei paesi di provenienza dei bambini (orfanotrofi, autorità giudiziaria, ecc.) e le cop-
6 Cfr. online: http://www.tribunaledeiminori.it/adozione.php. In Italia l’adozione nazionale, chiamata “legit-timante”, è diffusa e normata da tempo (Legge 184/1983 e successive integrazioni) secondo il principio della rescissione completa dei legami di origine e della creazione giuridica di un legame esclusivo, mimetico al legame familiare biologico. La rilevante contrazione delle nascite ha reso tuttavia l’adozione domestica un evento molto raro, per quanto numerose coppie continuino tuttora ad avanzare richiesta in tal senso, dando vita di fatto allo scenario contemporaneo delle adozioni transnazionali. 7 Sin dalla fine dell’ultimo conflitto mondiale, l’adozione internazionale ha rappresentato un piccolo ma signifi-cativo aspetto delle relazioni internazionali, ampliando progressivamente la sua portata. Inizialmente sono stati coinvolti soprattutto gli Stati Uniti, ma in successione la questione ha interessato tutti i paesi implicati nella transazione adottiva, siano essi riceventi o donatori.
XXIV
Affetti da adozione
pie richiedenti, quale unico strumento che consentirà a quel particolare bambino di prendere la via di “casa”8.
Nell’ambito dei paesi di accoglienza, l’Italia presenta una giustappo-sizione distintiva tra il quadro relativo all’andamento della popolazione fornito dall’Istituto Nazionale di Statistica (istat)9 e il panorama dell’a-dozione, segnatamente transnazionale, tratteggiato dalla cai. Al di là del dato di pubblico dominio sul crollo della natalità10, argomento di grande interesse accademico, politico e mediatico, ciò che colpisce maggiormente è il quadro della rapidità della progressione storica dell’implosione demo-grafica, che dà conto, in un certo senso, sia dell’urgenza politica di pratiche di “ingegneria sociale” (cfr. Melosh 2002), come l’adozione transnazionale, sia dell’azzardo (sociale) contenuto in questo esperimento.
Il censimento del 2011 mostra che negli ultimi quarant’anni la famiglia italiana ha cambiato aspetto in modo rapido e sostanziale (cfr. Barbagli et al. 2004; Gini, Caranti 1954), un processo che sembra aver coinvolto in ugual modo tutte le aree della penisola. Tra gli elementi più rilevanti le previsioni demografiche di (de)natalità hanno naturalmente suscitato una grande apprensione pubblica, per quanto in Italia la tradizionale centralità della famiglia appare ormai più una necessità (economica) che un costu-me inossidabile. L’analisi dei dati della cai (2013) contribuisce, seppur indirettamente, ad individuare alcune strategie messe in atto da una parte significativa delle coppie italiane – oltre 70.000 negli ultimi trent’anni (cfr. Selman 2013) – per fronteggiare il desiderio generativo utilizzando il mo-derno idioma dell’amore tra genitori e figli.
Vediamo innanzitutto quali tratti andrebbero ad individuare le nuo-ve famiglie che vengono istituite attraverso l’adozione transnazionale. La grande maggioranza delle coppie che desiderano adottare appaiono mo-tivate dal desiderio di diventare genitori a fronte dell’impossibilità a pro-creare dettata dall’infertilità, mentre una parte più limitata - e in sensibile contrazione rispetto agli anni precedenti - è spinta da ragioni umanitarie, soprattutto nelle seconde adozioni. In qualche modo un segno del cambia-mento in direzione di una maggiore “secolarizzazione” dei sentimenti che spingono a desiderare un figlio “estraneo”.
8 Gli enti autorizzati censiti sono oltre sessanta, un numero esageratamente elevato rispetto ad organismi del tutto analoghi presenti in altri paesi d’accoglienza europei. Spesso nei confronti di questi organismi emergono contestazioni sia sul piano della trasparenza dei costi che sul piano del metodo (a titolo esemplificativo cfr. online http://www.italiaadozioni.it/?p=5262). 9 Cfr. online: http://dati-censimentopopolazione.istat.it/#.10 Un interessante contributo (Krause 2012) sottolinea come in Italia la decisa contrazione della fertilità sia ac-compagnata da una “curiosa” limitazione dell’intenzionalità nel programmare la nascita di un figlio. Gli aspetti discussi nell’articolo sembrano contraddire le riflessioni di altri studiosi (cfr Gauchet 2010) sulla preminenza della volontà nel diventare genitore, oppure, più verosimilmente, mostrano la natura antinomica della famiglia italiana contemporanea, tuttora in movimento tra ciò che è stata e ciò che è diventata o diventerà.
XXV
Introduzione
Gli aspiranti genitori hanno un’istruzione ed una posizione socio-eco-nomica elevati, sono piuttosto “anziani” (in media oltre i 45 anni) e sono orientati verso il figlio unico, per quanto molti di loro abbiano accolto, soprattutto negli anni scorsi, due fratelli11. Queste future famiglie abitano in netta prevalenza nelle regioni più ricche del Nord della penisola, soprat-tutto in Lombardia, ma stanno diventando progressivamente numerose anche nelle regioni del Sud12. Una volta ricevuta l’idoneità ad adottare dal competente Tribunale per i Minorenni, gli aspiranti genitori vanno alla ricerca del “proprio” figlio, una ricerca che può durare alcuni mesi ma anche protrarsi per qualche anno. I figli “destinati” provengono da quattro continenti (Europa dell’Est, Africa, Asia e America Latina) e in prospettiva ci si attende che siano sempre più africani e asiatici e sempre meno lati-no-americani o europei, un dato che conferma una sostanziale inversione di tendenza rispetto alle provenienze precedenti. Sono in netta prevalenza maschi, hanno un’età media di cinque anni e mezzo e provengono da una condizione per cui – come riassumeva una mamma adottiva – “orfani non ce ne sono più, i bambini o sono lasciati o sono tolti”. Lasciati dai parenti di nascita o allontanati dalla famiglia per intervento dello Stato, secondo le informazioni della cai i futuri figli restano in media due anni in una strut-tura per l’infanzia prima di essere immessi nel sistema adottivo internazio-nale. Molti di loro, in costante aumento, sono portatori di patologie gravi e irreversibili (bisogni speciali) oppure di sofferenze psico-fisiche trattabili e reversibili (bisogni particolari).
Non occorre sottolineare quanto possa apparire audace questo genere di assemblaggio di famiglia, tanto nella lente fornita dai paradigmi degli studi classici di antropologia della parentela quanto allo sguardo della comunità di appartenenza di queste nuove famiglie. A ciò si aggiungano le disposi-zioni incorporate che gli aspiranti genitori condividono in quanto membri del proprio gruppo sociale e il sentimento di estraneità che i bambini, so-prattutto se grandicelli, manifestano al loro arrivo. Dunque non sorpren-de se, nonostante l’adozione sia diventata un evento familiare (ognuno di noi ha tra i suoi conoscenti qualcuno direttamente o indirettamente coinvolto in questa esperienza) essa continua a suscitare in chi guarda una velata diffidenza, anche tra gli stessi operatori che la istituiscono, certi che il legame a cui la legge ha dato vita si rivelerà, in definitiva, una connes-
11 L’elevato tasso di infertilità è in gran parte di natura esogena (matrimonio tardivo, lunga attesa per la prima gravidanza, ecc.), un fenomeno ampiamente studiato dalle scienze demo-sociologiche (cfr. De Sandre et al. 1997). Questa condizione oggettiva, presentata dalle coppie al momento di adottare, rende gli aspiranti genitori italiani più “nonni” che genitori agli occhi dei futuri figli, i quali spesso provengono da contesti in cui le condi-zioni socio-economiche e culturali favoriscono gravidanze molto precoci.12 Rispetto agli ingressi vi sono aree che di recente hanno subito flessioni, come la Lombardia (-13,3%), e aree che hanno segnalato un incremento, come la Sardegna (+12,8%), variazioni che complessivamente non hanno modificato di molto la posizione preminente dell’Italia nell’accoglienza adottiva (cfr. cai 2013).
XXVI
Affetti da adozione
sione intrinsecamente fragile e alienante. E tuttavia, vista da vicino, questa connessione, seppur impegnativa, non appare così frammentata, pronta a disfarsi in ogni momento, rivelando di fatto uno scarto tra le attese di-sposizionalmente condivise e l’esperienza viva del fare famiglia attraverso l’adozione transnazionale (cfr. Howell 2009).
Come le altre forme di parentela contemporanea, la famiglia adottiva transnazionale manifesta la sua particolare natura post-familiare laddove, per darsi, trasgredisce i confini e le norme del modello consuetudinario di famiglia e parentela, che nel suo caso particolare riguarda lo scontato isomorfismo razza-parentela-nazione, un tradimento rilevante che, “natu-ralmente”, richiede un risarcimento molto alto sul piano della piena legit-timazione personale e sociale.
Nel mio studio con le famiglie dell’area metropolitana del Milanese e del Gallurese ho cercato di esplorare in che modo genitori e figli ( ma an-che nonni/zii/nipoti,cugini, ecc.) “per legge” riescono a trasformare l’estra-neità iniziale nella perdurante intimità e nella mutualità che rende parenti e se vi sono elementi comparativi interessanti attraverso cui argomentare una specificità regionale dell’esistenza e dell’azione di patrimoni familiari diversi che intervengono nel processo di apparentamento adottivo.
Quest’ultima considerazione può richiamare, sul piano delle differen-ziazioni socio-culturali e delle discontinuità temporali, la particolare di-namica dicotomica centro-periferia con cui è stata spesso individuata la relazione tra Europa nord-occidentale e area mediterranea (cfr. Boissevan 1979). Senza voler aprire un fronte analitico-riflessivo troppo complesso, la cui trattazione richiederebbe uno spazio dedicato, vorrei in ogni caso ricordare che quando ci si immerge nell’investigazione delle tematiche di famiglia e di parentela delle società del sud dell’Europa, non si può non imbattersi in quella nozione di “distintività mediterranea” così come è stata (variamente) argomentata dai numerosi studi delle società mediterranee (cfr. Piña Cabral 1989; Herzfeld 1984; Gilmore 1982). Studi che presen-tano non poche limitazioni, ma che, in alcuni casi, offrono stimoli interes-santi per la comprensione (e la comparazione) critica della vita quotidiana dei membri di queste comunità sociali nel presente, laddove viene cattura-ta nella sua specifica processazione storica (cfr. Piña Cabral 2013).
Nelle prossime pagine, il lettore verrà accompagnato dentro il mondo denso dell’ordinarietà della vita familiare, uno scivoloso amalgama di pra-tiche, saperi e affetti che dà al vivere quotidiano la qualità di un continuo, ininterrotto movimento di relazioni, coreografie, contingenze ed emergen-ze. Sono “le cose che succedono” (Stewart 2007, 2), i fatti della vita, che si producono sottoforma di desideri, sensazioni, aspettative, immaginari, incontri e abitudini relazionali, di strategie e loro fallimenti, di attenzione,
XXVII
Introduzione
connessioni e agency13, e che circolano nei mondi sociali mentre, contem-poraneamente, intessono la trama della vita intima delle persone. In par-ticolare, gli affetti ordinari, che in questo testo hanno voce tanto quanto le pratiche quotidiane e i saperi incorporati, raccolgono densità quando si muovono attraverso corpi, sogni, drammi e mondi sociali di qualunque genere. La loro significatività nell’apparentamento adottivo (e non solo) traspare nell’intensità relazionale che costruiscono e in quali pensieri ed emozioni rendono possibili.
Dunque, pensare la parentela adottiva solo in termini di “mancanza” – del legame di sangue, della capacità di procreare, della famiglia di nascita –, portando in primo piano la marginalità sociale delle famiglie e l’aliena-zione individuale dei parenti, non illustra in profondità l’esperienza delle persone coinvolte. Viceversa, il farsi parenti tra estranei è molto più di que-sto, tanto per il bambino quanto per i neo-genitori: è la capacità di gestire simultaneamente disconnessioni e connessioni delle relazioni concettuali e interpersonali, ovvero la capacità di governare ciò che è dato (dall’origine/dall’infertilità) e ciò che viene creato (dall’arrivo del bambino) riguardo un certo modo di riconoscere il mondo e un certo modo di riconoscere i parenti (Strathern 2005).
Per focalizzare in che modo questi parenti creano affetti e pratiche or-dinarie di famiglia, ho cercato di indagare la traccia delle relazioni nella loro dimensione diacronica – delle disconnessioni all’origine e della ri-composizione all’arrivo – del modo in cui questo movimento cattura le persone nel processo di costruzione negoziata delle soggettività, dei ruoli, dei sentimenti familiari. Ho osservato il fermento emozionale degli “acco-modamenti” messi in opera dalle famiglie, del modo in cui le persone si scoprivano contemporaneamente connesse alla loro vita precedente e alla vita che stavano creando e vivendo come parenti adottivi. Ho anche cerca-to di comprendere le disposizioni interne dei neo-parenti, i loro costrutti ideazionali e il loro immaginario, analizzando come questi avessero dato forma all’atto di adottare (o di essere adottati), ma anche esplorando lo sforzo operato su di essi per rendere la forma del mondo più appropriata alle esigenze attuali della loro particolare esperienza di apparentamento. E in ragione della relazione interpersonale che mi ha consentito l’accesso alla “casa”, ho partecipato a numerosi rituali e segmenti significativi della loro vita quotidiana, raccolto testimonianze e narrazioni che mi hanno fornito una preziosa prospettiva su come le famiglie “pensino” il tempo per adden-sare la trama delle loro relazioni più intime.
13 Intesa come capacità sociale e semiotica - a volte definita in termini di scelta, intenzione, volontà, autocon-sapevolezza - più o meno flessibile, che consente alla persona (o attore sociale) di individuare attraverso quali e quanti strumenti raggiungere uno o più obiettivi (cfr. Kockelman 2007).
XXVIII
Affetti da adozione
L’indagine, condotta tra il 2010 e il 2014, ha visto la partecipazione di quindici famiglie, prevalentemente del milanese e alcune del gallurese, e di dieci giovani adottivi transnazionali “non accompagnati” arrivati in Italia tra la fine degli anni ’70 e la metà degli anni ’80 del secolo scorso.
Tra le famiglie, le prime abitano un territorio metropolitano che registra il più elevato numero di accoglienze adottive e la più vivace presenza di as-sociazioni di famiglie adottive a livello nazionale. La specificità di quest’area conserva ancor oggi le tracce di quell’evento sociale di portata storica che, nel corso degli anni ‘60 e ’70 del Novecento, aveva registrato il trasferimen-to di rilevanti porzioni della popolazione dal Sud al Nord della penisola, riconfigurando profondamente il contesto socio-culturale di interi territori, le relazioni inter-regionali e il senso di appartenenza delle persone (cfr. Berta 2008; Alasia, Montaldi 1975). Le seconde vivono in prevalenza all’interno della municipalità del comune capoluogo della Gallura e in alcune località limitrofe. La loro tipologia comprende famiglie più nuove al matrimonio tardivo e alla bassa natalità rispetto alle famiglie del milanese (cfr. De Sandre et al. 1997) ma il loro numero sta guadagnando velocemente terreno, come mostrano i dati del censimento del 2011 e le informazioni provenienti dalla cai, dati che sembrano in larga parte scardinare, o quanto meno riconfi-gurare, anche localmente, quell’idea di famiglia mediterranea fondata sul valore della consanguineità e la forte generatività a lungo istanziata dalla stessa letteratura antropologica14. Il numero di famiglie adottive presenti in questo territorio si è velocemente moltiplicato nell’ultimo decennio: la trasformazione demo-socio-culturale di cui sono espressione è infatti più recente rispetto a quelle del milanese, ed è avvenuta in tempi più rapidi, una condizione che in parte si riflette sul modo in cui creano le loro nuove famiglie e sulle difficoltà che si trovano a fronteggiare.
Le realtà familiari (e soggettive) che ho indagato sono complessivamen-te rappresentative dell’esperienza privata e pubblica dell’adozione in Italia e alcune delle loro ricche testimonianze di vita vengono restituite nelle pagine che seguono. Sono famiglie che presentano dimensioni diverse e una diversa partecipazione degli agnati e dei collaterali alla vita familiare; sono costituite prevalentemente attraverso l’adozione transnazionale ma non solo; i figli presentano caratteristiche diverse per numero, età all’in-gresso e genere, e le esperienze di vita familiare che ho approfondito nel corso della ricerca sono collocate in momenti temporalmente diversi del cosiddetto ciclo familiare. Infine, per quanto immersi in contesti storici, economici, sociali e culturali assunti come molto diversi tra loro, queste
14 La tradizionale società agropastorale della Sardegna è stata oggetto di numerosi studi etnografici, nazionali e internazionali, che ne hanno restituito un’immagine essenzialmente familistica dove la prossimità di sangue definisce il valore dei parenti e il numero dei parenti definisce il valore della famiglia sulla scena pubblica (cfr. Murru Corriga 2000; Pinna 1971).
XXIX
Introduzione
famiglie condividono numerose caratteristiche che li rendi del tutto simili e conformi al “modello” di genitori adottivi descritto dal report della cai.
Le famiglie sono variamente dislocate secondo distanze più o meno ampie e in generale non hanno rapporti tra loro. La loro unica connessione riguarda la condivisione di una comune esperienza di vita, quella di essere giuridicamente istituite attraverso un particolare dispositivo adottivo. Di fatto, più che di una “comunità sociale” di malinowskiana memoria si po-trebbe parlare di un “conglomerato occasionale” che deve la sua esistenza alla ricerca, o meglio allo sforzo della ricercatrice di fornirgli un corpo, una densità, assegnandogli una dimensione spazio-temporale nel momento in cui costruisce una rete attorno ad un interesse e, alla ricerca di risposte, fa di questa rete il suo oggetto di studio (cfr. Keane 2003). In questo caso – più che mai – il campo non si è configurato come una casa lontano da casa, e tuttavia la sua l’esperienza spaziale non solo permane ma è stata addirittura accentuata dalla multilocalità, dal continuo arrivare e partire, dal continuo rimando di connessioni e disconnessioni a luoghi e relazioni (cfr. Clifford 2008).
L’individuazione di famiglie disponibili ha richiesto l’attivazione di strategie diverse che, in una certa misura, hanno determinato se non la qualità certamente la profondità della relazione che è stata co-costruita con i testimoni durante il campo. Nel milanese le relazioni già in essere con le associazioni di famiglie adottive hanno facilitato i contatti, mentre la mia rete amicale ha contribuito a crearne di nuovi. Nel gallurese si è resa necessaria la mediazione dei servizi pubblici, un aspetto che ha (inevitabil-mente) influito sia sulla posizione che alcune famiglie mi hanno assegnato, più di tipo professionale, sia sulle mie possibilità di movimento all’interno della relazione che si è venuta a creare. In entrambi i casi, sono state so-prattutto le mamme a condividere con me gran parte del loro tempo di famiglia, dei loro commenti, considerazioni, memorie. Soprattutto, ma non esclusivamente.
Per quanto riguarda i giovani adottivi, la loro conoscenza deriva soprat-tutto da contatti personali, non solo recenti.
L’accesso agli aspetti più intimi dello spazio domestico ha richiesto una fase di negoziazione spesso prolungata, e in alcuni casi la relazione con il ricercatore non è andata oltre il comportamento riservato allo studioso: educato, moderatamente deferente, ma segnato dalla preoccupazione del giudizio e quindi di fatto reticente, modalità del tutto comprensibile in chi, come queste coppie, hanno sperimentato direttamente il valore di-scriminante della valutazione degli esperti. Come tutte le relazioni, an-che la relazione che si crea sul campo è frutto di un circuito ermeneutico attraverso cui i partecipanti modellano il loro posizionamento in base ad
XXX
Affetti da adozione
una pre-comprensione fornita dal contesto e da esperienze precedenti che presentano analogie con la situazione attuale. Ad esempio, per i neo-geni-tori galluresi il contesto adottivo è configurato dalla mancanza di attività associative che in un certo qual modo incrementa nelle coppie l’auto-per-cezione della difformità del loro apparentamento adottivo, mentre l’espe-rienza è forgiata dalla partecipazione a precedenti ricerche, condotte da o per conto di psicologi, in cui queste famiglie sono state coinvolte da quegli stessi operatori che ne hanno richiesto la disponibilità anche in questo caso. La connessione analogica è apparsa pertanto scontata15.
Anche laddove sono riuscita ad avviare una relazione più confidenziale, come è accaduto con gran parte delle famiglie, è emersa tutta la comples-sità dell’indagare, negli abiti di un estraneo, le cose di famiglia dentro la famiglia. Per vanificare almeno in parte questa sorta di ossimoro, queste famiglie mi hanno trasformata, in modo più o meno accentuato, in per-sona di famiglia. Tale operazione di familiarizzazione ha comportato quasi “istintivamente” l’adozione di una serie di condotte conformi da entrambe le parti – come lo scambio di doni natalizi, gli auguri e/o i doni di comple-anno soprattutto verso i bambini, le offerte di cibo cucinato di persona, gli inviti a feste e cerimonie di famiglia, un clima confidenziale nelle conver-sazioni – condotte che consentissero il reciproco riconoscimento dei nuovi posizionamenti16.
La relazione etnografica ha dunque costruito il campo seguendo il flus-so diacronico della narrazione biografica dei testimoni, laddove ciò che viene narrato (o osservato) è il risultato di un intenso lavorìo tra agency (e desiderio) individuale e necessità del sistema in cui queste persone sono immerse. L’osservazione e la partecipazione sono state condotte in alcuni siti che istituiscono la famiglia contemporanea: la casa innanzitutto, come contenitore di memorie, oggetti, relazioni, con la sua quotidianità, le sue ricorrenze, i suoi rituali ordinari e alcuni eventi eccezionali (matrimoni e lutti), le cene e/o i pranzi con amici e/o parenti, ma anche il parco giochi e/o la gelateria per la merenda dopo la scuola, le feste scolastiche, la pizze-ria, il carnevale, la festività di Santo Stefano. Con gli adolescenti e i giovani adottivi mi sono ritrovata meno spesso in casa e più di frequente all’aperi-tivo, in pizzeria, agli incontri associativi, ma anche in accompagnamento per la prova dell’abito da sposa.
15 Raramente sono stata invitata da queste famiglie nella loro abitazione, pur avendo utilizzato diversi stra-tagemmi per potervi accedere con una certa frequenza. Gli incontri con l’intera famiglia, anche ravvicinati e prolungati, sono avvenuti soprattutto in luoghi pubblici, per una pizza, una merenda o una passeggiata.16 In letteratura viene evidenziato come il posizionamento del ricercatore sia il risultato di una negoziazione con i propri testimoni tra ciò che viene assunto e ciò che viene assegnato. Questo sembra particolarmente rilevante nelle etnografie dentro le case delle famiglie dove i componenti spingono per “costruire” un ruolo al “professionista estraneo”, cercando di definire la situazione secondo i loro bisogni, le loro conoscenze e le loro esperienze (cfr. Jordan 2006).
XXXI
Introduzione
La scomposizione e ricomposizione della vita domestica ha richiesto strumenti epistemologici molto versatili in grado di cogliere gli innume-revoli elementi e le diverse stratificazioni di cui si compone e in cui si articola l’ordinarietà della vita di famiglia. Ad esempio, la descrizione feno-menologica - nel senso di registrare le cose come sono - mi ha permesso di rappresentare quegli assunti inesplorati che organizzano il coinvolgimento delle persone con la realtà. Diversamente da quanto accade nella parentela biologica, dove il tipo di relazione tra genitori e figlio è assunta a-priori dall’esperienza, i neo-parenti adottivi si trovano infatti nella condizione e nella necessità di “lavorare” intenzionalmente l’esperienza della relazione in un faccia-a-faccia quotidianamente reiterato che consenta loro di su-perare l’estraneità di partenza e, infine, di creare quella connessione che li definisce come genitori e figlio. In questo modo mettono a nudo i processi attraverso cui la “naturale attitudine” dell’essere genitori o figlio viene co-stituita (cfr. Desjarlais, Throop 2011)17. Indagare la relazione nell’apparen-tamento adottivo ha significato dunque registrare gli aspetti esperienziali – della consapevolezza, della corporeità, delle sensazioni percettive e della conoscenza – dei soggetti che la creano e la agiscono, investigando quel-le strutture della coscienza che contribuiscono a configurare l’esperienza, l’attribuzione di senso e la costituzione culturale del mondo in cui si abita (cfr. Throop, Murphy 2002).
Inoltre, nel caso adottivo, il comportamento esteriorizzato, ovvero il “te-sto” contenuto nel “discorso” delle pratiche del fare famiglia, è fortemente contaminato dall’esperienza soggettiva del “prima” dell’adozione, soprattutto da parte di figli già grandi (ma dei neo-genitori) che in qualche modo traducono nella nuova esistenza familiare elementi incorporati nel corso di precedenti stratificazioni del senso assegnato alla famiglia. Di con-seguenza, per restituire la comprensione del “testo” attuale e per rilevare gli sforzi concertati dei neo-parenti, tesi a modificare l’ordine della gerar-chizzazione dei significati tra ciò che viene portato e ciò che deve essere creato, è stato necessario porre in evidenza il dialogo tra il comportamento esteriorizzato e l’esperienza evocata dalle persone che agiscono quel com-portamento (cfr. Geertz 1998; Taylor 1989; Ricoeur 1971).
Infine l’aspetto narrativo, costitutivo di ogni legame familiare, emerge in modo rilevante nel processo del fare famiglia in adozione sin dalle sue prime battute. Infatti coloro che sono stati “abbinati” come genitori e figli “de-stinati” debbono costruire una storia di famiglia in cui le azioni sono rese significativamente coerenti all’intreccio narrativo in modo tale da restituire un’identità familiare e soggettiva riconoscibile tanto nello spazio domestico 17 Ad esempio, Amanda, una mamma adottiva, utilizza la frase “ci siamo annusate” per descrivere in modo metaforico ma molto esplicativo le prime fasi dell’esperienza di relazione con la figlia adottiva Aurora (Milano, 2012).
XXXII
Affetti da adozione
quanto sul piano sociale. Dunque, la narrazione in adozione non è solo de-scrizione di eventi o richiamo della memoria, ma è costitutivo della (nuova) vita e del (nuovo) tempo della famiglia, della connessione tra i neo-parenti e della loro soggettività (cfr. Kaplan 2008; Ricoeur 1986, 1971).
Accanto a questi macro-orientamenti teoretici, voglio ricordare gli sti-moli provenienti da altre prospettive analitiche che hanno consentito in modo particolare di indagare la specificità del legame adottivo contem-poraneo, laddove, ad esempio, il principio di esclusività della connessione tra genitori e figlio è posto sotto assedio dalla fluidità delle disconnessioni e delle riconnessioni vissuta dai neo-parenti (Strathern) o dove è possibile osservare una densità emozionale significativa anche in una relazione di famiglia priva dell’ “ombrello” di senso fornito dal principio del legame di sangue (Sahlins, Viveiros de Castro).
Descrivere la vita di famiglia, ovvero gli affetti e le pratiche ordinarie che hanno luogo in una casa, significa restituire una “polifonia” (concertata) composta non solo di parole, ma anche di gesti, modulazioni vocali, am-miccamenti, posture, in breve tutti quei segni coreografici che individuano l’idioma intimo della relazione tra genitori e figli o tra parenti stretti18. Di qui l’attenzione a restituire in modo diretto le voci dei soggetti catturate nella loro quotidianità, un’attenzione che tuttavia non può sfuggire al ca-rattere poietico che ogni scrittura porta con sé. Così nella descrizione, un certo uso del presente etnografico, quale tecnica di oggettivazione, si ac-compagna ad una maggiore attenzione alla contestualizzazione del “detto”, e anche, in alcuni passaggi, ad una più evidente presenza dell’io-autore. E se la costruzione interpretativa del testo etnografico comincia sul campo (Borutti 1999, 181), in questo studio la traduzione del “dire” in “detto” si è configurata attraverso un flusso testuale che segue l’ordine cognitivo – inteso come modo in cui i neo-parenti comprendono il loro legame – e sociale della cronologia di famiglia secondo la particolare messa in forma dell’esperienza familiare proposta dai testimoni.
Ho scelto dunque un approccio “biografico” che mi consentisse di argo-mentare la vita quotidiana di queste famiglie e dei loro membri in tutta la sua complessità e densità, a partire da uno “stadio” che potremmo definire “prenatale” (l’abbinamento tra futuri genitori e figlio) per seguire in succes-sione le varie fasi della vita degli adottati, delle loro famiglie e delle loro “pa-rentele” nelle reti relazionali e negli ambiti istituzionali in cui si collocano o si trovano ad essere immessi. Un approccio che cerca, come ho già detto,
18 Benché la corporeità sia assunta e costituisca un aspetto rilevante delle moderne relazioni di filiazione in Occidente (e non solo), la filiazione adottiva contemporanea connota il suo uso in modo specifico dal momento che la comunicazione non verbale rappresenta l’unico strumento del dire tra genitori e figli che, almeno inizial-mente, non condividono la medesima lingua e spesso neppure il medesimo ordine di significati da assegnare al detto.
XXXIII
Introduzione
di recuperare la dimensione diacronica delle testimonianze, ma anche una qualità dinamica con cui rimarcare la plasticità di questo tipo di apparen-tamento all’interno del variegato panorama di forme familiari, domesticità e composizione sociale oggi presente nella società italiana. E attraverso la scrittura ho voluto dare rilievo alle voci dei testimoni, le cui esperienze, sentimenti, condotte ho cercato di riportare anche in ampi stralci.
Questioni, quesiti e riflessioni prendono corpo e si articolano nel dia-logo tra materiale etnografico, letteratura e fonti documentarie, siano esse ufficiali o “popolari”, come i numerosi forum e i siti Web attorno ai quali si muove una parte considerevole delle conversazioni pubbliche dei parenti adottivi.
Naturalmente, questo studio non esaurisce, né potrebbe esaurire, l’in-dagine di un oggetto tanto complesso quale quello del farsi parenti tra “estranei”. Come ho detto, si tratta semplicemente di un piccolo contribu-to all’attuale dibattito sulla famiglia e sulla famiglia adottiva in particolare. Intenzionalmente ho operato una scelta del materiale raccolto, decidendo ad esempio di non discutere in modo approfondito, tranne in un caso, eventi peraltro molto significativi del ciclo di vita delle famiglie e ai quali ho variamente partecipato19, poiché, dal mio punto di vista, avrebbero po-tuto distogliere l’attenzione dal processo di costituzione del legame fami-liare tra estranei e dallo sforzo di rendere intellegibile al lettore l’intensità quotidiana della vita familiare e soggettiva così come é stata registrata nel corso della ricerca. Una scelta prospettica indubbiamente parziale.
Infine, la questione del posizionamento porta a parlare anche della presa di posizione dell’io-autore e, ancora prima, dell’io-ricercatore. Un “nodo” che, nel mio caso, si produce in modo specifico all’intreccio della doppia appartenenza professionale. I temi dell’infanzia, dell’adolescenza e della fa-miglia, infatti, non sono nuovi al patrimonio analitico di cui sono entrata in possesso. L’adolescente in modo particolare, in tutte le sue “espressioni”, e la sua famiglia, sono stati per me soggetti di studio e di pratica profes-sionale per lungo tempo. Di conseguenza la mia presa di posizione in re-lazione alle vite di queste persone emerge in modo palese, oserei dire quasi “militante”, sia nella individuazione delle angolature meritevoli di osserva-zione e partecipazione, sia nella scelta di particolari strumenti analitici che ho ritenuto più appropriati a scomporre e ricomporre la complessità della vita quotidiana che questi soggetti portavano alla mia attenzione.
Tutti i testimoni vengono naturalmente presentati con nomi fittizi, per-lopiù scelti da loro stessi. Laddove è stato possibile sono stati omessi o camuffati quegli elementi sensibili ad una individuazione pubblica delle 19 Come il matrimonio di una delle giovani adottive che ho frequentato o la morte precoce di un’altra di loro, o ancora la scomparsa di una mamma adottiva che era stata una preziosa testimone nel mio precedente studio delle associazioni di famiglie adottive e che aveva partecipato alle fasi iniziali di questa ricerca.
XXXIV
Affetti da adozione
famiglie citate, ma in ogni caso senza stravolgere il senso e la densità della testimonianza.
Oltre all’introduzione e alle conclusioni, il corpo del testo si articola in tre sezioni principali racchiuse da un prologo ed un epilogo.
Il tema della trasformazione dell’estraneità in familiarità nello spazio domestico e nella comunità sociale di appartenenza percorre trasversal-mente tutte le sezioni; un secondo filo conduttore, altrettanto trasversale, si sviluppa a partire dalle domande: Quali strategie devono mettere in atto le famiglie adottive per “legittimarsi” ed essere “legittimate” nella loro co-munità di vita? Quali nuove rappresentazioni di sé esprimono i parenti adottivi? E quali valori propongono al “vecchio” sistema familiare?
Il prologo “prepara” le argomentazioni della prima sezione analizzando la pratica adottiva contemporanea nei discorsi delle Convenzioni Interna-zionali e delle norme nazionali, e nelle regole da queste stabilite; discute in modo approfondito la “tecnica” dell’abbinamento tra il bambino “de-stinato” e gli aspiranti genitori, quali attori vi sono coinvolti e quali effet-ti produce sull’immaginario dei futuri genitori e del figlio e sulle prime battute dell’apparentamento adottivo; argomenta come l’attuale forma di adozione sembra assumere il senso di un accordo economico fondato sulla soddisfazione di bisogni (del bambino, del paese di origine) e desiderio (della coppia) e, in questa cornice, come si posizionano le tecnologie so-ciali impegnate nell’adozione. Viene anche presentata e discussa la nozione di “assemblaggio” adottivo laddove, in questa prima fase dell’esperienza, la famiglia “fabbricata” per mezzo dell’adozione emerge come una particola-re configurazione delimitata da specifiche infrastrutture tecniche, apparati amministrativi e regimi valoriali.
Nella prima sezione viene analizzata la specifica cornice storico-cultu-rale entro cui si è conformata la pratica adottiva contemporanea, che ha fornito il senso per pensare il trasferimento adottivo transnazionale e mo-dellato quelle disposizioni attraverso cui coloro che intendono adottare danno forma al desiderio di un figlio. Viene evidenziato come l’aspirazio-ne ad essere genitori e a “fare” famiglia per mezzo dell’adozione proceda da una specifica prospettiva ideologica globale che istituisce sofferenti e soccorritori, individua il futuro figlio nella figura dell’“orfano sociale”, si materializza nell’incontro prefigurato dallo scambio delle fotografie (del futuro figlio, dei futuri genitori, della futura casa) e giunge, con l’arrivo del bambino e sulla spinta degli operatori sociali, alla scrittura di una sto-ria o favola di famiglia attraverso cui coniugare, quantomeno nell’artificio dell’intreccio narrativo, il passato imperfetto della coppia infertile e del bambino “orfano” con un futuro immaginato e soprattutto socialmente legittimato, poiché familiare e plurale.
XXXV
Introduzione
La seconda sezione esplora in che modo e utilizzando quali strategie i neo-parenti adottivi affrontano e articolano la complessa costruzione so-ciale delle proprie (nuove) soggettività di genitori, figlio, parenti e in che modo vanno a creare quel particolare spazio intersoggettivo in cui hanno luogo pratiche e sentimenti di famiglia che consente loro di riconoscersi ed essere riconosciuti come parenti. L’analisi dello sforzo operato nella ri-scrittura di ruoli che, solo alcuni mesi prima, individuavano categorie di persone del tutto diverse (moglie, marito, “orfano”), spesso provenienti da luoghi geograficamente e culturalmente distanti, mostra come la creazio-ne del legame familiare richieda la presenza imprescindibile di un’“agen-cy concertata”, vale a dire la capacità e l’abilità delle persone coinvolte di operare scelte negoziate e condivise, all’interno della cornice fornita dalle attese culturali e dalle strutture sociali in cui sono o sono stati immersi. Da questa prospettiva, il processo dell’apparentamento porta in primo piano la reciprocità delle azioni che “fabbricano” la connessione familiare, lad-dove genitori e figli sono ugualmente e contemporaneamente impegnati nel processo di “gestazione sociale” della loro famiglia attraverso la mo-dulazione delle pratiche e degli affetti quotidiani e la negoziazione della capacità di penetrazione di “segmenti” di memoria connessi alle precedenti relazioni familiari e del loro potere nel configurare e dare senso alla nuova relazione di famiglia.
La terza sezione discute gli effetti della trasgressione dei confini – di razza, di parentela, di nazione – operata dall’esperienza adottiva contem-poranea e il modo in cui genitori e figli cercano di governare l’incongru-ità tra razza e parentela di cui sono portatori all’interno delle interazioni quotidiane con la comunità di vita e le istituzioni. Più precisamente, viene argomentata la costruzione culturale delle nozioni di razza/etnicità, iden-tità e cultura e viene analizzato come tali nozioni acquistino una partico-lare rilevanza con la scolarizzazione dei figli, investendo la vita quotidiana e i sentimenti dei parenti adottivi soprattutto nel corso dell’adolescenza, quando l’intensificazione delle relazioni sociali allargate rende queste no-zioni discorsivamente pervasive. La discussione è dunque focalizzata sulla trasformazione che coinvolge la famiglia in questo particolare momento del ciclo di vita, facendo avanzare il punto di vista dei figli, che parla di “erosione” dell’appartenenza, dando spazio all’analisi dei movimenti con-tradditori che accompagnano i tentativi dei giovani adottivi di “riscrivere” le loro radici e che rinnovano la riflessione lungamente dibattuta se l’adot-tivo sia “uno spazio culturale aperto” o sia inestricabilmente “radicato in un suolo nazionale” (Yngvesson 2000, 177).
Infine, l’epilogo si pone come chiosa alla terza sezione, annunciando il discorso attualmente più “bollente” nel campo dell’adozione, quello della
XXXVI
Affetti da adozione
rivendicazione dei giovani adottivi all’accesso alle informazioni sulle loro origini. Ci si chiede se, anche nel caso italiano, le pratiche adottive possono riprodurre il problema dell’identità e della differenza in senso multicultu-ralistico, attraverso un’operazione di “addomesticamento” della differen-za, o se tali esperienze possono spingere il significato dell’essere genitori e l’essere figli al di là del senso comunemente assegnato in Occidente (cfr. Anagnost 2000). Viene anche evidenziato in che modo coloro che sono in-timamente coinvolti nell’esperienza adottiva stiano riflettendo su sé stessi o si chiamano in campo, e come, soprattutto i giovani adottivi, affronta-no le particolari congiunture che definiscono la loro soggettività e la loro appartenenza. Questi aspetti vengono esplorati e discussi comparando le esperienze transnazionali di giovani adottivi provenienti da paesi diversi, come ad esempio l’India e la Corea del Sud.