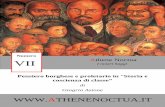Il Racconto della famiglia borghese
Transcript of Il Racconto della famiglia borghese
2
INTRODUZIONE
Questo lavoro prende come oggetto di analisi e comparazione Casa Howard (1910) di E.M.
Forster e Gli Indifferenti (1929) di Alberto Moravia. La scelta di queste due opere, nasce dalla
volontà di lanciare uno sguardo su quelle narrazioni che pongono al proprio centro la famiglia,
riferendomi cronologicamente all’inizio del XX secolo.
La mia scelta non è ricaduta su questi due romanzi unicamente perché il soggetto comune
della narrazione è la famiglia, ma perché in entrambi i racconti è possibile riscontrare un elemento
di crisi; una crisi familiare che si fa metafora della crisi dell’intera classe borghese.
Inoltre, mi è parso utile un confronto tra la scrittura di Forster e Moravia: Forster, scrittore inglese,
non fa sua la lezione del Bloomsbury Group, circolo modernista al quale egli è molto vicino. Tutta
la prima fase della sua scrittura si rifà, piuttosto, ad una poetica tipicamente ottocentesca. Una
sensibilità molto più moderna sembra attraversare la scrittura di Moravia, conscio della piena crisi
dell’uomo del Novecento e dei suoi valori.
La dimensione familiare, a mio avviso, tenta di raccontare a livello microscopico ciò che
avviene in una dimensione macroscopica. Ma, se la crisi della borghesia appare come un pericolo
da sventare in Forster, è, a distanza di quasi vent’anni un fatto compiuto in Moravia.
Tenterò di spiegare questa distanza proprio a partire dalle diverse visioni dei due scrittori, al fine di
evidenziare anche i differenti approdi delle due scritture che daranno vita ad un quadro
interamente positivo in Forster, e interamente negativo in Moravia.
3
1. ONLY CONNECT: Il racconto della famiglia in Casa Howard ed il trionfo della borghesia
1.1. E.M. Forster e l’arte dell’unità.
E.M. Forster (1879-1970) vive la sua vita di scrittore nell’Inghilterra del primo Novecento, l’epoca
del trionfo del Modernismo, delle sperimentazioni di scrittori come Virginia Woolf e James Joyce.
Il nuovo secolo ha posto l’uomo di fronte al crollo di quelli che erano riconosciuti come valori
universali, all’assenza di un’oggettività ben precisa; è una visione unitaria che si sfalda e che
conduce alla frammentarietà e di conseguenza alla necessità di un nuovo modo di scrivere che
rappresenti questo frantumarsi del mondo interiore.
Le pennellate dei post impressionisti sconvolgono gli scrittori londinesi; dopo la mostra
«Manet and Post – Impressionist» organizzata a Londra nel 1910, Virginia Woolf affermerà che il
carattere dell’uomo era, oramai, definitivamente cambiato1 .
Nonostante Forster fosse entrato in contatto con alcuni personaggi protagonisti del
rinnovamento modernista – grazie alla frequentazione del Bloomsbury Group, aggregazione di
scrittori ed intellettuali accomunati dalla volontà di distaccarsi dalle convenzioni artistiche del
secolo precedente2 – egli non si abbandonerà mai a nessun tipo di sperimentalismo: tutte le sue
opere iniziali restano intrise di un certo realismo molto più vicino alle poetiche dell’Ottocento.
Scrive Franco Marenco a tal proposito:
[…]Forster si ferma dunque molto al di qua di Conrad nella critica alla civiltà occidentale, come si ferma molto al di qua di Woolf e Joyce nello sperimentalismo letterario, in lui quasi del tutto inesistente – né poteva essere altrimenti, la moderazione politica rispecchiandosi nella moderazione espressiva […]
3
La prima produzione di Forster sembra porre al proprio centro un’unica dinamica: vi è un
mondo razionale, in contrasto con un mondo originario, in cui sopravvivono sentimenti reali. Tale
opposizione si concretizza nelle figure del borghese e del giovane diverso, un vero e proprio
outsider della società. L’intento di questo contrasto è di ricondurre queste dicotomie ad un’unità.
È quello che precisamente accade in Casa Howard, che si apre con una frase esplicativa al
massimo di questo concetto: only connect. Bisogna connettere, connettere tutti gli spiriti della
1 Bertinetti P. (a cura di) Storia della letteratura inglese, Torino, Einaudi, 2000, pag. 170 2 Ivi, pp. 176-177
3 Marenco F. (a cura di) Storia della civiltà letteraria inglese, volume III, Torino, UTET, 1996, pag. 54
4
borghesia, (unica grande protagonista del romanzo, che esclude ogni altra classe sociale): quello
imprenditoriale e freddo della famiglia Wilcox, quello intellettuale e appassionato della famiglia
Schlegel. All’interno di quest’ultima sembra apparire un’ulteriore divisione: Margaret, la maggiore
delle sorelle, è colei che riuscirà a compiere l’incontro tra i due nuovi volti della borghesia,
sposando il Signor Wilcox, mentre Helen appare, al contrario, avversa a questa possibilità.
Ma, sul finale Forster, porta tutti i personaggi, Helen compresa, a ricongiungersi proprio sullo
sfondo di Casa Howard, simbolo di un mondo ancora non corrotto, immune dalla frenesia e
dall’avanzare della modernità della metropoli londinese: come per i personaggi, anche i luoghi
subiscono una forte polarizzazione: Londra, la città che cresce e si espande, è il luogo del caos,
Casa Howard – come le altre dimore in campagna – è il luogo della pace e della serenità.
Tutte le fratture si sanano nell’unità. Non c’è altra possibilità al di fuori di una vita
borghese, e questo sembra suggerirci la morte di Leonard Bast, unico personaggio appartenente
ad una classe sociale inferiore.
Il finale con la famiglia allargata, finalmente riunita in Casa Howard ci dimostra
definitivamente come Forster creda – ancora per poco – alla possibilità di una risoluzione in
positivo degli eventi. La problematicità della storia del nuovo secolo che avanza è intravista,
seppure in modo debole, come crisi di valori. I possibili contrasti interni alla classe borghese.
vengono risolti in nome di quella tendenza delle differenti parti all’unità, poiché l’arte può
ricondurre all’ordine il caos dell’universo.
Tale visione sarà soggetta, successivamente, ad una crisi: Forster, riconoscerà una
maggiore complessità del reale e l’incapacità della sua scrittura di ritrarla, per cui deciderà di
interrompere la sua attività di scrittore fino alla pubblicazione di Passaggio in India4 (1924).
Seppure con i suoi limiti oggettivi, offuscati da una visione quasi semplicistica del mondo
circostante, Casa Howard ha il merito di saper fornire una descrizione minuziosa, quasi maniacale
di due tipi e di due spiriti della famiglia borghese. Nel paragrafo successivo mi concentrerò su
queste descrizioni e sulle loro possibili interpretazioni.
4 Ivi, pp. 55-56
5
1.2 Casa Howard
Noi non ci occupiamo dei poverissimi. Questi sono inimmaginabili e li possono avvicinare soltanto gli esperti di statistica o i poeti. La nostra storia tratta della gente di buona famiglia, o di coloro che sono obbligati a far finta di esserlo
5
In questa frase, sembra essere raccolto tutto lo spirito di Casa Howard. Il romanzo, pubblicato nel
1910 racconta della storia di due famiglie inglesi – quella delle Schlegel e quella dei Wilcox – le
quali appaiono come le due facce di un’unica medaglia.
La famiglia Schlegel è composta da Margaret, Helen e Tibby: di origini tedesche sono lo spirito
borghese nutrito di cultura, che tende una mano a ideali progressisti come il voto alle donne e
l’uguaglianza tra i sessi, così come pongono attenzione alle classi sociali inferiori, per le quali
sentono il dovere di preoccuparsi (come accade per Leonard Bast), ma dalle quali si pongono,
comunque, a distanza poiché il denaro resta per loro il centro dell’universo:
Solo quando vediamo traballare qualcuno vicino a noi ci rendiamo conto di quanto significa un reddito indipendente. Ieri sera, quando discorrevamo qui davanti al fuoco, ho cominciato a pensare che l’essenza stessa del mondo è di natura economica e che l’abisso più profondo non è la mancanza d’amore ma la mancanza di quattrini. […] Non sempre i poveri possono raggiungere quelli che vogliono amare e quasi mai fuggire da quelli che non amano più. Noi ricchi sì.
6
Leonard Bast è l’unico protagonista del romanzo (insieme a sua moglie) proveniente da una
classe sociale inferiore; quest’uomo, un impiegato di una compagnia di assicurazioni, vive in una
situazione di indigenza poiché impiega tutti i suoi guadagni per soddisfare i capricci della moglie,
ma anche per rimediare al suo senso di inadeguatezza, giacché egli vorrebbe essere un borghese,
proprio come le sorelle Schlegel. Leonard vive, infatti, con l’intenzione di elevarsi culturalmente:
“sperava di arrivare alla Cultura d’un tratto un po’ come il fautore di un rinnovamento religioso
spera di arrivare a Gesù”7e ci prova attraverso la lettura di Ruskin o frequentando concerti di
musica classica. Proprio ad uno di questi, avviene l’incontro con le sorelle Schlegel, le quali
tenteranno di salvare l’uomo dalla sua condizione di miseria intellettuale e materiale. Sarà
soprattutto Helen a prendere a cuore la sua situazione, anche quando Margaret – scoperto che
sua moglie era stata l’amante del suo futuro marito – abbandonerà l’idea di prestargli aiuto.
Helen, crede sia necessario salvare Leonard, che, nel frattempo, cade completamente in malora
5 Forster E. M., Casa Howard, Milano, Mondadori Editore, 2011, cit. pag.44
6 Ivi, pag. 59
7 Ivi, pag. 49
6
anche a causa di un consiglio sbagliato del signor Wilcox, il quale, però, non sembra preoccuparsi
più di tanto della sua sorte. Successivamente si scoprirà che Helen è incinta di Leonard, il quale
malato e povero, perderà la vita nel tentativo di confrontarsi, per l’ennesima volta inutilmente,
con la classe borghese. Per la sua morte, il maggiore dei figli del signor Wilcox viene accusato di
omicidio, sebbene, apparentemente la morte sia avvenuta per cause naturali. Dopo questa morte,
la vita procede in modo migliore: sembra che la felicità si possa compiere solo in assenza di questo
personaggio, quasi di disturbo per lo sviluppo del racconto.
La coscienza di Leonard sembra essere l’unica coscienza di uomo del Novecento, di fatti, il suo
malessere appare incomprensibile agli altri personaggi: la sua morte è, quindi, quasi necessaria per
poter ricongiungere insieme tutte le parti del racconto, nel quale è evidente l’impossibilità di una
vita altra che non sia quella borghese.
Helen e Margaret sono due donne simbolo di una borghesia che potremmo definire
matriarcale. Il loro fratello minore Tibby, dedito allo studio e appassionato di musica, appare
quasi una figura sterile se comparato allo spirito appassionato delle donne di famiglia; Tibby “non
desiderava né rafforzare la posizione del ricco, né migliorare quella del povero”8, è diverso da tutti
gli uomini che appaiono, ed è quasi ininfluente per lo svolgersi del racconto.
Le due donne dispongono di enormi finanze e rendite proveniente da investimenti,
viaggiano, ascoltano concerti di musica classica, portano avanti dibattiti in circoli di donne,
leggono, si occupano di politica e ospitano gente nella loro dimora, Wicham Place: “musicisti
barbuti, perfino un’attrice[…] conoscenze raccattate nel continente”9 . La loro vita va avanti in
questa direzione, all’insegna degli ideali e delle passioni, fino allo sconvolgimento che apporta,
nelle loro vite, la famiglia Wilcox. Il primo incontro avviene proprio a Casa Howard che è solo una
delle varie dimore della famiglia10 , ed è Helen la prima ad incontrarsi con questo mondo “nuovo”
e lontano da quello della sua famiglia, del suo microcosmo; il testo si apre con delle lettere che ella
invia alla sorella, in una di queste viene descritto, in poche righe, il contrasto esistente tra i due
animi delle famiglie:
Il buffo è che mi considerano una sempliciotta, e me lo dicono – almeno il signor Wilcox me lo dice – […] Egli dice nel modo più simpatico cose tremende sul voto alle donne e quando io ho dichiarato di credere nell’uguaglianza ha incrociato semplicemente le braccia e mi ha “messo a posto” come non mi era mai capitato prima. Meg, quando impareremo a parlare meno? Non mi
8 Ivi, pag.245
9 Ivi, pag.13
10 Sull’importanza della casa all’interno di entrambi i romanzi ritornerò successivamente.
7
sono mai vergognata tanto in vita mia. Non ho saputo indicare un epoca in cui gli uomini siano stati tutti uguali, e nemmeno una in cui il desiderio di essere uguali li abbia resi felici in altri modi. Non ho saputo dire una parola. Avevo semplicemente tratto l’opinione da qualche libro – probabilmente di poesia – oppure da te
11 .
Helen appare innamorata di questa famiglia e di questo nuovo mondo che tocca con mano
per la prima volta. Subisce il fascino della residenza fuori città, dove si vive una vita semplice,
lontana dal caos della metropoli londinese: le rose selvatiche, l’olmo, gli animali da campagna. I
due figli, Charles ed Evie impegnati in attività sportive; la signora Wilcox intenta a curarsi del suo
giardino; niente concerti, niente vita mondana: casa Howard incarna quello spirito di vita
“semplice”, di senso dell’origine contro la corruzione del mondo moderno tanto caro a Forster (e,
proprio per questo risulta essere l’elemento unificante dei due poli della narrazione). Ma Helen
ben presto accantonerà l’episodio fugace con Paul, il figlio minore dei Wilcox, rendendosi
improvvisamente conto che non c’era alcuna possibilità per quell’unione, e a diventare elemento
di contatto con questi sarà invece Margaret.
Dapprima, ella stringe amicizia con Ruth Wilcox, moglie di Henry. Sono unite da uno strano
legame sebbene siano due donne completamente diverse: Margaret, come abbiamo visto, è la
nuova donna della borghesia progressista, la signora Wilcox è tutt’altro: ella è estranea al resto dei
membri della sua famiglia, appare come l’immagine del passato: “su di lei era discesa l’istintiva
saggezza che solo il passato può dare: quella alla quale diamo il goffo nome di aristocrazia”12 . Uno
spirito differente quindi la attraversa, che nulla ha a che vedere con lo spirito borghese affarista
del marito, né con le pretese intellettuali e culturali delle sorelle Schleghel: ella “sembrava
appartenere non ai giovani e alla loro automobile, ma alla casa e all’albero”13 Ma è proprio a
Margaret che in punto di morte ella lascia in eredità Casa Howard: è il passaggio di testimone dei
valori aristocratici alla borghesia a quella borghesia nella quale risiedono ancora dei valori, la quale
appare ancora immune dall’avidità degli affari:
Per loro, casa Howard era una cosa, non sapevano che agli occhi di lei era uno spirito, per il quale cercava un erede spirituale.
14
Esclusa dalla narrazione la Signora Wilcox, (che appare, anch’ella come Leonard Bast
elemento di disturbo) il resto della famiglia, appare come l’immagine della nuova mentalità
borghese affaristica incarnata soprattutto nel padre Henry, che prenderà in sposa Margaret. È 11
E.M. Forster, Op.cit., pag. 5 12
Ivi, pag. 21 13
Ibidem 14
Ivi, pag. 96
8
proprio questa unione che sancirà la fusione dei due universi borghesi.
I Wilcox sono impegnati in altre attività che nulla hanno a che fare con quelle culturali
intraprese dalle sorelle Schlegel, anzi, il signor Wilcox considera “ l’Arte e la Letteratura, salvo
quando contribuivano a rafforzare il carattere, una sciocchezza”15. Helen ce li descrive intenti a
praticare sport; tennis e cricket. Entrambi figli maschi lavorano nell’azienda del padre, l’unica figlia
femmina, Evie, non lavora ma è dedita ad altro, come l’allevamento dei cani e, molto presto, verrà
data in sposa ad un buon partito. Posseggono automobili con le quali intraprendono lunghi viaggi.
Proprio questo oggetto viene percepito come simbolo di una modernità disturbante da parte di
Margaret:
L’aspettava una corsa in automobile, forma di felicità che Margaret detestava16
Confinata al chiuso della desolata stagione, riacquistò il senso dello spazio, che l’automobile aveva tentato di toglierle.
17
Tra le varie differenze che intercorrono tra le due famiglie, una appare centrale: il lavoro. Il
signor Wilcox – sebbene Forster non lo chiarisca a pieno nel romanzo – è uno dei tanti uomini che
nell’Inghilterra di quel tempo facevano fortuna impegnandosi in attività economiche (e di
sfruttamento) nelle colonie; vediamo nel suo studio troneggiare la carta dell’Africa, dove il figlio
minore Paul porta avanti gli affari, mentre il maggiore, Charles, affianca il padre in Inghilterra.
Nel suo The Boourgeois . Between History and Literature, Franco Moretti, analizza la
presenza ed il ruolo del lavoro nel romanzo di Daniel Defoe Robinson Crusoe . Moretti giunge a
chiedersi come mai il borghese – nel caso della sua analisi personificato in Robinson Crusoe –
lavori anche dopo che i suoi bisogni primari vengono soddisfatti. Ancora, si chiede come mai lavori
così duramente come se fosse sottoposto ad un capo, che in realtà non esiste poiché egli è il capo.
Il nuovo borghese, portatore del nuovo spirito capitalista, lavora per accumulare ma anche perché
il lavoro è oramai la nuova forma di legittimazione del potere sociale18.
Tale discorso può essere tranquillamente trasfigurato anche sul personaggio del signor Wilcox, il
quale sente di poter occupare quel posto in alto nella società proprio in virtù del suo lavoro:
15
Ivi, pag. 23 16
Ivi, pag. 193 17
Ivi, pag. 197 18
Moretti F., The Bourgeois. Between History and Literature, New York – Londra, Verso, 2013, pp. 29-31
9
L’uomo d’affari sorrise. Dopo la morte della moglie aveva quasi raddoppiato il suo reddito. Finalmente era un uomo importante, un nome che ispirava fiducia sui prospetti delle società e che dalla vita era stato trattato benissimo. Sembrava avere il mondo in pugno mentre ascoltava il fiume Tamigi, che dal mare rifluiva ancora entro terra. Così stupefacente per le ragazze, esso non aveva misteri per lui. Egli aveva contribuito ad accorciare il lungo tratto soggetto alla marea comprando azioni della chiusa di Teddington e, se egli e gli altri capitalisti lo avessero ritenuto opportuno, un giorno questo tratto sarebbe potuto essere accorciato ancora
19.
Gli affari sono una questione del tutto estranea, invece, agli Schlegel che, dal canto loro,
vivono di rendita. Margaret annunciando il suo matrimonio alla sorella Helen, annuncia anche la
necessità di smettere di guardare in modo negativo alla borghesia del capitalismo, e, anzi, di
ringraziarla, perché il tenore della loro vita può essere sostenuto grazie a tutti i vari Wilcox
esistenti:
«Lo stesso vale per lui» ella continuò. «Ci sono moltissime cose nel signor Wilcox… più specificamente cose che fa… le quali resteranno sempre un mistero per me. Egli ha tutte le qualità pubbliche che tu disprezzi tanto e che rendono possibile tutto questo…» Agitò una mano verso il paesaggio, che confermava ogni cosa. «Se i Wilcox non avessero lavorato e non fossero morti in Inghilterra per migliaia di anni, tu e io non potremmo starcene sedute qui senza che ci fosse tagliata la gola. Non ci sarebbero treni, non ci sarebbero navi per portare in giro noi gente di lettere, non ci sarebbero nemmeno campi. Solo barbarie. No… forse neppure questa. Forse senza il loro spirito la vita non si sarebbe mai evoluta dal protoplasma. Sempre più io mi rifiuto di ritirare la mia rendita e schernire quelli che la garantiscono. […]»
20
Margaret è oramai è parte integrante di questo mondo, sebbene spesso riflette sulle
diversità presenti tra lei e suo marito. Helen, che non riesce invece ad accettare questa unione,
abbandona la sua famiglia e l’Inghilterra per fare ritorno alla patria d’origine, proprio per il rifiuto
di questa possibile convivenza. Ma anche ella, incinta dell’ormai defunto Leonard, cederà. Il
momento massimo di tensione del romanzo, sembra condurre ad una rottura suggerendo
l’impossibilità di due mondi così diversi di poter convivere; Margaret sta per abbandonare Henry e
per andare via con Helen in Germania, ma l’amore e il senso della famiglia hanno la meglio.
La scena si riapre con la famiglia oramai riconciliata in Casa Howard, il simbolo dei valori
puri e genuini: Margaret è ritornata la moglie docile ed apprensiva verso un uomo che ha perso
tutta la sua forza e il suo potere, il quale viene mostrato ammalato e indifeso, ma questo non
basta a interrompere la visione positiva della storia:
19
E.M.Forster, Op. cit., pag.128 20
Ivi, pag.171
10
Dal giardino giunse una risata. «Eccoli, finalmente!» esclamò Henry, liberandosi con
un sorriso. Helen correva nella semioscurità, tenendo Tom per una mano e portando
il suo bimbo con un’altra. Vi furono scoppi di gioia contagiosa. «Il campo è falciato!»
gridò Helen con eccitazione… «Il campo grande! L’abbiamo visto proprio fino
all’ultimo e sarà un raccolto di fieno come non c’è mai stato.»21
La borghesia ha trionfato, la famiglia ha trionfato. Tutta l’azione racconta le problematiche,
le caratteristiche, l’evoluzione di un’unica classe sociale: il resto del mondo, la società e tutte le
problematiche che emergono nella scrittura all’inizio del Novecento vengono tagliate fuori:
appaiono di riflesso con la presenza di Leonard Bast, il quale, però, viene escluso dalla narrazione e
troverà la morte proprio nel tentativo di apparire come un borghese modello.
Di tutt’altro tono è invece il romanzo di Moravia: se per Forster la famiglia è il mezzo per
raccontare il trionfo di una classe, di un futuro radioso guidato da essa e dai suoi valori, lo scrittore
romano utilizza lo stesso soggetto narrativo per compiere invece un racconto in negativo della
borghesia, dei suoi valori e di un futuro che non è più la prospettiva di un tempo lineare, ma
oramai già incerto, oramai aggredito da quella crisi dei valori tipicamente moderna.
21
Ivi, pag. 336
11
2. Il racconto della famiglia italiana: Gli indifferenti ed il declino morale della borghesia
2.1: Moravia come scrittore borghese
Gli indifferenti (1929) segna l’esordio in letteratura dello scrittore romano Alberto Moravia
(1907-1990). Sebbene questo romanzo può apparirci oggi come una spietata immagine della
classe borghese e dei suoi valori, lo scrittore dichiarerà successivamente che non era sua
intenzione costruire un’opera con queste caratteristiche:
A questo punto qualcuno vorrà sapere perché non parlo degli intenti sociali e larvatamente politici di critica antiborghese che molti attribuiscono al romanzo. Rispondo che non ne parlo perché non c’erano. Se per critica antiborghese si intende un chiaro concetto classista, niente era più lontano dal mio animo in quel tempo. Essendo nato e facendo parte di una società borghese ed essendo allora borghese io stesso (almeno per quanto riguarda il modo di vivere) Gli indifferenti furono tutt’al più un mezzo per rendermi consapevole di questa mia condizione. […] Che poi Gli indifferenti sia risultato un libro antiborghese questa è tutt’altra faccenda. La colpa o il merito è soprattutto della borghesia, specie quella italiana in cui ben poco o nulla è suscettibile di ispirare non dico ammirazione ma neppure la più lontana simpatia. Tutto questo è tanto vero che soltanto molto tempo dopo aver pubblicato Gli indifferenti mi accorsi della reale portata del libro e cominciai a sentire ripugnanza per il modo di vivere borghese nel suo complesso. Debbo avvertire però che questo modo di vivere mi apparve sempre più come un fatto morale piuttosto che materiale.
22
Anche se non voluta, una certa lucidità contraddistingue il romanzo nell’analisi di alcuni
aspetti del declino, sotto il peso del Fascismo, della società borghese. Come sosterrà Eduardo
Sanguineti nella sua introduzione al romanzo:
Gli indifferenti segnano, nella nostra letteratura narrativa, l’atto definitivo di morte del buon senso borghese, non per frontale eversione, del che si dovrebbero cercare documenti in una zona assai lontana dall’arte di Moravia, ma per semplice
svuotamento interno23.
Da questo punto di vista la visione offerta da Casa Howard è completamente opposta.
Come ho avuto modo di analizzare precedentemente, la volontà dell’opera di Forster è quella di
rendere la famiglia soggetto di una narrazione che auspica e vede la possibilità di un trionfo
borghese e di un rinvigorirsi dei suoi valori. Ne Gli indifferenti, al contrario, la famiglia diventa
l’emblema della crisi in atto, oramai compiuta e senza alcuna possibilità di risoluzione.
Esiste, quindi, una differenza sostanziale: quell’assenza di morale che veniva rappresentata in
22
A.Moravia, L’uomo come fine, in R. Tessari, Alberto Moravia. Introduzione e guida sullo studio dell’opera moraviana. Storia e antologia della critica, Firenze, Le Monnier, 1975, pag. 48 23
E. Sanguineti, Introduzione in A. Moravia, Gli indifferenti, Milano, Bompiani 2009, pag. XII
12
Casa Howard solo come un pericolo visto in lontananza, è oramai qualcosa di compiuto ne Gli
indifferenti.
Tutti i membri di questa grottesca rappresentazione sono tra di loro uniti solo da interessi
ed affettivamente lontani. Carla e Michele, i due fratelli, la madre, Mariagrazia e l’amante di
questa Leo (il quale diventerà il marito della sua giovane figlia): ciò che li lega ha sempre ed
unicamente un connotato negativo. Un presente immobile, dove le uniche azioni portano i
personaggi ad una caduta in basso ancora maggiore. L’inazione caratterizzerà tutti i protagonisti
fino alla fine: poiché, infondo, tutti decidono di accettare quella realtà e nessun valore positivo,
nessun senso di riscatto li spinge ad agire.
2.1 Gli indifferenti
Mi ero proposto, come ho spiegato, di scrivere una tragedia in forma di romanzo; ma scrivendo, mi accorsi che i motivi tradizionali della tragedia e insomma di ogni fatto veramente tragico mi sfuggivano proprio nel momento in cui cercavo di formularli. In altre parole dato l’ambiente e i personaggi, la tragedia non era possibile; e se avessi cambiato ambienti e personaggi avrei voltato le spalle alla realtà e fatto opera di artificio. Mi si chiariva insomma l’impossibilità della tragedia in un mondo nel quale i valori non materiali parevano non aver diritto di esistenza e la coscienza morale si era incallita fin al punto in cui gli uomini, muovendosi per
solo appetito, tendono sempre più a rassomigliare ad automi24.
Sebbene lo scrittore rinunci alla tragedia di fronte all’assenza di elementi nella realtà adatti
a contribuire alla sua realizzazione, c’è qualcosa nel romanzo dell’iniziale impostazione pensata da
Moravia. Innanzitutto l’ambientazione: il romanzo si svolge quasi esclusivamente all’interno di ville
ed appartamenti, o comunque luoghi chiusi. È un’impostazione fortemente scenica che ha quasi
una resa teatrale, nella quale la casa ritorna, come in Forster, elemento centrale della narrazione.
Qui è oggetto che lega lo spregiudicato Leo Meremuci alla famiglia; egli intrattiene rapporti prima
con la madre e poi con la figlia, unicamente al fine di impadronirsi della villa. Nelle descrizioni,
l’abitazione ci appare come un luogo angusto e buio:
24
A.Moravia, L’uomo come fine, in R. Tessari, Alberto Moravia. Introduzione e guida sullo studio dell’opera moraviana. Storia e antologia della critica, Firenze, Le Monnier, 1975, pag. 48
13
Entrarono nel freddo oscuro salone rettangolare che una specie di arco divideva in due parti disuguali e sedettero nell’angolo opposto alla porta; delle tende di velluto cupo nascondevano le finestre serrate, non c’era lampadario ma solamente dei lumi in forma di candelabri, infissi alle pareti a eguale distanza l’uno dall’altro; tre dei quali, accesi, diffusero una luce mediocre nella metà più piccola del salone; l’altra metà, oltre l’arco, rimase immersa in un’ombra nera in cui si distinguevano a malapena i riflessi degli specchi e la forma lunga del pianoforte.
25
La casa si fa specchio della condizione dei personaggi; l’ombra, la luce scarsa, sembrano
quasi il risvolto esteriore di un buio che è interno ai suoi abitanti; nemmeno gli oggetti riescono a
salvarsi dal declino che Moravia ha intenzione di raccontare. E così, anche la casa di Lisa sembra
essere l’immagine esteriore della sua essenza; ella cerca di fare innamorare di lei Michele,
provando in questo modo a ingannare il tempo che passa, per provare ancora a sentirsi giovane.
La sua abitazione sembra essere l’immagine di questo intendo di dissimulazione:
A prima vista tutto appariva puro e innocente, si osservano mille gentilezze, qui un cestino da ricamo, là una piccola biblioteca di libri multicolori, e poi dei fiori smilzi sulle mensole laccate, degli acquerelli sotto vetro alle pareti, insomma una quantità di cose che, dapprima, facevano pensare: “Eh, che bel posticino chiaro e sereno, qui non può abitare che qualche giovinetta”; ma sei si guardava meglio si cambiava idea; allora ci si accorgeva che il boudoir non era più giovane del resto dell’appartamento, si osservava che la lacca dei mobili era scrostata e ingiallita, che la tappezzeria era scolorita e qua e là mostrava la trama, che una stoffa lacera e dei cuscini sordidi coprivano il divano d’angolo; ancora uno sguardo e si era convinta: si rivelavano gli strappi delle tendine, i vetri spezzati degli acquerelli, i libri polverosi e sdruciti, le larghe screpolature del soffitto; e sei poi alfine era presente la padrona di casa, non c’era neppur bisogno di cercare, tutta questa corruzione saltava agli occhi come accusata dalla figura della donna.
26
Tutt’altro, invece, il valore che la casa acquista nel romanzo di Forster. Oltre alle possibili
simbologie già illustrate di unità e di valore positivo, essa sembra anche metafora della vita, in
completa opposizione a Gli indifferenti. L’anziana guardiana che arreda la villa con gli oggetti lì
depositati della vecchia casa di Margaret, suggerisce la necessità di riportare l’esistenza in quel
luogo, contro l’abbandono ed il declino a cui stava andando incontro. Un’immagine simile sembra
riproporsi in Gita al faro (1927) di Virginia Woolf. Anche qui, dopo la morte della Signora Ramsay,
la casa delle vacanze, che prima aveva ospitato la famiglia ed i suoi amici viene lasciata all’incuria
del tempo.
La casa fu abbandonata, diserta. Fu abbandonata come si abbandona una conchiglia sulle dune a colmarsi di sterile sale in luogo della vita perduta. […] I rospi si introdussero nell’interno. […] Le rondini fecero il nido in salotto; i pavimenti si coprirono di strame; l’intonaco si distaccò a palate; le travi rimasero a nudo; i topi portarono via roba da rodere dietro gli assiti. Farfalle madreperlace, rotto il bozzolo,
25
A. Moravia, Gli indifferenti, Milano, Bompiani, 2009, pag.19 26
Ivi, pag. 42
14
s’ammazzarono sbattendo contro i vetri delle finestre. I papaveri si disseminarono tra le dalie; il prato sventolò alti ciuffi d’erba; carciofi giganteschi torreggiarono fra le rose; un garofano frangiato sbocciò tra i cavoli; e durante le notti d’inverno, invece del tocco lieve d’una pianticella contro la finestra, risuonò un rullìo di robusti alberi e di rovi che d’estate inondavano la stanza di verde. Qual forza poteva ormai porre ostacolo alla fertilità indifferente della natura?[…] Tutta la villa andava in malora.
27
Quasi ingoiata dalla natura, la dimora ritroverà una nuova vita, proprio quando, finalmente
il Signor Ramsay deciderà di tornare e compiere con i suoi figli la famosa gita al faro, riportando la
vita e allontanando declino, che invece prende il sopravvento nell’ambientazione domestica de Gli
indifferenti.
Ed è sempre nella casa che nel romanzo moraviano si ripete il rituale oramai vuoto e sterile
dei pasti, il quale si rivela come momento di confronto tra i membri della famiglia.
Seduti al tavolo della sala da pranzo, i personaggi sono sempre impegnati in conversazioni,
durante le quali, il discorso diretto molto spesso è intervallato da stralci di monologo interiore;
come a dimostrare che questi sono presenti nel gruppo familiare, ma ognuno di loro è preso dai
propri pensieri e dalla propria individualità:
“Vediamo mamma”, intervenne Carla “egli non ha detto nulla di insultante”: ora, dopo quest’ultima scena, un’atterrita disperazione possedeva la fanciulla: “finirla”, pensava guardando la madre puerile e matura che a testa bassa pareva ruminare la gelosia; finirla con tutto questo, cambiare ad ogni costo.” Delle risoluzioni assurde passavano per la sua testa; andarsene, sparire, dileguarsi nel mondo, nell’aria. Si ricordò delle interessanti parole di Leo: “Tu hai bisogno di un uomo come me.” Era la fine: “Lui o un altro…” pensò; la fine della pazienza, dalla faccia della madre i suoi occhi sofferenti passarono a quelli di Leo: eccoli i volti della sua vita, duri, plastici, in comprensivi, allora riabbasso gli sguardi sul piatto dove il cibo si freddava nella cera coagulata dell’intingolo.
28
O ancora:
La fine della cena fu silenziosa: tutti avevano qualche pensiero dominante, nessuno parlava. “Che vada al diavolo” si ripeteva Leo sconcertato, guardando Mariagrazia; benché il contegno della donna gli fosse indifferente, quest’insolito rancore non gli presagiva nulla di buono. La madre cercava invece un mezzo per vendicarsi di Leo […]. Carla pensava alla notte vicina, un turbamento straordinario la possedeva: “Gliel’ho veramente promesso?” si domandava; “è proprio stanotte che devo andarci?”. In quanto a Michele, un disagio acuto lo tormentava, gli pareva che il suo contegno durante la discussione tra sua madre e Leo fosse stato d’una indifferenza senza pari: “Ancora una buona occasione perduta” si diceva “per litigare con lui.”
29
27
V. Woolf, Gita al faro, Milano, Garzanti, 2000, p. 150 28
A.Moravia, Op. cit., pag .17 29
Ivi, pp. 131-132
15
Il nucleo familiare appare costantemente in conflitto e le scene dei pasti portano a galla
questi scontri. Contrariamente ad un immagine del pasto come momento conviviale (immagine
che ci viene restituita in una delle scene di Casa Howard, quando per la prima volta Margaret ed
Henry cenano insieme in presenza della figlia di lui) durante il quale la famiglia si ritrova attorno al
tavolo e può serenamente conversare, qui pranzi e cene sono piuttosto momenti di scontro.
L’unione della famiglia in un unico ambiente domestico, è dettata dall’esigenza del nutrimento
ma, se a questi personaggi fosse data possibilità di scelta, pranzerebbero sicuramente separati:
vengono costantemente a galla odi, rancori, gelosie. Ci appare quindi quello del pasto un incontro
non ricercato; è l’impossibilità, a mio avviso, – dettata dalla dimensione individuale dell’uomo che
si fa strada a partire dal Novecento e che la poetica modernista ci pare suggerire – di fare gruppo,
sebbene questo gruppo sia la famiglia; l’incomprensione dell’altro e l’inaccessibilità risultano tali
anche all’interno di quell’ambiente che dovrebbe essere quello più intimo.
In modo simile, in Gita al faro, per un numero considerevole di pagine ci viene narrata una cena
che vede per protagonisti la famiglia Ramsay e i suoi ospiti. E, proprio uno di questi, seduto a
tavola con gli altri, richiama quell’impossibilità di comprendersi che mi pare essere elemento
determinante nell’interpretazione delle cene moraviane:
Egli era sceso a tavola, coi suoi vecchi calzoni di flanella. Non ne aveva altri. Si sentiva meschino, isolato, solo. Capiva che ella cercava di canzonarlo: ch’ella non desiderava di andare al Faro con lui; ch’ella lo disprezzava, come lo disprezzava Prudenza Ramsay, come lo disprezzavano tutti. […] Se avesse potuto rimaner solo a lavorare nella sua stanza! Pensò. Soltanto in mezzo ai libri si sentiva a suo agio
30.
Nella dimensione conviviale e di aggregamento della cena egli rifletterà sul suo essere
isolato tra tanti. E proprio l’ambiente della sala da pranzo ed il momento del pasto sembrano
diventare un’ambientazione e una metafora adatta per questo tema.
Altra traccia che può richiamare alla mente l’impostazione tragica ipotizzata dallo scrittore,
è la presenza di un numero ristretto di personaggi.
Ad esclusione di Lisa, vediamo come protagonista unicamente il nucleo familiare il quale non ci
appare affatto unito, ma contraddistinto da un forte senso di isolamento dei suoi membri:
30
Woolf V., Op.cit. , pag. 93
16
Mariagrazia – spesso menzionata unicamente come la madre – vive in modo morboso il rapporto
con Leo Meremuci, presenza fissa nella casa.
Il rapporto tra i due appare oramai logoro; la donna appare innamorata, mentre egli è trattenuto
unicamente dalla volontà di non permettere la vendita all’asta della villa, per poterla acquistare ad
una cifra inferiore. Delle sue intenzioni è ben cosciente Michele, ma la madre appare accecata
dall’amore e dalla volontà di non allontanare l’uomo; oramai in pieno declino economico,
Mariagrazia vede il suo amante come il suo unico “bene”, e perderlo è per lei inaccettabile, quasi
quanto perdere la casa e di conseguenza i privilegi della sua posizione borghese:
“ma ora basta… o Michele mi fa delle scuse o io me ne vado” […] “Meremuci ha assolutamente ragione” disse la madre con volto duro e con voce imperiosa, perché temeva che l’amante cogliesse questa occasione per rompere i loro rapporti: “la tua condotta è disgustosa… ti ordino di fargli delle scuse…”
31
Descritta come una “maschera stupida e patetica”32, la donna sempre in preda a ridicoli
attacchi di gelosia non ha sui figli alcun ruolo autoritario, ne appare come un punto di riferimento.
Anche loro la trovano ridicolo e spesso ne hanno pietà:
“Credi veramente” domandò la voce piangevole: “dimmi, credi che egli sia veramente tornato ad amare quella lì?” “Ma chi?” chiese Carla turbata; sentiva contro il braccio quel petto molle e ansante, non sapeva cosa fare, le ripugnava, come un atto contro natura, di dover consolare sua madre: “almeno cessasse di piangere” si ripeteva
33.
Ma, in realtà, tutto il romanzo ha come centro i due figli, Carla e Michele: Carla sente
l’esigenza di apportare alla sua vita un cambiamento, sente di dover agire al fine di uscire dalla
mediocrità, dalla bassezza in cui la madre l’ha affondata, e a tal fine cede al corteggiamento di Leo.
La sua reazione però implica distruzione: “finirla, rovinare tutto”34, e quello che ella ha intenzione
di fare è cadere ancora più in basso per rompere definitivamente il cordone ombelicale:
Anche questa ignobile coincidenza, questa sua rivalità con la madre le piaceva; tutto doveva essere impuro, sudicio, basso, non doveva esserci né amore né simpatia, ma solamente un senso di rovina: “Creare una situazione scandalosa, impossibile, piena di scene e di vergogne” pensava; “completamente rovinarmi…”
35
31
Moravia A., Op.cit., pag. 27 32
Ivi, pag.7 33
Ivi, pag. 130 34
Ivi, pag.7 35
Ivi, pag37
17
Michele, all’opposto, non riesce a trovare nemmeno lo stimolo per agire, è paralizzato nella
sua esistenza. Come Moravia stesso scrive, egli è il personaggio in cui la tragedia trova un effettivo
sviluppo:
Così la tragedia di spostava dai dati esteriori (seduzione di una figlia ad opera dell’amante della madre) a quelli interiori di Michele, personaggio impotente e rivoltato che partecipa dell’insensibilità generale ma conserva abbastanza consapevolezza per soffrire di questa partecipazione
36.
Michele ha coscienza ed appare il vero indifferente; si sforza costantemente di provare a
sentire qualcosa, ma nessun evento riesce a scuoterlo dal torpore della sua apatia, nulla riesce a
portarlo verso un cambio di rotta. L’unica cosa che gli resta, oramai, è provare a fingere: fingere di
amare Lisa, fingere di odiare Leo e quindi arrendersi ad una vita di menzogne; in questa ottica,
l’indifferenza di Michele, potrebbe apparirci come una forma di resistenza che lo lascia cosciente
ma immobile, al fine di non cedere definitivamente alla realtà negativa che lo circonda. Sostiene
Sanguineti a tal proposito:
Il suo essere indifferente è la ultima, miserabile forma di nobiltà etica che è concesso ritrovare all’interno di una classe che non ha più speranze di redenzione: è la nobiltà negativa dell’impartecipazione.
37
Ma cosa vorrebbe Michele? Michele sente più di tutti la perdita dei valori della classe
borghese, vorrebbe un ritorno al passato, percepito come tempo della verità e della sincerità:
“Come doveva esser bello il mondo” pensava con un rimpianto ironico […] quando non si pensava tanto, e il primo impulso era sempre quello buono; quando la vita non era come ora ridicola, ma tragica, e si moriva veramente, e si uccideva, e si odiava, e si amava sul serio, e si versavano vere lacrime per vere sciagure, e tutti gli uomini erano fatti di carne ed ossa e attaccati alla realtà come alberi alla terra. A poco a poco l’ironia svaniva e restava il rimpianto; egli avrebbe voluto vivere in quell’età tragica e sincera, avrebbe voluto provare quei grandi odi travolgenti, innalzarsi a quei sentimenti illimitati… ma restava nel suo tempo e nella sua vita, per terra
38.
Il passato è quindi anche il tempo della tragedia poiché appare il tempo dei sentimenti; ed
è così che quando Michele scoprirà da Lisa
il rapporto che intercorre tra sua sorella e l’uomo che ha ridotto in miseria la sua famiglia, egli 36
R.Tessari, Op. cit., pag. 37
E. Sanguineti, Introduzione in A. Moravia, Gli indifferenti, Milano, Bompiani, 2009 pag. XXI 38
A.Moravia, Op. cit., pag. 191
18
programmerà di ucciderlo. Quest’atto di vendetta dovrebbe ripristinare quel quadro di valori
borghesi, quel ritorno alla dimensione umana poiché sarebbe stato compiuto provando dei
sentimenti, che, naturalmente, non prova. Ma anche quest’azione si traduce in una non azione; la
pistola non ammazzerà Leo, poiché è scarica. Un ultimo e teatrale gesto che rimarca ancora
l’impossibilità di potersi salvare dal declino e dalla crisi del presente.
È in questo punto del racconto che egli cerca di dissuadere, senza successo, la sorella dalla
proposta di matrimonio di Leo, interessato unicamente a non perdere la casa. Ma oramai Carla ha
deciso di compiere il suo destino, e di darsi in sposa a Leo; il suo gesto appare come l’unico
possibile; il rimedio alla sua condizione è il matrimonio, l’ennesimo atto borghese che dovrebbe
essere immagine di rettitudine. Ma, in realtà, questo matrimonio ha per Carla la stessa valenza che
per Michele ha avuto lo sparo mancato; è l’impossibilità di un’uscita dalla dimensione della
bassezza della propria esistenza logora, tanto più che nel momento in cui decide di sposarsi ella
sta già immaginando il suo triste futuro fatto di apparenza:
La sua vita continua così per anni… molti la invidiano… ella è ricca, si diverte, viaggia, ha un amante, che più? Tutto quel che può avere una donna lo ha…
39
Il significato che qui viene dato al matrimonio è completamente diverso da quello che
questo assume in Casa Howard: il matrimonio tra Margaret ed Henry, (curiosamente anche tra di
loro vi è una forte differenza d’età) sancisce l’unione tra i due volti della borghesia e questa unione
sembra rappresentare la possibilità della famiglia – così come della classe sociale – di essere
portatrice di valori. Vi è ancora nella visione di Forster la possibilità di una vita vera ed eticamente
corretta per i borghesi, simbolo anche del trionfo della borghesia. Le difficoltà vengono superate e
risolte (i tradimenti passati di Henry, la condizione di Helen madre senza marito) proprio
nell’unione della famiglia. L’affarismo e la povertà d’animo non avranno la meglio su quei valori
sinceri che Michele rimpiange in quanto assenti nella sua esistenza, e che Forster teme si possano
perdere.
Ne Gli indifferenti il matrimonio assume un valore negativo; la famiglia sarà ancora unita,
ma ancora attraverso le apparenze.
Siamo di fronte ad una condanna definitiva ed anche alla visione lucida di una crisi che
appare, oramai, senza possibilità di risoluzione. Una crisi molto più moderna e pienamente
novecentesca, che si stacca da quel realismo e positivismo dal quale Forster sembra invece non
volersi slegare. 39
Ivi, pag. 281
19
Al lieto fine forsteriano di Casa Howard, con il ricco raccolto di fieno, si contrappone il
fittizio lieto fine del matrimonio di Carla, che consegue anche la sistemazione lavorativa di
Michele. L’intera famiglia che si reca ad un ballo in maschera ci mostra, con un richiamo quasi
pirandelliano, l’oramai definitivo declino della classe borghese come modello morale.
20
CONCLUSIONI
La comparazione dei due testi presi in esame ci conduce a notare come lo stesso tema, ed
alcune caratteristiche comuni – come ad esempio la centralità della casa – portino, comunque, a
considerazioni e conclusioni estremamente diverse.
La cognizione dello scrittore rispetto al proprio tempo gioca un ruolo fondamentale e, in contrasto
con la serenità familiare di Casa Howard, Moravia appare molto più disilluso sul valore della
famiglia, oramai decaduto come ogni altro valore borghese.
Varcando la soglia data come limite temporale, e rifacendoci a tempi a noi più vicini,
soprattutto nel cinema e nella televisione vediamo il ripetersi del racconto della famiglia borghese.
Possiamo prendere come riferimento – uno tra tutti, ma il discorso si potrebbe sicuramente
ampliare – fiction come Una grande famiglia. Le prime due stagioni, trasmesse da Rai1 e dirette da
Ivan Cotroneo, hanno sullo sfondo una trama riconducibile al genere del giallo; all’inizio della
prima stagione il maggiore dei figli dei coniugi Rengoni improvvisamente sparisce lasciando un
buco milionario nell’azienda di famiglia e da qui si snoda il racconto, nel quale trovano spazio
storie secondarie, più leggere (amori e tradimenti) o che portano in campo temi di attualità come
l’omosessualità.
In ogni caso, in modo del tutto slegato dalla storia, vi è tracciato un netto profilo della
famiglia borghese. I Rengoni, ricca famiglia del nord sono quasi tutti impegnati nelle attività
dell’azienda di famiglia. Vivono in una casa lussuosa, hanno quasi tutti un livello di istruzione
elevata. Sono liberi professionisti, per lo più emancipati.
Nello specchio televisivo, vengono mostrati – anche solo visivamente – degli elementi che ci
portano a classificare quella famiglia come borghese.
La continuità nel tempo del racconto della famiglia borghese rende possibile, a mio avviso,
rintracciare ancora una classe borghese, una sua narrazione e, ancor’oggi una sua identificazione.
21
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
Bertinetti P.:
2000: Storia della letteratura inglese, Torino: Einaudi
Forster, E. M.:
2011: Casa Howard, Milano: Mondadori
Marenco, F. (a cura di):
1996: Storia della civiltà letteraria inglese, Torino: UTET
Moravia, A.:
2009: Gli indifferenti, Milano: Bompiani
Moretti, F.:
2013: The Bourgeois. Between History and Literature, New York-Londra: Verso
Tessari, R.:
1975: Alberto Moravia. Introduzione e guida sullo studio dell’opera moraviana. Storia e
antologia della critica, Firenze: Le Monnier
Woolf, V.:
2000: Gita al faro, Milano: Garzanti