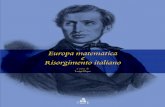Famiglia rurale e \"Sistema integrato\": Un modello di umanesimo sociale (1880-1910)
Transcript of Famiglia rurale e \"Sistema integrato\": Un modello di umanesimo sociale (1880-1910)
Fondazione Istituto Gramsci
Famiglia rurale e "Sistema integrato": Un modello di umanesimo sociale (1880-1910)Author(s): Fiamma LussanaReviewed work(s):Source: Studi Storici, Anno 43, No. 1 (Jan. - Mar., 2002), pp. 247-276Published by: Fondazione Istituto GramsciStable URL: http://www.jstor.org/stable/20567131 .Accessed: 30/08/2012 06:12
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Fondazione Istituto Gramsci is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to StudiStorici.
http://www.jstor.org
FAMIGLIA RURALE E <<SISTEMA INTEGRATO>>: UN MODELLO DI UMANESIMO SOCIALE (1880-1910)*
Fiamma Lussana
L'interesse per l'uomo piu che per l'operaio e un carattere tipico del sociali smo emiliano e romagnolo, le cui radici ideali sono rintracciabili nella tradi zione politica dell'Italia liberale e nella cultura dell'associazionismo operaio e democratico diffusa nell'area padana. Emancipare l'uomo, nel suo doppio significato morale e politico, era stato un motivo centrale della tradizione ri sorgimentale rappresentata dalle idee di Mazzini e Garibaldi ed e un carat tere originale dell'umanesimo integrale emiliano. Durante il congresso di Ge nova che, nel 1892, vedra nascere il Partito dei lavoratori italiani, dalla com ponente emiliana verra la sollecitazione a cambiare il nome in Partito socialista italiano. Cio avverra, come e noto, solo tre anni dopo, al congres so clandestino di Parma'. <<Solo operai? Solo lavoratori?>>, scrive Andrea Co sta nel suo diario alla fine di maggio del 1898, mentre si trova in carcere a
Milano. E dopo aver bollato di <<materialita'o e <brutalita>> gli statuti dell'In ternazionale che si rivolgono agli operai e ai lavoratori, continua: <<Nostro problema era umano. Lo ponevamo umanamente. Era l'uomo. L'umana mento dell'uomo>>2. f1 socialismo, scrive Costa, non dovra muovere da prin cipi astratti, ma da bisogni, da problemi concreti. Dovr"a partire dall'uomo e dai suoi diritti fondamentali, dal riconoscimento dell'eguaglianza naturale de gli uomini (<<Ma cio si capi tardi>)3. La politica come umanesimo e l'intrec cio fra morale e politica sono elementi chiave del socialismo emiliano e, come si vedra, questi aspetti diventano centrali soprattutto nel modello reggiano, nel socialismo riformista di Camillo Prampolini e Giovanni Zibordi.
* Rielaborazione della relazione presentata al seminario di ricerche storiche organizzato a
Reggio Emilia il 21 e 22 giugno 2001 dalla Camera del lavoro, in occasione del suo cente simo anniversario. 1 Cfr. II sodalismo nella storia d'Italia. Storia documentar?a dal Risorgimento alla Repubbli
ca, a cura di G. Manacorda, Bari, Laterza, 1966, p. 185. 2 A. Costa, Annotazioni autobiografiche per servir? alle ?Memorie della mia vita?, in ?Mo
vimento operaio?, n.s., IV, marzo-aprile 1952, p. 319. 3
Ibidem.
248 Fiamma Lussana
Fra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del nuovo secolo, la diffusione delle idee sull'uomo socialista e sulla morale sociale sono all'origine di cam biamenti profondi nella mentalita e nel costume. fl mondo rurale attraversa una difficile fase di passaggio, tipica della transizione al modello industriale, ed e permeabile a questa corrente di idee che si intreccia con riti, tradizioni e consuetudini della vita dei contadini. Vangelo e socialismo sono due espres sioni della nuova morale sociale, tipiche del mondo rurale: hanno in comu ne un 'aspirazione alla trascendenza che prefigura un mondo di redenzione e di giustizia partendo dai bisogni concreti dell'uomo. Attraverso le analisi di Prampolini e Zibordi, fermeremo l'attenzione sulla variante reggiana del so cialismo riformista, dove l'uomo e inteso come singolo soggetto e la morale sociale e la sua spinta ideale a riconoscersi in un organismo collettivo in cui i bisogni individuali si integrano con i bisogni di tutti. In tal senso si puO par lare di socialismo integrale reggiano. Vedremo come la famiglia mezzadrile,
molecola base di questo socialismo, rappresenti un modello morale compiu to e autosufficiente di integrazione sociale. Nella sua struttura semplice e ar ticolata si leggono con straordinaria chiarezza bisogni e contraddizioni di un
mondo che cambia: nella famiglia del wbuon mezzadro>>4, contrapposta a quella del bracciante salariato o dell'operaio agricolo che viene emergendo negli anni dell'industrializzazione, troviamo lo stesso incastro fra bisogni sog gettivi e bisogni sociali che sara alla base del sistema integrale delle coopera tive di consumo, il cosiddetto ?sistema integrato>> reggiano. Tale sistema, che sperimenta un nuovo equilibrio produttivo, prefigura un'idea di societa dove i bisogni individuali diventano funzionali agli interessi produttivi e la media zione politica si afferma come strumento per sanare la conflittualita. Cerche remo di far emergere la corrispondenza fra il modello morale della grande famiglia patriarcale emiliana, ultimo e persistente baluardo territoriale, mi
4 Importanti contributi sulla famiglia mezzadrile come unit? morale e produttiva sono i la
vori di C. Poni, La famiglia e il podere, in Cultura popolare nell'Emilia Romagna. Struttu
re rurali e vita contadina, Bologna, Federazione delle Casse di risparmio delPEmilia e Ro
magna, 1977 (lo stesso saggio, ampliato e aggiornato, ? stato pubblicato col titolo Family and ?podere? in Emilia Romagna, in ?The Journal of Italian History?, I, Autumn 1978, 2,
pp. 201-234), e Fossi e cavedagne benedicon le campagne. Studi di storia rurale, Bologna, Il
Mulino, 1982 (in particolare il cap. VI, La famiglia contadina e il podere in Emilia Roma
gna); cfr. inoltre il fascicolo monogr?fico di ?Quaderni storici? dedicato a Famiglia e co
munit? (1976, 33); Famiglia e mutamento sociale, a. cura di M. Barbagli, Bologna, Il Muli
no, 1977; D.I. Kertzer, Famiglia contadina e urbanizzazione. Studio di una comunit? alla pe
riferia di Bologna. 1880-1910, Bologna, Il Mulino, 1981; A. Manoukian, La famiglia dei
contadini, in La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi, a cura di P. Melograni con la col
laborazione di L. Scaraffia, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 3-60; M. Barbagli, Sotto lo stes
so tetto, Bologna, Il Mulino, 1988; Storia della famiglia italiana 1750-1950, a cura di M.
Barbagli e D.I. Kertzer, Bologna, Il Mulino, 1992; R. Zangheri, Storia del sodalismo ita
liano, I, Dalla Rivoluzione francese a Andrea Costa, Torino, Einaudi, 1993, pp. 112 sgg.
249 Famiglia rurale e <<sistema integrato>>
nacciato dal diffondersi del modello bracciantile di famiglia nucleare, e il mo dello cooperativo ?integrato>>, basato sull'interazione costante fra bisogni sog gettivi e benessere collettivo. 1. Mezzadri e braccianti. Fra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni
Ottanta dell'Ottocento, l'impiego su larga scala dele nuove tecnologie, so prattutto al Nord e al centro del paese, coincide con la fine della <<tregua so ciale>> e della <<proletarizzazione indolore>> che avevano accompagnato il de collo del modello agricolo, perseguito dai gruppi dirigenti liberali. Crescono in questi anni la produzione cerealicola al Nord, mentre al Sud della peni sola prevale l'agricoltura da esportazione (vino, olio e agrumi). Crescono i
margini di profitto per la parte padronale, che trae vantaggi considerevoli dal la modernizzazione delle campagne e che vuole competere con i mercati eu ropei. Cresce, parallelamente, la sproporzione fra l'Italia centro-settentriona le, dove il modello di sviluppo agricolo 'e al passo coi tempi, e l'Italia del Sud, dove sopravvivono forme e metodi di conduzione agricola di tipo semifeu dale e dove l'arretratezza e le condizioni di vita miserabili sono all'origine del vasto movimento migratorio che coinvolge il mondo rurale. La modernizzazione postunitaria precede la crisi agraria che, fra il 1882-83 e il 1888, si configura largamente come una crisi di sviluppo e come ricerca di nuovi mercati, intrecciandosi fortemente con quella piu generale crisi di tran sizione dell'assetto economico, sociale e politico del paese, che prelude al de finitivo decollo industriale. La crisi agraria sar'a un fenomeno di lunga dura ta e di profonda intensita, destinato a sconvolgere il quadro economico e so ciale delle campagne italiane che, nel ventennio postunitario, si erano largamente giovate del modeblo di sviluppo liberista. Ed e anche all'origine della crisi sociale che attecchisce sulle contraddizioni delo sviluppo e sulla sua disomogeneit'a. II moderno modello di produzione agricola, avviato nei due decenni postunitari dalla politica liberista del governo, e la premessa na turale della nascita di un proletariato agricolo, destinato ad assumere sempre piu( un carattere di classe. La crisi agraria degli anni Ottanta rompe l'equili brio precario che ha fin 1i contraddistinto il modello di sviluppo nelle cam pagne e genera una forte spinta al cambiamento sociale che anima i rigurgi ti <<rivoluzionari>> del mondo rurale. La protesta dei lavoratori della terra co
mincia nella Bassa Padana, proprio nella zona dove l'ammodernamento delle forme di produzione e piu forte: le bonifiche, l'irrigazione, l'impiego delle
macchine fanno di questa terra un modello di equilibrio produttivo, forte mente collegato al progresso tecnologico e, nello stesso tempo, un esempio eclatante della contraddizione fra progresso e crisi sociale. Gli anni che precedono lo scoppio della rivolta contadina - che raggiunge la massima visibilita dall'estate del 1884, quando, nel Polesine, si sviluppa il mo vimento de <<La boje? - sono gli anni dell'impiego delle idrovore a vapore per la bonifica della terra. Col generale riassetto del territorio all'insegna del
250 Fiamma Lussana
la crescita e del progresso, migliaia di lavoratori della terra sono espulsi dal ciclo di produzione e gran parte dei salariati fissi diventano braccianti av ventizi. E noto come la rivolta de <<La boje>> - di cui, secondo le autorit'a, sa rebbe responsabile la propaganda di anarchici, repubblicani e socialisti - si risolva in un temporaneo successo dei lavoratori, destinato pero a rifluire, prima ancora che la svolta protezionista del governo Crispi scarichi i costi della crisi soprattutto su rendite e salari. Anarchici e radicali guidano nel Po lesine le agitazioni contadine che, altrove, si sviluppano invece nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Sviluppo nelle campagne, crisi agraria e rivolta dei contadini sono i passaggi che segnano, dalla meta degli anni Settanta alla meta degli anni Ottanta, la transizione al decollo industriale. Le contraddizioni di questa epoca di pas saggio pesano soprattutto sul mondo rurale in cui si rompe il modello pro duttivo basato sulla famiglia mezzadrile e incomincia ad emergere il brac ciantato di massa. L'atto di nascita della famiglia patriarcale complessa, gruppo sociale dotato di un preciso codice comportamentale, che puo arrivare a comprendere quin dici o venti individui5, e soprattutto organismo integrale e unita produttiva di base, dove ciascun componente ha precisi ruoli e funzioni, e strettamente collegato in Emilia e in Toscana al contratto di mezzadria. La grande famiglia patriarcale comincia cioe a svilupparsi attorno alla casa colonica e al podere6. f1 numero dei componenti e funzionale alla produzione: se una famiglia di
mezzadri e troppo piccola puo comprare braccia, come durante la festa del l'Annunziata (la <<Madona di garzon>>), ogni 25 marzo, quando a San Gio vanni in Persiceto o a Borello, i braccianti poveri portano i figli adolescenti, offrendoli come garzoni. Nella famiglia contadina emiliana e toscana, tipica espressione della cultura mezzadrile, cogliamo una contraddizione che e, a suo modo, anche un pro
5 E. Carretti, in un ciclostilato dal titolo La vecchia famiglia patriarcale contadina, scritto in
collaborazione con M.P. Nediani e conservato presso il Museo dell'agricoltura di San Mar
tino in Rio (Reggio Emilia), cita casi-limite di famiglie contadine di 50 membri, come i Mo rini di San Donnino di Casalgrande nei 1914. 6 Cfr. Poni, La famiglia e apodere, cit., p. 108. Zibordi si sofferma sulla tipolog?a della fa
miglia mezzadrile nella provincia di Reggio Emilia: ?il fondo si aggira su le 50 blolche (cir ca 15-20 ettari); e se nella collina e montagna vi ? la piccola propriet? povera, e se nella bas
sa pianura verso il Po vi ? il latifondo, il n?cleo maggiore ? formato di fondi condotti a mez
zadria o in affitto da una famiglia di agricoltori conduttori-coltivatori diretti del suolo?. I
contadini di quella zona, nota sempre Zibordi, sono sui generis perch?, rispetto ai coloni di
altre regioni, sono favoriti dalla grande fertilit? del suolo e dall'arteria Milano-Bologna che
facilita il commercio dei prodotti. Sono spesso benestanti, ma non per questo rinunciano
?a lavorare essi stessl? i campi. Tenaci e laboriosi, attaccati alla loro terra, rimangono ?fe
deli alla terra e alla fatica dei campi? (G. Zibordi, Saggio sulla storia del movimento op?ralo in Italia. Camillo Prampolini e i lavoratori reggiani, Bari, Laterza, 1930, pp. 101-102; 103).
251 Famiglia rurale e *<sistema integrato>>
blema storico: il suo essere insieme un'unita sociale autoritaria, serrata attor no alla figura carismatica del reggitore, e una unit'a produttiva integrale, un modello morale dove si intrecciano in armonia bisogni soggettivi e interesse collettivo. La famiglia mezzadrile e cioe un prototipo di autoritarismo e di egualitarismo: da un lato c'e il potere indiscusso del capofamiglia, che so vrintende alle scelte della produzione e al lavoro nei campi; dall'altro la ?vera comunione universale di tutti i beni>> owero, la comune distribuzione di beni e risorse fra i diversi membri della famiglia. Tutti anche se in modo diverso partecipano dei prodotti della terra e del lavoro. Nel mese di novembre, alla fine del contratto che ha scadenza annuale, la parte dei frutti del raccolto che spetta al mezzadro, viene divisa fra i membri del gruppo familiare in base a precisi criteri relativi al lavoro prestato, al sesso e all'eta: ai bambini sotto i dodici anni non spetta niente, perche sono un carico passivo e hanno rice vuto vitto e vestiario; dai dodici ai diciotto anni si ricevono i due terzi di quanto spetta ai maschi adulti che hanno compiuto diciotto anni; le donne, le cui occupazioni principali sono la cura del pollaio, la pulizia domestica, la preparazione del cibo e, d'inverno, la filatura, ricevono i due terzi di quanto spetta agli uomini. Le donne non hanno un potere visibile, ma una funzione altamente simbolica, garante dell'unita e della compattezza del gruppo fami liare: prima di lasciare la casa colonica per trasportare mobili e prodotti del raccolto in un altro podere, la reggitrice stacca dal camino la catena e porta via gli alari, oggetti simbolo dell'unita domestica. Come il capitano che ab bandona una nave alla deriva, e l'ultima a lasciare la casa dopo aver messo in salvo le cose da portar via, ma e la prima ad entrare nella nuova, dove il suo primo gesto sara accendere il fuoco o mettere sale e olio beneauguranti sul camino. I1 patrimonio <vecchio>, che comprende i beni della famiglia, non ha mai come destinatario un solo erede, ma l'intera comunita. Solo le donne <non sono comprese nella comunione>> perche sono destinate ad abbandona re la famiglia di origine con il matrimonio e bisogna impedire che il patrimo nio si disperda: usciranno dalla famiglia con la dote che, nell'Ottocento, com prende il letto, il canterano o un baule, quattro lenzuola e una coperta7. La contraddizione fra autoritarismo e comunismo segna profondamente la cultu ra contadina di vaste aree territoriali dell'Italia centrale, ne condiziona ritmi di sviluppo e consuetudini lungo t'arco di diverse generazioni, fino all'aboli zione del contratto di mezzadria che, come e noto, avviene solo nel 1964. Per
7 Solo nel corso del Novecento la dote diventer? pi? ricca. Sulla trasmissione del patrimo
nio nella famiglia mezzadrile, cfr. Pon?, La famiglia e apodere, cit., pp. 112 sgg. Sulle re
g?le della comunione famili?re cfr. M. Palazzi, Famiglia, lavoro e propriet?: le donne nella
societ? contadina fra continuit? e trasformazione, in Istituto ?Aleide Cervi?, ?Annali?, 12,
1990, soprattutto pp. 48 sgg. e la bibliograf?a citata.
252 Fiamma Lussana
la sua doppia connotazione di modello autoritario ed egualitario, il comuni smo staliniano e stato avvicinato alla struttura della famiglia mezzadrile8.
A partire dalla seconda met'a dell'Ottocento, l'aumento della produttivita dei terreni agrari dipende in gran parte dall'introduzione di nuove tecnologie, di
macchine per la semina, la trebbiatura, la falciatura o per la bonifica dei ter reni. f1 progresso tecnologico e la modernizzazione delle campagne, cui gia si e accennato, modificano sensibilmente morfologia, ruoli e funzioni di im portanti microstrutture territoriali, l'azienda-famiglia in primo luogo. Emer ge la figura del bracciante-operaio, che insidia cultura, compattezza e con suetudini della grande famiglia mezzadrile. Le fotografie delle famiglie patriarcali, riprodotte da Poni nei suoi studi sul la famiglia e il podere in Emilia Romagna, ritraggono gruppi familiari in posa davanti alla casa colonica, durante il lavoro nei campi o raccolti in uno spa zio domestico scelto accuratamente come sfondo dell'immagine fotografica. Nell'azienda-famiglia strategie produttive e regole generali di convivenza sono rigidamente accentrate nelle mani del reggitore e della reggitrice che de tengono tutto il potere: il primo per il lavoro nei campi, la seconda per i la vori domestici. La disposizione dei membri della famiglia ricalca uno sche ma di potere gerarchico: generalmente al centro della foto sono seduti il reg gitore e la reggitrice o uno dei due e attorno a loro la famiglia, grande o piccola, ma piu spesso estesa in tutte le sue diramazioni con i fratelli e le so relle, i figli, i nipoti, i cugini. I grandi sono al centro, i giovani e i bambini in posizione periferica, i piccoli in braccio alle madri. Le espressioni sono il piu delle volte gravi, solo raramente qualcuno sorride, come a voler testimonia re la solennita del ritratto di gruppo che, per le generazioni che lo conserve ranno, sara la memoria ufficiale della famiglia. Una foto del 1880 circa, che ritrae una famiglia di Canolo di Correggio (Reggio Emilia), raffigura i mem bri del gruppo familiare divisi per sesso e, si potrebbe dire, quasi per fun zione sociale: le donne si affacciano dalle finestre al primo piano della casa colonica; gli uomini sono tutti all'esterno, in piedi, con il cappello in testa, davanti alla porta di ingresso. Un'altra foto, scattata nella campagna reggia na nel 1894 circa, ritrae un nonno con la barba e il cappello, seduto al cen tro di un gruppo di nipoti: il volto e serio e guarda verso l'obiettivo, mentre i ragazzini che lo circondano guardano lui con aria intenta e quasi con sog gezione. Una foto scattata durante la prima guerra mondiale, forse nel 1917, a San Martino in Rio (Reggio Emilia) raffigura una famiglia nucleare: la ma dre, forse vedova, e al centro in abito lungo scuro ed e circondata dai suoi dieci figli, raggruppati per sesso, eta e per abito: le femmine mediane sono a
8 Cfr. L. Paggi, Storia di una memoria anti-partigiana, in Storia e memoria di un massacro
ordinario, a cura di L. Paggi, Roma, Manifestolibri, 1996, pp. 58-59. Paggi si riferisce al
Panalisi di E. Todd in L'invention de l'Europe, Paris, Editions du Seuil, 1990.
253 Famiglia rurale e +<sistema integrato>>
destra, vestite di chiaro; le piu grandi sono dietro alla madre, assieme ai fra telli, vestiti di scuro; accanto a lei si tengono per mano le femmine piu pic cole sempre in abito scuro e con i volti imbronciati. L'inchiesta parlamentare Jacini sull'agricoltura, svolta fra il 1878 e il 1885, e an cora una fonte indispensabile per fotografare la realta sociale delle campagne e le condizioni di vita di mezzadri e braccianti. Dai diversi rapporti regionali si ri cavano i caratteri specifici territoriali del mondo rurale e il sovrapporsi, soprat tutto nelle aree mezzadrili dell'Italia centrale, della figura emergente del brac ciante a quella del mezzadro. Oltre a rappresentare un'unita morale, salda e compatta, la famiglia mezzadrile e anche un'unita produttiva autosufficiente: al leva polli, maiali e pecore, produce il vino e iA cibo di cui ha bisogno e i filati per confezionare il vestiario. Canapa, frumento, granturco sono i prodotti prin cipali. Gode di una relativa stabilita e di un certo benessere. Lo spazio delle per sone e ben separato dalo spazio degli animali: la stalla, che i ragazzi oltre i do dici anni usano per dormire, diventa un luogo simbolico di relazione sociale. Nelle campagne emiliane, soprattutto nei mesi invemali, vi si svolgono i trebb, raduni notturni che, per il loro carattere trasgressivo, dal momento che vi si ri trovano donne e uomini insieme, sono condannati dalla Chiesa che li ritiene ?al I'anima pericolosi>>9. L'ambiente e riscaldato dagli animali e la famiglia o piu gruppi di famiglie vi trascorrono insieme quattro o cinque ore, passando la not te in diverse occupazioni o a chiacchierare. Gli uomini giocano a carte e rac contano episodi di vita del villaggio, parlano del raccolto o di politica. Le don ne filano la canapa alla conocchia e intanto raccontano storie di fantasmi, fuo chi fatui, malocchio, stregonerie. I giovani si corteggiano e ai primi approcci nella stalla seguono spesso fidanzamenti e matrimoni. Funzioni comuni sono la preghiera o la festa. Nella stalla si fa musica, si canta, si improvvisano reci te, il cosiddetto ?teatro di stalla>>. Prende forma una vera e propria vita co
munitaria con i suoi riti, le sue superstizioni, la sua religione. I trebb sono un'e spressione della cultura mezzadrile: delimitati nel tempo e nello spazio, sim boleggiano una comunita integrale, un modello morale, dove ciascuno ha un suo ruolo specifico, ma entra in rapporto con gli altri creando un circuito di rela zioni sociali. Ci sono funzioni divise per sesso e per eta, ma c'e il momento del la condivisione in cui, coralmente, attraverso la preghiera, si da libero sfogo al bisogno di spiritualita o, con il canto e il balo, al bisogno di divertirsi. Diversa e la condizione dei braccianti. A dieci anni il bambino e gia adulto perche comincia a lavorare per la famiglia - raccogliendo erba e legna o pa scolando la <vaccherella della casa>> - o per il padrone del fondo. La donna
9 Cfr. Atti della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agr?cola (d'ora
in poi Inchiesta Jadni), vol. VIII, t. 1, Roma, 1883, pp. 640 sgg. Sulla funzione della stal
la e sui trebb cfr. rispettivamente Manoukian, La famiglia dei contadini, cit., p. 18, e Poni,
La famiglia e il podere, cit., p. 111.
254 Fiamma Lussana
invece, che fin da piccola comincia a lavorare in casa e in campagna, ?si reca in giornata>> all'eta di quattordici o quindici anni, zappando la melica o mon dando il riso. E si guadagna il corredo che le servira per trovare marito10. fl bracciante, ?misero sempre e dappertutto>>? e contrapposto per definizione al <<buon mezzadro>> e alla societa morale del gruppo mezzadrile, ha una casa angusta, disadorna, malsana, arredata con un letto di tavole, un pagliericcio, una culla, qualche ?cuccia per le figlie? e un tavolo di legno'2. Ha un nucleo familiare semplice, mononucleare, scarsa propensione per la cura dei rapporti familiari. Ha una reputazione poco raccomandabile, dal momento che i brac cianti sono normalmente ritenuti responsabili dei furti dei prodotti del rac colto e del bestiame, e trascorre il tempo libero all'osteria, a bere o a gioca re. Con la vanga, la zappa e le sue braccia, che sono le sole cose che possie de, il bracciante offre il suo lavoro quando ce n'e bisogno: viene pagato a giornata, a mese, a stagione per la mietitura, la fienagione, la vendemmia o per i lavori piu pesanti collegati alla bonifica di terre malsane o di manova lanza occasionale. 1E il primo ad essere chiamato quando le diverse fasi del lavoro nei campi lo richiedono ed e ancora il primo ad essere espulso se non serve piu. E un operaio agricolo disamorato della terra, perche non la pos siede, del suo lavoro, perche cambia continuamente, e della sua famiglia, che e generalmente piccola e a cui non ha tempo per affezionarsi. La perdita di autorita della famiglia mezzadrile come sistema di relazioni di potere e come unita produttiva autonoma e direttamente proporzionale, come si e visto, allo sviluppo dei sistemi di produzione. La modernizzazione delle campagne e le opere di bonifica richiedono la forza lavoro di decine di migliaia di <scarriolanti>> e di zappatori. E i giovani sono attratti dalla pro spettiva di un guadagno autonomo, fuori del controllo del reggitore o del pa drone del podere. I1 numero sempre crescente di operai agricoli sottrae brac cia alla famiglia mezzadrile, messa a dura prova dal ridimensionamento dei suoi componenti. La prospettiva di assumere garzoni occasionali e infatti un elemento di forte instabilita economica per l'azienda-famiglia, gia duramen te colpita dall'obbligo del servizio di leva che le sottrae le forze migliori.
Anche se minacciata dal capitalismo nelle campagne e dall'emergere del brac ciantato, la famiglia colonica patriarcale e tuttavia un fenomeno persistente, che tende per lungo tempo a sopravvivere parallelamente all'aumento dei nu
10 Cfr. Inchiesta Jadni, vol. VIII, t. 1, pp. 627-628.
11 Per la descrizione della vita del bracciante e la sua definizione, tratte dall'inchiesta Jaci
ni, cfr. Manoukian, La famiglia dei contadini, cit., p. 29. 12
?Tutta questa roba che non val 150 lire in totale la si pone venuto il tempo del San Mar
tino, su un carro tratto da due buoi e la si reca nella nuova dimora distante forse parec chi chilometri dall'antica? (Inchiesta Jadni, vol. VIII, t. 1, p. 628).
255 Famiglia rurale e <<sistema integrato>>
clei familiari bracciantili"3. fl suo declino e lento anche se inesorabile: le ra gioni della sua forza stanno principalmente nella sua cultura, nella sua mo ralita, nel suo essere, come la cooperativa, al tempo stesso un'unita di pro duzione e di consumo. Anzi, la nostra ipotesi e che il sistema mezzadrile e il ?sistema integrato? delle cooperative di consumo sono sistemi contigui: al de clino dell'uno corrisponde lo sviluppo dell'altro. Tuttavia, pur rappresentan do due sistemi integrali, cioe moralmente coesi e armonici, sono entrambi retti da un principio antistorico: sono mondi separati, autarchici, territorial
mente autosufficienti, slegati dallo sviluppo economico nel suo complesso. Particolarismo, corporativismo, autarchia sono i caratteri principali della fa miglia mezzadrile, ma sono tratti distintivi anche della cooperativa di consu mo. La famiglia colonica patriarcale e la cooperativa di consumo rappresen tano simbolicamente due cittadelle assediate, dal capitalismo agricolo e dal bracciantato di massa la prima, dallo sviluppo di un'economia di mercato e di interscambio, la seconda.
2. Famiglia rurale e <<sistema integrato>>. Sono cinque gli elementi attraverso cui e possibile immaginare una relazione fra cultura mezzadrile e sistema coo perativo. II primo e di carattere morfologico: sia il gruppo familiare mezza drile che la cooperativa di consumo sono comunita integrali. Esiste cio'e un rapporto osmotico fra singoli soggetti e gruppo e le esigenze individuali sono sempre mediate dalla prospettiva del benessere collettivo. I1 secondo e il ca rattere di utopia sociale che accomuna la famiglia mezzadrile e la cooperati va di consumo che rappresentano comunita integrali basate al tempo stesso su un forte progetto teorico e su una pratica di socialismo sperimentale. Per quanto strano possa sembrare, il modelo economico e sociale delle coope rative, espressione fra le piu vitali della cultura imprenditoriale di vaste aree produttive dell'Italia centrale, affonda le sue radici nel socialismo utopistico. La prima idea di <villaggi cooperativi>, in cui realizzare una societa comuni sta basata sulla giustizia sociale e l'utopia di un industrialismo a misura d'uo
13 Kertzer, che ha studiato l'impatto dell'urbanizzazione sulla composizione dell'aggregato
domestico a Bertalia, una comunit? alla periferia di Bologna, fra il 1880 e il 1910, nota la
persistenza degli aggregati domestici di tipo complesso sia fra i mezzadri che fra i brac
cianti (che pure sono i due terzi dei lavoratori agricoli). Nella trasformazione delle fatto
rie da mezzadrili a bracciantili, viene meno progressivamente la caratteristica della grande
famiglia patriarcale come unit? produttiva (cfr. Kertzer, Famiglia contadina e urbanizza
zlone. Studio di una comunit? alia periferia di Bologna. 1880-1910, cit., pp. 73 sgg.). Sia
Kertzer che Poni mettono in rilievo che il passaggio dal sistema mezzadrile a quello brac
ciantile non implica necessariamente la contrazione o nuclearizzazione dell'aggregato do
mestico. Poni sottolinea come la diminuzione della mortalit? infantile e la crescita delle at
tese di vita dopo i vent'anni contribuiscano ad incrementare le dimensioni delle grandi fa
miglie coloniche (cfr. Poni, La famiglia e apodere, cit., p. 114).
256 Fiamma Lussana
mo si deve a Robert Owen che, all'inizio dell'Ottocento, da vita in America at primo esempio di comunita cooperativa. Organismi armonici creati, se condo Vergnanini, dall'ottimismo di un osognatore>>4, le comunit'a impianta te da Owen a New Harmony come i Falansteri creati parallelamente in Fran cia da Fourier, sono esperimenti destinati al fallimento. La stessa doppia con notazione di utopia e sperimentalismo segna la famiglia mezzadrile, unita morale e produttiva braccata dal sistema bracciantile e dal crescente conflit to di classe fra capitale e lavoro. Terzo elemento di raccordo fra famiglia ru rale e sistema cooperativo e il meccanismo circolare produzione-consumo che crea, sia all'interno del gruppo familiare che nel <<sistema integrato>>, un equi librio fra bisogni soggettivi e risposte a tati bisogni in termini di distribuzio ne delle risorse. Le dure condizioni di vita dei contadini e la lotta per la so pravvivenza contro la miseria e la fame contribuiscono a radicare nella cul tura mezzadrile un'istintiva tendenza al calcolo e al risparmio: quarto elemento di raccordo e la tradizione materiale, ovvero quell'attitudine seco lare, tipica della famiglia contadina, ma anche dell'esperienza cooperativa, a far quadrare conti e bilanci, a calcolare costi e benefici, a stare con i piedi per terra. La contabilizzazione dei prodotti del lavoro, che il mezzadro do vra dividere a meta con il proprietario del fondo, si estende anche ai rapporti familiari: secondo determinate proporzioni, a ciascuno spetta una parte dei prodotti del raccolto. Contabilita e attaccamento alla terra e ai suoi beni ma teriali sono tratti distintivi della cultura rurale che materializza la stessa, for tissima, aspirazione alla trascendenza, tesa a umanizzare Dio e i santi piu che a metterli su un piedistallo. Nel sistema cooperativo l'interesse per i beni ma teriali e all'origine di quel diffuso dinamismo imprenditoriale che segna come un codice genetico aspirazioni e attitudini in una vasta area territoriale, che comprende soprattutto Toscana ed Emilia, dove piu forte che altrove e l'in treccio fra cultura positiva, sperimentalismo, imprenditorialita.
Come la cooperativa, infine, la famiglia mezzadrile e un'unita produttiva, un' azienda, dotata di regole interne e autosufficiente. La famiglia contadina e una molecola sociale di tipo autoritario, rigidamente sottoposta al control lo del proprietario del fondo e, al suo interno, a regole ferree di dipendenza dal reggitore. La casa dei mezzadri e generalmente collocata al centro del po dere, in posizione di isolamento, materiale e simbolico, dal mondo esterno, dal paese, dall'osteria. Sorge in mezzo al podere, dove si lavora la terra: e lon tana dai luoghi di socializzazione, ma rappresenta il luogo materiale in cui coincidono l'<unita produttiva>> e l'<unita di consumo>>. E un mondo a se, una roccaforte, il cui compito naturale e custodire una tradizione secolare di
14 II giudizio di A. Vergnanini ? in Le due grandi vie della rivoluzione econ?mica. Marxi
smo-cooperativismo, edito a cura della Lega nazionale delle cooperative e della Federazio
ne italiana delle societ? di m.s., Milano, 1914, p. 8.
257 Famiglia rurale e <<sistema integrato>>
vita comunitaria, resistendo allo sgretolamento del gruppo di cui sarebbero responsabili il progresso industriale e la tendenza inarrestabile, tipica del gruppo familiare bracciantile, a spezzare l'armonica compattezza della gran de famiglia patriarcale. Diffidenza e ostilita furono gli atteggiamenti prevalenti nel partito socialista verso l'esperienza dedle cooperative. Solo il loro dilagante proliferare deter mina, all'inizio del secolo, un cambiamento d'opinione. Pesa sul movimento cooperativistico di fine Ottocento il giudizio inappellabile dello stesso Marx, piu indulgente verso le cooperative di produzione e lavoro rispetto a quelle di consumo, ma che bolla in generale il movimento delle cooperative di egoi smo corporativo se non di esplicito compromesso col mondo borghese15. <<L'i dea della cooperazione di consumo, questo germe di una grande concezione economica - scrive Vergnanini - sboccio dalla mente di modesti operai>>6: lo sforzo del socialismo emiliano e reggiano e radicare il movimento cooperati vistico nella tradizione del marxismo e del socialismo nazionale anche a ri schio di acrobatiche forzature. Argomento forte per dimostrare le analogie fra cooperativismo e socialismo sarebbe il fine comune: I'abolizione dello sfruttamento capitalistico e la costruzione di una societa socialista in cui i pro dotti del lavoro vengono egualmente distribuiti e consumati dagli stessi la voratori"7. Soprattutto la cooperativa di consumo in cui, come nella grande famiglia patriarcale, i prodotti del lavoro diventano beni di consumo per i suoi stessi membri, e un organismo armonico, nella cui tensione morale si in trecciano bisogni individuali e interesse collettivo. La moralita della coope rativa di consumo sta nella sua unit'a e nel rapporto di reciprocit'a che lega i suoi membri. La sua interna coesione e apertura verso esperienze analoghe la rende quasi uno <<Stato in formazione>>, una molecola sociale, potenzial
mente protesa verso altri aggregati sociali moralmente coesi. <<Di qui la ne cessita - scrive Vergnanini - che le Cooperative di ogni localita a mezzo di organi coordinatori, si colleghino fra loro ed agiscano come le membra di un unico organismo nazionale>>18. Disgregata e frazionata, la cooperativa di con
15 Cfr. XI Congresso nazionale del Partito socialista italiano (Milano, 21-22-23-24-25 otto
bre 1910), Cooperazione e sodalismo, relazione di Nullo Baldini e Antonio Vergnanini, Reg
gio Emilia, Cooperativa lavoranti tipografi, 1910, pp. 3 sgg. 16 Vergnanini, Le due grandi vie della rivoluzione econ?mica, cit., pp. 6-7.
17 ?La cooperazione di consumo - scrive Vergnanini
- [...] collima coi principi collettivi
sti, propugnati dal socialismo. Essa ? socialista per natura e la sua azione quotidiana d'e
liminazione dello speculatore privato dal campo della produzione e dei servizi di distribu
zione ? la pratica attuazione del programma socialista che vale emancipare la societ? dal
la soggezione econ?mica del capitale? (A. Vergnanini, La cooperazione di consumo e
Vorganizzazione sindacale, edito per cura della Lega nazionale delle cooperative, Como,
1914, p. 8). 18
Ivi, p. 9.
258 Fiamma Lussana
sumo non avrebbe maggior valore di qualunque altra azienda commerciale ?ingranata alla catena della speculazione privata della quale sarebbe uno dei tanti anelli?". In realt'a, il limite oggettivo di tale esperienza, cio che la ren de socialista solo come utopia sociale, e che la cooperativa di consumo sara morale solo finche non avra bisogno di stringere rapporti d'affari e d'inte resse con altre ditte produttrici o di ricorrere alle banche del mondo capita lista. In una parola, come l'azienda mezzadrile, la cooperativa sara integrale finche sar'a autosufficiente. Sara socialista finche bastera a se stessa, cittadel la morale assediata dallo sviluppo industriale e dal capitalismo. La <<forza di consumo>> la quantita dei consumatori che la cooperativa avra saputo con quistare. II paradosso cui giunge Vergnanini e che ?la sua vittoria finale verra consacrata il giorno in cui tutti i consumatori saranno passati sotto la sua ban diera>>20. La proposta del ?sistema integrato>> trae origine da una semplice constata zione: nell'ordinamento capitalistico la produzione e il consumo si basano su una legge illogica e irrazionale che viene chiamata ?legge di inversione>>. Pro duzione e consumo, che dovrebbero procedere in stretto rapporto di reci procita, secondo ?rigide norme di corresponsione>>, si svolgono invece in modo innaturale: <la distribuzione della ricchezza si compie [...] in modo che gli uomini e le classi sociali [...] partecipano al godimento dele ricchezze in proporzione inversa degli sforzi da loro fatti per produrre>>21. Marxismo e cooperativismo danno risposte diverse a tale fenomeno: sostenendo l'analo gia di obiettivi e di effetti fra le due scuole, Vergnanini sostiene invece la loro semplice differenza di tattica. L'organizzazione sindacale o di resistenza, in cui si riconosce il socialismo scientifico marxiano, pratica la lotta di classe che, attraverso scioperi e agitazioni organizza i lavoratori proletari contro i borghesi capitalisti. La lotta fra capitale e lavoro ha come fine l'abolizione del profitto che, nella teoria marxiana, e lavoro non pagato mentre, secondo la scuola cooperativistica, e il prezzo ingiusto pagato in piu dai consumato ri. Per il marxismo, il profitto dovra ritornare al produttore, per il coopera tivismo al consumatore. Ma, secondo Vergnanini, si tratta di una differenza apparente perche la parte di profitto estorta dal capitalista al produttore ri torna comunque al lavoratore che, nella cooperativa di consumo, si identifi ca con il consumatore22.
19 Ivi, p. 10.
20 Ivi, p. 12.
21 Vergnanini, Le due grandi vie della rivoluzione econ?mica, cit., p. 7.
22 ?Secondo la teor?a del plusvalore marxista il profitto che intasca il capitalista ? lavoro
non pagato, secondo la scuola cooperativistica sarebbe invece il prezzo pagato in pi? dal
consumatore. Secondo il marxismo il profitto dovrebbe ritornare al produttore, secondo
la cooperazione al consumatore? (Vergnanini, Le due grandi vie della rivoluzione econ?
mica, cit., p. 18).
259 Famiglia rurale e <<sistema integrato>>
Esiste in realta una differenza fondamentale fra marxismo e cooperativismo che ne segna l'azione e le strategie, vanificando qualunque tentativo di un loro possibile avvicinamento: il primo pratica la lotta di classe pura, il movi
mento cooperativo agisce invece attraverso la ?politica della neutralita>> che, nella variante reggiana del socialismo emiliano, si identifica con la <<lotta senz 'odio>>. La teoria del <<sistema integrato>> delle cooperative di consumo si basa sull'unita' morale e sull'armonia sociale di una comunit'a doveil conflit to di classe non avrebbe ragione di esistere. Ma dove invece si riproducono, come nella famiglia mezzadrile, rigidi rapporti gerarchici: le funzioni del reg gitore e della reggitrice e i rapporti che vincolano i membri della famiglia pa triarcale rappresentano, come si e visto, un modello autoritario che e l'altra faccia della comunita integrale. Allo stesso modo, nel <<sistema integrato>> del le cooperative di consumo, ciascuna categoria di produttori/consumatori, se guendo il gioco della domanda e dell'offerta e puntando ad ottenere i migliori proventi, tender'a ad imporsi sulle altre, creando lo stesso conflitto di interes si che caratterizza il regime borghese. L'esperienza delle cooperative non ba sta dunque a ristabilire la giustizia sociale. Raffigura una societa <<perfetta>> che e in realta una molecola chiusa e corporativa. I1 <<sistema integrato>> riconosce nell'organizzazione sindacale la necessaria azione per accorciare le distanze fra le categorie privilegiate e quelle disagiate, ma intanto non smette di prefigu rare un mondo nuovo <<piu armonico e umano>>23, comunque diverso da quel lo attuale. Marxismo e cooperativismo sarebbero dunque entrambi necessari per ?accorciare le distanze>> e per conquistare una vita migliore. Cioe per co minciare a cambiare il mondo in attesa che venga quello nuovo.
3. Le nuove idee morali. I1 mondo rurale e scosso da una crisi che non e solo economica: parallelamente alla crisi agraria, il fenomeno del bracciantato e destinato a mutare profondamente abitudini di vita, mentalit'a e aspirazioni dei contadini. Pane e lavoro sono i bisogni immediati dei contadini. Ma, a questi bisogni elementari, si aggiunge, fortissimo, anche quello di una vita mi gliore. E dunque proprio in questi anni di transizione al modello industriale e di profonde trasformazioni sociali - anni in cui il vecchio mondo rurale chiuso e autosufficiente e sopraffatto dall'imporsi di nuove tecniche e mo dalita produttive e in cui comincia ad emergere la figura del contadino/ope raio - che cresce il bisogno di una nuova morale che sia anche sociale e l'a spirazione ad una palingenesi quasi religiosa. La prefigurazione di una societa nuova e la creazione di ian nuovo ordine so ciale fondato sull'uomo socialista, sono temi classici dellaI letteratura sociali sta di fine Ottocento e dei primi decenni del Novecento e sono ben rappre sentati soprattutto negli opuscoli della propaganda socialista destinati al po
23 Ivi, p. 23.
260 Fiamma Lussana
polo, la cosiddetta letteratura <<a un soldo>>24. I1 significato culturale di que sta <?etteratura di opuscoli>> e colto dal Gramsci dei Quaderni: la loro diffu sione viene descritta come una <<"riforma" intellettuale e morale (cioe reli giosa) di portata popolare nel mondo moderno>> che, per estensione e profondita, e paragonabile alla circolazione dei principi della rivoluzione francese25. Nella forma grossolana dell'<<opuscoletto>>, Gramsci coglie il si gnificato storico di una nuova filosofia della prassi, ma sottolinea l'<<inconsi stenza>> e l'?assenza di carattere forte ed energico>> nei ?dirigenti di tale rifor
ma>>. Negli ?opuscoletti>> della propaganda socialista e nella <<Giustizia>>26 troviamo le idee chiave del socialismo spiegato al popolo: nasce una forma nuova di retorica socialista che punta a raggiungere le folle inventando un socialismo di tipo nuovo, una combinazione di umanesimo sentimentale e di semplici ragionamenti sulla vita quotidiana. Questa nuova morale sociale assume i
modi espositivi ?da prediche di un curato di campagna? e i contenuti della narrazione evangelica. Le spiegazioni, i ragionamenti su come sara il sociali smo sono sempre circonfuse ?da un'aura di sentimento>> che li rende piu per suasivi e digeribili alle masse. L'umanesimo integrale di Prampolini e dei suoi seguaci reagisce alla <frigidita' scientifica che spesso prendeva troppo rude
24 Una raccolta significativa di questi opuscoli ? in R. Pisano, II paradlso sodalista. La pro
paganda socialista In Italia alia fine dett'Ottocento attraverso gli opuscoli di ?Critica soda
le?, Milano, Angel?, 1986, e in Educazione e propaganda nei primo sodalismo. La ?Libre
r?a? della ?Lotta di classe? 1892-1898, a cura di R. Pisano, Roma, Editori Riuniti, 1995
(Fondazione Istituto Gramsci, ?Annali?, V, 1993); sulla societ? futura del socialismo cfr.
P. Audenino, Etica laica e rappresentazione del futuro nella cultura sodalista dei primi del
Novecento, in ?Societ? e storia?, 1982, 18, pp. 877-919; Id., La prefigurazione della sodet?
futura nella propaganda del sodalismo italiano di fine Ottocento, in Educazione e propagan da nei primo sodalismo, cit., pp. 3-32. 25
A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica dell'Istituto Gramsci, a cura di V. Ger
ratana, Torino, Einaudi, 1975, III, Q 19 (X) 1934-1935 (Risorgimento italiano), pp. 1985 1986. Su questo giudizio di Gramsci si sofferma R. Pisano in Editoria popolare e propaganda sodalista in Italia fra Otto e Novecento: gli opuscoli di ?Critica sodale?, in ?Studi Storici?,
XXV, 1984, 2, p. 390. Tale giudizio non ? condiviso da R. Vivarelli, il quale fa notare come
?i postulad di un tradizionale modo di pensare e di sentir?, cos? come la loro matrice catto
lica, siano rimasti tra i ceti popolari del tutto invariati? (Storia delle origini del fasdsmo. Vi
talia dalla grande guerra alia marda su Roma, Bologna, Il Mulino, 1991, II, p. 423). 26
II Io gennaio 1885, dal rapporto di Prampolini con Contardo Vinsani, collaborator de
?Lo Scamiciato?, e con il possidente Giacomo Maffei, era nato il quotidiano ?Reggio nova?, con tre pagine che venivano da Roma e il resto confezionato a Reggio. Prampolini vi scriveva regolarmente, collaborando contempor?neamente all'?Avanti? di Imola. Quan do ?Reggio nova? divenne settimanale, Prampolini ne assunse la direzione. Dal 29 gennaio 1886 il giornale cambia il titolo in ?Giustizia. Difesa degli sfruttati?, che uscir? ininterrot
tamente fino al 1925.
261 Famiglia rurale e <?sistema integrato>>
mente di fronte l'anima popolare>>27 e risponde al bisogno spirituale dele mas se. L'umanesimo integrale, cioe l'attenzione verso la condizione umana e non solo verso le condizioni di vita delle masse proletarie, la divulgazione di Marx, <<interpretato con plastica larghezza italiana, adattato a condizioni diverse, nel suo spirito intimo, e reso accessibile alle masse>>28, sono i tratti tipici del so cialismo reggiano e della sua nuova etica sociale. I1 dibattito sulla nuova morale sociale vede contrapporsi due diverse inter pretazioni, l'altruismo maloniano e l'utilitarismo inglese29. Vedremo le loro reciproche contaminazioni e come entrambe si misurino con la cultura posi tivista. I1 malonismo, che e accolto in Italia come un completamento della cri tica marxiana dell'economia politica, ritenuta insufficiente <<in quanto tra scura totalmente le forze morali>>30, ha una parte importante nella formazio ne della nuova morale socialista anche se, nel socialismo italiano, altruismo e utilitarismo sono entrambi presenti. Nel ricostruire la storia del socialismo da Aristotele e dal cristianesimo, fino al pensiero utopistico e a Marx, Malon aveva espresso l'idea che alla base dell'evoluzione sociale non ci fossero solo fatti economici, ma anche morali3". In seguito, Malon sviluppa l'idea che la
morale ha un preciso carattere sociale: con l'evoluzione e il progresso, ogni ?fatto sociale>>, dove si ritrovano naturalmente i sentimenti di reciprocita e di altruismo, ?diviene "moralizzatore"3>>2. Anzi, il fatto morale deriva dal fat to sociale nel senso che, solo attraverso il ?senso sociale>>, le aspirazioni e i sentimenti umani si affinano, si altruizzano e diventano morali33. L'altruismo
27 Zibordi, Saggio sulla storia del movimento operaio in Italia, cit., p. 54.
28 ?Dall'86 in poi
- scrive Zibordi a proposito di Prampolini - ci? che Turati e Anna Ku
liscioff fecero nella Critica, per diffondere il marxismo tra gli intellettuali e i politici, egli lo
fece per divulgarlo tra le folle, unendo un rigoroso indirizzo dottrinale a una miracolosa fa
colt? di volgarizzazione senza volgarit?, di semplicit? senza semplicismo, di accessibilit? sen
za inganni? (Zibordi, Saggio sulla storia del movimento operaio in Italia, cit., p. 54). 29
Per la scuola utilitaristica cfr. E. Belfort Bax, H. Quelch, Catechismo sodalista, prefa zione di A. Schiavi, Firenze, Nerbini, 1904. Il sostegno all'utilitarismo e il confronto fra
Pinterpretazione altruistica e quella utilitaristica ? in G. Rensi, La morale sodale, in ?Cri
tica sociale?, VII, n. 10, 16 maggio 1897, pp. 153-157. 30
B. Malon, La morale sodale, con prefazione di E. Bignami, Milano, Editori della biblio
teca socialista, 1897, p. 379. Su Malon cfr. anche G. Turi, Editoria e cultura sodalista (1890
1910), in Angelo Fortunato Formiggini. Un editore del Novecento, a cura di L. Balsamo e
R. Cremante, Bologna, Il Mulino, 1981, soprattutto pp. 114-115. 31
Cfr. B. Malon, Il sodalismo. Compendio storico, te?rico, pratico, Milano, Max Kanto
rowicz, 1894. 32 Malon, La morale sociale, cit., p. 44.
33 ?Tutte le azioni morali - scrive Malon - tendono verso Y altruismo che solo pu? dar loro
il carattere sociale, e senza il quale non hanno alcuna efficacia ben?fica, cio? alcun valore
morale. In una parola, la morale novella non pu? pi? essere n? teol?gica, n? metaf?sica, n?
puramente naturalista: essa non pu? essere che sociale? (La morale sodale, cit., p. 11).
262 Fiamma Lussana
di Malon ha come scopo la revisione del marxismo in senso umanitario, e rie sce a coniugare la teoria del progresso e dell'evoluzione sociale con lo spiri tualismo dell'ultimo Comte che, nel Syste'me de politique sociale, si era pro posto di reinterpretare il positivismo secondo i principi spirituali di una nuo va religione dell'umanita'. L'altruismo era per Comte l'antidoto all'egoismo moderno. Riferimenti culturali di Malon sono la simpatia universale di Scho penauer e l'altruismo di Comte, la cui influenza sul socialismo italiano pre cede la diffusione delle correnti neoidealistiche. E infatti solo all'inizio del Novecento - come Antonio Labriola segnala a Croce nel 190334, anno in cui nasce la <<Critica>> - che, per reazione allo storicismo, al positivismo e all'e voluzionismo, si diffonde in tutta Europa il neoidealismo. f1 socialismo non e solo lo studio delle classi sociali e dei loro rapporti economici: la diffusio ne del neoidealismo prelude al dibattito sul socialismo come scienza etica. Nel periodo della II Internazionale, il socialismo italiano ha in effetti un ca rattere multiforme. Piu che il Capitale di Marx35, i suoi riferimenti sono Tol stoj, De Amicis, i romanzi della letteratura sociale e sentimentale di Sue e Zola, la letteratura d'appendice36. Fra i suoi motivi culturali, oltre al sociali smo utopistico francese, all'evoluzionismo darwiniano, al positivismo e al truismo di Comte, si ritrovano la tradizione del pensiero risorgimentale, il neoidealismo, la ripresa dei temi religiosi, le due scuole morali, l'altruistica di Malon e l'utilitaristica di Stuart Mill. Recensendo sulla <<Critica sociale>> La morale sociale di Malon, Giuseppe Ren si presenta criticamente il malonismo e l'utilitarismo smontando l'altruismo umanitario e i suoi presupposti teorici in favore della teoria utilitaristica37: l'e sposizione descrittiva dei diversi sistemi religiosi, su cui si sofferma Malon
34 La lettera di Labriola a Croce, scritta il 7 settembre 1903, ? in A. Labriola, Lettere a Be
nedetto Croce 1885-1904, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1975, pp. 366-367,
ed ? citata da Turi in Editoria e cultura sodalista (1890-1910), cit., p. 113. 35
Sulla fortuna di Marx ed Engels in Italia cfr. G.M. Bravo, ?Il Capitale? in Italia: 1867
1895, in appendice a A.V. Uroeva, La fortuna del ?Capitale?, a cura di G.M. Bravo, Roma,
1974; G. Turi, Aspetti dell'ideolog?a del Psi, in ?Studi Storici?, XXI, 1980, 1, p. 64. Il ca
pitale di Cario Marx brevemente compendiato da Cario Cafiero. Libro primo. Sviluppo della
produzione capitalista esce a Milano nel 1879 nella ?Biblioteca socialista? di Enrico Bi
gnami. II Compendio di Cafiero ebbe numer?se ristampe. La seconda edizione, quella pos seduta da Gramsci, fu pubblicata nel 1913 dall'Istituto editoriale ?II pensiero?. Sulla for
tuna editoriale del Compendio cfr. R. Pisano, presentazione a II Capitale di Karl Marx. Com
pendio di Cario Cafiero, Roma, Editori Riuniti, 1996, pp. VH-XHI. 36
Cfr. R. Monteleone, Cosa legge la classe operaia?, in ?Movimento operaio e socialista?,
1977, 2-3, pp. 370-381; Turi, Aspetti dell'ideolog?a del Psi, cit., pp. 61-94; P. Audenino, La
cultura della classe operaia nell'et? del decollo industr?ale, in ?Studi Storici?, XXII, 1981,
4, pp. 887-901; cfr. inoltre O. Morgari, L'arte della propaganda socialista, Milano, Uffici
della ?Lotta di classe?, 1896. 37
Cfr. Rensi, La morale sodale, cit.
263 Famiglia rurale e ?<sistema integrato>>
per dimostrare la potenza sovrastante delle forze sentimentali e morali sui fat ti economici, sarebbe un esercizio puramente formale perche i fenomeni mo rali e intellettuali sono privi di fondamento se scollegati dal <<sottosuolo eco nomico>>. L'accusa di Malon alla teoria marxiana, ?la trascuranza delle forze morali>>, sarebbe errata. Rensi riporta l'arguto giudizio di Deville che, nei suoi Principes socialistes (1896), attribuisce al marxismo un unico <<torto>>, quello di voler mettere il carro dietro ai buoi: le correnti o <<superedificazioni>> idea li (i buoi) si formano infatti nell'uomo a partire dai rapporti di produzione e dalla struttura economica della societa (il carro). Gli unici impulsi che gui dano l'azione degli uomini sarebbero, secondo Stuart Mill, il piacere e l'as senza del dolore: anziche stemperare questi impulsi nell'altruismo malonia no, che annega questi bisogni primordiali in un dolciastro sentimentalismo, la teoria utilitaria indica nella ricerca della felicita il fondamento positivo del la morale. Senza negare la discordanza e la diversita dei bisogni, il socialismo utilitaristico mette in relazione gli interessi individuali con quelli della col lettivita. Bisogni e interessi che, anche in una societa socialista, e difficile che possano conciliarsi. Nel socialismo utilitaristico e implicita secondo Rensi questa tensione a diminuire, ?per quanto e possibile>>, il prevalere dell'inte resse egoistico sulla felicita altrui. Nel lavoro, che equivale a produrre e dun que ad essere utili a se e agli altri, l'egoismo si concilia con I'altruismo e in tal senso il lavoro e giudicato un fenomeno economico, ma anche morale.
Malonismo e utilitarismo influenzano entrambi il socialismo emiliano, la cui variante reggiana accentua alcuni caratteri della teoria altruistica, senza per dere di vista la soggettivita umana, ovvero la capacita dei singoli di contri buire alla costruzione di un modello integrale dove ogni parte e funzionale al tutto. L'umanesimo integrale di Prampolini, questo ?sciroppo? che, come lo definirono i suoi critici, si nutre ?un po' di Tolstoj e un po' di Pascoli>>, apre una nuova prospettiva interpretativa38: la sua novita e la mobilitazione del principio soggettivo come fondamento della morale sociale. L'elemento soggettivo e il suo punto di partenza per la costruzione di un nuovo ordine sociale cominciando ?da se>>, dal miglioramento morale dei singoli soggetti. L'esercizio dell'<onesta privata>> e del ?buon costume>>39 trovano nella fami glia socialista, prima molecola morale e sociale, il terreno adatto su cui at
38 Tale prospettiva si rivela interessante soprattutto per i suoi sviluppi in campo storiogra
fico: Fumanesimo integrale fa ricorso alla categor?a della soggettivit? che, come ? noto, ?
un riferimento metodol?gico fondamentale per la storia orale o ?nuova storia?, trovando
ad esempio utili applicazioni nei caso della Life History. E questa la prospettiva metodo
l?gica cui si ispirano gli studi compiuti in Gran Bretagna da Paul Thompson. 39
Zibordi sottolinea come Prampolini riuscisse a istillare ?i doveri di onest? privata, di
buon costume famigliare, contrastando ferinamente quelle teorie di un eccessivo determi
nismo, secondo le quali il lavoratore, siccome vive in condizioni di strettezze e di abbie
zione, e circondato dai mali esempi dei ricchi, pu? dispensarsi dal cominciare in s? lo sfor
264 Fiamma Lussana
tecchire perche, secondo la lezione di Malon, la morale si sviluppa piena mente nel rapporto di interrelazione e di solidarieta. Le figure forgiate da questo nuovo modello etico sono quelle del ?buon socialista? (oil sentimen to fondamentale che muove tutta la propaganda socialista - scrive Prampo lini - e [...] il culto della vita umana. Nessun partito puo vantarsi, come il so cialismo, di aver lavorato e di lavorare con tanta coerenza di principi e di condotta per sradicare ogni sentimento di violenza, di vendetta, di sopraffa zione, di ingiustizia>>)40 e del <<buon padre di famiglia>> (<<Compagno, ascolta
mi. Tu non sarai sinceramente pienamente un socialista, mai, se nella tua fa miglia non saprai essere un modello di padre, di marito, di figlio, di fratello. Uomini, circondate di rispetto, soprattutto di rispetto, la donna, sia essa vo stra madre, vostra moglie, vostra sorella>>)41. II neokantismo e il neoidealismo sono il retroterra ideale di una visione del socialismo dove diventa centrale la soggettivita umana: nel 1903 Ettore Cic cotti pubblica da Laterza Psicologia del movimento socialista; dieci anni dopo l'uscita de La morale sociale di Malon, Carlo Petrocchi pubblica nella <<Bi blioteca della Critica sociale> II lato psicologico del socialismo, in cui si teo rizza l'intreccio inscindibile dei fatti oggettivi e di quelli soggettivi nella sto ria del pensiero umano e nel socialismo. Viene inoltre tratteggiata una teoria dei bisogni incentrata sul dolore come motore universale della storia: <<Do lore: ecco la vera parola a cui noi possiamo, senza tema, ricondurre tutta l'at tivita umana [...] II dolore e la vera molla della civilta>42. Questa teoria dei bisogni corregge dal punto di vista dei soggetti la critica marxiana dell'eco nomia politica: la molla che mobilita le masse proletarie non e l'ideale di una societa senza classi, dove sara abolita la proprieta privata, ma e la forza psi cologica del bisogno. La fame, ad esempio, e una delle molle principali del la rivolta popolare: il bisogno del pane spinge una popolazione affamata al l'assalto del municipio, spinge ad ammazzare e a farsi ammazzare. I1 giorno dopo la sommossa popolare, scrive Petrocchi, <<si tolgono le piu' elementari liberta, si imprigiona, si processa, si condanna un'infinita di cittadini: ma il prezzo del pane ribassa [...] Lo scopo e raggiunto: a caro prezzo, e vero; a sudori di sangue, ma e raggiunto. Che importa, del resto, a chi muore di fame, di affrontare i rigori della cella o anche le bocche dei fucili? Morte per mor
zo del suo miglioramento morale [...]? (Zibordi, Saggio sulla storia del movimento op?ralo in Italia, cit., p. 63). 40
C. Prampolini, Perch? il sodalismo ? una propaganda efficace contro la follia degli atten
tati, in ?II Seme?, 2a quino?cina, marzo 1912. 41
F. Ciccotti, Come deve essere un buon sodalista nella famiglia, in ?II Seme?, 2a quindi
cina, ottobre 1908. 42
C. Petrocchi, II lato psicol?gico del socialismo, Milano, Uffici della Critica sociale, 1907,
p. 38.
265 Famiglia rurale e <<sistema integrato>>
te, tanto vale il tentare>>43. fl bisogno soggettivo del pane e la molla della som mossa popolare. La forza del socialismo starebbe dunque nel trovare un rac cordo fra bisogni soggettivi e interessi materiali delle folle. I1 dolore si lega per Prampolini alla condizione di isolamento in cui si trova no gli individui nel regime della libera concorrenza: all'<<isolamento doloro so? del mondo capitalistico il socialismo opporra la <<solidarieta sociale>> che, in una societa moderna, coincide con tutte le forme di associazione dei la voratori, con l'<<embrione di organizzazione socialista?. Prima della conqui sta dei pubblici poteri, infatti, il socialismo procede gradualmente verso l'a bolizione della concorrenza, del commercio e delle leggi capitalistiche del mercato. <In tutte le nazioni moderne - scrive Prampolini - gli operai si uni scono appunto in associazioni di mestiere, fondano giomali professionali, co stituiscono Cooperative di produzione - che sono anch'esse un'ottima scuo la di lavoro collettivo - impiantano Camere del lavoro e tengono Congressi nazionali e internazionali dove si discutono gli interessi generali delle loro corporazioni>>44. Ma, si affretta ad aggiungere, la vita degli operai e dolorosa per la loro debolezza intellettuale e morale: <<e una colpa loro, se pure di col pa si puo parlare. E Ii incitiamo a elevarsi, a migliorarsi, a non cercare che in se stessi la forza che deve emanciparli>45. All'origine della <<solidarieta' socia le>> e della ?morale piu alta>>46 che si forma nella coscienza del proletariato c 'e una scelta soggettiva. La morale sociale nasce dentro di se, dalla coscien za soggettiva dei propri bisogni. La propaganda di Prampolini, nota Zibordi, guarda piu alla <<critica dei sog getti? che alla critica della classe dominante:
se si vuol parlare di colpe morali, guardino allora i lavoratori dentr.o di se, prima di inveire contro i potenti [...] Chi fomisce ai dominanti i puntelli del loro potere [...] se non il popolo? Esso ha mile attenuanti, d'accordo: la miseria, l'ignoranza, la tra dizione. Ma cio spiega e giustifica: non rompe il circolo vizioso. A romperlo, occor re una visione nuova, e uno sforzo di volonta. Occorre convergere alla conoscenza e alla redenzione di noi stessi, la piu gran parte di quella energia che si disperde nel re criminare o nell'imprecare contro gli <<oppressori?>; suscitando e formando in noi - anziche cercarla fuori di noi - la forza consapevole e attiva della ricostruzione socia le47.
Nel socialismo etico di Prampolini e Zibordi, l'umanesimo integrale di Ari drea Costa, l'utilitarismo di Bentham e di Stuart Mill e l'umanitarismo di Ma lon, si arricchiscono di spunti nuovi, tesi a superare e correggere sia il mo
43 Ivi, p. 37.
44 Prampolini, Come avverr? il sodalismo, in Pisano, II paradiso sodalista, cit., p. 169.
45 Ivi, p. 171, corsivo mio.
46 Ivi, p. 161.
47 Zibordi, Saggio sulla storia del movimento operaio in Italia, cit., p. 60.
266 Fiamma Lussana
dello anarchico che quello riformista tradizionale"8. La morale del socialismo etico e una morale integrale, nel senso che il principio soggettivo non ha va lore autonomo, ma contribuisce alla formazione di una societa in equilibrio ?fra il piacere e il dovere>>, ?fra la gioia nostra e il dovere degli altri>>49. La nuova idea di morale integrale nasce nel contesto culturale e sociale del positivismo e la sua influenza va ben oltre la generazione di Turati o di La briola. La Morale dei Positivisti di Ardigo esce nel 1878 e ha un'ampia dif fusione. Il socialismo etico di Prampolini e di Zibordi integra i valori mora li del positivismo, l'idea dell'evoluzione sociale, del progresso indefinito, del socialismo inevitabile, con il sentimento dell'umana ingiustizia di cui e re sponsabile il capitalismo borghese. La morale positivista e pratica e raziona le. Riporta sulla terra i valori astratti della morale tradizionale: il Bene diventa l'abbondanza del raccolto, il Male, la miseria e la malattia, il Sacro, l'aspira zione a una trascendenza che risponde a bisogni umani e terreni. Il sociali smo reggiano fa della cultura positivista l'impalcatura di base su cui far at tecchire una nuova idea morale che, come il positivismo, si basa sulla fede nell'evoluzione sociale. Ma, al progresso della scienza e della societa, aggiunge il progresso dell'uomo. La leva per cambiare il mondo e per Prampolini lo sviluppo della persona umana, e il sentimento dell'ingiustizia e della disu guaglianza e la tensione morale a superarle. Nella morale integrale ciascuno tende a soddisfare i propri bisogni e la propria storia individuale rafforzan do i legami della solidarieta umana e della cooperazione, e usando l'azione collettiva per trasformare la societa. Che e infatti intesa spencerianamente come un organismo la cui vitalita e tensione morale derivano dagli impulsi e dai bisogni dei singoli soggetti.
Come nel corpo umano - scrive Prampolini - lo stomaco, il cuore, il fegato, il cer vello e tutti gli organi che lo compongono, adempiono ciascuno ad una funzione che serve alla vita di tutti gli altri, cosi le diverse corporazioni dei lavoratori costituenti l'organismo della societa futura si provvederanno scambievolmente i prodotti e i ser vigi necessari all'esistenza ed al maggior benessere di tutti, cioe lavoreranno l'una per l'altra, anzi una per tutte e tutte per una50.
48 Cfr. G. Zibordi, Etica sodale, Milano, Tipograf?a degli op?rai, 1909, e Id., Saggio sulla
storia del movimento operaio in Itaila, cit. 49
Zibordi, Etica sodale, cit., p. 24. 50
C. Prampolini, Come avverr? il sodalismo, in Pisano, Il paradlso socialista, cit., p. 169.
Questo testo, pubblicato sotto forma di lettera aperta ai socialisti di Bra sulla ?Giustizia?, Io aprile 1894, fu in seguito raccolte in opuscolo (?Biblioteca popolare di propaganda so
cialista?, Reggio Emilia, Caselli editore, 1894) e ristampato pi? volte. ? stato riproposto
integralmente, in occasione del centenario della nascita di Prampolini, su ?Mondo ope
raio?, XII, 1959, 6, pp. 41-48.
267 Famiglia rurale e osistema integrato>>
L'uomo non si perde nel mare magnum dell'organismo sociale5", ma contri buisce al progresso e all'evoluzione sociale a partire da se. Questa morale in tegrale, che trova nella famiglia rurale la sua prima molecola sociale, e alla base della formula reggiana della cooperazione, il cosiddetto <<sistema inte grato? dove, come nell'organismo sociale, ogni singola parte contribuisce al tutto in modo originale.
Questo modello di societa socialista si oppone radicalmente alla societa ca pitalistica la cui regola base e il regime della libera concorrenza: la risposta di Prampolini alla lotta di tutti contro tutti, e un ?motto "evangelico" che e marxista: la lotta senz'odio>>52. Un quadro, immagine-culto del socialismo ita liano all'inizio del Novecento, fotografa con grande precisione i caratteri del socialismo umanitario: e il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Tema del grande dipinto e un fiume umano (Fiumana e il titolo del dipinto di Pellizza che precede Quarto Stato), fatto di contadini, proletari, forse ope rai, che marciano verso il futuro socialista. Una marcia pacifica, <<inarresta bile>>, dove non ci sono segni di lotta o di combattimento. E il percorso gra duale, progressivo, del socialismo degli albori, il cui carattere umano e reto ricamente sottolineato, fra le figure in primo piano, da una madre col bambino in colo. fl popolo proletario di Pellizza non ha nulla di trionfante: i tratti dei protagonisti sono appena abbozzati, come se il loro stesso carat tere uscisse appena dall'indistinto della folla, senza esprimere forza o deter
minazione. E il <<gregge>> di cui parleranno i nemici del riformismo socialista di Prampolini. Nell'incedere ameno, ?da gita di campagna>>3, della folla pro letaria c'e la forma ancora indistinta della lotta di classe, che ben si adatta alla forma <<senz'odio>> del socialismo reggiano.
4. Vangelo e socialismo. Nella forma emiliana54 (e reggiana), l'uomo socialista e un uomo in came e ossa che vive e lavora nella sua terra e non si limita ad annunciare la promessa del socialismo: sperimenta una nuova pratica politi
51 ?Nessuna forma di societ? pu? reggersi
- scrive Zibordi a proposito dell'idea prampoli niana della societ? come ?organismo?
- se fra il suo assetto gen?rale e la forma dei vari
elementi che la compongono, non vi ? una corrispondenza e una reciproca armon?a? (Zi
bordi, Saggio sulla storia del movimento operaio in Italia, cit., p. 23). 52
Ivi, p. 64. 53
Sul celebre dipinto di Pellizza si sofferma A. Asor Rosa in La cultura, in Storia d'Italia,
IV, Dall'Unit? a oggi, t. 2, Torino, Einaudi, 1975, pp. 998-999. 54
Per un inquadramento del socialismo emiliano e romagnolo cfr. Zangheri, Storia del so
dalismo italiano, I, Dalla Rivoluzione francese a Andrea Costa, cit., e II, Dalle prime lotte
nella Valle Padana ai fasci sidliani, Torino, Einaudi, 1997. Cfr. inoltre M. DeglTnnocenti, Cittadini e rurali nell'Emilia rossa tra '800 e '900, Milano, Angel?, 1990; D. Mengozzi, II
?buon? sodalista: note sulla morale e la politica del Psi, in Gli uomini rossi di Romagna. Gli
anni della fondazione del Psi (1892), a cura di D. Mengozzi, Manduria, Lacaita, 1994, pp.
268 Fiamma Lussana
ca, conquista un nuovo potere. E soprattutto crea un circuito autarchico, au tosufficiente, dove, attraverso il sistema delle cooperative, produce, gestisce e consuma direttamente i prodotti del suo lavoro. L'uomo rosso emiliano stempera l'irruenza passionale dell'eroe romagnolo e incarna un modello in tegrale di vita dove i valori prevalenti sono l'operosit'a, la solidariet'a, il sen timento, una vita sessuale basata sulla semplicita e naturalit'a dei rapporti. I1 ritmo armonico dei rapporti sociali, basati sulla regola prampoliniana della <<lotta senz'odio>>, illumina la vita dell'uomo emiliano di una luce quasi reli giosa.
L'elemento forte della predicazione evangelica cristiana era la solidarieta col lettiva, collante sociale di grande efficacia e promessa di armonia e di con senso: Prampolini coglie l'essenza piu autentica di questo messaggio e la tra duce nel linguaggio semplice di una nuova religione sociale, fondata sui prin cipi cristiani di fraternita, solidarieta e uguaglianza. Perche, come martella la propaganda socialista, <senza il socialismo il Vangelo e lettera morta>>55 e, so prattutto, <i socialisti sono i soli, i veri cristiani?>>6. Obiettivo di Prampolini e separare il Vangelo dalla Chiesa che per secoli ha legato le masse popolari ai valori della tradizione e del potere costituito. Sui valori evangelici la Chiesa ha costruito un'impalcatura di riti gerarchici e pre giudizi che hanno snaturato la sua etica originaria: il socialismo dovra dun que distruggere non la religione, ma le sue incrostazioni superstiziose, recu perando la semplicita evangelica e il valore della solidariet'a. Per Prampolini, la tattica dell'<<innovare utilizzando anziche sopprimendo era la sola vera
mente positiva ed evoluzionista>>57. E, sottolinea Zibordi, egli riusci a cavar ?fuori dal cristianesimo tutta la sua essenza etica di fraternita, di solidarieta, per risvegliare negli spiriti delle masse le scintille di una fede predicata per secoli, ma non praticata mai, e collegarle ai principi e piu ancora alfatto del socialismo, nel quale soltanto la legge di Cristo potra avere la sua piena e sin cera attuazione>>?. E1 socialismo non deve essere ateo perche il cristianesimo
etico e stato portatore dei suoi stessi valori. Non ha senso impostare la pro paganda socialista cominciando dal problema dell'esistenza di Dio: <comin ciare dal tetto>> vuol dire fare della metafisica. Bisogna invece usare il terre no gia seminato dalla religione cristiana, raccogliere la sua essenza etica e, so prattutto, rovesciare il messaggio del cattolicesimo teologico e riportare Dio
207-236; O. Maroni, Educare col cuore e colla mente. I sodallsti romagnoli e Peducazione
del pop?lo fra '800 e '900, ivi, pp. 237-257. 55
B. Carlantonio (Tonio) [pseud?nimo di Fabio Maffi], Vangelo e socialismo (1896), ri
prodotto in Pisano, II paradiso sodalista, cit., p. 235. 56
Piccolo manuale dett'oratore sodalista ad uso degli op?rai e contadini (1896), ivi, p. 289. 57
Zibordi, Saggio sulla storia del movimento op?ralo in Italia, cit., p. 74. 58
Ibidem.
269 Famiglia rurale e <<sistema integrato>>
dal cielo in terra. Nella religione cattolica e infatti implicita un'aspettativa di giustizia e di redenzione che verranno nell'aldila. I1 padrone e in terra, Dio nell'aldila: la vita terrena si consuma nell'attesa di un riscatto che non e di questo mondo. Nella condizione umana prevale invece la rassegnazione e l'ac cettazione dell'ingiustizia e della disuguaglianza. Riportare Dio in terra e l'i dea morale di Prampolini: non e vero che le masse dei contadini e dei pro letari non hanno bisogni spirituali. La tensione verso gli ideali piu alti e istin tiva nell'uomo: anziche negarla, il socialismo dovra dare un significato morale alla lotta terrena per la giustizia e combattere la <<sfiducia nella possibifita di
mutar le cose di questo mondo>>59. Questo socialismo etico o sentimentale si incontra con un'aspirazione al sa cro che, nel mondo contadino, non coincide con la religione cattolica, anzi, se ne discosta profondamente. Nel suo Catechismo spiegato al popolo per via di esempi e di similitudini, il coadiutore del vescovo di Lodi, Angelo Bersa ni, rivolgendosi ad un immaginario contadino, si sofferma sulla disugua glianza terrena, descrivendola come <un tratto della Provvidenza di Dio?: se nel mondo non ci fosse questa diversita <<sparirebbero di botto tutti i nego zii, tutte le botteghe, tutte le industrie, e la terra, con tutto il suo oro, si ri durrebbe a un vero deserto>>60. La Chiesa dunque parla il linguaggio dei pa droni, ma non per questo i contadini rinunciano a credere. Gesiu Cristo, pri mo socialista, voleva la giustizia e l'uguaglianza fra gli uomini: la formazione di una coscienza proletaria e le lotte operaie sempre piu diffuse convivono, nel mondo rurale, con una religiosita naturale e positiva, fortemente intrisa di una morale sociale in cui si ritrovano i principi del malonismo, dell'utili tarismo e della cultura positiva.
Due dati generali offrono spunti di riflessione sul comportamento religioso in Emilia Romagna nel primo decennio del Novecento: l'aumento degli evan gelici protestanti e degli atei a scapito dei cattolici e il balzo in avanti dell'e lettorato socialista61, anche in seguito alla riforma elettorale del 1882 che ha allargato il suffragio, superando il sistema oligarchico e censitario a favore di un sistema piu rappresentativo. Crescono a livello nazionale i gruppi senza religione e gli evangelici e sembra prevalere a livello territoriale emiliano un cattolicesimo di tipo conservatore. Esempi di interpretazioni liberal-cattoli
59 Ibidem.
60 A. Bersani, Catechismo spie gato al pop?lo per via di esempi e di similitudini, Lodi, 18795.
La citazione ? tratta da C. Ginzburg, Folklore, magia, religione, in Storia d'Italia, I, I ca
ratteri originali, Torino, Einaudi, 1972, p. 669. 61
Bedeschi riporta i dati nazionali dei due censimenti del 1901 e del 1911: in died anni i cattolici diminuiscono del 26 circa per mille, mentre i senza religione passano dall'1,1 al
25,2 per mille e gli evangelid protestanti dal 2 al 3,6 per mille. Confrontando il dato re
gionale dell'Emilia Romagna al quadro nazionale, risulta che in Romagna, seguita dall'E
milia, si registra il maggior incremento dei gruppi senza religione. Da rilevare che nel 1911,
270 Fiamma Lussana
che o progressiste, come il gruppo popolare reggiano de <<La Plebe>>, sono rari in Emilia. Pur dichiarandosi obbedienti al Vaticano in materia ecclesia stica, <<i preti buoni>> de <<La Plebe>>, come li chiama Prampolini, praticano un socialismo evangelico che lotta per la giustizia sociale in difesa degli sfrut tati. La Chiesa ufficiale bolla le forme eterodosse con sanzioni spirituali. La stessa <<Giustizia>> viene colpita da scomunica nel 1901 per la polemica con i preti cattolici sull'essenza cristiana del socialismo. Accanto a pratiche religiose di tipo conservatore, il mondo rurale presenta forme di religiosit'a popolare in cui la trascendenza e strettamente collegata alla terra e ai bisogni concreti dell'uomo. La religione dei contadini si oppo ne alla Chiesa tradizionale e rifiuta la liturgia cattolica e le gerarchie eccle siastiche. Professa invece un ?umanitarismo sociale evangelico>> che si ri chiama alla spiritualita e ai valori cristiani, recuperando parallelamente miti e tradizioni del mondo rurale pagano, come il rito della festa, trionfo sul de
monio, o il culto dei santi, inteso come panteismo. Quella ?pseudo-teologia>> che permea la vita dei campi, cercando forme nuove, eterodosse, di rappor to fra la vita terrena e l'aldila, che umanizza i santi e imputa al demonio le disgrazie, le alluvioni, la grandine e i cattivi raccolti, e una delle due espres sioni della nuova morale sociale. L'altra e il socialismo. Entrambe aspirano ad un mondo nuovo dove la giustizia di Dio e vincere la fame e la miseria. 11 clima avverso e le sciagure naturali condizionano la vita dei contadini: con tro il rischio di tempeste, i contadini dispongono sui campi piccole croci di rami d'ulivo e, dopo la mietitura del grano, dispongono i covoni a forma di croce. Attraverso la preghiera chiedono alla Madonna e ai santi di allonta nare la fame con raccolti abbondanti e di scongiurare siccita, carestia e scia gure:
Ligreza, Ligreza, Madona benedeta Madona dla fion parghe e Snor par nun,
Madona d'Frampuil, fasi che vegna di gran fasil62.
La diffusione dei testi sacri, soprattutto della Bibbia, del Vangelo e delle Let tere apostoliche e molto scarsa in tutta l'Emilia e il culto degenera spesso in
nella sola Reggio Emilia gli evangelid sono 43.720 (cfr. L. Bedeschi, Il comportamento re
ligioso in Emilla-Romagna, in ?Studi Storici?, X, 1969, 2, pp. 387-406). 62
Questo testo, raccolto in territorio di Forlimpopoli, ? citato da A. Alessandri, Le feste
popolari religiose nella campagna romagnola, in La religiosit? popolare nella Valle Padana.
Atti del 2? convegno dl studi sul folklore padano (Modena, 19-21 marzo 1965), Modena,
1966, ed ? citato da A. Turchini, // campo, l'aia, il sagrato: religione popolare e mondo ru
271 Famiglia rurale e <<sistema zntegrato>>
<<devozionismo>>, ovvero nella pratica di credenze e superstizioni63. Piu che i rituali liturgici tradizionali, come la messa o i sacramenti, la fede dei conta dini segue le antiche superstizioni, le credenze magiche collegate alla fertilita della terra e i riti popolari che esaltano la vittoria sul male e sulle forze in fernaliA. Piu di Dio, oggetto di culto sono la Madonna e i santi, cui si attri buiscono qualita <<umane>> e poteri speciali: sul bestiame veglia sant'Antonio eremita, sui fidanzamenti sant'Antonio da Padova, sugli occhi santa Lucia. f1
mondo dei santi assomiglia a quello dei comuni mortali: e un pantheon ric chissimo e variegato, che si interessa alle sorti e alle miserie della vita conta dina e ai tempi e ai riti del mondo rurale e la cui devozione e legata all'im mediato soddisfacimento di bisogni materiali. fl sentimento religioso si ma nifesta cioe nel mondo contadino come tensione morale che ha quasi sempre un fine pratico: far si che l'alluvione o la grandine non rovinino il raccolto o che il decotto di foglie di noce, di ciliegio e di susino vinca la febbre della
malaria. Le pratiche religiose convivono spesso con la militanza socialista e con for me diffuse di anticlericalismo: motivo dominante della nuova etica sociale o religione civile del socialismo emiliano e che la Chiesa e i preti difendono i ricchi e non la povera gente e che predicano il Vangelo, ma non lo pratica no. In Emilia - e in particolare a Reggio, dove sono presenti numerose co munita evangeliche - non sembra azzardato parlare di una <doppia fedelta>>, a Cristo, che la religiosita popolare proclama ?primo socialista>>, e al sociali smo, che far'a giustizia per i poveri e gli sfruttati. Sembra esistere una corri spondenza fra le forme dell'evangelismo umanitario, cosi forte a livello terri toriale, e la militanza socialista65.
rale in Emilia-Romagna tra storia e antropolog?a, in Istituto ?Aleide Cervi?, ?Annali?, 7,
1985, p. 131. 63
Cfr. Bedeschi, II comportamento religioso in Emilia-Romagna, cit., p. 397. 64
Su questi aspetti si ? a lungo soffermato nei suoi studi sul mondo contadino Emilio Se
ren?, la cui ricca raccolta di appunti, schede e riferimenti bibliografici ? conservata nel fon
do Emilio Seren? dell'archivio dell'Istituto Alcide Cervi di Roma. Si vedano in particolare le bb. 11 (fase. 27 ?Riti e culti agrari?); 15 (fase. 52 ?Sec. XIX. Agricoltura?); 16 (fase. 53 ?Sec. XX?; fase. 54 ?Paesaggi agricoli?; fase. 55 ?Paesaggio reggiano?). Son? grata a Giu
liana Giunti e Valeria Ascione per la disponibilit? con cui hanno agevolato la mia ricerca
presso la biblioteca e Parchivio dell'Istituto Cervi di Roma. 65
?Nella provincia di Reggio Emilia - scrive Zangheri - la predicazione valdese aveva con
trastato con successo, dopo l'unit?, il cattolicesimo romano, a Guastalla specialmente nel
le campagne. Ma non sono state tr?vate testimonianze di un "transito autom?tico dall'e
vangelismo al socialismo"? (Zangheri, Storia del sodalismo italiano, II, Dalle prime lotte
nella Valle Padana ai fasci siciliani, cit., p. 371). Su questo punto cfr. F. Boiardi, Evange lismo e socialismo, in Gli anni della ?Giustizia?. Movimento operaio e sodet? a Reggio Emi
lia (1886-1925), Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, 1986, p. 260. La tesi della continuit? era stata invece sostenuta da F. Manzotti, Dal?'evangelismo valdese alia propaganda sodalista
272 Fiamma Lussana
Vangelo e socialismo sono entrambi riferimenti ideali che parlano di un uomo nuovo e della sua possibilita di salvezza e di riscatto. L'uno e la religione del l'.aldila, l'altro e la ?religione del di qua>>, ma il loro messaggio e in sintonia. Ecco perche si puo essere fedeli all'uno e all'altro. Anzi, compito della mo rale integrale e fare in modo che le leggi dell'economia politica, che parlano di classi sociali, capitalismo e collettivismo, siano intese dalle folle proletarie come risposte <<scientifiche>>, e dunque positive, a bisogni umani, come il pane, un tetto, un lavoro. Malonismo, utilitarismo e cultura positiva si in contrano anche nel rispondere al bisogno di una nuova spiritualita, di una ri generazione morale, che, soprattutto alla fine degli anni Ottanta, durante la crisi agraria, agita il mondo rurale, sconvolto da fame e miseria e animato da una forte spinta al cambiamento. Questa aspirazione ad una trascendenza non slegata dalla vita quotidiana e dai bisogni umani che anima il mondo rurale trova una sua spiegazione nel la forte influenza della cultura positivista e naturalista sul socialismo italia no'. Per la loro naturale esposizione ai ritmi biologici della terra e dei rac colti, ai riti e alle credenze superstiziose, i contadini sono inoltre sensibili piu di altri alla predicazione religiosa (quell'universo metafisico e morale che, se condo Michels rendeva <d'anima del campagnuolo [...] facilmente accessibi le al sentimento religioso>>)67. fl socialismo risponde al bisogno di rigenera zione (palingenesi) che anima le folle proletarie e traduce per il popolo, uma nizza, principi e valori della tradizione cristiana, etica e filosofica. La religione dei contadini e aspirazione al sacro nel senso evangelico di tensione verso una trascendenza non liturgica ne gerarchica ed e protesa al tempo stesso al sod disfacimento di bisogni umani, terreni. Nel mondo rurale, pane e metafisica sono entrambi bisogni. fl contadino chiede alla Madonna il piatto di fagioli quotidiano e guarda al cielo con la speranza che la giustizia di Dio sia ugua le alla giustizia degli sfruttati.
nella planura padana, in Accademia di scienze lettere e arti di Modena, ?Atti e memorie?,
V s., vol. XV, Modena, 1957. 66
Sul rapporto fra morale positivista e socialismo cfr. M. Viroli, Vetica sodalista e la mo
rale del posltlvlstl, in Vet? del positivismo, a cura di P. Rossi, Bologna, Il Mulino, 1986; L. Mascilli Migliorini, Camillo Prampolini e la cultura positiva, in Prampolini e il sodalismo
riformista, Atti del convegno di Reggio Emilia, ottobre 1978, [Roma], Mondo operaio-Edi zioni Avanti!, 1979, I, pp. 49-67, e Zibordi, Saggio sulla storia del movimento operaio in
Italia, cit. 67
R. Michels, Storia critica del movimento sodalista italiano. Dagli inizi fino al 1911, Fi
renze, Soc. an?n. ?La Voce?, 1911, p. 60. Zangheri attribuisce la permeabilit? degli am
bienti rurali al socialismo evang?lico o profetico alia fase storica di grande instabilit? so
c?ale in cui esso si sviluppa e all'assenza di una ?cultura della laicizzazione? che sappia rac
cogliere le tensioni e le paure da cui ? agitato il mondo rurale (cfr. Zangheri, Storia del
sodalismo italiano, II, cit., p. 381).
273 Famiglia rurale e <<sistema integrato>>
fl clero, scrive Kautsky, rimane il ?nemico giurato di ogni movimento rivo luzionario>>, ma, se i credenti si riconoscono nella lotta di classe, i socialisti non hanno alcun motivo di tenerli ?lontani da se>>: i ?bisogni religiosi>> sono anch'essi bisogni e come tali vanno riconosciuti68. Si puo dunque essere cre denti e anche socialisti: lasciare questa liberta di giudizio fa parte della <<mis sione storica? del partito socialista. Ma soprattutto, come si legge sul <<Seme>>, il giornale socialista per i contadini fondato nel 190169, ?quella della religio ne e una questione privata?70. La responsabilita della lotta fra cattolici e so cialisti, delle campagne anticlericali che infiammano la stampa socialista lo cale, e attribuita ai preti che ?minacciando l'inferno a chi si metteva in lega, a chi votava pel candidato dei poveri nelle elezioni?, tentano ?di mettere una
muraglia di diffidenza tra noi ed i nostri compagni credenti nel cattolicesi mo>>71. Soprattutto quando, alle elezioni amministrative del 1904, i socialisti sono sconfitti a Reggio Emilia dal blocco conservatore riunito nella cosid detta ?Grande Armata?, la <<Giustizia? di Zibordi, che intanto ha assunto la direzione del giornale, inizia una nuova linea politica basata sull'attacco con tro il clero dei preti, alleati degli sfruttatori, e la campagna per l'istruzione di base per fare della cultura uno strumento di conquista del potere. Bersaglio del giornale non e la religione, ma la Chiesa in quanto istituzione antisocia lista: molti contadini sono cattolici, ma credono in Dio, non nei preti. E so prattutto sono ignoranti, sono come <<sordomuti?: Zibordi li descrive sulla <<Giustizia? come uomini semi-selvaggi che il prete riesce ad abbindolare dal pulpito con un linguaggio rozzo ed elementare: ?Inferno, bestie, mangiare, vacca, casa. Moglie, eretici, diavoli, e con qualche segno cabalistico segnato in aria, dall'alto in basso, e da dritto a sinistra, il mandriano tricornuto sa ca var miracoli dalle sue truppe selvatiche>72. Questo branco selvaggio guidato astutamente dal prete-mandriano e vittima di un'ignoranza cieca, che lo ren de succube della predicazione antisocialista. Risvegliare nelle masse contadi
68 K. Kautsky, Il partito sodalista e la chiesa cattolica, prima traduzione autorizzata di E.
Pensuti, Siena, Alessandri, 1904, pp. 13-14. 69
?Il Seme. Propaganda socialista per i contadini?, il cui sottotitolo diventa poi ?Quindi
cinale per i lavoratori?, esce contempor?neamente alla ?Giustizia? di Prampolini dal 1901
al 1915, a Terni nei primo anno di vita e poi a Roma fino alla fine. Mold sono gli spunti e i terni che ?Il Seme?, diretto da Francesco Paoloni, trae dalla ?Giustizia?. Alla funzione
di propaganda elementare del giornalino si riferir? Gramsci, nei 1924, quando scrive da
Vienna ai compagni del PcdT auspicando l'uscita di una testata per i contadini che avreb
be dovuto ispirarsi al ?Seme? (e che per? non vide mai la luce). Sul ?Seme? cfr. S. Do
minici, La lotta senz'odlo. Il sodalismo evang?lico del ?Seme? (1901-1915), Milano, Ange
l?, 1995. 70
La questione della religione, in ?Il Seme?, Ia quindicina, settembre 1911. 71
Dove si vede per qualt ragioni ? dichiarata la guerra fra preti e sodallsti, ivi, Ia quindici
na, settembre 1907. 72
g.z., Le squadre elettorall dei preti, in ?Giustizia?, n. 1063, 27 gennaio 1907.
274 Fiamma Lussana
ne la vera religione, quella evangelica, che predica l'uguaglianza e la solida rieta, e istruire il popolo sono il nuovo manifesto della <<Giustizia>> che, dal 1904, all'edizione domenicale aggiunge quella quotidiana. Istruirsi e anche l'unico modo per esercitare il diritto elettorale: a Reggio, prima delle elezio ni del 1907, dopo le quali il Comune viene riconquistato dai socialisti, ope rai e contadini si mobilitano per vincere l'analfabetismo73. Per cambiare il mondo bisogna istruirsi. <<L'affetto per la cultura e per la scuola>> e il sentimento che rendera piu forte il socialismo reggiano, che Giu seppe Soglia, in un discorso pubblicato a puntate sulla <<Giustizia>>, definisce <<evoluzionista, pacifico, civilizzatore per eccellenza e soprattutto sperimen tale e antidogmatico>>74. Le biblioteche, l'Universita popolare, la scuola festi va, i corsi serali sono gli strumenti per combattere l'ignoranza e per conqui stare il diritto elettorale75. L'uomo nuovo socialista dovra uscire dalla foschia delle superstizioni che avvolge il mondo rurale e che lo rende succube dei preti e dello sfruttamento. Dovra incarnare un modello morale e diventare un cittadino. fl socialismo riformista emiliano esprime un modello di umanesimo sociale di cui gia il Gramsci dei Quaderni aveva colto il carattere morale, popolare e <<religioso>>. Ma, quasi dieci anni prima, nel manoscritto Alcuni temi della quistione meridionale, Gramsci si era schierato in modo esplicito contro l'e sperienza riformista delle cooperative reggiane, citando l'esempio di una grande officina di Reggio Emilia che avrebbe dovuto trasformarsi in azienda cooperativa col sostegno entusiasta dei riformisti reggiani. Basto che <<un co
munista torinese>> si recasse a Reggio per esporre i rischi dell'operazione in un comizio di fabbrica perche si ottenesse <il "miracolo": gli operai, a gran dissima maggioranza, respinsero la tesi riformista e corporativa. Fu dimo strato - continua Gramsci - che i riformisti non rappresentavano lo spirito degli operai reggiani; ne rappresentavano solo la passivita e altri lati negativi [...] Ma era bastata la presenza di un rivoluzionario capace, per metterli in iscacco e rivelare che gli operai reggiani sono dei valorosi combattenti e non
73 Cfr. L. Serra, Cultura e socialismo a Reggio dal 1904 al 1914, in Prampolini e il sodali
smo riformista, cit., pp. 109-125, e Gli anni della ?Giustizia?, cit. 74 Ai giovani e ai lavoratori, ? il discorso di G. Soglia, pubblicato il 10, 17, 24 e 31 maggio e il 7 giugno 1908 sulla ?Giustizia?. 75
II 7 marzo 1910 viene inaugurata a Reggio la Biblioteca popolare che, alla fine dell'an
no, conta 2.667 volumi. L'anno successivo, al congresso dei giovani socialisti reggiani, Gui
do Raise, collaborator della ?Giustizia? domenicale, auspica il sostegno delle cooperati ve per la costituzione di teatri e filodrammatiche, con l'intento di rappresentare scene di
vita sociale e popolare in cui le classi lavoratrici possano riconoscersi. Alla fine del 1912
la Biblioteca raggiunge i 4.000 volumi e concede in prestito nel corso dell'anno 40.900 vo
lumi, soprattutto romanzi (cfr. Serra, Cultura e socialismo a Reggio dal 1904 al 1914, cit.,
pp. 122-123).
275 Famiglia rurale e osistema integrato>>
dei porci allevati con la biada governativa>>76. Nel secondo dopoguerra, gli strali polemici della storiografia comunista si scagliano contro il socialismo
morale, riformista, sperimentalista, basato sulla moralita della cultura mezza drile e l'autosufficienza del <<sistema integrato>> dele cooperative. Togliatti bolla con un unico giudizio liquidatorio i suoi ideatori e la sua proposta. <I capi del movimento socialista emiliano - afferma - furono, in prevalenza, riformisti. Questo vuol dire che nel loro orientamento e nella loro attivita po litica vi era qualcosa di sbagliato, che deve essere respinto [...]>>77. Bersaglio di Togliatti era l'appello agli ideali dello spirito, alla necessita di guardare a ?tutto l'uomo>>, mentre, secondo la morale comunista, solo il <dominio del mondo economico>> e una <<societa fondata sul lavoro libero>>, rendono giu stizia alla persona umana. fl modello comunista del dopoguerra rifiuta la ca tegoria della soggettivita come valore autonomo. La solidarieta evangelica del <<gregge>> prampoliniano diventa compattezza ideologica, ma soprattutto l'<<uomo socialista>> diventa solo socialista. Non viene riconosciuto il valore innovativo di un socialismo integrale, ?senz'odio>>, che mette l'uomo al cen tro di tutto ed e espressione fra le piu originali della transizione al modello industriale e alla modernita. Sulle esperienze del socialismo riformista e dell'umanesimo integrale, desti nate al fallimento perche nate in un contesto preindustriale, economicamen te e politicamente immaturo e dunque prive di possibilita concrete di svi luppo, il giudizio di Togliatti e controverso: il modello comunista dell'Emi lia rossa recupera l'idea dell'integrazione a livello territoriale fra bisogni individuali e interessi produttivi, ma inserisce la modalit'a del sistema coope rativo di produzione e di consumo in un quadro nazionale, accusando il vec chio riformismo di Andrea Costa e Prampolini di chiusura corporativa e ri fiutando l'idea di un umanesimo che prescinda dal mondo economico78. To gliatti vedra nel <<particolarismo>> emiliano la causa principale della sconfitta politica del socialismo riformista: i vecchi dirigenti riformisti erano chiusi nel
76 A. Gramsci, Alcuni temi della quistione m?ridionale, in La costruzione del partito comu
nista 1923-1926, Torino, Einaudi, 1971, pp. 149-150. II ?comunista torinese? citato nei te
sto ? Umberto Terracini. 77
P. Togliatti, Ceto medio e Emilia rossa, conferenza svolta il 24 settembre 1946 a Reggio
Emilia, al teatro Municipale, sul tema II Partito comunista e i ceti medi, in Pol?tica nazio
nale e Emilia rossa, a cura di L. Arbizzani, presentazione di N. Jotti, Roma, Editori Riu
niti, 1974, p. 37. 78
?Quando essi andavano a predicare il vangelo socialista in queste campagne -
afferma
Togliatti -
l'accusa che li perseguitava era la stessa con la quale ci si vorrebbe perseguita re noi [...] di non vedere tutto l'uomo? (Togliatti, Ceto medio e Emilia rossa, cit., p. 49).
Gi? nei 1927, sul primo numero dello ?Stato operaio? Ruggero Grieco aveva espresso un
giudizio critico sul socialismo riformista (cfr. R. Grieco, Op?rai e contadini nella rivoluzio
ne italiana, in ?lo Stato operaio?, I, marzo 1927, 1, pp. 21-38).
276 Fiamma Lussana
l'interesse ?esclusivistico>> della cooperativa e mantenevano la stessa chiusu ra in campo politico e sindacale. Erano cioe separati dagli interessi generali del movimento dei lavoratori, perdendo di vista il loro carattere nazionale. Chiusura e separatezza rendevano il socialismo emiliano una cittadella asse diata, campo di manovra ?delle ambizioni di avvocati e altri politicanti della citta>>. Come la famiglia rurale mezzadrile, il sistema delle cooperative di consumo si regge in realt'a su un paradosso: il suo essere al tempo stesso un modello integrale dal punto di vista dell'articolazione interna dei rapporti ed equili brato dal punto di vista produttivo, ma storicamente incompiuto perche scol legato dal contesto in cui e inserito ed espressione debole e contraddittoria di un'epoca di transizione. Espressione della crisi, certo, ma propellente fra i piu dinamici di una nuova cultura imprenditoriale il cui limite storico - che nel caso della cooperativa di consumo e la premessa del suo insuccesso - e prefigurare un modello innovativo in assenza di sviluppo industriale. Che e come pensare a una rivoluzione socialista senza che ci sia stata prima quella borghese.