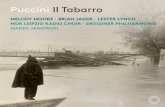'Tristano o il terzo ignoto : il funzionamento del modello eroico nella costruzione del...
-
Upload
uni-goettingen -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 'Tristano o il terzo ignoto : il funzionamento del modello eroico nella costruzione del...
Teodoro Patera
TRISTANO O IL TERZO IGNOTO: IL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO EROICO NELLA COSTRUZIONE DEL
PERSONAGGIO
Abstract - This paper analyzes the role of the archetypal hero inthe construction of the character in old French Tristan’s poems.As is well known, in Folies Tristan, but also in Béroul and Thomas’sromance, Tristan’s process of identification with a mythic modelis constantly mediated by the multiples levels of diegesis. As aconsequence of the writing’s movements, the character acquires newcomplexity and rejects crystallization in a definite profile.Rather, the character dissolves itself in a hybrid image thatendlessly needs to be displaced and adjusted, always disseminatedinto various paradigms of identity.
1. Al verso 1182 del romanzo che la leggenda di Tristano e Isottaha ispirato a Eilhart von Oberg1, Tristano, in una delle tanteoccasioni in cui è costretto a celare la propria identità per nonincappare nella vendetta dei suoi nemici, dice al re d’Irlanda dichiamarsi ‘Pro’, come a suggerire di essere ‘qualcuno che sta perqualcun altro’ e riportando i pensieri del lettore a Ulisse chedice a Polifemo di chiamarsi Nessuno. Nei testi delle Folies diOxford e Berna, che vedono Tristano travestito da folle al fine diraggiungere in incognito la corte di Tintagel e ricongiungersi aIsotta, il suo nome è ora Tantris, ora Picous, ora Picolet2. Siaggiungano gli svariati travestimenti disseminati nei testi che lovedono protagonista: giullare, mercante, lebbroso, pellegrino,medico, monaco. Una propensione alla metamorfosi che parrebbeguidare verso la lettura di una messa in scena, da parte delprotagonista, di una dislocazione che investe lo statuto dell’io,
1 Eilhart d’Oberg, Tristrant, texte traduit, présenté et annoté par René Pérennec,in Tristan et Yseut. Les premières versions européennes, édition publiée sous la direction deCh. Marchello-Nizia, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1995, pp.263-388, a p. 279. Tutte le citazioni dei passi tristaniani, salvo diversaindicazione, saranno tratte dal volume della «Pléiade». 2 La Folie de Tristan. Version d’Oxford e La Folie de Tristan. Version de Berne, textes établis,traduits, présentés et annotés par Mireille Demaules, in Tristan et Yseut. Les premièresversions européennes, pp. 217-243 e pp. 245-260. Si veda, del testo di Oxford, ilverso 328; del testo di Berna si vedano i versi 125, 160, 193.
di un soggetto spostato rispetto a un centro di non semplicelocalizzazione.
L’insistita rappresentazione di un soggetto che rifiuta dicristallizzarsi in una data identità è stata analizzata dallacritica nel senso del mascheramento, del travestimento,dell’alterazione formale e di superficie del personaggio, aspettitipici della figura del trickster, che presenta evidenti consonanzecon il personaggio di Tristano3. Un’analisi imperniata sullasuperficie del travestimento, dei movimenti prodotti dallemaschere, è un’analisi che finisce per investire le ‘azioni’ delpersonaggio, ‘che cosa il personaggio fa’. Le trovate di Tristano,le maschere che indossa con disinvoltura generano, nel giococomico che propongono, quella «schidionata potenzialmenteinfinita» di cui parla Cesare Segre4, consentono un’aperturainfinita dell’universo diegetico, una costante disponibilità diesso ad accogliere nuove avventure, un procrastinare la morte deidue amanti.
La prospettiva della valorizzazione della ruse, dell’azioneingannatrice che alimenta il potenziale auto-amplificatoriodell’intreccio si coniuga con una visione del personaggiomedievale come concretizzazione di una maschera fissa, di un tipo,di uno schema pre-costituito, distante quindi dalla moderna ideadi personaggio, scaturente da una visione complessa e articolatadell’individuo5. Incapace di «franchir la barrière du cogito, ergo3 Si vedano: Nancy Freeman Regalado, «Tristan and Renart: Two Trickster», L’EspritCréateur 16 (1976): 30-38; Mariantonia Liborio, «La logique de la déception dansles romans de Tristan et Iseut», Annali dell’Istituto Universitario Orientale. SezioneRomanza 23 (1981): 151-163; Merritt R. Blakeslee, «Tristan the Trickster in theOld French Tristan Poems», Cultura Neolatina 44 (1984): 167-190; Massimo Bonafin,«Le maschere del trickster (Tristano e Renart)», L’immagine riflessa 9 (2000): 181-96;Barbara Franceschini, «Ephémeros. Per un’analisi dei caratteri nel “Tristano” diThomas e di Béroul», Cultura neolatina 61 (2001): 275-299; Insaf Machta, Poétique de laruse dans les récits tristaniens français du XIIe siècle, Paris, Champion, 2010. Uno studiocomplessivo sulle maschere di Tristano è quello di Merritt R. Blakeslee: Love’sMasks. Identity, Intertextuality, and Meaning in the Old French Tristan Poems, Cambridge, D.S.Brewer, 1989. Si veda inoltre Jean-Marc Pastré, «Les métamorphoses de Tristan»,in Tristan-Tristrant. Mélanges en l’honneur de Danielle Buschinger à l’occasione deson 60ème anniversaire, A. Crépin et W. Spiewok (dir.), Reineke-Verlag,Greifswald, 1996, pp. 409-422. 4 Cesare Segre, «Personaggi, analisi del racconto e comicità nel Tristano», inLos caminos del personaje en la narrativa medieval, a c. di P. Lorenzo Gradin, Firenze,Edizioni del Galluzzo, 2006, pp. 3-18, a p. 9. 5 Visione che sarebbe preclusa all’uomo medievale, il quale si riconoscerebbesoltanto come parte di una forma collettiva (la famiglia, il popolo, ecc.) erisponderebbe a un’idea di personalità «centrifuge et façonnée par des formesextérieures, tandis que la personnalité moderne est son propre centre»
sum»6, il personaggio medievale sarebbe, come una statua di marmo,«figé dans une pose éternelle»7, concretizzazione di un’essenza, diuna «quiddité hors du temps» che «exclut toute évolution»8. Nelconfronto con l’essere di finzione della letteratura moderna, ilpersonaggio medievale apparirà come ‘mancante’, mancante dioriginalità, di evoluzione nel tempo, di profondità psicologica:
loin d’être doués d’une singularité, les personnages appartiennent à des typesfacilement reconnaissables, dont les combinaisons s’effectuent selon desmodalités limitées et programmables.9
I personaggi dei testi della letteratura medievale farebberodifetto di una «specifica psicologia che li individualizzi»10,sarebbero inevitabilmente «définis par la quantité de leursqualités, et non par la qualité de leurs qualités»11 e, inopposizione al personaggio moderno propenso a dipanare la propriacomplessità nel corso nel tempo, «dati una volta per tutte»12,affidati a una «scrittura narrativa dove l’azione domina sullameditazione, sullo scavo nell’interiorità, sulla descrizionepsicologica o l’analisi sociale»13.
Alcuni studi, attraverso strumenti analitici provenientidall’antropologia, dalla psicoanalisi e dalla narratologia, hannomesso in discussione quest’asserto alquanto condiviso,rintracciando nel romanzo medievale un’articolata costruzionedell’essere finzionale, un’idea di soggetto da intendersi giàmodernamente come processo14. Il personaggio, anche quello
(Dominique Iogra-Prat, «La question de l’individu à l’épreuve du Moyen Âge», inL’individu au Moyen Âge. Individuation et individualisation avant la modernité, B. M. Bedos e RezakD. Iogna-Prat [dir.], Paris, Flammarion/Aubier, 2005, pp. 7-29, a p. 12).6 Pierre Berthiaume, Personae et personnage dans les récits médiévaux. L’illusionanthropomorphique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2008, p. 307.7 Ivi, p. 147.8 Ivi, p. 146.9 Pierre Glaudes e Yves Reuter, Le personnage, Paris, PUF, 1998, pp. 19-20.10 Alberto Varvaro, «La costruzione del personaggio romanzesco nel XII secolo»,in Il personaggio romanzesco. Teoria e storia di una categoria letteraria, a c. di F. Fiorentino eL. Carcereri, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 23-44, a p. 29.11 Evelyn B. Vitz, «Type et individu dans l’‘autobiographie’ médiévale. Étuded’“Historia Calamitatum”», Poétique 24 (1975): 426-445, a p. 430.12 Segre, «Personaggi, analisi del racconto e comicità nel Romanzo di Tristano»,p. 16.13 Maurizio Virdis, «Idee di letteratura. Medioevo e dintorni», in Idee diletteratura, a c. di D. Caocci e M. Guglielmi, Roma, Armando, 2010, pp. 56-69, a p.57. 14 Si vedano: Virginie Greene, Le sujet et la mort dans «La mort Artu», Saint-Genouph,Nizet, 2002; Dominique Demartini, «Le discours amoureux dans le Tristan en prose.
medievale, non potrebbe essere definito se non come ‘relazione’,cioè nel rapporto che intrattiene con gli altri personaggi deltesto, ed è possibile descriverne l’identità alla luce di unaserie di processi d’identificazione. Non mi propongo, in questasede, di addentrarmi in una simile discussione, ma di provare aproblematizzare, attraverso alcuni passi dei testi tristaniani delXII secolo, l’idea di personaggio medievale inteso comeattualizzazione di un modello noto dell’immaginario e dellacultura, dinamica che è senz’altro uno degli assi distrutturazione del testo medievale. Se, infatti, un’analisi delpersonaggio medievale come sistema di relazioni sull’assesintagmatico può comportare qualche difficoltà, innegabile è ilsuo essere attraversato da un fascio di rapporti associativi15:
definire l’identità del personaggio a partire dal sistema di relazioni che lolega agli altri personaggi di un’opera, dalla dinamica delle identificazionipossibili, presuppone una unicità, un’individualità, una soggettività che èsenz’altro appropriata nel contesto letterario moderno e che si manifesta – o siaggrappa – al nome proprio, ma porta forse a trascurare l’aria di famiglia chespesso un personaggio ha con altri suoi simili presenti in altri testi: unarelazione verticale o paradigmatica con personaggi di altre opere, epoche,lingue e culture, con i quali condivide caratteristiche che lo rendono subitoriconoscibile dal lettore, in quanto, in un certo senso, replica di un tipo giànoto e codificato nella sua enciclopedia.16
Miroir et mirage du je», in L’individu au Moyen Âge. Individuation et individualisation avant lamodernité, pp. 145-165; Bénédicte Milland-Bove, La Demoiselle arthurienne. Écriture dupersonnage et art du récit dans les romans en prose du XIII e siècle, Paris, Champion, 2006; Damiende Carné, «Construction concurrentielle du personnage romanesque. Trois exemplestirés du roman médiéval», in Façonner son personnage au Moyen Âge, Ch. Connochie-Bourgne (dir.), Actes du 31e colloque du CUER MA, 9, 10 et 11 mars 2006, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2007, pp. 87-97.15 Riguardo al personaggio come fascio di relazioni si legga il postulatosemiologico di Philippe Hamon: «In quanto concetto semiologico, il personaggiopuò essere definito, ad un primo approccio, come una sorta di morfemaarticolato, morfema migratorio manifestato da un significante discontinuo (uncerto numero di contrassegni) che rinvia ad un significato discontinuo (il sensoe il valore del personaggio). Verrà pertanto definito da un fascio di relazionidi rassomiglianza, di opposizione, di gerarchia e di organizzazione (la suadistribuzione) che esso stabilisce, sul piano del significante e delsignificato, successivamente o/e simultaneamente, con gli altri personaggi edelementi dell’opera, e ciò in un contesto vicino (in praesentia: gli altripersonaggi dello stesso romanzo, della stessa opera) o in un contesto lontano(in absentia: gli altri personaggi dello stesso genere)» (Philippe Hamon, «Pour unstatut sémiologique du personnage», Litterature 6 [1972]: 86-110, in it. «Per unostatuto semiologico del personaggio», in Id., Semiologia, lessico, leggibilità del testoletterario, Parma, Pratiche, 1977, pp. 87-127, a p. 94).16 Massimo Bonafin, «Prove di un’antropologia del personaggio», in Le vie del racconto.Temi antropologici, nuclei mitici e rielaborazione letteraria nella narrazione medievale germanica e
Il riferimento dell’analisi sarà, almeno in un primo stadio,la figura archetipica dell’eroe per com’è presentata da KárolyKerényi e Carl Gustav Jung nel loro Prolegomeni allo studio scientifico dellamitologia17. Si tratterà d’indagare come il modello mitico ‘funzioni’nel testo18, non semplicemente dal punto di vista della messa afuoco in esso di un sistema d’immagini e di motivi derivanti dalmito, ma anche dal punto di vista della ‘formalizzazione’.Proporremo cioè qualche riflessione sul meccanismo testuale chepermette al mito di penetrare nelle strutture profonde del testorivelandosi mezzo precipuo di costruzione del personaggio, ilquale, lungi dall’essere la mera riproduzione di una mascherafissa, contemplerebbe piuttosto ‘un altro tipo di complessità’,alternativo allo sviluppo psicologistico caratteristico delpersonaggio sette-ottocentesco19. In quest’ottica, l’irregolaritàidentitaria di cui Tristano sembra latore potrà essereapprofondita alla luce di una ‘visione modale’ del personaggio,che, di là da che cosa il personaggio fa o di che cosa è, sipreoccupi di ‘come’ il personaggio è20, delle logiche identitarieche lo attraversano e di come queste logiche pilotinol’organizzazione formale del racconto, l’atto diegetico, ilmovimento della scrittura21.
romanza, a c. di A. Barbieri, P. Mura, G. Panno, Padova, Unipress, 2008, pp. 3-18, a p. 4. 17 Carl G. Jung, Károly Kerényi, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, trad. diA. Brelich, Torino, Bollati Boringhieri, 1999 (ed. orig. 1941). 18 Come scrive Pierre Brunel, «dans en même texte, plusieurs textesfonctionnent . . . Le mythe, langage préexistant au texte, mais diffus dans letexte, est l’un de ces textes qui fonctionnent en lui» (Mythocritique. Théorie etparcours, Paris, PUF, 1992, p. 61). 19 Più che di rintracciare una psicologia individuale complessa, si tratterà dirintracciare una complessità della costruzione.20 Sulla concezione modale del personaggio, inserito in un sistema di relazioni enon identificabile esclusivamente con un gruppo di parole, si veda GiovanniBottiroli, «Differenze di famiglia», in Problemi del personaggio, a c. di G.Bottiroli, Bergamo, Sestante Edizioni, 2001, pp. 11-46.21 Sullo stretto rapporto di mito e scrittura si veda Marcel Détienne: «Lamythologie, au sens grec – à la fois fondateur et toujours assumé –, seconstruit à travers des pratiques scripturales, dans la mouvance impérieuse del’écriture» (L’invention de la mythologie, Paris, Gallimard, 1981, p. 232). Sul punto,rimando all’Avant-propos di Véronique Gély-Ghedira nel volume collettivo Mythe etRécit poétique, Clermont-Ferrand, Association des Publications de la Faculté desLettres et Sciences Humaines de Clermont-Ferrand, 1998, in particolare alleindicazioni bibliografiche a p. 9.
2. È noto come i romanzi di Thomas e Béroul pervenutici non abbianoconservato (ammesso che la prevedessero) la prima parte dellaleggenda di Tristano, non potendo quindi dirci nulla sulconcepimento, la nascita, l’infanzia del protagonista, elementiquesti che vanno a costituire la costellazione del fanciullo divinoe del motivo della nascita dell’eroe22, che nello studio di Jung eKerényi diventa una metafora della condizione umana e della ricercaidentitaria, un processo, legato a una figura, che si ripete ognivolta che la fantasia creativa si mette in moto23. Per la partedella leggenda tristaniana relativa all’attualizzazione dellafigura del fanciullo divino bisognerà rivolgersi alle versionitedesche del citato Eilhart von Oberg e di Gottfried vonStrassburg24. I racconti di Tristano fanciullo, illuminati dallepagine degli studiosi sopra nominati, ci indirizzeranno versoun’‘incongruenza identitaria primordiale’, un funzionamento delpersonaggio che, nell’atto del suo stesso porsi, si rivela come‘disfunzionamento’, perché così prevede il linguaggio delleimmagini del mito.
Tristano, in linea con la parabola del fanciullo divino, hanobili natali, è orfano, il suo concepimento e la sua nascitarivelano tratti miracolosi, il suo essere al mondo sembra segnatodalla solitudine25. Figlio di Biancofiore, sorella di Marco, e diRivalin, nobile signore messosi al servizio del sovrano diCornovaglia, Tristano è, nella versione di Eilhart, estratto dalgrembo della madre, morta, specifica il testo, proprio a causa del
22 Sul motivo della nascita dell’eroe si veda anche Otto Rank, Il mito della nascitadell’eroe, trad. di F. Marchioro, Milano, SugarCo, 1987 (ed. orig. 1909). 23 Sulla nozione di archetipo si veda Marta Tibaldi, «Critica archetipica», inDizionario degli studi culturali, a c. di M. Cometa, Roma, Meltemi, 2004, pp. 115-121. 24 Gottfried de Strasbourg, Tristan et Isolde, texte traduit par Danièlle Buschingeren collaboration avec Wolfgang Spiewok, présenté par D. Buschinger et W.Spiewok, et annoté par D. Buschinger, in Tristan et Yseut. Les premières versionseuropéennes, pp. 389-635. Per la traduzione italiana si veda Gottfried vonStrassburg, Tristano, a c. di L. Mancinelli, Torino, Einaudi, 1994. 25 La solitudine di cui ci parla la mitologia, appunta Kerényi, non ha nulla ache vedere con la solitudine umana, quella di cui ci racconta la figuradell’orfano della fiaba di magia. La solitudine del fanciullo divino è invece unsegno della sua superiorità, una «solitudine confacentesi all’elementoprimordiale», un «trionfo della natura elementare del prodigioso fanciullo»(Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, p. 63). Di «semantica della solitudinedell’eroe» parla anche Eleazar M. Meletinskij in Introduzione alla poetica storica dell’epose del romanzo, trad. di Ch. Paniccia, Bologna, il Mulino, 1993 (ed. orig. 1986),p. 82 ss. La solitudine è un tratto particolarmente marcato nel personaggio diTristano (si pensi per esempio a quando, ferito mortalmente, si fa abbondonaredai suoi in una barca in mare).
bambino26. In questa versione Tristano ha un padre, ma si tratta diuna figura di fatto assente nel percorso dell’eroe: Rivalin loaffiderà prima a una nutrice, poi a uno scudiero27. In GoffredoTristano è invece orfano di entrambi i genitori e il suoconcepimento ha un carattere singolare. Venuta a conoscenzadell’imminente morte dell’amato, ferito durante un combattimento,Biancofiore, travestita da mendicante per raggiungerlo, si stendeaccanto al moribondo Rivalin, riaccendendone la passione28. Inquesta versione della leggenda, Biancofiore morirà dopo aver datoalla luce Tristano29.
Quella del fanciullo divino sarebbe la storia di unaseparazione precoce dalla protezione parentale, essendo cosìpresentata in forma embrionale la prima fase della dialetticaseparazione-allontanamento-ritorno messa in luce dal mitologo estorico delle religioni Joseph Campbell nei suoi studi sul monomitodell’eroe30, rispetto al quale il fanciullo divino si porrebbe comeuna sorta di prefigurazione. Una caratteristica del fanciullodivino sarebbe infatti secondo Kerényi la condensazione nella suafigura di quelli che saranno i tratti caratteriali dell’eroeadulto. L’eroe ritratto nella sua infanzia non sarebbe associabilea «un’età biografica della vita», ma esprimerebbe sempre «l’essenzadi un dio»31:
il lato prodigioso di quelle storie d’infanzia e di gioventù consiste nel fattoche esse presentano le divinità già in pieno possesso del proprio carattere edel proprio potere, escludendo così la maniera di pensare biografica checonsidera le singole età come altrettanti fasi di un’evoluzione.32
Contrariamente a quanto lascerebbe presupporre una «maniera dipensare biografica», attenta all’evoluzione dell’individuo, ilromanzo di Goffredo ci racconta di un Tristano che, già dafanciullo, è abile nella caccia e insegna a esperti cacciatori asquartare elegantemente un cervo33 (doti queste che saranno oggetto26 Tristan et Yseut. Les premières versions européennes, p. 264.27 Ivi, p. 265. 28 Ivi, pp. 406-407. 29 Ivi, p. 412. Per un approfondimento del motivo si rinvia a Jean-Marc Pastré,«Les mères dans les romans de Tristan», in La mère au Moyen Âge. Actes du colloquedu Centre d’Études Médiévales et Dialectales de Lille 3 (25-27 septembre 1997),textes réunis par A. Petit = Bien dire et Bien Aprandre 16 (1998): 203-216.30 Joseph Campbell, L’eroe dai mille volti, trad. di F. Piazza, Parma, Guanda, 2000[1973]. 31 Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, p. 48.32 Ivi, p. 47.33 Tristan et Yseut. Les premières versions européennes, pp. 426-7.
di un significativo ritratto nel celebre episodio della foresta inBéroul), si distingue per la sua saggezza, parla molte lingue, èansioso di conoscere luoghi e culture, è abile nella corsa, nelsalto, nella lotta, a lanciare il giavellotto, sa cantare34. Questosul versante dell’eroe-tipo del mito, prode, valoroso,intelligente, dotato cioè di quei tratti che saranno assimilati inarea francese medievale dalla figura del cavaliere cortese. MaTristano rivela già nel suo primo ritratto anche l’altra faccia delmito, rivela cioè la fisionomia del trickster, dell’escogitatore distratagemmi, dicitore di menzogne. Rapito da un gruppo di mercantinorvegesi attratti dalle doti del ragazzo e poi abbandonato suun’isola in cui si smarrisce, Tristano incontra due pellegrini, peri quali inventa di sana pianta una «jolie estoire»35, ottenendo diessere accompagnato alla corte di Marco. In Eilhart, giunto inCornovaglia per completare l’apprendistato di cavaliere, imponeagli accompagnatori di mentire sulle sue origini36.
Nel Tristano fanciullo confluiscono insomma quei due profili,quello dell’eroe culturale e del trickster, che Eleazar Meletinskij ciinsegna a non considerare come contraddittori: «gli eroi miticiagiscono spesso con l’astuzia e l’inganno perché la coscienzaprimitiva non distingue tra intelletto e astuzia»37.
3. Le annotazioni di Kerényi c’invitano a mettere da parte un‘pensiero del biografico’, dell’evoluzione nel tempo, perconcentrarci su altre logiche, altri funzionamenti. Se, accettandoun’opinione alquanto condivisa, il personaggio medievale è ‘giàdato in partenza’, il linguaggio del mito ci porta a noninterpretare questa (apparente) fissità in senso riduttivo, con gli34 Ivi, pp. 413-418.35 Ivi, p. 424.36 Ivi, p. 267. 37 Eleazar M. Meletinskij, Il mito. Poetica folclore ripresa novecentesca, trad. di A.Ferrari, Roma, Editori Riuniti, 1993 (ed. orig. 1979), p. 196. Così continuaMeletinskij: «È solo col progressivo chiarirsi nella coscienza mitologica delladifferenza tra astuzia e intelletto, inganno e rettitudine, organizzazionesociale e caos, che si sviluppa la figura del briccone mitologico come doppiodell’eroe culturale. I trucchi sono le parodie delle imprese serie dell’eroeculturale. Un personaggio bivalente come l’eroe culturale-trickster fonde inun’unica persona il pathos della regolarizzazione del cosmo e della collettivitàe l’espressione di un ordine non ancora costituito. Questa associazionecontraddittoria è possibile perché i cicli fiabeschi e mitologici collocanol’azione in un tempo mitico che prevede l’instaurazione di un rigido ordinamentouniversale» (Ibidem). Anche Joseph Campbell sottolinea l’andare «oltre le coppiedi contrari» dell’eroe del mito (Campbell, L’eroe dai mille volti, p. 46).
occhi del lettore del romanzo sette-ottocentesco, abituato all’ideache un personaggio debba vivere un’evoluzione, debba seguire unpercorso ascensionale nel tempo. Quello che il linguaggio del mitoci propone è un altro modo d’essere del personaggio, che non vainquadrato in una logica temporale. Nel mito il tempo non è dato,essendo il mito il racconto di ciò che sempre si ripete, ilracconto del mondo che ‘ri-percorre’ la sua storia.
Gilbert Durand ha argomentato come gli universi del mito edell’immaginario rispondano a una logica a-temporale.L’immaginazione, che fonda i propri movimenti sul potere dellamemoria, «si manifesta come priva di armoniche temporali»38. Lamemoria, «lontana dall’essere intuizione del tempo, sfugge aquest’ultimo nel trionfo di un tempo “ritrovato”, dunque negato»39:
ben lontana dal perorare il tempo, la memoria, come l’immaginario, si levacontro i volti del tempo, e assicura all’essere, contro la dissoluzione deldivenire, la continuità della coscienza e la possibilità di ritornare, diregredire, al di là della necessità del destino.40
Il principio d’identità e non contraddizione, strettamentedipendente da una logica cronologica, non ha modo di sussistere neltessuto atemporale dell’immaginario:
è il tempo, e il tempo solo, che trasforma il principio d’identità in un‘rischio da correre’, rischio irrimediabile di errore e di contraddizione. Perun pensiero a-temporale, tutto è sempre pensato nei quadri della simultaneità edell’antagonismo, «in illo tempore», «allo stesso tempo e sotto lo stessorapporto». È il tempo che appare come la distensione stessa dell’identità innon-contraddizione. 41
In questo movimento che si pone di là dal tempo, lecontraddizioni coesistono valorizzandosi reciprocamente. È propriadel mito una ‘visione sincretica delle diverse dimensionidell’esistenza’, un idea di ‘cambiamento in cui si rimane glistessi’. Attento a precisare come l’archetipo del fanciullo divinosia estraneo a un vissuto che si sviluppa cronologicamente, Jungusa il termine ‘sintesi’ per descriverlo, delineando un’entità incui «tutto ha l’apparenza come se in modo paradossale una cosa giàpreesistente dovesse ancora comporsi»42. Per Kerényi il fanciullo è38 Gilbert Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario. Introduzione all’archetipologiagenerale, traduzione di E. Catalano, Bari, Dedalo, 1972, p. 403 (ed. orig. 1960).39 Ivi, p. 406.40 Ivi, p. 408.41 Ivi, p. 417.42 Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, p. 127. Il termine «sintesi» nelpensiero junghiano richiede qualche precisazione. Contrariamente al pensiero
«l’Eterno Indeterminato»43. Il suo legame con l’elemento umorale (ènoto lo spazio che occupa il mare nella leggenda di Tristano)rappresenterebbe un «non-essere-ancora-staccati dal non-essere,eppure esistere di già»44. Si insiste, insomma, sull’idea diun’instabilità identitaria, sull’idea di un essere che è miscelaindefinita, oscillazione continua e aliena da un percorsorettilineo. Il fanciullo divino è per Jung in bilico tra «un nonpoter essere diversamente», nel senso che il fanciullo è già dotatodi tutti i tratti dell’eroe, e un «poter essere diversamente»45,potenzialità infinita, disponibilità perenne all’aperturaidentitaria.
Questa logica della ‘ridefinizione continua’, che mai sifossilizza in un dato assestato e che contempla una convivenzadelle contraddizioni, è per Jung, di là dal caso specifico delfanciullo divino, una marca generale dell’archetipo, il qualerifiuta di incarnarsi in un’immagine nitida:
ciò che un contenuto archetipico sempre esprime è, anzitutto, una similitudine.Se esso parla del sole, identificandolo con il leone, con il re, con l’orocustodito dai dragoni, o con la vitalità o la salute degli uomini, esso non èl’uno né l’altro, bensì un terzo ignoto che può venire espresso più o menoadeguatamente per mezzo di tutte queste similitudini, ma che – a eterno dispettodell’intelletto – rimane fatalmente ignoto e indefinibile46.
Quello che ci viene descritto è un profilo confusivo cherespinge ogni messa a fuoco, una forza oscillante in unafluttuazione di significanti riluttanti a incanalarsi in unprocesso di significazione unilateralmente definito. «Simbolo»,
‘indirizzato’, ossia il pensiero razionale, quello ‘non indirizzato’, ossia ilpensiero fantastico, proprio del mito, del sogno, della fantasia, ‘compone’ leopposizioni. Ma bisognerà non confondere questo tratto con un processodialettico di superamento dei contrari. Scrive lo psicanalista junghianoFerruccio Vigna: «Jung sostiene che il pensiero razionale è un “pensare peropposizioni”, laddove il pensiero fantastico realizza una “composizione” – osintesi – delle opposizioni. Naturalmente, dobbiamo intenderci sul significatodel concetto di composizione, escludendo innanzi tutto un utilizzo del terminein chiave hegeliana (come “superamento” delle opposizioni): Jung intende lacomposizione come un “mantenere in relazione” gli opposti inconciliabili,unificandoli in quella tensione vitale inesauribile che è l’attività simbolica»(«Prefazione» a Jung e le immagini, a c. di F. Vigna, Bergamo, Moretti & Vitali,2010, pp. 9-21, a p. 11). 43 Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, p. 106.44 Ivi, p. 103.45 Ivi, p. 135.46 Ivi, p. 116
dice Kerényi, «non è un semplice modo di dire in maniera diversa»47.Il modo d’essere di cui Jung e Kerényi parlano è improntato a unospostamento incessante, a un affollamento mai stabile di immaginiche sempre rinviano ad ‘altro’, a un mai dato ‘terzo ignoto’,appunto, secondo una logica delle spezzature, una logica allusiva,un’estetica dell’assenza.
4. Nelle Folies di Berna e di Oxford Tristano, in dissidio con lacorte di Marco («Mout est Tristanz mellez a cort», ‘Tristano è ingrave conflitto con la corte’, v. 1), si maschera da folle e sireca, irriconoscibile a tutti, alla corte di Cornovaglia perriunirsi a Isotta. Neanche Isotta però lo riconosce, e Tristanodovrà convincerla della sua identità con il racconto delle loroavventure passate. Sarà proprio la parola di Tristano, o, secondolo spunto di Anne Berthelot, la follia come «artificio retorico»48,a delineare, attraverso il racconto nel racconto, la figura di unpersonaggio da intendersi come processualità, come sintassi ditratti identitari che mai trova una stabilizzazione49. Ilmeccanismo della rimemorazione e il concatenamento metadiegeticodei livelli della narrazione sembrerebbero gli strumentiattraverso cui il testo dà forma a quell’idea d’immagine confusivae non pilotata da una logica temporale di cui parlano Jung,Kerényi, Durand: il personaggio si risolve in un’immagine che èoggetto costante di spostamenti e aggiustamenti50. 47 Ivi, p. 75. Le annotazioni di Jung e Kerényi sull’archetipo si avvicinano, nelmeccanismo che propongono, alle considerazioni di Max Black sulla metafora.Secondo Black, alla metafora non converrebbe una concezione sostitutiva, per cuimetaforico sarebbe semplicemente un termine che sta al posto di un altro, ma lametafora incorporerebbe invece un meccanismo d’interazione tra due identità, cheridisegna e dilata i confini semantici di queste, attuando una ‘ridescrizione’.Cfr. Max Black, «Metaphor» (1954), in it. «Metafora», in Id., Modelli archetipimetafore, Parma, Pratiche, 1983, pp. 41-66. Sulla concezione della metafora diBlack si veda Giovanni Bottiroli, Che cos’è la teoria della letteratura, Torino, Einaudi,2006, p. 289 e seguenti.48 Anne Berthelot, «La Folie Tristan», in Tristan et Yseut. Un thème éternel dans la culturemondiale, D. Buschinger e W. Spiewok (dir.), Greifswal, Reineke-Verl, 1996, pp.27-33, a p. 28.49 L’analisi delle Folies qui proposta riguarda esclusivamente l’asse paradigmaticodel personaggio. Per un’analisi più articolata dei due testi, che si estendealle relazioni sintagmatiche, mi permetto di rinviare al mio «Liminalité etperformance: de l’anthropologie de Victor Turner aux “FoliesTristan”», Perspectives médiévales 35 (2014). Identificatore della risorsa:http://peme.revues.org/5025.50 Riguardo alla metadiegesi nelle Folies, si rimanda in particolare a: FrancescoZambon, «Tantris o il narratore-sciamano», Medioevo Romanzo 12 (1987): 307-328;
Nella prima parte della Folie di Berna, quella precedente altravestimento, l’autore presenta Tristano alla luce del trattoche, con un’espressione utilizzata da Meletinskij, potremmochiamare dell’«uomo interiore»51:
sovant sopire et mout se dialtDe ce c’o lui nen a Ysiaut.Ysiaut a il, mais nen a mieceli qui primes fu s’amie.Porpanse soi qu’il porra faire,con la porra a soi atraire,car n’ose aler en sa contree.«Ha! Deus, fait il, quel destinee!C’ai-je sofert en tel amor!Onques de li ne fis clamorne ne me plains de ma destrece.Por qoi m’assaut? por quoi me blece? (vv. 47-58)
(spesso sospira e si tormenta / per non avere Isotta con sé. / Egli ha Isotta, ma non è / quella che per primafu sua amica. / Pensa a che cosa può fare, / come potrà farla venire a sé, / poiché non osa andare nel paese./ «Ah, Dio», dice, «qual destino! / Che ho sofferto in quest’amore! / Non me ne lamentai mai, / non milamentai mai della mia angoscia. / Perché mi assale? Perché mi ferisce?).
L’eroe del mito e dell’epos è stato messo a nudo dal divarioche in lui si è spalancato tra l’essere per il mondo e l’essereper se stesso, tra il sociocentrismo del mito e il richiamo dellasfera privata:
prima di bere il fatale filtro amoroso Tristano era un eroe fiabesco o unmodello epico, vincitore di mostri, difensore del paese, non voleva pagare iltributo ai nemici, era il vassallo ideale e il degno erede di suo zio, il reMarco. Nella parte fondamentale, specificamente romanzesca di quest’opera,Tristano, schiavo del suo amore, compie gesta eroiche solo per la salvezzapropria e di Isotta, per la difesa del proprio rapporto illegale dalle spie edai delatori, e dalla persecuzione da parte del re Marco, legittimo marito diIsotta. Per gli stessi motivi Tristano arriva addirittura a organizzare
Cesare Segre, «Un procedimento nella narrativa medievale: l’enucleazione», inItalica et Romanica, Tübingen, Niemeyer, 1997, III, pp. 361-7; Huguette Legros,«Quand Tristan réécrit son histoire…», in Remenbrances et resveries. Hommage à JeanBatany, Orléans, Paradigme, 2006, pp. 29-40. Si vedano inoltre: Jean-CharlesPayen, «Tristan, l’amans-amens et le masque dans les Folies», in La légende de Tristanau Moyen Âge, D. Buschinger (dir.), Göppingen, Kümmerle Verlag, 1982, pp. 61-68;Rosanna Brusegan, «La folie de Tristan: de la loge du Morrois au palais deverre», in La légende de Tristan au Moyen Âge, pp. 49-59; Jean-Charles Huchet, «Lemythe du Tristan primitif et les Folies Tristan», in Tristan et Iseut, mythe européen etmondial, D. Buschinger (dir.), Göppingen, Kümmerle Verlag, 1987, pp. 139-150;Cesare Segre, «Preistoria delle ‘Folies Tristan’», in Le Roman de Tristan. Le mascheredi Béroul = Medioevo Romanzo 25 (2001): 165-180. 51 Meletinskij, Introduzione alla poetica storica dell’epos e del romanzo, p. 236.
stratagemmi di tipo novellistico.52
L’appunto di Meletinskij coglie i volti, i tratti di Tristano:eroe mitico-epico-fiabesco, cavaliere, uomo interiore, trickster (ilTristano novellistico). Meletinskij, che pure dice che «l’eroemitico può riunire in un unico personaggio i tratti dell’eroecivilizzatore e della sua controfigura comica»53, separa inTristano questi volti secondo un prima e un dopo, secondo unalogica temporale, secondo una logica identitaria rigida, che nontiene conto dei sommovimenti dell’identità, di cui i testi delleFolies sembrano una vera e propria messa in scena.
Nella dinamica del rappel a segmenti precedenti della storia,il testo di Berna, una volta avviata la rimemorazione, continua agiocare sull’ambiguità delle due diverse mancanze in cui si logoraTristano. Dalle prime battute del racconto nel racconto, la vocedel protagonista si spende in un elogio dell’oggetto d’amore, maquesto è subito offuscato, e spodestato quasi, daun’autorappresentazione dell’eroe:
mout me gari soëf ma plaieque je reçui en Cornuailleqant al Morhot fis la batailleen l’ile ou fui menez a nagepor desfandre lo treüssajeque cil devoient de la terre;a m’espee finé la guerre. (Fb, vv. 77-83)
(con tanta dolcezza mi guarì la ferita / che ricevetti in Cornovaglia, / quando diedi battaglia al Moroldo /nell’isola dove fui portato per mare / a combattere per il tributo / che dovevano quelli della terra; / con lamia spada posi fine alla guerra).
Il tratto dell’innamorato melanconico ha portato Tristano atessere le lodi di Isotta, rievocando come curò la sua ferita dopola grande impresa del combattimento contro il Moroldo, ma subitoil ricordo cambia centro e finisce per fornire un’autocelebrazionedell’eroe. Accanto all’uomo interiore appare l’immagine dell’eroe-tipo, uccisore di mostri e salvatore di popoli assoggettati atiranni vessatori, che pone fine a ogni male con la sua spada.
Il richiamo al Tristano eroe compare nella prima parte di Foin maniera ancora più sottile che in Fb. Al contrario del testo diBerna, dove il viaggio di Tristano in mare verso la Britannia èliquidato in due versi («quant il ot passé mer, / Passez est outrelo rivage», ‘quando ebbe attraversato il mare, passò al di là52 Ivi, p. 237.53 Ivi, p. 47.
della riva’, vv. 125-126), quello di Oxford dedica un certo spazioalla sua rappresentazione. Tristano, per non essere riconosciuto,raggiunge a piedi la costa e qui trova una grande nave mercantilediretta in Inghilterra; chiede ai marinai che stanno perimbarcarsi se sono disposti ad accoglierlo e, accettata larichiesta, parte alla volta della Britannia:
entrez dunc tost, venez avant!Tristan i vent e si entre enz.El vail amunte s’i fert li venz.A grant esplait s’en vunt par le unde,trenchant en vunt la mer parfunde.Mult unt bon vent a grant plenté,a plaisir, a lur volunté.Tut droit vers Engleterre curent,dous nuiz e un jur i demurent;al secund jur venent al port,a Tintagel, si droit record. (Fo, vv. 84-94)
(«entrate, dunque, presto, venite avanti». / Tristano avanza e s’imbarca. / In alto il vento batte sulla vela. / Sene vanno rapidamente per le onde, / vanno solcando il profondo mare. / Hanno in abbondanza ventofavorevole, / a loro piacere, a loro volontà. / Corrono dritto verso l’Inghilterra;/ viaggiano due notti e ungiorno; / al secondo giorno giungono al porto, / a Tintagel, se ben ricordo).
Il passo ha una certa valenza intertestuale. Benché nessunodei due più importanti romanzi francesi possa dirci nulla sullaprima parte della leggenda, il testo tedesco di Eilhart von Obergconosce bene quest’immagine di Tristano in mare alla conquista diIsotta, la fanciulla dal capello d’oro54: Tristano parte con unequipaggio di cento cavalieri che «passèrent un mois en mer sansvoir autre chose que le ciel et les flots»55. Ma, se in quel casoTristano si metteva in mare alla conquista di una donna nondestinata a lui, creando uno spostamento rispetto alla parabolaprevista dal monomito dell’eroe, rispetto all’eroe-tipo del mito edel folklore, qui il paradigma viene realizzato nella suapienezza: Tristano affronta il mare alla conquista della ‘sua’principessa, e sembra quasi che il testo si preoccupi di risolvereun’anomalia congenita della leggenda56. Nello stesso tempo, non sipuò però non tenere presente che a partire alla conquista d’Isottanon è una superba figura eroica con un folto seguito e una nave sucui è stato imbarcato «en grande quantité de l’or»57, ma un anonimo54 Tristan et Iseut. Les premières versions européennes, pp. 263-388, alle pp. 282-285.55 Ivi, p. 283.56 Su questa deviazione si veda la già citata Legros («Quand Tristan réécrit sonhistoire…»).57 Tristan et Iseut. Les premières versions européennes, p. 283.
popolano che ha avuto la fortuna di essere ospitato su una navemercantile. Anche in questo caso il mito è cioè distanziato,alluso ma non pienamente assimilato dal testo: il mito è ‘citato’.Tra il personaggio e il suo paradigma si frappone un diaframma,che non permette un’univoca identificazione. Il tormento d’amoredi Tristano, tormento privato, lo fa sprofondare, sì, inun’incolmabile lontananza dalla sua matrice eroica, ma senza chequesta sia mai veramente annullata; ne resta un’ombra, unriflesso, e lo statuto identitario del personaggio perde indefinizione, si converte in un’immagine fluttuante tra passato epresente.
L’ibridismo di quest’immagine si complica ulteriormente con iltravestimento da folle. Giunto alla corte di Cornovaglia,Tristano-folle è interrogato da Marco:
Fous, con as non? – G’é non Picous.Qui t’angendra? – Uns galerous.De qui t’ot il? D’une balaine. (Fb, vv. 160-162)
(«Folle, quale nome hai?». «Ho nome Picous». / «Chi ti generò?». «Un tricheco». / «Da chi ti ebbe?». «Da unabalena»).
Più articolato il racconto delle origini nel testo di Oxford:
ma mere fu une baleine, en mer hantat cume sereine, mes je ne sai u je nasqui.Mult sai ben ki me nurri:une grant tigre me alettaten un roche u ele me truvat.Ele me truvat suz un perun, quidat ke fusse sun foün,si me nurri de sa mamele. (Fo, vv. 273-281)
(mia madre fu una balena / che abitava nel mare come sirena. / Ma non so dove nacqui. / So bene chi miallevò: / mi allattò una grande tigre / su una rupe dove mi aveva trovato. / Mi trovò sotto una grande pietra,/ pensò che fossi un suo cucciolo, / e mi nutrì della sua mammella).
Il folle continua, in entrambi i testi, raccontando di avereuna sorella che baratterebbe volentieri con Isotta, con cui sirifugerebbe in una dimora sospesa tra le nuvole e il cielo, che inOxford è più minuziosamente descritta come una reggia di cristallo(vv. 301-310). La descrizione della dimora aerea ha spinto lacritica a mettere a fuoco un evidente richiamo intertestuale allaconvivenza dei due amanti nella foresta del Morrois o nella
Minnengrotte58, ma mi pare che tutto l’episodio sia fitto dirichiami intertestuali.
Il racconto delle origini è evidentemente improntato allacaratterizzazione animalesca della figura del trickster, controfiguracomico-parodica dell’eroe civilizzatore. Eppure, l’effettoparodico è ambiguo e, rappresentando il basso, il testo evoca‘l’alto-altro’. Nell’effetto ludico prodotto in sede di ricezione,basato sul contrasto e sulla menzogna, il racconto del follerichiama l’altra matrice delle origini del protagonista, quellaseria e alta – e non meno favolosa – che lo ritrae figlio diBiancofiore, sorella di Marco, e di Rivalen, nobile cavalieremessosi al servizio del sovrano di Cornovaglia. L’effetto, ancorauna volta, è quello di un’immagine ambigua e fluttuante delpersonaggio.
Di là dall’ambiguità del gioco parodico, bisogna inoltreprecisare che il tratto stesso dello zooantropomorfismo è pregnodi ambiguità, appartenendo a una concezione della natura eroicache non prevede dicotomie di nessun tipo: la ferinità sembra«eccedere di gran lunga i limiti della caricatura, rinviandoinvece a sostrati arcaici e memorie ancestrali»59. Il rapportodell’eroe con l’animale è, in una fase arcaica del percorso umano,molto stretto, e il mito, con i richiami al totemismo dell’eroe ealla natura zooantropomorfa degli eroi civilizzatori, non fa cheaffermare questa stretta parentela di eroe e bestia, di forzacivilizzatrice e potenza animalesca di una natura primordiale60.Sia che questi passi delle Folies si leggano in chiave parodica, siache si opti per la lettura di un motivo antropologico denso diimplicazioni semantiche, il risultato resta comunque quello di unoltrepassamento delle dicotomie, di una strategia diassimilazione, mai pienamente risolta, di due tratti delpersonaggio, che oscilla tra gli estremi dell’alto e del basso,della potenza civilizzatrice e di quella animalesca, della figuraeroica e di quella dell’escogitatore di stratagemmi, in unaconcomitanza di gioco comico e spirito tragico mai veramenteannullato.
L’identificazione del personaggio di Tristano con uno dei due
58 Si veda sull’argomento il già citato contributo di Brusegan, «La folie deTristan: de la loge du Morrois au palais de verre».59 Alvaro Barbieri, «Ivain cavaliere-sciamano: elementi estatici e ritid’iniziazione nel Chevalier au lion», in Figure della memoria culturale. Tipologie, identità,personaggi, testi e segni. Atti del convegno (Macerata, 9-11 novembre 2011), a c. di M.Bonafin = L’immagine riflessa N.S. 22 (2013): 109-148, a p. 120.60 Si veda Meletinskij, Il mito. Poetica folclore ripresa novecentesca, p. 185 e seguenti.
tratti, trickster o eroe-tipo, ha vita breve, e all’evocazionedell’uno subentra immediatamente l’immagine dell’altro, secondo ledinamiche di una logica fluida, dove il confine identitario èdisponibile alla ridefinizione continua, non solo sulla base deglienunciati presenti nel testo, ma anche delle associazioni versocui questi enunciati pilotano il lettore-spettatore. I volti diTristano si condensano e si sfumano reciprocamente. Più che uneroe ‘multiplo’, un eroe ‘dai mille volti’, come suggerisce laformula di Campbell, Tristano sembrerebbe un eroe scisso,oscillante, attraversante rappresentazioni estreme. Oltre lamaschera e il travestimento, oltre le facciate che variano secondogli episodi e le necessità dell’intreccio, i testi di Berna e diOxford ci offrono un soggetto ibrido nella concomitanza deimodelli che evoca, e mai pienamente definito.
Il modello eroico sarà ovviamente valorizzato (soprattutto perquanto riguarda il testo di Oxford) nella rimemorazione che ilfolle proporrà nel colloquio con Isotta, in cui si menzionerannola grande impresa contro il Moroldo e il suo primato di cavaliereineguagliabile. Un passato che sembra sprofondare in un tempomitico e irrimediabilmente perduto riconfigura il presente e ilprofilo di un Tristano esiliato dalla corte e costretto amascherarsi da folle:
membrer vus dait quant fui nauvrez,– maint home le saveit assez –quant me cumbati al Morhout ki votre treü aver volt. (Fo, vv. 329-332)
(dovete ricordarvi di quando fui ferito – molti lo sanno – allorché combattei col Moroldo, che voleva avere ilvostro tributo).
mais je ere chevaler mervilus,mult enpernant e curajus:ne dutai par mun cors nul homeki fust de Scoce treske a Rume. (Fo, vv. 405-408)
(ma ero un cavaliere straordinario, / molto ardito e coraggioso: / non temevo nessuno di fronte a me, / chefosse dalla Scozia fino a Roma).
5. Attraverso l’articolazione dei livelli diegetici e larimemorazione, i testi delle Folies creano un personaggio-immagine61
61 Per la nozione di image-personnage, con la quale si considera il personaggio ilfrutto di una collaborazione tra testo e lettore, si rinvia a Vincent Jouve(L’effet personnage dans le roman, Paris, PUF, 2001, in particolare alle pp. 40 ss.).
che oltrepassa tanto la contrapposizione cronologica tra passato epresente quanto quella tra alto e basso, tra un versante tragico-eroico e, per riprendere un’espressione bachtiniana, uno basso-materiale-corporeo. In questa ‘com-presenza’, in questa ‘sintesi’,le Folies si appropriano non semplicemente di motivi e contenutimitologici, ma anche di meccanismi propri del linguaggio del mitoe delle immagini che in esso si producono, di logiche efunzionamenti fluidi che attraversano il tessuto mitico. Laparticolare conformazione che il gioco della memoria conferiscealle Folies isterilisce quella dicotomia di un Tristano pre- e post-filtro di cui parla Meletinskij, dicotomia secondo cui, «nellaparte specificamente romanzesca», Tristano si distaccherebbe dalmodello mitico per incanalare il proprio eroismo in un’ossessivitàerotica, che lo porterebbe a quegli «stratagemmi di tiponovellistico» che sono al centro dei testi di Oxford e Berna. Ilrecupero del passato mitico messo in atto nelle Folies non è unmotivo puramente esornativo, ma rientra nelle strutture profondedel testo, testo diviso tra un qui e un altrove, che mette inscena un personaggio altrettanto diviso e complesso nellaconfluenza che in lui si realizza di paradigmi diversi ma noncontraddittori. Tristano travestito da folle e dicitore del suostesso romanzo cita il mito non solo nel senso che cita leimmagini del mito, ma incorpora e rivela anche il modo delpensiero mitologico, che diventa modo d’essere del personaggio, ilquale si realizza nella tensione confusiva tra un’identità inpraesentia e un modello in absentia.
In quest’ottica, le Folies ci inviterebbero a un’attenzione allaformalizzazione dei testi, oltre i dati contenutistici. CesareSegre, proponendo un parallelismo tra le Folies Tristan e l’Amleto diShakespeare, testi in cui «il passato viene incastonato nelpresente della vicenda»62, ha avanzato l’ipotesi dell’«esistenza dimotivi non contenutistici, ma formali, in pratica di procedimentinarrativi che collegano narrazioni anche eterogenee non in base aquanto raccontano, ma in base a espedienti narrativi comuni»63. Leforme possono essere depositarie di un senso, trascurare il qualecondurrebbe a un impoverimento del testo. Nel caso delle Folies,sarebbe piuttosto agevole valorizzare il gioco comico deltravestimento, della ruse, trascurando la costante citazione di unpiano eroico, alto, tragico, il quale sembra costituire per ilpersonaggio una mancanza che conferisce spessore al suo statuto62 Cesare Segre, «Tra le Folies Tristan e l’Amleto», in Id., Ritorno alla critica, Torino,Einaudi, 2001, pp. 233- 238, a p. 238.63 Ivi, p. 237-238.
identitario.Benché il meccanismo metadiegetico costituisca un asse
strutturante che segna macroscopicamente i testi di Oxford eBerna, il gioco della pluralità dei livelli del racconto non èprecluso ai due romanzi in versi della leggenda tristaniana. Ènoto come nel romanzo di Thomas64 lo spazio riservato alla figuraeroica e all’azione sia messo in ombra dall’analisi introspettivadell’innamorato melanconico, «triste e ripiegato su se stesso»65.Ciononostante, il frammento conservato dal manoscritto Sneydracconta dell’episodio del gigante delle barbe, il cui valore inrapporto alla costruzione del personaggio mi pare nontrascurabile. Dopo il racconto della prima notte di nozze diTristano e Isotta dalle Bianche Mani, in cui Tristano apporta lascusa della ferita al fianco per astenersi dai doveri coniugali,il frammento prevede un cambio di scena (v. 855 ss.). Il raccontosi sposta a contemplare Isotta en sa chambre, che pensa a Tristano esi mortifica per non avere da qualche tempo sue notizie; non sa nédove si trovi né se sia vivo o morto. Le ultime informazionirisalgono alla sua impresa in Spagna:
ne set pas qu’il est en Bretaigne,encore le quide ele en Espaigne,la u il ocist le jaiant, le nevod a l’Orguillus grant,ki d’Afriche ala requereprinces e reis de tere en tere.66 (vv. 867-872)
(non sa che lui è in Bretagna, / lo crede ancora in Spagna, / là dove uccise il gigante, / il nipote del GrandeOrgoglioso, / che, venuto dall’Africa, andava sfidando / principi e re di terra in terra).
L’evocazione dell’impresa di Tristano offre all’autorel’occasione di raccontarne l’antefatto, introducendo nella tramala figura di re Artù, assente, per il resto, nel romanzo(diversamente dal romanzo di Béroul, dove Artù figura nellacelebre scena dell’escondit, nel ruolo di autorevole testimone delgiuramento d’Isotta). Orgoglioso il Grande aveva l’abitudine disfidare a duello principi e re per strappare loro le barbe, con le
64 Tristan et Yseut. Les premières versions européennes (pp. 123-212). L’edizione dei passi diseguito citati è curata da Christiane Marchello-Nizia.65 Franceschini, «Ephémeros. Per un’analisi dei caratteri nel “Tristano” diThomas e di Béroul», p. 277.66 Per l’episodio del gigante delle barbe si veda La Geste du roi Arthur. Selon le ‘Romande Brut’ de Wace et l’‘Historia Regum Britanniae’ de Geoffroy de Monmouth, présentation, éditionet traduction par E. Baumgartner et I. Short, Paris, Union générale d’Éditions,1993, pp. 298-299.
quali si era confezionato una pelliccia. Sentendo parlare di reArtù e del suo rinomato valore, il gigante gli chiede se siadisposto a farsi tagliare la barba e a inviargliela, perché possacompletare il bordo della pelliccia; in caso contrario, si sarebbecomportato con lui come con gli altri, sfidandolo a duello. Artùnon accetta la proposta, il gigante gli lancia la sfida, i due siscontrano e il prode Artù vince la battaglia. L’autore tiene aprecisare il carattere digressivo dell’episodio:
A la matire n’afirt mie,nequedent boen est quel vos die, que niz a cestui cist esteitki la barbe aveir voleitdel rei e de l’empereür cui Tristan servi a icel jor,quant il esteit en Espaigne,ainz qu’il reparaist en Bretaigne. (vv. 935-942)
(non riguarda la materia, / ma tuttavia è necessario che ve lo racconti, / perché è il nipote di costui / chevoleva avere la barba / del re e dell’imperatore / al cui servizio si trovava allora Tristano, / quando era inSpagna, / prima di recarsi in Bretagna).
Il re di Spagna non trova nessuno tra parenti e amici che siapronto a battersi per difendere il suo onore. Tristano si proponeper l’impresa:
e Tristan l’emprist pur s’amur,si lui rendi molt dur esture bataille molt anguissuse;vers amduis fu deleruse.Tristan i fu forment naufrée el cors blecé e grevé,dolent em furent si amis.Mais li jaianz i fu ocis. (vv. 951-958)
(e Tristano s’impegnò per amicizia del sovrano, / e si batté contro il gigante in un combattimento duro / e inuna battaglia molto angosciosa; / fu dolorosa per entrambi. / Tristano fu colpito / e si procurò una graveferita, / gli amici ne furono afflitti, / ma il gigante fu ucciso).
Credo che la digressione, benché breve, rivesta un ruolonotevole: «la digression innerve l’ensemble, dynamise la lecture;elle fait sens, permettant de ranger la diversité sous l’Unité»67.Sarebbe abbastanza agevole vedervi una semplice parentesi, unbreve cenno a un ritratto eroico tra centinaia di versi impegnatia tratteggiare un personaggio ripiegato su se stesso, che si67 Chantal Connochie-Bourgne, «Avant-propos», in La digression dans la littérature et l’art duMoyen Âge, Senefiance 51 (2005): 7-9, a p. 8.
crogiola nelle sue pene d’amore, poco propenso all’azione.Bertolucci Pizzorusso, per esempio, considera le peripezie diTristano in Spagna «del tutto secondarie e come tali presentate»68.La nostra prospettiva ci porta invece ad attribuire loro un ruolomeno marginale.
Innanzitutto, mi pare d’obbligo considerare la posizioneoccupata nel romanzo di Thomas dal motivo del doppio: l’interoromanzo si articola attorno a una serie di richiami identitari,d’immagini speculari, di echi e incroci di maschere e figure69. Lostretto parallelismo tracciato tra Tristano e Artù, il fatto cheil protagonista compia la stessa impresa compiuta dal grandesovrano non può non far pensare a un meccanismo d’identificazionerispetto a un modello. A ciò si aggiunge la particolare posizionedella digressione, cui seguirà poco dopo l’incontro di Isotta conCariado, che cerca di conquistare i suoi favori. Interrotta neisuoi pensieri d’amore, Isotta è informata dal più vile deicavalieri delle nozze di Tristano con Isotta dalle Bianche Mani.Così risponde la regina:
ne unques chaenz ne venistesque males noveles ne desistes.Il est tuit ensement de vos cum fu jadis d’un perechus,ki ja ne levast de l’astrirfors pur alcon home coroceir.De vostre ostel jan en isterezsi novele oï n’avezque vos poissiez avant conter.Ne volez pas luin alerpur chose faire que l’en die!De vos n’irt ja novele oïedunt voz amis aient honur,ne cels ki vos haient dolor. Des altrui faiz parler volez,les voz n’irent ja recordez. (vv. 1041-1056)
(non siete mai venuto qui / senza cattive notizie. / Siete esattamente come quel pigro / che abbandonaval’uscio / solo per far incollerire qualcuno. / Non uscirete mai da casa / se non avete prima ascoltato qualchenotizia / che possiate raccontare. / Non andrete mai lontano / a compiere qualche impresa di cui si possaparlare. / Non si sentirà mai di voi una notizia / di cui i vostri amici siano onorati / e che addolori i vostrinemici. / Siete capace di parlare delle azioni / altrui, le vostre non saranno mai ricordate).
Mi sembra evidente il gioco dell’antitesi, della presentazione68 Valeria Bertolucci Pizzorusso, «Il discorso narrativo su Tristano e Isotta»,in Ead., Morfologie del testo medievale, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 7-17, a p. 16.69 Si veda, tra gli altri, Susan Dannenbaum Crane, «Doubling and Fine Amor inThomas’s Tristan», Tristania 5/1 (1979): 3-14.
di un personaggio come esatto opposto di Tristano e del modelloarturiano evocato nella digressione. Tanto Tristano è simile adArtù nella sua eroicità, tanto è lontano da Cariado, che non esceda casa se non per raccontare le imprese altrui, senza maiintraprenderne una in prima persona. Le posizioni dei trepersonaggi son ben calibrate nella struttura che le ospita, dallaquale emerge quel volto eroico che il romanzo di Thomas oscura aprofitto dei travagli sentimentali70. Lo stretto parallelismo conArtù, il richiamo a questo come a un modello d’identificazioneevocano un’eroicità che convive accanto alle pene inflittedall’amore contrastato. Se dovessimo riconsiderare le etichetteproposte da Meletinskij per Tristano, diremmo che, seppur permezzo di una digressione e di un fugace cenno, il Tristanomelanconico e introspettivo sta accanto all’eroe, o, almeno, a unasua ombra. Oltre i lunghi monologhi di un personaggio ripiegato su
70 Jean-Marc Pastré, commentando il confronto che il testo di Thomas propone conil modello eroico arturiano, ne parla in termini di subordinazione della materiatristaniana a quella arturiana. Non solo, dice lo studioso, le imprese diTristano dipendono da quelle di Artù, costituendone una copia infedele, ma«Arthur en outre s’en sort beaucoup mieux que Tristan», visto che il secondo,durante il combattimento con il nipote del gigante Orgoglioso, riceve una feritamortale (Jean-Marc Pastré, «Digressions et transmission du modèle héroïque dansles romans de Tristan au Moyen Âge», in La digression dans la littérature et l’art du MoyenÂge, pp. 309-317, a p. 313). L’argomento è utilizzato da Pastré per sostenereuna progressiva emancipazione della materia tristaniana da quella arturiana.Thomas farebbe già molto in questo senso, eliminando Artù dalla trama efacendolo comparire in una digressione, ma lascerebbe comunque intravedere unatraccia di dipendenza, mentre Goffredo di Strasburgo completerà l’operazione,eliminando totalmente il riferimento ad Artù. Personalmente, non trovocondivisibile l’idea di una subordinazione della figura di Tristano a quella diArtù. Se è vero che Tristano resta gravemente ferito nel combattimento colgigante, è vero anche che il testo menziona le difficoltà incontrate da Artù nelsuo combattimento: «ensemble vindrent puis andui, / e la barbe e les pelsmistrent, / par grant irrur puis se requistrent. / Dure bataille, fort estur /demenerent testruit le jor. / Al demain Artur le vencui, / les pels, la testelui toli (vv. 926-932: si ritrovarono uno contro l’altro, / misero in palio labarba e la pelliccia, / poi si affrontarono con violenza. / Dura fu labattaglia, rude l’assalto, / durò tutta la giornata. / L’indomani Artù fuvincitore, / gli tolse la pelliccia e lo decapitò). Mi sembra, insomma, che ilrapporto sia totalmente paritario e che il testo si sforzi di esaltare il valoreeroico di Tristano proprio tracciandone un perfetto parallelismo con Artù. Allacarriera eroica di Tristano, Pastré ha dedicato diversi contributi. Tra glialtri, si segnalano: «Morhold et le Tricéphale: les sources indoeuropéennes dumythe tristanien», in L’unité de la culture européenne au Moyen Âge, D. Buschinger e W-Spiewok (dir.), Greifswald, Reineke-Verlag, 1994, pp. 77-94 e «Tristan etHeraclès: la mort violente et le destin du héros», in La violence dans le mondemédiéval, Aix-en-Provence, CUER MA, 1994, pp. 379-395.
se stesso, afflitto dalle pene d’amore, poco propenso all’azione,leggiamo di un Tristano pronto alla battaglia, fiero, prode,disposto a combattere per difendere l’onore altrui. Certo, questapropensione interagisce minimamente con l’elemento più forte,quello del tormento amoroso, ma contribuisce nondimeno a definirelo statuto identitario del protagonista, la sua fluttuazione traun ritratto eroico e votato all’azione e l’inabissamento in unacupa melanconia, in una predilezione per i moti dell’anima e delpensiero.
6. Il potenziale semiotico della metadiegesi non è dasottovalutare. Essa crea un movimento testuale paragonabile a unmovimento ludico, è strumento di un gioco di segni con cui ilracconto ostacola la formazione di significati nitidi e asseconda,invece, il dipanarsi di un senso sempre in fieri.
Con la tecnica del racconto nel racconto, «l’attenzione sisposta dal fatto al modo di fare»71, ci troviamo davanti a unastruttura che oltre a significare al livello della storiaraccontata, significa anche al livello «del codice narrativo,della natura rappresentata, quindi artificiale e interpretativa,di ogni racconto»72. Il linguaggio e la scrittura diventanopresenze che il testo denuncia e, per Dällenbach, è come se ilracconto dichiarasse: je suis littérature73.
La riflessività del racconto apre al suo carattere di giocometamorfizzante. Lotman, in alcune pagine della Struttura del testopoetico74, ha spiegato come l’effetto di gioco nel testo letterarionon sia semplicemente riconducibile alla compresenza, magaricontraddittoria, di due diversi significati, ma nella coscienza71 Mario Perniola, Il metaromanzo, Milano, Silva, 1966, p. 57.72 Giovanni B. Tomassini, Il racconto nel racconto. Analisi teorica dei procedimenti d’inserzionenarrativa, Roma, Bulzoni, 1990, p. 22.73 Lucien Dällenbach, Le récit spéculaire. Essai sur la mise en abîme, Paris, Seuil, 1977, p.79. 74 Jurij M. Lotman, «I molti piani del testo artistico», in Id., La struttura del testopoetico, trad. di E. Bazzarelli, E. Klein, G. Schiaffino, Milano, Mursia, 1972(ed. orig. 1970), pp. 77-90. Scrive Lotman: «l’arte presenta una serie ditratti, che la apparentano con i modelli ludici. La percezione (e la creazione)di un’opera d’arte richiede un particolare comportamento, quello artistico, cheha una serie di tratti in comune con quello ludico»; «La determinazionerigorosamente monosemantica del significato del modello artistico è possibilesolo nell’ordine della sua transcodificazione nella lingua dei sistemi disimulazione non artistici. Il modello artistico è sempre più largo e più vivodella sua interpretazione, e l’interpretazione è sempre possibile comeapprossimazione» (ivi, alle pp. 85 e 88).
della costante possibilità di altri significati che esulino daquello immediatamente presente e comprensibile. Richiamandosi aquelle pagine, Philippe Daros ha illustrato l’effetto ludico dellametatestualità, la quale agisce in due sensi (piège e jeu)apparentemente contraddittori. Da un lato, si ha un ripiegamentodel testo su se stesso, con un effetto di rinvio autoreferenziale,chiuso e sterile, dall’altro, il processo che lega gli elementiriflessi e quelli riflettenti impedisce una cristallizzazionedegli uni come degli altri, li dinamizza costantementenell’autopresentazione ludica del testo, sempre sottoposto a ungioco di velamento e disvelamento75. Il testo, nella suariflessività, nel rimando a se stesso e all’altro, sottopone ognielemento a una vibrazione adulterante, in cui un dato non è maifissato in un’entità chiusa, ma si apre ai suoi possibili altri, aun’inafferrabile ‘terzietà’.
Questa riflessività del racconto in cui il personaggio sirealizza come immagine ibrida tra passato e presente, alto ebasso, tragico e comico si ritrova anche nel frammento di Béroul76.Nel complesso, la figura mitico-eroica sembrerebbe non contemplatanella parte del romanzo che possiamo leggere. Rispetto al suoprotagonista, Béroul «semplifica i tratti mitici costitutivi»77,ponendo al centro del suo romanzo due personaggi «sauvages,inapprivoisé et inapprivoisables»78, «qui commettent l’adultèreaussi souvent que possible, qui mentent régulièrement et avec75 «Le moirage provoqué par la diffraction paradigmatique de l’œuvre sur elle-même instaure précisément un jeu d’altération de son identité en lamétamorphosant en espace multidimensionnel et… transitionnel. A proprementparler, ce moirage lui confère son volume de “volume”. La réflexivité relèvealors du ‘piège’ et du ‘jeu’. Du piège parce qu’elle semble emprisonner l’œuvredans des effets de renvois obtus et itératif, du jeu parce que ce piège, aufond, n’emprisonne rien véritablement puisque ni les éléments réflecteurs, niles éléments réfléchis ne s’épuisent les uns les autres dans l’imparfaiteclôture de leurs renvois. L’auto-présentation – lacunaire, factice, multiple etcontinue – de l’œuvre par elle-même ouvre au jeu infini des interprétations,infini puisqu’elle souligne tout autant qu’elle occulte et, qui plus est, masquece qu’elle montre. Au total, la réflexivité double le mécanisme qui est celui dulittéraire même. En ce sens, elle fonctionnerait comme monstration de lacomposante ludique – ‘le jeu nécessairement déréglé’ – du littéraire» (PhilippeDaros, «De la réflexivité en général et de la mise en abîme [comme procédé] enparticulier», in La métatextualité, Narratologie 3 [2000]: 89-110, alle pp. 99-100).76 Tristan et Yseut. Les premières versions européennes, pp. 3-121. L’edizione del frammentodi Béroul è a c. di Daniel Poirion. 77 Valeria Bertolucci Pizzorusso, «Béroul e il suo “Tristan”», in “Le roman deTristan”. Le maschere di Béroul, pp. 211-220, a p. 219.78 Barbara N. Sargent-Baur, «La dimension morale dans le “Roman de Tristan” deBéroul», Cahiers de Civilisation Médiévale 31 (1988): 49-56, a p. 55.
virtuosité, qui se moquent de normes de leur société, qui sontmotivés par la soif de vengeance»79. Eppure, come abbiamo visto inThomas (e ancor più che in Thomas), il gioco analettico complicale cose.
Emmanuèle Baumgartner ha rilevato come il romanzo di Béroul,nella sua utilizzazione dell’analessi, proponga due tipi dipassato. Uno, per così dire, interno, che rinvia a una dinamica dirichiami che si offrono al lettore-spettatore, un passato cheripresenta spezzoni della storia già contemplati nel testo;l’altro, esterno, richiama una sorta di passato remoto cheinfluenza la costruzione di senso:
il y a ainsi, chez Béroul, toute une série de moments où l’on assiste en directà la création d’un passé qui n’est pas vraiment restitué à loisir nirigoureusement inséré dans la chaîne des causes et des conséquences, mais quisurgit lorsqu’il en est besoin, d’un coup de baguette magique.80
Di questi richiami analettici quello che si presenta conmaggiore frequenza è il riferimento all’impresa contro il Moroldo(ma compare anche qualche accenno al combattimento di Tristano conil dragone d’Irlanda). Nella distinzione tra un’analessi interna euna esterna di cui parla Baumgartner va ovviamente precisato chenon possiamo essere certi che gli eventi che sembrano affondare inquesto passato primitivo non fossero presenti nella versioneoriginaria del romanzo di Béroul81, ma, stando al frammento anostra disposizione, essi assumono un’aura mitica dotata diun’estrema autorevolezza.
Nel celebre episodio del colloquio spiato, Isotta, sapendo diessere ascoltata da Marco, s’impegnerà a tratteggiare unprestigioso ritratto di Tristano allo scopo di persuadere il re ariaccoglierlo a corte. Inoltre, se in un primo momento Isotta
79 Ivi, p. 54.80 Emmanuèle Baumgartner, «A la cour, il y avait trois barons», in “Le roman deTristan”. Le maschere di Béroul, pp. 269-283, a p. 272. Sull’analessi in Béroul sivedano anche Donald Maddox, «L’auto-réécriture béroulienne et ses fonctions», in“Le roman de Tristan”. Le maschere di Béroul, pp. 181-190 e Gioia Paradisi, «Lacostruzione del racconto nel “Tristan” di Béroul», in Parole e temi del romanzomedievale, a c. di A.P. Fuksas, Roma, Viella, 2007, pp. 39-66.81 «In effetti tutte le attualizzazioni della storia che noi conosciamo, sianoesse lunghe o brevi, presuppongono – più che un testo archetipo – una lineabiografica che va almeno dal duello con il Morholt alla morte degli amanti, laquale si sostanzia volta a volta attingendo ad una costellazione mobile, esoprattutto aperta, di episodi» (Alberto Varvaro, «Il Tristan di Béroul,quarant’anni dopo», in “Le roman de Tristan”. Le maschere di Béroul, pp. 312-346, a p.325).
rileva il valore dell’amato, in seguito entra nella cornice diquesto ritratto autoritario, vi si colloca al centro, accanto aTristano:
mot vos estut mal endurerDe la plaie que vos preïstes En la batalle que feïstes O mon oncle. Je vos gari. (vv. 50-53)
(vi è toccato sopportare molto dolore / per via della ferita che avete ricevuto / nel duello / contro mio zio. Iovi ho guarito).
Nella sua replica, Tristano insisterà sull’azione contro ilMoroldo, a ribadire lo scarto tra lui e i baroni:
mot les vi ja taisant et muz,quant li Morhot fu ça venuz,ou nen i out uns d’eus tot sousqui osast prendre ses adous. Mot vi mon oncle iluec pensis,mex vosist estre mort que vis.Por s’onor croistre m’en armai,combati m’en, si l’en chaçai. (vv. 135-142).
(li ho visti tacere, muti, / quando il Moroldo venne qui, / quando non ce ne fu uno solo di loro / che osòprendere le armi. / Allora vidi mio zio molto turbato, / avrebbe preferito essere morto. / Per accrescere il suoonore presi io le armi, / combattei, ed ebbi la meglio).
Tristano e Isotta si collocano così sul piano di una coppiaideale, superiore alla meschinità della corte di Marco,contrapponendovi la prospettiva di un passato autorevole che liblocca nella loro eroicità82. Nel successivo incontro con Isotta,82 Quest’appunto, interessato a illuminare una logica diegetica, si coniuga conla prospettiva proposta da Maria Luisa Meneghetti, che ha letto nel romanzo diBéroul una lotta per la successione a un re incapace di governare: «non misembra improprio avanzare un’interpretazione di tutto il Tristan . . . in chiavedi racconto di un tentativo (fallito) di passaggio – di translatio – del potere daun sovrano ormai considerato non meritevole di regnare a un altro, ritenuto piùdegno o capace (Maria-Luisa Meneghetti, «Béroul e il ‘male’ di re Marco», in “Leroman de Tristan”. Le maschere di Béroul, pp. 240-256, a p. 243). In effetti, il romanzopresenta spesso i due protagonisti come potenziali sovrani ideali, cosa che, mipare si realizzi, nella costruzione del personaggio, proprio in forza di unacontinua identificazione degli amanti rispetto a un modello trascendente. Sulruolo d’Isotta in questa idealizzazione della coppia, si vedano: ValeriaBertolucci Pizzorusso, «La corte e le sue immagini nel Tristan di Béroul», in Id,Morfologie del testo medievale, pp. 19-33; Bénédicte Milland-Bove e Vanessa Obry,«Appel et rappel des personnages dans le Tristan de Béroul», Textuel 66 (2012): 59-78 («Tristan et Yseut sont d’abord des individus qui peuvent être parfois vuscomme une entité supérieure», ivi, p. 73).
Marco, ancora una volta, proporrà la scena del colloquio nelgiardino, insistendo sulla profonda commozione che aveva suscitatoin lui:
«Sire, estiez voc donc el pin?- Oïl, dame, par saint Martin.Onques n’i ot parole diteGe n’oïse, grant ne petite.«Qant j’oï a Tristan retrairela batalle que li fis faire,pitie en oi, petit fallique de l’arbre jus ne chaï.Et quant je vos oï retrairele mal q’en mer li estut trairede la serpent dont le garistes,et le grans bien que li feïstes,et quant il vos requist quittancede ses gages, si oi pesance;ne li vosistes aquiterne l’un de vos l’autre abiter,pitie m’en prist an l’arbre sus.Souef m’en ris, si n’en fis plus. (vv. 475-492)
(«Sire, eravate dunque sul pino?». / «Sì, signora, per san Martino. / Non c’è stata parola / che io non abbiaudito, grande e piccola. / Quanto ho sentito Tristano raccontare / il duello che gli ho fatto combattere, / neho avuto pietà, mancò poco / che non cadessi dall’albero. / E quando vi ho sentito raccontare / il male chegli toccò sopportare in mare, / della ferita inferta dal drago, da cui lo avete guarito, / e il gran bene che gliavete fatto, / e quando vi ha chiesto di riscattare / i suoi beni, ho provato una gran pena; / non avete volutoliberarlo dal debito, né vi siete avvicinati l’uno all’altra. / Pietà mi ha preso lì sull’albero. / Ne ho sorrisodolcemente, non ho fatto altro).
L’operazione di penetrazione nella coscienza di Marco duranteil colloquio spiato ha dato un esito che si spinge ben oltre ipresupposti. Si noti il verso 485, che richiama il serpent, ildragone che terrorizzava l’Irlanda e da cui Tristano, pronto acombatterlo, ricevette una ferita mortale. Nella scena delcolloquio spiato si fa riferimento soltanto al combattimento conil Moroldo, che, verosimilmente, è la batalle che Marco rievocacinque versi prima del serpent. La performance di Tristano e Isottaha talmente manipolato la coscienza del re da creare in luiun’associazione d’immagini per cui il Moroldo richiama il dragone,mettendo a fuoco le due grandi imprese che fissano Tristano nelsegno dell’eroicità83. Ancor più di quanto non avessero fatto
83 Il riferimento al Moroldo, associato a quello al dragone, sembra ispirato,come nel romanzo di Eilhart von Oberg (éd. Pléiade, p. 268 e seguenti) a unafigura arcaica, che valorizza il riferimento al modello mitico di cui si èdetto. Il personaggio assumerà tutt’altro aspetto nel romanzo di Goffredo di
Tristano e Isotta, Marco colloca i due amanti sul pianotrascendente di un richiamo a un mondo mitico: Tristano è ilvincitore di mostri e liberatore di popoli, Isotta è colei che,puntualmente, lo guarisce da ferite mortali.
Il riferimento alle grandi imprese tristaniane è l’argomentoprincipale con cui il popolo, «personaggio-coro»84, sostiene i dueamanti condannati al rogo:
ahi! Tristan, si grant dolorssera de vos, beaus chiers amis,qant si seroiz a destroit mis!Ha! Las, quel duel de vostre mort!Qant le Morhout prist ja ci port,qui ça venoit por nos enfanz,nos barons fist si tost taisanzque onques n’ot un si hardiqui s’en osast armer vers lui.Vos enpreïstes la batallepor nos trestoz de Cornoualleet oceïtes le Morhout.Il vos navra d’un javelot,sire, dont tu deüs morir.Ja ne devrïon consentirque vostre cors fust ci destruit. (vv. 844-859)
(ahi, Tristano, che enorme dolore / proveremo per voi, caro amico, / quando sarete suppliziato! / Ah, chedolore la vostra morte! / Quando il Moroldo è sbarcato qui / per prendersi i nostri figli, / fece ammutolire ibaroni, / tanto che non ce ne fu uno così temerario / da osare prendere le armi contro di lui. / Voi aveteaffrontato il combattimento / per tutti noi della Cornovaglia, / e avete ucciso il Moroldo. / Egli vi ferì con ungiavellotto, / signore, e ne sareste dovuto morire. / Non dovremmo permettere, ora, / che siate messo amorte).
Tristano e Isotta sono posti dal popolo sotto il segno diun’autorità che travalica la loro colpa, quella stessa autoritàche i due protagonisti reclamavano per sé nell’episodio delcolloquio spiato: Tristano ha ucciso il Moroldo, e sarebbe mortose non fosse stato per le cure prestategli da Isotta. Il popolo,riconoscente a Tristano per averlo liberato da una tirannia,rivendica per i due amanti il ruolo di garante del tessutosociale. Come abbiamo visto nelle Folies, o nel racconto del giganteStrasburgo, in cui appare nei panni di un cavaliere (ed. Pléiade, pp. 469 ss.).Sul Moroldo, oltre i citati contributi di Pastré, si veda Fabrizio Cigni, «Daun’avventura tristaniana al mito di Eracle: la sconfitta del Moroldo», inRinascite di Ercole, a c. di A.M. Babbi, Verona, Fiorini, 2002, pp. 183-198.Sull’importanza del richiamo analettico all’impresa contro il Moroldo nelromanzo di Béroul insiste Legros («Quand Tristan réécrit son histoire…»).84 Alberto Varvaro, Il “Roman de Tristan” di Béroul, Torino, Bottega d’Erasmo, 1963, p.94.
delle barbe in Thomas, l’analessi pone Tristano (e, con lui,Isotta) su un piano mitico, che lo immortala nella sua levaturaeroica.
Il riferimento al combattimento contro il Moroldo sarà ripresoancora una volta anche da Marco nell’episodio della foresta delMorois, quando, sorpresi gli amanti a dormire insieme vestiti econ una spada che separa i loro corpi, sostituirà la propria spadacon quella di Tristano:
et, quant vendra au departir,prendrai l’espee d’entre eus deusdont le Morhot fu del chief blos. (vv. 2036-2038)
(e, al momento di andar via, / prenderò la spada tra loro due, / quella con cui fu tagliata la testa alMoroldo).
Nel momento in cui, finito l’effetto del filtro, i due sipentiranno e accetteranno, per il tramite dell’eremita Ogrin, diinviare una lettera a Marco con una richiesta di perdono, si porràcome premessa alla richiesta l’altra grande impresa di Tristano,l’uccisione del dragone che affliggeva l’Irlanda e, eliminando ilquale, l’eroe ottenne la mano d’Isotta85:
rois, tu sez bien le mariagede la fille le roi d’Irlande.Par mer en fui jusqu’en Horlande,par ma proece la conquis,le grant serpent cresté ocis,par qoi ele me fu donee. (vv. 2556-2561)
(re, tu sai come si è realizzato il matrimonio / con la figlia del re d’Irlanda. / Mi sono recato in Irlanda permare, / l’ho conquistata grazie alla mia prodezza, / ho ucciso il gran drago crestato, / per cui ella mi fuconcessa).
Si denuncia così, come già visto in precedenza, l’alterazionerispetto alla legittima trama: Isotta sarebbe dovuta andare insposa a Tristano, non a Marco86. L’anomalia attorno a cui gravitala storia dei due amanti sarebbe così capovolta, essendoimputabile all’indebita appropriazione del re piuttosto cheall’amore extraconiugale. 85 Cfr. Brian Pitts, «Writing and Remembering in Beroul’s Roman de Tristan: the Roleof Ogrin in the Second Hermit Episode, Tristania 13 (1987-1988): 1-18.86 «A nouveau, le message est clair: celui qui a accompli l’exploit qualifiantmérite en récompense la fille du roi; Yseut lui revenait donc de droit» (Legros,«Quand Tristan réécrit son histoire…», p. 36). Si veda anche MariantoniaLiborio, «Come dire l’indicibile: il Tristano di Béroul», in “Le roman de Tristan”. Lemaschere di Béroul, pp. 257-268, a p. 260.
I passi estrapolati rappresentano ben poca cosa rispetto aimomenti in cui i due amanti sono impegnati a mentire, escogitarestratagemmi per incontrarsi, assecondare la propria bramosia, mail gioco analettico influenza profondamente la costruzione deicaratteri. Il doppio piano del racconto assolutizza una storiapresupposta, la pone nella sfera di un’autorità trascendente chepilota il senso della storia attuale, l’attira in un universosuperiore agli intrighi della corte di Cornovaglia. Il pechié diTristano e Isotta è, dunque, sminuito da una loro continuaidentificazione rispetto a un modello superiore che percorre iltesto. Nel romanzo di Béroul, la visione a favore degli amanti87 siformalizza in una particolare configurazione della scrittura, inun rinvio a una storia altra che sembra appartenere a un passato dacui il personaggio trae il proprio archetipo, in un gioco diprospettive per cui il testo rinvia a un altro testo e i due eroisono contemporaneamente inscritti in un qui e in un altrove. Ilromanzo si costruisce attorno allo scarto tra il modello in absentiacui gli eroi fanno riferimento e la loro sfortunata collocazione,in praesentia, nella corte di Marco.
Se in Thomas domina l’innamorato melanconico ripiegato su sestesso, mentre in Béroul «l’uomo attivo, mobile, agile, attento,vigile, capace in ogni momento di sfruttare l’occasione a suovantaggio, abile nel parlare e nell’ingannare il suo prossimo,caratteristiche queste dell’uomo dotato di metis»88, il gioco deilivelli narrativi complica le prospettive, proponendo in alcunipunti di entrambi i romanzi un personaggio da intendersi comeimmagine confusiva che non si cristallizza in un profilo dallelinee nettamente tracciate. Benché non sia soggetto aun’evoluzione psicologistica che si sviluppi nel percorsotemporale, il personaggio di Tristano non si lascia bloccare nelcarattere che sembra maggiormente descriverlo, perché rispetto aquel carattere i testi offrono punti di fuga, punti in cui siscivola nel contiguo e nell’opposto. Le fluttuazioni dellamemoria, su cui s’imperniano le Folies con quel loro oltrepassare labarriera tra passato e presente, sono già in embrione nei duetesti più antichi.
87 Visione che, come rileva Bertolucci Pizzorusso, viene spesso assunta come undato di fatto: «La posizione assunta da Béroul, decisamente schierato dallaparte degli amanti, è curiosamente presentata come “scontata”: equivale a ungiudizio già dato nel merito» (Bertolucci Pizzorusso, «Béroul e il suo“Tristan”», p. 213). 88 Franceschini, «Ephémeros. Per un’analisi dei caratteri nel “Tristano” diThomas e di Béroul», p. 277.
Nell’inclinazione confusiva del personaggio, il testo cita ilmito due volte. Non solo richiama immagini e motivi propri delmito, ma, dal punto di vista della forma, ne assume anchel’ibridismo, la libera circolazione delle contraddizioni, ilrifiuto di un rigido principio d’identità che si affermi nellosviluppo temporale. Il personaggio rivela così una complessitàdata da un movimento pur nella stasi, da una simultaneità degliopposti, dall’annullamento di passato e presente comeconfigurazioni autonome, da un’oscillazione tra estremi che loridefiniscono, lo riscrivono. Ecco che gli enunciati che ‘lodicono’ non bastano ad afferrare il personaggio, poiché esso è unpiù articolato prodotto delle strategie testuali. Mai soltantoeroe, mai soltanto trickster, cavaliere o folle d’amore, Tristanosembra piuttosto, per riprendere la formula di Jung, uninafferrabile terzo ignoto, oscillante tra rappresentazioni i cuiconfini restano sfumati.