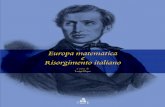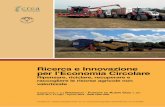Innovazione e sviluppo economico. Limiti e atipicità del modello italiano
Transcript of Innovazione e sviluppo economico. Limiti e atipicità del modello italiano
Corso di Laurea in Relazioni Internazionali e
Studi Europei
Tesi di Laurea in Storia Economica
Innovazione e sviluppo economico.
Limiti e atipicità del modello italiano
Relatore: Prof. Luciano Renato Segreto Candidato: Lorenzo Tiberi
Anno Accademico 2013/2014
2
INDICE
INTRODUZIONE ................................................................................................................ 4
CAPITOLO I
L’INNOVAZIONE NELLA TEORIA ECONOMICA ....................................................... 7
1 Progresso tecnico e innovazione nel pensiero economico ......................................... 7
1.1 I classici e il progresso tecnico ............................................................................ 8
1.2 Il pensiero Neoclassico e il progresso tecnico esogeno ..................................... 10
1.3 La Contabilità della Crescita ........................................................................... 12
1.4 Deviazioni dal pensiero Neoclassico ................................................................. 13
1.5 La flessibilità del filone Mainstream ................................................................ 15
2 Economia evolutiva dell'Innovazione ..................................................................... 16
2.1 Il pensiero di Schumpeter ................................................................................ 17
2.2 Approccio evolutivo .......................................................................................... 19
2.3 La teoria comportamentista ............................................................................. 20
3 Fondamenti di economia dell'innovazione ............................................................. 21
3.1 L’ambiente e gli agenti ..................................................................................... 22
3.2 Apprendimento e Routine ................................................................................ 23
3.3 La varietà nel sistema economico .................................................................... 25
3.4 La selezione ....................................................................................................... 26
3.5 La diffusione ..................................................................................................... 28
3.6 Path dependence ............................................................................................... 29
3.7 Le istituzioni ..................................................................................................... 30
3.8 Traiettorie, paradigmi e regimi tecnologici ..................................................... 31
3.9 Coevoluzione/Sistema di Innovazione .............................................................. 32
4 Innovazione: una possibile definizione ................................................................... 34
5 La complessità dell’innovazione ............................................................................. 36
CAPITOLO II
L'ITALIA DEL DOPOGUERRA: UNA STORIA INNOVATIVA DI SUCCESSO ......... 38
1 Dal dopoguerra agli anni Novanta .............................................................................. 39
1.1 La Guerra è finita ............................................................................................. 40
1.2 Età dell'Oro ...................................................................................................... 41
1.3 Il rallentamento dell’economia italiana ........................................................... 47
3
2 Il sistema d’innovazione italiano ............................................................................. 53
2.1 Arretratezza, cambiamento strutturale o innovazione? ................................. 53
2.2 Misurare l’innovazione .................................................................................... 56
2.3 L’attività di Ricerca e Sviluppo ....................................................................... 59
2.4 L’attività brevettuale ........................................................................................ 64
2.5 Acquistare tecnologia dall’estero ..................................................................... 69
2.6 L’importanza dei beni capitali ......................................................................... 72
2.7 Istruzione formale e apprendimento informale............................................... 75
2.8 Uno sguardo d’insieme ..................................................................................... 78
2.9 Uno sguardo alle prestazioni settoriali ............................................................ 81
3 Sistema innovativo o Sistemi innovativi? ............................................................... 86
CAPITOLO III
DA TANGENTOPOLI ALLA CRISI: IL VENTENNIO PERDUTO ITALIANO .......... 94
1 L’Italia e il mondo che cambia ................................................................................ 94
1.1 Crollo politico ed economico ............................................................................ 95
1.2 La terza rivoluzione industriale e la terziarizzazione dell’economia ........... 102
2 L’andamento dei sistemi innovativi italiani ......................................................... 105
2.1 L’innovazione diminuisce .............................................................................. 105
2.2 Ricerca e Sviluppo: un mancato decollo ........................................................ 107
2.3 L’attività brevettuale ...................................................................................... 110
2.4 Acquistare tecnologia all’estero ..................................................................... 115
2.5 Macchinari e investimenti .............................................................................. 118
2.6 Istruzione formale e apprendimento informale............................................. 120
2.7 Pochi cambiamenti nelle prestazioni settoriali .............................................. 123
2.8 Diffusione delle ICT e altri ostacoli all’innovazione ..................................... 126
2.9 Che innovazione fa? ....................................................................................... 128
3 Un declino inarrestabile? ...................................................................................... 131
CONCLUSIONI ............................................................................................................... 136
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 143
4
INTRODUZIONE
Lo sviluppo economico di un paese dipende in maniera cruciale dalle innovazioni introdotte nel
suo sistema produttivo poiché, procurando un guadagno di produttività, la loro diffusione
aumenta la competitività e il tasso della crescita economica. Ai giorni nostri questa relazione è
ancora più evidente rispetto al passato visto che l’effetto delle innovazioni sulla vita di tutti i
giorni e sul sistema economico è divenuto maggiormente percepibile.
Per molto tempo è stato affermato che esclusivamente attraverso la presenza di determinati
fattori e l’espletamento di certe attività era possibile attivare il processo innovativo. Solamente
l’attività di Ricerca e Sviluppo, l’attività brevettuale, la partecipazione di elevato capitale
umano e la presenza di grandi imprese nei settori avanzati potevano essere le vie attraverso le
quali perseguire questo scopo.
In Italia però questi fattori, riconosciuti generalmente come favorevoli all’attività innovativa,
non hanno avuto un ruolo cruciale poiché la loro consistenza è stata nettamente inferiore rispetto
a quella dei paesi avanzati per tutto il periodo che va dal dopoguerra fino ai giorni nostri. A
dispetto di questo l’Italia dal dopoguerra all’inizio degli anni Settanta ha fatto registrare tassi di
crescita molto alti, superiori a quelli degli altri paesi avanzati; tale dinamica, nonostante un
rallentamento evidente, è continuata fino all’inizio degli anni Novanta.
Alla luce di queste considerazioni è evidente per quale motivo, in molti degli studi economici
che hanno cercato di spiegare le ragioni del periodo di eccezionale crescita economica italiana,
sia stato escluso il ruolo dell’innovazione. Però si è lasciato insoluto il problema di determinare
quale fattore utilizzare per assolvere a tale compito.
Molti elementi differenti sono stati usati per spiegare la crescita economica italiana ma non ne
è emerso uno riconosciuto come preponderante. Questa indeterminatezza sulle cause del
fenomeno e l’apparente inadeguatezza dell’Italia ad ottenere prestazioni economiche elevate ha
portato gli studiosi a coniare per l’Italia il parallelismo con il volo del calabrone: secondo gli
scienziati, considerate le sue caratteristiche, esso non potrebbe volare, ma non sapendolo, lo fa;
così l’Italia, secondo gli economisti, non poteva avere performance così straordinarie valutate
le sue caratteristiche, ma comunque l’ha fatto.
5
Queste considerazioni sono legittime nell’alveo dell’economia neoclassica, la quale ha per
lungo tempo escluso l’innovazione dall’analisi economica, e oggi la considera parte integrante
in alcuni modelli formali comunque sempre rappresentata da una sola variabile, sia essa la
Ricerca e Sviluppo, il capitale umano oppure l’accumulazione di capitale. Quindi la teoria
neoclassica rimane inadeguata per analizzare le dinamiche innovative, ancora di più quelle
italiane.
Negli ultimi decenni si sono sviluppati campi di ricerca che hanno considerato il processo
innovativo sotto una diversa luce, non più caratterizzato da uno sviluppo lineare ma
contrassegnato da una straordinaria complessità e discontinuità. Per essere pienamente
compreso esso necessita quindi dello studio di molte variabili che esulano anche dal campo
dell’economia, così come variabili istituzionali, sociali, culturali e l’influenza delle decisioni
passate.
Utilizzando questa nuova interpretazione dell’innovazione come processo complesso e
procedendo con lo studio di molteplici variabili, lo scopo di questo lavoro è dimostrare come il
ruolo dell’innovazione sia stato fondamentale nello sviluppo economico italiano dal dopoguerra
alla fine degli anni Ottanta. Ciò è avvenuto senza che le attività generalmente associate ad alti
livelli di innovazione abbiano avuto in Italia uno sviluppo paragonabile a quello degli altri paesi
avanzati. L’Italia ha saputo sopperire a questa mancanza con lo sviluppo di dinamiche
innovative atipiche che hanno consentito grossi guadagni di efficienza trainando la crescita
economica italiana.
Il secondo obiettivo del presente lavoro è quello di delineare le caratteristiche di queste
dinamiche alternative che hanno permesso al “calabrone” Italia di volare.
Il terzo obiettivo è invece inquadrare il ruolo dell’innovazione nel periodo di declino che l’Italia
sta vivendo dall’inizio degli anni Novanta ai giorni nostri, mostrando quali possono essere le
ragioni che hanno portato ad un affievolimento della dinamica innovativa. Inoltre si vuole
delineare quali siano le prospettive future per l’innovazione e per lo sviluppo economico
italiano considerato il loro inscindibile legame.
Il lavoro è strutturato come segue. Nel primo capitolo viene riassunto il ruolo che il progresso
tecnico e l’innovazione hanno avuto nella teoria economica a partire dai classici. Viene
analizzato il pensiero che più si è concentrato sul ruolo dell’innovazione negli ultimi anni,
ovvero l’approccio evolutivo all’economia dell’innovazione di cui vengono descritte le origini
e i concetti chiave. Nell’ultima parte viene delineata una definizione di innovazione prima di
6
chiudere il capitolo con alcune considerazioni metodologiche sul presente lavoro.
Nel secondo capitolo viene compiuta un’analisi storico-economica dell’andamento dell’Italia
nel periodo che va dal dopoguerra alla fine degli anni Ottanta, dando rilievo anche alle variabili
sociali, culturali e istituzionali. Viene proposta una misurazione dell’attività innovativa a partire
dalla contabilità della crescita e viene stimato il contributo che essa ha fornito nello sviluppo
economico italiano. Vengono poi analizzate una serie di statistiche legate all’attività innovativa:
le spese in Ricerca e Sviluppo, l’attività brevettuale, l’importazione di tecnologia incorporata,
la bilancia tecnologica dei pagamenti, il capitale umano, le esportazioni. Di tutte queste
statistiche sono esaminati gli andamenti italiani per farne il confronto con gli altri paesi avanzati
e, dove possibile, un raffronto anche tra i diversi settori produttivi. Infine vengono esposti gli
esiti di questa analisi e viene tracciata una relazione tra lo sviluppo economico italiano e le
dinamiche innovative, delle quali vengono descritte le caratteristiche e i tratti peculiari.
Nel terzo capitolo viene inizialmente proposta un’analisi analoga a quella presente nel secondo
per il periodo che va dal 1990 ai giorni nostri. Si passa dall’analisi storica alla misurazione
dell’innovazione fino ad arrivare all’esame degli stessi dati analizzati per il periodo precedente
usando gli stessi criteri. In seguito vengono esaminati i risultati e viene delineata la relazione
tra l’innovazione e l’andamento dell’economia italiana prestando particolare attenzione a come
i cambiamenti connessi alla globalizzazione e alla terza rivoluzione industriale hanno
influenzato lo sviluppo economico. Infine, attingendo dagli elementi presentati in questo lavoro,
una volta posizionata l’Italia nel contesto globale e schematizzati i risultati delle dinamiche
innovative, vengono tracciate le azioni da intraprendere affinché si possa sperare in una ripresa
delle dinamiche innovative e conseguentemente nel risveglio dello sviluppo economico.
7
CAPITOLO I – L’INNOVAZIONE NELLA TEORIA ECONOMICA
Nel corso del capitolo viene proposto un breve resoconto sulla prospettiva con cui è stata
considerata l'innovazione nella teoria economica nel corso del tempo; viene descritta con
maggiore enfasi la teoria evolutiva dell'innovazione che, tra tutte, è quella che ne delinea un
ruolo centrale nel sistema economico.
Successivamente viene tracciata una definizione della stessa innovazione, illustrando quale
teoria sembra più adatta ad interpretare il fenomeno innovativo e quali dati, concetti e
metodologie possono essere più idonei per analizzarlo. Ovviamente gli strumenti considerati
più adeguati in questo frangente, saranno quelli utilizzati nel proseguo della trattazione.
1 Progresso tecnico e innovazione nel pensiero economico
Nei paragrafi che seguono viene tracciato un quadro relativo a come, il progresso tecnico prima
e il cambiamento tecnologico dopo sono stati analizzati dalla teoria economica a partire da
Smith fino ai giorni nostri. Agli albori della teoria economica il progresso tecnico era inteso
prevalentemente come la meccanizzazione del processo produttivo, vale a dire l'introduzione
di macchinari che sostituivano il lavoro umano.
Successivamente all’evolversi della teoria, il progresso tecnico è stato inteso in maniera più
ampia come il processo di creazione ed acquisizione di nuove conoscenze e capacità, attraverso
le quali è possibile incrementare beni e servizi producibili nel sistema economico, modificando
le modalità di produzione e potenziando l’efficienza produttiva. All’interno del progresso
tecnico è compreso il concetto di innovazione che rappresenta il momento di introduzione nel
sistema produttivo della conoscenza prodotta o dell’invenzione realizzata1.
1 Treccani online, Dizionario di Economia e Finanza, 2012,
http://www.treccani.it/enciclopedia/innovazione_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/.
8
L’uso del termine progresso tecnico viene gradualmente abbandonato poiché è inadatto a
descrivere la crescente complessità del sistema economico. Inoltre, le sempre maggiori critiche
da parte delle nuove teorie neo-schumpeteriane ed evolutive verso l’impianto di teorie
neoclassiche, le quali assumevano un ruolo marginale per il progresso tecnico, hanno favorito
la sostituzione di esso con il termine cambiamento tecnologico.
1.1 I classici e il progresso tecnico
Il pensiero economico classico è il primo che si può definire moderno poiché affonda le basi
della sua analisi in un’economia già capitalista ed in piena rivoluzione industriale.
Convenzionalmente si fa coincidere l'inizio del pensiero classico con Adam Smith che, assieme
a David Ricardo e Karl Marx, rappresentano i più illustri autori di tale filone. Il loro pensiero è
caratterizzato da una visione circolare del sistema economico, il quale ha la capacità di
autoriprodursi ed autoalimentarsi tramite i processi di produzione e consumo. La loro analisi si
concentra sulla formazione, distribuzione ed uso del "prodotto sociale" o reddito nazionale, che
viene distribuito tra proprietari terrieri, capitalisti e lavoratori (rispettivamente sotto forma di
rendite, profitti e salari)2. La formazione del sovrappiù, vale a dire il reddito nazionale decurtato
dalla parte di esso che serve per ripristinare le condizioni iniziali del processo produttivo, ed il
suo impiego sono considerati alla base della crescita economica. Il progresso tecnico in tale
struttura analitica è considerato unicamente il processo di meccanizzazione o incorporazione di
tecnologia nei beni capitali.
Smith definisce la "ricchezza delle nazioni" in termini affini a quello che noi oggi potremmo
chiamare PIL pro capite. Disaggregando tale misura, egli identifica due variabili da cui esso
dipende: la quota di popolazione impiegata nel lavoro e la produttività del lavoro. A sua volta
la produttività del lavoro dipende in maniera centrale dalla divisione del lavoro, la quale
produce nel sistema produttivo tre effetti molto importanti, come esemplificato nel celebre
riferimento alla fabbrica degli spilli. Per prima cosa, grazie alla divisione del lavoro, la capacità
del lavoratore aumenta poiché deve svolgere un compito più circoscritto; il secondo effetto
riguarda il risparmio di tempo che si ottiene nel non dover più passare da una mansione all'altra;
infine, il terzo effetto è quello di stimolare l'introduzione di progresso tecnico, dal momento
2 P. Fariselli, Economia dell’innovazione, Torino, Giappichelli Editore, 2014, pp. 9-12.
9
che è più facile realizzare macchine per svolgere una mansione semplice che per svolgere varie
mansioni complesse3. Comunque Smith considera la relazione tra progresso tecnico e divisione
del lavoro anche in maniera inversa. Difatti sia il progresso tecnico, che consente l'introduzione
di macchinari più efficienti, sia l'accumulazione di capitale, che è alla base degli investimenti
in capitale fisico, influenzano positivamente la divisione del lavoro. Conseguentemente essi
favoriscono l’incremento della produttività e consentono di realizzare rendimenti di scala
crescenti, favorendo così la crescita del sistema economico.
Si può quindi affermare che Smith considera il progresso tecnico come una variabile endogena
che favorisce la crescita economica, ciò nonostante il fatto che egli subordina il realizzarsi di
tutte le relazioni viste sopra alla crescita del mercato di sbocco, poiché senza tale espansione
verrebbe a mancare la domanda per i nuovi beni prodotti e, di conseguenza, sarebbe inutile
aumentare la capacità produttiva e promuovere la crescita. È proprio dal fatto che egli considera
lo sviluppo di nuovi mercati come prerequisito fondamentale per lo sviluppo della “Ricchezza
delle Nazioni”, che derivano le sue teorie liberiste sul commercio internazionale4.
Negli anni successivi, David Ricardo riprende l’analisi del progresso tecnico elaborandone due
visioni contrapposte. La prima, positiva, è legata al fatto che il progresso tecnico rappresenta
una spinta per la crescita economica, avendo la funzione di consentire il superamento di un forte
vincolo per lo sviluppo del sistema economico rappresentato dalla scarsità di terra e di risorse
naturali. Ciò avviene perché il progresso tecnico migliora l'efficienza dell’utilizzo di tali fattori,
contrastando in tal modo i rendimenti decrescenti intrinseci nelle risorse naturali e nella terra.
La seconda considerazione, di matrice negativa, compare nelle opere risalenti a pochi anni
prima della sua morte5. Ricardo abbandona la teoria della compensazione, che aveva sostenuto
fino ad allora in perfetta sintonia con Smith 6 . Egli afferma che il progresso tecnico,
comportando l'introduzione di nuovi macchinari sostitutivi del lavoro umano, ha l'effetto di far
diminuire i posti di lavoro, generando disoccupazione e danneggiando i lavoratori. Questo
3 A. Roncaglia, La ricchezza delle idee: storia del pensiero economico, Roma, GLF editori Laterza, 2003, pp. 139-
148. 4 Comunque è da considerare che Smith nelle sue opere non tratta in maniera centrale il progresso tecnico, ma lo
fa in via secondaria quando analizza la produttività e gli investimenti. Quindi, pur essendo importante, il
progresso tecnico non è alla base della sua analisi del sistema economico. 5 A. Roncaglia, La ricchezza delle idee, cit., pp. 218-221. 6 La teoria della compensazione afferma che gli effetti negativi sull'occupazione dovuti all'introduzione di nuove
macchine sono compensati da due fattori: dall'aumento di forza lavoro necessaria a produrre le nuove macchine
e dall'aumento della domanda conseguente dalla riduzione dei prezzi, dovuta anch'essa al cambiamento
tecnologico.
10
dibattito sulla disoccupazione causata dalla tecnologia è continuato nel tempo, ed ancora oggi
la discussione tra gli studiosi non è giunta ad una soluzione condivisa.
L’ultimo grande pensatore annoverato tra i classici è Karl Marx. Egli considera il progresso
tecnico come endogeno al sistema economico e dinamico, associandolo, come gli altri, alla
meccanizzazione del lavoro. Egli riconosce il ruolo positivo che svolge, assieme
all'accumulazione di capitale, nel processo di formazione della ricchezza ma, nonostante questo,
lo considera in maniera molto più negativa rispetto a Smith. Difatti il progresso tecnico nella
sua visione è un processo dialettico sociale che riflette i conflitti tra i vari gruppi sociali. Nel
caso specifico è visto come lo strumento con il quale i capitalisti contrastano i lavoratori e le
loro pretese salariali, poiché l'introduzione del progresso tecnico consentirebbe ai capitalisti,
tramite miglioramenti di efficienza e minore necessità del fattore lavoro, di realizzare maggiori
profitti e pagare meno lavoratori. Per questo, in sintonia con Ricardo, Marx ritiene il progresso
tecnico responsabile di una crescente disoccupazione tecnologica7.
Quindi i pensatori classici, nonostante non analizzino il progresso tecnico come elemento
centrale della loro teoria economica, ne riconoscono il suo carattere endogeno al sistema
economico e la sua correlazione positiva con la crescita. Con la rivoluzione marginalista e
l'affermarsi della teoria neoclassica queste considerazioni di endogeneità del progresso tecnico
e della sua correlazione positiva con la crescita saranno completamente stravolte. Solamente a
partire da Schumpeter esse torneranno al centro dell'analisi economica.
1.2 Il pensiero Neoclassico e il progresso tecnico esogeno
A partire dagli anni Settanta dell'Ottocento la scienza economica subisce una profonda
trasformazione susseguente la rivoluzione marginalista. La visione dei classici di un sistema
economico circolare che si autoalimenta viene abbandonata, sostituita da una visione che si
concentra sull'allocazione efficiente di risorse scarse e che utilizza come concetti fondanti
quello di equilibrio statico e quello analitico di utilità marginale8.
Progressivamente si assiste ad una profonda trasformazione della scienza economica, la quale
7 A. Roncaglia, La ricchezza delle idee, cit., pp. 271-276. 8 Ivi, pp. 296-300; I promotori di tale rivoluzione sono identificati in Menger, Jevons e Walras, questo nonostante
il fatto che le loro opere e le loro analisi siano abbastanza differenti. Ma essi costruiscono molti dei concetti
analitici che saranno alla base del filone neoclassico.
11
abbandona le sue origini derivanti dalla filosofia morale ed assume il carattere di scienza
formalizzata, sul modello della fisica e della matematica. Si iniziano a misurare empiricamente
i fenomeni dell'economia, costruendo modelli matematici con il compito di spiegare quali sono
le variabili rilevanti del sistema economico; comunque da tale analisi viene completamente
trascurata ogni possibile influenza del contesto sociale.9
Dalla rivoluzione marginalista si è sviluppato il filone neoclassico che, in breve tempo, è
diventato maggioritario tra gli accademici e, soprattutto dal secondo dopoguerra, ha
monopolizzato la disciplina economica. Esso si basa su assunzioni restrittive della realtà che
consentono di modellizzare analiticamente l'economia, considerando solamente poche variabili
come importanti e necessarie per spiegare il funzionamento del sistema.
Il prodotto, l'output del sistema economico, viene ora definito dalla funzione di produzione, che
utilizza due soli fattori, il lavoro (L) e il capitale (K), con una produttività marginale positiva e
decrescente. La trasformazione di tali fattori in output avviene dunque per mezzo della funzione
di produzione all’interno della quale opera la tecnologia, la quale è prodotta al di fuori del
sistema economico ma è perfettamente conoscibile e accessibile da parte delle imprese10. Viene
assunto che gli agenti economici, in questo caso le imprese, abbiano perfetta informazione sulle
tecnologie esistenti e sul loro rendimento futuro. Per questa ragione esse riescono sempre a
compiere la scelta ottimale, adottando quella tecnologia che consente loro di avere più output a
parità di input11.
Quindi il produttore, ma le stesse considerazioni valgono anche per il consumatore, agisce in
maniera perfettamente razionale, poiché ha in ogni momento a disposizione una perfetta
informazione che gli consente di realizzare sempre la scelta ottimale. Il fenomeno collettivo
della produzione e del consumo è rappresentato semplicemente dalla sommatoria di tutti i
comportamenti degli agenti, che però sono considerati identici. Quindi dal comportamento di
un singolo agente razionale, che ha il solo scopo di massimizzare il profitto, o nel caso del
consumatore l'utilità, si può desumere il comportamento di tutto il sistema economico12.
9 P. Fariselli, Economia dell’innovazione, cit., pp.12-14. 10 Questa visione è facilmente criticabile poiché la funzione di produzione rappresenterebbe quindi una sorta di
scatola nera dove non si sa come la tecnologia si combina con gli altri fattori. Inoltre la tecnologia entra nel
sistema economico come fosse una “manna dal cielo” che da un giorno all'altro è disponibile per tutti. Si capisce
come davanti alla grande ripresa dell'attività innovativa avutasi con le tecnologie della comunicazione tale
visione non era più facilmente sostenibile. 11 P. Fariselli, Economia dell’innovazione, cit., pp. 13-14. 12 Questo rappresenta il cosiddetto individualismo metodologico, che costituisce una delle assunzioni più criticate
della visione neoclassica dell’economia, poiché non riesce a descrivere la situazione che si osserva tutti i giorni
12
Perciò nell’analisi neoclassica il progresso tecnico non è il risultato di un azione ponderata
dell'agente economico ma proviene dall'esterno, tramite flussi informativi perfettamente
conoscibili da tutti gli agenti. Essendo esogeno al sistema economico e non potendo scaturire
da comportamenti volontari degli agenti, il progresso tecnico non rientra più nel dominio della
scienza economica, che infatti ne abbandona l’analisi riservandola ad altri campi della scienza.
1.3 La Contabilità della Crescita
La contabilità della crescita (Growth Accounting) si è sviluppata a partire dal lavoro di Robert
Solow che ha elaborato un modello per indagare il rapporto causale tra progresso tecnico e
crescita economica13 . Allo stesso modo dei neoclassici egli considera il progresso tecnico
esogeno al sistema economico, ma variabile in funzione del tempo (comunque indipendente dai
fattori lavoro e capitale). Questa assunzione serve per consentirne una misurazione, difatti
Solow considera il progresso tecnico alla stregua di un fattore che ha sulla funzione di
produzione lo stesso effetto di un aumento di capitale o di lavoro, senza che però questo
modifichi il loro saggio marginale di sostituzione. Solow ammette che il progresso tecnico
modifichi gli isoquanti verso l'origine degli assi, vale a dire che, grazie al progresso tecnico, a
parità di input si può produrre più output, ma asserisce la sua completa neutralità e rendimenti
di scala costanti14.
Partendo da questo modello, si è arrivati ad una metodologia che consente di misurare il
progresso tecnico in maniera residuale. Visto che non si riusciva a trovare una corrispondenza
tra l'incremento dei fattori capitale e lavoro e la crescita economica effettivamente registrata, si
è considerato lo scarto tra queste misure, che poi risulta la parte più grande, attribuibile al
progresso tecnico. Difatti, già con Solow, i risultati empirici sulla crescita americana indicavano
che l'aumento dei fattori lavoro e capitale era responsabile di solo un ottavo della crescita,
mentre i restanti sette ottavi rimanevano non spiegati15.
Tale scarto tra incremento dei fattori e incremento dell'output viene ribattezzato Total Factor
nel mondo reale, dove l’eterogeneità degli attori è facilmente percepibile.
13 R. Solow, Technical Change and the Aggregate Production Function, in The Review of Economics and Statistics,
Vol. 39 no. 3, 1957, pp. 312-320. 14 Si assume che il progresso tecnico modifichi nella stessa misura la produttività marginale del fattore lavoro e
del fattore capitale. 15 R. Solow, Technical Change and the Aggregate Production Function, cit., p. 320.
13
Productivity (TFP). La TFP oppure la misura della nostra ignoranza, come la definiva
Abramovitz16, viene considerata dagli studiosi di contabilità della crescita per la maggior parte
identificabile come l’effetto che il progresso tecnico esercita sul sistema economico.
Avendo osservato che nelle successive misurazioni l'ampiezza della nostra ignoranza, ovvero
la TFP, continuava ad essere la parte preponderante, gli studi di contabilità della crescita hanno
cercato di raffinarsi allo scopo di diminuire l’ampiezza del residuo. Hanno fatto ciò
introducendo nella loro analisi differenziazioni qualitative dei fattori come, ad esempio,
differenti livelli di qualità dei lavoratori dovuti a diverse dotazioni di capitale umano, o
introducendo nell'analisi altre variabili che possono migliorare la produttività a parità di capitale
e lavoro. Recentemente le due variabili che con più assiduità sono state inserite in tale analisi
sono gli investimenti in R&S e ICT. Nonostante questi raffinamenti, la parte residuale non
spiegata della crescita rimane elevata, facendo pensare che il ruolo del progresso tecnico sia
effettivamente cruciale.
1.4 Deviazioni dal pensiero Neoclassico
Considerata l'ampiezza dell'effetto del progresso tecnico sullo sviluppo economico rilevata
dalla contabilità della crescita, all'interno degli stessi neoclassici sono stati compiuti numerosi
tentativi di ricondurre il progresso tecnico all'interno dell’analisi economica. Rendendolo
endogeno o quantomeno dipendente da fattori interni al sistema economico, si è cercato di
accordare maggiormente la teoria con il mondo reale.
Tra questi tentativi, Arrow sviluppa una teoria secondo la quale la conoscenza e i processi di
apprendimento rappresentano fattori endogeni di sviluppo 17 . Egli assume che l'invenzione
tecnica sia identificabile come produzione di conoscenza, che però non rappresenta un normale
bene economico, date le sue caratteristiche di appropriabilità, indivisibilità e incertezza.
Date queste caratteristiche intrinseche alla conoscenza, è impossibile creare un mercato dove
possa essere scambiata secondo le leggi dell’offerta e della domanda. Conseguentemente, per
16 M. Abramovitz, Resource and Output Trends in the United States Since 1870, in American Economic Review
Vol. 46, no.1, 1956, pp. 11-12. 17 K. Arrow, Economic welfare and the allocation of resources for invention in R.R. Nelson (a cura di), The Rate
and Direction of the Inventive Activity: Economic and Social Factors, Princeton, Princeton University Press,
1962, pp. 609-629.
14
raggiungere un livello di Ricerca e Sviluppo (R&S) che produca conoscenza in quantità
ottimale per il sistema economico, è necessario che tale attività sia finanziata pubblicamente.
Un altro apporto di Arrrow, che deriva dalle caratteristiche della conoscenza, è la costruzione,
basata sul modello neoclassico, di una teoria dello sviluppo endogeno basato sul learning by
doing. Egli afferma che si hanno aumenti di produttività anche in assenza di investimenti in
nuove tecnologie ed a parità di lavoro, poiché con il tempo si acquisisce maggiore destrezza e
conoscenza delle tecnologie/macchinari precedentemente acquistati, con il risultato di un
miglioramento dell'efficienza produttiva. Secondo Arrow l'esperienza cresce in funzione del
capitale fisso accumulato, che quindi risulta il fattore causale capace di spiegare il livello di
sviluppo economico. L’analisi di Arrow risulta importante poiché rappresenta la prima
trattazione sistematica sul ruolo e sulle caratteristiche della conoscenza.
Sempre all'interno dei neoclassici, da metà anni Ottanta, si è cercato di spiegare la crescita
economica come il risultato di processi interni e deliberati al sistema produttivo. A partire da
Lucas e Romer sono stati costruiti i primi modelli di crescita endogena che spiegano lo sviluppo
economico come il risultato del livello di accumulazione del capitale umano raggiunto18. In
accordo con questa teoria, tutti gli Stati avrebbero le stesse possibilità di sviluppo che
dipendono in via esclusiva dal livello di investimenti in capitale umano.
Esterno al filone neoclassico è il lavoro di Kaldor, il quale ritiene la struttura delle irrealistiche
assunzioni di base postulate dai neoclassici stessi come il maggiore ostacolo che si frappone
all'obiettivo di far diventare l'economia una scienza19. Kaldor deve la sua fama alla sua critica
verso il concetto di equilibrio aggregato e verso le assunzioni troppo restrittive dei neoclassici.
Ma, oltre a questo, egli ha avuto un ruolo importante nell'ipotizzare che il progresso tecnico sia
in parte endogeno. Infatti, considerando il fatto che esso è incorporato nei beni capitali, risulta
che il suo livello è deliberatamente aumentabile tramite investimenti; in questa visione
l’aumento della domanda agisce da importante fattore di stimolo.
18 R. E. Lucas Jr., On the mechanics of economic development, in Journal of Monetary Economics, Vol. 22, no. 1,
1988, pp. 3-42; P. M. Romer, Endogenous technological change, in Journal of Political Economy, Vol. 98, no.
5, 1990, pp. S71-S102. 19 N. Kaldor, The irrelevance of equilibrium economics, in The Economic Journal, Vol. 82, no. 328, 1972, p. 1237.
15
1.5 La flessibilità del filone Mainstream
Samuelson definisce come filone mainstream il complesso di teorie economiche che viene
riconosciuto preponderante nell'insegnamento universitario e nell’ambito accademico in un
dato momento. Egli riconosce la sintesi neoclassica-keynesiana come quella preponderante20.
Allo stato attuale sembrerebbe invece che il filone mainstream abbia deviato dall'approccio
neoclassico, incorporando nella sua analisi alcune variabili istituzionali e dell'innovazione, così
da rendere la loro modellizzazione più aderente alla realtà. Nonostante questa apertura, gli
appartenenti a tale filone rimangono sempre troppo legati a formalizzazioni matematiche di una
certa rigidità.
Ad oggi non è facile tracciare un netto confine per definire chi è mainstream e quali siano
effettivamente le basi teoriche su cui concordano gli appartenenti a tale filone. Difatti il dibattito
sull'effettiva differenziazione dei mainstream con i neoclassici è ancora aperto. La risposta da
dare è positiva considerato l'ecletticismo d'analisi dei mainstream e l’uso di un corpo di
metodologie modellistiche flessibile, anche se il rigore formale continua a prevalere sulla
significatività delle investigazioni21.
Se l’eclettismo e la flessibilità prevarranno sulla formalizzazione, facendo aprire il filone
mainstream verso nuovi campi di ricerca, allora sarà possibile per esso unire gli sforzi con
alcune teorie eterodosse sviluppatesi negli ultimi anni a partire dalle critiche al modello
neoclassico o da spunti dati da altre scienze sociali o matematiche22. Da questa unione potrebbe
nascere il nuovo paradigma dominante della scienza economica23.
Comunque allo stato attuale, nonostante alcuni miglioramenti e i possibili sviluppi futuri, il
20 P.A. Samuelson, Economia, Bologna, Zanichelli, 1983, pp. 753-757. 21 J.B. Davis, The turn in economics: neoclassical dominance to mainstream pluralism?, in Journal of Institutional
Economics, Vol. 2, no.1, 2006, pp. 1-20. 22 J.B. Davis, The turn in economics, cit., pp. 17-18; B. Maurseth, Recent Advances in Growth Theory. A
Comparison of Neoclassical and Evolutionary Perspectives, Working Paper no. 615, Norwegian Institute of
International Affairs, 2001, pp. 19-25. Per Davis questo è quello che accadrà; ma è da notare come per altri, come Maurseth, tale possibilità è da escludere fermamente poiché approccio neoclassico ed evoluzionista non
solo non rappresentano paradigmi differenti nel senso di Kuhn, ma neanche programmi di ricerca in
competizione tra loro nel senso di Lakhatos. Quindi sarebbero solo due rami dello stesso filone di ricerca. 23 D. Colander, The death of neoclassical economics, in Journal of the History of Economic Thought, Vol. 22, no.
2, 2000, pp. 140-142; J.B. Davis, The turn in economics, cit., pp. 17-18; Molti prevedono un soppiantamento
della teoria neoclassica dominante a favore di un approccio pluralista mainstream, che sarà contraddistinto da
una pluralità di approcci interconnessi, i quali potrebbero trovare una sintesi comune che porterà verso un
nuovo paradigma nella scienza economica oppure uno di tali approcci potrebbe risultare dominante sugli altri
e rappresentare esso stesso la base verso un nuovo paradigma della scienza economica.
16
filone mainstream continua a non essere idoneo a svolgere un’analisi accurata del processo
innovativo, essendo ancora troppo legato a modelli formali di origine neoclassica e ad
assunzioni troppo restrittive che non consentono di analizzare la complessità della realtà.
2 Economia evolutiva dell'Innovazione
Tra gli approcci economici che hanno tratto ispirazione da altre scienze sociali e da altri autori
esterni ai neoclassici, quello che prende in maggiore considerazione il processo innovativo è
sicuramente l'approccio evolutivo all'economia dell'innovazione. Difatti esso pone
l'innovazione e le sue determinanti al centro della sua analisi sullo sviluppo del sistema
economico. Tale approccio ha cominciato a formarsi agli albori dello sviluppo delle tecnologie
della comunicazione e dell’informazione, per merito della loro pervasività nell'economia si è
tornati a considerare il fenomeno innovativo sotto una diversa luce. Infatti adesso non solo si
ritiene l’innovazione come fattore endogeno al sistema economico, ma addirittura la si usa quale
elemento centrale per spiegare l'andamento della crescita economica.
Il lavoro di Richard R. Nelson e Sidney G. Winter del 1982 “An Evolutionary Theory of
Economic change” può essere considerato l'atto fondante di tale approccio, anche se molte
considerazioni o studi verso questa struttura interpretativa erano già stati fatti. L’approccio
evoluzionista all'economia dell'innovazione considera Schumpeter come padre fondatore,
riconoscendo come fondamentali anche altri contributi provenienti dalle scienze sociali, quali
il pensiero evolutivo della biologia e le teorie comportamentiste di Simon.
Nei successivi paragrafi vengono analizzati gli spunti che l’opera schumpeteriana, la biologia
e le teorie comportamentiste hanno fornito all'analisi dell'innovazione, in seguito vengono
delineate le basi dell'approccio evolutivo all'economia dell'innovazione.
17
2.1 Il pensiero di Schumpeter
Schumpeter può essere considerato l'autore della più sistematica analisi dell'innovazione
precedente alla fondazione dell'economia dell'innovazione, la quale lo ritiene a buon diritto il
proprio antenato più illustre. Schumpeter abbandona la visione neoclassica del progresso
tecnico esogeno al sistema economico. Infatti, le invenzioni e il cambiamento tecnologico
vengono prodotte all'esterno del sistema economico, ma sono portate al suo interno grazie
all'innovazione introdotta dall'imprenditore spinto dalla volontà di sopravvivere nella
competizione di mercato ed ottenere extra profitti.
L'equilibrio stazionario walrasiano è solo il punto di partenza dell'analisi schumpeteriana,
poiché una volta introdotta l'innovazione tecnologica il sistema capitalistico si trova in
condizioni di disequilibrio, dato che l'innovatore riesce ad ottenere extra profitti. Tali extra
profitti scompaiono con il passare del tempo grazie alla diffusione graduale dell'innovazione,
però la società continua a godere del benessere aggiuntivo derivante dall'innovazione, visto che
la maggiore efficienza del sistema economico, ottenuta grazie all'introduzione di essa, permane.
Grazie alla diffusione dell’innovazione ed ai meccanismi competitivi, il sistema tenderà
nuovamente a stabilizzarsi, fino a quando non sarà introdotta una nuova innovazione. Il sistema
economico si sviluppa quindi “saltando” da un disequilibrio all'altro, modificandosi
qualitativamente. Questo meccanismo, che è il motore di sviluppo della crescita e del
capitalismo, è identificato come distruzione creatrice: distruzione di ricchezza esistente, anche
nel senso di prodotti e processi, per creare nuova ricchezza o nuovi prodotti e processi più
efficienti.
Questa analisi del sistema economico rappresenta la prima fase del pensiero schumpeteriano,
dove la concorrenza perfetta è la condizione base per il dispiegarsi della distruzione creatrice,
visto che è proprio il meccanismo concorrenziale che consente al potere monopolistico
temporaneo dell'impresa innovatrice di essere riassorbito grazie alla diffusione
dell'innovazione24. L'altra condizione ottimale per il dispiegarsi del fenomeno innovativo è la
presenza sul mercato di molte imprese, con un ampio processo di ingresso da parte di imprese
24 La prima fase del suo pensiero coincide con il pensiero contenuto nel libro Teoria dello Sviluppo Economico
del 1912; la seconda fase può dirsi perfettamente descritta nella sua opera Capitalismo, Socialismo e
Democrazia del 1942.
18
innovative e di uscita da parte di impresi inefficienti25.
Nella seconda fase del suo pensiero Schumpeter rovescia questa visione, ritenendo che sia il
monopolio la forma di mercato più indicata per il processo innovativo. Tale affermazione è
basata sul fatto che solo le grandi imprese possiedono le risorse necessarie per effettuare gli
ingenti investimenti in R&S e in nuovi impianti allo scopo di sviluppare la tecnologia e le
invenzioni, le quali porteranno all'introduzione di innovazioni ed al loro sviluppo26.
Schumpeter matura questo cambiamento nel suo pensiero anche per il fatto che ha la possibilità
di osservare dall’interno, nel corso della sua vita, due sistemi economici differenti. Per la prima
fase egli aveva tratto le sue conclusioni dalle osservazioni sull'economia inglese, mentre la
seconda fase è figlia del suo trasferimento in USA, dove le grandi imprese governavano il
mercato. Comunque c’è complementarietà tra le due fasi descritte: esse potrebbero essere
considerate come diverse fasi dello sviluppo di un’industria27.
Schumpeter, rifacendosi alle teorie dei cicli economici, suppone che essi esistano effettivamente
all’interno del sistema economico e siano originati dalla discontinuità prodotta dalle
innovazioni tecnologiche. Egli suppone che esista un modello ad onda in grado di spiegare sia
l’introduzione delle innovazioni che la crescita.
Un’altra considerazione di Schumpeter, ritenuta valida dall’Economia dell’Innovazione,
riguarda la metodologia di ricerca, difatti egli è fautore di un liberalismo metodologico che
consenta di adattare le ipotesi del metodo a seconda degli scopi, in modo da ottenere una certa
flessibilità, poiché egli nega assolutamente che possano esistere leggi esatte in economia28 .
Inoltre Schumpeter è fra i primi a proporre una classificazione delle innovazioni secondo la loro
tipologia distinguendole tra innovazioni di prodotto, di processo, organizzative, di fonti di
approvvigionamento o di mercati. Tale classificazione è ritenuta sempre valida ed è usata come
base per numerose altre definizioni.
Dal suo lavoro emerge chiaramente che la dinamica innovativa rappresenta un elemento
centrale ed irrinunciabile per condurre un’analisi del sistema economico.
25 J.A. Schumpeter, Teoria dello sviluppo economico, Milano, Firenze, Sansoni, 1971, (edizione originale 1912),
pp. 255-298. 26 J.A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, Milano, ETAS, 2001, (edizione originale 1942), pp.
87-105. 27 R.R Nelson, S.G.Winter, Evolutionary theorizing in economics, in The Journal of Economic Perspectives, Vol.
16, no. 2, 2002, pp. 33-37. 28 A. Roncaglia, La ricchezza delle idee, cit., pp. 462-464.
19
2.2 Approccio evolutivo
È alla fine degli anni Settanta che si va a delineare un approccio evolutivo del cambiamento
tecnologico soprattutto grazie al lavoro di vari studiosi come Nelson, Winter, Dosi, Metcalfe,
Malerba, Saviotti.
L'approccio evolutivo all'economia trae spunto dal suo omonimo in biologia, sviluppato a
partire dal lavoro di Darwin. L'affinità risulta con maggiore chiarezza quando si va a
considerare la visione base del funzionamento del sistema economico utilizzata nell'analisi
degli evoluzionisti economici: la diversità con cui l'innovazione incide sui diversi componenti
eterogenei di una popolazione e ne decreta la sopravvivenza o l'estinzione.
Secondo Dosi sia in biologia che nelle scienze sociali si possono delineare tre principi generali
comuni concernenti il concetto di evoluzione. Il primo è l'eterogeneità e la selezione
nell'ambiente/sistema che si vuole analizzare. Infatti, in entrambe le discipline, si suppone che
siano presenti numerose entità eterogenee, con caratteristiche differenti, che interagiscono tra
loro tramite svariati meccanismi. Questi meccanismi e le caratteristiche peculiari di ogni entità
determinano coloro che all’interno del sistema hanno più possibilità di sopravvivere e riprodursi.
A livello economico il primo meccanismo di interazione identificabile, ma che al contempo è
anche un meccanismo di selezione, è il mercato. Esso influenza le opportunità ed i vincoli alla
crescita, alla profittabilità e alla probabilità di sopravvivere delle imprese. Tale meccanismo di
selezione, contrariamente alle concezioni darwiniane, non ha il risultato di far sopravvivere il
migliore, ma colui che sa adattarsi meglio o sa sfruttare meglio determinate caratteristiche o
situazioni. Lo stesso principio vale anche nella moderna biologia, dove la nozione di migliore
e di peggiore sono contingenti agli specifici meccanismi di selezione, alla loro storia e alla
distribuzione delle caratteristiche degli agenti29.
Il secondo concetto comune riguarda il fatto che i sistemi in continua evoluzione incorporano
meccanismi che inducono l'emergere continuo di novità. Nel sistema economico questo è
rappresentato dalla persistente ed incessante introduzione di innovazioni, mentre in biologia
questo riguarda l'emergere continuo di mutazioni a livello genetico, con conseguenti
cambiamenti a livello delle caratteristiche osservabili e a livello di popolazioni che
29 G. Dosi, L'interpretazione evolutiva delle dinamiche socio economiche, LEM Working Paper Series, Laboratory
of Economics and Management Sant’Anna School of Advanced Studies, 2004, pp. 2-13.
20
interagiscono tra loro. In socio economia invece le mutazioni avvengono a livello tecnologico,
organizzativo ed istituzionale.
L'ultimo concetto comune riguarda la metodologia e il fatto che entrambi rifiutano
interpretazioni di tipo panglossiano30, vale a dire accettare il fatto che se qualcosa esiste allora
esso è ottimo, oppure di tipo finalistico, che fanno derivare il motivo dell'esistenza di un
soggetto dalla funzione che esso svolge. Al contrario gli evoluzionisti, sia in biologia che in
economia, prediligono spiegazioni incentrate sulla dinamica del tempo che ha condotto
all'emergere di un fenomeno particolare o di una particolare entità. Da queste considerazioni
risulta che l'evoluzionismo in campo socio economico è altamente complementare ad
interpretazioni che enfatizzano il ruolo della storia e la dipendenza dal sentiero31.
2.3 La teoria comportamentista
La teoria comportamentista nasce a partire dagli studi di Herbert Simon sul comportamento
delle organizzazioni, che gli sono valsi il premio Nobel per l'economia nel 1978.
In contrapposizione alle affermazioni neoclassiche l'impresa viene considerata come un
complesso di individui e centri di potere interagenti, vale a dire come un'organizzazione che
risulta necessaria poiché l'impresa opera in condizioni di incertezza e complessità informativa.
L'impresa non può essere considerata come entità individuale che opera in condizioni di
informazione perfetta, ma deve essere esaminata come un sistema organizzativo con diversi
centri di potere che è necessario coordinare e controllare. Come nella visione evoluzionistica il
fine di un’impresa è rappresentato dalla sua sopravvivenza, che viene garantita dal
conseguimento di un profitto sufficiente allo scopo; questa concezione è notevolmente diversa
da quella neoclassica, dove l'impresa massimizza il profitto in ogni dato momento.
Per poter conseguire quella razionalità perfetta postulata dai neoclassici l'impresa, nel suo
processo decisionale, dovrebbe essere in grado di svolgere tre azioni. Per prima cosa dovrebbe
essere in grado di poter identificare tutte le possibili alternative riguardanti ogni singola
decisione da prendere. Successivamente dovrebbe poter determinare tutte le conseguenze, ed i
relativi rendimenti, di ogni eventuale alternativa. Alla fine dovrebbe riuscire a comparare tutte
30 Da Pangloss, il personaggio leibniziano del Candide di Voltaire che sosteneva di vivere nei «migliore dei mondi
possibili. 31 G. Dosi, L'interpretazione evolutiva delle dinamiche socio economiche, cit., pp. 2-13.
21
le possibili alternative riuscendo a scegliere quella che le consenta di massimizzare il profitto.
Secondo i comportamentisti, in accordo con l'evidenza empirica, l'impresa non è in grado di
svolgere tutti questi compiti alla perfezione, visto che incontra dei limiti di natura conoscitiva
dovuti al fatto che essa agisce in un ambiente caratterizzato da informazione imperfetta e
incertezza. Inoltre l'impresa ha evidenti limiti computazionali poiché, anche se avesse tutte le
informazioni, non sarebbe in grado di elaborarle e determinare tutte le conseguenze ed i
rendimenti di ogni possibile azione alternativa.
Quindi l'impresa, operando in un ambiente dove regna l'incertezza e che muta incessantemente,
e date le sue limitate capacità computazionali, agisce sulla base di una razionalità limitata o
procedurale: essa prende decisioni tramite regole di comportamento coerenti con l'esperienza
passata. Tramite tentativi e sulla base delle reazioni dell'ambiente e del sistema interno
all'impresa si cerca di elaborare una decisione che faccia ottenere dei risultati soddisfacenti. Si
vengono così a costituire le routine dell'impresa che servono a prendere decisioni accettabili in
un ambiente dominato dall’incertezza. Quindi la razionalità dell'impresa permette di avere
risultati soddisfacenti per la sopravvivenza, non ottimizzanti.
3 Fondamenti di economia dell'innovazione
La scuola evolutiva, nonostante conservi alcune somiglianze con il filone mainstream, se ne
distanzia fortemente, soprattutto per l'avversione verso i modelli formali seppur allargati a
variabili non di mercato. Per gli evoluzionisti è difficile rinunciare alla ricchezza qualitativa ed
alla specificità dei fenomeni relativi al cambiamento tecnologico. Infatti essi abbandonano i
modelli formalizzati con rigide assunzioni e si affidano all'analisi storica, ai casi studio e a
modelli che si basano su di un’analisi non statica. Le dinamiche economiche, sociali, storiche,
organizzative, culturali e cognitive dell'innovazione, intesa come un processo per mezzo del
quale si vuole realizzare profitto in condizioni di incertezza e di razionalità limitata, diventano
quindi centrali nell'analisi dell'innovazione. La massimizzazione del profitto è qui vista come
una meta a cui tendere in un processo dinamico, non una condizione statica che vale in ogni
momento. Molto importanti sono i processi di selezione, diffusione e l'instabilità32.
Traendo linfa dai tre pensieri descritti nei paragrafi precedenti si è sviluppato l'approccio
32 P. Fariselli, Economia dell’innovazione, cit., pp. 38-40.
22
evolutivo all'economia dell'innovazione. L'obiettivo di questo filone teorico è quello di
analizzare la relazione tra il cambiamento tecnologico e il cambiamento economico, sia a livello
microeconomico che a livello macroeconomico. L'innovazione risulta l'elemento chiave per
comprendere come il cambiamento tecnologico agisce sul sistema economico, poiché è con
essa che il cambiamento tecnologico viene introdotto nel sistema economico. Fatte queste
considerazioni è facile desumere come per tali studiosi l'innovazione risulta non solo come
endogena nell’analisi economica, ma è anche il fattore determinante per spiegare l’andamento
della crescita del sistema economico.
Nel seguito della trattazione verranno analizzati i concetti consolidati alla base dell'economia
dell'innovazione, in modo da renderne più chiara la struttura e le finalità.
3.1 L’ambiente e gli agenti
L'approccio evolutivo vuole avere una visione degli agenti e dell'ambiente in cui essi operano
il più possibile aderente alla realtà. Per conseguire tale fine considera gli agenti, in questo caso
le imprese, come eterogenee e dotate ognuna di proprie peculiarità, come possono essere diversi
i livelli di efficienza, di competenza e di conoscenza.
Viene abbandonata la perfetta razionalità postulata dai neoclassici che dona agli agenti/imprese
il potere di prevedere gli esiti futuri di tutte le azioni intraprendibili, rendendo
conseguentemente possibile realizzare sempre la scelta ottimale, ovvero quella che fa ottenere
il profitto maggiore33. Sempre in contrapposizione con i neoclassici, si nega che le imprese
dispongano di informazioni complete ed accessibili rispetto alle tecnologie esistenti e ai loro
rendimenti. Al contrario, il processo di acquisizione di tali informazioni è fortemente
dispendioso in termini di tempo, denaro e risorse. Come conseguenza le imprese si trovano ad
affrontare un’elevata incertezza sia sulle tecnologie presenti sia sugli sviluppi futuri.
Sulla scia dei comportamentisti la razionalità viene considerata limitata/procedurale. Il
comportamento degli agenti/imprese non deriva più da un calcolo razionale perfetto, ma bensì
deriva da schemi comportamentali a media-alta invarianza che prendono la forma di routine.
Esse sono plasmate dalla specifica storia passata di ciascun impresa, dalle sue conoscenze
accumulate, dai suoi valori e dalle sue credenze. Essendo tali schemi comportamentali specifici
33 R.R Nelson, S.G.Winter, Evolutionary theorizing in economics, cit., pp. 29-32.
23
per ogni agente, le decisioni e la loro ottimizzazione parziale saranno diverse per ogni impresa
e, quindi, anche la performance prodotta sul mercato sarà molto differente34. Queste assunzioni
sono evidentemente molto coerenti con quello che si può osservare empiricamente nel sistema
economico: la presenza di imprese molto diverse tra loro che non hanno la possibilità di
accedere a tutte le informazioni e presentano grossi limiti nell'elaborazione delle decisioni.
Come conseguenza si avrà una netta differenziazione delle performance delle imprese, con il
fallimento di alcune e la loro susseguente uscita dal mercato.
3.2 Apprendimento e Routine
Le imprese accumulano conoscenza e informazioni che vengono utilizzate per supportare il loro
processo decisionale. Questo avviene tramite un processo di apprendimento (learning)
collettivo dell'impresa, sia per mezzo di ognuno dei propri membri sia in quanto organizzazione.
L'apprendimento e la conoscenza influenzano in modo fondamentale il comportamento
dell'impresa poiché costituiscono la base per la formazione delle routine, che sono risposte
predeterminate a determinati stimoli o situazioni utilizzate dall'impresa per superare l'incertezza
ambientale ed i propri limiti computazionali.
Tramite i meccanismi di apprendimento le imprese sono capaci di incorporare il cambiamento
tecnologico proveniente dall'esterno e trasformarlo in innovazioni oppure, grazie alla
conoscenza acquisita, sono capaci esse stesse di generare internamente cambiamento
tecnologico e trasformarlo susseguentemente in un’innovazione. Di conseguenza in questo
approccio teorico l'innovazione risulta senza ombra di dubbio endogena, prodotta dagli agenti
del sistema economico.
La base di conoscenza dell'impresa si forma tramite il raggruppamento e la cernita della
conoscenza dei singoli membri di un’organizzazione, processo che per mezzo dell’utilizzo di
codici di comunicazione e meccanismi di accumulazione e apprendimento. Tale base di
conoscenza, assieme all'accumulazione nel tempo di esperienza nella risoluzione di problemi e
ai valori che l'impresa sviluppa, vanno a costituire le routine organizzative: risposte inerziali
34 Ottimizzazione che si può anche definire soggettivamente ottimale ex-ante, ma che non è oggettivamente
ottimale ex-post. Vale a dire che la decisione presa è quella che nel determinato momento appare migliore
sulla base delle informazioni disponibili dell'impresa e nella situazione specifica di tale impresa. Ma questa
decisione molte volte non risulta essere quella ottimale, ed anzi molte volte produce risultati negativi.
24
per la soluzione di problemi decisionali di varia complessità e regole di comportamento
dinnanzi a certe situazioni e a stimoli esterni. Le routine consentono la riduzione dello sforzo
cognitivo nella risoluzione di problemi e l'abbassamento o l'azzeramento dei costi di
acquisizione di nuove informazioni/conoscenza, inoltre esse contribuiscono ad evitare i conflitti
all'interno delle organizzazioni35.
Vista la sostanziale differenza che caratterizza gli agenti presenti nel sistema economico, ovvero
le loro peculiarità nei valori, nella storia e nella loro base di conoscenza, le routine risulteranno
molto diverse in ogni impresa, saranno cioè firm-specific. Data la diversità delle routine e delle
decisioni prese per contrastare l'incertezza sulle tecnologie e sul futuro, risulta impossibile
trovare una routine ottima in generale, valida per tutte le imprese. Al contrario coesistono molte
routine diverse, ognuna ottimale sul piano locale di ogni specifico agente.
Quando lo stimolo proveniente dall'esterno dell'organizzazione è diverso dalla casistica prevista
dalle routine, potrebbe sorgere la necessità di sostituirle con delle nuove perché oramai
potrebbero essere divenute inefficaci. Però bisogna considerare che il processo di sostituzione
delle routine non è di facile realizzazione, poiché esse sono il risultato di un processo di
riduzione della varietà messo in pratica allo scopo di facilitare i processi decisionali e di
realizzare una più efficiente allocazione delle risorse in un ambiente caratterizzato da
complessità. Di conseguenza le routine sono radicate nell'impresa e tendono a resistere al
cambiamento, riproponendosi anche nella situazione in cui gli stimoli provenienti dall'esterno
rappresentino delle vere e proprie discontinuità rispetto all'apprendimento consolidato fino a
quel momento, risultando non più idonee ad affrontare tale situazione. Quando le routine
frenano o bloccano le decisioni e la sperimentazione di percorsi alternativi, si può parlare di
path dependence, l'impresa ha difficoltà a comportarsi in modo difforme dalle scelte del
passato36.
Nonostante queste difficoltà e la possibilità che le routine rappresentino un ostacolo al
cambiamento, nel momento in cui il comportamento adottato dall'impresa dovesse non risultare
più soddisfacente, vale a dire quando essa non riesce più a conseguire un profitto ritenuto
adeguato, l'impresa possiede la capacità di modificare le proprie routine per migliorare la
35 P. Fariselli, Economia dell’innovazione, cit., pp. 49-52. 36 Ivi, pp. 49-55; La path dependence, dipendenza dal sentiero in italiano, è la teorizzazione del fatto che le
decisioni che ci troviamo a prendere in un dato momento sono fortemente condizionate dalle decisioni che
abbiam preso in passato, così come le possibilità stesse di scelta sono la diretta conseguenza di ciò che abbiamo
scelto precedentemente.
25
propria performance competitiva. Inoltre l'impresa può provare a introdurre le routine di
successo appartenenti ad altre imprese poiché esse tendono a diffondersi nel mercato attraverso
processi di imitazione, anche se adattate contestualmente ad ogni situazione specifica.
Abbiamo visto come una caratteristica delle routine sia quella di essere persistenti davanti ai
cambiamenti, esse però esprimono anche un processo dinamico: consentono all'organizzazione
di apprendere, per poi modificarsi esse stesse successivamente sotto la spinta di cambiamenti
organizzativi, tecnologici e istituzionali. Difatti è possibile dividere le routine in due tipologie:
quelle statiche, che hanno lo scopo di consentire la replica di procedure, quelle dinamiche
orientate all'apprendimento.
L’efficienza dinamica, che è rappresentata dalla capacità di innovare, è lo strumento chiave per
la sopravvivenza dell'impresa nella competizione di mercato. L'apprendimento risulta centrale
perché può condurre all'innovazione in vari modi. È possibile, innanzitutto, che grazie alla
ricombinazione della conoscenza precedentemente accumulata e alla creazione di nuova
conoscenza, come accade solitamente nella Ricerca e Sviluppo interna, l'impresa stessa sia in
grado di generare cambiamento tecnologico e poi introdurlo nel sistema economico tramite
un'innovazione. Inoltre l'impresa può anche apprendere il cambiamento tecnologico generato
all'esterno di essa, acquisirlo adattandolo alle sue necessità e produrre da esso un'innovazione.
Infine i processi di apprendimento sono utili anche nel caso in cui è necessario apprendere
conoscenza su un’innovazione già generata da altri ed adattarla alle specifiche condizioni
dell'impresa, innovando tramite l'imitazione37.
3.3 La varietà nel sistema economico
Descritto l'ambiente, gli agenti, i loro comportamenti e i meccanismi di apprendimento,
vediamo quale sia l'effetto, nel sistema economico, dell'introduzione di una innovazione
derivante dal cambiamento tecnologico38. L’introduzione di essa genera discontinuità in tale
sistema, producendo una maggiore varietà, vale a dire aumentando sia il numero di tecnologie
tra cui le imprese possono scegliere sia il numero di prodotti, processi, materiali e forme
organizzative presenti nel mercato. La scelta delle imprese sarà condizionata, come abbiamo
37 Ivi, pp. 52-55. 38 Rappresentato sia da una tecnologia completamente nuova sia dal il miglioramento di una preesistente.
26
già visto, dalla loro razionalità limitata e dal fatto che non dispongano di informazioni perfette
e non conoscano i rendimenti futuri delle tecnologie, prodotti o processi.
Tramite il processo di scelta delle imprese su quali tecnologie adottare, che avviene nel mercato
in cui operano, si genera varietà netta, cioè la differenza tra la varietà creata dall'introduzione
di innovazioni e quella distrutta per colpa di queste, specificatamente la differenza tra quelle
tecnologie, quei processi, prodotti, materiali e forme organizzative nuovi e quelli abbandonati
poiché ritenuti obsoleti o meno efficienti. Tale varietà netta che si produce nel sistema
economico determina le condizioni di quel disequilibrio che secondo Schumpeter è il motore
primo dello sviluppo economico, l'incessante burrasca della distruzione creatrice39 . Questo
meccanismo è attivato dalla volontà delle imprese di ottenere, attraverso l'innovazione, un
vantaggio competitivo e, conseguentemente, extra-profitti.
Per i consumatori l'aumento di varietà può essere visto in maniera sempre positiva, visto che
incrementa le possibilità di scelta. Invece per le imprese una maggior varietà comporta anche
degli effetti negativi, tra i quali l'aumento dei costi d'informazione sulle varie tecnologie e dei
costi per realizzare nuovi prodotti ed adottare nuovi processi. Inoltre essa aumenta l'incertezza
presente nel sistema. Tali effetti negativi tendono a diminuire quando sul mercato emerge un
progetto dominante, sia in termini di tecnologia che di prodotto o processo, verso cui le imprese
convergono con il risultato di ridurre la varietà presente nel mercato. Solitamente questo accade,
come vedremo in seguito, in un dato momento della vita di un’industria, identificabile con la
sua maturità40.
3.4 La selezione
Il processo di innovazione, basato sull'apprendimento e sulle routine, prevede che alcune
tecnologie, ritenute valide e con ottime prospettive future, vengano adottate da più imprese
mentre altre, ritenute non idonee, vengano trascurate o adottate da pochi.
Quindi un primo processo di selezione, nel senso biologico del termine, avviene tra le varie
tecnologie disponibili sul mercato. Successivamente una seconda selezione avviene sulla base
delle performance ottenute dalle imprese che hanno introdotto le tecnologie disponibili:
39 J.A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, cit., pp. 81-87. 40 P. Fariselli, Economia dell’innovazione, cit., pp. 46-47.
27
“sopravvivono” solo quelle che hanno ottenuto i miglioramenti di efficienza maggiori
producendo le innovazioni migliori, non in termini assoluti, ma quelle più adatte al loro
specifico contesto. Mentre le altre che hanno ottenuto meno miglioramenti di efficienza devono
subire ridimensionamenti, perdite o l'uscita dal mercato41.
Questo meccanismo di selezione che opera sul mercato ha chiare affinità con la biologia, difatti
in entrambi gli ambienti, economico e biologico, chi sa adattarsi meglio, arrivare prima,
sfruttare una propria caratteristica o sfruttare una fonte di approvvigionamento risulta il
soggetto che detiene le maggiori possibilità di sopravvivenza.
Tramite questa selezione una determinata industria evolve la sua struttura nel corso del tempo.
Molti studi hanno verificato empiricamente l’esistenza di schemi stabili di sviluppo delle
industrie, una delle periodizzazioni più riutilizzate è quella dei “cicli di vita delle industrie” 42.
Questa schematizzazione delinea tre fasi nello sviluppo di un’industria ma, nonostante questo,
ha una forte somiglianza con i due periodi del pensiero schumpeteriano.
La prima fase è caratterizzata da un’elevata incertezza nell'industria, all’interno della quale
coesistono vari disegni tecnologici nessuno dei quali risulta dominante. In questo periodo si
manifesta un alto tasso di entrata e di uscita di imprese dal mercato. Nella seconda fase si assiste
all'emergere di un disegno dominante, basato su una data tecnologia. Le imprese che hanno
adottato innovazioni appartenenti a tale disegno ne approfondiscono la conoscenza e
l'esperienza, accumulando capacità e competenze. Conseguentemente a questo processo di
apprendimento (learning), le imprese, che sviluppano innovazioni lungo la traiettoria
tecnologica del nuovo disegno dominante, tendono ad ottenere buone performance, mentre le
imprese che avevano adottato disegni alternativi tendono a fallire e uscire dal mercato.
Nonostante il numero di imprese all’interno dell’industria diminuisca, grazie ai processi di
apprendimento e all'aumentata efficienza, l'output complessivo aumenta comunque. Il disegno
dominante emerso sarà alla base di un regime tecnologico verso cui convergeranno imprese,
istituzioni e programmi di ricerca e di formazione 43 . La terza fase, quella della maturità
dell'industria, è generalmente caratterizzata dall'aumentare delle dimensioni delle poche
imprese rimaste sul mercato, le quali assumono una posizione dominante e sviluppano
41 Per esempio quelle che hanno scelto la tecnologia che si adatta meglio alle specifiche caratteristiche dell'azienda
o del mercato in cui operano. Oppure le imprese che hanno scelto la tecnologia che diventerà dominante e
soppianterà le altre. 42 W. Abernathy, J. Utterback, A dynamic model of process and product innovation, in Omega, Vol. 3, 1975, pp.
645-655. 43 Su questi concetti vedere il paragrafo 3.8.
28
un’intensa attività di R&S al proprio interno, riuscendo a ricreare internamente la competizione
tra progetti di ricerca alternativi44.
Sia le assunzioni alla base di questo modello che l'evidenza empirica contraddicono un altro
assunto dei neoclassici, ovvero che il tasso di introduzione delle innovazioni sia costante. Al
contrario le innovazioni compaiono a grappoli e sono concentrate nel tempo, come accade nella
prima fase di vita di un'industria. In seguito si registrano innovazioni incrementali più
sporadiche, fino al momento in cui altre invenzioni o ricombinazioni di conoscenza favoriscono
l’emergere di nuove innovazioni radicali che consentano il soppiantamento del paradigma
dominante e diano il via ad un’altra ondata di innovazioni.
3.5 La diffusione
Il processo di diffusione delle tecnologie avviene attraverso le scelte di adozione delle imprese
e il processo di selezione operato dal mercato. La diffusione di una data tecnologia è
fondamentale per determinarne il peso economico, infatti solamente le tecnologie che vengono
trasformate in innovazioni e adottate dalle imprese producono rendimenti per chi le ha prodotte.
Inoltre solo queste sono in grado di attivare quel circolo virtuoso che consente alle imprese di
ottenere extra profitti ed al sistema economico di crescere.
La diffusione delle tecnologie che generano innovazioni non si limita ai prodotti e ai macchinari,
ma si applica anche alla conoscenza necessaria per il loro utilizzo. Ma, considerata la specificità
dei processi di apprendimento, le organizzazioni che adottano la nuova tecnologia, la adattano
alle loro condizioni specifiche e la modificano contestualmente, realizzando così una sequenza
di innovazioni di prodotto e di processo collegate, che hanno una ricaduta economica. Il fatto
che la conoscenza di ogni impresa, così come i suoi meccanismi di apprendimento siano
fortemente specifici, spiega in parte il diverso comportamento e la diversa performance delle
imprese rispetto all'innovazione tecnologica.
L'ambiente economico, istituzionale e sociale in cui l’innovazione viene a realizzarsi è
fondamentale per la sua diffusione, infatti essa dipende in maniera cruciale dalla qualità delle
relazioni e delle connessioni che si stabiliscono tra le imprese e tra queste e le istituzioni di
44 Il passaggio da una fase all’altra riflette le differenze tra il pensiero del primo periodo di Schumpeter a quello
del secondo periodo.
29
ricerca, di formazione e regolative. L’importanza dell’ambiente e delle relazioni è dovuto al
fatto che il processo di diffusione dell’innovazione è dinamico, si modifica qualitativamente
con il suo procedere, grazie alle azioni e reazioni (feedback) che si hanno tra le tecnologie, le
imprese e le istituzioni. Quindi l'innovazione risulta inscindibilmente legata con la sua
diffusione, poiché è questo processo che plasma lo sviluppo stesso della tecnologia45.
3.6 Path dependence
Sempre in contrapposizione con i neoclassici, bisogna considerare un altro concetto alla base
della teoria evoluzionista, la path dependence, traducibile in italiano come dipendenza dal
sentiero, che riguarda sia il processo decisionale degli agenti/imprese sia il processo di adozione
delle tecnologie. L'assunto di base è che la storia conta, ovvero le decisioni che ci troviamo a
prendere non sono indipendenti dalle decisioni prese nel passato. Un'impresa che ha adottato
una tecnologia che richiedeva molti investimenti in capitale fisso difficilmente troverà
conveniente passare ad un’altra tecnologia rivale, così come chi ha basato il proprio successo e
specializzato le sue risorse in un dato settore/tecnologia potrà trovare ostacoli mentali e
organizzativi nel caso in cui provasse a cambiare strada. Come già visto, le routine
organizzative davanti a stimoli completamente nuovi si opporrebbero quasi sicuramente al
cambiamento, così come potrebbero opporsi i membri dell'organizzazione poiché le loro
competenze non sono riutilizzabili nel nuovo percorso che l'impresa potrebbe intraprendere.
Lo stesso grado di dipendenza dalle decisioni passate si può avere per quanto concerne una
tecnologia adottata in un’industria. Per esempio, se emerge una tecnologia ritenuta più
efficiente, è possibile che non si proceda alla sua adozione a causa di scelte passate che non
rendono conveniente cambiare. Infatti, potrebbe essere troppo costoso in relazione ai benefici
attesi a causa degli alti costi fissi sostenuti per le tecnologie precedenti; potrebbe esserci la
mancanza delle conoscenze necessarie e la loro acquisizione sarebbe troppo onerosa e lenta nel
tempo; oppure ci potremmo trovare nel caso in cui un’industria a valle di questa ha sviluppato
processi produttivi compatibili solo con la tecnologia già in uso. Tutti questi sono esempi di
come le scelte passate si riflettono sulle scelte da compiere nel presente.
Il concetto di path dependence è fondamentale per un analisi dinamica del sistema economico
45 P. Fariselli, Economia dell’innovazione, cit., pp. 57-59.
30
come descritto perfettamente da Antonelli:
“The notion of path dependence provides one of the most articulated and comprehensive frameworks
to move towards an analysis of the conditions that make it possible to conceive the working of an
economic system where agents are able to generate new technological knowledge, introduce new
technological innovations and exploit endogenous growth. The notion of path dependence can be
considered the analytical form of complexity most apt to understand the dynamics of economic systems
where heterogeneous agents are characterized by some levels of past dependence, as well as by local
creativity, interdependence and limited mobility in a structured space that affects their behavior, but is
not the single determinant. Path dependence is an essential conceptual framework, which goes beyond
both the analysis of static efficiency and enters the analysis of the conditions for dynamic efficiency. It
applies both to each agent, in terms of quasi-irreversibility of his own endowment of tangible and
intangible assets, networks of relations in both product and factor markets, stock of knowledge and
competence, and to the system level in terms of general endowments of production factors, industrial
and economic structure, and architecture of the networks in place” 46.
3.7 Le istituzioni
Nell'approccio evolutivo le imprese non sono gli unici attori rilevanti, così come la storia, anche
le istituzioni contano, siano esse il mercato, come regolatore delle interazioni degli agenti,
oppure le istituzioni che presiedono alle definizioni delle politiche o quelle direttamente
coinvolte nella diffusione di conoscenza. Il processo innovativo è difatti un fenomeno collettivo,
raffigurabile come un sistema il cui risultato è dato dalle relazioni e interazioni di differenti
attori con diverse competenze47.
Le istituzioni hanno differenti influenze sul processo innovativo. Alcune, come le università e
i centri pubblici di ricerca, condizionano sia la finalità che i processi di apprendimento del
settore scientifico e tecnologico, indirizzando la ricerca verso alcune aree invece che altre. Le
istituzioni che presiedono al governo dei meccanismi di mercato e quindi determinano il suo
funzionamento, regolando l'interazione tra i vari soggetti presenti nel mercato, ne influenzano
in maniera cruciale le opportunità.
Inoltre sono gli assetti istituzionali che plasmano variabili macroeconomiche quali la
distribuzione del reddito, i pattern di consumo e più in generale i comportamenti degli agenti
46 C. Antonelli, The foundations of the Economics of Innovation, Dipartimento di Economia “S. Cognetti de
Martiis”, Working paper no. 2, 2007, pp. 40-41. 47 P. Fariselli, Economia dell’innovazione, cit., pp. 59-63.
31
economici. Per questo motivo esiste un'alta complementarità tra l'analisi evoluzionista, che
enfatizza il ruolo dell'innovazione e del cambiamento tecnologico, e le analisi istituzionaliste
direttamente focalizzate sui meccanismi di governo sociopolitico. Tale complementarità non è
ancora stata esplorata in tutte le sue potenzialità e rappresenta una delle sfide più affascinanti
per entrambe le prospettive interpretative48.
3.8 Traiettorie, paradigmi e regimi tecnologici
Nella biologia l'evidenza empirica supporta la tesi dell'imprevedibilità della direzione lungo la
quale le mutazioni avvengono, la stessa evidenza empirica però non si riscontra nell'ambito
socio economico. Conseguentemente gli evoluzionisti hanno elaborato concetti che identificano
possibili regolarità nei processi di apprendimento tecnologico e nelle loro determinanti. Sono
state rilevate importanti invarianze nei processi di accumulazione di conoscenze tecnologiche
e nei meccanismi attraverso i quali esse vengono incorporate in nuovi prodotti e nuovi processi
produttivi49 . Da queste osservazioni sono stati elaborati alcuni concetti utili per descrivere
l'evoluzione dell'innovazione nel tempo.
Esiste un’ampia analogia, in termini di definizioni e di procedure, tra “scienza” e “tecnologia”.
Infatti, così come nella scienza contemporanea vengono definiti i paradigmi scientifici, allo
stesso modo si possono definire anche “paradigmi tecnologici” 50 . Entrambi i paradigmi
scientifici e tecnologici avrebbero al loro interno una visione, una definizione dei problemi
rilevanti da affrontare e un modello di indagine che ha la funzione di affrontarli51.
Un paradigma tecnologico definisce allo stesso momento i bisogni che intende soddisfare, i
principi scientifici utilizzati per lo scopo e la tecnologia materiale utilizzata. In altre parole può
essere definito come il “modello” di soluzione di determinati problemi tecnologici, basato su
selezionati principi derivanti dalle scienze naturali.
A partire da un dato paradigma tecnologico derivano altre opportunità tecnologiche che
consentono di sviluppare ulteriori innovazioni. Tali opportunità orientano gli sforzi innovativi
48 G. Dosi, L'interpretazione evolutiva delle dinamiche socio economiche, cit., pp. 9-11. 49 Ivi, pp. 7-9. 50 T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi, 1999, (edizione originale 1962), pp. 213-
216. 51 G. Dosi, R.R. Nelson, The Evolution of Technologies: an Assessment of the State-of-the-Art, in Eurasian
Business Review, Vol. 3, no. 1, 2013, pp. 5-12.
32
verso certe direzioni: le traiettorie tecnologiche, che possono essere definite come le attività di
progresso tecnologico sviluppate secondo le opportunità offerte dai paradigmi tecnologici. In
altri termini potremmo definire le traiettorie come il progressivo perfezionamento e sviluppo
nel tempo, lungo percorsi invarianti, delle caratteristiche tecnico-economiche di determinati
prodotti o processi produttivi52.
La nozione di regime tecnologico fornisce una descrizione dello specifico contesto nel quale
competono le imprese, contano quindi le caratteristiche settoriali del processo innovativo con
particolare attenzione per le variabili determinanti e le procedure di tali attività. Per regime
tecnologico si intende una particolare combinazione di alcune proprietà fondamentali delle
tecnologie quali: opportunità, appropriabilità, cumulatività dell’avanzamento tecnologico e
caratteristiche della base conoscitiva53. A seconda delle caratteristiche della tecnologia esistono
quindi diversi regimi tecnologici che influenzano il modo con cui il processo innovativo viene
portato avanti54.
3.9 Coevoluzione/Sistema di Innovazione
Abbiamo visto come le istituzioni e la storia siano variabili importanti per gli evoluzionisti, ma
anche l'ambiente conta poiché possiede un’influenza sulle stesse dinamiche innovative. Le
variabili culturali e i processi sociali, così come i valori di una società, sono determinanti per
favorire o ostacolare la crescita ed il processo innovativo.
Il processo innovativo ha una dimensione sistemica visto che coinvolge un’ampia gamma di
soggetti ed istituzioni, dalle quali è influenzato. Il concetto di sistema di innovazione si è
sviluppato come unità di analisi fondamentale per comprendere le ragioni del successo o della
disfatta, in termini economici, di unità territoriali più o meno estese, dai sistemi locali a quelli
regionali e nazionali, e di settori specifici caratterizzati da un dato regime tecnologico.
Un sistema è un insieme di attività e di attori legati tra loro: per determinare come ognuno
influisce sulle performance delle altre componenti e dell'intero sistema sono di fondamentale
importanza i legami, le interazioni e i meccanismi tramite i quali una parte influenza l’altra. Per
52 Ibidem. 53 B. Bigliardi, La gestione dell’innovazione nelle imprese industriali: il caso empirico dell’impiantistica
alimentare, tesi di dottorato in Ingegneria Industriale XIX ciclo, Università di Parma, 2007, pp. 15-19. 54 R.R Nelson, S.G.Winter, Evolutionary theorizing in economics, cit., pp. 35-37.
33
la performance innovativa risultano essere di fondamentale importanza il sistema educativo, il
sistema pubblico di ricerca, il sistema finanziario, le istituzioni regolative, le infrastrutture e le
istituzioni di governo. Le performance qualitative di ognuno di queste parti influenza
direttamente le possibilità delle imprese di innovare.
Anche altri aspetti meno intuitivi possono comunque influenzare la performance di un sistema
innovativo, per esempio la cultura dominante di una nazione o il sistema sociale e di welfare
presente. Infatti per introdurre innovazioni con successo, soprattutto quelle radicali, è spesso
necessario che in tutto il sistema avvengano dei cambiamenti istituzionali, sociali e culturali.
Come possiamo vedere anche dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, solo se tali cambiamenti avvengono contestualmente l'innovazione potrà
dispiegare il suo potenziale, permettendo all'intero sistema di produrre una performance
adeguata.
Freeman, coerentemente con quanto detto finora, studiando la crescita economica in una
prospettiva storica, rifiuta di fermarsi ad analizzare le sole variabili economiche alla guisa dei
neoclassici. Conseguentemente egli riconosce che le variabili che influenzano il processo
innovativo e la crescita sono più varie e riguardano tutta la società. Egli individua cinque
dimensioni/variabili: scienza, tecnologia, economia, politica e cultura. Tali dimensioni
interagiscono e sono interconnesse tra di loro pur mantenendo una relativa autonomia.
Allo scopo di ottenere una performance di sistema accettabile queste cinque dimensioni devono
co-evolvere, sviluppandosi in maniera congruente. Difatti se una o più dimensioni si sviluppano
in maniera non sincronica, non congruente con le altre, si creano scompensi nell'intero sistema
con la conseguenza che le altre dimensioni vedranno diminuire la loro performance, data la
reciproca influenza che intercorre tra di esse. Solo attraverso una co-evoluzione congrua nel
corso del tempo di tutte le cinque dimensioni si favorisce la crescita complessiva del sistema,
facendo sì che ogni dimensione produca un effetto di rafforzamento reciproco con le altre,
invece che di indebolimento55.
55 C. Freeman, History, Co-evolution and Economic Growth, IIASA Working Paper no. 76, 1995, pp. 2-16; P.
Fariselli, Economia dell’innovazione, cit., pp. 59-63.
34
4 Innovazione: una possibile definizione
Dare una definizione di innovazione esaustiva e condivisa appare molto difficile, per questo
motivo spesso gli studiosi hanno preferito concentrarsi ogni volta su delle sue differenti
caratteristiche. Comunque esistono concettualizzazioni e definizioni legate all’innovazione che
sono più usate e accettate.
Per cominciare una distinzione importante è quella tra invenzione e innovazione. L'invenzione
consiste nel concepire per la prima volta un’idea, che sia un nuovo prodotto, servizio, processo,
mercato di sbocco o semplicemente una ricombinazione di conoscenza già esistente che però
deve essere identificata come novità. L'invenzione può essere realizzata in luoghi molto diversi,
anche all’esterno del mercato, al contrario le innovazioni avvengono tipicamente nelle imprese.
L'innovazione consiste nel mettere in pratica le invenzioni utili, nel senso economico del
termine, introducendole nel sistema economico. Tra invenzione e innovazione può intercorrere
anche un notevole lasso di tempo56.
Molto interessante è la definizione di innovazione proposta dall'OECD nel Manuale di Oslo che
viene usata come base per le statistiche sull'innovazione in tutto il mondo: essa è definita come
l'implementazione di un prodotto (bene o servizio), di un processo, nuovo o considerevolmente
migliorato, di un nuovo metodo di marketing, di un nuovo metodo organizzativo con
riferimento alle pratiche commerciali, al luogo di lavoro o alle relazioni esterne 57 . Tale
definizione è molto simile a quella proposta da Schumpeter nel 1912 che considerava
l'innovazione come l'introduzione di una vasta gamma di novità nel sistema economico, che
potevano essere nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi mercati, nuove fonti di
approvvigionamento e nuove forme di organizzazione.
Dalla definizione dell’OECD si desume che l'innovazione deve possedere due caratteristiche
fondamentali: la prima è la necessità che essa rappresenti una novità o un miglioramento
qualitativo importante; in secondo luogo l'innovazione per essere tale deve essere stata
implementata. Per un prodotto, nuovo o migliorato, essere implementato significa essere
introdotto nel mercato. Per i nuovi processi, metodi di marketing o metodi organizzativi essere
56 Per esempio come il caso della realizzazione del Kevlar, materiale ultraresistente ed ora utilizzato in svariati
campi che ha però visto passare anni tra la sua invenzione ed il suo effettivo utilizzo. 57 OECD, Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Inovation Data, Paris, OECD, 2005, pp. 31-
33.
35
implementati significa essere effettivamente utilizzati nelle attività dell’impresa.
Oltre alle definizioni sono state proposte molte classificazioni/tipizzazioni dell'innovazione in
base a varie caratteristiche quali il suo oggetto, la sua intensità, la sua provenienza o il suo grado
di continuità rispetto alla tecnologia precedente58.
Per l’approccio evolutivo l’innovazione tecnologica può essere vista come l'anello di
congiunzione tra il cambiamento tecnologico, inteso come invenzione o produzione di
conoscenza, e la produttività e la crescita del sistema economico. Attraverso l'innovazione
tecnologica è possibile ottenere, a partire da un dato ammontare di risorse, un maggior volume
di prodotto o un prodotto qualitativamente superiore59. Come riassume Fariselli:
“L'innovazione è fondamentalmente il risultato di un processo di ricombinazione delle conoscenze,
acquisite, sia mediante la ricerca svolta nei laboratori dell'impresa e/o nei centri istituzionali della ricerca
scientifica e tecnologica al suo esterno, sia mediante meccanismi di apprendimento (learning) che
l'impresa innesta nelle sue routine e accorda agli skills, alle competenze e alle capabilities che
compongono il collante delle attività produttive e la base della sua competitività.60”
Nelson considera l’impresa nella sua peculiarità e la pone al centro di un ambiente dominato
dalla varietà e dall'incertezza: nella sua definizione di innovazione il necessario carattere di
novità è riferito alla specifica impresa che genera o adotta l’innovazione. Infatti, a seconda del
caso, come innovazione può essere considerata anche l'imitazione o il trasferimento in un
contesto diverso da quello in cui è stata originariamente introdotta o generata.
Inoltre anche la semplice imitazione molte volte richiede che i processi ed i prodotti vengano
adeguati alle specificità del contesto. Tali adattamenti, anche di natura organizzativa, si
sostanziano in innovazioni incrementali da parte dell'impresa che imita o a cui viene diretto il
trasferimento tecnologico61.
58 Per una panoramica di tali classificazioni si veda F. Malerba, Innovazione imprese, industrie, economie, Roma,
Carocci, 2007. 59 P. Fariselli, Economia dell’innovazione, cit., pp. 78-80. 60 Ibidem. 61 Ibidem.
36
5 La complessità dell’innovazione
Nel corso del capitolo è stato analizzato il modo in cui il progresso tecnico, il cambiamento
tecnologico e l’innovazione sono stati trattati dalle varie teorie economiche nel corso del tempo.
Dalla visione classica del progresso tecnico come variabile endogena, anche se non centrale,
nel sistema economico si è passati ad escluderlo dall'analisi economica nei neoclassici,
ritenendolo esogeno. Molti, anche all'interno degli stessi neoclassici, che non si trovavano a
loro agio nel considerare il progresso tecnico e l'innovazione irrilevanti, hanno compiuto degli
sforzi per provare a reinserirli nell'analisi del sistema economico.
Dagli anni Ottanta, con l'ondata di innovazioni legate alla comunicazione, all’informatica e alle
biotecnologie, che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, è diventato impossibile ignorare
l'innovazione in qualsiasi analisi sul sistema economico. Tra tutti gli approcci, quello che ha
compiuto più progressi sul sentiero dell’analisi dell'innovazione è stato, senza ombra di dubbio,
quello evoluzionista.
Per il proseguo della trattazione e per determinare il ruolo svolto dall'innovazione in Italia viene
ritenuta valida la visione del processo innovativo portata avanti dall’approccio evoluzionista.
Infatti essa considera la complessità del fenomeno innovativo e lascia un’ampia libertà
metodologica che consente di utilizzare numerosi concetti e dati statistici.
Infatti, vista la complessità del fenomeno, non c’è nessuna logica nel basare l’analisi
dell’innovazione su modelli che ne spiegano l'influenza sul sistema economico attraverso
l’utilizzo di una sola variabile rilevante. Per quanto importante una singola variabile possa
essere, il fenomeno innovativo non potrà mai essere spiegato da una sola determinante. Molti
dubbi infatti mi attanagliavano nel pensare a come analizzare le dinamiche innovative e la loro
relazione con lo sviluppo economico, considerata la complessità del mondo che ci circonda e
la ricchezza qualitativa del sistema economico. Come posso considerare la crescita economica
derivante solo dall’accumulazione di capitale fisso? O di capitale umano? O di livelli di R&S?
O di qualsiasi altra variabile presa singolarmente? Queste domande non trovavano risposta
all'interno dell'alveo neoclassico. Tali interrogativi, più che procedevo nella lettura di testi e
nell’analisi dei dati statistici relativi all'innovazione, si sommavano ad altri. Come posso
accettare che il sistema scolastico non influenzi le dinamiche innovative di in un paese? Come
posso non considerare il ruolo del sistema finanziario nel sostenere le innovazioni? Come posso
trascurare nella mia analisi il fatto che la classe dimensionale delle imprese influisce sulla loro
37
propensione ad innovare? Come è possibile non considerare che la proprietà familiare della
maggior parte delle imprese italiane influenza la scelta dei manager poiché ci si basa
maggiormente sulla lealtà alla proprietà che sulle effettive capacità? Che effetto ha questo sul
processo innovativo?
A queste domande potrei aggiungerne un'infinità di altre, ma il concetto sembra abbastanza
chiaro, non è adeguato effettuare un'analisi dell'innovazione basandosi su poche variabili e tutte
di stampo economico. È necessaria maggiore libertà di spaziare in vari ambiti per descrivere le
dinamiche innovative e determinare quali siano i fattori che le hanno favorite e quelli che le
hanno bloccate nel corso del tempo.
Conseguentemente nel proseguo della trattazione all’analisi di numerose variabili economiche
viene affiancato la descrizione di variabili istituzionali e sociali. Inoltre viene descritto l’intero
processo in una prospettiva storica in modo da capire come fenomeni di path dependence
abbiano potuto influenzare le scelte compiute dagli attori rilevanti e come la situazione attuale
sia anche il riflesso di una serie di decisioni prese nel passato.
38
CAPITOLO II -
L'ITALIA DEL DOPOGUERRA: UNA STORIA INNOVATIVA DI
SUCCESSO
Il titolo di questo capitolo anticipa quelle che sono le sue conclusioni. Infatti, alla fine del
percorso di analisi svolto all’interno dello stesso, viene affermato che l'Italia nel Dopoguerra ha
prodotto forti dinamiche innovative che hanno avuto un ruolo preponderante nell’alimentarne
la crescita economica.
Gli studi che considerano il ruolo del progresso tecnologico come centrale, nella spiegazione
della crescita economica italiana della seconda parte del XX secolo, sono stati marginali per
lungo tempo. Solitamente, vengono messi in risalto altri elementi, tra i quali sono annoverati
con maggior frequenza il processo di accumulazione di capitale, il ruolo di traino della domanda,
le forme organizzative ed il mercato del lavoro. Invece, negli ultimi anni, sono stati molti i
lavori che si sono focalizzati sul ruolo del progresso tecnologico.
Traendo spunto da queste ricerche e tramite l'evidenza empirica, viene mostrato come il nostro
sistema economico ha prodotto importanti dinamiche innovative che, però, si sono
contraddistinte per avere caratteristiche molto diverse rispetto a quelle dei paesi avanzati.
Proprio queste forti peculiarità sono state uno dei principali motivi per il quale l’innovazione è
stata molte volte esclusa dall’analisi sulla crescita italiana e, proprio queste specificità, rendono
necessaria l’elaborazione di considerazioni ad hoc per analizzare il sistema innovativo italiano.
A questo scopo il capitolo è organizzato come segue. Nel primo paragrafo viene brevemente
analizzato l’andamento economico dell’Italia, nel periodo che va dagli anni Cinquanta all’inizio
degli anni Novanta, al fine di tracciarne un quadro generale.
Nel secondo paragrafo vengono delineate le caratteristiche del sistema di innovazione italiano.
Tramite strumenti propri della contabilità della crescita, viene trovata una misura che può
quantificare l’effetto delle dinamiche innovative sul sistema economico. Successivamente viene
proposta una misurazione empirica delle varie attività che hanno contribuito al processo
innovativo italiano. Per fare ciò viene usato un corposo apparato di dati statistici. Al fine di dare
un giudizio migliore, i dati relativi a queste attività vengono continuamente confrontati con gli
39
stessi dati relativi agli altri paesi avanzati. In seguito viene tracciato un resoconto allo scopo di
comprendere quali siano i settori che hanno contribuito maggiormente a tali dinamiche
innovative.
Nel terzo paragrafo, quello finale, vengono tracciate le conclusioni di questa ricerca sul periodo
che va dal dopoguerra al 1990 e vengono descritte, in maniera generale, le caratteristiche delle
dinamiche innovative italiane ed il loro funzionamento. Contestualmente vengono poste delle
problematiche riguardo al sistema innovativo italiano che verranno riprese nel capitolo
successivo, in cui sarà affrontata l’analisi delle stesse dinamiche negli anni che vanno dal 1990
ad oggi.
1 Dal dopoguerra agli anni Novanta
Nel corso di questo paragrafo viene descritta in termini generali la performance dell’economia
italiana nel secondo dopoguerra. Partendo dall’analisi della situazione globale che si profilava
in Europa alla fine della seconda Guerra Mondiale, viene osservato come gli aiuti degli Stati
Uniti e i vari accordi di cooperazione tra gli Stati sono stati fondamentali per stabilizzare la
situazione e far ripartire l’economia europea. La trattazione prosegue accettando ed utilizzando
la classica periodizzazione della crescita italiana proposta da quasi tutti gli studiosi di storia
economica: l’Età dell’Oro, che va dal 1950 al 1973, e una fase di rallentamento successiva, che
va dal 1973 al 19901. Viene poi descritto come l’Italia porta avanti un processo di convergenza
verso le economie avanzate che le consente, nel corso degli anni, di ridurre notevolmente il
divario in termini di Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite, produttività e livelli di produzione
industriale.
1 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, in AA.VV., Innovazione tecnologica e
sviluppo industriale nel secondo dopoguerra, Bari, Editori Laterza, 2007, pp. 47-49; G. Toniolo, La crescita
economica italiana, 1861-2011, in G. Toniolo (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità ad oggi,
Venezia, Marsilio Editori, pp. 34-37; Antonelli e Barbiellini Amidei la chiamano “Productivity slowdown”,
mentre Toniolo la chiama “Età dell’argento”, entrambi sottolineano però che, nonostante un forte
rallentamento rispetto al periodo precedente, il periodo è da considerarsi, in termini di crescita della ricchezza,
ancora positivo per l’Italia.
40
1.1 La Guerra è finita
Nel 1945 si chiuse il secondo conflitto mondiale, lasciando il continente europeo in uno stato
di distruzione, conflitti sociali e in ginocchio economicamente. L'Italia non faceva certo da
eccezione a questa situazione, con il PIL sprofondato ai livelli del 19062.
Ma le caratteristiche della seconda sistemazione post-bellica, molto differenti da quelle createsi
dopo la prima Guerra Mondiale, furono decisive nel preparare il terreno alla successiva rapida
crescita dell’Europa Occidentale3. Sono molti i fattori che hanno contribuito alla creazione di
un ambiente economico internazionale relativamente stabile, favorevole allo sviluppo
economico e alla crescita del mercato globale.
Innanzitutto, il Piano Marshall risultò fondamentale per la ripartenza delle economie europee,
non tanto per la sua dimensione, quanto perché fornì i mezzi di pagamento per l'importazione
di materie prime e di tecnologia dagli Stati Uniti. Mezzi di pagamento che risultarono
fondamentali visti i grossi deficit di bilancio e della bilancia dei pagamenti di tutti i paesi
europei. Il Piano risultò efficace, favorendo la riorganizzazione industriale, l’introduzione della
tecnologia e del modello industriale americano.
La stabilizzazione economica, cui era strettamente connessa quella socio-politica, fu favorita
dagli accordi di Bretton Woods del 1944 e dalla costituzione dell’Unione Europea dei
Pagamenti (UEP). A Bretton Woods si stabilirono cambi fissi delle valute nei confronti del
dollaro e la sua convertibilità in oro. Fu costituito il Fondo Monetario Internazionale con il
compito di evitare gli squilibri derivanti dai pagamenti internazionali. In questo quadro di
notevole importanza risultò anche l’accordo General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
del 1947, e i successivi accordi in seno ad esso, che riducevano le tariffe doganali favorendo la
liberalizzazione del commercio tra Stati. L’effetto congiunto di tali avvenimenti fu
fondamentale per consentire all’economia europea di ripartire, creando un terreno stabile su cui
costruire le basi per ricostituire economie di mercato aperte internazionalmente.
L’Europa si ritrovò divisa a metà dalla “discesa della Cortina di Ferro da Stettino a Trieste”4.
Nella parte orientale si consolidò il dominio comunista con istituzioni solo formalmente
democratiche ed un’economia in mano allo stato. Invece, nella parte occidentale, una volta
2 G. Toniolo, La crescita economica italiana, cit., p. 29. 3 Ivi, pp. 29-31. 4 Dal discorso di Whinston Churchil del 5 marzo 1946.
41
sconfitta la minaccia comunista, si ottenne una stabilizzazione socio-politica, con il
consolidamento di istituzioni democratiche abbinate a economie di mercato.
È in questo periodo che si compiono le scelte dell’Italia di ancorarsi saldamente all’Occidente
e partecipare alle nascenti istituzioni comuni europee come paese fondatore. Infatti l’Italia
decise di aderire al Piano Schuman e formare, assieme a Francia, Germania e ai paesi del
Benelux, la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), organizzazione
sovranazionale con l’obiettivo di gestire congiuntamente la produzione carbosiderurgica.
Successivamente la collaborazione fra questi paesi si fece sempre più stretta, con i Trattati di
Roma del 1957 venne istituita la Comunità Economica Europea (CEE), che aveva come
obiettivo la libera circolazione di merci, persone e servizi attraverso le frontiere, primo passo
per il raggiungimento di un mercato comune europeo. La partecipazione alla CEE permetterà
ai paesi aderenti di incrementare notevolmente le possibilità di importazione ed esportazione5.
La situazione economica mondiale, grazie ad una regolamentazione del commercio e dei
pagamenti tra Stati, si stabilizza, consentendo l’apertura dei mercati nazionali al commercio
internazionale. L’Italia sfrutta pienamente questa situazione e gli aiuti americani per cominciare
lo sforzo della ricostruzione e della riorganizzazione industriale, favorita dalla prospettiva di un
periodo di relativa stabilità economica. L’Italia realizza un progressivo inserimento nel mercato
mondiale, ancora più marcato in Europa, dove oltre al mercato comune cresce il ricorso a forme
istituzionali che lasciano presagire un progetto più ampio con un futuro comune per molti paesi
europei6.
1.2 Età dell'Oro
Il periodo di elevata crescita dell’economia Europea nel Dopoguerra, che va dall’inizio degli
anni Cinquanta al 1973, secondo molti, è stato favorito dalla situazione di distruzione e
arretratezza in cui le economie europee si trovarono alla fine del conflitto mondiale. Infatti la
necessità di ricostituire gran parte della propria dotazione industriale ha consentito ai paesi
europei di inserire nell’apparato produttivo le tecnologie, i macchinari e le strutture
organizzative più avanzate provenienti dagli Stati Uniti. Inoltre, i paesi europei, disponendo di
5 B. A’Hearn, A.J. Venables, Geografia, commercio estero e divari regionali, in G. Toniolo (a cura di), L’Italia e
l’economia mondiale, dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio Editori, 2013, pp. 859-860. 6 G. Toniolo, La crescita economica italiana, cit., pp. 29-33.
42
una grossa riserva di manodopera inutilizzata, hanno potuto mantenere i salari bassi per il
periodo considerato. Riuscendo così, tramite aumenti della produttività del lavoro maggiori
della crescita salariale, a mantenere prezzi competitivi nel sempre più grande mercato mondiale,
incrementando nettamente le proprie esportazioni. Si può quindi affermare che la ricostruzione,
attraverso i cambiamenti tecnologici e strutturali che ha determinato, abbia facilitato la crescita
delle economie europee, alimentando il processo di convergenza verso il livello di ricchezza
americano.
L’introduzione di tecnologie è avvenuta tramite la crescita esponenziale degli investimenti,
difatti, in Europa, lo stock di impianti e macchinari ha fatto registrare un progresso dell’8% su
base annua nel periodo considerato, con un conseguente crollo dell’età media del capitale7.
L’Italia non rappresenta un’eccezione a queste dinamiche generalizzate, pur mantenendo le sue
peculiarità. In particolare, essa ha goduto per un lungo periodo di ampie sacche di manodopera
disoccupata, proveniente dall’agricoltura, che è stata fondamentale per mantenere alta l’offerta
di lavoro e conseguentemente moderare le dinamiche salariali. In quest’ottica molto importante
è risultato il fenomeno migratorio lungo la direttrice Sud-Nord, che ha fornito lavoratori a basso
costo ai distretti industriali8.
Gli studiosi del periodo sostengono che in Europa la moderazione salariale avesse una base
contrattuale di tipo corporativista, dove le rinunce salariali dei lavoratori erano finalizzate al
raggiungimento di un obiettivo condiviso, rappresentato dal benessere di tutto il paese. La stessa
cosa non può dirsi per l’Italia, dove la moderazione salariale rifletteva piuttosto la debolezza
sindacale e l’elevata offerta di lavoro. Grazie a questo le dinamiche salariali fino al 1968
crebbero meno della produttività del lavoro, favorendo i profitti delle imprese e la competitività
dei prodotti italiani. L’industria crebbe vistosamente impiegando molti lavoratori provenienti
dall’agricoltura e, nel giro di pochi anni, questo processo di trasformazione mutò
profondamente il volto del paese: il settore agricolo passò dal 44% sul totale dell’economia del
1951 al 18% del 19739, l’Italia era diventata una società industrializzata.
Guardando alla qualità della forza lavoro, nonostante la scarsa presenza di capitale umano,
7 N. Rossi, G. Toniolo, Italy, in N. Crafts, G. Toniolo (a cura di), Economic Growth in Europe since 1945,
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 427-454. 8 Per quantificare la disoccupazione nel periodo mancano dati precisi, ma per capire l’entità del fenomeno basti
pensare che dal 1956 al 1963 la disoccupazione diminuisce passando da più di 2 milioni di persone per arrivare
a 800.000; cfr. OECD, http://stats.oecd.org/. 9 S.N. Broadberry, C. Giordano, F. Zollino, La produttività, in G. Toniolo (a cura di), L’Italia e l’economia
mondiale, dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio Editori, 2013, pp. 278-279.
43
l’Italia ha potuto sfruttare la presenza di un buon numero di ingegneri qualificati e operai esperti,
fondamentali per l’adozione di tecnologie incorporate, che hanno costituito il principale mezzo
di innovazione. Inoltre sono emersi alcuni forti spiriti imprenditoriali che hanno portato al
rafforzamento del sistema delle imprese, ma allo stesso tempo si è palesato un limite che
caratterizza le imprese italiane ancora oggi: la scarsa disponibilità di risorse manageriali dovuta
a ritardi del nostro sistema formativo10
Come abbiamo visto, la stabilità economica nel sistema occidentale ha favorito il rapido
sviluppo del commercio internazionale. Oltre a questo, l’Italia, ha potuto beneficiare del fatto
di essere all’interno del Mercato Comune Europeo, fondamentale per espandere ancora di più
le possibilità di importazione ed esportazione.
Tale maggiore apertura agli scambi internazionali, unita all’aumento della produzione di merci
italiane e della loro competitività, ha causato una crescita dell’export italiano che, a partire dal
3,7% sul totale dell’export mondiale dei prodotti manifatturieri del 1950, è quasi raddoppiato
fino a raggiungere il 6,8% nel 197311.
Nello stesso periodo, grazie all’aumento della domanda interna e all’ampliarsi del mercato del
Sud Italia, entrambi dovuti alla maggiore capacità di spesa degli italiani collegata al repentino
aumento del reddito pro capite, si sviluppò un dinamico mercato interno. Grazie a ciò e all’alta
domanda nel mercato internazionale, le imprese italiane vedono i loro mercati di sbocco
aumentare progressivamente di dimensioni, avendo così la possibilità di sfruttare economia di
scala sempre maggiori.
L’efficienza complessiva del sistema economico italiano aumenta notevolmente, come
dimostra anche la crescita della TFP al ritmo del 5,8% annuo lungo il periodo considerato12.
Questa robusta dinamica della TFP è stata spiegata in molteplici modi dagli studiosi: alcuni ne
attribuiscono il merito allo spostamento strutturale dei lavoratori agricoli verso i settori
industriali maggiormente produttivi, altri alla realizzazione di notevoli economie di scala o
ancora ad altri fattori. La tesi che tale crescita fosse dovuta alle dinamiche innovative è stata
spesso scartata poiché si affermava che l’Italia non disponeva di un efficiente sistema nazionale
di innovazione, inteso come il classico sistema di innovazione basato su attività di ricerca e
sviluppo e produzione brevettuale. Infatti, come vedremo nei paragrafi successivi, le statistiche
10 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 46-48. 11 N. Crafts, M. Magnani, L’Età dell’Oro e la seconda globalizzazione, in G. Toniolo (a cura di), L’Italia e
l’economia mondiale, dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio Editori, 2013, p. 110. 12 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., p. 200.
44
relative a queste attività sono molto negative se raffrontate con gli altri paesi avanzati;
nonostante questo, i nostri concorrenti europei hanno beneficiato di processi di convergenza
verso il livello di ricchezza degli Stati Uniti meno vigorosi del nostro.
Infatti la nostra economia è risultata, rispetto agli altri paesi avanzati, fatta eccezione per il
Giappone, quella che ha prodotto il più importante processo di convergenza verso il livello di
ricchezza della maggiore economia mondiale, gli Stati Uniti. Per questo motivo, il periodo che
va dal 1950 al 1973, è giustamente chiamato l’Età dell’Oro dell’economia italiana 13 .
L’eccezionalità dei risultati italiani può essere apprezzata nella figura 2.1, dove si vede come,
nel periodo in esame, il PIL pro capite italiano passa da rappresentare il 33% del PIL pro capite
degli Stati Uniti fino ad arrivare al 67%, e passa dal 46% all’87% rispetto a quello del Regno
Unito.
Figura 2.1: Rapporto tra Pil pro capite dell'Italia e quelli di Stati Uniti e Regno Unito, nel periodo 1950-1973
Fonte: mie elaborazioni su dati da Maddison Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/.
La portata eccezionale della performance economica italiana è evidenziata anche dal confronto
tra i tassi di crescita del PIL, nel periodo 1950-1973, delle maggiori economie mondiali. Nella
figura 2.2 si può vedere come solamente la Germania esprima una performance che può essere
13 G. Toniolo, La crescita economica italiana, cit., pp. 31-33; in tale periodo il PIL pro capite aumento mediamente
del 5,3% annuo, la produzione industriale del 8,2% e la produttività del lavoro del 6,2%.
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Italia/ Stati Uniti Italia/Regno Unito
45
paragonata a quella dell’Italia, facendo segnare una crescita del PIL del 5,02% annuo contro
una performance italiana del 5,3%. Tuttavia, bisogna notare la differenza di crescita tra la
Germania e l’Italia nei sotto-periodi 1950-1962 e 1962-1973, che denota come l’Italia abbia
saputo realizzare una performance molto più continua nell’intero periodo. Inoltre bisogna
considerare che la Germania partiva da livelli di distruzione dell’apparato economico molto più
elevati, avendo quindi potenzialmente più possibilità di crescita.
Figura 2.2 Tassi di crescita medi del PIL pro capite nel periodo 1950-1973
Fonte: mie elaborazioni su dati da Maddison Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/.
L’Età dell’Oro italiana è e sarà sempre considerata come esempio di una performance
economica straordinaria, sia per quanto concerne la storia del nostro paese sia a livello globale
nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Questo ventennio ha sancito il definitivo
passaggio dell’Italia da una società agricola ad una fortemente industrializzata, consentendo un
grado di sviluppo tale da far entrare l’Italia nel club dei paesi più ricchi del pianeta.
Nonostante la straordinaria positività del periodo in esame, appare doveroso fare una
considerazione di fondo: il cammino di convergenza è rimasto incompleto. Infatti l’economia
italiana rallenterà fortemente nel ventennio successivo, pur mantenendo un livello di crescita
accettabile, per poi entrare in profonda crisi all’inizio degli anni Novanta.
Per questo motivo appare doveroso analizzare quegli elementi che, già nell’Età dell’Oro,
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Italia Germania Francia Regno Unito Stati Uniti
1950-1962 1962-1973 1950-1973
46
potrebbero aver ostacolato un’ulteriore crescita dell’economia italiana. Innanzitutto sembra
evidente come molte colpe siano da imputare all’incapacità della classe dirigente italiana
(imprenditori, politici, banchieri) di comprendere che ben diverse sono le azioni e le politiche
necessarie quando si è lontani dalla frontiera tecnologica rispetto a quelle che si devono mettere
in atto quando ci troviamo in prossimità di essa, se il nostro obiettivo è quello di continuare il
percorso di sviluppo e mantenere un’elevata performance economica. Infatti il fallimento di
adeguare istituzioni, regolamentazione e dimensione dell’intervento pubblico alle nuove
condizioni create dallo sviluppo del dopoguerra è uno degli elementi alla base delle difficoltà
successive dell’Italia, nonché un fulgido esempio di una caratteristica persistente della politica
economica italiana, la scarsa capacità riformatrice14.
Tra i fattori che porteranno nel periodo successivo al 1973 ad un rallentamento della crescita,
ma che affondano le radici in questo periodo, è da citare il funzionamento delle imprese
pubbliche: nell’Età dell’Oro hanno ben funzionato, allocando le risorse in maniera efficiente ed
agendo da traino allo sviluppo, invece dopo l’avvicinamento dell’Italia alla frontiera
tecnologica esse sono diventate sacche di inefficienza e di giochi di potere15.
Il mancato sviluppo di un solido sistema finanziario, soprattutto in termini di mercato azionario,
è stato sicuramente un altro fattore limitante. Infatti quando le imprese hanno diminuito il
reinvestimento degli alti profitti degli anni Sessanta, non trovando fonti alternative di
finanziamento, hanno diminuito gli investimenti che sono crollati dall’11% del periodo 1956-
1963 al 5% del periodo 1963-197216.
Anche dal lato dell’offerta di lavoro, arrivano, nel 1962, le prime avvisaglie di rialzo dei salari,
anticipatori del forte rialzo salariale che comincerà nel 1969. Questi rialzi sono dovuti alla fine
dell’offerta “illimitata di lavoro” e al maggior potere e consapevolezza che avevano acquisito i
sindacati. La competitività delle imprese viene fortemente danneggiata da queste dinamiche,
poiché i salari cominciano a crescere più della produttività.
Applicando all’Italia il concetto di convergenza delle dimensioni del sistema elaborato da
Freeman, illustrato nel primo capitolo, si può considerare l’eccezionale performance italiana
come dovuta ad una condizione di forte convergenza tra le varie dimensioni che sono co-evolute
14 N. Crafts, M. Magnani, L’Età dell’Oro e la seconda globalizzazione, cit., pp. 114-115. 15 F. Barca, K. Iwai, U. Pagano, S. Trento, Postwar Istitutional Reform: The Divergence of Italian and Japanese
Corporate Governance Models, Dipartimento di Economia Politica dell’Università degli Studi di Siena,
Working Papers no. 234, 1998, pp. 34-35. 16 N. Crafts, M. Magnani, L’Età dell’Oro e la seconda globalizzazione, cit., pp. 113-114.
47
assieme, determinando la crescita complessiva del sistema17 . Raggiunto però, un livello di
ricchezza elevato, l’Italia non ha saputo cambiare per adeguarsi alle nuove condizioni che
derivano dal fatto di essere un paese avanzato. Infatti, da allora le varie dimensioni hanno
cominciato a svilupparsi lungo traiettorie divergenti, ostacolando la crescita.
Terminata la ricostruzione e raggiunto un livello di benessere elevato ci siamo seduti sugli allori
culturalmente e politicamente, non comprendendo che la nostra situazione avrebbe richiesto
una nuova opera di cambiamento strutturale che, se realizzata, avrebbe posto le basi per
continuare un’elevata crescita economica e il processo di rafforzamento della posizione globale
dell’Italia.
1.3 Il rallentamento dell’economia italiana
L’anno 1973 è considerato dagli storici economici come un punto di svolta di tutta l’economia
mondiale. Allo stesso modo viene considerato come l’anno della fine dell’Età dell’Oro italiana
e l’inizio del periodo di rallentamento della crescita. Nonostante alcune dinamiche negative
fossero già presenti negli anni precedenti, è nel 1973, con lo shock petrolifero, che si inizia a
sperimentare un forte rallentamento del tasso di crescita e l’avvio di una pesante dinamica
inflattiva. Questo, unito alle tensioni sociali e alla fine della stabilità delle condizioni
internazionali, inizia a mettere a nudo le forti criticità del sistema italiano.
In tale periodo si esauriscono molti fattori che avevano contribuito alla stabilità del sistema:
finisce la disponibilità di materie prime a buon mercato, soprattutto del petrolio, che faceva
mantenere ai paesi occidentali buone ragioni di scambio; finisce, con lo sgretolarsi del sistema
di Bretton Woods, il periodo di stabilità sul mercato internazionale dei cambi che torna ad essere
altamente incerto; si esaurisce la riserva di manodopera che consentiva di mantenere dinamiche
salariali favorevoli alle imprese.
Nonostante il brusco rallentamento, l’Italia riesce a mantenere buoni tassi di crescita del PIL,
soprattutto in raffronto agli altri paesi avanzati. Riesce, inoltre, a continuare il processo di
convergenza verso il livello di Pil pro capite dei paesi europei, mentre la dinamica nei confronti
17 La tecnologia da incorporare si adattava perfettamente al contesto produttivo italiano, alla dotazione di fattori e
alla presenza di buoni ingegneri. La politica favoriva questo processo aumentando le possibilità di scambi
internazionali. Culturalmente l’Italia, dopo il Ventennio Fascista e la guerra, voleva dimostrare di poter
crescere e svilupparsi, con la conseguenza che tutti i cittadini producevano uno sforzo in tale direzione. Sono
molti altri gli esempi di come le varie dimensioni si sono reciprocamente rafforzate.
48
degli Stati Uniti subisce una stabilizzazione. Come possiamo vedere dal grafico 2.3, l’Italia
riesce, in questo periodo, addirittura a raggiungere il livello di reddito pro capite del Regno
Unito, mantenendosi poi attorno alla parità. Invece nei confronti degli USA riesce ad ottenere
solo un lieve miglioramento nell’intero periodo, passando dal 66,2% del 1974 al 70,3% del
1990.
Figura 2.3: Rapporto tra Pil pro capite dell'Italia e quelli di Stati Uniti e Regno Unito, nel periodo 1973-1990
Fonte: mie elaborazioni su dati da Maddison Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/.
Anche in termini di tassi di crescita del PIL, come si vede dalla figura 2.4, l’Italia riesce ad
avere performance migliori dei suoi partner europei e degli Stati Uniti. Infatti, in Italia, il PIL
cresce mediamente del 2,5% annuo, contro prestazioni degli altri paesi considerati che oscillano
tra l’1,5% e il 2% annuo. Quindi, nonostante il vistoso rallentamento, l’Italia continua a
mantenere elevati tassi di crescita, che riescono a farle raggiungere la posizione di quinta
economia mondiale per grandezza del PIL.
Sebbene questi dati sembrino far trasparire una situazione rosea, almeno in una prospettiva
comparata, è nel rallentamento di questo periodo e nelle condizioni sistematiche che si vanno a
delineare che bisogna ricercare le cause della pesante crisi in cui l’Italia entrerà a partire dagli
anni Novanta.
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Italia/Stati Uniti Italia/Regno Unito
49
Figura 2.4: Tassi di crescita annui medi del PIL, periodo 1974-1990
Fonte: mie elaborazioni su dati da Maddison Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/.
Infatti gli shock petroliferi ed energetici hanno forse conseguenze peggiori per l’Italia che per
altri paesi, poiché essi, assieme alle fortissime pressioni salariali, producono una spirale
inflattiva a due cifre che si affievolirà solamente dopo l’adesione dell’Italia al Sistema
Monetario Europeo.
Inoltre, dal 1968, comincia una stagione di proteste sindacali che avrà come conseguenza quella
di porre fine a quel circolo virtuoso per mezzo del quale i salari crescevano meno della
produttività, favorendo la competitività delle imprese. I sindacati accrescono molto il loro
potere rispetto agli anni precedenti, raggiungendo tassi di partecipazione e mobilitazione molto
elevati18. La conseguenza è che, crescendo i salari più della produttività, la competitività delle
imprese diminuisce sensibilmente. Basti pensare che il costo del lavoro per ora lavorata nel solo
periodo che va dal 1968 al 1978 è aumentato del 450%19.
Una classe politica debole, non riuscendo a contrastare le proteste di sindacati ed imprese, prova
ad affievolirle aumentando notevolmente le risorse destinate al welfare e agli incentivi per le
18 A. Boltho, Italia, Germania e Giappone. Dal miracolo economico alla semistagnazione, in G. Toniolo, L’Italia
e l’economia mondiale, dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio Editori, 2013, pp. 172-173; gli iscritti al sindacato
in percentuale dei lavoratori passano dal 24,7% del 1960 al 49,6% del 1980, gli scioperi divengono
frequentissimi, si stima che per mille lavoratori in quegli anni siano stati in media 1500 i giorni di lavoro persi
a causa degli scioperi, confronto impietoso rispetto alla Germania, dove nello stesso periodo il dato si aggira
in media attorno ai 50 giorni. 19 V. Castronovo, Storia economica d’Italia: dall’Ottocento ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 2013, pp. 368-379.
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
Italia Germania Francia Regno Unito Stati Uniti
1974-1981 1981-1990 1974-1990
50
imprese, al sistema pensionistico e ai salari dei dipendenti pubblici. Tutto questo avviene per
mezzo di una notevole espansione della spesa pubblica, senza che ci si preoccupi dei possibili
effetti negativi a lungo termine 20 . Questo aumento incontrollato della spesa pubblica fa
aumentare l’entità dei deficit nel bilancio dello Stato, con la conseguenza che il debito pubblico
inizia ad aumentare vorticosamente. Nemmeno il “divorzio” tra la Banca d’Italia ed il Tesoro
del 1981 riuscirà a contrastare questo aumento senza controllo del debito; infatti basta pensare
che, solamente nel corso degli anni Ottanta, il debito pubblico italiano in rapporto al Pil sale
dal 56% al 94%21.
Le imprese pubbliche, perso il ruolo trainante ricoperto nei primi anni dopo la guerra, divenute
ormai oggetto di spartizioni politiche e giochi di potere, cominciano ad avere performance
nettamente negative e ad accumulare livelli di indebitamento eccessivo 22 . Ormai l’impresa
pubblica non rappresenta più un fattore di sviluppo per il sistema ma, piuttosto, un fardello con
cui bisogna fare i conti.
Anche le imprese private, durante gli anni Settanta, vedono crescere il loro indebitamento in
maniera velocissima, necessitando di livelli sempre maggiori di finanziamento. Ma, visto che
il canale del ricorso al capitale azionario non si è sviluppato in modo efficiente, le imprese sono
costrette a ricorrere alle sole banche, con la conseguente necessità di destinare un’ingente mole
di risorse per pagare gli interessi sul debito bancario. Quindi la grande industria italiana si trova
nella situazione di destinare la maggior parte delle proprie risorse per ripagare il debito e per
far fronte ai continui aumenti salariali, sottraendo così risorse destinate agli investimenti, che
di fatto calano fortemente nel periodo23.
Sempre in questi anni si compie un’altra trasformazione nella struttura produttiva italiana,
dovuta ad una crescita notevole del settore dei servizi, che all’inizio degli anni Novanta vede
tra le sue file più del 60% degli occupati totali 24 . Ma l’incremento del peso dei servizi
20 A. Boltho, Italia, Germania e Giappone, cit., pp. 161-163; i politici hanno cercato di “comprare” la pace sociale
senza preoccuparsi delle ricadute macroeconomiche che questa gestione scellerata avrebbe prodotto nel lungo periodo. In un confronto con la Germania ed il Giappone appare come i sindacati di questi paesi, pur
affrontando problemi simili, si dimostrarono molto più consci dei vincoli macroeconomici. 21 Banca d’Italia, http://bip.bancaditalia.it/4972unix/homebipentry.htm?dadove=corr&lang=ita. 22 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., pp. 366-370; basti pensare che nel 1978 le imprese controllate
dall’IRI avevano un indebitamento superiore al proprio fatturato. 23 N. Rossi, G. Toniolo, Italy, cit., pp. 427-430; si passa da una crescita media degli investimenti in attrezzature in
doppia cifra per l’intero periodo 1951-1973 ad una crescita del 2,6% nel periodo 1974-1990, con una crescita
nulla degli investimenti in costruzioni. 24 N. Crafts, M. Magnani, L’Età dell’Oro e la seconda globalizzazione, cit., p. 118; partendo da poco più del
40% dell’inizio anni Settanta, questo calcolo comprende la pubblica amministrazione.
51
nell’economia non è stato accompagnato da un’uguale dinamica nella produttività. Difatti la
crescita della produttività in tale settore collassa, passando dal 4,9% del periodo 1953-1973 ad
un misero 0,4% nel periodo 1973-199325. Inoltre tale settore è caratterizzato da un’assenza di
esposizione alla competizione internazionale, situazione per la quale si ha una bassa qualità dei
servizi accompagnata però da prezzi elevati26.
Quindi, visti gli scarsi risultati della grande impresa pubblica e privata e la scarsa produttività
del settore dei servizi, sorge spontanea la domanda su come sia stata possibile una performance
di crescita abbastanza positiva dell’Italia. La risposta è da ricondurre allo sviluppo di numerose
piccole e medie imprese, soprattutto nel settore manifatturiero, flessibili e competitive, che
hanno visto accrescere il loro peso nell’economia italiana.27
Le piccole e medie imprese sono state il motore principale della performance italiana durante
questo periodo, controbilanciando gli scarsi risultati della grande industria, in termini di
produttività, di investimenti, dinamiche innovative, produzione e profitti28 . La nascita delle
piccole e medie imprese è stata favorita anche dal processo di ristrutturazione delle grandi
imprese, avvenuto all’inizio degli anni Ottanta. Spronate dall’alto costo del lavoro, alcune
grandi imprese, attraverso il decentramento produttivo in unità più piccole, il superamento della
rigidità della catena di montaggio e gli investimenti in macchinari fortemente labour saving,
riescono a cambiare volto alla propria struttura. Questa ristrutturazione influisce positivamente
sulla successiva performance delle industrie che la portano avanti, ma comunque si continua a
non affrontare alcune problematiche: si insiste nel trascurare elementi importanti che
influiscono sulla produttività, come la R&S, la formazione lavorativa e l’efficienza dei servizi29.
In secondo luogo bisogna considerare che in questa ristrutturazione non sono rientrate le
industrie pubbliche. Inoltre viene persa l’occasione per rilanciare imprese in crisi nei settori a
media-alta tecnologia in cui l’Italia è presente, come la chimica e l’elettronica, come
25 S.N. Broadberry, C. Giordano, F. Zollino, La produttività, cit., p. 263, pp. 282-285; producendo performance
molto minori di Germania e Usa, ma comunque migliore rispetto al Regno Unito. 26 N. Rossi, G. Toniolo, Italy, cit., pp. 446-447. 27 A. Boltho, Italia, Germania e Giappone, cit., pp. 165-167; dal 1961 fino al 2001 il trend è sempre risultato di
crescita, passando dal 26,4% di imprese (tra gli 11 e 99 dipendenti) sul totale delle imprese del manifatturiero
al 41,8% del 2001. Ma il periodo con la crescita maggiore è stato quello tra il 1971 e il 1991 in cui tali imprese
sono aumentate di più del 10%. 28 L. Burroni, C. Trigilia, Italy: Rise, Decline and Restructuring of a Regionalized Capitalism, in Economy and
Society, no. 38, 2009, pp. 635-638; la crescita del periodo può essere attribuita allo svilupparsi della Terza
Italia (Centro, Nord-est), contrapposta al Nord-Ovest di classica industrializzazione, e al Sud. Nella Terza
Italia si sviluppano una miriade di PMI flessibili e competitive nei settori tradizionali ma anche in settori
moderni, come la meccanica ingegneristica e i macchinari. 29 N. Rossi, G. Toniolo, Italy, cit., pp. 446-448.
52
esemplificato dai casi della Montedison e dell’Olivetti30.
Un altro punto di debolezza del sistema Italia che emerge in questo periodo, ma che risulterà
nel tempo sempre maggiore, è quello delle diseconomie esterne, vale a dire le disfunzioni più
o meno gravi e l’arretratezza delle infrastrutture e delle reti. Tutto ciò, unito all’inefficienza dei
servizi essenziali per le industrie, non crea certo un ambiente ideale per lo sviluppo delle
imprese. Difatti, nel periodo descritto, l’Italia figura nelle posizioni di retroguardia delle
classifiche che valutano il sistema infrastrutturale e delle reti all’interno dell’allora CEE31.
In conclusione si può affermare che questa fase, per l’Italia, è da considerarsi in maniera
positiva se guardiamo solamente ai risultati raggiunti in termini di crescita del PIL, mentre è da
considerarsi in un’ottica completamente differente se consideriamo una prospettiva di lungo
termine. È chiaro come le caratteristiche sistemiche dell’economia italiana, che si delineano
lungo questo arco di tempo, la rendono inadatta ad affrontare con successo la rivoluzione delle
tecnologie della comunicazione e dell’informatica, rendendole impossibile continuare il
processo di crescita. È in questo periodo che l’Italia perde terreno nei nascenti settori strategici
a medio-alto contenuto tecnologico, relegando la specializzazione dell’economia ai settori
tradizionali e a quelli a media-bassa tecnologia, lontani dalla frontiera tecnologica32. Si può dire
che la crescita economica di questo periodo ha rappresentato una sorta di velo di Maya33 che ci
ha fatto trascurare, non affrontandoli, i problemi strutturali dell’Italia.
30 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., pp. 370-371; la Montedison ed il settore chimico produssero una
buona performance in termini di crescita e di attività innovativa negli anni dell’Età dell’Oro, per poi vedere deteriorare la loro posizione nel periodo del rallentamento. L’industria elettronica, invece, aveva mostrato
sforzi importanti in termini di R&S e acquisizione tecnologica dall’estero negli anni Sessanta, ma tali sforzi
produssero scarsi risultati, condannando l’Italia ad essere tecnologicamente dominata in tale settore. 31 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., pp. 385-386; tali vischiosità risultavano ancora più gravi poiché
riducevano l’efficienza generale del sistema economico, in un momento in cui la competitività internazionale
era sempre più legata con la crescita del settore terziario e la sua interconnessione con il mondo industriale. 32 C. Antonelli, Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 251-253. 33 Concetto derivato dalla filosofia indiana usato da Schopenhauer che sta a dire che tra la realtà delle cose e quello
che noi vediamo c’è un ostacolo, uno schermo che ci impedisce di cogliere l’effettiva realtà. La nostra visione
della realtà è una mera illusione.
53
2 Il sistema d’innovazione italiano
Nel paragrafo precedente è stata descritta la performance economica dell’Italia del periodo che
va dal dopoguerra al 1990, constatando come, in questo arco di tempo, essa abbia compiuto
passi da gigante nella posizione internazionale e compiuto una profonda trasformazione
strutturale che, da società agricola, l’ha trasformata in una potenza industriale. Contestualmente,
però, è stato anche notato come in questo periodo sono emerse numerose contraddizioni interne
e fattori di preoccupazione che ostacoleranno, negli anni successivi al 1990, il tentativo
dell’Italia di mantenere la posizione internazionale raggiunta.
In questo paragrafo viene mostrato come la crescita italiana sia stata trainata da una notevole
attività innovativa, nonostante le statistiche con le quali abitualmente si misura tale attività,
ovvero le spese in R&S e la produzione brevettuale relative all’Italia, siano molto negative se
raffrontate con gli altri paesi avanzati.
Usando i dati della contabilità della crescita, viene mostrata l’evoluzione della Produttività
Totale dei Fattori italiana, per determinare quanta parte della crescita economica italiana non
scaturisce da un aumento nella dotazione dei fattori lavoro e capitale, ma è attribuibile ad altri
fattori, tra i quali viene ritenuto predominante l’innovazione tecnologica.
Successivamente tramite un corpo eterogeneo di statistiche viene introdotta l’analisi del
processo innovativo in Italia e vengono descritte le sue peculiarità.
2.1 Arretratezza, cambiamento strutturale o innovazione?
Molti studiosi hanno affermato che la notevole performance economica italiana del dopoguerra
è stata possibile grazie all’ampiezza delle possibilità di convergenza presenti dopo il secondo
conflitto mondiale, vale a dire grazie all’arretratezza nei confronti del paese più avanzato,
ovvero gli Stati Uniti.
L’arretratezza può, talvolta, costituire un vantaggio per avviare un processo di convergenza
verso il paese leader o i paesi più avanzati. Infatti, in tale processo, i paesi inseguitori hanno la
possibilità di introdurre la tecnologia in uso nel paese dominante senza sostenere i costi relativi
al suo sviluppo, aumentando velocemente e notevolmente la propria efficienza. Ma deve essere
chiaro che una simile dinamica di convergenza non è in alcun modo automatica e, anche qualora
54
si verifichi, non produce gli stessi risultati in paesi differenti34 . Inoltre, in molti casi, si è
verificato che un paese che partiva dall’arretratezza ha visto svilupparsi nei confronti dei paesi
più avanzati processi di polarizzazione che hanno avuto il risultato di ampliare il divario
piuttosto che ridurlo. In questo modo la tesi sull’automaticità della convergenza è
empiricamente negata.
Sono molti i fattori che devono sussistere per poter sfruttare i processi di convergenza, fra essi
quelli che sembrano ricorrere più frequentemente in casi del genere sono: un elevato livello di
investimenti, una dotazione quantitativa e qualitativa di capitale umano adeguato, un mercato
esteso e differenziato e una rete abbastanza sviluppata di commercio con l’estero,
particolarmente con i paesi più sviluppati. Oltre a questi fattori, devono essere presenti nel paese
quelle social capabilities35 fondamentali per attivare i processi di convergenza e consentire di
assorbire le tecnologie più avanzate. Queste “capacità sociali”, come le definisce Abramovitz,
sono rappresentate dal livello di sviluppo delle competenze tecniche e dalla qualità delle
istituzioni politiche, commerciali, industriali e finanziarie36.
Esiste un altro elemento importantissimo per attivare un processo di convergenza, vale a dire la
congruenza tecnologica tra il paese avanzato e quello inseguitore. Ovvero la tecnologia del
paese leader deve trovare nel paese inseguitore le condizioni per poter funzionare
efficientemente. Quindi è necessario che alcune dimensioni come ampiezza e omogeneità dei
mercati, pattern della domanda, dotazioni fattoriali, disponibilità di risorse naturali, scala di
produzione siano adatte alla tecnologia che si importa, poiché in mancanza di tale congruenza
sarebbe difficile per il paese inseguitore introdurre e sfruttare i vantaggi derivanti dalle
tecnologie avanzate del paese leader37.
Tra le social capabilities necessarie un posto di rilievo è sicuramente occupato dalle capacità di
assorbimento e di apprendimento di una determinata tecnologia, che determinano la possibilità
di un paese di sfruttare la tecnologia prodotta all’estero, oltre che la capacità di sviluppare
internamente conoscenza. Questa capacità dipende in maniera cruciale dalla qualità e dalla
34 J. Fagerberg, Technology and International Differences in Growth Rates, in Journal of Economic Literature, Vol.
32, no. 3, 1994, pp. 1156-1159. 35 M. Abramovitz, Catching up, Forging Ahead, and Falling Behind, in Journal of Economic History, Vol. 46, no.
2, 1986, pp. 405-406. 36 F. Barbiellini Amidei, J. Cantwell, A. Spadavecchia, Innovazione e tecnologia straniera, in G. Toniolo (a cura
di), L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio Editori, 2013, pp. 526-529. 37 M. Abramovitz, The Origins of the Postwar Catch-Up and Convergence Boom, in J. Fagerberg, B. Verspagen,
N. von Tunzelmann (a cura di), The Dynamics of Technology, Trade and Growth, Aldershot, Elgar, 1994, pp.
23-26.
55
quantità di capitale umano disponibile in un dato paese.
Quindi, invece di assumere che la crescita economica italiana sia stata un processo automatico,
bisogna concentrarsi sui fattori che l’hanno resa possibile. Utilizzando strumenti di Contabilità
della crescita, si può determinare quale sia stato il ruolo dei fattori lavoro e capitale e quale
quello della TFP. Nel caso italiano emerge che un ruolo notevole è attribuibile alla TFP, in
misura molto maggiore, come vedremo nel prossimo paragrafo, rispetto a tutti gli altri paesi
avanzati.
Sono due le tesi più gettonate per spiegare questo forte aumento della TFP. La prima è quella
che la collega al cambiamento strutturale dell’economia italiana, mentre la seconda è quella che
la fa risalire alle dinamiche innovative. Secondo i fautori della tesi del cambiamento strutturale,
l’aumento della TFP sarebbe da ricondurre allo spostamento di lavoratori dal settore agricolo,
caratterizzato da bassa produttività, verso il settore industriale a più alta produttività, che ha
fatto crollare gli addetti dall’agricoltura, passati dal 44,3% del totale nel 1951 al 17,7% del
197338. Producendo la maggior parte dell’aumento di efficienza complessiva del sistema.
Diversi autori hanno provato una misurazione di tale fenomeno, cercando specificatamente di
quantificare l’effetto che il cambiamento strutturale ha avuto sui tassi di crescita annui della
produttività del lavoro. Crafts, Magnani (2013), riprendendo i dati degli Studi di van Ark (1996)
e Broadberry (1998), affermano che il cambiamento strutturale abbia avuto un effetto positivo
sull’aumento della produttività compreso tra lo 0,80% e l’1,80% annuo, nel periodo 1950-1973,
a fronte comunque di una crescita annua della produttività maggiore del 5%39.
Secondo Broadberry, Giordano, Zollino (2013), l’effetto del cambiamento strutturale è stato
nell’ordine del punto percentuale sia nel periodo 1951-1973 che nel periodo 1973-1993.
Ridimensionando il ruolo del cambiamento strutturale, questi autori affermano che sia stata la
crescita all’interno dei settori, trainata dalle dinamiche innovative, a influenzare maggiormente
la crescita della TFP.
Antonelli, Barbiellini Amidei (2007) giungono a considerazioni analoghe, riducendo nei loro
calcoli ancora di più il ruolo che avrebbe avuto il cambiamento strutturale. Allora, senza
sminuire l’importanza del cambiamento strutturale, ma attribuendogli il giusto peso, è
necessario evidenziare come la crescita della TFP sia maggiormente attribuibile alle dinamiche
38 S.N. Broadberry, C. Giordano, F. Zollino, La produttività, cit., pp. 278-279. 39 N. Crafts, M. Magnani, L’Età dell’Oro e la seconda globalizzazione, cit., pp. 106-107.
56
innovative presenti nell’economia italiana, soprattutto in alcuni settori chiave che hanno fatto
registrare performance elevate lungo tutto il periodo considerato. A questo punto bisogna
assumere, non solo che l’innovazione sia un elemento importante nella spiegazione della
performance economica italiana, ma che essa ne sia un elemento centrale.
Ora si rende necessario indagare su come si siano svolti questi processi innovativi e quali siano
state le loro peculiarità. Poiché, come già anticipato, se considerassimo solamente le attività
riconosciute abitualmente come portatrici di innovazione, cioè Ricerca e Sviluppo e attività
brevettuale, non si potrebbe affermare che queste dinamiche siano centrali nella spiegazione
della crescita economica italiana, vista la differenza che intercorre tra i livelli di tali attività
dell’Italia e quelli degli altri paesi avanzati.
2.2 Misurare l’innovazione
Nonostante i limiti ed i dubbi che gravano sull’impiego della misurazione della TFP, essa
rimane largamente usata, essendo una delle poche misure in grado di cogliere gli effetti
dell’attività innovativa nel sistema economico. Infatti quasi tutte le statistiche utilizzate per
descrivere l’attività innovativa sono relative ai suoi input e si riferiscono, ognuna di esse, solo
a specifiche parti dell’attività innovativa stessa. Molto più difficile, in un sistema economico
complesso, è isolare gli effetti di questi input. Invece la TFP ci consente di stimare, in via
approssimativa, il risultato di tutta l’attività innovativa nel sistema economico. Quindi mi
sembra giusto usarla, così come fanno la maggior parte degli economisti, al fine di stimare
quanto l’innovazione ha influito sullo sviluppo economico italiano.
Allora se si può considerare la crescita della TFP come una misura abbastanza affidabile del
risultato del processo innovativo nel sistema economico, procediamo con lo studio delle sue
dinamiche temporali in Italia e in alcuni paesi europei. Facendo questo abbiamo la possibilità
di respingere un’altra tesi che minimizzava il ruolo dell’innovazione nel processo di crescita,
ovvero quella che ipotizzava il processo di convergenza come derivante essenzialmente dalla
crescita della dotazione di capitale. Essendo la TFP calcolata in via residuale, tolti il contributo
del capitale e del lavoro alla crescita, è facile affermare che la TFP è stata più importante
dell’aumento della dotazione di capitale, anche se in questo caso tra i due fenomeni c’è stata
forte complementarietà, poiché, come vedremo successivamente, l’importazione di macchinari
57
con tecnologia incorporata avanzata ha avuto ruolo fondamentale per le dinamiche innovative
italiane40.
Tabella 2.1: Tasso di crescita del Prodotto Reale, TFP e contributo della TFP alla crescita del prodotto in
Italia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna E Stati Uniti, nei sottoperiodi 1951-1990
Italia Francia Germania Giappone
Gran Bre-
tagna Stati Uniti
1951-1973
Prodotto (reale) 5,2 5,6 6,3 9,8 3,7 3,7
TFP 3,4 3,1 3,5 4,1 1,9 1,2
Contributo della TFP alla
crescita del prodotto
64,3 56,1 55,1 41,4 51,4 31,5
1960-1990
Prodotto (reale) 4,1 3,5 3,2 6,8 2,5 3,1
TFP 2 1,5 1,6 2 1,3 0,4
Contributo della TFP alla
crescita del prodotto
47,9 41,4 49,4 28,8 51,9 13,2
Fonte: C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., p. 200.
Per un confronto internazionale ho trovato dati che non coincidono perfettamente con la
partizione temporale che ho proposto, ma riescono perfettamente a dare un’idea delle
prestazioni dell’Italia nei confronti dei maggiori paesi avanzati. Quello che emerge, analizzando
l’andamento internazionale della TFP dal dopoguerra fino agli anni Novanta41, è che l’Italia
risulta il paese in cui la crescita della TFP influisce maggiormente sull’aumento del PIL,
soprattutto nel periodo dell’Età dell’Oro. Infatti, come si può vedere dalla tabella 2.1, anche se
40 Ma l’aumento dei livelli di capitale può avvenire senza che essi costituiscano mezzi per l’innovazione, poiché
potrebbero non incorporare tecnologia avanzata che rappresenta un’innovazione. Inoltre guardando alle
statistiche elaborate da Broadberry, Giordano, Zollino (2013) vediamo che il ruolo dell’aumento di capitale
per occupato ha un ruolo nettamente minore nel spiegare la crescita della produttività del lavoro nel periodo
rispetto a quello della TFP. 41 Per i dati sul tasso di crescita della TFP degli Stati della Tabella 2.1 mi sono affidato ai dati proposti da [1] C.
Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., p. 200; effettuando una verifica
incrociata con i dati proposti da [2] N. Crafts, G. Toniolo, Postwar growth: an overview, in N. Crafts, G.
Toniolo, Economic Growth in Europe since 1945, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 8-10. I
dati coincidono nell’identificazione dei trend e nella misura, tranne che per l’Italia dove c’è una sovrastima
proporzionale in entrambi i periodi da parte di [2], di circa il 40% rispetto alle misure inserite in tabella.
58
l’Italia nel periodo 1951-1973 non ha la TFP maggiore in valore assoluto, risulta comunque il
paese in cui essa contribuisce in misura maggiore all’aumento del PIL. Inoltre, nel lungo
periodo successivo, che va dal 1960 al 1990, la crescita della TFP italiana, nonostante un vistoso
rallentamento, è la più alta assieme a quella del Giappone, con un contributo percentuale
all’evoluzione del PIL ancora alto.
Il fatto che, in entrambi i periodi, la crescita della TFP è da considerare la maggiore responsabile
dell’aumento del PIL, potrebbe essere spiegato affermando che l’efficienza totale del sistema è
aumentata fortemente grazie all’innovazione, maggiormente rispetto agli altri paesi.
Gli Sati Uniti sono quelli con il contributo minore poiché, essendo il paese leader, si trovavano
già in condizioni di prossimità alla frontiera tecnologica42.
Tabella 2.2: Tasso di crescita della TFP, e Quota della crescita del valore aggiunto spiegata da diversi fattori:
lavoro, capitale, TFP, 1951-1988
Tasso crescita TFP
Quota della crescita del Valore Aggiunto spiegata da:
Lavoro Capitale TFP
1951-1963 3,6 16,4 25,2 58,4
1951-1973 3,3 9,8 29,3 60,9
1964-1973 2,9 7,8 40,2 52,1
1974-1988 1,0 22,5 43,1 34,4
Fonte: C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 202-203.
Per addentrarci nell’analisi dell’Italia possiamo proporre, nella Tabella 2.2, un’altra partizione
temporale, più consona alla periodizzazione che abbiamo adottato precedentemente. Guardando
a quali fattori tra lavoro, capitale e TFP abbiano influito maggiormente sulla crescita del valore
aggiunto italiano43, possiamo notare ancora di più la differenza nel passaggio tra i due periodi:
42 Infatti è più difficile innovare quando si è alla frontiera poiché bisogna modificarla per ottenere delle innovazioni
ulteriori, non essendo possibile acquisire tecnologia più avanzata in altri paesi perché non è presente, visto che
è la nostra quella più avanzata. Inoltre negli Stati Uniti la TFP è stata elevata in molti periodi del secolo scorso,
coerentemente con il fatto che la crescita è stata trainata da ondate di innovazioni successive e le frontiere
tecnologiche venivano spinte sempre più avanti. 43 Per i dati sul tasso di crescita della TFP italiana dei periodi considerati mi sono affidato ai dati proposti da [1]
C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 202-203; effettuando una
verifica incrociata con i dati di altri due serie di dati proposte da [2] N. Crafts, G. Toniolo, Postwar growth:
an overview, cit., pp. 8-10; e [3] S.N. Broadberry, C. Giordano, F. Zollino, La produttività, cit., pp. 295-302.
Mentre per le fonti [1] e [3] c’è praticamente perfetta coincidenza nei dati, in [2] c’è una sovrastima, del 35-
36% in entrambi i periodi, che però non altera l’evidenza del trend nei diversi periodi.
59
l’Età dell’Oro, dove la crescita della TFP è vigorosa, 3,3% annuo, e spiega la maggior parte
dell’aumento del valore aggiunto, e la fase del rallentamento dove la dinamica della TFP crolla,
1,1% annuo, assieme alla diminuzione della percentuale di crescita del valore aggiunto spiegata
dalla TFP.
Le dinamiche del periodo del rallentamento possono essere così spiegate: il contributo del
capitale aumenta grazie ai massicci investimenti derivanti dal processo di ristrutturazione
portato avanti dalle industrie italiane, avvenuto tramite l’introduzione di macchine fortemente
labour saving, che consentono di poter usare meno fattore lavoro, diventato terribilmente caro.
Invece, il contributo maggiore del lavoro alla crescita del valore aggiunto, potrebbe essere
spiegato come l’effetto del passaggio di molti lavoratori al settore dei servizi.
Comunque, il ruolo del lavoro risulta sempre marginale, in tutto il periodo che va dal
dopoguerra al 1990, se confrontato con gli altri paesi avanzati, poiché in tutto l’arco di tempo
non si registrano apprezzabili miglioramenti nella qualità del capitale umano44.
Visto che l’aumento della TFP è essenziale per spiegare il tasso di crescita economica italiana
e che la maggior parte di questo aumento dipende alle dinamiche innovative che il sistema
economico italiano ha saputo produrre, proseguo la trattazione con l’analisi delle attività che
possono essere state promotrici di tale innovazione.
2.3 L’attività di Ricerca e Sviluppo
Le statistiche relative alle spese in Ricerca e Sviluppo (R&S) sono state ritenute, per molto
tempo, l’indicatore più importante per valutare l’attività innovativa, sia a livello di impresa che
di paese. Tuttavia, negli ultimi anni, è stato giustamente riconosciuto che esse sono utili per
descrivere solamente una parte della più complessa gamma di attività intraprese allo scopo di
produrre conoscenza tecnologica e introdurre innovazioni tecnologiche nel sistema economico.
Infatti le statistiche relative a queste spese sono più idonee a descrivere lo sforzo innovativo
intrapreso dalle grandi imprese e dai laboratori di ricerca, piuttosto che l’attività delle PMI,
all’interno delle quali prevalgono attività innovative non formalizzate.
44 C. Dougherty, D.W. Jorgenson, International Comparisonons of the Sources of Economic Growth, in The
American Economic Review, Vol. 86, no.2, 1996, pp. 25-29; nel periodo 1960-1989 la crescita dovuta ad un
miglioramento della qualità del lavoro è pari al 3,4%, che risulta essere una percentuale nettamente inferiore
a tutti i paesi G7, che superano tutti il 10%, fatta eccezione per la Germania, che comunque si attesta all’8,9%.
60
Le serie statistiche riguardanti le spese in R&S dell’Italia, disponibili dal 1963 in poi, sono
utilissime per confermare la periodizzazione dell’andamento economico italiano proposta nel
primo paragrafo e per cogliere quella che è una caratteristica di lungo periodo dell’economia
italiana, ovvero la scarsità di risorse destinate alla R&S in confronto agli altri paesi avanzati.
Analizzando l’evoluzione temporale di tali spese in rapporto al PIL, figura 2.5, risulta chiaro
come sia possibile distinguere chiaramente alcune fasi. Tra il 1963-1973 si registrano evidenti
segni di vitalità con una crescita costante delle spese in R&S che arrivano a rappresentare lo
0,8% del PIL, sintomo di uno sforzo volto a dotare l’Italia di una propria base tecnologica. Però
questo tentativo viene presto interrotto visto che, nel proseguo degli anni Settanta, le spese di
R&S smettono di crescere, facendo registrare un’elevata volatilità. Negli anni Ottanta si verifica
un processo di crescita continua che riesce a portare la quota di spese fino all’1,25% nel 1990.
Questo trend positivo viene bruscamente interrotto da una forte decrescita all’inizio degli anni
Novanta che riporta il rapporto al di sotto del punto percentuale. Con il secondo lustro degli
anni Novanta la caduta si arresta e comincia una lieve risalita, si raggiunge un livello comunque
insufficiente per un paese che ambisce a rimanere una delle economie più avanzate a livello
globale.
Figura 2.5: Spese in R&S in % sul PIL, periodo 1963-2007
Fonte: mie elaborazioni su dati ISTAT, L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010, Roma, ISTAT, 2011, pp. 837-840.
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
Spese in R&S/PIL
61
La periodizzazione che emerge è coerente con quella già delineata per il fenomeno di
convergenza verso il livello di ricchezza degli Stati Uniti: la rincorsa dell’Età dell’Oro, la
crescita della turbolenza e, infine, il riaprirsi del divario negli anni Novanta.
La diminuzione drastica delle spese di R&S dell’ultimo decennio del secolo avviene in un
momento cruciale, ovvero quando il cambiamento tecnologico aumenta di intensità e le
opportunità tecnologiche si moltiplicano. Per questo è possibile parlare di occasione perduta e
di un chiaro segnale di debolezza del sistema economico italiano, poiché per sfruttare tali
opportunità sarebbe stato necessario aumentare notevolmente le spese destinate alla R&S, non
ridurle.
Figura 2.6: Spese in R&S sul totale del PIL, periodo 1962-1991
Fonte: mie elaborazioni su dati OECD, http://stats.oecd.org/; C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e
mutamento strutturale, cit., pp. 74-75; per i dati precedenti al 1981.
Nel confronto internazionale l’Italia non si caratterizza certamente per una buona performance,
soprattutto se paragonata agli altri paesi avanzati. La figura 2.6 indica l’ammontare delle risorse
destinate alla R&S rapportate al PIL di alcuni paesi avanzati. Come si può facilmente notare,
l’Italia, per tutto il periodo considerato, si caratterizza per livelli molto bassi di spesa. Gli altri
paesi spendono in R&S il doppio, o addirittura di più, come nel caso di Stati Uniti e Giappone,
rispetto all’Italia.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Francia Germania Italia Giappone Regno Unito Stati Uniti
62
Per analizzare la qualità della R&S svolta possiamo suddividerla in tre categorie: ricerca di base,
ricerca applicata e ricerca di sviluppo. Un sistema economico che predilige la ricerca di
sviluppo si prefigge lo scopo di ottenere risultati certi nel breve periodo, riuscendo ad adattare
le tecnologie messe a punto altrove alle specifiche condizioni dell’impresa o realizzando
innovazioni incrementali. Invece chi predilige la ricerca di base si prefissa di raggiungere
risultati di lungo periodo, poiché, nonostante tale attività sia altamente incerta, la conoscenza
prodotta potrebbe avere un potenziale di crescita dirompente, rappresentando la base per
innovazioni radicali. I paesi che investono in ricerca di base mirano a costruirsi una solida base
tecnologica e di conoscenza, che potrà sostenere una crescita futura stabile45.
A partire dal 1963 l’Italia sembra orientata, facendo un raffronto internazionale, a perseguire
un buon livello di ricerca di base, ovvero circa il 25% del totale delle spese di R&S. Dagli anni
Settanta, tuttavia, la situazione peggiora drasticamente fino ad arrivare alla quota minima
dell’inizio degli anni Ottanta, dove la ricerca di base rappresenta solamente il 15% del totale,
finanziata quasi interamente dal settore pubblico46. A partire dagli anni Novanta il livello della
ricerca di base si avvicina nuovamente, in termini percentuali, a quello degli altri paesi
industrializzati, ma il problema, come già visto, riguarda l’ammontare totale delle risorse, che
in Italia sono nettamente inferiori47. Questo sembra confermare il fatto che negli anni Sessanta
ci sia stato un tentativo di emancipazione tecnologica, caratterizzato da un grosso sforzo volto
allo sviluppo di una solida base tecnologica. Ma questo tentativo ha avuto un risultato
fallimentare, con la conseguenza che le attività innovative e la R&S si sono concentrate
maggiormente nella ricerca di sviluppo e nell’adozione e adattamento di tecnologie sviluppate
altrove.
L’andamento delle spese in R&S complessive italiane rispecchia fedelmente quelle delle
imprese, facendo emergere, invece, una certa stabilità delle spese di R&S finanziate
45 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 63-67; la ricerca di base è
perpetrata a scopi puramente conoscitivi, senza avere una finalità insita. Il risultato è altamente incerto ed è
alta la possibilità che si finisca per non raggiungere alcun risultato. Ma è da tale ricerca che arrivano i risultati migliori, visto che produce conoscenza in grado di portare all’introduzione di innovazioni radicali. La ricerca
applicata è volta ad acquisire conoscenza ma è guidata da un obiettivo specifico. La ricerca di sviluppo serve
per adattare una tecnologia a specifiche condizioni o per rielaborare delle conoscenze già acquisite per mettere
a punto innovazioni incrementali, varianti e perfezionamenti. 46 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 63-67; F. Barbiellini Amidei,
J. Cantwell, A. Spadavecchia, Innovazione e tecnologia straniera, cit., pp. 557-560; nella ricerca di base c’è
la quasi totale mancanza di finanziamento da parte delle imprese private, questo fatto si può spiegare anche
con la particolare classe dimensionale e specializzazione delle imprese italiane: tante piccole e medie imprese
nei settori tradizionali e moderni, invece che grandi aziende a forte base scientifica con laboratori. 47 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 63-67.
63
pubblicamente. Infatti sono proprio le imprese che sostengono la crescita della R&S nell’Età
dell’Oro e causano la volatilità e il rallentamento degli Anni Settanta. Successivamente sono le
imprese, soprattutto pubbliche, che trainano la crescita degli Anni Ottanta, e sono le
privatizzazioni di quest’ultime, unite a tagli alla ricerca pubblica, che determinano il crollo degli
Anni Novanta48.
Nonostante le imprese siano in grado di determinare l’andamento delle spese in R&S
complessive italiane, esse vi contribuiscano solamente nella misura del 50-55%, cioè in maniera
inferiore rispetto al comportamento delle imprese negli atri paesi avanzati che, in media, vi
contribuiscono nella misura del 60-65%. Questa considerazione, unita al fatto che le spese in
R&S complessive italiane risultano molto basse, ci fa capire come le imprese italiane destinano
veramente pochissime risorse alla R&S rispetto alle loro concorrenti estere49. Questa situazione
perdura lungo tutto l’arco temporale analizzato, consentendoci di affermare che la scarsa
propensione alla R&S delle imprese sia uno dei punti deboli del sistema produttivo italiano50.
Comunque anche il finanziamento pubblico della R&S non è esente da critiche, poiché molti
sostengono che le sovvenzioni pubbliche, non essendo perfettamente congeniate e amministrate,
abbiano avuto l’effetto di finanziare attività di R&S che le imprese italiane avrebbero svolto
anche in assenza di tali sovvenzioni, spiazzando la spesa privata con quella pubblica51.
Per quanto concerne la distribuzione settoriale delle spese di R&S, vediamo che la maggior
parte di esse risulta essere stata finanziata dal settore manifatturiero. All’interno di questo, i
comparti che hanno sostenuto maggiori spese sono la chimica, i mezzi di trasporto, l’elettronica
e la meccanica. Nonostante ciò, nel confronto con gli stessi comparti dei paesi avanzati, emerge
che le spese delle imprese italiane sono solamente il 20-40% di quelle delle imprese estere,
quantificando il ritardo dell’industria italiana nell’attività di produzione tecnologica52 . Le
industrie tradizionali sono caratterizzate da bassissimi livelli di R&S, anche perché si avvalgono
maggiormente di innovazioni incorporate in macchinari, fenomeno che le statistiche in R&S
non sono in grado di cogliere53.
48 F. Barbiellini Amidei, J. Cantwell, A. Spadavecchia, Innovazione e tecnologia straniera, cit., pp. 557-560. 49 Tra l’altro queste spese risultano fortemente concentrate in poche industrie, alla fine degli anni Sessanta il 77%
delle spese di R&S delle imprese era realizzata dal 10% delle imprese. Anche misurazioni più recenti
affermavano che a metà anni Ottanta le 5 più grandi imprese italiane realizzavano da sole il 46% delle spese
totali. 50 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 72-77. 51 Ivi, pp. 77-82. 52 Ivi, pp. 85-87. 53 Ivi, pp. 89-94.
64
In conclusione quello che emerge è un forte ritardo strutturale dell’Italia nell’attività di R&S:
il divario nei confronti degli altri paesi avanzati è elevato e perdura nell’arco del tempo,
nonostante l’Italia sia diventata uno dei paesi più ricchi a livello mondiale. Le imprese, anche
se il settore pubblico non è esente da colpe, sono le maggiori responsabili di questo ritardo.
Molti affermano che questo divario dipenda dalla specializzazione produttiva dell’Italia e dalla
dimensione delle imprese, poiché, essendo solitamente le grandi industrie che operano in settori
produttivi a forte base scientifica a sostenere la maggior parte di tali spese, il sistema italiano
caratterizzato da PMI in settori tradizionali e intermedi non è adatto a svolgere elevata attività
di R&S.
Nonostante la specializzazione e la dimensione delle imprese siano effettivamente delle
determinanti negative per l’attività di R&S, esse non bastano per fornire un alibi convincente
alle imprese italiane. Questo perché, se facciamo analisi che comparano le imprese italiane e
quelle degli altri paesi avanzati, facendo in modo da rendere neutrale la classe dimensionale
delle imprese e la loro specializzazione, otteniamo una riduzione del divario nell’attività di
R&S, ma comunque la distanza con le imprese estere rimane elevata54. Quindi emerge che
anche le grandi imprese italiane nei settori idonei a svolgere maggiori attività di R&S non hanno
fatto la loro parte. Sono solo pochissime le medie e grandi imprese che reggono il confronto a
livello internazionale, ma possiamo considerarle come poche oasi in un deserto sterminato.
Ma comunque dobbiamo sottolineare che le attività di R&S non sono sufficienti per descrivere
la totalità dello sforzo innovativo di un sistema economico, ed in particolar modo di quello
italiano, poiché rappresentano solo una delle molte attività da cui dipendono la produzione di
conoscenza tecnologica e l’introduzione di innovazioni.
2.4 L’attività brevettuale
Come le spese in R&S sono state generalmente usate per misurare l’input dell’attività
innovativa, l’attività brevettuale è stata usata come riferimento per misurarne l’output. Così
facendo, però, si corre l’analogo rischio di analizzare solamente una parte dello sforzo
innovativo prodotto nel sistema economico. Infatti, l’attività brevettuale, così come le spese di
54 M. Bugamelli, L. Cannari, F. Lotti, S. Magri, Il gap innovativo del sistema produttivo italiano: radici e possibili
rimedi, Banca d’Italia, Questioni di economia e Finanza no. 121, 2012, p. 14.
65
R&S, sono indicatori di attività portate avanti, nella maggioranza dei casi, dalle grandi imprese
con laboratori che operano in settori con forte base tecnologica. Tuttavia, per completare
l’analisi di questa parte di attività innovativa, che potrebbe essere definita come il sistema
“convenzionale” di innovazione, è importante analizzare la produzione brevettuale.
Principalmente le misurazioni dell’attività brevettuale avvengono tramite le statistiche sui
brevetti concessi negli Stati Uniti all’United States Patent and Trademark Office (USPTO).
Questa è una prassi che si è affermata nel tempo nella comunità scientifica per vari motivi; tra
questi possiamo annoverare il fatto che gli USA sono stati, e sono ancora, il paese
tecnologicamente leader, oltre ad essere il mercato in cui avvengono gli scambi di tecnologia
ed in cui la protezione nei confronti del depositario del brevetto è veramente efficace.
Se, per condurre tale analisi, si considerasse il numero di brevetti in termini assoluti, dovremmo
constatare che l’Italia aumenta notevolmente il numero di brevetti nell’arco del periodo,
lasciando pensare ad una buona performance. Invece questo dato è fuorviante, poiché tale
aumento fa parte di un trend generalizzato a livello mondiale, connesso all’avanzare della
globalizzazione ed al progresso scientifico. Per evitare tale errore, analizzerò l’evoluzione dei
brevetti italiani in termini relativi, comparandoli cioè con il numero di brevetti ottenuti
all’USPTO dagli altri paesi del mondo, senza considerare quelli ottenuti dai padroni di casa, gli
Stati Uniti.
Come si può vedere dalla figura 2.7, il distacco dell’Italia nei confronti dei paesi europei è
molto elevato in tutto il periodo. La nostra performance somiglia in maggior misura a quella di
paesi con pochi abitanti, come l’Olanda, invece che a quella di paesi con dimensioni analoghe
alle nostre, come Germania e Francia. Appare evidente come i nostri risultati non siano adeguati
alle dimensioni della nostra economia. Questo si può affermare nonostante la tendenza del
periodo in questione sia stata quella di una riduzione del gap rispetto ai principali paesi europei
che, comunque, non sembra tanto dovuta a nostri miglioramenti. Infatti è dovuta al fatto che, le
quote degli altri paesi, che partivano da livelli molto più elevati dei nostri, sono state erose
maggiormente dall’avanzata dei paesi asiatici. La nostra quota passa dal 4,06% del 1963 al 2,93%
del 1990, segnando una caduta del 28%, che risulta comunque la decrescita più bassa tra i paesi
considerati nella figura 2.7.
L’andamento più dettagliato dell’attività brevettuale italiana si può vedere nella figura 2.8, che
omette i dati precedenti al 1963, anno nel quale l’Italia raggiunge la quota relativa di brevetti
più alta di tutto il periodo. Si può vedere come, nell’Età dell’Oro, l’Italia riesce ad avere una
66
buona performance che le consente di attestarsi su una quota di brevetti attorno al 4%55. A metà
anni Sessanta comincia una lieve diminuzione che, comunque, continua a garantire il
proseguimento della convergenza verso Germania e Francia. All’inizio degli anni Ottanta si
registra un timido tentativo di risalita che, però, viene subito sostituito da un nuovo processo di
decrescita. La diminuzione diviene più marcata con l’inizio degli anni Novanta, producendo
una dinamica divergente con le quote degli altri paesi avanzati. Il rallentamento degli anni
Ottanta e Novanta coincide con il periodo nel quale, nell’intero sistema economico mondiale,
si produce il massimo sforzo per la produzione di conoscenza scientifica e tecnologica legata
alle nuove tecnologie della comunicazione, informatica ed elettronica. La mancata capacità di
incrementare la produzione brevettuale, o almeno mantenerla costante, in un momento di
transizione tecnologica ha rappresentato uno dei chiari indizi dell’imminente rallentamento
complessivo dell’economia italiana.
Figura 2.7: Quota di brevetti ottenuti all’USPTO, periodo 1963-1990
Fonte: mie elaborazioni su dati USPTO, http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/h_at.htm#PartA1_1a.
Nell’analisi settoriale dell’attività brevettuale emergono interessanti considerazioni, prima tra
le quali può essere quella sul settore dell’elettronica. Infatti nei paesi avanzati, nel corso del
periodo analizzato, tale settore rimane stabilmente al secondo posto per i livelli di attività
55 F. Barbiellini Amidei, J. Cantwell, A. Spadavecchia, Innovazione e tecnologia straniera, cit., pp. 535-544.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Germania Regno Unito Francia Italia Olanda
67
brevettuale fino agli inizi anni Novanta. Da quel momento raggiunge stabilmente la prima
posizione. Invece, in Italia, l’elettronica occupa stabilmente la terza posizione, con una tendenza
nettamente opposta rispetto ai paesi avanzati: dagli anni Settanta, invece di migliorare le proprie
performance, le peggiora, subendo un crollo all’inizio degli anni Ottanta, proprio agli albori
della formazione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione56 . Infatti,
come si può vedere nella figura 2.8, la quota dei brevetti italiani nel settore dell’elettronica
ottenuti all’USPTO è molto bassa, attestandosi, negli anni Ottanta, attorno all’1,5% del totale,
al di sotto della performance di tutti gli altri settori italiani e fanalino di coda tra le economie
avanzate.
La chimica, invece, nonostante mantenga una quota sopra la media nazionale, affronta una
progressiva de-specializzazione che, comunque, le consente di mantenere una quota accettabile,
attorno al 4%. Il settore dei mezzi di trasporto subisce lo stesso fenomeno di de-specializzazione
nel tempo della chimica, ma al contrario di essa, visti la sua quota di partenza ed il peso che
detiene nel nostro sistema produttivo, non si può dire che mantiene una quota accettabile, anzi
il giudizio è di segno diametralmente opposto. L’unico settore in cui le imprese italiane
sembrano mantenere stabilmente un’elevata capacità brevettuale nel tempo è la meccanica, che
infatti conserva sempre una quota attorno al 3,5%. Assieme alla chimica, esso risulta essere il
settore che ha prodotto il maggior sforzo per dotarsi di una forte base tecnologica e capacità
innovativa per mantenere la propria competitività nei mercati internazionali.
Se invece si guarda agli uffici brevettuali degli Stati europei, l’Italia riesce ad avere una migliore
performance, detenendo quote maggiori di brevetti rispetto all’USPTO. Nonostante ciò, anche
a livello continentale, i nostri livelli non sono assolutamente paragonabili a quelli di Francia e
Germania. La relativamente migliore performance negli uffici continentali dipende dal fatto che
le PMI vi fanno maggiore ricorso vista la vicinanza e le norme meno stringenti57.
Quello che si può desumere da questi dati è che l’Italia non riesce a produrre brevetti nella
misura in cui la dimensione della sua economia ed il suo ritmo di crescita lascerebbero pensare.
Sono solamente pochi i settori che riescono a distinguersi. Tra questi si possono sicuramente
annoverare la meccanica e la chimica, anche se quest’ultima è soggetta ad un progressivo calo.
Invece, appare evidente il fallimento dell’ingresso delle imprese italiane nelle tecnologie
avanzate a prevalente base elettronica.
56 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 109-113. 57 F. Barbiellini Amidei, J. Cantwell, A. Spadavecchia, Innovazione e tecnologia straniera, cit., pp. 535-544.
68
Ma il giudizio sull’attività innovativa non può fermarsi qua, poiché bisogna ricordarsi che
un’analisi basata solo sui dati dei brevetti descriverebbe solo una parte del fenomeno innovativo,
complementare a quello delle spese in R&S. Quindi l’analisi risulterebbe sicuramente inadatta
a cogliere l’attività innovativa del sistema italiano caratterizzato da tante PMI e dalla
predominanza di settori tradizionali senza una forte base tecnologica: per questo proseguirò
analizzando altre attività che possono avere come risultato l’introduzione di innovazioni58.
Figura 2.8: Quota dei brevetti italiani sul totale dei brevetti stranieri concessi dall’USPTO, periodo 1963-1990
Fonte: mie elaborazioni su dati USPTO,
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/naics/naics_stc_fgall/naics_stc_fg.htm.
58 A conferma di questa tesi si può considerare che nell’attività di registrazione di modelli, marchi e disegni, le
performance italiane sono molto migliori rispetto all’attività brevettuale, e il gap con i nostri competitor
europei è molto minore. Infatti le attività di registrazione di modelli, marchi e disegni è il frutto di attività
innovative meno formalizzate, portate avanti soprattutto dalle PMI.
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
ITALY Elettronica Elettrico Chimico Meccanica Mezzi di trasporto
69
2.5 Acquistare tecnologia dall’estero
Dopo aver analizzato i due indicatori più usati per descrivere l’attività innovativa, comunque
rappresentativi dello sforzo prodotto internamente alle imprese, proseguo ora con l’analisi dei
mezzi attraverso i quali, le imprese stesse, possono acquisire tecnologia dall’esterno, nel caso
specifico da soggetti di paesi esteri. Per fare questo utilizzo dati relativi alla bilancia tecnologica
dei pagamenti (BTP) dal 1956 al 1990, che registra le operazioni di acquisto e cessione, a livello
internazionale, di R&S, marchi, licenze, brevetti, assistenza tecnica e know-how.
Il saldo di tale bilancia, ovvero la differenza tra gli introiti e gli esborsi, può essere visto come
un indicatore della forza e dell’autonomia tecnologica di un paese. Invece, un’analisi più
accurata delle sue due parti, scomposte nelle loro componenti, può aiutare a descrive lo sforzo
che un paese può compiere per dotarsi di tecnologia oppure le aree in cui un sistema economico
mostra più lacune o punti di forza.
Figura 2.9: Introiti ed Esborsi della Bilancia dei Pagamenti Tecnologici italiana in rapporto al PIL, periodo 1956-
1990
Fonte: C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 132-133.
Nel periodo considerato, come possiamo vedere dalla figura 2.9, si registra una continua
crescita dei volumi di interscambio tecnologico, con il saldo che rimane però costantemente
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
0,30%
0,35%
0,40%
Introiti Esborsi
70
negativo, essendo gli esborsi nettamente maggiori degli introiti. Fino ai primi anni Settanta c’è
un continuo aumento della quota del Pil destinata all’acquisto di tecnologia estera, che in un
quindicennio sestuplica passando dallo 0,05% del 1956 allo 0,3% del 1972. Nel prosieguo degli
anni Settanta gli esborsi divengono altamente volatili, stabilizzandosi nuovamente nel corso
degli anni Ottanta, dove oscillano tra lo 0,3% e lo 0,35%.
Per quanto riguarda l’altro lato della BTP, ovvero gli introiti, abbiamo un andamento di lenta
crescita, che però li mantiene su una quota molto bassa, infatti si passa dallo 0,02% del PIL del
1956 allo 0,07% del 1972. Successivamente si registra un’impennata che li porta allo 0,13%
del 1977; da allora, e per tutti gli anni Ottanta, comincia una crescita costante che fa raggiungere
la quota dello 0,25% nel 1990. Comunque, nonostante questa vistosa crescita, è da evidenziare
come gli introiti rimangono sempre abbondantemente al di sotto del livello degli esborsi.
Dal quadro tracciato appare come le imprese italiane abbiano profuso un notevole sforzo per
acquisire tecnologia dall’estero, arrivando a spendere fino lo 0,35% del PIL. Questo dato appare
ancora più notevole se consideriamo che la spesa in R&S, nello stesso periodo, non supera per
lungo tempo l’1%, rendendo lampante l’importanza che ha avuto il canale dell’acquisto di
tecnologia estera non incorporata per l’introduzione di innovazioni nel sistema economico
italiano59.
Questo sembra ulteriormente confermato dal fatto che, nel confronto internazionale, l’Italia
risulta molto indietro nelle statistiche relative a R&S, Brevetti ed introiti della BTP, mentre, per
quanto riguarda gli esborsi della BTP, riusciamo a mantenere livelli simili a Germania, Francia
e Gran Bretagna fino all’inizio degli anni Ottanta60.
L’altro dato che sembrerebbe emergere riguarda il progressivo incremento della capacità
dell’Italia di esportare tecnologia, indice di un paese che sta sviluppando una solida base
tecnologica. Per confermare questi dati è utile scomporre le due parti della BTP, introiti ed
esborsi, nelle voci che le compongono e vedere quali di esse prevalgono. I risultati che
emergono da questa scomposizione forniscono un chiaro disegno del ruolo italiano nel mercato
internazionale della tecnologia. Dal lato degli esborsi le voci stabilmente più importanti sono i
59 L’attività di acquisto dall’estero può essere intesa come sostitutiva dell’attività di R&S, difatti si compra ciò che
non si riesce a produrre internamente. Se si considerasse solamente la R&S fatta dalle imprese, gli esborsi
della BTP ne rappresenterebbero quasi il 75%, evidenziando il ruolo sostitutivo svolto da questi ultimi. 60 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 137-140; Gli introiti
rimangono stabilmente al di sotto del 50%, in alcuni anni anche del 75%, rispetto a quelli di Germania, Francia
e Gran Bretagna.
71
brevetti, le invenzioni e le licenze, che messe assieme rappresentano, lungo tutto il periodo
considerato, più del 70% del totale. Dal lato degli introiti queste stesse componenti
rappresentano una parte molto esigua, che appare ancora più scarna se si raffrontano le differenti
dimensioni degli introiti e degli esborsi. La crescita considerevole degli introiti, che parte dagli
anni Settanta, è trainata soprattutto dall’assistenza tecnica, che rappresenta più del 40% degli
introiti61.
Detto questo sembrerebbe corretto affermare che lo sforzo fatto per dotarsi di una base
tecnologica, da parte delle imprese italiane, ci sia stato e sia stato importante. Altrettanto non
può dirsi per la capacità delle stesse di esportare tecnologia visto che, scorporando dagli introiti
l’assistenza tecnica che non rientra tra le attività core della produzione scientifica, la loro
dimensione si riduce notevolmente, rendendo impossibile affermare che l’Italia sia stata
un’esportatrice di tecnologia non incorporata62.
Tutto questo lascia pensare per l’Italia ad una posizione tecnologica di basso livello, visto che
acquista brevetti, invenzioni e licenze che sono la parte science based e di maggior valore
aggiunto della bilancia, mentre esporta maggiormente assistenza tecnica non connessa, legata
più a conoscenza tacita, difficilmente codificabile, acquisibile con l’apprendimento attraverso
l’uso e sicuramente di minor valore.
La medesima conclusione di arretramento tecnologico la possiamo derivare dall’analisi
geografica della BTP: infatti risulta che importiamo soprattutto dai paesi più avanzati, ma
esportiamo maggiormente verso i paesi in via di sviluppo63.
Se scomponiamo la BTP per settori produttivi risulta che il maggiore responsabile del deficit
strutturale tra introiti ed esborsi è il settore dell’elettronica, essendo costantemente responsabile
di quasi la metà del deficit. Si può parlare, in questo caso, dell’elettronica italiana come di un
settore dominato tecnologicamente. Dal lato degli esborsi, assieme all’elettronica, i maggiori
pagatori sono la meccanica e la chimica, che però, al contrario di essa, hanno il pregio di essere
anche tra i maggiori contributori dal lato degli introiti assieme ai settori tradizionali64.
Risulta quindi che l’Italia, soprattutto nei settori più avanzati, è stata incapace a dotarsi di una
forte base tecnologica allo scopo di riutilizzarla per attivare processi interni di produzione della
61 Ivi, pp. 140-142. 62 Visto il basso livello di R&S e brevetti apparirebbe infatti strano che l’Italia riesca ad esportare quelli che sono
prevalentemente i risultati di attività di ricerca formalizzate come brevetti, invenzioni e licenze. 63 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 143-145. 64 Ivi, pp. 146-162.
72
stessa. Comunque, lo sforzo profuso fino alla fine degli anni Settanta, volto all’acquisizione di
tecnologia, ha avuto importanti risultati consentendo il rafforzamento dei settori tradizionali e
dei produttori di macchinari, rendendoli tecnologicamente autosufficienti e aumentandone le
capacità di esportazione.
2.6 L’importanza dei beni capitali
Come abbiamo visto nel primo capitolo, l’immissione di macchinari nel processo produttivo è
considerata, a partire dagli economisti classici, uno dei principali canali con cui le innovazioni
vengono introdotte nel sistema economico. Infatti, l’immissione dei macchinari, che
incorporano una determinata tecnologia, nel processo produttivo di un’impresa comporta, nel
caso in cui la tecnologia incorporata è superiore a quella precedentemente usata, un
miglioramento dell’efficienza produttiva.
Ci sono molti modi in cui l’introduzione di macchinari, e della tecnologia che incorporano, può
portare ad un’innovazione. Principalmente, come abbiamo visto sopra, quest’ultimi apportano
un beneficio diretto in termini di efficienza produttiva se il macchinario introdotto è più
efficiente di quelli precedentemente usati, maggiore efficienza che può assumere varie forme:
minori costi, maggiore velocità o minore necessità di utilizzare lavoratori. In questo caso per la
competitività delle imprese è molto importante la capacità di introdurre velocemente i beni
capitali che incorporano le migliori tecnologie e risultano più efficienti. Non essendo però le
imprese tutte uguali, è difficile che esista una tecnologia universalmente ottimale. Quindi, ogni
impresa deve essere capace di scegliere quel bene capitali che incorpora quella determinata
tecnologia ottimale per le proprie condizioni specifiche, ovvero il mercato in cui compete, la
sua dotazione fattoriale, la sua fonte energetica e le sue altre caratteristiche.
Inoltre, nelle decisioni di scelta di un’impresa, potrebbe influire il fatto che le tecnologie
richiedano, per essere fatte funzionare efficientemente, processi di apprendimento, come visto
nel primo capitolo. Allora è possibile che una tecnologia ritenuta indubbiamente più efficiente
non risulti quella ottimale per una data impresa, poiché potrebbe necessitare di complessi e
dispendiosi processi di apprendimento che abbisognano di ingenti risorse e capitale umano
elevato, fattori di cui l’impresa potrebbe non disporre.
73
Oltre a ciò, successive innovazioni incrementali possono susseguirsi all’introduzione di nuovi
macchinari con tecnologia incorporata. In primo luogo le imprese possono, al loro interno,
modificare attivamente e continuamente le tecnologie in uso, migliorandone l’efficienza e la
compatibilità con le proprie caratteristiche, realizzando quel processo di adozione creativa in
cui imitazione e innovazione sono inscindibilmente legate. In secondo luogo molte volte è
necessario, al fine rendere effettivo ed efficiente l’utilizzo dei macchinari, introdurre
cambiamenti nei processi e nell’organizzazione, che spesso rappresentano un’ulteriore
innovazione.
Inoltre, un meccanismo che garantisce elevati benefici all’intero sistema economico, si verifica
quando vengono introdotte innovazioni a monte di una filiera produttiva, soprattutto se in settori
produttori di macchine per l’industria. Poiché, con la diffusione di questi beni capitali innovati
lungo tutta la filiera, è altamente probabile che le altre imprese intermedie e a valle della filiera
introducano a loro volta innovazioni di processo e di prodotto, moltiplicando gli effetti positivi
dell’introduzione della prima innovazione.
Questi meccanismi appaiono molto adatti a descrivere ciò che è accaduto nell’Età dell’Oro
italiana. Poiché è il periodo in cui, sfruttando l’ampliarsi della domanda proveniente dal
mercato interno e internazionale, che per essere soddisfatta richiedeva un aumento di capacità
produttiva, vengono fatti elevati investimenti che rinnovano la dotazione di beni capitali e la
tecnologia in essi incorporati, abbattendone l’età media 65 . Conseguentemente a questa
massiccia introduzione di macchinari si sono sviluppati i meccanismi sopra descritti
propagando nel sistema economico italiano innovazioni e creando ulteriori stimoli ed
opportunità per migliorare l’efficienza produttiva.
Si può affermare che, in questo periodo, l’introduzione di beni capitali con tecnologia
incorporata, sia importati che nazionali, è risultata il primo canale attraverso il quale le imprese
italiane hanno introdotto innovazioni66. Solamente considerando il canale estero, nel periodo
che arriva fino al 1973, vediamo che l’importazione di macchinari rappresenta una quota del
Pil compresa tra l’1% ed il 2%67 . Molto più della spesa in R&S e degli esborsi della BTP
sommati assieme.
Le importazioni di macchinari rappresentano, soprattutto negli anni Cinquanta e all’inizio degli
65 E.N. Wolff, Capital Formation and Productivity Convergence Over the Long Term, in The American Economic
Review, Vol. 81, no.3, 1991, pp. 565-579. 66 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 170-173. 67 cfr. Penn World Table, https://pwt.sas.upenn.edu/php_site/pwt_index.php.
74
anni Sessanta, una quota molto elevata sia delle attività di investimento totali che delle
importazioni68.
Figura 2.10: Quota di esportazioni su importazioni (in valore) per i settori produttori di macchinari italiani,
periodo 1962-1990
Fonte: mie elaborazioni su dati United Nations Commodity Trade Statistics Database,
http://comtrade.un.org/db/mr/rfCommoditiesList.aspx?px=S1&cc=7.
Progressivamente, dopo gli inizi degli anni Sessanta, anche le esportazioni di beni capitali
diventano un fattore importante. Come possiamo vedere dalla figura 2.11, nel 1962 si raggiunge
la parità, in valore, tra macchinari importati ed esportati. In seguito comincia una dinamica
fortemente favorevole alle esportazioni, soprattutto per quanto riguarda le macchine non
elettriche: negli anni Settanta le esportazioni arrivano a rappresentare il doppio delle
importazioni. Invece il trend per le macchine elettriche è molto meno positivo, anche se in
surplus. Questo dato cambia completamente se scorporiamo dal totale delle macchine elettriche
l’andamento del settore degli elettrodomestici. Infatti possiamo osservare come il settore delle
68 F. Barbiellini Amidei, J. Cantwell, A. Spadavecchia, Innovazione e tecnologia straniera, cit., pp. 547-549; infatti
in questi anni le importazioni di macchinari rappresentano il 20% dell’investimento complessivo negli stessi
macchinari, così come la quota di importazione di macchinari raggiunge anche il 30% del totale delle
importazioni di beni manufatti, quote molto superiori rispetto ad altri paesi avanzati (5 volte gli USA, 3 volte
la Germania e 2 volte il Regno Unito).
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Macchine non elettriche Macchine elettriche Macchine elettriche (esclusi elettrodomestici)
75
macchine elettriche ottiene una performance deludente, con un rapporto
esportazioni/importazioni che oscilla attorno alla parità per poi crollare all’inizio degli anni
Ottanta, in linea con l’andamento degli indicatori fin qui analizzati.
Per il settore delle macchine non elettriche comincia a svilupparsi una dinamica fortemente
crescente delle esportazioni, nonostante con prezzi inferiori alle macchine estere.
Successivamente, però, le dinamiche dei prezzi tendono a riequilibrarsi raggiungendo valori
unitari molto simili a quegli degli altri paesi avanzati, sintomo di una riduzione del gap di
contenuto tecnologico tra le macchine italiane e quelle estere69.
Lo sforzo di acquisizione di tecnologia incorporata tramite le importazioni scema a partire dagli
anni Settanta, complice anche lo sviluppo di una industria italiana del macchinario di qualità,
per veleggiare su livelli modesti sul totale delle importazioni per tutti gli anni Ottanta70. Anche
gli investimenti in beni capitali seguono una dinamica simile, attestandosi su livelli modesti in
confronto all’Età dell’Oro.
Quindi possiamo concludere dicendo che, negli anni Cinquanta e Sessanta, c’è stato un notevole
esborso per acquisire macchinari dall’estero, soprattutto da paesi più avanzati tecnologicamente,
ma che questa dinamica si è notevolmente ridotta negli anni Settanta e Ottanta, complici una
generalizzata diminuzione degli investimenti e lo sviluppo di un industria di macchinari italiana
di notevole qualità. Quello che ci interessa è considerare che lo sforzo profuso nell’Età dell’Oro
per acquisire tecnologia incorporata è stato notevole e superiore agli altri paesi avanzati. Invece
nell’età del rallentamento dell’economia italiana questo sforzo si è affievolito, attestandosi su
livelli inferiori agli altri paesi avanzati.
2.7 Istruzione formale e apprendimento informale
C’è sicuramente largo accordo, tra gli studiosi, sul fatto che il livello di capitale umano di un
paese abbia in vari modi un’influenza positiva sulla crescita economica. Partendo da questa
premessa e guardando i dati disponibili sulla materia, appare evidente come la performance di
crescita dell’Italia è stata conseguita senza poter contare su livelli di capitale umano elevati e
69 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 175-177. 70 F. Barbiellini Amidei, J. Cantwell, A. Spadavecchia, Innovazione e tecnologia straniera, cit., pp. 548-549; la
quota delle importazioni di macchinari sul totale delle importazioni arriva al 10%, dato inferiore a quello dei
paesi avanzati considerati nella nota 60.
76
paragonabili con quelli degli altri paesi avanzati. Infatti, come si può vedere dalla figura 2.11,
l’Italia si distingue per un livello di scolarizzazione sempre più basso rispetto a quello degli
altri paesi.
L’Età dell’Oro italiana si è basata, più che su un progresso dell’educazione formale, su uno
stock di conoscenze tacite in settori in cui la conoscenza scientifica ed universitaria non aveva
un ruolo preponderante. Queste conoscenze erano trasmesse attraverso percorsi informali di
formazione e meccanismi di trasmissione delle informazioni all’interno del luogo lavorativo o
nei distretti industriali altamente specializzati71.
Figura 2.11: Livello scolarizzazione (asse x) associato ai livelli di Pil pro capite (asse y), periodo 1960-2010, per
l’Italia (IT), la Germania (GE), il Giappone (GP), gli Stati Unit (US) e la Francia (FR)
Fonte: mie elaborazioni su dati Maddison Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/; International
Educational Attainment Database, http://www.parisschoolofeconomics.eu/en/cohen-daniel/international-
educational-attainment-database/.
71 G. Bertola, P. Sestito, Il capitale umano, in G. Toniolo (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità
ad oggi, Venezia, Marsilio Editori, 2013, pp. 370-374.
GE60
GE70
GE80
GE90
GE00
GE10
FR60
FR70
FR80
FR90
FR00FR10
IT60
IT70
IT80
IT90
IT00 ITA10
GP60
GP70
GP80
GP90
GP00
GP10
OL60
OL70
OL80
OL90
OL00
OL10
US60
US70
US80
US90
US00
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
17.000
19.000
21.000
23.000
25.000
27.000
29.000
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
77
La dotazione di lavoratori, che ha sostenuto l’innovazione in Italia, era formata da un buon
numero di ingegneri e diplomati nelle scuole tecniche, fondamentali per poter utilizzare la
tecnologia acquisita dall’esterno, sia incorporata che non incorporata, adattandola
efficacemente alle condizioni specifiche di utilizzo di ogni impresa. Nonostante l’importanza
di queste due categorie di lavoratori e delle loro competenze, non c‘è stato nessun incremento
degli investimenti volto ad aumentarne il numero e la qualità della formazione.
Conseguentemente il numero degli iscritti a ingegneria sul totale degli universitari è rimasto
stabile negli anni Sessanta, per poi calare negli anni successivi, con il risultato che oggi
possiamo vantare un numero di iscritti ad ingegneria, in percentuale, minore alla media
dell’intera Unione Europea72. Lo stesso può dirsi per gli istituti tecnici che, dopo anni di crescita,
dalla metà degli anni Sessanta, hanno visto calare il numero degli iscritti e della qualità,
perdendo importanza all’interno del sistema formativo italiano73.
Quello che sembra emergere è che la crescita italiana si è basata su una componente di capitale
umano con specifiche competenze tecniche ed un sistema di formazione e trasmissione della
conoscenza esterno al sistema formativo istituzionale.
Invece, oggi, il sistema formativo istituzionale è molto più importante e centrale nella
formazione del capitale umano. Poiché quest’ultimo è sempre più la risultante del processo di
apprendimento altamente specialistico effettuato all’interno del sistema formativo istituzionale,
essendo la conoscenza sempre più incorporata nelle persone. Il mancato miglioramento del
sistema universitario, che mantiene elevati gap con gli altri paesi sviluppati, è uno dei motivi
per cui l’Italia stenta ad ottenere delle buone performance economiche. Difatti, la difficoltà
nell’introduzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel sistema
produttivo, che è uno dei maggiori problemi dell’Italia, è causato dal livello inadeguato di
capitale umano, visto che introduzione e l’utilizzo delle ICT ne richiede un elevato livello, di
cui le imprese italiane spesso non dispongono74.
Sempre dal grafico 2.11 possiamo vedere che, nell’ultimo decennio, il livello di scolarizzazione
italiano sembra aumentato, ma purtroppo questa potrebbe essere una semplice distorsione
statistica dovuta ad una caratteristica peculiare italiana: infatti bisogna considerare il fenomeno
72 F. Barbiellini Amidei, J. Cantwell, A. Spadavecchia, Innovazione e tecnologia straniera, cit., pp. 552-554;
l’Italia nel 2009 aveva una quota di studenti di ingegneria del 9% contro una media UE del 10,1%. 73 Ivi, pp. 554-556. 74 F. Schivardi, R. Torrini, Cambiamenti strutturali e capitale umano nel sistema produttivo italiano, Banca d'Italia,
Questioni di Economia e Finanza no. 108, 2011, pp. 21-22.
78
del lungo tempo trascorso fuori corso dagli studenti universitari, tempistiche che non hanno
uguali nel resto dei paesi avanzati.
Anche per quanto riguarda il numero di laureati l’Italia è sempre stata molto indietro. Infatti, se
guardiamo la figura 2.12, vediamo come il numero di laureati italiani, nella popolazione che va
dai 25 ai 64, è molto inferiore a quello degli altri paesi considerati. Nel 2000 i laureati italiani
sulla popolazione erano meno del 10% contro porzioni superiori al 20% negli altri paesi. Questa
statistica, comprendendo i laureati da fine anni Sessanta ad oggi, è anche un buon indicatore
per considerare il numero dei laureati in prospettiva storica.
È difficile quindi non vedere il sistema di formazione istituzionale, ed i mancati investimenti in
esso, come una delle ragioni per cui l’Italia non è riuscita, e non riesce, a sfruttare le opportunità
connesse alle tecnologie più avanzate sviluppatesi a partire dagli anni Ottanta.
Figura 2.12: percentuale % di laureati sul totale della popolazione 25-64, periodo 2000-2010
Fonte: mie elaborazioni su dati OECD, http://stats.oecd.org/.
2.8 Uno sguardo d’insieme
Sulla base degli indicatori dell’attività innovativa fin qui raccolti, è possibile fare un primo
resoconto sulla loro evoluzione nel tempo, raffrontando la loro consistenza con gli stessi
indicatori degli altri paesi avanzati. La tabella che segue ha esattamente questa funzione.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Francia Germania Italia Giappone Olanda Regno Unito Stati Uniti
2000 2005 2010
79
Tabella 2.6: Riassunto indicatori sull’innovazione, periodo 1951-1990
1951-1963 1964-1973 1974-1990
Spese in R&S Rafforzamento adeguato Rallentamento del pro-
cesso di crescita e alta vo-
latilità
Crescita in termini asso-
luti, ma tassi crescita mi-
nori dei paesi sviluppati
Confronto altri paesi avan-
zati
Livello inferiore
Trend convergente
Livello inferiore
Trend convergente
Livello inferiore
Trend divergente
Attività Brevettuale Crescita maggiore con
raggiungimento apice in-
tero periodo
Calo e stabilizzazione Calo deciso, nonostante
tentativo di recupero
all’inizio anni Ottanta
Confronto altri paesi avan-
zati
Livello inferiore
Trend convergente
Livello inferiore
Trend stabile
Livello inferiore
Trend divergente
Esborsi della BTP Sforzo notevole per acqui-
sire tecnologia dai paesi
avanzati
Lieve crescita con alta vo-
latilità
Continua lievemente la
crescita
Confronto altri paesi avan-
zati
Livello simile
Trend convergente
Livello simile/inferiore
Trend lieve divergenza
Livello inferiore
Trend divergente
Acquisto di tecnologia in-
corporata
Livelli di importazione ele-
vati, superiori a quelli de-
gli altri paesi avanzati
Livelli in crescita, sempre
maggiori in prospettiva in-
ternazionale
Livelli assoluti in crescita,
ma meno degli altri paesi
avanzati
Confronto altri paesi avan-
zati
Livello superiore
Trend divergente
Livello superiore
Trend stabile
Livello inferiore
Trend divergente
Capitale umano Adeguato nelle compe-
tenze tecniche, inade-
guato settori avanzati
Livelli inadeguati nei set-
tori science based
Livelli inadeguati nei set-
tori science based
Confronto altri paesi avan-
zati
Livello inferiore
Trend convergente
Livello inferiore
Trend stabile
Livello inferiore
Trend divergente
Total Factor Productivity + 3,6%
+ 2,9%
+ 1%
Confronto altri paesi avan-
zati
Livello superiore
Livello lievemente supe-
riore
Livello inferiore
Crescita economica + 5,75% + 4,82% + 2,5%
Confronto altri paesi avan-
zati
Livello superiore
Livello superiore Livello lievemente supe-
riore
Fonte: elaborazione dei dati nel testo.
80
Quello che emerge da questa comparazione è che il modello “convenzionale” di sistema
innovativo, inteso come quello basato sulle spese in R&S, sull’utilizzazione di elevato capitale
umano e sulla produzione brevettuale, ha avuto in Italia una performance assolutamente scarsa
se confrontato con quello degli altri paesi avanzati. Solo nella prima parte dell’Età dell’Oro c’è
stato un evidente sforzo volto a sviluppare tale sistema innovativo, ma che evidentemente non
ha avuto successo.
Questa valutazione, avendo considerato la crescita della TFP italiana dipendente in maniera
preponderante dalle dinamiche innovative, ci porrebbe di fronte ad un’incoerenza logica: una
forte discrepanza tra le attività intraprese e i risultati ottenuti. Infatti sembrerebbe che siano stati
compiuti pochi sforzi per promuovere il sistema innovativo, ma siano stati ottenuti grandi
risultati di miglioramento dell’efficienza (TFP), da cui deriverebbe l’elevato tasso di crescita
della ricchezza italiana.
Per risolvere questa discrepanza è utile guardare oltre le indicazioni sull’innovazione che ci
pervengono considerando solamente il modello “convenzionale” del sistema innovativo. Solo
così si potrà trovare una correlazione tra le attività intraprese e i risultati raggiunti dall’Italia nel
Dopoguerra.
Quello che emerge è che l’Italia ha compiuto enormi sforzi, superiori alla media dei paesi
avanzati, per dotarsi di tecnologia prodotta all’estero, tramite gli acquisti di tecnologia
incorporata e non. Infatti, nel primo periodo considerato, che va dal 1951 al 1963, l’Italia spende
un’ingente mole di risorse nell’acquisto di tecnologia estera. È sempre negli stessi anni che si
ha il maggior attivismo nell’attività brevettuale e nella crescita del livello di R&S, soprattutto
ricerca di base, sintomo di una volontà di dotarsi di un proprio sistema innovativo
“convenzionale” indipendente, emancipandosi dal resto dei paesi avanzati. La crescita della
TFP e del PIL sono molto elevate, superiori al resto dei paesi avanzati.
Nel secondo periodo, che va dal 1964 al 1973, le varie statistiche legate al sistema innovativo
“convenzionale” subiscono un arresto della crescita, stabilizzandosi su livelli inferiori rispetto
agli altri paesi avanzati. Anche le statistiche legate all’adozione di tecnologia estera rallentano
la loro evoluzione, attestandosi però su livelli simili, se non maggiori rispetto agli altri paesi
avanzati. La crescita dell’efficienza e della ricchezza dell’economia continuano, seppur
rallentando leggermente rispetto al periodo precedente, rimanendo pur sempre superiori al resto
dei paesi avanzati.
È nel terzo periodo considerato, che va dal 1974 al 1990, che tutte le statistiche analizzate fanno
81
registrare un processo di divergenza nei confronti dei livelli dei paesi avanzati75, sia quelle
relative al sistema “convenzionale” che quelle relative al sistema che possiamo definire di
“adozione di tecnologie estere”. La performance dell’economia rallenta notevolmente, facendo
registrare comunque una crescita di livello simile rispetto agli altri paesi avanzati, mentre la
dinamica della TFP risulta minore. Il crollo vero e proprio avverrà con l’avvento degli anni
Novanta.
Quello che emerge è che le attività innovative in Italia sono state piuttosto scarse, se raffrontate
con gli altri paesi avanzati. In particolare il sistema innovativo “convenzionale” appare come
inadeguatamente sviluppato e in netto ritardo. Invece maggiore sforzi, a volte anche superiori
agli altri paesi avanzati, sono stati compiuti per alimentare quel sistema di innovazione che
abbiamo definito di “adozione di tecnologie estere”. Ma rimane ancora un problema di
discrepanza tra l’attività e i risultati, poiché se fosse stata mera adozione, non si spiegherebbe
perché il risultato sia stato maggiore, in termini di TFP e crescita della ricchezza, rispetto ai
paesi da cui adottavamo le tecnologie, essendo anche più durevole nel tempo di quanto ci
potessimo aspettare. Per rispondere alla domanda è necessario analizzare ancora un altro aspetto,
ovvero le prestazioni settoriali e le esportazioni, così da avere ulteriori elementi per formulare
una risposta.
2.9 Uno sguardo alle prestazioni settoriali
Proseguirò ora con un’analisi settoriale di alcune statistiche proposte e della performance
ottenuta nei mercati internazionali, supponendo che i settori che hanno saputo innovare
maggiormente abbiano, di conseguenza, ottenuto buoni risultati nelle esportazioni.
Per quanto riguarda l’attività di R&S risulta che il livello assoluto di spesa, in tutti i settori
produttivi italiani, è inferiore agli stessi settori dei paesi più avanzati. Infatti nei confronti degli
stessi settori produttivi di Germania, Francia e Regno Unito, le spese dei settori italiani risultano
essere costantemente inferiori del 50% o in misura maggiore. Se invece guardiamo a come è
ripartita percentualmente la spesa complessiva all’interno dei paesi, risulta che il settore della
75 La crescita nei loro livelli non deve ingannare, poiché fa parte di un trend generalizzato a livello mondiale, dove
le spese in R&S crescono fortemente, le importazioni aumentano vorticosamente grazie all’intensificarsi dei
commerci e le minori barriere ed il livello di scambio di tecnologia aumenta per il formarsi di un vero e proprio
mercato della conoscenza. Quello che deve importare è che la posizione relativa dell’Italia rispetto agli altri
paesi peggiora notevolmente.
82
meccanica e quello della chimica hanno un’importanza relativamente maggiore rispetto alle
loro controparti nei paesi considerati. Un settore che risulta parecchio arretrato è quello
dell’elettronica, sia perché detiene un livello assoluto di spese in R&S pari al 20-30% rispetto
allo stesso settore di Germania, Francia e Regno Unito, sia perché la quota relativa risulta molto
più bassa76.
Per l’attività brevettuale la situazione è già stata osservata, e come abbiamo visto (paragrafo
2.2.4), il settore chimico e quello della meccanica producono, lungo tutto il periodo considerato,
una quota di brevetti registrati all’USPTO maggiore rispetto alla media italiana, nonostante per
la chimica si assista ad una progressiva de-specializzazione. Per quanto riguarda il settore dei
mezzi di trasporto, pur partendo da una quota sopra la media, si assiste ad un calo lungo tutto il
periodo, una prestazione molto negativa visto il peso che tale settore detiene nel sistema
produttivo italiano. Anche nell’attività brevettuale il settore italiano dell’elettronica conferma i
suoi scarsi risultati, sia se paragonato agli altri settori italiani, ma ancor più in un confronto
internazionale, peggiorando ulteriormente nel tempo, visto che fa registrare un crollo nella
produzione brevettuale negli anni Ottanta, esattamente nel momento di massimo sviluppo del
settore a livello globale77.
Per quanto riguarda la BTP, abbiamo visto che sono i settori della meccanica e della chimica i
responsabili della maggior parte degli introiti, facendo pensare che abbiano raggiunto un buon
livello di produzione tecnologica. Dal lato degli esborsi, invece, sono la meccanica, la chimica
e l’elettronica i settori con maggiori esborsi. Tuttavia, mentre per i settori della chimica e della
meccanica questo è accompagnato da una corrispondente capacità di esportazione, per quanto
concerne il settore dell’elettronica, questa capacità manca, facendo supporre come questo sia
un settore nel quale l’Italia è dominata tecnologicamente.
Per analizzare le esportazioni a livello settoriale useremo la tassonomia proposta da Pavitt78, il
quale suddivide in gruppi omogenei, sotto il profilo della tecnologia, i settori dell’economia.
Egli identifica quattro settori che si differenziano sotto il profilo tecnologico. Per cominciare
76 M.R. Battaggion, A. Falzoni, Gli indicatori della scienza e della tecnologia: un’analisi aggregata, in F. Malerba,
F. Onida, La ricerca scientifica, Roma, SIPI, 1990, pp. 97-145; dati concernenti gli anni dal 1981 al 1985. 77 Ibidem; il settore del macchinario non elettronico rappresenta lungo tutto il periodo il 30% della produzione
brevettuale italiana, la chimica è in calo ed oscilla tra il 15%-20%, l’elettronica assieme al settore del
macchinario elettronico oscillano tra il 15%-18%, appare evidente la performance eccezionale del settore del
macchinario non elettronico. 78 K. Pavitt, Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory, in Research Policy, Vol.
6, no. 2, 1984, pp. 343-373.
83
abbiamo le industrie science based, caratterizzate da forti investimenti in R&S, operanti in
settori con un’elevata base tecnologica. La competitività è fortemente influenzata dalla capacità
di produrre innovazioni, che solitamente sono di vasta portata e producono effetti su tutto il
sistema economico (chimica, informatica, componentistica elettronica, telecomunicazioni,
aerospaziali).
Il secondo gruppo è quello delle industrie scale intensive, caratterizzato da forti economie di
scala ed elevata intensità di capitale (autoveicoli, elettronica di consumo, gomma, siderurgia).
Il terzo gruppo è quello specialized suppliers, caratterizzato da imprese medio piccole, con alta
diversificazione dell’offerta ed elevata capacità di produrre innovazioni incrementali
(meccanica strumentale, macchine utensili e macchine per l’industria).
Infine vi è il settore supplier dominated che comprende i settori più tradizionali, i quali
acquisiscono innovazione dagli altri settori, tramite macchinari e materiali, e sono influenzati
da competizione sul prezzo, sul design e sulla qualità (legno, tessile, calzature, ceramica)79.
La suddivisione di Pavitt, pur presentando alcuni limiti, ha il suo maggior pregio
nell’identificare i vantaggi competitivi di un paese in relazione a gruppi omogenei di imprese
per quanto concerne i processi innovativi. Infatti all’interno di questa suddivisione non si
rilevano solamente le attività innovative “convenzionali”, ma sono ricompresi gli altri tipi di
dinamiche innovative80.
Come possiamo osservare dalla figura 2.13, i settori che ottengono le migliori performance in
campo internazionale sono quelli tradizionali (dominated by suppliers) che contribuiscono
stabilmente ed in maniera elevata alla bilancia commerciale. L’altro settore che si
contraddistingue è quello e quello specialized suppliers. Invece il settore scale intensive subisce
un crollo lungo il periodo contribuendo, alla fine, largamente al disavanzo della bilancia
commerciale. Il settore science based ha una performance scarsa lungo tutto il periodo,
peggiorando ulteriormente negli anni Ottanta.
79 P. Guerrieri, C. Milana, L’Italia e il commercio mondiale, mutamenti e tendenze nella divisione internazionale
del lavoro, Bologna, Il mulino, 1990, pp. 33-37. 80 Ibidem.
84
Figura 2.13: Evoluzione della specializzazione italiana nel commercio internazionale, indicatore di contributo al
saldo commerciale, periodo 1970-1987
Fonte: mie elaborazioni su dati P. Guerrieri, C. Milana, L’Italia e il commercio mondiale, mutamenti e tendenze
nella divisione internazionale del lavoro, cit., p. 266.
Se si analizzano ancora più in profondità le performance settoriali, vediamo, coerentemente con
quanto fin qui delineato, che la specializzazione italiana è caratterizzata della costante presenza
dei settori tradizionali e dal progressivo rafforzamento del settore della meccanica. Questo è
quello che emerge chiaramente dalla figura 2.14, dove si può vedere l’evoluzione degli indici
di specializzazione delle esportazioni manifatturiere dell’Italia all’inizio e alla fine del periodo
del rallentamento.
Coerentemente con quanto visto precedentemente, anche tramite l’analisi della TFP settoriale,
si può giungere alla conclusione che i settori che hanno avuto il maggiore guadagno di
efficienza complessiva, contribuendo in maniera maggiore alla crescita della produttività del
lavoro e della ricchezza, sono quelli tradizionali assieme alla meccanica e alla chimica81 .
Coerentemente con le altre osservazioni fatte nel corso del capitolo, possiamo dire che sono
stati questi i settori che hanno avuto le maggiori dinamiche innovative, che però non risultano
rilevabili all’interno delle statistiche sull’attività innovativa “convenzionale”, poiché non è
questo il canale tramite il quale queste dinamiche si sono dispiegate.
81 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 229-235.
-10
-5
0
5
10
15
20
25
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1987
Dominated by suppliers Scale intensive Specializes suppliers Science based
85
Infatti sono altre le attività che hanno contato maggiormente, come l’importazione della
tecnologia estera, incorporata e non, i processi di adozione della stessa con una notevole
capacità di adattarla alle specificità locali, elevate relazioni tra produttori e utilizzatori che
consentivano mutui benefici, una velocità di diffusione delle innovazioni molto elevata grazie
alle forti relazioni e alla presenza di unità territoriali altamente permeabili come i distretti. È da
sottolineare come la forte opera di adattamento delle tecnologie alle specifiche condizioni locali
e la loro rielaborazione volta a produrre miglioramenti, rendono impossibile parlare di mero
processo di adozione, ma sottolineano la forte capacità di innovare, seppur in maniera
incrementale, usando come base le tecnologie prodotte al di fuori del nostro sistema economico.
Tutto questo va a delineare le caratteristiche delle dinamiche innovative italiane che, non
rientrando nello schema “convenzionale”, sono state per molto tempo escluse dall’analisi
sull’innovazione.
Figura 2.14: Indice di specializzazione nelle esportazioni manifatturiere
Fonte: P. Guerrieri, C. Milana, L’Italia e il commercio mondiale, cit., pp. 108-109.
Ind. Alimentare
Bevande alcoliche e non
Legno e mobilio, carta ed editoria
Industria dei metalli di base
App. e mat. elettrico
Tessile, abb., cuoio e calzature
Prodotti chimici, farmaceutici e
gomma
Derivati del petrolio
Ceramica, vetro e mat. da costruzione
Prodotti in metallo
Macch. agricole ed industriali
Termomeccanica e comp. meccanica
Macch. da ufficio ed elaboratori
App. telecomunicazione e comp. elettrici
Autoveicoli
Navi, treni ed aerei
Ottica e meccanica di precisione
0
50
100
150
200
250
300
1970-1973 1984-1987
86
3 Sistema innovativo o Sistemi innovativi?
Alla luce dei dati fin qui raccolti appare evidente come il sistema innovativo “convenzionale”
italiano non abbia raggiunto risultati paragonabili agli altri paesi avanzati, anzi si è distinto tra
essi come uno dei pochi casi di performance negativa. Allora, visto che è largamente sostenuto
che vi sia una forte correlazione positiva tra l’andamento di questo sistema e la crescita
economica, l’Italia, con le sue eccezionali performance di crescita del PIL e della TFP, rimane
un caso atipico da spiegare.
Figura 2.15: Rapporto tra Brevetti per milione di abitanti (asse y), Spese in R&S/PIL (asse x) e PIL pro capite
(scala a dx), anno 1990
Fonte: mie elaborazioni su dati Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
Difatti, come vediamo dalla figura 2.15, che fotografa la situazione alla fine del periodo
considerato in questo capitolo, a fronte di un modesto livello di attività innovativa
“convenzionale” l’Italia ha ottenuto performance simili, o in certi casi maggiori, in termini di
PIL pro capite, rispetto a paesi con livelli di attività nettamente maggiori. Sembra esserci una
effettiva correlazione tra il numero di brevetti e le spese in R&S da una parte e la grandezza dei
cerchi, che rappresentano il PIL pro capite dei paesi. Constatando che la grandezza dei cerchi
87
dovrebbe aumentare con il procedere verso destra e verso l'alto, deduciamo che l’Italia
rappresenta effettivamente un’anomalia tra questi paesi.
Per spiegare le prestazioni dell’Italia bisogna uscire dallo schema “convenzionale” di attività
innovativa, analizzando altre attività che possano essere state portatrici di innovazione o il
risultato di essa, esattamente il tipo di analisi che è stata svolta in questo capitolo. Quindi ora
posso affermare che l’Italia ha prodotto, tramite un sistema “atipico”, un’ottima performance
innovativa, la quale ha influito in maniera cruciale sul processo di crescita economica; questo
è risultato più vigoroso rispetto a quello di altri paesi che, stando a caratteristiche strutturali e
considerazioni comuni, avrebbero dovuto far meglio.
Dai dati e dalle considerazioni presentate nei precedenti paragrafi emerge come l’Italia abbia
sopperito alle scarse performance del sistema innovativo “convenzionale” tramite altre
dinamiche innovative appartenenti ad un sistema parallelo di innovazione basato maggiormente
sull’adozione creativa delle tecnologie, sulle relazioni tra fornitori ed utilizzatori, su elevate
competenze tecniche e sulla dinamicità delle PMI. Queste dinamiche sono ricomprese nel
sistema innovativo che abbiamo precedentemente rinominato di “adozione di tecnologia estera”
o “atipico”.
Uno dei processi innovativi più importanti, che ha caratterizzato la crescita economica italiana
del Dopoguerra, ed è riconosciuto oramai da molti autori, è rappresentato dal circolo virtuoso
che a partire dalla crescita del settore dei beni di consumo tradizionali, ha consentito lo sviluppo
di un dinamico settore dei beni capitali. Riformulato secondo i termini della tassonomia di
Pavitt, questo è il processo per cui lo sviluppo del settore dominated by suppliers ha trainato,
assieme alla concomitanza di altre condizioni, lo sviluppo del settore specialized suppliers.
Il risultato è stato quello di caratterizzare la specializzazione produttiva italiana in un modo che
si è rivelato altamente durevole nel tempo, la cui persistenza la possiamo osservare fino ai giorni
nostri.
Dopo la fine della guerra, l’espansione del mercato interno italiano e del mercato internazionale
ha aumentato notevolmente la necessità di beni di consumo. Conseguentemente le imprese
italiane produttrici di tali beni hanno dovuto sostenere una forte domanda per i loro prodotti,
necessitando di nuovi macchinari per aumentare la capacità produttiva e l’efficienza. Negli anni
Cinquanta, questa alta domanda di beni capitali più efficienti, è stata soddisfatta, in larga misura,
tramite l’importazione di macchinari che incorporavano tecnologia avanzata estera.
88
Ma, allo stesso tempo, i produttori italiani di beni capitali, scorgendo una nitida opportunità
nell’elevata domanda, si sono impegnati notevolmente per riuscire ad acquisire competenze e
tecnologie tali da permettere loro di produrre macchinari qualitativamente simili a quelli che le
industrie produttrici di beni di consumo italiane importavano dall’estero. Come abbiamo visto
(paragrafo 2.6), questo sforzo è evidenziato dall’ingente importazione di tecnologia incorporata
e non, soprattutto sotto forma di brevetti e licenze.
I risultati di questo notevole impegno sono visibili già a partire dai primi anni Sessanta, quando
i macchinari esportati hanno superato in valore quelli importati, nonostante le dinamiche di
prezzo evidenziassero una divergenza verso il basso dei nostri beni capitali rispetto a quelli dei
paesi avanzati. Tali differenziali di prezzo stavano a significare un più basso livello tecnologico
dei nostri macchinari. Ma, con il passare del tempo, queste differenze nei prezzi si sono
riequilibrate, sintomo di un livello qualitativo crescente delle macchine italiane e sempre più
simile a quello dei beni capitali dei paesi avanzati.
Oltre ad una dinamica fortemente positiva della domanda, sono anche altre le ragioni di un così
rapido sviluppo di questo settore; tra queste, è risultata sicuramente molto importante la capacità
delle imprese italiane di adattare le tecnologie estere allo specifico contesto ed alla propria
dotazione fattoriale, cioè con adattamento creativo. L’adozione creativa di una tecnologia si
sostanzia in un processo in cui è necessaria la partecipazione attiva degli adottatori, volenterosi
di aumentare la compatibilità della nuova tecnologia con le specifiche caratteristiche locali
dell’impresa, in termini di mercati, fattori, strutture organizzative e manageriali82. Aumentando
la compatibilità, da questo processo scaturiscono innovazioni incrementali che si sostanziano
in aumenti dell’efficienza complessiva.
L’elevata capacità di adozione creativa si è imposta come un tratto tipico delle imprese italiane,
sia nei settori dei beni di consumo che in quelli dei beni capitali. Questa attitudine è stata
favorita dalla congruenza tra la dotazione di lavoratori e le caratteristiche della tecnologia da
adottare. Infatti le imprese italiane utilizzavano lavoratori con buone capacità tecniche,
acquisite soprattutto tramite l’esperienza, ed un buon numero di ingegneri. Le tecnologie
prevalenti in questi settori erano particolarmente adatte a tale dotazione poiché erano soprattutto
incorporate nei macchinari, facilmente codificabili e acquisibili tramite processi di learning by
doing o by using. Le competenze necessarie all’utilizzo di tali tecnologie erano simili, seppur
82 Ivi, pp. 33-35.
89
molto più complesse, di quelle artigiane in cui l’Italia aveva una grande tradizione.
Conseguentemente le dinamiche innovative maggiori si sono prodotte in quei settori dove la
tecnologia era più congruente con la dotazione fattoriale italiana, ovvero dove le competenze
tecniche e la conoscenza apprendibile tramite l’utilizzo erano maggiormente necessarie. Invece
tali dinamiche sono state minori in quei settori dove era maggiore la necessità di capitale umano
elevato con conoscenza fortemente incorporata, fattore di cui l’Italia scarseggiava.
Un’altra condizione che ha influito in maniera importante sulle dinamiche innovative italiane
può essere identificata nella forte intensità di relazioni tra utilizzatori e fornitori, o più in
generale nelle forti interazioni presenti lungo tutte le filiere produttive, verticali e diagonali.
Queste relazioni e interazioni erano sicuramente facilitate dalla presenza di numerosi distretti
industriali, che molte volte racchiudevano al loro interno tutta la filiera produttiva, oltre che
dalla piccola e media dimensione delle imprese.
Tramite questo elevato grado di interazione veniva trasmesso un notevole flusso di conoscenza
lungo le filiere produttive. Altri ancora erano i benefici di questa struttura fortemente connessa:
tra questi è importante sottolineare come essa consentisse alle innovazioni di diffondersi
velocemente in tutto il sistema. Inoltre, le interazioni tra utilizzatori e produttori consentivano
di produrre continui feedback reciproci che permettevano, ai produttori, di costruire macchinari
più efficienti e, agli utilizzatori, di poter usufruire di macchinari specifici per le loro esigenze.
Tramite l’acquisto di beni capitali le imprese a valle delle filiere introducevano innovazioni di
processo, ma anche loro non si limitavano ad adottare passivamente tali tecnologie incorporate.
Anzi, tramite il processo di adozione creativa, come le imprese a monte, producevano ulteriori
innovazioni incrementali, sia riorganizzando la produzione che migliorando la compatibilità
delle tecnologie con le proprie condizioni specifiche locali.
Grazie a queste condizioni, i settori tradizionali e quelli del macchinario hanno saputo innovare
con continuità nel tempo, migliorando la loro efficienza e mantenendo elevata la loro
competitività internazionale e i loro profitti, rappresentando, ancora oggi, i settori italiani con
maggiore capacità di esportazione.
Quindi il sistema di innovazione parallelo a quello “convenzionale”, che potremmo anche
definire, come fa Malerba, “Network di PMI”83, si è basato su alcuni fattori peculiari, quali il
83 F. Malerba, Il sistema innovativo italiano, in F. Malerba (a cura di), Economia dell’innovazione, Roma, Carocci
editore, 2011, pp. 469-474.
90
processo di adozione creativa, la dotazione di lavoratori con elevate competenze tecniche
congruenti con la tecnologia in uso, le forti relazioni utilizzatori/produttori e la presenza di
molte aziende di piccole e medie dimensioni. Processi in parte simili a quelli descritti si sono
avuti anche nel settore della chimica e dei mezzi di trasporto, ma senza quella continuità e
intensità che hanno contraddistinto le imprese dei settori specialized suppliers e dominated by
suppliers. Inoltre questi due settori, date le loro caratteristiche, avrebbero necessitato di un
grosso sforzo nelle attività del sistema innovativo “convenzionale”, sforzo che evidentemente
è mancato.
Coerentemente a quanto affermato, nei settori science based, dove era maggiormente
importante lo sviluppo del sistema “convenzionale” di ricerca, le dinamiche innovative sono
state scarse.
Per dare coerenza a quanto esposto credo sa giusto riportare alcuni dati relativi alle prime
indagini sull’innovazione, risalenti agli inizi degli anni Novanta. Da esse emergono dei dati che
confermano quanto scritto sopra. L’attività di R&S è effettivamente svolta in maggior misura
dalle imprese dei settori science based e scale intensive, che la ritengono fonte molto più
importante per la generazione di innovazioni rispetto alle imprese dei settori specialized
suppliers e dominated by suppliers84.
Infatti le imprese dei settori specialized suppliers danno un peso maggiore, come fonte
dell’innovazione, ad altre dinamiche, ovvero ai rapporti con i clienti, al reverse engineering85
ed al contributo delle imprese affiliate. L’importanza di questi fattori è molto superiore sia
rispetto alle imprese degli altri settori italiani sia rispetto alla media europea delle imprese
appartenenti alla stessa categoria86.
I settori dominated by suppliers indicano la più importante fonte di introduzione di innovazioni
negli investimenti, infatti essi rappresentano il 59% dei costi innovativi sostenuti da queste
imprese87 . Invece le imprese dei settori specialized suppliers si contraddistinguono per una
84 D. Archibugi, R. Evangelista, L. Nascia, Il ruolo delle piccole e medie imprese nel sistema innovativo italiano,
in C. Antonelli (a cura di), Conoscenza tecnologica: Nuovi paradigmi dell’innovazione e specificità italiana,
Torino, Edizioni FGA, 1999, pp. 147-155; infatti la spesa per addetto in R&S è 16,4 (milioni di lire 1991) nei
settori SB contro 3,6 nei settori SS e 2,2 nei settori SD; così come sul versante dei costi innovativi le spese
per R&S sono il 61% nei settori SB, contro il 35% dei settori SS e il 26% dei settori SD. 85 È il processo tramite il quale si comprende il funzionamento di una macchina scomponendola nelle sue parti e
si riesce ad acquisire le competenze per ricostruirla magari migliorandone le caratteristiche e l’efficienza. 86 F. Malerba, Il sistema innovativo italiano, cit., pp. 464-469. 87 D. Archibugi, R. Evangelista, L. Nascia, Il ruolo delle piccole e medie imprese nel sistema innovativo italiano,
cit., pp. 144-150; contro il 16% dei settori SB e il 34% dei settori SS.
91
quota elevata di spese di progettazione e produzione di prova.
Per quanto riguarda le dimensioni delle imprese appare coerente chiamarlo sistema innovativo
del “Network delle PMI” poiché i settori specialized suppliers e dominated by suppliers sono
effettivamente quelli che hanno una quota largamente maggiore di PMI88.
Quindi le dinamiche innovative in Italia sono state vigorose proprio nel sistema di innovazione
del Network delle PMI, che ha compreso produttori di beni capitali, le imprese dei settori
tradizionali e le imprese dei distretti industriali89. Con la chimica e i mezzi di trasporto che
hanno apportato il loro contributo, ma meno intensamente e in modo più incostante. Tali
dinamiche innovative hanno contribuito in maniera fondamentale alla crescita italiana nel
dopoguerra.
La stessa cosa non si può dire per quanto riguarda il sistema “convenzionale” di innovazione,
che non è riuscito a svilupparsi adeguatamente, anche se, come abbiamo visto, molti sforzi sono
stati compiuti al fine di dotare l’Italia di una propria dimensione tecnologica prossima alla
frontiera. Questo è avvenuto soprattutto negli anni Sessanta, con l’aumento deciso delle spese
di R&S e l’incremento della produzione brevettuale. Ma con il passare del tempo questi sforzi
hanno perso slancio, affievolendosi, mettendo a nudo le difficoltà che le caratteristiche del
sistema economico italiano aveva ad avvicinarsi alla frontiera tecnologica. Già dagli anni
Settanta le dinamiche brevettuali e delle spese in R&S rallentano, e nonostante un tentativo di
recupero all’inizio degli anni Ottanta, prevale la tendenza verso la netta divergenza con i paesi
più avanzati. Anche dal lato del capitale umano non c’è stata una svolta decisa che ci
permettesse di raggiungere, o quantomeno avvicinare, i livelli dei paesi più avanzati (figura
2.11).
Il compito del sistema istituzionale ed economico negli anni successivi al boom economico
sarebbe stato quello di continuare la trasformazione strutturale dell’Italia, consentendole di
proseguire il processo di avvicinamento alla frontiera tecnologica, in modo da emanciparsi dai
paesi avanzati e diventare a tutti gli effetti una potenza economica mondiale.
Per quanto riguarda ciò che rileva l’attività innovativa, questo processo doveva verificarsi
principalmente tramite la promozione di una forte crescita del capitale umano e della R&S. Ma
88 D. Archibugi, R. Evangelista, L. Nascia, Il ruolo delle piccole e medie imprese nel sistema innovativo italiano,
cit., p. 135; le grandi imprese nel settore SB rappresentano il 69%, mentre nei settori SS e SD rispettivamente
il 37% ed il 30%. 89 F. Malerba, Il sistema innovativo italiano, cit., pp. 469-474.
92
l’incapacità di riformare questi aspetti del sistema italiano ha prima rallentato e poi affossato le
pretese di dotarsi di un valido sistema innovativo “convenzionale”. Purtroppo tale fallimento è
conciso con il periodo di transizione tecnologica a livello mondiale, in cui si è passati dalla
predominanza delle tecnologie cosiddette invisibili, tipiche della produzione di massa e con
elevata intensità di capitale fisico, alle nuove produzioni incentrate sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, intensive di capitale intangibile.
Le conoscenze tecnologiche, adesso, sono altamente incorporate nelle persone e, nonostante
siano parzialmente codificate e non tacite, esse sono altamente specifiche e al tempo stesso
fortemente condizionate da complementarietà tra diversi campi di conoscenza, non così
facilmente trasmissibili, sviluppate come risultato di investimenti conoscitivi di lungo periodo,
quindi di alti livelli di capitale umano90. Quindi il fallimento nell’elevare la qualità del nostro
capitale umano è risultata ancora più nociva, poiché non ha consentito all’economia italiana di
partecipare a questa trasformazione tecnologica, visto che in molti settori chiave non vi è entrata
o vi è uscita precocemente. Inoltre, data la pervasività delle nuove tecnologie la cui applicazione
è importante per aumentare l’efficienza e mantenere la competitività in tutti i settori produttivi,
il fatto di non poter contare su un livello adeguato di capitale umano, ha rallentato l’adozione e
l’adattamento delle nuove tecnologie, comportando una perdita di efficienza in tutto il sistema
economico. Accumulando forti svantaggi verso i paesi che invece hanno saputo cogliere questa
opportunità.
Conseguentemente si è aperta una nuova fase di divergenza tra la dinamica dell’economia
italiana e quella degli altri paesi avanzati, soprattutto gli Stati Uniti, i quali hanno continuato a
rappresentare il paese leader tecnologicamente. Grazie alla ripresa dell’introduzione di
innovazioni radicali, centrate sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche, raggruppate attorno
all’area dell’informatica, dell’elettronica e delle comunicazioni, gli Stati Uniti hanno
accumulato in pochi anni un deciso vantaggio verso i paesi inseguitori. Al loro interno il
processo di cambiamento tecnologico è stato favorito dal fatto che esso avesse una forte
direzionalità verso la dotazione fattoriale più disponibile nel paese, ovvero il capitale umano di
elevata qualità, dotazione che in Italia invece scarseggiava91.
Negli anni Sessanta abbiamo visto che tutte le dimensioni del sistema Italia convergono la loro
crescita lungo una traiettoria comune, rafforzando il processo di crescita complessivo, invece,
90 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 46-47. 91 Ivi, pp. 48-49.
93
negli anni successivi, le varie dimensioni iniziano a svilupparsi lungo percorsi divergenti
portando il sistema ad un elevato livello di incoerenza che diverrà palese all’inizio degli anni
Novanta.
L’occasione di adottare le tecnologie più efficienti provenienti dall’estero, presentatasi dopo la
guerra, è stata prontamente sfruttata. Questo processo, unito al sussistere di altre condizioni, ha
consentito lo sviluppo di un sistema innovativo “atipico” che ancora oggi risulta essere
efficiente. Al contrario non si sono sfruttati i nostri progressi economici per costituire un sistema
innovativo “convenzionale” che ci avrebbe garantito di continuare il sentiero di crescita e di
divenire meno dipendenti sul piano tecnologico. Non essendo stato completato il processo di
emancipazione tecnologica, la struttura produttiva italiana ha assunto una composizione molto
più simile ad un paese in via di sviluppo che ad un paese avanzato.
In Italia, dopo aver raggiunto un livello di ricchezza soddisfacente, è prevalsa, in molte parti
della società, la generale tendenza ad una difesa oltranzista delle posizioni raggiunte, come se
il livello di ricchezza e lo status acquisito non potessero cambiare più. Non si è compreso che
nel mondo in cui viviamo, caratterizzato da continuo cambiamento ed evoluzione, per
mantenere la posizione acquisita bisogna continuare ad andare avanti, perché altrimenti altri
paesi, tutt’altro che immobili, ci sorpasseranno.
La responsabilità dell’inadeguata trasformazione del sistema economico italiano è sicuramente
da attribuire all’incapacità di mettere in pratica azioni volte a modificare alcune caratteristiche
strutturali italiane. Si è preferito un atteggiamento passivo ed attendista verso il mondo, illusi
dai tassi di crescita soddisfacenti, pensando che tutto andava per il meglio.
La crisi degli anni Novanta, politica ed economica, avrebbe dovuto mettere in allerta e
provocare la reazione della società italiana, che attraverso una ristrutturazione del sistema
economico e istituzionale avrebbe dovuto assecondare e sfruttare il cambiamento globale,
invece di subirlo passivamente. Nel prossimo capitolo vedremo se c’è stato questo
cambiamento e come i due sistemi innovativi si sono evoluti.
94
CAPITOLO III -
DA TANGENTOPOLI ALLA CRISI: IL VENTENNIO PERDUTO
ITALIANO
All’interno di questo capitolo viene proseguita l’analisi temporale dei due sistemi innovativi
italiani delineati nel precedente capitolo. Viene tracciata prima una breve descrizione generale
dell’andamento economico italiano a partire dagli anni Novanta fino ai giorni nostri, poi
vengono delineate le caratteristiche dei cambiamenti che hanno modificato il contesto globale:
l’accelerazione della globalizzazione e la terza rivoluzione industriale.
In seguito vengono completate le serie storiche delle statistiche relative all’innovazione che
erano state prese in considerazione nel capitolo precedente. Sulla base di questi dati vengono
descritte le dinamiche innovative italiane e come esse hanno influenzato la crescita.
Successivamente viene rilevato come le debolezze strutturali italiane sono diventate dei veri e
propri ostacoli all’innovazione e quindi allo sviluppo economico. Alla fine vengono delineate
le prospettive future delle dinamiche innovative italiane cercando di evidenziare quali azioni
sono necessarie affinché esse tornino a sostenere lo sviluppo economico.
1 L’Italia e il mondo che cambia
Nel corso di questo paragrafo viene osservato come i grossi cambiamenti, avvenuti a livello
globale dagli Anni Novanta in poi, abbiano avuto influenza sull’Italia. Prima viene descritto
l’andamento generale dell’economia italiana, successivamente lo sviluppo delle tecnologie
della Terza Rivoluzione industriale e il processo di crescita del settore dei servizi all’interno
delle economie avanzate.
95
1.1 Crollo politico ed economico
Con la fine degli anni Ottanta si entra in una fase nuova dell’economia italiana: un periodo
caratterizzato dal declino della sua posizione internazionale e dalla fine del processo di
convergenza verso il livello di ricchezza e di produttività dei paesi più avanzati. Infatti un deciso
rallentamento economico, peggiorato dalla crisi del 2007, provoca la perdita di molti dei
progressi ottenuti nei quarant’anni precedenti. Come vediamo dalla figura 3.1, con l’inizio degli
anni Novanta, comincia un trend divergente del nostro PIL pro capite nei confronti di quello
dei paesi più avanzati: da quel momento ad oggi abbiamo perso più del 10% della ricchezza nei
confronti degli Stati Uniti e della Germania e addirittura il 20% rispetto al Regno Unito.
Figura 3.1: Rapporto percentuale tra PIL pro capite italiano e quello di Germania, Regno Unito e USA, periodo 1990-2010
Fonte: mie elaborazioni su dati Maddison Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data.htm.
In questi anni sono venute a mancare quelle condizioni propulsive della crescita che avevano
contribuito a mascherare le debolezze strutturali dell’economia, delle istituzioni e della società
italiana1. Questo esaurimento delle condizioni favorevoli, assieme alla mancanza di flessibilità
e capacità di adattamento al mondo esterno, che pesano in questo momento storico più che nei
1 G. Toniolo, La crescita economica italiana, cit., pp. 40-41.
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
Italia/Germania Italia/USA Italia/UK
96
precedenti, hanno provocato un inevitabile peggioramento delle condizioni economiche.
Infatti, già dagli anni Settanta, risultava chiaro come uno dei limiti più evidenti dell’Italia fosse
l’incapacità di cambiare e di riformare il sistema, nonostante ci fosse la consapevolezza della
necessità di agire. È proprio questa, forse, la responsabilità più pesante di chi ha avuto il compito
di governare l’Italia. Dal momento in cui è stato raggiunto un certo livello di benessere, ognuno,
individuo o categoria, si è arroccato a difesa dei propri interessi, perdendo la concezione di
società. Non ci si è curati dei danni che gli interessi particolaristici ed i privilegi arrecavano agli
altri membri della società e alla società stessa e, soprattutto, si è persa la prospettiva di lungo
periodo, la progettualità orientata al futuro: si è agito senza preoccuparsi di ciò che ci sarebbe
stato dopo, con l’unico obiettivo di non alterare lo status quo. La mancanza di pianificazione
del futuro e di una leadership adeguata hanno lentamente, ma inesorabilmente, eroso il futuro
dell’Italia.
La crisi finanziaria del 2007, che è poi sfociata in una pesante crisi dell’economia reale, ha
palesato i limiti dell’economia italiana e ha fatto gridare a molti che “il Re è nudo”, ma forse
questa consapevolezza generalizzata è arrivata troppo tardi ed è ormai troppo stereotipizzata.
Figura 3.2: Tassi di crescita annuali del PIL pro capite, periodo 1991-2012
Fonte: mie elaborazioni su dati OECD, http://stats.oecd.org/.
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
Francia Germania Italia Giappone Spagna UK USA Totale paesiOECD
1991-2000 2001-2007 2008-2012 1991-2012
97
I tassi di crescita del PIL pro capite descrivono perfettamente il rallentamento progressivo
dell’economia italiana. Infatti, come possiamo vedere dalla figura 3.2, l’Italia fa registrare
l’aumento minore tra tutti i paesi avanzati: il suo Pil pro capite cresce, nell’intero periodo, di
solamente lo 0,49% annuo. Questo risultato è peggiore anche di quello del Giappone, per il
quale, riferendosi a questo arco di tempo, è stato coniato il termine “ventennio perduto”. Ma
allora non si potrebbe parlare anche per l’Italia di “ventennio perduto”, oppure potremmo
parlare di cronache di una disfatta annunciata? 2
Se incolpiamo le debolezze strutturali per il rallentamento dell’economia italiana, allora
bisogna anche chiedersi perché queste non abbiano influenzato la performance italiana negli
anni precedenti. La risposta è duplice: per prima cosa, come abbiamo visto nel secondo capitolo,
molte di queste debolezze hanno impattato in minor misura poiché la loro importanza era
inferiore nelle condizioni di lontananza dalla frontiera tecnologica e con la prevalenza delle
tecnologie della produzione di massa. Abbiamo visto, per esempio, come la debolezza di un
sistema di ricerca “convenzionale” e l’esiguità del capitale umano siano state superate da un
sistema d’innovazione alternativo le cui caratteristiche atipiche hanno consentito comunque di
produrre performance straordinarie. Al contrario con l’avvicinarsi alla frontiera tecnologica e il
progressivo cambiamento del mondo, accelerato dalla fine della guerra fredda, dalla spinta della
seconda globalizzazione, dalla creazione dell’Euro e della rivoluzione tecnologica, queste
debolezze strutturali sono diventate cruciali per determinare il destino del sistema economico
italiano. In secondo luogo, vediamo che un’altra dimensione ha acquistato sempre più
importanza nel determinare le performance dei paesi, ovvero l’efficienza istituzionale. Difatti,
per il funzionamento ottimale del sistema economico sono sempre di maggiore importanza
l’efficienza della Pubblica amministrazione, la regolamentazione dei mercati, l’efficacia della
giustizia e la qualità delle infrastrutture. Questo avviene perché oramai, in società complesse e
fortemente interconnesse come le nostre, la prestazione complessiva dipende da quella di
ognuna delle sue parti.
Il tentativo di migliorare l’efficienza istituzionale di cui parlavamo è stato compiuto negli Anni
Novanta, che infatti sono stati il teatro del più grosso tentativo di riforme che il sistema politico
costituzionale abbia mai varato dopo la sua nascita. Dopo lo scandalo di Tangentopoli, che
mette a nudo anni di malgoverno e corruzione, la Prima Repubblica arriva al termine. Assieme
2 Infatti il PIL pro capite del Giappone è cresciuto dello 0,78% annuo (cfr. OECD, http://stats.oecd.org/).
98
al passaggio verso la seconda Repubblica, vengono varate importanti riforme come quelle sulla
legge antitrust, il diritto societario, la riorganizzazione del sistema bancario e vengono decise
le privatizzazioni di molte società a partecipazione statale. Ma la portata e l’attuazione di tali
riforme sono risultate ampiamente inadeguate rispetto alle intenzioni e alle effettive azioni che
sarebbe stato necessario mettere in pratica per superare le inefficienze strutturali che minavano
la competitività italiana3.
Le altre economie mondiali, già a partire dagli anni Settanta, hanno mostrato una buona capacità
di adattarsi al cambiamento dell’economia mondiale, rivelando una maggiore duttilità rispetto
all’Italia, nella quale questa capacità è mancata completamente e l’unico elemento di flessibilità
emerso è rappresentato dal sistema dinamico delle PMI.
Al fine di valutare le performance del sistema istituzionale, la Banca Mondiale ha costruito
alcuni indici che misurano la qualità e l’efficacia di governo e l’impatto che il sistema
istituzionale ha sulla capacità di fare impresa. Coerentemente con quanto scritto sopra, la
posizione italiana in queste classifiche non è certo soddisfacente. Infatti, sui 215 paesi
considerati, i risultati italiani somigliano più a quelli di un paese in via di sviluppo con
istituzioni democratiche non molto progredite che a quelli di un paese avanzato. Come vediamo
dalle tabelle 3.1 e 3.2, in cui vengono riassunte le posizioni dell’Italia nelle differenti classifiche,
il miglior piazzamento risulta il 41° posto nella misurazione delle difficoltà che si incontrano a
registrare una proprietà. Ovviamente il paese che occupa il primo posto è considerato quello
dove si incontrano minori ostacoli. Nelle altre classifiche la situazione peggiora notevolmente,
fino ad arrivare al 147° posto in quella che misura la capacità di far rispettare i contratti. Questi
dati palesano come il funzionamento delle istituzioni e l’inefficienza dell’attività governativa
rappresentano effettivamente un forte limite per la crescita dell’economia italiana.
Tabella 3.1: Indicatori Doing Business, posizione dell’Italia nelle varie classifiche
Facilità di fare
impresa
Avviare un
impresa
Affrontare i
permessi per
costruire
Registrare
proprietà
Ottenere cre-
dito
Far rispettare
contratti
56 46 116 41 89 147
Fonte: mie elaborazioni su dati Doing Business, http://www.doingbusiness.org/.
3 N. Crafts, M. Magnani, L’Età dell’Oro e la seconda globalizzazione, cit., pp. 133-135; G. Toniolo, La crescita
economica italiana, cit., pp. 44-46; V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., pp. 429-434.
99
Tabella 3.2: Indicatori di governance, posizioni dell’Italia nelle varie classifiche
Controllo della corru-
zione Efficacia governativa
Qualità della regola-
mentazione Efficacia della legge
91 73 55 82
Fonte: mie elaborazioni su dati Banca Mondiale, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home.
Oltre a questi, anche altri fattori hanno contribuito al rallentamento dell’economia italiana:
l’incapacità di sfruttare il potenziale offerto dalle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT), la continua crescita dello stock di debito pubblico, la riduzione delle
dimensioni e della produttività delle grandi imprese italiane e il passaggio, con l’Euro, da una
durevole sottovalutazione ad una costante sopravvalutazione del tasso di cambio reale.
Il debito pubblico ha continuato la sua crescita anche all’inizio degli anni Novanta fino a
raggiungere il 121% del PIL nel 1994. Nonostante ciò negli anni successivi, grazie allo sforzo
compiuto per riuscire a far parte dell’area dell’Euro fin dalla sua creazione, si riesce a contenere
tale dinamica riportando il rapporto debito/PIL al 100%. Invece, dai primi anni del Duemila, la
dinamica negativa è nuovamente ripresa e, aggravata dalla crisi mondiale, ha portato il rapporto
debito/PIL ad un valore superiore al 130%. È evidente come questi livelli di debito siano un
ostacolo alla crescita e rendano praticamente impossibili azioni governative incisive che
comportino l’utilizzo di spesa pubblica4.
Per comprendere meglio perché un così alto debito rappresenti un evidente limite alla crescita,
bisogna considerare che la sua sostenibilità richiede un elevato regime di tassazione, la quale
ha l’effetto aumentare il costo del lavoro e sottrarre risorse che altrimenti potrebbero essere
destinate alla R&S, all’istruzione e agli investimenti in infrastrutture. Questa situazione è
effettivamente quella italiana, dove la pressione fiscale è da molti anni tra le più alte dei paesi
europei5.
Le grandi imprese italiane hanno sperimentato negli ultimi anni un’ulteriore riduzione delle
loro dimensioni medie e della loro numerosità, nonostante partissero da livelli già bassi se
4 F. Balassone, M. Francese, A. Pace, Debito pubblico e crescita economica, in G. Toniolo (a cura di), L’Italia e
l’economia mondiale, dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio Editori, 2013, pp. 712-714; cfr. Eurostat,
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 5 La pressione fiscale nominalmente è più elevata in altri paesi europei, ma se si considera l’effetto totale delle
tasse e delle imposte risulta che l’Italia ha la pressione fiscale più alta, soprattutto sulle imprese; cfr. World
Bank, http://data.worldbank.org/.
100
confrontati con quelli degli altri paesi avanzati. Oltre a questo, si è registrata anche una
diminuzione delle loro performance, soprattutto per quanto riguarda la produttività6.
Le PMI italiane, sebbene godano sicuramente di migliore salute, beneficiano in vari modi della
presenza delle grandi imprese: sia perché ne sono sub-fornitrici, sia perché la ricerca condotta
dalle grandi imprese ha effetti di spillover a cascata su tutto il sistema produttivo. Quindi
l’indebolimento delle imprese di maggiori dimensioni ha comportato effetti negativi anche sulle
PMI, tali conseguenze sfavorevoli sono risultate amplificate dal fatto che questo indebolimento
è avvenuto proprio nel momento in cui la capacità di R&S era molto importante per affrontare
la rivoluzione tecnologica7.
Anche la sopravvalutazione del tasso di cambio reale, conseguente all’ingresso nell’Euro,
potrebbe essere vista come un fattore che ha rallentato la crescita influenzando la dinamica delle
esportazioni8. Comunque è da considerare che l’introduzione della moneta unica ha avuto anche
numerosi effetti benefici quali la stabilità dei prezzi e la rapida discesa dei tassi d’interesse,
unita ad un maggior potere d’acquisto sulle importazioni, fattore importante per un paese che
dipende sostanzialmente dai paesi esteri per le sue forniture energetiche. Inoltre bisogna
valutare come l’apprezzamento del tasso di cambio potrebbe non essere la causa della nostra
perdita di competitività, ma potrebbe essere la conseguenza diretta dell’incapacità di effettuare
riforme incisive nel mercato del lavoro e dei prodotti9.
Un altro fattore che limita le possibilità di crescita in Italia è la scarsa introduzione nel processo
produttivo delle tecnologie general purpose dell’informazione e comunicazione (ICT), poiché
esse permettono di ottenere notevoli incrementi di efficienza e produttività. Infatti, nel
confronto con gli altri paesi avanzati, risulta che le imprese italiane utilizzano molto meno le
ICT, diminuendo conseguentemente la loro competitività10.
Questo limite è dovuto principalmente al fatto che il trasferimento e la diffusione di queste
tecnologie richiede un capitale umano maggiore, sia in termini quantitativi che qualitativi, di
quello che l’Italia ha saputo produrre negli ultimi anni. Inoltre, anche la piccola dimensione
6 G. Toniolo, La crescita economica italiana, cit., p. 42; gli addetti della grande impresa (+ di 500 addetti) sono la
metà rispetto a quelli degli altri paesi avanzati, con una riduzione maggiore della media negli ultimi anni;
inoltre il prodotto per ora lavorata di questa tipologia di imprese si è ridotto di un quinto all’inizio degli anni
Duemila. 7 Ibidem. 8 N. Crafts, M. Magnani, L’Età dell’Oro e la seconda globalizzazione, cit., pp. 138-139; l’Italia ha subito
dall’ingresso nell’Euro un apprezzamento del tasso di cambio reale del 7,5%. 9 G. Toniolo, La crescita economica italiana, cit., pp. 43-44. 10 N. Crafts, M. Magnani, L’Età dell’Oro e la seconda globalizzazione, cit., pp. 129-133.
101
delle imprese e l’eccessiva regolamentazione dei mercati, dei prodotti e del lavoro, hanno
frenato l’introduzione delle ICT nel sistema produttivo 11.
Un altro grande cambiamento che ha trasformato l’economia italiana è la sua terziarizzazione.
Infatti il settore dei servizi rappresenta oramai la parte preponderante dell’economia,
impiegando quasi il 70% degli occupati 12 . Questo processo è avvenuto con un aumento
esponenziale degli esercizi commerciali e della burocrazia, la parte per così dire meno “nobile”.
Al contrario non si è sufficientemente sviluppata quella parte dei servizi complementari e
sussidiari alla produzione, che sono quelli che registrano una maggiore crescita del fatturato a
livello mondiale e garantiscono maggiore valore aggiunto.
Questa composizione sbilanciata unita all’incapacità di sfruttare le ICT, che nel settore in
questione sono molto importanti, hanno causato una dinamica della produttività dei servizi del
tutto insoddisfacente: negli anni che vanno dal 1993 al 2007 essa cresce solamente dello 0,2%
annuo, contro tassi di crescita nei paesi avanzati abbondantemente sopra l’1,5%13. Lo scarso
sviluppo di un settore moderno dei servizi avanzati e ad alto contenuto di conoscenza, che sono
il comparto dei servizi dove le dinamiche innovative contano di più, è imputabile ai bassi livelli
di capitale umano14.
Abbiamo visto come le molte debolezze strutturali e altri fattori contingenti hanno rallentato la
crescita economica italiana dagli anni Novanta ad oggi, destando molti dubbi sulle effettive
capacità di sviluppo del nostro paese. Per evidenziare quello che è il punto cruciale possiamo
usare i risultati di un lavoro svolto da alcuni economisti dell’OECD, i quali hanno costruito un
indice che misura la capacità dei paesi di affrontare la globalizzazione, tenendo conto di
variabili istituzionali ed economiche. L’Italia in questa classifica è terzultima sui 26 paesi
considerati, solo la Polonia e la Grecia fanno peggio. Questo rende ancora più evidente quale
sia la natura della scarsa performance economica: l’Italia non è stata in grado di realizzare
cambiamenti strutturali e intraprendere politiche di lungo periodo, risultando così incapace ad
affrontare il cambiamento derivante dal processo di globalizzazione e dal continuo progresso
tecnologico15.
11 G. Toniolo, La crescita economica italiana, cit., p. 49; N. Crafts, M. Magnani, L’Età dell’Oro e la seconda
globalizzazione, cit., pp. 129-133. 12 S.N. Broadberry, C. Giordano, F. Zollino, La produttività, cit., pp. 278-279. 13 Ivi, p. 263; anche nel periodo 1973-1993 la produttività dei servizi era cresciuta solo dello 0,4% annuo. 14 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 304-305. 15 D. Rae, M. Sollie, Globalisation and the European Union: which countries are best placed to cope?, OECD,
Economics Department Working Papers no. 586, 2007, pp. 32-34.
102
1.2 La terza rivoluzione industriale e la terziarizzazione dell’economia
A livello globale, a partire dagli anni Settanta, hanno preso il via una serie di dinamiche di
cambiamento tecnologico che hanno progressivamente trasformato il sistema economico e
continuano a farlo tuttora. Tale processo è guidato dallo sviluppo e dall’inserimento nel sistema
produttivo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che rappresentano le
general purpose technology della terza rivoluzione industriale, ovvero quelle tecnologie
generali o multifunzione che esercitano la loro influenza su tutti i settori produttivi. Le ICT
portano ad un restringimento dello spazio, visto che riducono le barriere al movimento fisico di
merci e persone ma, soprattutto, consentono alla conoscenza e alle informazioni di viaggiare in
tempo reale. Per analogia si può parlare dello sviluppo delle ICT, nonché delle biotecnologie e
delle nanotecnologie, come della terza rivoluzione tecnologica16.
Le tecnologie dominanti nell’immediato Dopoguerra erano quelle appartenenti alla seconda
rivoluzione tecnologica, ovvero quelle caratterizzate dalle tecniche legate alla produzione di
massa, altamente incorporate in macchinari, facilmente codificabili e trasmissibili. Per il loro
utilizzo necessitavano di una dotazione di lavoratori caratterizzati da elevate competenze
tecniche, simili a quelle artigiane, seppur più complesse. Infatti, come abbiamo visto nel
precedente capitolo, la congruenza della dotazione italiana di lavoratori con tali tecnologie ne
ha consentito l’introduzione e lo sviluppo17. Detto in altri termini, è grazie alla presenza di
lavoratori dotati di tali competenze, acquisite sul lavoro o nelle scuole secondarie, assieme ad
un nutrito corpo di ingegneri, che l’Italia ha saputo sfruttare le opportunità connesse alle
tecnologie della produzione di massa e attivare quel processo di adozione creativa che si è
rivelato essenziale per promuovere la crescita economica italiana.
Con la terza rivoluzione industriale le caratteristiche necessarie per utilizzare efficientemente
le tecnologie dominanti sono cambiate. Infatti ora sono necessarie elevate conoscenze
tecnologiche incorporate nelle persone, altamente specifiche e difficilmente trasmissibili,
essendo il frutto di investimenti conoscitivi di lungo periodo e caratterizzate dalla
16 F. Amatori, A. Colli, Storia d’impresa. Complessità e comparazioni, Milano, Bruno Mondadori, 2012, pp. 195-
212. 17 F. Amatori, M. Bugamelli, A. Colli, Tecnologia, dimensione d’impresa e imprenditorialità, in G. Toniolo (a cura
di), L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio Editori, 2013 pp. 631-671; C.
Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 46-48.
103
complementarietà tra diversi campi di conoscenza18. Vale a dire che è richiesto il possesso di
elevati livelli di capitale umano, la cui base si acquisisce all’interno del sistema formativo
istituzionale.
Per questo motivo la dotazione fattoriale dell’Italia non appare molto congruente alle nuove
tecnologie, considerato che la mancanza di capitale umano è da sempre riconosciuta come una
debolezza strutturale del suo sistema economico. Nonostante ciò abbiamo visto come nel
processo di convergenza realizzato fino all’inizio degli Anni Novanta, questa mancanza non
abbia precluso le possibilità di realizzare una notevole crescita, non indotta attraverso
un’efficiente sistema d’innovazione “convenzionale”, ma attraverso altre dinamiche innovative
che non richiedevano livelli di capitale umano elevato. Oggi, invece, la sua insufficienza è
diventata uno dei maggiori ostacoli alla crescita poiché esso è indispensabile affinché le ICT
possano essere introdotte, diffuse ed efficientemente usate nel sistema economico19.
Ma la terza rivoluzione tecnologica non è ancora terminata, visto che deve ancora arrivare a
conclusione uno dei processi che essa ha portato con sé, ovvero la deindustrializzazione del
sistema produttivo. Infatti le tecnologie oggi in uso consentono già di avere livelli più elevati
di produzione a parità, o con meno occupati, rispetto a due decenni fa. Ma la tendenza che
sembra emergere è quella di una quasi totale robotizzazione del sistema manifatturiero che
comporterà molta più flessibilità ed efficienza nella produzione, ma richiederà molti meno
lavoratori, facendo così calare ancora di più la quota di occupati in questo settore. Per questo
motivo saranno i servizi legati alla produzione ad assumere un ruolo maggiore rispetto
all’attività di produzione stessa20.
A conferma di ciò si può vedere come la struttura dell’economia dei paesi avanzati sia cambiata,
andando verso un’estrema terziarizzazione: dal Secondo Dopoguerra ad oggi si è compiuto un
processo che ha portato il settore dei servizi a rappresentare la parte quantitativamente più
grande del sistema produttivo. In effetti, sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, la percentuale
di occupati nel settore dei servizi è superiore all’80% degli occupati, nella Germania si arriva
al 72% mentre l’Italia si ferma al 68%21.
La crescita del settore dei servizi in Italia è stata trainata dall’aumento delle attività commerciali
18 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 46-48. 19 C. Antonelli, Introduzione, in C. Antonelli (a cura di), Conoscenza tecnologia, Nuovi paradigmi
dell’innovazione e specificità italiane, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1999, pp. 8-12. 20 A third industrial revolution, in The Economist del 21/04/2012, http://www.economist.com/node/21553017. 21 S.N. Broadberry, C. Giordano, F. Zollino, La produttività, cit., pp. 277-279.
104
e della burocrazia, che sicuramente non rappresentano i comparti dei servizi più legati alle
dinamiche innovative22 . Nonostante questo, anche la loro efficienza può essere aumentata
notevolmente per mezzo dell’utilizzo delle ICT, quindi emerge che il ritardo nella loro
introduzione ha frenato la produttività anche in questi comparti.
La componente dei servizi che fa registrare, a livello mondiale, la maggiore crescita della
produttività e risulta maggiormente legata alle attività innovative è quella dei servizi ad alta
intensità di conoscenza (Knowledge Intensive Services, KIS), soprattutto quelli rivolti alle
imprese (Knowledege Intensive Business Services, KIBS). Essi riescono in molti modi ad
alimentare le dinamiche innovative, sia producendole al loro interno sia agendo da attore
principale nel miglioramento dell’efficienza di altre imprese23.
Questi rami dei servizi non hanno avuto uno sviluppo paragonabile a quella degli altri paesi
avanzati, difatti l’Italia presenta percentuali occupazionali al di sotto della media dell’Unione
Europea sia per i settori dei servizi ad alta intensità di conoscenza sia per il loro comparto ad
alta tecnologia (High-Tech KIS)24 . Questo andamento di sottodimensionamento può essere
imputato alla carenza di capitale umano che ha rallentato sia lo sviluppo dal lato dell’offerta di
servizi avanzati, sia la formazione di un’elevata domanda degli stessi25.
L’Italia non è riuscita a realizzare quell’interazione virtuosa, avvenuta negli Stati Uniti e nel
Nord Europa, tra l’introduzione delle ICT e lo sviluppo delle nuove industrie dei servizi ad alto
contenuto di conoscenza. Questo processo avrebbe portato ad un arricchimento della
specializzazione produttiva che avrebbe potuto valorizzare il contenuto innovativo delle
industrie manifatturiere, a condizione che si fossero ricreate quelle dinamiche tra settori a valle
e a monte che abbiamo analizzato nel secondo capitolo26. Quindi per l’Italia è avvenuta una
“triplice esclusione” legata alle nuove tecnologie: è rimasta esclusa dai settori manifatturieri
legati ad esse, è fortemente arretrata nella loro applicazione nel sistema produttivo e, adesso,
non partecipa allo sviluppo del settore dei servizi avanzati realizzati attraverso l’utilizzo
intensivo di tali tecnologie.
22 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., pp. 383-385. 23 OECD, Innovation and Knowledge-Intensive Service Activities, Paris, OECD, 2006, pp. 7-10. 24 Per i primi 33,9% contro la media UE29 di 39,2%, per i secondi 2,4% contro la media UE28 di 2,8%; cfr.
Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 25 C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, Innovazione e mutamento strutturale, cit., pp. 302-306. 26 Ibidem.
105
2 L’andamento dei sistemi innovativi italiani
Sono ampie le responsabilità della crisi italiana che sembrano poter essere imputate alle scarse
performance del sistema “convenzionale” di innovazione; perché questo, nel momento del
cambiamento di paradigma tecnologico, ha fatto mancare il suo cruciale contributo per favorire
l’introduzione delle nuove tecnologie nel sistema produttivo e lo sviluppo dei settori
tecnologicamente avanzati. A decretare queste dinamiche negative ha contributo molto anche il
basso livello di capitale umano.
Mancando tale spinta, l’innovazione e la crescita potrebbero essere state trainate, come nei
periodi precedenti, dal sistema “atipico” di innovazione basato sulle PMI ed i settori distanti
dalla frontiera tecnologica. Ma sembra probabile che anche questo sistema abbia risentito della
mancata introduzione al suo interno delle tecnologie ICT, poiché esse avrebbero consentito
notevoli guadagni di efficienza che invece sono mancati.
Per verificare queste affermazioni e analizzare le performance che i due sistemi d’innovazione
italiani hanno fatto registrare dagli anni Novanta fino ai giorni nostri, la trattazione prosegue
completando, temporalmente fino ai giorni nostri, l’apparato statistico tracciato nel secondo
paragrafo del precedente capitolo. Questo consentirà di valutare il ruolo e la consistenza delle
dinamiche innovative italiane nell’ultimo ventennio.
2.1 L’innovazione diminuisce
Come già è avvenuto nel secondo capitolo viene supposto che l’andamento della TFP descriva
in modo appropriato il risultato delle dinamiche innovative all’interno del sistema economico.
Analizzando l’andamento della TFP italiana percepiamo come nel periodo considerato la sua
dinamica è molto deludente nel confronto con i paesi più avanzati. Infatti, come si può vedere
dalla figura 3.3, nel periodo 1995-2012 si registra una decrescita dello 0,06% annuo. Dal
confronto emerge come l’Italia sia l’unico paese, tra quelli presi in esame, a far registrare una
diminuzione. Anche il Giappone e la Spagna, nonostante i loro problemi, riescono a fare meglio,
facendo registrare un tasso di crescita annuo rispettivamente dello 0,70% e dello 0,12%.
Al fine di analizzare meglio questo arco di tempo si possono individuare tre periodi che fanno
registrare trend differenti: negli anni Novanta la dinamica rimane ancora leggermente positiva,
106
con una crescita dello 0,68% annuo negli anni dal 1995 al 2000; a cominciare dall’anno 2001
si registra una lieve decrescita annua dello 0,23% fino al 2006; successivamente all’inizio della
crisi si registra un ulteriore peggioramento, con una diminuzione dello 0,63% annuo dal 2007
al 2012.
Figura 3.3: Tassi di crescita annuali della TFP, periodo 1995-2012
Fonte: mie elaborazioni su dati OECD, http://stats.oecd.org/.
Come si può facilmente vedere l’Italia è l’unico paese che fa registrare un andamento
decrescente anche nel periodo 2001-2006, sintomo del fatto che già prima della crisi la nostra
economia si trovava in una situazione di forte difficoltà, incapace ad adattarsi e gestire i
cambiamenti della situazione globale.
Altri dati forniti recentemente dall’ISTAT forniscono un quadro leggermente meno cupo per
quel che concerne la TFP sia per il periodo 2001-2006 che per il periodo post-crisi. Comunque
il lieve miglioramento proposto non cambia la valutazione complessiva dell’economia italiana
né la sua posizione in confronto agli altri paesi avanzati. Quello che ci interessa è la valutazione
che viene a delinearsi sui comparti manifatturieri: da questi dati sembra emergere che essi
riescano a mantenere una dinamica della produttività leggermente positiva fino all’avvio della
crisi e che questo andamento dipenda quasi totalmente dalla TFP, la quale di conseguenza
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
Francia Germania Italia Giappone Olanda Spagna Regno Unito Stati Uniti
1995-2000 2001-2006 2007-2012 1995-2012
107
risulterebbe essere stata positiva all’interno del settore almeno fino al 200727.
Tale dinamica della TFP può essere vista come la risultante di due forze opposte scaturite
dall’andamento bivalente del settore manifatturiero: alcuni comparti, più esposti alla
concorrenza, hanno saputo mettere in atto processi di ristrutturazione organizzativa che hanno
portato a notevoli guadagni di efficienza e al mantenimento della competitività internazionale.
Altri comparti, meno esposti alla competizione globale, hanno invece continuato a diminuire la
loro efficienza e di riflesso la loro competitività28.
Coerentemente con quanto supposto, possiamo affermare che nel sistema economico italiano si
è verificato un forte rallentamento nell’introduzione di innovazioni, che ha causato la riduzione
dell’efficienza produttiva e, di conseguenza, le bassissime performance di crescita.
Le cause di questo rallentamento delle dinamiche innovative possono essere ricondotte alle
difficoltà italiane ad introdurre e adottare le tecnologie ICT all’interno del sistema produttivo,
a sviluppare la parte dei servizi a maggior valore aggiunto e ad aumentare la propria presenza
nei settori manifatturieri ad alta tecnologia. Ovvero l’Italia ha assunto una posizione marginale
in tutti quei settori a maggiore crescita della produttività a livello globale e dove le dinamiche
innovative sono risultate maggiori negli ultimi anni.
2.2 Ricerca e Sviluppo: un mancato decollo
Nel periodo considerato in questo capitolo l’andamento delle spese in R&S italiane non è
migliorato rispetto al quarantennio precedente poiché esse hanno continuato a rimanere basse
nel confronto con quelle degli altri paesi avanzati. Nonostante ciò, all’interno di questo periodo
si possono distinguere due specifiche fasi caratterizzate da trend opposti: una di diminuzione
per tutti gli anni Novanta, e una di lieve aumento che parte dall’anno Duemila.
Il divario con gli altri paesi avanzati, come si vede dalla figura 3.4, si mantiene elevato, difatti
le spese italiane sono inferiori alla metà di quelle degli altri paesi considerati. L’unica eccezione
è rappresentata dal Regno Unito con il quale è in atto un processo di convergenza, dovuto però
27 S.N. Broadberry, C. Giordano, F. Zollino, La produttività, cit., pp. 302-304; ISTAT, Misure di produttività, anni
1991-2011, Roma, ISTAT, pp. 6-11. 28 A. Accetturo, A. Bassanetti, M. Bugamelli, I. Faiella, P. Finaldi Russo, D. Franco, S. Giacomelli, M. Omiccioli,
Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza no.
193, 2013, pp. 15-16.
108
maggiormente al processo di forte decrescita inglese che ai nostri progressi.
Figura 3.4: Spese in R&S sul PIL, periodo 1991-2012
Fonte: mie elaborazioni su dati OECD, http://stats.oecd.org/.
L’inversione di tendenza, cominciata nel 2000, potrebbe essere dovuta all’impegno profuso
dall’Italia per tentare di seguire le raccomandazioni della Strategia di Lisbona varata da parte
delle istituzioni europee. In effetti con essa si esaltava il ruolo dell’innovazione e della
conoscenza considerandoli come i fattori chiave per trasformare l’Europa nella regione più
competitiva del mondo. Inoltre veniva posto l’obiettivo di raggiungere, entro il 2010, la quota
del 3% di spese in R&S in rapporto al PIL, i due terzi dei quali finanziati delle imprese29. La
crisi ha sicuramente compromesso la possibilità di raggiungere tale traguardo, che sarebbe stato
comunque irraggiungibile per molti paesi europei, Italia in testa, anche in condizioni di crescita
costante. Le linee guida di Lisbona sono state riprese nella strategia Europa 2020, che ripropone
molti obiettivi e ne fissa di nuovi.
L’intenzione di raggiungere il 3% del PIL di spese in R&S è stato confermato ma, allo stato
29 M. Decaro, Cronaca di un decennio nell’Unione Europea, fra governance e government, in M. Decaro (a cura
di), Dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020, Fondazione Adriano Olivetti, 2011, risorsa on-line
http://www.fondazioneadrianolivetti.it/_images/pubblicazioni/collana/120111100032Strategia%20di%20Lis
bona.pdf, pp. 35-40.
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Francia Germania Italia Giappone Regno Unito USA
109
attuale, per l’Italia sembra impossibile farcela. Difatti, nonostante il percorso di aumento che
prosegue dal 2000, le spese in R&S dell’Italia continuano a rappresentare una quota
insoddisfacente del PIL italiano: l’1,27%30.
Molti paesi europei, che partivano da livelli considerevolmente più alti del nostro, sono stati in
grado far registrare tassi di crescita più elevati, raggiungendo anticipatamente l’obiettivo31 .
Conseguentemente a queste dinamiche il divario italiano nei confronti dei paesi europei si è
ampliato notevolmente.
Anche le imprese italiane non hanno fatto registrare nessun miglioramento, visto che
continuano a mantenere livelli di spese in R&S significativamente più bassi rispetto alle loro
concorrenti dei paesi avanzati. Concentrandoci sui paesi europei di maggiori dimensioni,
vediamo come il distacco rimanga notevole: le spese in R&S delle imprese italiane
rappresentano la metà di quelle inglesi, un terzo di quelle francesi e un quinto di quelle
tedesche32.
Pure la ripartizione delle spese tra la ricerca pubblica e le imprese continua ad essere sbilanciata,
con le imprese italiane che finanziano solamente il 54% della R&S svolta in Italia, mentre le
loro concorrenti europee finanziano in media il 64% della spesa sostenuta nei loro paesi; in
Germania e negli Stati Uniti la percentuale è ancora maggiore33. In effetti l’indebolimento della
R&S italiana si può attribuire alla diminuzione delle spese da parte delle imprese private,
soprattutto quelle che sono state privatizzate a partire dagli anni Novanta34.
Usando come termine di paragone gli stessi paesi considerati prima, ovvero Germania, Francia
e Regno Unito, procediamo nel valutare le differenze settoriali di spesa in R&S tra le imprese
italiane e le loro concorrenti in questi paesi. La prima considerazione da fare è che il divario
nel settore manifatturiero è minore rispetto a quello nel settore dei servizi: nel primo le spese
italiane sono il 17,8% di quelle tedesche, il 54,7% di quelle francesi e il 97,9% di quelle inglesi,
mentre nel secondo le spese italiane sono il 37% di quelle tedesche, il 18,5% di quelle francesi
e il 21,7% di quelle inglesi35.
30 Commissione Europea, Bilancio della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, allegato della COM(2014) 130 final, pp. 6-9. 31 Ibidem; Tra i paesi che hanno già raggiunto l’obiettivo o sono in procinto di farlo ci sono Svezia, Finlandia,
Danimarca, Germania e Austria. 32 Tale rapporto tra l’Italia e gli altri paesi rimane praticamente costante, usando una certa approssimazione per il
periodo che va dal 1991 al 2012; cfr. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 33 Ibidem. 34 F. Barbiellini Amidei, J. Cantwell, A. Spadavecchia, Innovazione e tecnologia straniera, cit., pp. 557-560. 35 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
110
Figura 3.5: Rapporto tra le spese in R&S sul PIL di alcuni settori italiani e gli stessi settori di Germania, Francia e Regno Unito
Fonte: mie elaborazioni su dati Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
All’interno della manifattura, come vediamo dalla figura 3.5, i settori che si distinguono per
una migliore prestazione sono quelli tradizionali, soprattutto il tessile e il comparto del mobile,
uniti ai settori che utilizzano tecnologie intermedie, come la meccanica, i mezzi di trasporto e
gli elettrodomestici.
Si conferma invece l’arretramento, cominciato negli anni Ottanta, nei settori tecnologicamente
avanzati, soprattutto nell’elettronica. Anche la chimica diminuisce il suo impegno nella R&S
rispetto al periodo precedente.
In conclusione, nonostante la crescente enfasi posta sul ruolo che la R&S ha nell’alimentare la
crescita economica, l’Italia non è riuscita ad incrementare in modo sostanzioso le proprie spese,
facendo così aumentare ancora il distacco nei confronti degli altri paesi avanzati.
2.3 L’attività brevettuale
Nel passaggio al terzo millennio, così come l’attività di R&S italiana, anche l’attività
brevettuale continua a non dare segni di dinamismo, non riuscendo a compiere quel salto di
qualità che le avrebbe permesso di innescare una dinamica convergente verso gli altri paesi
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Italia/Germania Italia/Francia Italia/Regno Unito
111
avanzati.
Le statistiche sui brevetti ottenuti dalle imprese italiane all’USPTO ci mostrano come
l’andamento decrescente sia ripreso dopo la lieve crescita registrata negli anni Ottanta,
proseguendo ininterrottamente fino ai giorni nostri, senza dare l’impressione di imminenti
inversioni di rotta.
Figura 3.6: Quota di brevetti rilasciati dall’USPTO (esclusi gli Stati Uniti), periodo 1991-2012, Germania e Giappone vengono esclusi dal grafico al fine di consentire un migliore visualizzazione grafica
Fonte: mie elaborazioni su dati USPTO,
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/naics/naics_stc_fgall/naics_stc_fg.htm.
Come si può osservare dalla figura 3.6, la prestazione complessiva italiana continua a non essere
adeguata alle dimensioni della nostra economia. Esattamente, negli ultimi vent’anni l’Italia ha
perso il 40% della sua quota sul totale dei brevetti concessi a paesi stranieri, passando dal 2,67%
del 1991 al 1,60% del 2012. Questa diminuzione le consente di conseguire il poco nobile
risultato di essere il paese, tra quelli considerati, che ha visto la propria quota deteriorarsi
maggiormente. La figura 3.6, che omette le quote di Germania e Giappone (nel 2012
rispettivamente del 10,47% e del 38,45%), ci mostra come la forte crescita dei paesi asiatici,
Corea e Taiwan, eroda le quote dei paesi europei. Comunque, nel confronto con l’Italia, le altre
economie continentali perdono una quota percentuale minore, facendo emergere come sia in
atto un processo di divergenza che continua ad ampliare il già consistente ritardo italiano
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Regno Unito Francia Corea del sud Taiwan Italia Svezia Olanda
112
nell’attività brevettuale.
Come già visto nel secondo capitolo, la registrazione dei brevetti negli Stati Uniti è un’attività
intrapresa dalle grandi imprese, soprattutto nei settori avanzati. Quindi i risultati emersi stanno
a significare che c’è stato un ulteriore indebolimento della grande impresa italiana nella
produzione di conoscenza scientifica.
Figura 3.7: Quota di brevetti rilasciati dall’EPO (eccetto Stati Uniti), periodo 1991-2013, Germania e
Giappone vengono esclusi dal grafico al fine di consentire una migliore visualizzazione grafica
Fonte: mie elaborazioni su dati Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
La prestazione delle imprese italiane all’EPO è sempre risultata migliore, grazie al maggiore
contributo delle PMI. Nonostante questo anche all’ufficio europeo, dagli anni Novanta, la quota
italiana inizia a scendere, senza però innescare una dinamica divergente come all’USPTO.
Nella figura 3.7 vengono analizzate le quote di brevetti presentati all’EPO. Al fine di rendere
questi dati maggiormente paragonabili con quelli relativi all’USPTO (figura 3.6), le quote sono
state calcolate ignorando nel computo totale dei brevetti quelli ottenuti dagli Stati Uniti, come
avviene per le statistiche relative all’ufficio americano.
La quota italiana di brevetti passa dal 5,12% del 1991 al 4,02% del 2012. Questa diminuzione
insinua alcuni dubbi sulla competitività delle nostre piccole e medie imprese nel contesto
europeo. Osservando però le diminuzioni, ancora più marcate, delle quote di brevetti fatte
registrare da paesi come Germania, Francia e Regno Unito, le preoccupazioni si attenuano e
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Francia Italia Olanda Austria
Finlandia Svezia Regno Unito Corea del Sud
113
anzi emerge come, con questi paesi, sia in atto un lento processo di convergenza. Analogamente
con quanto emerso sul periodo analizzato nel precedente capitolo, osserviamo come continui a
permanere la situazione che vede i risultati sulla sponda europea dell’Atlantico migliori e con
distacchi molto meno consistenti nei confronti dei paesi più avanzati.
Figura 3.8: Quota di brevetti concessi all’USPTO per settore, periodo 1991-2012
Fonte: mie elaborazioni su dati USPTO,
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/naics/naics_stc_fgall/naics_stc_fg.htm.
Per analizzare le prestazioni settoriali torniamo a basarci sui dati relativi all’USPTO. Dalla
figura 3.8 si vede come continui la decrescita del settore dell’elettronica, incapace di sviluppare
conoscenza propria e quindi totalmente dipendente, come vedremo anche nel paragrafo
dedicato alla bilancia tecnologica dei pagamenti, dalla tecnologia estera. Il settore delle
apparecchiature elettriche offre una prestazione migliore, dovuta soprattutto ai buoni risultati
del comparto degli elettrodomestici che sono riusciti a rimanere competitivi nell’arena
internazionale.
Invece si conferma la progressiva de-specializzazione della chimica che, però, a partire dal 2007
sembra aver arrestato la caduta, riuscendo a crescere negli anni successivi e superare
nuovamente la quota del 3%. Anche i mezzi di trasporto hanno saputo progressivamente
riprendersi fino a tornare a livelli superiori della quota italiana complessiva. La gomma e
plastica è il settore che nel periodo ottiene la migliore performance raggiungendo livelli elevati.
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
Mezzi di trasporto Apparecchi elettrici Elettronica Macchinari
Gomma e plastica Chimica Tutti i settori
114
La meccanica ha cominciato invece una progressiva decrescita che, se continuasse, potrebbe
rivelarsi preoccupante, nonostante al momento i suoi livelli di attività brevettuale siano adeguati.
Altri due settori che negli ultimi anni hanno acquisito una buona capacità brevettuale sono il
tessile e l’alimentare: entrambi detengono quote superiori al 3,5%, anche se è da considerare
che il numero di brevetti in questi settori è veramente limitato.
Barbiellini Amidei, Cantwell, Spadavecchia (2013) hanno proposto un indice che misura il
vantaggio competitivo dei diversi settori nell’attività brevettuale: i loro risultati sono coerenti
con l’analisi fin qui svolta, infatti i comparti con l’indice più elevato risultano essere il tessile,
l’alimentare, la chimica, la gomma e plastica e i macchinari36.
Quello che emerge da questa analisi è che l’indebolimento della capacità brevettuale è
proseguito senza dare segnali di una possibile inversione del trend. La situazione che desta più
preoccupazione è quella all’USPTO dove la quota italiana, pur partendo da livelli bassi, si è
erosa maggiormente rispetto agli altri paesi avanzati. Invece la situazione all’EPO, nonostante
la diminuzione registrata, appare migliore. Quindi la decrescita dell’attività brevettuale è da
imputarsi maggiormente alla grande impresa, mentre risulta che le PMI abbiano saputo
difendersi meglio. A conferma di ciò si registra, sia all’EPO che all’USPTO, un aumento della
registrazione da parte delle imprese italiane di disegni, marchi e modelli. Infatti in queste attività
di registrazione, portate avanti soprattutto dalle PMI, l’Italia occupa la quarta posizione in
Europa e la quinta oltreoceano, risultati nettamente migliori rispetto alla produzione
brevettuale37.
Quindi dagli anni Novanta ad oggi è continuato il processo di peggioramento della performance
dei settori ad alta tecnologia italiani, mentre si è confermata la specializzazione nei settori
tradizionali e in quelli a tecnologia intermedia. Il sistema innovativo “convenzionale”, invece
di produrre risultati che lo facessero avvicinare ai livelli degli altri paesi, è sprofondato in una
dinamica negativa che lo ha reso ancora più inadatto a contribuire ad un possibile rilancio
tecnologico italiano.
36 Il vantaggio tecnologico risulta con un indice superiore ad 1, nel periodo dal 2001 al 2008 il tessile registra un
indice di 2.17, la chimica 1.56, la gomma e plastica 1.64, i macchinari 1.53 e l’alimentare 1.80. All’estremo
opposto, con la situazione peggiore, si trova il settore dell’elettronica con un indice di 0,59; F. Barbiellini
Amidei, J. Cantwell, A. Spadavecchia, Innovazione e tecnologia straniera, cit., p. 542. 37 F. Barbiellini Amidei, J. Cantwell, A. Spadavecchia, Innovazione e tecnologia straniera, cit., pp. 538-544.
115
2.4 Acquistare tecnologia all’estero
La bilancia tecnologica italiana dei pagamenti (BTP) ha risentito di due grossi cambiamenti nel
commercio di tecnologia a livello mondiale: l’aumento notevole degli scambi e la crescita
esponenziale di due voci che prima risultavano residuali, ovvero i servizi a contenuto
tecnologico e la R&S realizzata all’estero. Sulla scia di questi processi la BTP italiana ha visto
crescere ampiamente le sue dimensioni, a testimonianza di ciò la somma di introiti ed esborsi è
triplicata nell’arco di un ventennio, passando dallo 0,6% del Pil nel 1992, all’1,8% del 201238.
Come si può vedere dalla figura 3.9, gli introiti continuano ad essere costantemente minori degli
esborsi, solamente negli anni 2006 e 2007 si riesce ad avere un leggero avanzo nella BPT.
Il deficit italiano appare un’eccezione tra i paesi avanzati, visto che negli ultimi anni anche la
Spagna ha cominciato a far registrare dei surplus nella BPT. Il miglioramento che osserviamo
nel 2012 non deve trarre in inganno poiché esso è influenzato da una enorme transazione
compiuta verso il Regno Unito; se la si esclude dal computo totale, la prestazione del 2012
risulta del tutto simile a quella del 201139.
Figura 3.9: Rapporto Introiti/Esborsi della bilancia dei pagamenti tecnologica, periodo 1991-2012
Fonte: mie elaborazioni su dati OECD, http://stats.oecd.org/.
38 F. Tosti, La bilancia dei pagamenti della tecnologia dell’Italia, Banca d’Italia, Questioni di Economia e
Finanza no. 207, 2013, p. 18. 39 Ivi, p.8; l’operazione in questione riguarda la vendita dei diritti di emissione (certificati di CO²2).
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
Francia Germania Italia Giappone
Spagna Regno Unito Stati Uniti
116
La continuità con il periodo precedente agli anni Novanta è confermata dal persistere di alcune
dinamiche: tra queste, una delle più importanti sembra essere il perdurante deficit nello scambio
di brevetti, licenze e invenzioni, che costituiscono ancora il maggior motivo di esborso40. Infatti,
come si può vedere dalla figura 3.10, le ultime due voci in basso, che sono quelle che
comprendono i brevetti, le licenze e le invenzioni, sono pesantemente in disavanzo. Dalla stessa
figura si può vedere come l’altra attività in cui l’Italia deve acquisire elevati livelli di tecnologia
dall’estero è quella dei servizi informatici. Tutto ciò è coerente con le considerazioni svolte fin
qui sulle difficoltà italiane nel campo delle tecnologie ICT e sull’importanza del livello di
capitale umano.
Figura 3.10: Contributo alla BTP italiana cumulata per il periodo 2008-2012 per tipologia di transazione e per macro-settore
Fonte: mie elaborazioni su dati Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/statistiche/; E. Tosti. La bilancia dei
pagamenti della tecnologia dell’Italia, cit., pp. 22-24.
Le sole attività in cui l’Italia fa registrare un surplus della BTP sono i servizi di R&S e quelli di
architettura, ingegneria e altri servizi tecnici. Questi ultimi costituiscono uno dei pochi, se non
l’unico, punto di forza del macro-settore dei servizi dell’economia italiana; difatti, come
40 Ivi, pp. 5-6; Queste non sono più direttamente rintracciabili nelle voci della BTP perché è stato cambiato il
raggruppamento e il nome delle voci; con la nuova denominazione i brevetti, licenze e invenzioni sono
ricompresi nelle voci “Compravendita attività intangibili” e “Sfruttamento altre attività intangibili”.
-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
Compravendita attività intangibili
Sfruttamento altre attività intangibili
Sfruttamento conc. e diritti simili
Serv. architettura e ingegneria
Servizi informatici
Servizi di R&S
Servizi Manifattura Totale
117
vedremo in seguito, le imprese attive in tale comparto riescono ad assicurare un saldo positivo
nell’interscambio di tecnologia non incorporata di loro competenza.
Un altro aspetto merita di essere sottolineato poiché è coerente con quanto affermato fino ad
ora: l’intero deficit della BPT è da imputare all’andamento del settore dei servizi, mentre la
manifattura mantiene un sostanziale equilibrio tra esborsi e introiti.
Viene confermata anche un’altra tendenza dell’Italia, anche se meno accentuata rispetto al
periodo precedente agli anni Novanta, cioè quella di importare in larga scala dai paesi più
avanzati tecnologicamente e esportare in misura maggiore verso i paesi in via di sviluppo.
Questo a testimonianza del fatto che la base tecnologica italiana non è ancora al livello degli
altri paesi avanzati, verso cui manteniamo un certo grado di dipendenza tecnologica41.
Come accennavo prima, il settore italiano dei servizi è ancora molto arretrato a livello
tecnologico, solamente il comparto dei servizi di architettura e ingegneria sembra essere in
controtendenza. A conferma di ciò, come vediamo dal grafico 3.11, questo risulta l’unico
comparto che riesce a far registrare un surplus; gli altri invece riportano pesantissimi deficit,
soprattutto nelle telecomunicazioni e informazioni e nei servizi informatici.
Figura 3.11: Contributo alla BTP cumulata 2008-2012 per settore economico
Fonte: mie elaborazioni su dati Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/statistiche/; E. Tosti. La bilancia dei
pagamenti della tecnologia dell’Italia, cit., pp. 22-24.
41 Ivi, pp. 12-13.
-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Tessile e abbigliamento
Prodotti petroliferi raffinati
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici
Gomma e materie plastiche
Autoveicoli e mezzi di trasporto
Servizi del commercio
Servizi informatici
Telecom. e informazioni
Servizi di arch. e ingegneria
118
Per quanto riguarda la manifattura vediamo come i settori che fanno registrare i maggiori
surplus sono i mezzi di trasporto assieme alla gomma e materie plastiche. Le peggiori
performance sono quelle dei settori chimico, petrolifero e del tessile e abbigliamento. La
presenza di quest’ultimo settore fra quelli in disavanzo desta sorpresa ma può forse essere
spiegata dal largo ricorso all’acquisto di design, marchi e progetti esteri.
È quindi confermato il persistente deficit italiano negli scambi internazionali di tecnologia non
incorporata; questo risultato appare coerente con le peculiarità e i limiti del sistema economico
italiano nella produzione di tecnologia, infatti il deficit si concentra nelle voci considerate il
nucleo della BPT: compravendite e concessioni dei diritti di sfruttamento di brevetti, royalties,
invenzioni e altre licenze.
Il deficit della BPT è legato all’atipicità del sistema produttivo italiano, difatti il disavanzo è
provocato proprio da quei settori che, al contrario del resto delle economie avanzate, hanno
avuto uno scarso sviluppo: i settori dei servizi e quelli manifatturieri ad alta tecnologia.
2.5 Macchinari e investimenti
Nel paragrafo 2.6 del precedente capitolo abbiamo visto tutte le dinamiche con le quali
l’introduzione di macchinari conduce alla realizzazione di innovazioni e al miglioramento
dell’efficienza produttiva. Inoltre abbiamo osservato come l’Italia negli anni Cinquanta e
Sessanta ha fatto ampio ricorso all’importazione di beni capitali per introdurre tecnologia
avanzata estera. Grazie a questo sforzo e, conseguentemente alle dinamiche sviluppatesi
all’interno delle filiere tra produttori di beni capitali e utilizzatori, le imprese italiane sono
riuscite a produrre macchinari di alta qualità che hanno conquistato quote sempre crescenti delle
esportazioni mondiali. Come risultato di questo circolo virtuoso le imprese italiane hanno
dovuto far ricorso in misura sempre minore all’importazione di tecnologia incorporata,
avendola già disponibile nel mercato interno. Ad ogni modo il settore dell’elettronica è rimasto
completamente escluso da questo processo, facendo registrare importazioni sempre nettamente
maggiori rispetto alle esportazioni.
Comunque dagli anni Settanta sia le importazioni di macchinari che gli investimenti
complessivi hanno fatto registrare un calo generalizzato che ha frenato l’introduzione di
tecnologia incorporata nel sistema economico.
119
Figura 3.12: Rapporto Esportazioni/Importazioni di alcuni settori economici, periodo 1991-2013
Fonte: mie elaborazioni su dati UN Comtrade, http://comtrade.un.org/.
Come possiamo vedere dalla figura 3.12, le dinamiche del periodo precedente sono continuate
anche a partire dagli anni Novanta, subendo una polarizzazione: i comparti dei macchinari
generali e specializzati hanno continuato ad incrementare la loro competitività internazionale,
mentre i comparti dei computer e delle apparecchiature per la telecomunicazione non sono
riusciti a svilupparsi, anzi la dipendenza dalle macchine estere è ancora aumentata, visto che
oggi le importazioni rappresentano il doppio delle esportazioni.
La dinamica degli investimenti italiani non è molto diversa da quella degli altri paesi avanzati,
ma le differenze emergono se scomponiamo gli investimenti in macchinari e asset intangibili,
più legati alle nuove tecnologie ICT.
Come possiamo vedere dalla figura 3.13, l’Italia ricorre maggiormente ai macchinari,
spendendo per essi una quota del PIL vicina al 7%; al contrario sborsa pochissime risorse per
l’acquisto di beni intangibili, solamente l’1% del PIL. La quota del PIL destinata all’acquisto
di beni capitali degli altri paesi oscilla tra il 4% e il 6%, facendo risultare l’Italia come il
maggiore investitore in questi beni. Invece per i beni immateriali la quota dell’Italia, assieme a
quella tedesca, risulta la più bassa considerando che quella degli altri paesi è in media del 2%.
Coerentemente con la specializzazione italiana, i risultati confermano che ancora oggi
l’acquisto di tecnologia incorporata rappresenta uno dei maggiori canali di introduzione di
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
Macchinari specializzati Macchinari generali
Computer Apparecchi per le telecomunicazioni
Apparecchi elettrci
120
innovazioni in Italia. Al contrario si riscontra ancora molta difficoltà nell’investire in asset
intangibili poiché essi sono più legati alle tecnologie dell’ICT e al livello di capitale umano.
I comparti dei macchinari generali e specializzati hanno mantenuto una buona performance,
continuando a produrre macchinari di qualità, con la conseguenza che si confermano uno dei
maggiori punti di forza dell’economia. Al contrario l’elettronica prosegue nel suo arretramento,
continuando a rappresentare un punto di debolezza del sistema economico italiano.
Figura 3.13: Spesa media in rapporto al Pil per gli Investimenti in macchinari (MACC) e in asset fissi intangibili (AI), periodo 1991-2012
Fonte: mie elaborazioni su dati Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
2.6 Istruzione formale e apprendimento informale
In questo capitolo sono state fatte molteplici considerazioni sul ruolo di freno alla crescita
economica rappresentato dal basso livello di capitale umano, analizzando le varie dinamiche
tramite le quali esso blocca l’innovazione e il miglioramento dell’efficienza produttiva.
Ora consideriamo l’evoluzione delle statistiche sull’istruzione in Italia dagli Anni Novanta ad
oggi, al fine di comprendere se si sono registrati dei miglioramenti e determinare quale sia la
situazione attuale.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
UE a 15 Danimarca Germania Spagna Francia Italia Olanda Svezia RegnoUnito
AI 1991-2000 AI 2001-2012 MACC 1991-2002 MACC 2001-2012
121
La percentuale di laureati sul totale della popolazione italiana continua a rimanere molto più
bassa rispetto agli altri paesi avanzati, attestandosi al 15%. Anche se dagli anni Novanta ad oggi
sono stati compiuti notevoli progressi, con la quota di laureati che è aumentata di 5 punti
percentuali, la distanza con gli altri paesi considerati rimane ampissima. In effetti tutti gli altri
paesi superano la quota del 25% ed alcuni, come Belgio e Irlanda, riescono a raggiungere
percentuali attorno al 40%. Per colmare questo ritardo sarà necessario molto tempo.
Figura 3.14: Percentuale di laureati (livello ISCED 5-6) sul totale della popolazione, periodo 1992-2012
Fonte: mie elaborazioni su dati Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei laureati nel sistema economico, l’Italia risulta ancor più
indietro rispetto ai paesi avanzati. Infatti, come possiamo vedere dalla figura 3.15, solo il 15%
degli occupati italiani ha una laurea contro una media degli altri paesi del 30%.
Anche in questo campo i progressi dell’Italia dagli anni Novanta sono stati notevoli, ma la
distanza rimane evidente e molto ardua da riassorbire.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1992-1999 2000-2006 2007-2012
122
Figura 3.15: Percentuale di laureati (livello ISCED 5-6) sul totale della forza lavoro, periodo 1992-2012
Fonte: mie elaborazioni su dati Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
Emerge che, nonostante i progressi compiuti, la quantità di capitale umano ed il suo utilizzo
all’interno del sistema economico sono molto scarsi. Anche a livello qualitativo non sembra
essersi prodotto nessun miglioramento evidente, anzi sembrerebbe esserci stato un
peggioramento del capitale umano rispetto agli altri paesi sviluppati. Questa situazione è quanto
consegue dai risultati di vari test standardizzati sulle capacità degli studenti condotti a livello
globale42.
La mancanza di capitale umano, oltre ad agire da ostacolo all’utilizzo delle tecnologie più
avanzate, compromette la formazione del capitale sociale intangibile che è molto importante
per il livello di coesione di una società, per la formazione del suo capitale civico e per la qualità
delle proprie istituzioni e della politica43.
I risultati evidenziano come l’Italia è ancora molto molto indietro rispetto ai paesi avanzati nella
formazione e nell’utilizzo di capitale umano. Proprio per questo sembra importante cercare di
introdurre nel mondo del lavoro l’ampia riserva di giovani inoccupati. Infatti, visto che molti
di questi possiedono una laurea, la loro utilizzazione significherebbe un notevole incremento di
42 G. Bertola, P. Sestito, Il capitale umano, cit., pp. 362-367. 43 L. Guiso, P. Pinotti, Democratizzazione e capitale civico, in G. Toniolo (a cura di), L’Italia e l’economia
mondiale, dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio Editori, 2013, pp. 423-427.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1992-1999 2000-2006 2007-2012
123
laureati nel sistema produttivo e la presenza di forze fresche e più inclini al cambiamento,
sicuramente più confidenti con le ICT rispetto a molti lavoratori più anziani. Questo enorme
potenziale potrebbe rappresentare quella forza necessaria per dare un nuovo volto al nostro
sistema economico. A sostegno di ciò sembra che ci sia una forte correlazione tra il numero di
lavoratori laureati all’interno delle imprese italiane e il raggiungimento di elevati livelli di
produttività e con la sperimentazione di nuove forme di organizzazione44.
2.7 Pochi cambiamenti nelle prestazioni settoriali
Analogamente a quanto fatto nel precedente capitolo viene supposto che i settori con le migliori
performance nelle esportazioni siano gli stessi che hanno saputo introdurre maggiori
innovazioni.
Nel corso degli ultimi due decenni le esportazioni italiane hanno visto calare la loro quota sul
totale mondiale, tale diminuzione è stata determinata dalla maggiore concorrenza dei paesi
emergenti, dalla sopravvalutazione del tasso di cambio reale e dall’alto costo del lavoro italiano.
Nonostante ciò, alcune imprese hanno saputo reagire tramite processi di riorganizzazione che
hanno consentito di accrescere il valore unitario medio delle esportazioni, sintomo di un
miglioramento qualitativo dei prodotti che li ha posizionati in segmenti di mercato al riparo dai
concorrenti dei paesi emergenti45. Questo processo di ristrutturazione ha interessato le imprese
più esposte alla concorrenza, soprattutto nei settori in cui l’Italia vanta tradizionalmente una
buona capacità di esportazione, ovvero quelli tradizionali e la meccanica, caratterizzati dalla
presenza di un vasto sistema di PMI, le quali, ancora una volta, hanno dimostrato di possedere
un elevato grado di flessibilità e una notevole capacità di adattamento46.
44 F. Schivardi, F. Torrini, Structural change and human capital in the Italian productive system, Fondazione
Giovanni Agnelli, Working Paper no. 38, 2011, pp.14-15. 45 A. Lanza, B. Quintieri, Eppur si muove. Quote di mercato e qualità delle esportazioni italiane: il quadro
generale, in A. Lanza, B. Quintieri (a cura di), Eppur si muove. Come cambia l’export italiano, Soveria
Mannelli, Rubettino Editore, 2007, pp. 22-29; A. Tiffin, European Productivity, Innovation and
Competitiveness: The Case of Italy, IM, Working Paper no.79, 2014, pp. 10-11. 46 A. Tiffin, European Productivity, Innovation and Competitiveness: The Case of Italy, cit., pp. 14-15.
124
Al fine di determinare l’andamento temporale dei vantaggi comparati italiani a livello settoriale,
viene usato, nella figura 3.16, l’indice di Lafay. Questo indice, a differenza di quello di Balassa,
consente di considerare anche le importazioni e la quantità relativa delle esportazioni per ogni
settore47.
Figura 3.16: Indice di Lafay medio per classi di prodotti importati ed esportati in Italia, periodo 1991-2012
Fonte: mie elaborazioni su dati UN Comtrade, http://comtrade.un.org/.
La performance delle esportazioni è rimasta pressoché uguale a quella della fine degli anni
Ottanta, con la meccanica e i settori tradizionali che fanno registrare le prestazioni migliori
mentre il resto dei settori rimane in affanno.
L’elettronica continua a conseguire risultati molto negativi, infatti fa registrare pesanti deficit
con i comparti dei computer e degli apparecchi elettronici, invece il comparto degli apparecchi
elettrici, sospinto dagli elettrodomestici, riesce a ottenere dei risultati migliori.
I settori tradizionali, nonostante abbiano subito un deciso rallentamento con l’inizio del nuovo
47 G. Federico, N. Wolf, I vantaggi comparati, cit., pp. 469-473; L’indice di Lafay per un generico bene è 𝐿𝐹𝐼𝑖 =
100 × [(𝑥−𝑚
𝑥+𝑚) − (
𝑋−𝑀
𝑋+𝑀)] × (
𝑥+𝑚
𝑋+𝑀) dove x rappresentano le esportazioni del bene, X le esportazioni totali, m
le importazioni dl bene e M le importazioni totali. I valori possono andare da 200 a -200 (nei casi estremi di
importazione ed esportazione di un solo prodotto) Un valore positivo indica una specializzazione del paese
nel bene considerato. Questo indice ha vantaggi rispetto all’indice RCA di Balassa: considera anche le
importazioni, pesa il prodotto per la sua quota evitando di focalizzare l’attenzione su prodotti marginali.
Macchinari specializzati
Macchinari
Computer
App. telecomunicazione
Apparecchi elettrici
Mobili
Tessile e scarpe
Materiali e prodotti plastici
Farmaceutica
Chimica
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1991-2000 2001-2006 2007-2012
125
Millennio, continuano a rimanere altamente competitivi e determinano gran parte del surplus
della bilancia commerciale. A conferma di quanto detto e della persistenza della
specializzazione italiana, si possono usare i risultati del WTO/UNCTAD Trade Performance
Index che mostrano come, effettivamente, l’Italia risulti il paese più competitivo a livello
mondiale per quanto riguarda il tessile, l’abbigliamento e la pelle, e invece occupi la seconda
posizione, dietro solamente alla Germania, per i macchinari non elettrici48.
Per vedere come si sono evolute le esportazioni in rapporto al livello tecnologico, possiamo
guardare all’indice di Lafay suddiviso per il grado di tecnologia dei prodotti49. Tale suddivisione
rende molto più immediato il risultato in confronto alla tassonomia di Pavitt, che comunque
produce gli stessi risultati.50
Figura 3.17: Indice di Lafay dei settori italiani raggruppati per livello di tecnologia, periodo 1991-2009
Fonte: mie elaborazioni su dati G. Federico, N. Wolff, Comparative Advantages in Italy: A Long-run Perspective,
Banca d’Italia, Quaderni di Storia Economica no.9, 2011, pp. 48-49.
48 A. Tiffin, European Productivity, Innovation and Competitiveness: The Case of Italy, cit., p.4. 49 I prodotti a bassa tecnologia sono caratterizzati da tecnologie stabili e diffuse incorporate nei macchinari che
servono a produrli (tessile, mobili). I prodotti a tecnologia media comprendono i beni basati su una tecnologia
complessa (macchinari, veicoli, grossa parte delle industrie chimiche). I prodotti ad alta tecnologia richiedono
un elevato investimento in R&S e capacità tecniche specializzate (computer, attrezzature elettroniche). Questa
classificazione è stata proposta da Lall (2000) e ha il pregio di concentrarsi maggiormente sui prodotti invece
che sulla tipologia delle imprese come fa la tassonomia di Pavitt; G. Federico, N. Wolf, I vantaggi comparati,
cit., pp. 464-467. 50 ICE, L’Italia nell’economia internazionale. Rapporto 2013-2014, 2014,
http://www.ice.it/statistiche/rapporto20132014.htm, pp. 212-240.
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bassa Media Alta
126
Quello che emerge, come si vede dalla figura 3.17, è esattamente quello che ci si poteva
aspettare. L’Italia ha peggiorato la sua posizione nei beni a bassa tecnologia che comunque
rimangono quelli che contribuiscono maggiormente alla bilancia commerciale. Continua invece
il processo di rafforzamento nei settori a tecnologia intermedia, i quali hanno raggiunto quelli
tradizionali in quanto a contributo. I settori ad alta tecnologia continuano a rappresentare il
punto di debolezza delle esportazioni italiane.
Non era così scontato che venisse confermata la capacità di esportazione da parte dei settori
tradizionali e della meccanica, poiché molti fattori potevano far pensare il contrario. Infatti la
concorrenza dei paesi emergenti e la sopravvalutazione del tasso di cambio reale facevano
immaginare che si sarebbe registrato un netto declino. Al contrario, grazie alla loro flessibilità
e capacità di adattamento, il sistema delle PMI in questi settori ha saputo attivare un processo
di ristrutturazione che ha prodotto forti dinamiche innovative, consentendo di mantenere
un’elevata capacità di esportazione51.
2.8 Diffusione delle ICT e altri ostacoli all’innovazione
È già stato detto come la regolamentazione eccessiva dei mercati dei prodotti e del lavoro frena,
assieme ai bassi il livelli di capitale umano, l’introduzione delle ICT nel sistema produttivo. Per
avere un’idea del ritardo italiano in questa attività viene mostrato un grafico elaborato su dati
estrapolati dal Web Index, un indice costruito appositamente per misurare l’impatto della
tecnologie di internet su molti aspetti economici e sociali dei paesi.
Come si può vedere dalla figura 3.18, l’Italia si contraddistingue per avere una delle peggiori
valutazioni nell’indice dell’influenza complessiva della rete, ma ancora più rilevante è che
l’impatto di essa sull’economia italiana è nettamente più basso sia rispetto ai paesi avanzati, sia
rispetto ad un paese in via di sviluppo come la Cina. Sempre all’interno di questo indice,
guardando ai dati relativi all’adozione e all’uso di internet da parte dei cittadini, del settore
governativo e delle imprese, emerge che l’Italia è largamente in ritardo in confronto agli altri
paesi europei52. Stesso ritardo che si registra nell’adozione di tutte le ICT53.
51 A. Tiffin, European Productivity, Innovation and Competitiveness: The Case of Italy, cit., p. 5; M. Bugamelli,
F. Schivardi, R. Zizza, The Euro and Firm Restructuring, National Bureau of Economic Research, Working
Paper no. 14454, 2008, pp. 27-28. 52 World Wide Web Foundation, Web Index 2012, http://webfoundation.org/projects/the-web-index. 53 N. Crafts, M. Magnani, L’Età dell’Oro e la seconda globalizzazione, cit., pp. 128-133.
127
Figura 3.18: Indice dell’impatto complessivo di Internet su alcuni paesi (l’indice va da 0 a 100), anno 2012
Fonte: World Wide Web Foundation, http://webfoundation.org/projects/the-web-index/.
Un aspetto particolarmente interessante è la stima dell’effetto, sulla crescita della produttività,
derivante dall’introduzione nel sistema produttivo delle ICT e del capitale immateriale: infatti
risulta che, tra le economie dei paesi avanzati, l’Italia ottiene le performance peggiori, avendo
modestissimi contributi alla crescita della produttività da entrambe le voci54.
Emergono spesso nelle ricerche relative all’Italia anche altri fattori limitanti l’innovazione. Lo
scarso sviluppo del capitale azionario è sicuramente uno di questi poiché secondo molti studi il
suo utilizzo rappresenterebbe un canale maggiormente idoneo per finanziare le attività
innovative rispetto all’indebitamento bancario 55 . Ma in Italia tale strumento non è molto
utilizzato: la capitalizzazione di borsa è molto inferiore ai paesi europei di dimensioni
economiche simili, compresa la Spagna56.
Un altro fattore limitante, sempre legato al finanziamento dell’innovazione, è lo scarso sviluppo
del capital venture: in Italia è difficilissimo trovare un finanziatore per sviluppare un’idea
innovativa a forte base scientifica e avviare una start-up. Infatti i dati italiani relativi agli
54 Ibidem. In Italia il contributo alla crescita della produttività delle ICT e dei beni materiali si aggira attorno al
0,1% mentre per gli altri paesi avanzati tali indici variano da un minimo dello 0,2% ad un massimo dello 0,8%. 55 M. Bugamelli, L. Cannari, F. Lotti, S. Magri, Il gap innovativo del sistema produttivo italiano: radici e possibili
rimedi, Banca d’Italia, Questioni di economia e Finanza no. 121, 2012, pp. 18-21. 56 A. Accetturo, A. Bassanetti, M. Bugamelli, I. Faiella, P. Finaldi Russo, D. Franco, S. Giacomelli e M. Omiccioli,
Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi, cit., pp. 15-16.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Indice complessivo Impatto sociale Impatto economico
128
investimenti dei venture capital se confrontati con il resto dell’Europa risultano fortemente
inferiori, invece nel confronto con gli Stati Uniti si possono definire irrisori57.
Anche l’alto numero di imprese a gestione familiare presenti in Italia rappresenta un freno
all’innovazione, per il fatto che tali imprese risultano più avverse al rischio e meno propense
all’attività innovativa. Questo accade perché le imprese familiari in Italia, al contrario di quelle
europee, difficilmente tendono ad affidarsi a manager esterni e, quando lo fanno, effettuano la
loro scelta in base alla fedeltà del candidato più che sulle sue competenze. Questo spiega il
perché in Italia prevalgono per i manager schemi remunerativi che premiano la fedeltà al
proprietario mentre, nel resto d’Europa, prevalgono remunerazioni basate sulla performance. È
ovvio come questo possa in vari modi ostacolare l’innovazione, sia perché la capacità dei
manager scelti non sono elevate, sia perché i proprietari preferiscono prendere decisioni
improntate alla conservazione dell’impresa piuttosto che alla loro ristrutturazione. Infatti, molte
ricerche e studi econometrici affermano che c’è una forte correlazione negativa tra la presenza
di una governance familiare e di pratiche manageriali basate sulla fedeltà e il risultato
innovativo58.
2.9 Che innovazione fa?
Dall’analisi svolta emerge un quadro delle dinamiche innovative italiane abbastanza cupo:
entrambi i sistemi innovativi italiani descritti nello scorso capitolo, quello “convenzionale” e
quello “atipico”, peggiorano le loro prestazioni a cominciare dagli anni Novanta. Ciò avviene
proprio nel periodo in cui si esauriscono alcuni fattori che erano risultati favorevoli alla crescita,
l’impatto delle tecnologie ICT sul sistema economico diventa maggiore e il basso livello di
capitale umano rappresenta sempre più un limite per l’innovazione italiana.
Il sistema innovativo “convenzionale” non aveva mai prodotto, dal Dopoguerra in poi, dei
risultati eccezionali, ma l’arretramento registrato in questi ultimi anni dà l’impressione di una
resa. Infatti il cambiamento in atto a livello globale avrebbe richiesto uno sforzo maggiore per
sfruttare le opportunità connesse alle ICT e sviluppare, almeno in alcuni settori avanzati, una
57 M. Benvenuti, L. Casolaro, E. Gennari, Metrics of Innovation: measuring the Italian gap, Banca d’Italia,
Questioni di Economia e Finanza no.168, 2013, pp. 16-17; M. Bugamelli, L. Cannari, F. Lotti, S. Magri, Il
gap innovativo del sistema produttivo italiano, cit., pp. 18-21. 58 M. Bugamelli, L. Cannari, F. Lotti, S. Magri, Il gap innovativo del sistema produttivo italiano, cit., pp. 14-15.
129
solida base tecnologica. Ma in Italia, al contrario degli altri paesi avanzati, questo sforzo non
viene fatto, come si può vedere dalle scarse spese in R&S e dal calo della produzione brevettuale,
nonché dall’andamento deludente dei settori legati a tale sistema, elettronica in testa. La crisi
della grande impresa, che in questo periodo ha subito una diminuzione quantitativa e della
produttività, non ha certo aiutato in questo senso, essendo la promotrice della maggior parte di
queste attività.
Questo arretramento, con la complicità del basso livello di capitale umano, è uno dei fattori che
ha comportato per l’Italia quella “triplice esclusione” legata alle nuove tecnologie: produce
pochi beni legati ad esse, le utilizza scarsamente nel sistema economico e ha sviluppato in modo
limitato la componente di servizi avanzati che ne fanno un uso intensivo.
Il sistema innovativo “atipico” che, come abbiamo visto, è caratterizzato da processi di
adozione creativa, dalla dotazione di lavoratori con elevate competenze tecniche congruenti con
la tecnologia utilizzata, dalle forti relazioni utilizzatori/produttori e dalla presenza di molte
aziende di piccole e medie dimensioni, ottiene invece una performance migliore. Effettivamente
sono i settori più legati ad esso, che in accordo con Malerba (2011) possiamo definire come
“Network di PMI”, ad ottenere i migliori risultati nelle attività innovative, perfino nella R&S e
nei brevetti che, come abbiamo evidenziato, non sono così importanti per le dinamiche
innovative di questo sistema. Sono le imprese di questi settori che, riorganizzando la loro
produzione, hanno continuato a far registrare i migliori risultati per le esportazioni, venendo
considerate tra i settori più competitivi a livello mondiale.
Ma le dinamiche innovative del “Network di PMI” non sono state così diffuse nel sistema
produttivo come in passato, essendosi prodotte solamente nelle imprese maggiormente esposte
alla competizione mondiale. Infatti esse, sperimentando una forte concorrenza dai paesi
emergenti e osservando un deterioramento del tasso di cambio reale, hanno avviato un processo
di ristrutturazione che, attraverso guadagni di efficienza e miglioramenti qualitativi dei prodotti,
ha consentito loro di mantenere un’elevata capacità di esportazione. Ancora una volta le
imprese dei settori tradizionali e quelli specialized suppliers sono riuscite ad attivare dinamiche
innovative che hanno prodotto notevoli incrementi nell’efficienza, mostrando quella flessibilità
e quella capacità di adattamento che è mancata all’Italia nel suo complesso. Quindi l’intensità
dell’attività innovativa è stata molto diversa tra i comparti esposti alla competizione
internazionale e quelli non esposti.
Le dinamiche del sistema “atipico” non sono state in grado, come in passato, di evitare il
130
collasso della crescita economica italiana per due ordini di motivi collegati tra loro. Primo,
risulta sempre minore l’importanza dei settori legati ad esso all’interno delle economie dei paesi
avanzati. Infatti la terziarizzazione e il cambiamento tecnologico hanno causato una notevole
riduzione del peso della manifattura e, all’interno di essa, i settori a bassa e media tecnologia
sono quelli che hanno sperimentato la maggiore diminuzione a favore di quelli a tecnologia
avanzata.
Secondo, anche il Network di PMI risente, e risentirà maggiormente in futuro, dell’incapacità
di sfruttare le opportunità connesse all’introduzione delle ICT e della mancanza di capitale
umano. Con molta probabilità l’applicazione delle nuove tecnologie rivoluzionerà, nei prossimi
anni, il modo di produrre della manifattura, erodendo la competitività di chi non saprà adattarsi.
Quindi anche per il sistema innovativo “atipico” diventa cruciale usufruire di capitale umano
adeguato e utilizzare le ICT, fattori che nel passato non avevano inficiato le sue possibilità di
innovazione.
Le considerazioni delineate fin qua consentono di affermare che, nella transizione verso le
tecnologie della terza rivoluzione industriale, le dinamiche innovative dell’Italia siano state
scarse, non paragonabili a quelle degli altri paesi avanzati. Inoltre sono emersi seri dubbi
riguardo alle capacità di ripresa dell’Italia poiché, se da un lato è certo che il sistema innovativo
“convenzionale” non comincerà dall’oggi al domani a produrre risultati significativi, dall’altro
lato iniziano a sorgere numerose preoccupazioni anche riguardo all’efficacia futura del sistema
“atipico”.
Alla luce di questa analisi il destino del sistema innovativo italiano non sembra troppo roseo
con conseguenti effetti molto negativi sulla crescita, vista la forte relazione tra sviluppo
economico e innovazione. Comunque non bisogna abbandonarsi al pessimismo poiché sono
molte le azioni che si possono mettere in pratica per migliorare il nostro futuro, a condizione
che si abbandoni l’immobilismo decisionale e la focalizzazione sul presente che da tanto tempo
caratterizza la classe dirigente italiana.
131
3 Un declino inarrestabile?
Da quello che è emerso in questo capitolo l’Italia, sembra condannata ad un riposizionamento
verso il basso del suo status internazionale poiché l’incapacità di adeguarsi ai cambiamenti
avvenuti a livello globale l’ha resa meno idonea a eguagliare i livelli di crescita degli altri paesi
avanzati.
La terza rivoluzione industriale ha aumentato l’importanza del sistema innovativo
“convenzionale” caratterizzato da ampie spese in R&S, alti livelli di produzione brevettuale,
capitale umano elevato, efficienza istituzionale e imprese attive in settori a tecnologia avanzata.
Infatti oggi la sua centralità nel sistema economico è molto aumentata rispetto al periodo della
seconda rivoluzione industriale così come il suo ruolo nel determinarne lo sviluppo economico.
A dimostrazione di ciò, nei paesi avanzati si è registrata una forte correlazione positiva tra la
performance del sistema innovativo “convenzionale” e la crescita economica. L’Italia, nel
periodo che va dal Dopoguerra agli anni Novanta, ha rappresentato l’eccezione a questa
connessione poiché, nonostante le dinamiche innovative “convenzionali” siano state scarse, il
PIL è aumentato con tassi annui maggiori degli altri paesi.
Negli ultimi anni questa anomalia è stata riassorbita: come si può vedere dalla figura 3.19, il
cerchio dell’Italia è ora di una dimensione minore dei paesi che nel grafico stanno più a destra
e più in alto di lei. Ovvero il PIL pro capite italiano, è tornato ad essere minore o uguale rispetto
ai paesi che producono uno sforzo innovativo “convenzionale” maggiore.
Quindi sembra che le sole dinamiche del sistema “atipico” non siano più sufficienti a garantire
una crescita economica adeguata al fine di mantenere la posizione italiana a livello globale. Per
fare questo è arrivato il momento che tutto il sistema Italia torni a “produrre innovazione”.
132
Figura 3.19: Rapporto tra Brevetti pro capite (asse y), Spese in R&S/PIL (asse x) e PIL pro capite (scala a dx), anno 2012
Fonte: mie elaborazioni su dati Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database; OECD, http://stats.oecd.org/.
Tuttavia sembra molto difficile che si torni a “produrre innovazione” considerati tutti i dubbi
che gravano sulle prestazioni future di entrambi i sistemi innovativi. Per la precisione quello
“convenzionale”, più che destare preoccupazioni, offre una certezza, nel senso che sicuramente
otterrà risultati negativi nei prossimi anni, poiché è impensabile che senza un progetto ed il
tempo necessario per metterlo in pratica si possano raggiungere risultati positivi.
Per sviluppare un sistema complesso come quello in esame sono molti gli investimenti da
compiere e i loro frutti saranno visibili solo molto tempo dopo. In questo caso le difficoltà sono
ancora maggiori perché è necessario coordinare molti attori e aspetti differenti per ottenere un
risultato unitario efficiente. È indispensabile, per molti anni di seguito, investire ingenti risorse,
allestire centri di ricerca, creare network territoriali ristretti e altri più ampi che contengano i
soggetti, pubblici e privati, interessati ed in grado di portare un contributo. Allo stesso tempo è
necessario promuovere politiche volte al miglioramento qualitativo e quantitativo del capitale
umano. Ad oggi non sembra esserci nessun progetto a livello nazionale che prospetti delle
azioni simili e le politiche regionali sull’innovazione, nonostante possano ottenere molti
successi localizzati, sono incapaci di perseguire obiettivi di così grande respiro che esulano
dalla loro competenza.
Un piano di questa portata potrà essere elaborato nei prossimi anni e potrà gettare le basi per
133
costituire, in futuro, un efficiente sistema innovativo “convenzionale”, ma al momento questa
prospettiva sconfina nella pura immaginazione.
Quello che non si deve fare è costruire un sistema diffuso, cioè orientato verso tutti i campi
della conoscenza, poiché bisognerebbe evitare di consumare risorse in quei settori dove l’Italia
è troppo arretrata per poter immaginare di diventare competitiva. Gli interventi dovrebbero
essere concentrati in alcuni settori dove la buona performance italiana è consolidata e in altri,
possibilmente sulla frontiera tecnologica, in cui sembrerebbe esserci un’effettiva possibilità di
sviluppo.
Al contrario, i dubbi sul sistema “atipico” sono più ipotetici perché nei prossimi anni potrebbe
ancora garantire buone prestazioni, continuando a sospingere i comparti ad esso legati. Ma
come avviene per tutta l’economia, anche in questi settori il problema dell’introduzione delle
nuove tecnologie è sempre più pressante, poiché sembra molto probabile che, nel giro di alcuni
anni, il loro modo di produrre sarà completamente rivoluzionato.
Conseguentemente, anche per queste imprese, acquisisce maggiore importanza aumentare le
proprie dotazioni di capitale umano, necessario al fine di sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT; altrimenti si verranno a creare degli svantaggi competitivi rispetto ai concorrenti esteri
maggiormente in grado di elaborare le nuove tecnologie. Quindi anche le future dinamiche
innovative “atipiche” sono avvolte da un alone di aleatorietà.
Allora viene da domandarsi se questo declino italiano sia inarrestabile. La risposta è negativa
se nei prossimi anni verranno implementate azioni volte a rimuovere i limiti all’attività
innovativa, creando contestualmente condizioni favorevoli ad essa. Facendo cioè in modo che
il sistema “atipico” continui la sua performance e quello “convenzionale” riesca finalmente a
svilupparsi.
Molte di queste possibili azioni penso che emergano chiaramente dall’analisi fin qui compiuta,
non per l’acutezza di chi scrive, ma per il semplice fatto che è da molto tempo che i soliti fattori
vengono additati come punti di debolezza dell’Italia senza che nulla sia stato posto in essere
per modificare la situazione. Infatti appare evidente che, per alimentare l’innovazione in Italia,
sarebbe necessario promuovere la formazione di capitale umano con elevate competenze
nell’utilizzo delle ICT e delle nuove tecnologie che rappresentano il futuro del sistema
economico. Il solo paragone con gli altri paesi avanzati ci dovrebbe far capire come sia
necessario destinare maggiori risorse alla R&S e sforzarsi di connettere meglio i vari attori,
soprattutto centri di ricerca pubblici e imprese. In questo tentativo sarebbe bene evitare di
134
destinare risorse in maniera irrazionale, ma selezionare una serie di settori nel quale l’Italia è
già competitiva ed altri, possibilmente alla frontiera tecnologica, in cui l’Italia ha seriamente la
possibilità di raggiungere dei risultati apprezzabili. Inoltre, favorire la crescita degli
investimenti immateriali e le competenze informatiche dei lavoratori sarebbe un altro passo
verso la risoluzione del problema. Così come procedere con una deregolamentazione dei
mercati porterebbe ad avere più concorrenza, favorendo di conseguenza i processi di
ristrutturazione di imprese inefficienti e l’introduzione delle ICT nel sistema produttivo italiano.
La necessità e l’urgenza di queste azioni sono rese evidenti da quello che è emerso con più forza
nel corso di questa ricerca, ovvero che le attuali dinamiche innovative italiane sono insufficienti
a produrre quel miglioramento di efficienza che permetterebbe all’Italia di tornare a livelli di
crescita economica adeguati a mantenere la sua posizione internazionale.
L’altra domanda da porsi è se il sistema innovativo “atipico” potrà continuare in futuro a
svolgere il ruolo di traino della crescita italiana come è successo fino agli anni Novanta.
La risposta alla domanda sarebbe negativa se continuassero a mancare due elementi. In primo
luogo, come abbiamo visto, anche in questi settori è necessaria una intensa introduzione delle
ICT nel sistema produttivo volta a sfruttarne il potenziale. In secondo luogo non si può
prescindere da un arricchimento della specializzazione italiana orientata verso i servizi avanzati
alle imprese. Infatti basandosi sulle dinamiche del sistema innovativo “atipico” potrebbe
rinnovarsi quel circolo virtuoso che ha consentito lo sviluppo di un robusto settore del
macchinario italiano. Ma questa volta, l’alta domanda consentirebbe il completamento a monte
della filiera produttiva con lo sviluppo di un robusto settore dei servizi avanzati alle imprese,
settore che a livello mondiale sta acquisendo sempre più importanza e porta con sé importanti
dinamiche innovative.
Potrebbe replicarsi l’intensità relazionale tra produttori e utilizzatori che ha fornito bacini di
conoscenza per effettuare continui innovazioni incrementali. La piccola e media dimensione
delle imprese e la concentrazione territoriale garantirebbero lo svilupparsi di tali relazioni e la
flessibilità necessaria per riuscire a cogliere tale opportunità. L’adozione creativa delle
tecnologie potrebbe avvenire anche in questo settore tramite la rielaborazione di quelle
conoscenze tacite tramite le quali per anni sono state prodotte importanti dinamiche innovative
dai settori tradizionali e dagli specialized suppliers, che vedrebbero così valorizzato il loro
patrimonio innovativo accumulato nel tempo
Ma ambedue questi processi non possono prescindere da un miglioramento nella dotazione di
135
capitale umano sia a livello qualitativo che quantitativo. Questo miglioramento deve avvenire
tramite uno sforzo culturale collettivo, inteso a riportare la conoscenza come elemento centrale
della nostra società. Sarà onere del governo elaborare un piano di lungo respiro che programmi
l’attuazione di azioni volte a migliorare l’architettura del sistema formativo italiano in modo da
renderla più adeguata alle sfide della globalizzazione e del cambiamento tecnologico. Inoltre
sarà fondamentale aumentarne la congruenza con le competenze che le nuove tecnologie
necessitano, focalizzando maggiormente i vari livelli dell’istruzione sulle materie scientifiche
e incentivando l’iscrizione a facoltà che hanno un ruolo chiave nel paradigma tecnologico
odierno.
Se parliamo del futuro italiano e del miglioramento del capitale umano una considerazione
appare d’obbligo. Per un paese avanzato non è possibile avere livelli di disoccupazione
giovanile maggiori del 40%, significa che non sta sfruttando le risorse che ha formato.
L’inserimento di questi giovani nel mondo del lavoro porterebbe ad un miglioramento della
dotazione di capitale umano nel sistema produttivo, il quale sarebbe rivitalizzato dalla presenza
di forze fresche più inclini al cambiamento e più confidenti con l’utilizzo delle nuove tecnologie:
se vogliamo guardare al futuro dobbiamo ripartire da chi rappresenta il futuro.
Queste azioni sono indispensabili per ottenere nei prossimi anni un rilancio dell’Italia, poiché
solo tramite un rafforzamento del sistema “atipico” e lo sviluppo del sistema “convenzionale”
si otterranno nuovamente forti dinamiche innovative che sosterranno un elevato sviluppo
economico.
136
CONCLUSIONI
L’innovazione ha avuto un ruolo fondamentale nel sostenere lo sviluppo economico italiano
del dopoguerra: questo è ciò che permettono di affermare i risultati acquisiti nel corso del
presente lavoro.
Infatti, tramite un sostanzioso apparato statistico e un’analisi incentrata sull’evoluzione storico-
economica dell’Italia, che ha compreso anche variabili culturali e istituzionali, è stato
dimostrato come le dinamiche innovative sono state cruciali per favorire l’eccezionale sviluppo
economico italiano dall’Età dell’Oro alla fine degli anni Ottanta, così come è stato dimostrato
che l’attenuazione di tali dinamiche ha condannato l’Italia all’attuale periodo di stagnazione.
Le tesi alternative, che volevano spiegare la crescita economica italiana attraverso il processo
di accumulazione di capitale, lo spostamento di lavoratori verso la manifattura o grazie ad un
processo automatico di convergenza prodotto dall’arretratezza iniziale dell’Italia, sono state
progressivamente abbandonate sulla base dei dati raccolti e delle considerazioni scaturite con
il progredire di questa ricerca. Sono state più di tutto le misurazioni della contabilità della
crescita che hanno fornito la base per sostenere che l’accumulazione di capitale e lo
spostamento strutturale dei lavoratori, nonostante siano fattori importanti, risultano marginali
nel confronto con le dinamiche innovative all’interno dei diversi settori, le quali hanno
rappresentato il vero motore dello sviluppo economico italiano.
La scelta di campo effettuata nel primo capitolo, ovvero quella di utilizzare come base
concettuale l’approccio evolutivo all’innovazione, è risultata adeguata allo scopo prefissato.
Infatti, se l’analisi fosse stata condotta secondo i precetti della teoria neoclassica sarebbe stato
impossibile giungere a sostenere una simile tesi. Al contrario, la conclusione naturale
dell’analisi sarebbe stata quella di negare che le dinamiche innovative abbiano avuto un ruolo
nello sviluppo economico italiano poiché, anche usando una certa flessibilità, le variabili che
vengono considerate dai neoclassici come promotrici della crescita sono la R&S e il capitale
umano che, come abbiamo constatato, in Italia hanno avuto un andamento deludente.
Invece, grazie agli evoluzionisti, è stato appurato come l’innovazione sia un processo
complesso influenzato da molteplici variabili, sia di tipo economico che istituzionale-culturale;
inoltre si è valutato come l’analisi storica aiuti a comprendere le ragioni di certe situazioni e
137
l’influenza sul presente delle decisioni prese in passato.
Conseguentemente, per analizzare le dinamiche innovative e le loro caratteristiche, è stato
utilizzato un ampio apparato statistico comprendente le spese in R&S, l’attività brevettuale,
l’acquisto di tecnologia incorporata, l’analisi della Bilancia Tecnologica dei Pagamenti,
l’analisi sul capitale umano disponibile, oltre ai dati sulle esportazioni italiane. Sono state
fornite, dove possibile, delle valutazioni settoriali di queste statistiche al fine di determinare
quali settori hanno contribuito di più alle dinamiche innovative e conseguentemente allo
sviluppo economico.
Dalle analisi compiute è risultato che l’innovazione italiana non è stata alimentata da quelle
attività usualmente considerate dagli studiosi, ovvero la R&S, la produzione brevettuale,
l’elevato capitale umano e la presenza di imprese nei settori ad alta tecnologia. Infatti dai dati
statistici risulta chiaro come in questi campi l’Italia è sempre rimasta fortemente indietro
rispetto agli altri paesi avanzati, solo negli anni Sessanta c’è stato l’inizio di un processo di
convergenza che però si è prontamente volatilizzato. Appurando come l’insieme di tali attività,
definite sistema innovativo “convenzionale”, non abbia mai ottenuto risultati apprezzabili e non
abbia sicuramente agito da traino per la crescita, si è riproposto lo stesso dubbio di partenza:
come ha fatto l’Italia ad innovare in questo periodo se il risultato del suo sistema innovativo è
stato così scarso.
Seguendo la strada tracciata nel primo capitolo, dove è stato osservato come esistano altre
attività perseguibili per intraprendere il processo innovativo e come esso sia caratterizzato da
elevata complessità, sono state ricostruite le “vie” verso l’innovazione percorse dall’Italia.
Le dinamiche innovative alternative italiane sono state individuate tramite l’analisi di processi
specifici e di caratteristiche peculiari del sistema economico, descritti unitariamente all’interno
di quello che abbiamo definito il sistema innovativo “atipico” italiano.
Per fare ciò è stato seguito un percorso che comincia con l’analisi delle importazioni di
tecnologia. È stato osservato come, negli anni Cinquanta e Sessanta, siano stati fatti molti sforzi
diretti ad acquisire tecnologia incorporata in macchinari e tecnologia non incorporata
specialmente nella forma di brevetti e licenze. Questo impegno è stato considerevole e del tutto
paragonabile, se non superiore, a quello degli altri paesi avanzati.
Le imprese italiane produttrici di macchinari hanno avuto un ruolo importante in questo
processo di acquisizione di tecnologia estera, soprattutto nell’acquisto e nello sfruttamento di
138
licenze e brevetti. Questo sforzo per dotarsi di una base tecnologica, assieme all’alta domanda
del mercato interno, ha consentito al settore italiano dei macchinari di svilupparsi in maniera
molto rapida. Infatti già da metà degli anni Sessanta le esportazioni di macchinari hanno
superato le importazioni.
Le imprese dei settori tradizionali hanno giocato un ruolo fondamentale in questo processo:
tramite i loro cospicui investimenti si è formata l’elevata domanda che ha costituito la base per
lo sviluppo del settore dei macchinari; inoltre, attraverso le forti relazioni sviluppatesi tra queste
imprese e i produttori di beni capitali, è stato possibile migliorare continuamente le macchine e
diffondere rapidamente le innovazioni. Si è creato un circolo virtuoso in cui entrambi i settori
hanno beneficiato reciprocamente della presenza dell’altro. Questa evoluzione e le sue
dinamiche sono alla base dello sviluppo del sistema innovativo “atipico”, il quale si
contraddistingue per essere fortemente legato alle piccole e medie imprese dei settori
tradizionali e della meccanica, per le intense interazioni che avvengono lungo tutta la filiera
produttiva, per avere una dotazione del fattore lavoro congruente con le tecnologie in uso e per
i processi di adozione creativa.
Mentre è stato appurato come la mancanza di elevato capitale umano ha rappresentato un
problema per lo sviluppo del sistema “convenzionale”, questo non è stato un limite per il
sistema “atipico” poiché esso sfruttava la presenza di un discreto numero di ingegneri e
lavoratori con buone competenze tecniche che si sono rivelate particolarmente idonee
nell’utilizzo delle tecnologie della produzione di massa. Questa specifica dotazione del fattore
lavoro ha consentito di eccellere nel processo di adozione creativa, ovvero nell’adattamento
alle specificità locali delle tecnologie acquisite, che ha garantito continui aumenti di efficienza
tramite una serie di innovazioni incrementali.
Un altro punto di forza è stato quello delle relazioni, la cui intensità ha permesso lo scambio di
numerosi feedback tra produttori e utilizzatori, consentendo un continuo miglioramento delle
tecnologie in uso e un elevato soddisfacimento delle specifiche esigenze dei clienti. Questa
intensità relazionale è stata favorita dalla piccola e media dimensione delle imprese e dalla
presenza dei distretti industriali.
I risultati del lavoro, quindi, confermano che le dinamiche innovative sono state cruciali nel
determinare lo sviluppo economico italiano dal dopoguerra fino all’inizio degli anni Ottanta.
Queste dinamiche, però, non si sono prodotte tramite il sistema “convenzionale” come nella
maggior parte degli altri paesi avanzati, ma sono state generate dal peculiare sistema innovativo
139
“atipico”, sostenuto soprattutto dalle numerose PMI appartenenti ai settori tradizionali e alla
meccanica. Tali imprese hanno rappresentato uno dei pochi elementi di flessibilità
dell’economia italiana, infatti, tramite varie ristrutturazioni e riorganizzazioni, sono state in
grado di adeguarsi ai cambiamenti delle condizioni globali e rimanere competitive nel corso del
tempo.
Lo sviluppo economico sostenuto da queste dinamiche “atipiche” ha consentito all’Italia di
rappresentare, nel periodo analizzato nel secondo capitolo, un’anomalia alla correlazione
secondo la quale buone prestazioni del sistema innovativo “convenzionale” portano a livelli di
ricchezza elevati, mentre basse prestazioni condannano ad un grado di ricchezza minore. Questa
correlazione sembra essere valida a livello globale ma non per l’Italia, dove era presente un
elevato PIL pro capite a fronte di un sistema innovativo “convenzionale” nettamente meno
performante rispetto agli altri paesi avanzati. Questa anomalia ricorda la metafora del calabrone
che, secondo gli scienziati, non può volare ma esso vola ugualmente; allo stesso modo per
l’Italia si pensava che, date le sue caratteristiche, non potesse crescere con continuità a certi
tassi e invece l’ha fatto, grazie soprattutto alle dinamiche innovative “atipiche”.
Nel secondo capitolo è stato dunque delineato il ruolo dell’innovazione fino agli anni Novanta
ed è emersa la dualità del sistema innovativo italiano. Però, accanto a questo sono emerse, a più
riprese, crescenti inquietudini sulle debolezze strutturali dell’Italia, sulla sua congenita
incapacità di cambiare e sulla sua inettitudine a progettare il futuro.
Queste preoccupazioni si sono rivelate fondate poiché, come viene esposto nel terzo capitolo,
il declino che comincia negli anni Novanta e continua fino ai giorni nostri, è il frutto di questi
fattori limitanti. L’Italia sperimenta in questo periodo tassi di crescita bassissimi e un
incremento dell’efficienza produttiva vicino allo zero; conseguentemente comincia un processo
di divergenza dei livelli di ricchezza nei confronti dei paesi più avanzati che non si è ancora
riusciti a fermare.
Negli ultimi vent’anni l’accelerazione del processo di globalizzazione e la terza rivoluzione
industriale hanno notevolmente cambiato il volto del sistema economico: è aumentata, in tutti
i settori produttivi, l’importanza dell’utilizzo delle ICT; oggi risulta molto più rilevante che nel
passato l’efficienza delle istituzioni perché, nelle nostre società sempre più complesse, la
performance globale dipende da quella di ognuna delle sue parti e l’aspetto istituzionale è
diventato una parte fondamentale; inoltre la struttura produttiva ha subito un deciso
spostamento verso il settore dei servizi.
140
A causa di queste trasformazioni, le debolezze strutturali italiane e l’incapacità di adeguarsi ai
cambiamenti globali si sono ora trasformate in veri e propri ostacoli all’innovazione e alla
crescita. Infatti la crescente rilevanza delle ICT e delle altre tecnologie legate alla terza
rivoluzione industriale, che hanno caratteristiche molto differenti rispetto alle tecnologie della
produzione di massa, richiede sempre maggiori livelli di capitale umano e accresce
l’importanza del sistema innovativo “convenzionale” e dei settori ad alta tecnologia. Quindi il
basso livello di capitale umano italiano, che prima non aveva precluso le possibilità di produrre
sostanziose dinamiche innovative, ora rappresenta uno dei maggiori ostacoli all’utilizzo delle
ICT. Ciò rappresenta un ostacolo anche per il sistema “atipico”, poiché i settori ad esso legati
necessitano del loro utilizzo per conseguire notevoli guadagni di produttività.
L’efficienza delle istituzioni e la qualità della governance italiana si attestano su livelli
veramente bassi in confronto al resto del mondo, facendo facilmente intuire come questo
rappresenti un effettivo ostacolo alla crescita.
Inoltre, lo spostamento della struttura produttiva verso i servizi in Italia è avvenuto con
un’espansione dei comparti meno efficienti, mentre i settori ad utilizzo intensivo di conoscenza,
che rappresentano la parte più legata alle dinamiche innovative e che arreca maggiori benefici
al resto dell’economia, si sono sviluppati in maniera insufficiente.
Queste considerazioni, unite alle misurazioni della contabilità della crescita, confermano che il
sostegno allo sviluppo economico italiano da parte dell’innovazione è venuto a mancare; ciò è
confermato dal fatto che, negli ultimi vent’anni, le stesse statistiche sulle attività innovative
analizzate nel secondo capitolo fanno registrare un processo di divergenza nei confronti dei
paesi avanzati.
Viene attestata l’esiguità del sistema “convenzionale” di innovazione che appare essersi arreso
di fronte alla terza rivoluzione industriale. Mentre il sistema “atipico”, anche se ha peggiorato
notevolmente le sue performance, non si è arreso: i settori legati ad esso e orientati alle
esportazioni hanno saputo continuare a produrre importanti dinamiche innovative che hanno
consentito loro di rimanere competitivi nel mercato globale.
È avvenuta quindi una polarizzazione della specializzazione italiana: c’è stato un ulteriore
rafforzamento nei settori a bassa e media tecnologia orientati alle esportazioni, con meccanica
e “made in Italy” in testa alle classifiche della competitività mondiale, mentre si è confermata
la “triplice esclusione” legata all’alta tecnologia: i settori manifatturieri collegati ad essa non
hanno saputo svilupparsi, essa viene utilizzata in maniera insufficiente nel sistema produttivo
141
e la componente di servizi avanzati che ne fa un uso intensivo si è evoluta in modo limitato.
La diminuzione delle dinamiche innovative è stata cruciale per determinare l’andamento
negativo dell’economia: in questo ventennio si è riassorbita l’anomalia che l’Italia
rappresentava nel panorama internazionale, ovvero i livelli di ricchezza, diminuendo, sono ora
più in linea con le scarse performance del suo sistema innovativo “convenzionale”.
Sull’andamento negativo dei processi innovativi ha influito il fatto che l’Italia non è stata in
grado di affrontare le sfide e cogliere le opportunità derivanti dalla terza rivoluzione industriale
e dall’aumento della velocità del processo di globalizzazione. In modo particolare l’incapacità
di migliorare il livello del capitale umano ha causato una notevole difficoltà a sfruttare le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione che, data la loro pervasività, influenzano
la produttività di tutti i settori dell’economia. Ciò ha comportato la perdita di competitività nei
confronti di molti paesi che hanno saputo sfruttare tali opportunità. Inoltre, senza capitale
umano adeguato, viene a mancare uno dei principali input del sistema “convenzionale” che
vede così preclusa la possibilità di svilupparsi.
Il quadro delineato è cupo e pare non lasciare molte speranze per il futuro poiché, alle condizioni
attuali, sembra che il declino italiano debba continuare. Nonostante ciò, nel lavoro è emerso
come ci siano i presupposti per una ripresa economica, ma solamente a patto che si mettano in
pratica una serie di azioni volte a rimuovere gli ostacoli all’innovazione e creare condizioni ad
essa favorevoli, facendola tornare ad essere il fattore propulsivo dello sviluppo economico.
Quindi la condizione necessaria risulta essere quella di abbandonare l’immobilismo decisionale,
cominciando a mettere in atto processi di adeguamento ai cambiamenti globali e recuperando
quella fondamentale progettualità rivolta al futuro che è essenziale per continuare ad
immaginare un avvenire in cui l’Italia sia ancora tra i paesi più sviluppati al mondo. Molte delle
possibili azioni da mettere in pratica per rilanciare l’economia italiana scaturiscono
direttamente da questo lavoro perché sono l’ovvio corollario del processo di individuazione dei
problemi.
Tra tutte le azioni intraprendibili il miglioramento del capitale umano risulta essenziale: è
urgente migliorare la formazione e l’istruzione italiana poiché esse sono elementi
imprescindibili per affrontare qualsiasi futuro sia dinnanzi a noi. Per prima cosa alti livelli di
capitale umano renderanno più veloce l’introduzione nel sistema economico delle ICT che,
come abbiamo visto, sono fondamentali per migliorare l’efficienza in tutti i settori produttivi.
In secondo luogo, alti livelli di istruzione potranno migliorare il capitale sociale/civico dei
142
cittadini e quindi, indirettamente, anche la qualità delle istituzioni e della classe dirigente che
si andrà a formare negli anni successivi. Inoltre, elevati livelli di capitale umano saranno
necessari per promuovere lo sviluppo di una solida base tecnologica e del sistema innovativo
“convenzionale”, elementi necessari per affrontare qualsiasi cambiamento tecnologico che ci
potrà essere in futuro.
Un altro obiettivo da raggiungere, allo scopo di favorire la ripresa italiana, è lo sviluppo dei
servizi ad uso intensivo di conoscenza, settore che a livello mondiale sta acquisendo sempre
più importanza, facendo registrare importanti tassi di crescita e influenzando positivamente la
produttività e le dinamiche innovative. Questa evoluzione potrebbe avvenire attraverso il re-
plicarsi di quel circolo virtuoso che ha consentito, negli anni Cinquanta e Sessanta, la nascita
di un robusto settore del macchinario. Questa volta il completamento della filiera produttiva
potrebbe prodursi con l’espansione di un settore dei servizi avanzati alle imprese che sfrutte-
rebbe i canali del sistema innovativo “atipico” per aumentare la sua competitività.
Contestualmente non bisogna dimenticarsi della necessità di promuovere la crescita del sistema
innovativo “convenzionale”, aumentando il volume delle risorse ad esso rivolte e favorendo il
coordinamento tra la ricerca pubblica e le imprese. Visto che la scienza compie progressi inim-
maginabili nello spazio di pochi anni, ampliando le opportunità di innovazione del sistema eco-
nomico all’inverosimile, il miglioramento del sistema “convenzionale” è alla base di qualsiasi
futuro si voglia concepire per l’Italia.
Una volta delineati i problemi e le possibili azioni da intraprendere per superarli, bisogna
decidere cosa fare: l’Italia può continuare a tenere un atteggiamento passivo e subire le
conseguenze dei cambiamenti globali, proseguendo nel suo declino; oppure, ben conscia della
propria attuale inadeguatezza, deve mettere in atto quelle azioni volte a cambiarne la struttura
economica e sociale. Questa strada non è semplice da percorrere e necessita di uno sforzo
condiviso da parte di tutta la società, ma è l’unico modo per costruire un futuro dove l’Italia sia
ancora protagonista. Come descritto in questo lavoro, per ottenere un simile risultato è
essenziale rilanciare l’innovazione, in modo che essa possa sostenere un notevole sviluppo
economico necessario a mantenere l’Italia tra i paesi più ricchi del pianeta. Questo rilancio deve
avvenire rapidamente, poiché molti paesi nel mondo stanno sviluppandosi a velocità per noi
inimmaginabili: se l’Italia vuole fermare il suo declino e mantenere la sua posizione globale
non può più permettersi di stare ferma o semplicemente camminare, deve correre.
143
BIBLIOGRAFIA
Abernathy W., Utterback J., (1975), A dynamic model of process and product innovation, in
Omega, Vol. 3, pp. 639-656
Abramovitz M., (1956), Resource and Output Trends in the United States Since 1870, in
American Economic Review Vol. 46, no.1, pp. 5-23
Abramovitz M., (1986), Catching up, Forging Ahead, and Falling Behind, in Journal of
Economic History, Vol. 46, no. 2, pp. 385-406
Abramovitz M., (1994), The Origins of the Postwar Catch-Up and Convergence Boom, in
Fagerberg J., Verspagen B., von Tunzelmann N. (a cura di), The Dynamics of Technology, Trade
and Growth, Aldershot, Elgar, pp. 21-52
Accetturo A., Bassanetti A., Bugamelli M., Faiella I., Finaldi Russo P., Franco D., Giacomelli
S., Omiccioli M., (2013), Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi, Banca
d’Italia, Questioni di Economia e Finanza no. 193
A’Hearn B., Venables A.J., (2013), Geografia, commercio estero e divari regionali, in Toniolo
G. (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio Editori,
pp. 825-868
Amatori F., Colli A., (2011), Storia d’impresa. Complessità e comparazioni, Milano, Bruno
Mondadori
144
Amatori F., Bugamelli M., Colli A., (2013), Tecnologia, dimensione d’impresa e
imprenditorialità, in Toniolo G. (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità a oggi,
Venezia, Marsilio Editori, pp. 631-671
Antonelli C., (1999), Conoscenza tecnologia, Nuovi paradigmi dell’innovazione e specificità
italiane, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli
Antonelli C., (2007), The foundations of the Economics of Innovation, Dipartimento di
Economia “S. Cognetti de Martiis”, Working paper no. 2
Antonelli C., (2010), The economic complexity of technology and innovation. A review article
of The nature of technology. What it is and how it evolves, Dipartimento di Economia “S.
Cognetti de Martiis”, Working paper no. 3
Antonelli C., (2013), Un quadro di politica economica per guidare la transizione dall'economia
manifatturiera all'economia digitale della conoscenza, Dipartimento di Economia “S. Cognetti
de Martiis”, Working paper no. 2
Antonelli C., Barbiellini Amidei F., (2007), Innovazione tecnologica e mutamento strutturale
dell’industria italiana nel secondo dopoguerra, in Antonelli C., et al. (a cura di), Innovazione
tecnologica e sviluppo industriale nel secondo dopoguerra, Laterza, Roma, pp. 3-358
Antonelli C., Barbiellini Amidei F., (2009), Knowledge, innovation and localised technological
change in Italy, 1950-1990, Dipartimento di Economia “S. Cognetti de Martiis”, Working paper
no. 13
Antonelli C., Barbiellini Amidei F., (2011), The dynamics of knowledge externalities: localized
technological change in Italy, Cheltenham, Elgar
145
Archibugi D., Filippetti A., (2012), Innovation and economic crisis lessons and prospects from
the economic downturn, London, Routledge
Archibugi D., Evangelista R., Nascia L., (1999), Il ruolo delle piccole e medie imprese nel
sistema innovativo italiano, in Antonelli C. (a cura di), Conoscenza tecnologica: Nuovi
paradigmi dell’innovazione e specificità italiana, Torino, Edizioni FGA
Arrow K., (1962), Economic welfare and the allocation of resources for invention, in Nelson R.
R. (a cura di), The Rate and Direction of the Inventive Activity: Economic and Social Factors,
Princeton, Princeton University Press
Balassone F., Francese M., Pace A., (2013), Debito pubblico e crescita economica, in Toniolo
G. (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio Editori,
pp. 711-733
Banca d’Italia, http://bip.bancaditalia.it/4972unix/homebipentry.htm?dadove=corr&lang=ita
Barbiellini Amidei F., Cantwell J., Spadavecchia A., (2013), Innovazione e tecnologia straniera,
in Toniolo G. (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio
Editori, pp. 5-51
Bassanetti A., Iommi M., Jona-Lasinio C., Zollino F., (2004), La crescita dell'economia italiana
negli anni novanta tra ritardo tecnologico e rallentamento della produttività, Banca d'Italia,
Temi di discussione del Servizio Studi no. 539
Barca F., Iwai K., Pagano U., Trento S., (1998), Postwar Istitutional Reform: The Divergence
of Italian and Japanese Corporate Governance Models, Università degli Studi di Siena,
Dipartimento di Economia Politica, Working Papers no. 234
146
Battaggion M.R., Falzoni A., (1990), Gli indicatori della scienza e della tecnologia: un’analisi
aggregata, in Malerba F, Onida F. (a cura di), La ricerca scientifica, Roma, SIPI, pp. 97-145
Benvenuti M., Casolaro L., Gennari E., (2013), Metrics of Innovation: measuring the Italian
gap, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza no.168
Bertola G., Sestito P., (2013), Il capitale umano, in Toniolo G. (a cura di), L’Italia e l’economia
mondiale, dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio Editori, pp. 343-374
Bigliardi B., (2007), La gestione dell’innovazione nelle imprese industriali: il caso empirico
dell’impiantistica alimentare, Tesi di dottorato in Ingegneria Industriale XIX ciclo, Università
di Parma
Boltho A., (2013), Italia, Germania e Giappone. Dal miracolo economico alla semistagnazione,
in Toniolo G. (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio
Editori, pp. 97-145
Broadberry S.N., (1998), How Did the United States and Germany Overtake Britain? A Sectoral
Analysis of Comparative Productivity Levels 1870-1990, in Journal of Economic History, Vol.
58, no. 2, pp. 375-407
Broadberry S. N., Giordano C., Zollino F., (2013), La produttività, in Toniolo G. (a cura di),
L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio Editori, pp. 257-311
Bugamelli M., Cannari L., F. Lotti e S. Magri (2012), Il gap innovativo del sistema produttivo
italiano: radici e possibili rimedi, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza no. 121
147
Bugamelli M., Pagano P., (2001), Barriers to Investment in ICT, Banca d'Italia, Temi di
discussione del Servizio Studi no. 420
Bugamelli M., Schivardi F., Zizza R., (2008), The Euro and Firm Restructuring, National
Bureau of Economic Research, Working Paper no. 14454
Burroni L., Trigilia C., (2009), Italy: Rise, Decline and Restructuring of a Regionalized
Capitalism, in Economy and Society, no. 38, pp. 630-653
Castronovo V., (2013), Storia economica d’Italia: dall’Ottocento ai giorni nostri, Torino,
Einaudi
Colander D., (2000), The death of neoclassical economics, in Journal of the History of
Economic Thought, Vol. 22, no. 2, pp. 127-143
Commissione Europea, (2014), Bilancio della Strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, allegato della COM(2014) 130 final
Crafts N., Magnani M., (2013), L’Età dell’Oro e la seconda globalizzazione, in Toniolo G. (a
cura di), L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio Editori, pp. 97-
145
Crafts N., Toniolo G. (1996), Postwar growth: an overview, in Crafts N., Toniolo G. (a cura di),
Economic Growth in Europe since 1945, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-37
D’Aurizio L., Marinucci M., (2013), L'innovazione delle imprese italiane tra il 2008 e il 2010,
Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza no. 197
148
Davis J.B., (2006), The turn in economics: neoclassical dominance to mainstream pluralism?,
in Journal of Institutional Economics, Vol. 2, no.1, pp. 1-20
Decaro M., (2011), Cronaca di un decennio nell’Unione Europea, fra governance e government,
in Decaro M. (a cura di), Dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020, Fondazione Adriano
Olivetti,
http://www.fondazioneadrianolivetti.it/_images/pubblicazioni/collana/120111100032Strategia
%20di%20Lisbona.pdf
Dosi G., Nelson R.R., (2013), The Evolution of Technologies: an Assessment of the State-of-
the-Art, in Eurasian Business Review, Vol. 3, no. 1, pp. 3-46
Dosi G., (2004), L'interpretazione evolutiva delle dinamiche socio economiche, Laboratory of
Economics and Management Sant’Anna School of Advanced Studies, Lem Working Paper
Series
Dougherty C., Jorgenson D.W., (1996), International Comparisons of the Sources of Economic
Growth, in The American Economic Review, Vol. 86, no.2, pp. 25-29
EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Fariselli P., (2014), Economia dell’innovazione, Torino, Giappichelli Editore.
Fagerberg J., (1994), Technology and International Differences in Growth Rates, in Journal of
Economic Literature, Vol. 32, no. 3, pp. 1147-1175
Federico G, Wolff N., (2011), Comparative Advantages in Italy: A Long-run Perspective, Banca
d’Italia, Quaderni di Storia Economica no. 9
149
Federico G., Wolff N., (2013), I vantaggi comparati, in Toniolo G. (a cura di), L’Italia e
l’economia mondiale, dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio Editori, pp. 453-485
Freeman C., (1995), History, Co-evolution and Economic Growth, IIASA Working Paper no.
76
Francese M., Pace A., (2008), Italian Public Debt since National Unification: A Recostruction
of the Time Series, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza no. 31
Gambardella A., (2009), Innovazione e sviluppo miti da sfatare, realtà da costruire, Milano,
EGEA
Giannetti R., (1998), Tecnologia e sviluppo economico italiano 1870-1990, Bologna, Il mulino
Grilli L., Mariotti S., (2006), Politiche per l'innovazione e cambiamento strutturale in Italia, in
L' Industria: rivista di economia e politica industriale, Vol. 27, no. 2, pp.365-396
Guerrieri P., Milana C., (1990), L’Italia e il commercio mondiale, mutamenti e tendenze nella
divisione internazionale del lavoro, Bologna, Il mulino
Guiso L., Pinotti P., (2013), Democratizzazione e capitale civico, in Toniolo G. (a cura di),
L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio Editori
ICE, (2014), L’Italia nell’economia internazionale. Rapporto 2013-2014,
http://www.ice.it/statistiche/rapporto20132014.htm
150
International Educational Attainment Database,
http://www.parisschoolofeconomics.eu/en/cohen-daniel/international-educational-attainment-
database/
ISTAT, (2011), L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010, Roma, ISTAT
ISTAT, (2012), Misure di produttività anni 1991- 2011,
http://www.istat.it/it/files/2012/11/Report_produttivit%C3%A0.pdf?title=Misure+di+produtti
vit%C3%A0+-+21%2Fnov%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
ISTAT, (2014), Rapporto Bes 2014 lo sviluppo equo e sostenibile in Italia,
http://www.istat.it/it/files/2014/06/11_Ricerca-innovazione-Bes2014-3.pdf
Kaldor N., (1972), The irrelevance of equilibrium economics, in The Economic Journal, Vol.
82, no. 328, pp. 1237-1255
Kuhn T. S., (1999), (edizione originale 1962), La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino,
Einaudi
Lall S., (2000), The Technological Structure and Performance of Developing Country
Manufactured Exports, 1995-1998, University of Oxford, QEH Working Papers no. 44
Lanza A., Quintieri B, (2007), Eppur si muove. Quote di mercato e qualità delle esportazioni
italiane: il quadro generale, in Lanza A., Quintieri B. (a cura di), Eppur si muove. Come cambia
l’export italiano, Soveria Mannelli, Rubettino Editore
Lucas Jr. R.E. (1988), On the mechanics of economic development, in Journal of Monetary
Economics, Vol. 22, no. 1, pp. 3-42
151
Maddison Projects, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/
Malerba F., (1992), Learning by firms and incremental technical change, in The Economic
Journal, Vol.102 no. 413, pp. 845-859
Malerba F., et al. (2007), Innovazione imprese, industrie, economie, Roma, Carocci
Malerba F, (2011), Il sistema innovativo italiano, in Malerba F. (a cura di), Economia
dell’innovazione, Roma, Carocci editore, pp. 461-491
Maurseth B., (2001), Recent Advances in Growth Theory. A Comparison of Neoclassical and
Evolutionary Perspectives, Norwegian Institute of International Affairs, Working Paper no. 615
Metcalfe J.S., (1994), Evolutionary economic and technological policy, in The Economic
Journal, Vol. 104, no. 425, pp. 931-944
Metcalfe J.S., (2012), J.A. Schumpeter and the theory of economic evolution (One Hundred
Years beyond the Theory of Economic Development), Max Planck Institute of Economics
Evolutionary Economics Group, Paper on Economics and Evolution no. 1213
Metcalfe J.S., Foster J., (2012), Economic emergence: An evolutionary economic perspective,
in Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 82, pp. 420-432
Moncada Paternò Castello P., Ciupagea C., Piccaluga A., (2006), L'innovazione industriale in
Italia: persiste il modello "senza ricerca"?, in L' Industria: rivista di economia e politica
industriale, Vol. 27, no. 3, pp.533-551
152
Nelson R.R., Winter S.G., (1974), Neoclassical vs. Evolutionary theories of economic growth:
critique and prospectus, in Economic Journal, Vol. 84, no. 336, pp. 886-905
Nelson R.R., Winter S.G., (1982), An Evolutionaary Theory of Economic change, London,
Belknap
Nelson R.R., Winter S.G., (2002), Evolutionary theorizing in economics, in The Journal of
Economic Perspectives, Vol. 16, no. 2, pp. 23-46
OECD Database, http://stats.oecd.org/
OECD, (2005), Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data,
Parigi, OECD
OECD, (2006), Innovation and Knowledge Intensive Service Activities, Parigi, OECD
Pagano P., Schivardi F., (2001), Firm Size Distribution and Growth, Banca d’Italia, Temi di
discussione del Servizio Studi no. 394
Pavitt K., (1984), Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory,
in Research Policy, Vol. 6, no.2, pp. 343-373
Penn World Table, https://pwt.sas.upenn.edu/php_site/pwt_index.php
Rae D., Sollie M., (2007), Globalisation and the European Union: which countries are best
placed to cope?, OECD, Economics Department Working Papers no. 586
153
Ricardo D., (1976), (edizione originale 1817), Sui principi dell’economia politica e della
tassazione, Milano, Istituto Editoriale Internazionale
Romer P.M., (1990), Endogenous technological change, in Journal of Political Economy, Vol.
98, no. 5, pp. S71-S102
Roncaglia A., (2003), La ricchezza delle idee: storia del pensiero economico, Roma, GLF
editori Laterza
Rosenberg N., (2010), Handbook of the economics of innovation, Amsterdam, Elsevier
Rossi N., Toniolo G., (1996), Italy, in Crafts N., Toniolo G. (a cura di), Economic Growth in
Europe since 1945, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 427-454
Samuelson P. A., (1983), Economia, Bologna, Zanicchelli
Schivardi F, Torrini R., (2011), Cambiamenti strutturali e capitale umano nel sistema produttivo
italiano, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza no. 108
Schumpeter J. A., (1971), (edizione originale 1912), Teoria dello sviluppo economico, Firenze,
Sansoni
Schumpeter J. A., (2001), (edizione originale 1942), Capitalismo, socialismo e democrazia,
Milano, ETAS
Smith A., (2008), (edizione originale 1776), La ricchezza delle nazioni, Roma, grandi tascabili
economici Newton
154
Solow R., (1957), Technical Change and the Aggregate Production Function, in The Review
of Economics and Statistics, Vol. 39, no. 3, pp. 312-320
Tiffin A., 2014, European Productivity, Innovation and Competitiveness: The Case of Italy, IMF,
Working Paper No. 79
Toniolo G., (2013), La crescita economica italiana, 1861-2011, in Toniolo G. (a cura di),
L’Italia e l’economia mondiale, dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio Editori, pp. 5-51
Tosti F., (2013), La bilancia dei pagamenti della tecnologia dell’Italia, Banca d’Italia,
Questioni di Economia e Finanza no. 207
Treccani, (2012), Dizionario di economia e finanza,
http://www.treccani.it/enciclopedia/progresso-tecnico_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
Trento S., (2007), Innovazione e crescita delle imprese nei settori tradizionali, Centro Studi
Confindustria, Working Paper no. 57
Trento S., Warglien M., (2001), Nuove tecnologie e cambiamenti organizzativi. Alcune
implicazioni per le imprese italiane, Banca d’Italia, Temi di discussione del Servizio Studi no.
428
United Nations Commodity Trade Statistics Database,
http://comtrade.un.org/db/mr/rfCommoditiesList.aspx?px=S1&cc=7
USPTO, http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/h_at.htm#PartA1_1a
155
van Ark B., (1996), Sectoral Growth Accounting and Structural Change in Postwar Europe, in
Crafts N., van Ark B. (a cura di), Quantitative Aspects of Post-War European Economic Growth,
Cambridge, Cambridge University, pp. 84-164
Wolff E.N., (1991), Capital Formation and Productivity Convergence Over the Long Term, in
The American Economic Review, Vol. 81, no.3, pp. 565-579
World Bank, http://data.worldbank.org/
World Wide Web Foundation, Web Index 2012, http://webfoundation.org/projects/the-web-
index