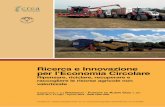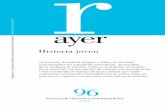Luigi Cortesi intellettuale comunista fra tradizione e innovazione
Transcript of Luigi Cortesi intellettuale comunista fra tradizione e innovazione
2
Anno XXIV – Nuova SerieN. 1-2 – gennaio-agosto 2011
Comitato scientifico:Alberto Burgio, Ugo Dotti, Roberto Fineschi, Andrea Fumagalli, Severino Galante, Ruggero Giacomini, Domenico Losurdo, Giorgio Lunghini, István Mészáros, Paola Pellegrini, Luigi Pestalozza, Vito Francesco Polcaro, Nicolas Tertulian, Emanuele Tortoreto, Mario Vegetti
Comitato di redazione: Marco Albeltaro, Stefano G. Azzarà, Gianni Fresu, Alessandro HöbelCoordinamento: Nunzia Augeri
Direttore: Guido Oldrini
Direttore responsabile: Edio Vallini
Sede legale: Associazione Culturale Marxista – Via Spallanzani 6 – 20129 Milano
Direzione e redazione: Via Sant’Eusebio 24 – 20144 Milanoe-mail: [email protected]
Amministrazione: [email protected]
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 266 del 22/5/1993Pubblicità inferiore al 50%Editore: La Città del Sole s.r.l. – Napoli – [email protected] – www.lacittadelsole.netTipografia: Grafica Bodoni – NapoliDiffusione: per abbonamento e nelle principali librerieUna copia: euro 12,00 – Abbonamento annuo (3 numeri):Italia euro 30,00; estero euro 48,00; sostenitore euro 60,00
AbbonamentiL’importo dell’abbonamento può essere versato sul CCP n. 59912162 intestato a La Cit-tà del Sole s.r.l. specificando la causale oppure sul conto bancario intestato ad Associazio-ne Culturale Marxista, presso Banca Intesa, Agenzia 4, Piazza Oberdan 4, 20129 MilanoIBAN IT26 0030 6909 4510 0001 3697 179. In caso di bonifico avvertire l’amministra-zione via e-mail e telefono
Ogni saggio, con abstract in inglese, che appare nella rivista è preventivamente sottoposto alla lettura e all’approvazione di almeno due blind referee.
marxismooggi RIVISTA QUADRIMESTRALE
DI CULTURA E POLITICA
3
Indice
Editorialedi Mario Vegetti p. 5
INTERVENTI
La questione ecologica: un’analisi a partire dal rapporto uomo-natura nel pensiero di Lenin di Vito Francesco Polcaro 7
La crisi economica attuale e la prospettiva dell’economia eterodossadi Arturo Hermann 16
Elezioni e democrazia al lume della matematicadi Mario Alessio 26
Luigi Cortesi intellettuale comunista fra tradizione e innovazionedi Alexander Höbel 33
SAGGI
Necessità di un’alternativa al parlamentarismo borghesedi István Mészáros 43
Crisi della cultura di massa, postmodernismo e necessità della menzognadi Stefano G. Azzarà 67
La resistibile ascesa della destra reazionaria in Europadi Renato Caputo 141
DOCUMENTI
Lettera/petizione della Georg-Lukács-Gesellschaftper il Lukács Archivum di Budapest 155
ASTERISCHI LIBRARI - Schede a cura di Guido Oldrini 157
37
Luigi Cortesi intellettuale comunista fra tradizione e innovazione*
di Alexander Höbel
1. Vorrei cominciare questo in-tervento con un ricordo personale. Ho conosciuto Luigi Cortesi nel 1993. Erano i primi anni di Rifon-dazione comunista, un’esperienza a cui Cortesi diede per qualche anno la sua fiducia e il suo contributo. Noi, un gruppo di giovani comu-nisti napoletani, eravamo però già critici rispetto ad alcune dinami-che che si erano subito innescate, e soprattutto avvertivamo l’esigenza di costruire luoghi e strumenti di analisi, formazione e dibattito teo-rico, incontrando in questo la tota-le indifferenza dei gruppi dirigenti. Decidemmo quindi di seguire un “editore militante” – che, guarda caso, è lo stesso che oggi pubblica
“Marxismo Oggi” – non solo nel suo progetto di casa editrice, ma anche nell’associazione politico-culturale che egli promuoveva, e che chiamammo un po’ pomposa-mente “L’Internazionale”. L’asso-ciazione si dotò subito di una pic-cola rivista, per la quale iniziammo a cercare collaborazioni illustri. Fu così che, assieme al compagno edi-tore, ci recammo a Roma a parlare con Cortesi. Luigi ci accolse in quel suo studio, che avrei imparato a conoscere negli anni della mia col-laborazione a “Giano”, e, circon-dato come sempre da pile di libri, ascoltò la nostra proposta. In verità dubitavo un po’ che uno storico affermato come Cortesi avrebbe
* Relazione tenuta alla giornata di studio “Luigi Cortesi. Il percorso di un intellettuale militante”, organizzato dal Circolo Gramsci e dall’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, e svoltosi a Bergamo il 19 aprile 2011.
38
accettato di contribuire al nostro percorso. E invece Luigi accettò di buon grado, cosicché il primo nu-mero della rivista (che non poteva che chiamarsi “Futura umanità”) si fregiò di un suo editoriale, dal titolo molto significativo: Bandiere rosse e comunismo critico.
Nell’articolo Cortesi si compia-ceva di una grande manifestazione che poco prima (febbraio 1993), ad onta di liquidatori e transfughi della esperienza comunista, aveva portato in piazza, in un mare di bandiere rosse, circa duecentomila persone, si soffermava sulla “crisi di sistema” che si estende “a misura delle sfide che la legge del profitto lancia sul piano globale ai popoli e alla natura”. Ma come “anda-re oltre il capitalismo”, come co-struire “soluzioni più consone agli interessi reali e vitali della comu-nità umana”? Cortesi rispondeva:
Nell’eredità di pensiero e di esperienza che ci è toccata c’è mol-to di irrinunciabile [...] c’è una struttura di pensiero e di elabora-zione politica che regge alla tempe-sta reazionaria di questi decenni e uscirà rafforzata dalla prova.
Occorreva però mettere “quell’eredità a contatto con i nostri attuali e concreti problemi”, “con-giungere il soggetto delle lotte di libe-razione sociale, il proletariato mon-
diale, con le urgenze” dei problemi globali. “Insieme con la bandiere ros-se – concludeva Gigi – facciamo mar-ciare il comunismo critico [...]. Tut-to, allora, tornerà ad essere possibile”.
2. Questa del “comunismo cri-tico”, peraltro, è la cifra della con-cezione e dell’impegno di Luigi Cortesi, un intellettuale comuni-sta mai allineato, spesso fuori dagli schemi, ma lontano anni luce dalle abiure politiche come dall’ecletti-smo culturale.
Cortesi aveva manifestato questa posizione in occasione del-la crisi del 1956, poi nella stessa esperienza della Rivista storica del socialismo e nei contributi storio-grafici sul PCI e sul movimento operaio di cui hanno parlato Ma-ria Grazia Meriggi e Aldo Agosti. Nel 1989, nel pieno della tempe-sta che avrebbe portato al crollo dei paesi del “socialismo reale”, aveva dato vita, assieme ad altri studiosi militanti, a una rivista come Giano. Ricerche per la pace, che portava in sé i germi di una cultura radicalmente antagonista al sistema e al tempo stesso frut-to dell’incontro tra un approccio marxista e altre culture politiche, dal pacifismo all’ambientalismo.
Negli anni ’90 Cortesi conti-nuò questo percorso. Mentre la maggioranza del PCI decideva lo scioglimento del Partito, fu tra gli
39
intellettuali autori di un manifesto sulle ragioni del comunismo. Alla nascita di Rifondazione, pubbli-cò, con la prefazione di Armando Cossutta, un libro che riprendeva quel titolo: Le ragioni del comu-nismo. In esso Cortesi ribadiva l’attualità dell’identità comunista e della stessa forma-partito, ma al tempo stesso insisteva sulla ne-cessità di “una autentica rifonda-zione”. “Pace, internazionalismo interetnico, ambiente, modello di sviluppo (cioè modo e rapporti di produzione)” erano i “terreni di lotta antimperialistica i cui sogget-ti attuali o potenziali sono già pre-senti”, a partire dal “grande pro-letariato mondiale”, visto come il principale soggetto antagonista “dell’età globale”1.
Tale età – sottolineava in un convegno internazionale sull’idea di socialismo – apre questioni “alle quali il capitalismo non è in grado di rispondere per l’intima contrad-dizione” tra il “tempo breve della riproduzione del capitale” – il qua-le per sua natura tende al profitto immediato, non curandosi del fu-turo, delle generazioni successive o dei destini del Pianeta – e il “tem-po lungo della riproduzione delle condizioni naturali, sottoposte ad un sempre più rapido saccheggio che aumenta a dismisura il declino antropico”. Rispetto a questo ine-dito ordine di problemi occorreva
dunque uno scatto del pensiero marxista, che lo ponesse al livello delle nuove contraddizioni; e in tal senso bisognava “fare dei problemi globali un terreno d’impegno di-rettamente rivoluzionario” volto “a costituire una strategia nuova della lotta [...] per il socialismo”. “Attingendo all’internazionalismo e al fondamentale umanesimo universalistico” del marxismo, in-somma, il soggetto sociale anta-gonista “può farsi carico dei più grandi problemi storici e rappre-sentare la forza d’un progetto ra-dicalmente alternativo”. Cortesi dunque attualizzava il concetto marxiano del proletariato come “classe generale”, che liberando – e in questo caso salvando – se stes-so, consente all’umanità intera di sopravvivere ed emanciparsi; sul piano concreto, la stessa “idea di piano”, la pianificazione, acqui-stava per Cortesi “una valenza de-terminante nel momento in cui il trend della crescita economica af-fidata alla legge del profitto celebra i suoi trionfi sull’orlo dell’abisso e mette a repentaglio la vita sull’in-tero pianeta”2.
3. L’impegno di Cortesi intel-lettuale comunista si intreccia-va quindi con la sua attenzione all’emergenza ambientale, con il suo contributo al movimento pa-cifista e con il percorso di Giano.
40
Nel 1990, nel pieno del proces-so di disfacimento del blocco so-vietico, con la Guerra del golfo contro l’Iraq iniziava la stagione delle nuove guerre, dell’unipo-larismo statunitense, di una rin-novata aggressività dell’imperia-lismo. Introducendo la raccolta di scritti Le armi della critica. Guerra e rivoluzione pacifista, Cortesi scriveva parole di grande attualità, ora che con i bombar-damenti sulla Libia si sta ripro-ducendo una situazione simile:
Desidero che un movimento di popolo sostituisca Saddam Hussein così come gli sceicchi del petrolio, e prenda nelle sue mani il destino dell’Irak e del mondo arabo, ma confesso di non riuscire a demo-nizzare e odiare Saddam Hussein più di quanto gli antifascisti del 1935-36 fecero nei confronti del Negus Neghesti.
[...] nulla di quanto attiene ai rapporti tra le Potenze industria-lizzate e il Terzo Mondo può es-sere capito al di fuori della storia dell’imperialismo [...] e della sua attualità e funzionalità in ordine al dominio del mercato mondiale.
Confesso anche di non capire come persone che non amano la guerra si dimostrino incapaci di una visione critica di quanto sta svolgendosi [...] e indichino nel ‘dittatore iracheno’ l’unico colpe-
vole, il mostro, il ‘capo invasato’ (Bobbio) e come uomini la cui vita è stata legata al movimento operaio [...] siano giunti a firmare col voto parlamentare il loro malinconico tramonto3.
Cortesi si riferiva all’ala mag-gioritaria dell’ultimo PCI, quella che aveva deciso di considerare esaurita l’esperienza del PCI e non più valido l’obiettivo del sociali-smo. E per lui non era un caso se il brusco distacco dalla tradizione comunista e l’abbandono di una prospettiva di trasformazione si accompagnavano all’accettazione della guerra, ora definita – con uno strano ossimoro che si use-rà anche nei confitti successivi – “guerra umanitaria”.
Nella stessa prefazione, Cortesi non rinunciava a tornare sulla vi-cenda del “socialismo reale”, che vi-veva la fase più acuta della sua crisi. Egli ribadiva la “presenza di fondo del ‘fattore esogeno’ nel processo post-rivoluzionario, nelle origini stesse dello stalinismo”, il “ruolo decisivo della ‘guerra fredda’” nel contribuire a determinare alcuni caratteri di fondo del sistema so-vietico, e pur sottolineando la ne-cessità di indagare le “debolezze del modello economico-sociale in sé”, vedeva la stessa vicenda dell’ulti-mo decennio come “una disfatta
41
dovuta ad un confronto militare e strategico (e, mediatamente eco-nomico e tecnologico) cui l’Unione Sovietica è stata incapace di sot-trarsi”; un confronto “tanto impari da essere stato vinto dall’Occidente con un lucido calcolo dei rischi, anche estremi”, pur senza giungere alla guerra totale4.
D’altra parte, nel suo volume sul Comunismo inedito. Lenin e il problema dello Stato, Cortesi aveva sottolineato anche i limiti intrinseci dell’esperienza sovieti-ca, in particolare sul problema del rapporto Stato/masse e della de-mocrazia socialista, riprendendo le riflessioni in proposito di Lenin, e in particolare dell’ultimo Lenin, allorché il grande dirigente e teo-rico bolscevico pose la sua elabo-razione a confronto coi problemi reali della transizione, offrendo spunti di analisi e proposte con-crete che avrebbero potuto evitare alcune deformazioni successive5.
Quanto ai paesi a capitalismo avanzato, Cortesi li definiva “Stati-guerra”, nei quali “la ‘democrazia reale’ funziona anche nell’occulta-mento del potere supremo e non democratizzabile”, quello appunto economico e militare, centrale in ciò che Lenin aveva definito “impe-rialismo” – una categoria cui Corte-si non rinunciò mai – e che deline-ava una “maggior disponibilità del sistema capitalistico alla guerra”,
in quanto quest’ultima si lega alle esigenze della sua stessa riproduzio-ne e ai conflitti che essa innesca6.
Pochi mesi dopo, all’indoma-ni del tentato di colpo di mano dell’agosto 1991 da parte dell’ala del PCUS ostile a Gorbačëv, Cor-tesi – che pure aveva sperato molto nel tentativo di rinnovamento del leader della perestrojka, apprez-zandone tra l’altro l’idea di inter-dipendenza – così commentava:
La clamorosa ritirata dall’URSS non ha favorito un armistizio du-revole e garantito [...] ma è andata a vantaggio d’una proiezione oc-cidentale generatrice di crisi, di squilibri, di nuove minacce [...] che costituiscono la fenomenologia classica dell’imperialismo.
Il mondo sembra tornato in-dietro ai tempi della guerra ispano-americana, della spedizione contro i boxers, delle crisi marocchine e balcaniche [...] con una Interna-zionale socialista che può celebrare gloriosamente i suoi innumerevoli 4 agosto [...]7.
Rispetto a tutto questo, la storia del movimento comunista e del-lo stesso “socialismo reale” – pur coi suoi drammi che Cortesi ben conosceva e indagava – portava dentro di sé un segno diverso, un carattere originario che, nonostan-te tutte le “deformazioni”, non era
42
mai venuto meno. In un dossier di “Giano” per l’80° della Rivolu-zione d’Ottobre, Cortesi ribadiva:
L’Unione Sovietica era una superpotenza armata fino ai denti eppure; da parte sua sono venute le più forti resistenze alla corsa agli armamenti nucleari e le uniche, possiamo dire, serie proposte di di-sarmo; principalmente nell’URSS, sul piano internazionale, il pacifi-smo trovava ascolto e perfino un certo linguaggio comune. Il suo re-gime interno era ormai screditato; eppure da ogni angolo del mondo ancora si guardava alla società so-vietica [...] come a quella che per prima [...] aveva indicato al mondo degli sfruttati e degli umiliati la via della liberazione [...].
Può essere interessante studiare gli aspetti mitici di quest’immagine [...]; ma ancor più interessante è cogliere il loro nocciolo di verità8.
E nel numero successivo, com-mentando l’uscita in Francia del Libro nero del comunismo, Cortesi – oltre a respingere l’identificazio-ne tra la fase staliniana dell’URSS e il comunismo tout court – tor-nava sulla “sfida tra titani”, tra movimenti e Stati contrapposti, svoltasi nel Novecento, sull’“asse-dio” subito dal campo socialista come origine della costruzione di una “alterità difensiva bisogno-sa di strutture statali, esecutive e
militari adeguate alla sfida”, e ag-giungeva: “In questa condizione, più che in una vocazione statali-stica e totalitaria del marxismo e del leninismo, occorre cercare le radici dello stalinismo”. Quanto a quest’ultimo, “chi potrebbe essere, eventualmente, il giudice di una Norimberga dello stalinismo? [...] Quante furono tra le due guerre mondiali le vittime dell’imperiali-smo [...] Quante quelle dell’antico-munismo”, dalla Spagna alla Cina di Chiang Kai-shek, quante le “vit-time della grande crisi economica del 1929 e seguenti”? E infine vi sono innumerevoli “sofferenze [...] incorporate nelle strutture materia-li e nella stessa cultura d’un sistema che si vuole necessario e aclassista, ed ora organicamente democratico, e quindi pretende di offendere e uccidere senza perdere la propria innocenza”9. Le sue bombe sono sempre umanitarie, le sue guerre sono sempre democratiche, i suoi raid sempre “chirurgici”.
4. Cortesi quindi mantenne sempre una posizione anticapita-lista e comunista. Ma la forza e l’originalità della sua elaborazione sta nell’aver collocato questa scelta di campo nel nuovo contesto dei problemi globali e degli stessi “pro-blemi finali”. Non certo per una impostazione apocalittica a prio-ri, ma per la consapevolezza che
43
il progressivo esaurimento delle risorse energetiche, l’assottigliarsi della disponibilità di materie pri-me essenziali, la crisi climatica e ambientale, accanto alle contrad-dizioni sociali aperte dalla mon-dializzazione capitalistica, stanno portando il mondo verso una “cri-si di civiltà” che solo la rimessa all’ordine del giorno di una gestio-ne collettiva, democratica e socia-le, e di un’equa distribuzione delle risorse, solo il superamento di un sistema finalizzato a una illimitata riproduzione di merci – insomma solo il riaffacciarsi della prospetti-va socialista – potrebbe fermare10.
La stagione della “guerra infi-nita” di Bush, ora proseguita sotto altre forme dal democratico Oba-ma e dall’Unione Europea, confer-mava questa urgenza. Cortesi sot-tolineava la contraddizione dram-matica di “una guerra infinita che forza le soglie d’un mondo finito”, e accentua la distruzione di beni e risorse, oltre che di vite umane, creando una situazione in cui la guerra stessa diventa “un prolun-gamento organico dell’economia e della politica”. Ma per “svellere le radici” di questo processo – osser-vava all’indomani dell’11 settem-bre 2001 – occorre “una strategia che riporti e alimenti il confitto nel cuore della società”, nelle sue dinamiche strutturali; riattivare il conflitto sociale e politico, in que-
sto senso, era “l’unica via di salvez-za dell’umanità”, l’unico modo per rimettere in discussione la dinami-ca distruttiva del sistema11.
In questo senso Cortesi co-glieva anche i segnali positivi, di controtendenza, manifestatisi con le grandi mobilitazioni contro la guerra e col movimento no-glo-bal. Anche rispetto a quest’ultimo, però, senza subalternità, senza nes-sun approccio da “anno zero”, ma sempre, al contrario, con un forte senso della continuità storica, e della necessità di saldare le nuove mobilitazioni alla tradizione del movimento comunista. Aprendo il convegno “Globalizzazione senza governo”, Cortesi osservava che “una ‘società civile globale’ è certa-mente in formazione” sotto forma di “grandi movimenti di massa”, e vedeva il rapporto di tale soggetto col movimento operaio e la sua storia come “un nodo di importan-za decisiva”. E non per motivi sen-timentali, ma per precise ragioni politiche, e cioè per il contributo che quel movimento aveva portato e continuava a portare al cammi-no delle forze progressive. Corte-si ne elencava i punti principali:
Una analisi ‘aperta’ delle forze motrici della storia umana e dei meccanismi di funzionamento [...] delle società capitalistiche; l’esperienza di spostamento del
44
principale asse conflittuale della storia contemporanea dalla guer-ra tra gli Stati alla lotta di classe; la [...] necessaria unità di movi-mento e di elaborazione teorica; la proposta di indirizzi di pia-no come rimedio necessario alla ‘anarchia capitalistica’ [...]; infine, il senso dell’alternativa storica12.
Solo così, vivificando questo legame, il movimento no-gobal poteva uscire dalla indetermina-tezza dell’altro mondo possibile, e cominciare a delinearne i caratteri.
In questo modo di porsi rispet-to ai movimenti e alla loro elabo-razione, Cortesi si differenziava anche dal partito di cui aveva fatto parte, Rifondazione comunista, e dal suo segretario Fausto Bertinot-ti. “La priorità del conflitto sociale [...] come via d’uscita dall’impasse apocalittica va affermata in tutte le direzioni – scriveva nel 2006 –: anche contro la mistica impro-duttiva della nonviolenza”13. Né Cortesi aveva temuto di parlare di “resistenza irachena” e di schierar-si al suo fianco in occasione della guerra del 200314. Né infine si era fatto abbacinare dalle teorizzazio-ni su un presunto Impero unico, privo di confini e “de-territoria-lizzato”, rimanendo invece salda-mente ancorato a quella categoria di imperialismo, di cui la realtà
stessa ha purtroppo confermato l’attualità15. Già nel 1992, peral-tro, Cortesi aveva affermato la “irrinunciabilità” della categoria di imperialismo, definendola anzi “incunabolo dei ‘problemi globa-li’”, loro premessa e chiave inter-pretativa fondamentale16.
Rispetto alle tante guerre di questi anni e all’imperialismo de-mocratico – l’imperialismo dei di-ritti umani, per dirla con Antonio Gambino17 – che le ha sorrette e guidate, l’atteggiamento di Cor-tesi fu sempre molto netto. Ma sebbene Gigi non avesse alcuna simpatia per Saddam Hussein e nemmeno per Milosevic, rifuggì sempre da quella equidistanza tra aggrediti e aggressori che pure nel movimento pacifista era diffusa, e percepì la distruzione della Jugo-slavia in tutta la sua drammaticità.
Insisté molto, infine, e giusta-mente, sulla crisi di civiltà nella quale il mondo stava precipitando: la stessa plurisecolare civiltà bor-ghese – osservò – potrebbe finire per “dissolversi per incapacità di autolimitazione”18. E dinanzi alla possibilità che la guerra, vista or-mai come prosecuzione della po-litica, potesse invece porre le basi per la “fine della civiltà umana”, aggiungeva:
Su questi crinali escatologici vanno ripensate le varie strategie
45
del socialcomunismo e le linee del-la costruzione d’una nuova società; il primato dell’interesse collettivo e universale sul privato capitalisti-co va ristabilito sulle basi imposte dalla necessità oggettiva. Sono pro-penso a credere che l’introduzione di misure di socialismo nell’assetto socio-economico e una reale de-mocratizzazione della politica sarà parte di un tale più ampio processo di costruzione d’una società mon-diale senza più guerre19.
L’epoca apertasi dopo il 1989-91, dopo la sconfitta dell’antago-nista storico, aveva fatto emerge-re il “fallimento del capitalismo come sistema mondiale di gover-no” e aperto scenari allarmanti; si affacciava cioè la prospettiva che la crisi capitalistica – che dal 2007 sarà conclamata – sfociasse appunto “in una generale crisi di civiltà”. D’altra parte, aggiungeva, ciò che in genere si intende per ci-viltà è quella stessa “al cui impian-to strutturale” può farsi risalire “la genesi del disastro”. Emergeva dunque con chiarezza il “carattere ambivalente della tipologia di svi-luppo imposta al mondo, e della prevalenza in essa dell’aspetto de-generativo e distruttivo”20.
È per questo che la consapevo-lezza dei problemi globali e della loro drammaticità e urgenza si legava per Gigi in modo inestri-cabile con la lotta per una diver-sa prospettiva sociale e politica, col suo essere comunista. Quella che il mondo viveva era una “crisi del modo di produzione nel suo complesso”, originata dalla “sua incapacità di affrontare i proble-mi della globalizzazione” e dal suo scontro coi limiti delle stesse “con-dizioni fisico-chimiche della vita”.
Quando tutto ciò si ritradurrà in termini espliciti di lotta di classe – aggiungeva – il comunismo tor-nerà sulla scena in tutti i continen-ti, riprenderà con maggior vigore il suo corso pratico e la funzione teorica di analisi critica e di pro-getto sociale alternativo.
E ciò forse accadrà quando la sopravvivenza stessa del Pianeta “diventerà un problema di lotta politica e di cambiamento rivolu-zionario”21. “Lì dunque comincerà – è già cominciato, sotto qualche altro cielo – un altro ciclo storico” per il cui sviluppo “l’esperienza del socialismo e del comunismo appare imprescindibile”22.
1 L. Cortesi, Le ragioni del comunismo. Scritti e interventi per la Rifondazione,
prefazione di A. Cossutta, Milano, Teti, 1991. Cfr. in particolare le pp. 42-51.
46
2 L. Cortesi, Socialismo e problemi glo-bali, ivi, pp. 117-133.
3 L. Cortesi, Le armi della critica. Guerra e rivoluzione pacifista, Napoli, Cuen, 1991, pp. 14-15.
4 Ivi, pp. 10-11.5 L. Cortesi, Il comunismo inedito.
Lenin e il problema dello Stato, Milano, Punto Rosso, 1995.
6 Ivi, p. 11.7 L. Cortesi, Il comunismo, la storia, la
pace, “Giano. Ricerche per la pace”, 1991, n. 8, poi in Id., Le ragioni del comunismo, cit., pp. 136-142.
8 1917-1997. Rivoluzione, “socialismo reale”, normalizzazione, “Giano. Pace am-biente problemi globali”, 1997, n. 26.
9 L. Cortesi, Le “vittime del comunismo” ed altre vittime, ivi, 1997, n. 27, pp. 37-41.
10 L. Cortesi, Problemi finali e rinno-vamento del comunismo, ivi, 2001, n. 37, pp. 77-80.
11 L. Cortesi, Perché? Why?, “Giano. Pace ambiente problemi globali”, 2001, n. 38, pp. 5-13.
12 L. Cortesi, Introduzione. L’umanità al bivio, ivi, 2003, n. 44, p. 109.
13 L. Cortesi, Il pacifismo antagonista e l’impatto con la politica, ivi, 2006, n. 54, p. 156.
14 Id., Iraq libero. Un saluto alla resisten-za irachena, ivi, 2003, n. 45.
15 Cfr. ad es. L. Cortesi, Imperialismo americano, complicità europea e nuovo ci-clo geopolitico, ivi, 2007, n. 57.
16 L. Cortesi, L’imperialismo, incu-nabolo dei “problemi globali”, “Giano. Ricerche per la pace”, 1992, n. 11, poi in Id., Una crisi di civiltà. Cronache di fine secolo. Dal “socialismo reale” alla guerra in Jugoslavia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 63.
17 A. Gambino, L’imperialismo dei diritti umani. Caos o giustizia nella so-cietà globale, Roma, Editori Riuniti, 2001.
18 L. Cortesi, Occidente, una crisi di civiltà, “Giano. Pace ambiente problemi globali”, 1998, n. 29-30, ora in Id., Una crisi di civiltà..., cit., pp. 129-131.
19 L. Cortesi, Storia e catastrofe. Sul sistema globale di sterminio, prefazione di Edoarda Masi, II ed., Roma, manife-stolibri, 2004, p. 52.
20 L. Cortesi, Crisi del capitalismo e crisi di civiltà, “Giano. Pace ambien-te problemi globali”, 2005, n. 51, poi in Id., L’umanità al bivio. Il Pianeta a rischio e l’avvenire dell’uomo, Roma, Odradek, 2006, pp. 119-133.
21 Cortesi, Il comunismo inedito. Lenin e il problema dello Stato, cit., pp. 16-17.
22 Cortesi, Il comunismo, la storia, la pace, cit.