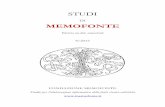Accademie, autodidatti e studio dal modello nella roma di primo seicento
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Accademie, autodidatti e studio dal modello nella roma di primo seicento
N ella vita di Nicolas Poussin, il biografo e pittore Giovan Battista Passeri lamenta che a Roma i giovani non studino anatomia, architettura,
prospettiva, « e quello tanto bisognoso al pittore di luce e ombra » ; aggiunge anzi che a Roma la gioventù ride spropositatamente di questi studi così necessari, incoraggiati in ciò dai loro maestri che non ne hanno nessuna cognizione 1. È possibile che quello del Passeri sia solo un artificio retorico, ma in realtà si ha l’impressione che nella città eterna l’apprendimento fosse poco sistematico e più basato sulla pratica che sulla teoria. Inoltre, come notato da John Marciari, dalla morte di Perin del Vaga nel 1547, mancavano a Roma botteghe grandi e bene organizzate, dove un giovane potesse imparare la professione ; anzi già Perino aveva introdotto l’abitudine di assumere lavoranti a giornata, che quindi non venivano formati presso di lui 2.La necessità di provvedere all’istruzione dei giovani, che affluivano a Roma da ogni parte d’Europa e che per motivi economici cominciavano a lavorare prima di avere ricevuto una preparazione adeguata, è ben presente nei documenti che testimoniano i vari tentativi di fondare un’accademia dei pittori. Nella bolla di Gregorio XIII, concessa a Girolamo Muziano nel 1577 e che non ebbe risvolti pratici, in quella di Sisto V del 1588, negli statuti elaborati durante il principato di Federico Zuccari nel 1594 e in tutti quelli successivi, l’insegnamento dei giovani risulta una preoccupazione costante della nascente accademia di San Luca 3. È però abbastanza evidente che questo ruolo da parte dell’istituzione, almeno fino agli anni trenta del Seicento, fu marginale ; come sottolineato da Nicholas Pevsner, non compare in nessuna biografia di pittore 4.All’accademia Federico Zuccari aveva istituito un programma di insegnamento basato sia sulla teoria che sulla pratica, che sembra non sia sopravvissuto al suo principato. A detta del segretario Romano Alberti, i gentiluomini aggregati all’istituzione erano più interessati alle lezioni teoriche di quanto non fossero gli artisti ; pensavano anche che se questi ultimi non erano in grado di svolgere le lezioni loro assegnate dal principe avrebbero dovuto farsele preparare da qualcuno più versato di loro in questi argomenti 5.L’insegnamento pratico organizzato dallo Zuccari era basato sul disegnare, non sul dipingere, e graduato a seconda dell’abilità degli allievi. I principianti copiavano disegni di particolari di parti del corpo e del volto ; alcuni copiavano cartoni e rilievi ; altri ancora « opere di maestri » (probabilmente dipinti), mentre i più esperti disegnavano di invenzione 6. Per l’accademia lo Zuccari acquistò un cadavere, che fu usato per lezioni di anatomia, e come è noto intendeva anche fare disegnare gli allievi dal modello vivente 7.Esistono pochissime tracce per documentare un insegnamento sistematico e non sporadico all’accademia da San Luca per oltre trent’anni dopo il principato dello Zuccari e comunque la frequenza prevista delle lezioni, che nel migliore dei casi si sarebbero dovute tenere la mattina della domenica e dei giorni di festa, non
Patrizia Cavazzini
Accademie, autodidatti e studio dal modello nella Roma
del Caravaggio
82 LE CARAVAGE AUJOURD’HUI
era certo sufficiente per la formazione dei giovani 8. Che l’insegnamento non funzionasse come ci si auspicava, è suggerito anche dal fatto che Simon Vouet, principe dal 1624, sentì il bisogno di rifondare il corso di studi 9. Non si sa quali risultati abbia ottenuto la sua riforma, ma va sottolineato che vari artisti, anche tra quelli molto legati all’istituzione, avevano creato accademie private dove si studiava dal modello. Il Domenichino ad esempio teneva le riunioni nella sua dimora, in quegli anni situata a piazza Scannenberg 10. La carica di maestro dello studio, da lui ottenuta nel gennaio del 1630, non era certo abbastanza prestigiosa per fargli dimenticare lo smacco subito il mese precedente quando, su inizia-tiva del cardinale Francesco Barberini, aveva dovuto rinunciare al principato in favore di Gian Lorenzo Bernini ; la vicenda anzi sembra avere incoraggiato la partenza dello Zampieri per Napoli, avvenuta nell’autunno di quell’anno 11. Anche Andrea Sacchi aveva una sua accademia di studio dal modello, ben docu-mentata in Bellori, in Passeri, nelle testimonianze di un processo del 1635, e dai numerosissimi disegni eseguiti dagli allievi, in parte conservati a Windsor 12. Nel processo il pittore Tommaso Donini cita ripetutamente la « scola et acca-demia del signor Sacchi », che forse erano istituzioni separate. Come notato da Ann Sutherland Harris, a Berlino esistono anche copie di disegni di figura del Sacchi (quindi non eseguite direttamente dal modello vivente) che potrebbero provenire dalla sua scuola, e non dalla sua accademia 13.Bisogna invece riflettere sull’ipotesi che il Bernini avesse creato un’accademia di pittura nel palazzo della Cancelleria, sostenuta da Tomaso Montanari sulla base di quattro pagamenti effettuati dal cardinale Francesco Barberini allo scultore « per l’accademia de’ pittori » 14. Ma i pagamenti cominciano due mesi dopo l’inizio del principato del Bernini a San Luca ; inoltre, in vari documenti notarili, l’accademia di San Luca è chiamata appunto « accademia de’ pittori » 15. Sembra perciò che il cardinale rimborsasse al Bernini piccole somme che questi aveva anticipato all’accademia di San Luca, o che le donasse tramite lo scultore. Tra l’altro uno solo dei quattro pagamenti, quello effettuato nel 1642, nomina il palazzo della Cancelleria, forse perchè l’ordine venne dato dal palazzo (dove il cardinale risiedeva in quanto vice-cancelliere), in maniera analoga a quello che si osserva nei mandati del Cardinal Alessandro Peretti Montalto 16.L’ambizione dell’accademia di San Luca di avere un ruolo importante nell’in-segnamento, in modo da assicurare un certo livello qualitativo delle opere prodotte, derivava in parte dal fatto che a Roma il numero dei pittori non era regolamentato da una corporazione delle arti e mestieri. Dato che esisteva una domanda sostanziale per dipinti e decorazioni anche di qualità scadente, molti giovani si avviavano alla pittura non tanto per diventare artisti, ma per trovare un mestiere che consentisse loro di sopravvivere in maniera decente, se non proprio agiata. Anche molti stranieri con un minimo di bagaglio tecnico arri-vavano in città e cominciavano a lavorare senza incappare in nessun ostacolo, che invece avrebbero incontrato spostandosi da una città all’altra dei loro paesi di origine 17. A Roma infatti era forse più facile aprire una bottega di pittore che di falegname o pasticciere 18, data l’assenza quasi totale di norme per quello che riguardava la professione.Il basso costo dell’apprendistato contribuiva ad attirare molti giovani nella città. La percezione di John Michael Montias che per i pittore stranieri fosse molto costoso impararvi il mestiere è sbagliata, poiché vi erano vari modi per finan-ziarsi 19. Anche se Carlo Caroselli, figlio del pittore Angelo, spiegò a un giudice che « nell’arte di pittori quelli che insegnano ai giovani inesperti e principianti li fanno pagare et alcuni lo fanno gratis », in realtà era comune all’inizio compen-sare i propri maestri 20. Il figlio di un gentiluomo, o comunque chi non voleva
83ACTES DU COLLOQUE
svolgere un lavoro manuale, pagava in denaro, ma si poteva pagare in servizi resi, non solo come garzoni di bottega, ma anche come domestici 21. Si poteva anche evitare una delle fasi puramente manuali dell’apprendimento, dato che a Roma era molto comune acquistare le tele già imprimite, tanto presso i commercianti di colori che presso quelli di dipinti da pochi scudi 22.Gli aspiranti pittori potevano lavorare per il proprio maestro, o anche per altri, in modo da assicurarsi almeno vitto e alloggio. « Uno che attende continua-mente alla pittura può fare anche altri servizi », dichiarò lo sconosciuto pittore Francesco Gubernario nel 1641 23 : infatti vari gentiluomini ospitavano pittori in casa e finanziavano il loro apprendimento, forse in cambio di un lavoro poco gravoso. Oppure, per assicurarsi la sussistenza, alcuni pittori praticavano mestieri del tutto diversi, ad esempio diventavano soldati. Ma appena si era in grado di contribuire alla produzione del proprio maestro, si aveva diritto a un compenso, sia presso i pittori che presso gli scultori. Per questo Alessandro Rondoni nel 1599 dichiarava : « Quando prendo delli garzoni cerco sempre che loro paghino me nelli primi anni, [avanti] che io paghi loro » 24.Vari elementi inducono a pensare che, a parte qualche eccezione, a Roma il livello culturale dell’apprendistato non fosse elevato. Ad esempio il Cavalier d’Arpino, che aveva molti allievi e, a detta di Giovan Pietro Bellori anche una vera e propria scuola, da giovane era analfabeta 25. L’attività didattica di Andrea Sacchi è ben documentata, ma è significativo che nel lungo elenco di libri e di materiali di bottega presenti nel suo inventario manchi qualsiasi titolo relativo all’ottica, all’anatomia, alla prospettiva, all’architettura e alla matematica 26. Il Sacchi possedeva invece trattati di storia, di religione e volumi utili dal punto di vista iconografico, come la Genealogia degli dei di Vincenzo Cartari o la Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso.Almeno a detta del Baglione, numerosi pittori nella Roma seicentesca erano autodidatti. Di molti, in effetti, non conosciamo la formazione e in certi casi non ne sapevano nulla neppure i contemporanei : in un lunghissismo processo civile del 1629 il giudice chiese a vari testimoni con « quale pittore eccellente » avesse studiato Giovanni Antonio Galli, soprannominato Spadarino 27. Nonostante molti testimoni, compreso Giovanni Lanfranco, conoscessero benissimo lo Spadarino da almeno 25 anni, nessuno fu in grado di dare una risposta, al di là del dichiarare che il pittore aveva vissuto per molto tempo nel palazzo di San Marco (cioé a palazzo Venezia), presso il cardinal Giovanni Dolfin. Se per motivi stilistici si è tentati di collocare l’alunnato dello Spadarino presso il Caravaggio, nulla risulta dalle fonti, tranne appunto il lungo soggiorno nel palazzo dell’ambasciatore di Venezia, dove il pittore è documentato nel 1603, nel 1619 e nel 1620 (nel 1613 invece risiedeva altrove) 28.Il non sapere con chi si fossero formati molti pittori che lavorarono a Roma dipende in parte dal fatto che l’apprendistato poteva essere estremamente flessi-bile e discontinuo. Nel tardo Cinquecento si trovano ancora contratti di appren-distato per pittori, ma è quasi impossibile rintracciarli per il Seicento, anche se continuarono ad essere in uso tra i pittori indoratori 29. L’esame degli stati di anime dei pittori rivela che nelle loro dimore gli apprendisti cambiavano molto frequentemente, il che suggerisce fosse comune cambiare maestro spesso. Ad esempio, nell’abitazione di Bartolomeo Manfredi, nello spazio di pochi anni, passarono Pietro da Lorena, Francesco Guerrieri romano, Raffaello Cassallo da Farnese, Jacopo Sciappi francese e Andrea Risto maltese 30. Un esempio di pittore dall’apprendistato discontinuo è Tommaso Donini, il quale studiò con Nicolas Régnier, Andrea Sacchi, Angelo Caroselli e Giovanni Lanfranco : al
84 LE CARAVAGE AUJOURD’HUI
di là del numero dei maestri, colpisce la totale mancanza di coerenza stilistica tra di loro 31.Molti pittori nella Roma di primo Seicento dovettero apprendere i primi rudi-menti del mestiere da mediocrità, forse anche da indoratori, e per questo non si curarono di pubblicizzare il proprio periodo giovanile. Lo Spadarino avrà imparato dal fratello Giacomo, più anziano, che era un indoratore e dipingeva prospettive sceniche, affreschi e tele, soprattutto di uccelli. Andrea Sacchi prese il cognome da Benedetto Sacchi, che non era il padre, ma deve essere stato il suo primo maestro, anche se non raggiunse certo i vertici della professione 32. Era infatti un copista di Madonne miracolose, che vendeva per 10 scudi 33. Il padre del Cavalier d’Arpino era anch’egli un pittore « grosso », cioè mediocre, e tale rimase « per avere più pratica di armi che di pennelli » 34.Giovanni Baglione affermò di avere studiato con un tal Francesco Morelli per due anni, e poi di essere stato uno dei tanti autodidatti : narra che « da se mede-simo attendeva a studiare le belle opere di questa città » 35. Il fondamentale ruolo didattico svolto da Roma stessa è sottolineato tanto nei racconti dei biografi, quanto dalle testimonianze che emergono dai processi giudiziari. Per questo a Roma l’uso di calchi in gesso per studio non era poi così frequente, e molti inventari di pittori ne contengono pochi o nessuno.Per consentire un certo grado di autonomia nell’apprendimento, fu essenziale il diffondersi prima di disegni e poi di incisioni che rappresentavano le varie parti del corpo e del volto 36. Ne sentiamo parlare nel secondo Cinquecento, inizialmente come uno strumento per dilettanti ; in seguito diventarono comuni anche per gli artisti 37. Federico Zuccari considerava questi disegni l’ABC della pittura, e chiaramente i Carracci li usavano a Bologna 38. Karel van Mander, poco prima del 1600, auspicava che un grande maestro li incidesse, in modo da creare un abecedario destinato all’apprendimento dei giovani 39. Il suo desiderio fu soddisfatto dalle incisioni di Odoardo Fialetti, che pare fossero disponibili dal 1599 in fogli sparsi, e che furono pubblicate tutte insieme nel 1608 40 (fig. 1). Già dal primo Cinquecento esistevano fogli analoghi in Germania, che saranno arrivati anche a Roma, ma erano molto meno dettagliati ed anche più difficili da imitare, in quanto basati più su elementi geometrici che naturalistici 41.In una fase più avanzata dell’apprendimento si copiavano disegni di singole figure (e in parte per questo esistono copie di disegni di nudi del Sacchi) e in seguito di composizioni ; poi sempre tramite disegni si copiavano anche dipinti 42. I giovani pittori frequentavano le botteghe di piazza Navona per ammirare e acquistare le incisioni di opere celebri, che venivano anch’esse copiate 43. Vari processi, e soprattutto quello al Cavalier d’Arpino, che si concluse con il sequestro dei suoi dipinti, mostrano la fase successiva della formazione degli artisti. Aspiranti pittori, noti o sconosciuti, andavano in giro per la città e disegnavano quello che vedevano, cominciando dalle facciate di Polidoro da Caravaggio, particolarmente facili, dato che sono bidimensionali e non impli-cano l’uso del colore, per poi passare a copiare affreschi, rilievi e statue 44. Nel 1602 un Sebastiano de Papalibus di Capua copiava le figure dipinte sul palazzo Planca Incoronati in via Monserrato, esattamente come in seguito fece il giovane Andrea Sacchi 45. Nel 1607 Giovan Domenico da Pontecorvo e Francesco Brianzo da Acquasparta giravano per la città e disegnavano alla villa della Farnesina, nelle cappelle di Santa Maria Maggiore, in palazzo Farnese, nelle logge vaticane di Raffaello, nel cortile del Belvedere e in Campidoglio. Poi portavano i loro disegni al Cavalier d’Arpino che offriva loro consigli, sugge-rimenti e soprattutto correggeva sul foglio i loro errori. Pontecorvo dichiarò : « non sono molto pratico delle case del Cavalier d’Arpino perché non andavo,
85ACTES DU COLLOQUE
nè trattavo con lui se non con occasione che io gli andavo a mostrare i disegni che io faceva ». Il d’Arpino in cambio richiedeva minimi servizi, come pulire le ciotole dove si mescolavano i colori. Al contrario di Flaminio Allegrini, i due evidentemente non erano parte stabile dell’entourage del d’Arpino, ma erano comunque pittori con ambizioni 46 : sappiamo da Gianni Papi che Francesco Brianzo nel 1603 aveva aggredito lo Spadarino a causa di rivalità artistiche 47. Questi meccanismi di apprendimento, che si propagavano lungo la scala sociale, durarono nel tempo ; nel 1641 Francesco Gubernario correggeva i disegni di un tal Francesco Sancarlo, il quale lavorava con un pittore così scadente da non essere in grado di insegnargli nulla 48. Anche Andrea Sacchi correggeva i disegni dei propri allievi, la cui eterogeneità è evidente dalle testimonianze grafiche che sono sopravvissute 49.Il disegnare d’invenzione veniva in una fase successiva dell’apprendimento, e non si trovano molte informazioni relative al suo insegnamento. Solo una volta all’anno l’accademia di San Luca organizzava una gara dove, stabilito un soggetto letterario o religioso, i giovani dovevano sottoporre un disegno originale per una composizione ; secondo il Bellori il giovane Andrea Sacchi ne vinse una a undici anni (o più probabilmente qualche anno dopo) 50. La pratica aveva forse origine dall’accademia dei Carracci a Bologna, dove simili competizioni avevano luogo ogni due mesi 51. Da quando il cardinale Francesco Barberini divenne protettore dell’accademia nel 1627, il premio consisteva nel suo commissionare un quadro dal disegno vincente, che veniva pagato gene-rosamente. Il Passeri descrive come in queste gare i maestri aiutassero i propri allievi nelle composizioni, ma volendo fare credere il contrario, mostravano « il disegno fatto dal nudo nella propria accademia » (cioè i disegni dal modello delle singole figure) 52.Comunque le basi dell’apprendimento a Roma erano il disegnare, il copiare e lo studio dal modello : si disegnava per molti anni, molti più che a Napoli, senza toccare i pennelli 53. Le testimonianze riguardo all’importanza del disegno sono
Fig. 1 – Odoardo Fialetti, Piedi, in Il vero modo e ordine per disegnare tutte le parti e membra del corpo umano, Venezia, 1608.
86 LE CARAVAGE AUJOURD’HUI
numerosissime ed è anche per questo che l’arrivo del Caravaggio fu scioccante : secondo il Bellori chi imita Caravaggio copia dalla natura e ottiene i propri risultati senza studio o sforzo 54. In maniera analoga il Baglione narrò come Carlo Saraceni, dopo avere studiato e copiato le bellezze di Roma, si diede ad imitare il Caravaggio e smise di studiare 55.Ma anche quando finalmente si passava all’uso dei pennelli, si copiava 56 : per questo vari pittori che avevano istituito scuole possedevano copie di dipinti famosi, a cominciare dai Baccanali di Tiziano. Si eseguivano perciò anche copie di copie. E ovviamente gli allievi copiavano le opere del proprio maestro, il quale poi interveniva come sui disegni, cioè non solo offrendo consigli, ma anche correggendo gli errori sulla tela con i pennelli. Copiare tramite mezzi meccanici, cioè tramite lucidi o spolveri, che avrebbero ovviamente evitato errori ma non sviluppato l’abilità manuale, era considerato poco utile per l’ap-prendimento, anzi dannoso 57. Secondo l’accademia di San Luca infatti l’eseguire lucidi rovinava tanto i dipinti quanto i pittori 58. Per questo ci si deve interrogare sull’assunto che i pentimenti in una tela siano sempre un segno di autografia e non di copia : è possibile siano a volte correzioni, effettuate o dall’allievo stesso o dal maestro.Riguardo alla funzione della copia nell’apprendimento, Bologna e Roma erano simili. Ad esempio il Guercino destò sorpresa perché, quando incominciò a dipingere, per prima cosa eseguì ritratti dei propri congiunti invece di copiare altre opere 59 ; all’accademia dei Carracci un nuovo allievo chiese un dipinto da copiare ; il Domenichino si preoccupava di « contraffarre » la mano dei propri maestri 60.Non è possibile, allo stato attuale delle conoscenze, stabilire quanti seguaci del Caravaggio abbiano effettivamente evitato il disegnare, forse pochi. Comunque, anche presso di loro, il copiare per apprendere rimase fondamentale. Attribuendo meno importanza al disegno, i pittori caravaggeschi si concentrarono forse sul copiare dipinti, spesso quelli dei propri maestri, ma non solo, contribuendo così a creare la pletora di versioni di alcune tele che ci è ben nota. Le copie eseguite dagli allievi, spesso corrette e perciò ritoccate dai maestri, potevano anche essere vendute come autografe. Opere ora generalmente attribuite a Nicolas Tournier (i due Bevitori alla Galleria Estense a Modena), o a Nicolas Régnier (il Davide e Golia della Galleria Spada), figurano in due inventari rispettivamente del 1624 e del 1637 come eseguiti da Bartolomeo Manfredi 61. Forse il Manfredi le aveva spacciate per autografe, anche se non lo erano.Il copiare a Roma prese spesso il posto degli studi teorici, anche se l’appren-dere tramite la pratica e non la teoria avvicinava pericolosamente la pittura a quelle arti meccaniche da cui invece l’accademia di San Luca avrebbe voluto distanziarsi 62. Ad esempio non si studiava anatomia, ma si copiava il Giudizio universale di Michelangelo, oppure le statue antiche, quando si era in grado di riprodurre su un foglio un oggetto tridimensionale 63. Modelli anatomici del corpo umano in gesso erano rari, anche se l’accademia di San Luca ne aveva uno, non si sa quanto usato, così come il modesto pittore Giuseppe Franchi 64.Nel vuoto di studi teorici, a Roma divenne importantissimo il disegno dal modello vivente sotto la guida di un maestro 65. Sono queste le accademie private di cui parlano i biografi seicenteschi, che tendono a chiamarle « accademie dal naturale » o del nudo. Che fossero proibite dall’accademia di San Luca, come è spesso ripetuto, non è affatto vero : per timore degli scandali era proibito ai giovani accademici (e soltanto a loro) di riunirsi per questo scopo senza licenza, che poteva però essere concessa 66. Comunque nessuno si preoccupava in questo
87ACTES DU COLLOQUE
periodo dei dettami dell’accademia e molti pittori affermati ospitavano nelle loro case riunioni dove gli studenti copiavano dal modello. Erano frequentate anche da molti stranieri, ma probabilmente organizzate per lo più da pittori italiani (un’eccezione era Robert Picou, mentre non si è mai rintracciato il documento che avrebbe dovuto testimoniare l’esistenza di un’accademia del nudo in casa di Nicolas Régnier) 67. A Roma non si usavano modelle in queste riunioni, e in generale nella città, almeno a detta del fiorentino Francesco Furini, era difficile trovare donne disposte a posare nude per i pittori 68.Secondo il Passeri, furono i Carracci ad accordare il nome di accademie agli incontri in cui si disegnava dal nudo, inappropriatamente a suo giudizio, perché le accademie invece dovrebbero essere luoghi in cui si tengono discussioni erudite 69. Il modello veniva messo in posa, gli studenti disegnavano e ancora una volta il maestro correggeva i loro errori. Non bisognava essere allievi di un pittore per frequentare la sua accademia, anzi si poteva benissimo essere allievi di un altro pittore, o essere autodidatti. Pittori di ambito caravaggesco, emeriti sconosciuti e pittori di paesaggio, frequentavano l’accademia del Sacchi, al fianco di Carlo Maratta 70.Anche se i primi disegni dal modello di Federico Zuccari si datano poco dopo il 1560, e quelli del Baglione nei tardi anni Ottanta del Cinquecento, tali studi divennero molto più frequenti a Roma dal 1600 circa, come ha notato John Marciari 71. È possibile che i pittori toscani, tra cui Cristoforo Roncalli e Andrea Commodi – il quale aveva istituito un’accademia del nudo a Roma forse già nel tardo Cinquecento – abbiano avuto un ruolo importante in questo sviluppo ; anche la presenza di Annibale Carracci a Roma avrà influito - e sappiamo da Chantelou che lui stesso disegnava dal modello nella misteriosa accademia del signor « Paolo Giordano » 72.Va ricordato inoltre che intorno alla fine del secolo avvenne un cambiamento fondamentale nel modo di tenere le riunioni accademiche, che contribuì consi-derevolmente ad accrescere la loro importanza nella formazione dei pittori. Inizialmente si tenevano solo durante la bella stagione, e infatti nel 1594 Federigo Zuccari dichiarava che l’inverno non era la stagione per « spogliar ignudi » 73. A Bologna d’inverno si studiava anatomia dai cadaveri, che ovviamente si mante-nevano meglio che d’estate ; a Roma invece si disegnavano panneggi. Pochi anni dopo nella città eterna le accademie avevano invece luogo tutto l’anno, soprattutto l’inverno, e soprattutto la sera, così quando le giornate corte non consentivano di lavorare a lungo si poteva studiare con profitto. Il cambiamento è documentato dal Passeri, dal Bellori, e dal processo, più volte menzionato, in cui testimoniarono vari pittori che avevano frequentato l’accademia di Andrea Sacchi nei primissimi anni Trenta ; è evidente da queste fonti che le sessioni di disegno dal modello si tenevano quotidianamente 74. L’accademia di San Luca invece si proponeva di organizzare sessioni di studio dal modello solo la dome-nica mattina dopo la messa, da maggio (o giugno) a ottobre : può anche darsi che in certi periodi l’abbia effettivamente fatto, ma sicuramente non ogni giorno 75. I dodici giulii, cioè poco più di uno scudo, stabiliti dall’accademia di San Luca come compenso mensile per il modello nel 1628 (e non prima di questa data), corrispondono in effetti al pagamento di quattro sedute, mentre in un’accademia privata i modelli erano pagati intorno ai 10 scudi al mese 76.Come fosse divenuto possibile disegnare dal modello durante le sere d’inverno è narrato da Crispijn Van der Passe, il quale mostra anche in un’incisione come le riunioni accademiche avessero luogo in stanze piccole e basse, riscaldate e illuminate dall’alto, tramite una lampada appesa al soffitto (d’estate invece,
88 LE CARAVAGE AUJOURD’HUI
secondo il Bernini, era meglio studiare con la luce naturale) 77(fig. 2). L’idea forse originava dall’accademia bolognese dei Carracci, almeno a giudicare da un disegno di un loro allievo 78 (fig. 3). Vi si distingue chiaramente la lampada appesa al soffitto, il braciere per scaldare il modello nudo, e si intuisce l’ambiente un po’ claustrofobico e buio, con la finestra chiusa e il soffitto basso. Anche a Firenze, dove il dise-gnare dal modello era in voga prima che a Roma, Ludovico Cigoli e Gregorio Pagani riscaldavano una stanza per potere tenere sessioni accademiche l’inverno, ma pare che adoperassero un ambiente spazioso e luminoso 79.Si direbbe comunque che altri metodi sperimentati dai Carracci nella loro acca-demia a Bologna trasmigrassero a Roma : ne sentiamo l’eco, come già accennato, nelle gare di disegno di invenzione dell’ac-cademia di San Luca, o nell’abitudine di disegnare nature morte, in uso presso l’accademia dei Crescenzi 80. Annibale riteneva importante che chi presiedeva ad un accademia correggesse i disegni degli allievi, un procedimento adottato già da Denis Calvaert a Bologna e che divenne fondamentale a Roma 81. Furono i Carracci ad avere l’idea di atteggiare i modelli nelle pose delle figure dipinte da artisti famosi, a cominciare da quelle di Michelangelo 82. È abbastanza evidente che il Caravaggio
adottò lo stesso metodo, anche se egli evitava lo stadio del disegno e dipingeva direttamente sulla tela 83.Van der Passe sottolineò l’importanza della posizione della lampada quando si disegnava dal modello, « affinché la gioventù possa meglio comprendere la forza dell’ombra » 84. Ci si domanda se questo metodo abbia dato al Caravaggio l’idea di illuminare le sue figure dall’alto, per mezzo di una finestra, in stanze dalle pareti scure, anche se il pittore lombardo ne trasse poi risultati drammaticamente differenti da quelli ottenuti dai pittori accademici 85. Tanto il Caravaggio quanto Jusepe de Ribera aprirono veramente fori nel soffitto delle loro abitazioni « per comodità di dipingere », come avevano narrato i biografi seicenteschi 86. Un documento finora inedito mostra che anche nella lussuosa dimora affittata da Ribera nel 1615 a via Margutta, venne aperta una finestra considerata inutile dal proprietario, dato che doveva essere rimurata a locazione finita 87.Le riunioni accademiche erano però l’antitesi del naturalismo caravaggesco : erano necessarie per imparare a dipingere senza avere davanti l’esempio del naturale, per costruire una memoria da cui ottenere un repertorio di pose del corpo umano in maniera automatica 88. Servivano a completare l’istruzione, ma si potevano frequentare anche a formazione avvenuta. I modelli erano scelti con cura, e molto ammirato era il caporal Leone che posava nell’accademia
Fig. 2 – Crispijn van der Passe, Studio del nudo in un’accademia, in ‘t licht der teken en schilderkonst, Amsterdam, 1643-1644.
Fig. 3 – Anonimo carraccesco, L’Accademia dei Carracci, Stoccolma, Museo Nazionale.
89ACTES DU COLLOQUE
di Andrea Sacchi, « per lo spirito che dava alle attitudini nelle quali veniva posto » 89.Il famoso processo per lo stupro di Artemisia Gentileschi, che si tenne nel 1612, invece mostra bene il metodo caravaggesco : il padre Orazio metteva in posa pellegrini presi dalla strada, o il suo barbiere ; si chiudeva in una stanza della sua abitazione, li spogliava e non faceva entrare nessuno 90. Dipingeva quello che aveva davanti, con grande lentezza, per giorni e giorni. Si osserva lo stesso procedimento in un dipinto di Michelangelo Cerquozzi che mostra un modello in posa di San Girolamo 91. Era un metodo costoso, e sorprende scoprire che era utilizzato anche da emeriti sconosciuti : uno tal Lucarello pittore, che sarà sicu-ramente stato mediocre, dipinse un Cristo dal modello, in sole cinque ore, ovvia-mente per limitare la spesa, offrendogli un compenso insufficiente 92. Disegnare in un’accademia invece consentiva di dividere la spesa tra i partecipanti.Il metodo di lavoro caravaggesco era deriso dai pittori accademici ; Pietro Testa, ad esempio, narrò la storia di un vecchio appeso a testa in giù per essere dipinto come dio padre, che era precipitato a terra 93. Non è però detto che il metodo accademico fosse ridicolizzato dai pittori caravaggeschi. Vari di loro frequentarono accademie del nudo : Bartolomeo Manfredi, Orazio Borgianni, Gerrit Van Honthorst, Carlo Saraceni, Pietro Paolini, anche perché l’accesso era relativamente libero e non c’era bisogno di fare parte della stessa corrente stilistica del maestro.Esisteva perciò a Roma un sistema di insegnamento poco codificato, flessibile, dove si poteva in parte apprendere da soli, e in parte tramite legami tenuissimi con un pittore affermato. Era però un sistema che penalizzava fortemente le pittrici, dato che fondamentale era il poter girare per la città copiando tutto ciò che si vedeva e potere prendere parte alle riunioni di disegno dal modello. Erano entrambe attività precluse alle donne, che invece avrebbero potuto usufruire di lezioni più teoriche 94 : Artemisia stava in casa e dato che il padre non la lasciava uscire è impensabile immaginarla per strada a copiare facciate e bassorilievi 95. La sua conoscenza dell’anatomia inizialmente era vaghissima, e fu solo con il tempo, a Firenze, che imparò a rendere la figura umana correttamente. Forse anche per questo rimase una figura quasi isolata nel mondo della pittura romana del primo Seicento.
1 G. B. Passeri, Die Künstlerbiographien von Giovanni Battista Passeri, Roma, 1772, ed. a cura di J. Hess, Worms, 1995, p. 326. Vedi anche p. 10. Vari argomenti qui accennati sono sviluppati in P. Cavazzini, Painting as Business in Early Seventeenth Century Rome, University Park, 2008, a cui si rimanda anche per ulteriore bibliografia.2 J. Marciari, « Artistic Practice in Late Cinquecento Rome and Girolamo Muziano’s Accademia di San Luca », in P. Lukehart (a cura di), The Accademia Seminars, Washington, 2009, p. 197-223, in particolare p. 201-202.3 P. Lukehart (a cura di), op. cit. nota 2, p. 348-352, 358.4 N. Pevsner, Academies of Art Past and Present, Cambridge, 1940, ed. it. Le accademie d’arte, Torino, 1982, p. 61 ; C. Goldstein, Teaching Art : Academies and Schools from Vasari to Albers, Cambridge, 1996, p. 45.5 R. Alberti, Origine e progresso dell’Accademia del Dissegno, de pittori, scultori et architetti di Roma, Pavia 1604, p. 70 (ristampato in F. Zuccari, Scritti d’Arte, ed. a cura di D. Heikamp, Firenze, 1961) ; F. Gage, « Giulio
Mancini and Artist-Amateur Relations in Seventeenth-Century Roman Academies », in P. Lukehart (a cura di), op. cit. nota 2, p. 247-288 ; M. Lafranconi, « Da Vouet a Poussin : la comunità artistica francese nell’Accademia di San Luca », in O. Bonfait, A. Desmas (a cura di), L’idéal classique : les échange artistiques entre Rome et Paris au temps de Bellori (1640-1700), Parigi, 2002, p. 211-222.6 R. Alberti, op. cit. nota 5, p. 11.7 P. Roccasecca, « Teaching in the Studio of the “Accademia del disegno dei pittori, scultori e architetti di Roma” (1594-1636) », in P. Lukehart (a cura di), op. cit. nota 2, p. 123-160. Sono però in disaccordo con alcune conclu-sioni dell’autore.8 Archivio dell’Accademia di San Luca (d’ora in avanti AASL), Statuti 1607, fol. 24 v°.9 M. Lafranconi, op. cit. nota 5, p. 215 ; N. de La Blanchardière, « Simon Vouet, prince de l’Académie de Saint Luc », Bulletin de la Société de l’Histoire de l’art français, 1972, p. 79-94.
90 LE CARAVAGE AUJOURD’HUI
10 G. B. Passeri, op. cit. nota 1, p. 326 : « Si esercitava Nicolò [Poussin] anche nello studio della Accademie che si costumano l’inverno in diverse case, e perché cessò quella del Domenichino per la sua partenza da Roma per Napoli alla quale andava volentieri per la stima che faceva di quel grande huomo, andò a quella di Andrea Sacchi nella quale si spogliava il Caporal Leone il qual fu uno dei modelli migliori per lo spirito che dava all’attitudini nelle quali veniva posto ». Per l’abitazione del Domenichino nei tardi anni venti : A. Negro, Guide Rionali, Rione II : Trevi, parte V, Roma 1992, p. 9 ; R. Vodret, « La pala della chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi », in C. Strinati e A. Tantillo (a cura di), Domenichino (1581-1641), (cat. della mostra, Roma, Palazzo Venezia, 1996-1997), Milano, 1996, p. 298-310, n° 42. I registri parrocchiali suggeriscono che l’abitazione si trovasse in Piazza Scannenberg, vedi Archivio storico del Vicariato di Roma (d’ora in avanti ASVR), parroc-chia dei Santi Vincenzo e Anastasia, Stati di anime, 1627 ; 1628 ; 1629, fol. 45 ; 1630, fol. 73.11 M. Lafranconi, « L’Accademia di San Luca nel primo Seicento. Presenze artistiche e strategie culturali dai Borghese ai Barberini », in O. Bonfait, A. Coliva (a cura di), Bernini dai Borghese ai Barberini : la cultura a Roma intorno agli anni Venti, Roma, 2004, p. 39-45. G. Perini, « Paura di volare », in C. Strinati e A. Tantillo (a cura di), op. cit. nota 10, p. 103, n. 81.12 G. P. Bellori, Le vite de’ pittori, scultori, e archi-tetti moderni, Roma, 1672, ed. a cura di E. Borea, Torino, 1976, p. 555-557, 576 ; G. B. Passeri, op. cit. nota 1, p. 326 ; A. Blunt, H. L. Cooke, The Roman Drawings of the XVII th & XVIII th Centuries in the Collection of her Majesty the Queen at Windsor Castle, Londra, 1960. Per l’insegnamento del Sacchi, vedi P. Cavazzini, op. cit. nota 1, p. 56, 76, 181, n. 58.13 A. S. Harris, « Drawings by Andrea Sacchi : Additions and problems », Master Drawings, IX, 1971, p. 384-391.14 T. Montanari (a cura di), Bernini pittore (cat. della mostra di Roma, palazzo Barberini, 2007), Milano, 2007, p. 36-51, 164.15 Vedi ad esempio ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 20, 8 ottobre 1630, fol. 418. Anche nell’indice dello stesso volume l’atto è indicato come « Accademia dei pittori concordia ».16 M. Aronberg Lavin, Seventeenth Century Barberini Documents and Inventories of Art, New York, 1975, p. 5. Per il cardinal Montalto, vedi i numerosi pagamenti trascritti in B. Granata, « Appunti e ricerche d’archivio per il cardinal Montalto », in F. Cappelletti (a cura di), Decorazione e colle-zionismo a Roma nel Seicento. Vicende di artisti, commit-tenti, mercanti, Roma, 2003, p. 47-51.17 J. M. Montias, Artists and Artisans in Delft. A Socio-Economic Study of the Seventeenth Century, Princeton, 1982, p. 74-111.18 E. Cohen, « Miscarriages of apothecary justice : un-separate spaces of work and family in early modern Rome », Renaissance studies, XXI, n° 4, 2007, p. 480-504 ; P. Anderson, « The Archiconfraternita di San Giuseppe and the Università dei Falegnami : The Development of Professional Institutions in Early Baroque Rome », in P. Lukehart (a cura di), op. cit. nota 2, p. 289-324.19 J. M. Montias, op. cit. nota 17, p. 46, 166 ; W. Franits, Dutch Seventeenth-Century Genre Painting. Its Stylistic and Thematic Evolution, New Haven-Londra, 2004, p. 7.20 Archivio di Stato di Roma (d’ora in avanti ASR), Tribunale civile del Governatore, b. 149, 21 giugno 1641, fol. 330-333.
21 Per ciò che segue, P. Cavazzini, op. cit. nota 1, p. 57-64.22 R. Spear, in P. Sohm e R. Spear (a cura di), Painting for Profit : the Economic Lives of XVII Century Italian Painters, in corso di stampa.23 ASR, Tribunale civile del Governatore, b. 149, 21 giugno 1641, fol. 330-333.24 ASR, Tribunale civile del Senatore, 34/87, 12 ottobre 1599. Lo scultore, nato a Como nel 1562 e morto a Roma nel 1634, non va confuso con l’omonimo attivo nella cappella Ginetti a Sant’Andrea della Valle fino ai primi del Settecento.25 G. B. Bellori, op. cit. nota 12, p. 536 ; K. Van Mander, « Di Giuseppe d’Arpino eccellente pittore in Roma », in H. Röttgen, Il Cavalier Giuseppe Cesari d’Arpino. Un grande pittore nello splendore della fama e nell’incostanza della fortuna, Roma, 2002, p. 552.26 A. Sutherland Harris, Andrea Sacchi. Complete edition of the Paintings with a Critical Catalogue, Oxford, Princeton, 1977, p. 123-125.27 P. Cavazzini, « Oltre la committenza : sul commercio d’arte a Roma nel primo Seicento », Paragone, 59, 2008, p. 72-92.28 La permanenza dello Spadarino presso il cardinal Dolfin è ampiamente discussa in G. Papi, Spadarino, Soncino (Cremona), 2003, p. 12-13 ; Ibid., p. 10, per l’ipotesi di un contatto personale tra Caravaggio e Spadarino.29 G. L. Masetti Zannini, Pittori della seconda metà del Cinquecento in Roma, Rome, 1974.30 J. Bousquet, « Valentin et ses compagnons. Réflexions sur les caravaggesques français à partir des archives parois-siales romaines », Gazette des beaux-arts, XCII, 1978, p. 101-114, p. 105 ; Id., Recherches sur le séjour des artistes français à Rome au XVIIe siècle, Montpellier, 1980, p. 202. ASVR, parrocchia Sant’Andrea delle Fratte, Stati di anime, 1617, fol. 14 v° ; 1618, fol. 44 v°.31 P. Cavazzini, op. cit. nota 1, p. 56.32 A. Sutherland Harris, op. cit. nota 26, p. 1, 115.33 ASR, Archivio Sforza Cesarini, II parte, sez. I, b. 499, fol. 698, 9 dicembre 1605, deposizione di Benedetto Sacchi, pittore, abitante a piazza Padella. Il pittore chiese il risarci-mento dei danni a un muratore che, aggiustando il tetto della sua abitazione, aveva fatto cadere « più di una carrettatata di terra, qual terra ha dato in un quadro che in detta camera io tenevo con l’immagine di Santa Maria Maggiore fresca di pittura quale è restata attachata si che me l’ha rovinato che l’havevo venduta dieci scudi ».34 K. Van Mander, op. cit. nota 25, p. 552.35 G. Baglione, Le Vite de’ Pittori, Scultori et Architetti. Dal Pontificato di Gregorio XIII sino a tutto quello d’Ur-bano Ottavo…, Roma, 1649, p. 401.36 D. Rosand, « The Crisis of the Venetian Renaissance Tradition », L’arte, 1970 (11-12), p. 5-53.37 M. Bury, The Print in Italy, Londra, 2001, p. 198-99.38 R. Alberti, op. cit. nota 5, p. 17 ; M. Missirini, Memorie per servire alla storia della Romana Accademia di San Luca fino alla morte di Antonio Canova, Roma, 1823, p. 30 ; C. Goldstein, Visual Facts over Verbal Fiction : A study of the Carracci and the Criticism, Theory and Practise of Art in Renaissance and Baroque Italy, Cambridge, 1988, p. 48.39 H. Gombrich, Art and Illusion, Princeton, 1960, ed. 1972, p. 146-178.40 M. Bury, op. cit. nota 37, p. 198-99.41 H. Gombrich, op. cit. nota 39, p. 160.42 Per l’importanza del copiare nell’insegnamento acca-demico, C. Goldstein, op. cit. nota 4, p. 119. Per le copie dal Sacchi, A. S. Harris, op. cit. nota 13, 1971.
91ACTES DU COLLOQUE
43 ASR, TCG, processi, b. 162, fol. 780 v°, 782, depo-sizione del pittore Nicolò Bedino : « io passeggiando per Piazza Navona vicino quel palazzo grande dove se vendono le figure che in mia compagnia c’erano Mercurio Stellato pittore e Giulio del Papa similmente pittore arrivò lì Francesco indoratore che non so di chi (…) io andavo a spasso con Mercurio e mentre stavamo guardando certe figure di Raffaele Mercurio ed io soppraggiunse Giulio suddetto et ce disse siete qui volete comperare le stampe et ce mettessimo a ragionare tutti assieme ». ASR, TCG, costituti, 703, 19 dicembre 1621, fol. 70 v°, testimonianza del pittore Giovanni Antonio Bartolomeo Ruscelli : « Hoggi essendo andato a far dell’orina nel palazzo dove è la scimia a piazza Navona che stavo lì vedendo le istorie m’hanno preso gli sbirri e non so perché ».44 L’interessantissimo processo all’Archivio Storico Capitolino (d’ora in avanti ASC), CC 1255, è stato discusso e parzialmente trascritto da L. Sickel, « Künstlerrivalität im Schatten der Peterskuppel : Giuseppe Cesari d’Arpino und das Attentat auf Cristoforo Roncalli », Marburger Jahrbuch für Kunstwissenchaft, 28, 2001, p. 159-89 ; A. Cirinei, « Conflitti artistici, rivalità cardinalizie e patronage a Roma fra Cinque e Seicento. Il caso del processo criminale contro il Cavalier d’Arpino », in M. A. Visceglia (a cura di), La nobiltà romana in epoca moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali, Roma, 2001, p. 255-305 ; H. Röttgen, op. cit. nota 25. Per la formazione dei pittori, P. Cavazzini, op. cit. nota 1, p. 52-53.45 ASR, archivio Sforza Cesarini, II parte, sez. 1, b. 499, 7 febbraio 1602, fol. 14 v°, deposizione di Palmerius di Giuseppe Albi da Todi : « Sendo io in compagnia di Giorgio Casella e Bastiano da Capua pittori d. Bastiano stava nella piazza delli Incoronati a disegnare quelle figure che stanno dipinte nella casa in detta piazza e mentre stava dipingendo è uscito di casa uno spagnolo del quale non so il nome e il suo cocchiere di nome Lisandro ». Vedi anche fol. 14. Per il Sacchi, G. B. Bellori, op. cit. nota 12, p. 537.46 ASC, CC 1255, f.34, « et con il detto cav. Gioseppino si accomoda il detto ragazzo Flaminio Allegrino (…) fa esercitio di pittore ».47 G. Papi, op. cit. nota 28, p. 16.48 ASR, Tribunale civile del Governatore, b. 149, 21 giugno 1641, fol. 330-333. Deposizione di Pietro Paolo Gubernario, romano, pittore di anni 35 : « vedevo che detto Sancarlo teneva delli disegni avanti e disegnava et io qualche volta li davo lezioni et accomodavo li disegni fatti da lui e per il spazio di due anni haveva continuato a imparare a disegnare perché dopo doi anni che io l’imparai lo cominciai ad imparare a dipingere ».49 G. B. Bellori, op. cit. nota 12, p. 557.50 Ibid., p. 537.51 G. B. Bellori, op. cit. nota 12, p. 307 ; C. C. Malvasia, Felsina pittrice : Vite de’ pittori bolognesi, a cura di G. Zanotti, Bologna, 1841, I, p. 334 ; G. Feigenbaum, « Practice in the Carracci Academy », in P. M. Lukehart (a cura di), The Artist’s Workshop, Studies in the History of Art, XXXVIII, 1993, p. 59-76, p. 62 ; K. E. Barzman, « The Florentine Accademia del Disegno : Liberal Education and the Renaissance Artist », in A.W.A. Boschloo et al. (a cura di), Academies of Art between Renaissance and Romanticism, L’Aia, 1989, p. 14-32 ; C. Dempsey, « The Carracci Academy », in Academies of Art between Baroque and Romanticism, p. 40. Vedi anche C.C. Malvasia, op. cit. nota 51, I, p. 196, per simili competizioni organizzate da Calvaert.52 G. B. Passeri, op. cit. nota 1, p. 82.
53 Ibid., p. 386.54 G. B. Bellori, op. cit. nota 12, p. 230.55 G. Baglione, op. cit. nota 35, p. 146.56 G. B. Passeri, op. cit. nota 1, p. 292.57 C. C. Bambach, Drawing and Painting in the Italian Renaissance Workshop. Theory and practice, 1300-1600, Cambridge, 1999, p. 127-28, 133-36.58 AASL, statuti 1607, f. 31 v°.59 G. B. Passeri, op. cit. nota 1, p. 345.60 G. B. Bellori, op. cit. nota 12, p. 85, 307.61 N. Hartje, « L’influence de Bartolomeo Manfredi (1582-1622) sur les caravagesques français et sur Nicolas Tournier en particulier », in A. Hémery (a cura di), Nicolas Tournier. Un peintre caravagesque, 1590-1639, (cat. della mostra di Tolosa, musée des Augustins, 2001), Parigi, 2001, p. 32, 80-84 ; A. Lemoine, Nicolas Régnier : (alias Niccolò Renieri) ca. 1588-1667 peintre, collectionneur et marchand d’art, Parigi, 2007, p. 214.62 K. Barzman, op. cit. nota 51, p. 14-32.63 P. Fréart de Chantelou, Journal de voyage du Cavalier Bernin en France, in D. Del Pesco, Bernini in Francia, Napoli, 2007, p. 436 (11 ottobre 1665) ; Z. Waźbiński, Il Cardinale Francesco Maria del Monte 1549-1626, Firenze, 1994, I, 232, anche per i commenti a questo riguardo di Edward Norgate.64 L’accademia di San Luca acquistò un piedistallo per mostrare un modello anatomico nel 1594, ma un modello anatomico in gesso si trova elencato soltanto nell’inventario del 1633, non in quelli precedenti, vedi P. Roccasecca, op. cit. nota 7, p. 133 ; P. Lukehart (a cura di), op. cit. nota 2, p. 379 ; P. Cavazzini, op. cit. nota 1, p. 159, per Franchi.65 P. Cavazzini, op. cit. nota 1, p. 70-80 ; A. Lemoine, op. cit. nota 61, 2007, p. 33.66 AASL, Statuti 1607, fol. 22-22 v° ; vedi anche fol. 36 v° : « Forma della licenza da darsi alli modelli o altri che fanno addunanze di disegnatori per Roma. Concediamo licenza (…) di poter fare adunanze in casa, di studianti della nostra professione et servire di ignudo et vestito con conditione che non s’introduca donne ignude né vestite sotto pena di scudi dieci per ogni volta né si permetta giuochi di sorta alcuna nè possino portare nessuna sorte di arme sotto la medesima pena » ; Vedi anche Statuti 1617, fol. 17 v° : « nessun studente potrà far adunanze avanti loro, né tenere huomini ignudi per dissegnare in casa loro senza licenza del principe ».67 J. Thuiller, « Plaidoyer pour Robert Picou », in A. Cavina et al. (a cura di), Mélanges en hommage à Pierre Rosenberg : dessins en France et en Italie XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, 2001, p. 441-447 ; A. Lemoine, op. cit. nota 61, 2007, p. 32-33.68 R. Maffeis, « La camera della Luna. Storia di Francesco Furini », in Un’altra bellezza. Francesco Furini, catalogo della mostra a cura di M. Gregori, R. Maffeis, Firenze, 2007, p. 21-63.69 G. B. Passeri, op. cit. nota 1, p. 22.70 P. Cavazzini, op. cit. nota 1, p. 76.71 J. Marciari, op. cit. nota 2, p. 215.72 Vedi J. Brooks, « Florentine Artists and Disegno in Late Cinquecento Rome », in P. Lukehart (a cura di), op. cit. nota 2, p. 233-234 ; Disegni dei Toscani a Roma (1580-1620), catalogo della mostra a cura di M. L. Chapel et al., Firenze, 1979. Per Annibale Carracci, vedi n. 74.73 R. Alberti, op. cit. nota 5, p. 31.74 G. B. Passeri, op. cit. nota 1, p. 170, 326, vedi n. 10 ; G. B. Bellori, op. cit. nota 12, p. 576. Secondo il Bernini, Annibale Carracci a Roma disegnava nell’accademia del signor Paolo Giordano (forse Orsini, vedi D. Del Pesco,
92 LE CARAVAGE AUJOURD’HUI
op. cit. nota 63, p. 388, n. 142) e gli attribuisce i seguenti commenti « che bisogna fare i torsi più grossi rispetto alle braccia (…) all’Académie d’estate bisogna disegnare alla luce del giorno, d’inverno a quella della lampada e che, se avesse avuto tempo, sarebbe andato ancora a disegnare lì ; inoltre che sarebbe opportuno che chi presiede l’Académie corregga gli esercizi degli allievi e che bisogna che essi eseguano i panneggi e i bassorilievi altrettanto bene che i nudi », vedi P. Fréart de Chantelou, op. cit. nota 63, p. 350 (13 settembre 1665). ASR, Tribunale Criminale del Governatore, processi, b. 302, fol. 980, testimonianza del pittore Francesco Vestri, « Io son solito praticare spesso con detto Giovanni Battista [Greppi] et son andato con esso di notte cinque o sei volte che siamo andati all’accademia insieme d’inverno qualche volta soli, et qualche volta accompagnati… ». L’accademia citata è quella del Sacchi.75 M. Lafranconi, op. cit. nota 5, p. 216-18. Vedi anche AASL, Statuti, 1617, fol. 17 v°, dove si auspica che in futuro si possa studiare all’accademia quotidianamente.76 P. Roccasecca, op. cit. nota 7, p. 134 ; M. Lafranconi, op. cit. nota 5, p. 218. Vedi n. 87 per il costo di un modello, dove si dichiara che vengono pagati un testone, cioè un terzo di scudo, al giorno più le spese. Bernini pagava i modelli 15 scudi al mese, vedi P. Fréart de Chantelou, op. cit. nota 63, p. 218 (16 giugno 1665). Vedi anche R. Spear, op. cit. nota 22, per i compensi dei modelli.77 Z. Waźbiński, op. cit. nota 63, I, 1994, p. 233-237. Vedi n. 72 per Chantelou, op. cit. nota 63 (13 settembre 1665).78 C. Robertson, The Invention of Annibale Carracci, Milano, 2008, p. 72.79 J. Brooks, op. cit. nota 72, p. 228.80 G. Baglione, op. cit. nota 35, p. 343, 365. C. C. Malvasia, op. cit. nota 51, I, p. 196 narra che anche Denis Calvaert correggeva i disegni degli allievi.81 Vedi n. 72.82 G. Feigenbaum, op. cit. nota 51, p. 66-68.83 H. Hibbard, Caravaggio, New York, 1983, p. 149-163.84 Z. Waźbiński, op. cit. nota 63, I, p. 235.85 G. Papi, « La schola del Caravaggio », in G. Papi (a cura di), La schola del Caravaggio. Dipinti dalla collezione Koelliker (cat. della mostra di Ariccia, palazzo Chigi, 2006-2007), Milano, 2006, p. 13.86 G. Papi, Ribera a Roma, Soncino (Cremona), 2007, p. 17.87 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 26, 9 maggio 1615, fol. 43-43 v°. Giacomo Scaglia, tutore e curatore dei figli
di Alessandro Alborghetti affitta a « Joseph Rivera, f. D. Simonis de Sciativa Valentinens. dioces., pictor » una casa situata a via Margutta, appartenente agli eredi Alborghetti. L’affitto annuale era di 55 scudi, che dovevano essere pagati trimestralmente e in anticipo (e forse l’affitto era già cominciato dal febbraio). Lo Scaglia fece inserire le seguenti clausole nel contratto : « che finita la presente loca-tione detto signor Gioseppe sia obbligato far rimurare la finestra che è stata fatta nell’appartamento di sopra et che in essa [casa] non possa fare alcuna sorte di miglioramente et utili et non necessari senza licentia di d. m. Giacomo et facendoli vadano in bene d’essa casa senza speranza di ripeter il valore d’essi… ».88 E. Cropper, « Michelangelo Cerquozzi Self-portrait : The Real Studio and the Suffering Model », in V. von Flemming, S. Schütze (a cura di), Ars Naturam adjuvans : Festschrift für Matthias Winner, Mainz, 1996, p. 401-412, p. 407.89 G. B. Passeri, op. cit. nota 1, p. 320.90 P. Cavazzini, « Appendix 1. Documents relating to the Trial of Agostino Tassi », in K. Christiansen, J. Mann (a cura di), Orazio and Artemisia Gentileschi (cat. della mostra, Roma, New York, St. Louis, 2001-2002), New York, 2001, 1, p. 435-436, 440.91 E. Cropper, op. cit. nota 88, p. 406.92 ASR, TCG, Investigazioni, b. 457, 7 maggio 1625, fol. 6 v°- 7, testimonianza di Agostino Spinola, genovese : « (…) la domenica dell’olivo havendo Lucarello chiamato per volermi ritrarre et per tenermi per modello di un quadro di un Christo che faceva lì in casa sua io ci andai et stetti per spatio di cinque hora et essendo solito fra pittori che a quelli che servono per modello si da per sua mercede un testone il giorno et le spese, et quando non si finisce la giornata sempre è solito darsi due giulii, lui mi mise in mano un carlino il quale io non volsi pigliare che di poi mi diede un giulio et sdegnatosi per questo mi cominciò a ingiuriare minac-ciandomi di volermi dare delle bastonate ». K. Christiansen, J. Mann (a cura di), op. cit. nota 90, p. 96, per il tempo occorso al Gentileschi per dipingere il San Girolamo.93 E. Cropper, op. cit. nota 88, p. 407.94 Vedi il commento di Urbano VIII, in P. Fréart de Chantelou, op. cit. nota 63, p. 433 (11 ottobre 1665), riguardo all’impossibilità per le donne di studiare dal modello.95 P. Cavazzini, « Artemisia Gentileschi in her Father’s House », in K. Christiansen, J. Mann (a cura di), op. cit. nota 90, p. 282-295.