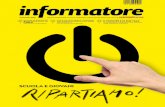Liutai, chitarrai e violinai nella Firenze del Cinque-Seicento
Transcript of Liutai, chitarrai e violinai nella Firenze del Cinque-Seicento
per archi
rlvlsta dl atoriae culiuradegll strumentiad a.coanno lV numero 3/4novembre 2009
. Libreria Musicale Italiana .
Liutai, chitarrai e violinai nella Firenze del Cinque-Seicento
di Gabriele Rossi Rognoni
Tra le diverse tradizioni liutarie locali conosciute in Italia a partire dal tardo
Medioevo quella fiorentina è allo stesso tempo la pirì antica su cui si conservino
documenti e - almeno nelle sue fasi originarie - ancora una delle meno note.
Le prime notizie di una produzione fiorentina di strumenti a corde risalgono,
infatti, già alla metà del XIV secolo quando un commentatore della Divina Com-
media dantesca, Benvenuto da Imola, riferisce che un certo Beìacqua, alias Duccio
di Bonavia, annoverato da Dante tra gli ignavi, "faciebat citharas et alia instru-menta musica, unde com magna cura sculpebat et incidebat colla et capita citha-
rarum".lSebbene la brevità del passo del commentatore lasci molti interrogativi sulla na-
tura dell'attività liutaria di Belacqua (la costruzione di strumenti costituiva una
professione o un'attività collaterale? Esisteva una bottega? Era inserito in una tradi-zione costruttiva cittadina? ecc.) è nondimeno evidenziato il fatto che oltre alle ce-
tere, che dovevano costituire la parte piìr notevole della produzione, egli costruisse
anche non meglio specificati "altri strumenti". Un cenno esplicito cioè a una situa-
zione produttiva - nota peraltro in altri ambiti artigianali più studiati come quello
artistico-figurativo - che combinava nella stessa bottega la produzione di un ampio
spettro di tipologie di oggetti appartenenti a uno stesso ambito, non conoscendo
invece la specializzazione in una singola tiPologia di oggetti cui si è adusi nella tra-dizione moderna.
Nel campo degli strumenti musicali si trova un analogo indizio nell'Autobio-grafia diBenventto Cellini. Qui l'artista, in un'ampia sezione introduttiva dedicata
alle molteplici (e forse un po'esagerate) abilità del padre, ricorda come egli co-
Il presente articolo è il risultato della fusione e dell'ampliamento di due interventi presentati, ri-spèttivamente, a Michaelstein (Stiftung Kloster Michaelstein, maggio 2005) e a Bologna (ll Saggia-
tore Musicale, novembre 2008).I. BENVENUT-o o,t Ivor.,r 1887 (ed. mod.), p 133. Una ricostruzìone della documentazione biograffca
superstite su Belacqua - in cui peraltro non sono stati trovati riferimenti alla sua attivita liutariasi trova in D|RENÈD rr 1906.
LIutet, cartelner l vtoltrqet tuLa Fnrltzr pu Cl}leur-srrcrmo
struisse "organi, con canne di legno maravigliosi, gravicembali, i migliori e i pihbelli che allora si vedessero, viole, liuti, ed aipe bellissime ed eccelleritissime".i Seanche il tono apologetico generalmente adottato da Cellini in relazione ai propriantenati induce in qualche modo alla cautela nel prendere alla lettera le auitìta àt-tribuite al padre, tuttavia il passo evidenzia come l'abilità di un solo individuo nelcostruire- strumenti di tipologie così differenti fosse considerata non solo possibile,ma un ideale da perseguire. Un ideale, quindi, che era probabilmente poisibile ri_trovare nella produzione delle botteghe attive in città, sulla quale, attualmente,nulla altro è noto.
Gli indizi dell'esistenza di un'attività professionale di costruzione di strumenti acorde a Firenze, d'altra parte, sono stati recentemente individuati proprio a partiredagli anni in cui cellini pubblica la propria descrizione.3 Ricerche d-'archivio neiregistri dell'università dei Fabbricanti (una struttura corporativa nata nel 1534 dal-l'accorpamento tra Maestri di pietra e Legname, Legnaioii, Fabbri, Chiavaioli e Co-razzai) hanno infatti portato al ritrovamento della menzione di un certo Barto_lomeo di Giorgio, tedesco, attivo almeno dal 1557 al 1585 come.liutaio,,. La fre_quenza e la regolarità con cui altre analoghe botteghe si aggiungono alla sua neglianni successivi, inoltre, evidenzia come tale tradizione dovesse in realta essere g-iàampiamente affermata in quegli anni, suggerendo con tutta probabilità una con-ti_nuità di sviluppo, sebbene attualmente non documentata, sin dalla sopracitatamenzione dantesca.
Sono non meno di sette le botteghe aperte tra quella data e il 15g6, quandoun'ulteriore riorgrnizzazione delle corporazioni fioientine determina la nascitadell'Università di Por s. Piero e Fabbricanti in cui confluiscono numerose arti mi-nori assieme ai commercianti di generi alimentari. Il numero di iscritti alla corpo_razione, già elevato prima dell'accorpamento, cresce così al punto che i costrutioridi strumenti musicali non superano lo 0,57o del totale degli iicritti: una presenza ri_dotta al punto da giustifìcare l'assenza di qualsiasi menzione a questa aitivita neglistatuti superstiti.
Nondimeno i campioni, owero i registri fiscali della corporazione, riportano inomi di novantacinque botteghe impegnate nella costruzione di strumenti musi-cali nel periodo compreso tra la metà del Cinquecento e 11270, anno in cui unalegge di Pietro kopoldo di Lorena, prima in Europa, abolisce le corporazioni sosti-tuendole con una Camera di Commercio.a Per ciascuna bottega vengono indicatinome, patronimico ed eventuale cognome del titolare, provenienza quando diversa
CrLuNr 1728, p. 5 (rist. anast. 1990).Per una-prima-ricognizione sui registri delle corporazioni fforentine, Iimilata però al periodo1633-1708, cfr. Pr.rr 1874. Sui risultati di tale indagine si sono poi basati tutti i h;ri e i r;pertoris,ccessivi sino al Novecento inoltrato. Un'estensione retrograda del lavoro di puliti è p;i statapubblicata in Rossr Rocl,rou 2002 e 2007.I campioni superstiti dell'Unversita dei Fabbricanti sono depositati presso t,Archivio di Stato diFirenza, UniveqitA di Por S, Piero e Fabbricanti, nn. 198-209.
)3.
Grsnrrr r Ross Roclrolr
da Firenze, anno dell'iscrizione alla corporazione, obbligatoria per chi volesse eser-
citare questa professione, e successivi yersamenti delle tasse ordinarie e straordinarie. A partire dalla fine del Cinquecento, inoltre, viene indicata con regolaritàsempre maggiore l'ubicazione della bottega cosicché è possibile, sulla base di questi
dati, ricostruire una mappa topografia e cronologica della produzione di strumentimusicali a Firenze dalla seconda metà del Cinquecento.
Da un punto di vista quantitativo il numero di nuove immatricolazioni regi-strate nei campioni va continuamente crescendo a partire dalla metà del Cinquecento in una maniera che ben si accorda con quanto attualmente noto relativa
mente alla vivacità della vita musicale fiorentina di quel periodo: a fronte di una
sola immatricolazione nel decennio tra il 1550 e il 1560, se ne trovano due nel de-
cennio successivo e ancora due tra il 1570 e il 1580, mentre il numero cresce ulte-riormente a tre per decennio tra il 1580 e il 1600. Si tratta, al di là della semplicequantificazione, di un dato rilevante se si considera che il numero di artefici con-temporaneamente attivi in città era rigidamente regolato dalle corporazioni, co-
sicché un regolare incremento del numero di membri ammessi a esercitare questa
professione deve rispecchiare, con tutta probabilità, un parallelo incremento nellarichiesta di strumenti musicali di produzione locale.
Altrettanto significativo è il picco di quindici nuove immatricolazioni che si re-gistra tra la fine degli anni Venti e l'inizio degli anni Quaranta del Seicento: un re-pentino incremento che rispecchia lo slancio di energia impresso alla vita musicalefiorentina dai primi anni di granducato di Ferdinando II (1623-1669), così come ilpicco negativo segnato nel decennio successivo (solo tre immatricolazioni) rifletteun ben noto periodo di contrazione dell'economia cittadina (e di ridimensiona-mento dell'attività musicale anche da parte dello stesso Ferdinando che nel 1649prolvedeva al licenziamento di diversi musicisti al fine di contenere le spese),s macorrisponde anche al momento in cui sarebbe stata matura per l'immatricolazioneuna generazione che era stata, in realtà, decimata dalla famosa pestilenza manzo-niana che si era abbattuta su Firenze nel 1629.
A partire dalla seconda metà del Seicento il numero di nuove immatricolazionitorna ai livelli registrati prima di tale evento traumatico e rimane poi stabile sino alprimo Settecento, quando la crisi generale in cui si trova il granducato investe nonsolo la vita musicale, ma in generale le strutture amministrative, cosicché la ridu-zione del numero di nuove matricole può essere tanto legata a una crisi della realtàproduttiva, quanto all'inizio del collasso del sistema corporativo che si alviava allafine, dopo cinque secoli di funzionamento. Per questo, nel XVIII secolo i campionidelle corporazioni non sembrano piìr riflettere in maniera attendibile una situa-zione produttiva che si era fatta piir fluida e meno chiaramente regolamentata.
È importante evidenziare, tuttavia, che i numeri sin qui descritti corrispondonoesclusivamente al numero di nuove immatricolazioni di artigiani, ma che l'attività
5. Una ricostruzione di queste vicende, a Firenze, nel pcriodo indicato, si trova in Bscr,rru 200I, p.36.
Lrur,u, cutmrruu r vrolner lrlre Ftrutzt oeL Cnqun-Sucnuo
di una bottega, calcolata sulla base delle registrazioni fiscali, sembra proseguire inmedia per un periodo di venti-trent'anni. Ne consegue che in una città relatiya-mente piccola come Firenze devono essere state costantemente attive contempora-neamente circa dieci botteghe dedite alla costruzione di strumenti musicali tra ilsecondo Cinquecento e il primo Settecento.
Tuttavia, con l'eccezione di un solo costruttore, iÌ bolognese Bernardino di Ja-chopo Peroni indicato a piir riprese tra il 1560 e il 1585 come costruttore di "cete-rini", i campioni non offrono alcuna indicazione, né qualitativa, né quantitativa,sulla produzione delle singole botteghe, né informazioni di questo genere possonoessere tratte da strumenti superstiti, praticamente inesistenti, cosicché ogni ipotesiin materia deve essere per ora basata su considerazioni linguistiche e sul confrontocon altre realta produttive cittadine ed extrafiorentine.
Due terzi dei costruttori individuati sono citati nei campioni come "liutai" o"chitarrai", mentre il restante terzo è costituito da costruttori di strumenti a ta-stiera, indicati come "buonaccordai" o più tardi col termine "strumentai" che avevain realtà un significato generico di costruttore, riparatore, accordatore di strumentimusicali. Un'indicazione sull'esistenza di una specifica categoria professionale per i"tamburai" compare una sola volta in una descrizione cinquecentesca della corpo-razione,6 mentre Ia completa assenza di riferimenti a costruttori di strumenti afiato, tanto legni quanto ottoni, è purtroppo caratteristica comune a tutte le realtàitaliane sino a ora studiate al punto che si ritiene, a livello di ipotesi verosimile, chei nomi di tali artefici siano in realtà elencati sotto la dicitura generica di "tornitori"e 'calderai" rendendone di fatto impossibile l'individuazione.
L'utilizzo del termine "chitarraio", in particolare, fu interpretato dagli studiosiottocenteschi - e in particolare da Luigi Francesco ValdrighiT che fu poi base deiprincipali repertori del Novecento - come indicazione di una specializzazione co-struttiva nel campo delle chitarre. L'introduzione del termine - che compare per laprima volta nel 1662 è invece a tutti gli effetti sinonimo di "liutaio", termine chesi incontra a partire dal Cinquecento sino a scomparire del tutto entro il 1681,dopo un ventennio in cui se ne trovano solo rari utilizzi. Il passaggio dall'uno al-l'altro termine non distingue quindi tra due diverse specializzazioni, ma è segno,nell'ambito della stessa attività, della sostituzione nella pratica musicale fiorentinadel precedente strumento con cassa a guscio, il liuto, tipico della tradizione italianarinascimentale, con il nuovo modello della chitarra spagnola con fondo piatto e
cassa a otto. Sostituzione che sembra essere a\.r'enuta in maniera piuttosto repen-tina, almeno a giudicare dalla quasi immediatezza dell'affermazione del nuovo ter-mine dal 1662. Lo stesso fenomeno, peraltro, è registrato a Roma con circa un qua-rantennio di anticipo, sebbene la completa scomparsa del termine "liutaio" av-venga contemporaneamente nelle due città.8
Archivio di Stato di Firenz.e, Manoscritti,846.Cfr. Verorucu 1884.La situazione romana è descdtta in BaRBTERT 1989 (p.170), Mwccr 1994 e HENTNCH 2001.
6.7.8.
G,rtlitu Ross Roonou
In maniera analoga appare a Roma, negli anni Trenta del Settecento, un termineche a Firenze non è per il momento mai stato riscontrato: quello di "violinaro" che
anche in questo caso si sostituisce al termine di "chitarraro" senza mutarne però ilsignificato, salvo spostare l'attenzione sugli strumenti ad arco che nel frattempo
erano passati a costituire la parte più. rappresentativa e prestigiosa della produzione
della bottega. Ne è esempio I'utilizzo di questo termine in relazione a f)avid Tec-
chler e Michael Platner, entrambi registrati come "chitarrari" per Ia gran parte della
vita attiva e poi, in età avanzata, registrati invece come "violinari": è difficile imma-
ginare un così tardivo cambiamento di specializzazione professionale e, soprat-
tutto, era ormai passata una trentina d'anni dai primi loro violini attualmente noti.
Assodato, quindi, che l'uso dei tre termini (due a Firenze) non offre indicazionispecifiche sull'esistenza o meno di una specializzazione costruttiva che distingua ilprodotto di diverse botteghe in un dato momento è comunque possibile avanzare
alcune ipotesi basate sui dati esistenti: è infatti rilevante constatare come, per iquasi cinquant'anni tra il 1557 e il 1602, I'unico termine riferibile alla costruzione
di strumenti musicali registrato nei campioni sia quello di "liutaio", mentre solo a
partire dal 1602 si affianchi a esso quello di "buonaccordaio". Nel decennio tra il1600 e il 1610 vengono immatricolati a Firenze non meno di tre "buonaccordai",
tante quante sono le nuove immatricolazioni di "liutai". Considerando che ormaigià dal 1580 il numero di nuove immatricolazioni di costruttori di strumenti musi-cali si era attestato su tre per decennio è allora particolarmente notevole che talequota venga improwisamente raddoppiata col cambiare del secolo, a meno che laprofessione di "buonaccordaio" non venga considerata come del tutto distinta da
quella di liutaio e indichi quindi la nascita di una nuova professione, or'vero di unanuova specializzazione alla quale viene attribuita una quota di nuove immatricola-zioni pari a quella dei liutai, in quanto Ie due attività non sono in conflitto.
A conferma della distinzione tra i due ambiti viene anche la dislocazione dellebotteghe, come indicata dai campioni: gih a partire dal secondo Cinquecento, infatti, le botteghe dei liutai erano concentrate - secondo la tendenza al raggruppa-mento merceologico tipico della struttura corporativa - in una zona situata poco a
sud del Duomo, precisamente nella ptazza ancora oggi intitolata a Santa Maria dei
Ricci e nelle strade circonvicine, nell'area cioè facente parte della zona piìr antica diFirenze, la cosiddetta civitas vetus che si estendeva aPpunto dal duecentesco
Duomo all'Arno.e l buonaccordai, invece, furono sin dalla prima comparsa siste
mati in una zona ben distinta e secondo i parametri dell'epoca più perifericadella città: nel tratto di via de' Servi prossimo alla chiesa della SS. Annunziata, a
nord del Duomo, una zona di urbanizzazione più recente, come Piìr recente doveva
essere la nuova sp ecializzazione.Riconoscendo che è quantomeno improbabile che la città di Firenze possa es-
sere stata priva di una tradizione costruttiva locale di cembali per tutto il Cinque-
9. Una descrizione della crescita cittadina e delle dinamiche di urbanizzazione del territorio fforenti-no si trova in FR^Ncovr:rl e Sr:aupou 2004.
cento è allora forse possibile ipotizzare che tale pratica, a conferma delle parole diCellini, fosse nel Cinquecento nelle ampie competenze di botteghe i cui artefici, in-dicati con il termine generico "liutai", non avevano solo la competenza di costruirestrumenti a corde tanto sfregate quanto pizzicale, ma anche strumenti a tastieraoltre che, tornando ancora a Cellini, arpe. Una tarda testimonianza della capacitàdei "liutai" di costruire arpe, d'altronde, si troverebbe a Firenze nel 1749, con unostrumento con etichetta Lorenzo Carcassi ora conservato a Lipsia,lo e nella celebrearpa stradivariana.
L'individuazione della nascita di una specializzazione nella costruzione di cem-bali ai primi anni del XVII secolo, tra I'altro, rispecchierebbe una trasformazionerepentina e riscontrata sugli strumenti superstiti: la nascita della classica strutturadel cembalo italiano con due registri da 8', una soluzione piir complessa d.a realiz-zare rispetto ai modelli cinquecenteschi a un solo registro e quindi possibile segnodella nascita di una competenza specifica prima assente.
L'ulteriore questione dell'esistenza o dell'origine di una distinzione tra costrut-tori di strumenti a manico con corde pizzicate (liuti e chitarre) e sfregate (in parti-colare della famiglia del violino) riveste poi particolare rilevanza in relazionJ a ungruppo di costruttori di provenienza tedesca (non meno di undici, quasi la metàdel totale dei liutai) che vengono ammessi alla corporazione tra la metà del Cin-quecento e la metà del secolo successivo.
In contrasto con l'idea diffusa che identifica il sistema corporativo con un pre-valente immobilismo degli artigiani nell'intento di preservare i segreti produttivilocali, la provenienza dei liutai fiorentini risulta sin dalle prime attestazioni al-quanto variegata: accanto al nucleo straniero prevalente, quello appunto tedesco, sitrovano infatti già dal Cinquecento costruttori proyenienti da Roma, da Bologna eda Napoli e si può ipotizzare, in realtà, che il numero di artefici provenienti dafuori Firenze dovesse essere anche maggiore visto che non sempre i redattori deicampioni si dimostrano accurati nel registrare questo genere di informazioni "ag-giuntive" e visto che i cognomi stranieri venivano regolarmente italianizzati, comedimostra il caso di Giovanni di Cosimo Finchi, artefice la cui provenienza tedesca èdenunciata dal soprannome "il fringuello", che appunto corrisponde al significatodel suo originario cognome (Fink). Analoghi, poi, sono i casi di Cristofano di Gio-vanni Tosarcà, probabilmente imparentato, se non identificabile, con un certoToser o Doser che compare a Roma come allievo di Andreas Alberti agli inizi delXVII secolo e di Lorenzo di Giovanni Bomberghi, nel cui cognome si è addiritturariconosciuta una parentela con il celebre Mathias Buchenberg.
I legami di Firenze con i paesi "tedeschi" (il termine è utilizzato, nelle fonti, insenso generico per indicare tutti i paesi a nord e nord-est delle Alpi), d'altra parte,erano stati rafforzati nel 1565 dalle nozze di Francesco I con Giovanna d'Austria,
LIutat, cuttanlel r vrolrratlrtLLa Fnrrzn »tL CtNqur-Sucrmo
10. Lo strumento, proveniente dalla collezione di Alessandro Kraus e attualmente al Grassi Museumdi Lipsia (inv. n. 391), è descritto in Mercviglie sonore 2OO7,pp. t4B l5O.
Genrnr.r Ross RocNolrr
seguite nel 1608 da quelle di Cosimo II con Maria Maddalena d'Austria-Tirolo.Tali nozze, che certamente comportarono un'ulteriore ondata di immigrazione te
desca a Firenze (non foss'altro che per il seguito delle spose), non fecero comunqueche consolidare una presenza a Firenze che già alla fine del Quattrocento superava
il 40% del totale degli stranieri presenti in città.L'immigrazione in massa di liutai della Baviera meridionale e in particolare
dalla cittadina di Fùssen, nel Fùrstbistum Augsburg, a partire dal secondo Cinque-
cento è un fenomeno ampiamente studiato e di grande rilevanza, che interessa
tutte le principali città della penisola in cui fosse Presente una comunitìr tedesca.
Ne offrono gli esempi più notevoli città come Padova, Venezia, Bologna, Roma e
Napoli."Studi su altre realtà italiane, inoltre, sembrano aver evidenziato una peculiare
specializzazione dei liutai di provenienza tedesca, una volta stabilitisi in Italia, nella
produzione di strumenti a guscio della famiglia del liuto e un contemPoraneo ab-
bandono della costruzione di strumenti ad arco, che tuttavia esercitavano invece inpatria.r2
Sebbene una tale ipotesi sia supportata dalla corrispondenza cronologica tra Iasostituzione del termine "liutaio" con "chitarraio" e la scomparsa, anch'essa al've-nuta a metà Seicento, dei costruttori tedeschi da Firenze, essa solleva una serie diproblematiche difficilmente risolvibili a fronte della situazione sin qui descritta. La
presenza di tre liutai tedeschi a Firenze nella seconda metà del Cinquecento, infatti,dovrebbe far ipotizzare l'esistenza di una specializzazione nella costruzione di stru-menti a pizzico prima che l'insorgere di una simile specializzazione sembri essere
suggerita dalle altre fonti, almeno nel contesto fiorentino.Poche ulteriori tracce portano almeno a dubitare del fatto che una simile specia-
lizzazione si sia affermata nella realtà fiorentina; in primo luogo una fugace men-zione a violini superstiti e attribuiti all'ultimo dei liutai tedeschi immatricolati a Fi-renze: Filippo di Giorgio Griseri, il cui cognome costituirebbe un'italianizzazionedel tedesco Crieser o Griesser, famiglia della quale si conosce un liutaio di nomeMathias attivo a Fùssen.r3
Se tale rinvenimento è, effettivamente, troppo isolato per essere rappresentativo
merita invece una maggiore attenzione il fatto che tutta la liuteria ad arco fioren-tina e toscana pervenutaci dal XVII e XVIII secolo sia caratterizzata da linee stili-stiche chiaramente improntate alla tradizione tedesca.
Bombature molto alte, piatte al centro e con salita repentina dai bordi, forma e
posizionamento delle effe, in particolare, hanno spinto diversi storici della liuteriaad individuare in Iacob Stainer l'ispiratore della scuola produttiva locale. L'indivi-duazione di una tradizione costruttiva ben anteriore all'attività e diffusione dellafama di Stainer, tuttayia, impone di ricercare tale modello nel contesto culturale delquale Io stesso Stainer sarebbe stato pir) tardi il piir celebre rappresentante, quello
I l. Il fenomeno, in particolare, è stato oggetto di indagine in LAyER 1978, p. 94 e in BLErscHAcrirR 1978.
12. Una presentazione di tale situazione si trova in MEUccI 2008, PP. 87-90.13. Il riferimento si trova nella relativa voce biografìca in Vannes 2003'q, P. I37.
Lruret, cttttrnut t vtoLnt,rt trLLt,r Ftnrlzr ott Cneur-SrtctNro
cioè della liuteria tedesca, in genere, del Cinque e primo Seicento. Tale influenzatroverebbe la piir naturale e semplice spiegazione nella preponderante presenza diliutai tedeschi a Firenze, purché si ammetta che essi fossero impegnati non solonella costruzione di strumenti a pizzico, ma bensì anche in quella di strumenti adarco.
La forte presenza di liutai tedeschi, d'altra parte, è comune a tutte le città italianein cui si riscontrano scuole liutarie caratterizzate dalle linee stilistiche appena de-scritte: innanzitutto Roma e Venezia.
Il tentativo di appurare con certezza questo aspetto, tuttavia, è reso piìr arduodall'impressionante scarsità di strumenti superstiti da una tradizione che, sullabase dei numeri sin qui descritti, deve aver prodotto diverse centinaia di esemplari.
Salvo rare eccezioni, infatti, dalla tradizione liutaria fiorentina soprawivonostrumenti solo a partire dal Settecento inoltrato, dal momento cioè in cui sono at-tivi i fratelli Lorenzo e Tommaso Carcassi, la bottega di Giovanni Battista Gab-brielli e via via alcune dinastie che, dal secondo Settecento, si protrarranno nel XIXsecolo mentre nessuno strumento, sia esso a pizzico o ad arco, testimonia la naturae la qualità di una produzione cinque e seicentesca (periodo ampiamente docu-mentato invece, ad esempio, per Ia produzione cremonese, veneziana, bolognese,romana, napoletana). Produzione, peraltro, di cui non si trova menzione nemmenonegli inventari delle collezioni della corte granducale che invece registrano con ab-bondanza strumenti provenienti dalle altre città testé citate.
Non volendo tuttavia sostenere che le numerose botteghe individuate e imma-tricolate fossero in realtà del tutto inattive, è necessario riconoscere che la quasi to-talità di una tradizione produttiva longeva e vivace sia andata perduta nel corso deisecoli successivi. Una scomparsa di massa motivabile con le stesse considerazioniche giustificano l'assenza degli strumenti dalle collezioni di corte: il fatto che laproduzione fìorentina non raggiunga una fama di eccellenza sufficiente a farne ga-reggiare gli strumenti con le più prestigiose tradizioni italiane e che quindi la pro-duzione locale, sebbene evidentemente soddisfacente per la vita musicale cittadina,non diventa oggetto di collezionismo e trasmissione nel tempo. Indipendente-mente dalla qualità intrinseca degli strumenti, quindi, i costruttori fiorentini nonriuscirono - per ragioni che restano da appurare - a diventare "di moda" come lodiventarono gli strumenti a pizzico delle botteghe tedesche in Italia o quelli ad arcodella pianura padana. Lo dimostrerebbe, tra l'altro, il fatto che gli unici strumentiattribuibili a costruttori fiorentini che si ritrovano oggi nelle collezioni granducaliportano, in realtà, etichette contraffatte di costruttori di maggior successo, sullabase delle quali furono acquisiti.'a Una dichiarazione implicita, quindi, che non erala qualità della produzione locale a essere insoddisfacente, ma lo snobismo colle-zionistico tipico della corte a ricercare strumenti di maggior fama.
14. Cfr. Rossr Rooloru 2004, pp.36-37.
Grsrrrt.r Rossr RocìroNt
È quindi ben possibile che, lavorando sui numerosissimi strumenti antichi con
falsa etichetta, ci si possa imbattere in evidenze §uperstiti della scomparsa tradi-
zione fiorentina antica. Sarà tuttavia difiìcile riuscire a individuare e riattribuiret'li esemplari vista la mancanza di modelli stilistici di riferimento.