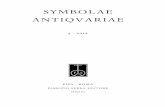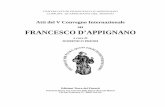La verna: da Francesco al primo insediamento minoritico
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of La verna: da Francesco al primo insediamento minoritico
Luigi Pellegrini
LA VERNA: DA FRANCESCO AL PRIMO INSEDIAMENTO MINORITICO
Il nostro percorso attraverso la vicenda della presenza francescana
alla Verna avrà inizio, quasi punto obbligato di partenza, da quello
straordinario documento che è la Cartula, gelosamente conservata per
alcuni decenni da frate Leone 1. In quel piccolo ritaglio di pergamena
sono contenuti due testi vergati di proprio pugno da "frate Francesco",
come l'Assisiate si denomina nell'altro suo autografo: la Lettera a frate
Leone 2 . I documenti contenuti nella Cartula hanno la forte
connotazione propria di chi esprime stati d'animo e rapporti talmente
personali, da assumere il carattere di una profonda intimità. Il bisogno
stesso di fissare sulla pergamena i sentimenti, pur con tutta la "fatica"
dello scrivere in quel travagliato e quasi drammatico momento della
vita di frate Francesco, sottolinea la volontà di dare al primo dei due
1
1Per lo studio del testo e delle rubriche apposte da frate Leone vedi D. LAPSANSKI, The Autogrph on the «Cartula» of St. Francis of Assisi, “Archivum franciscanum historicum (d’ora in poi AFH), 67(1974), pp. 18-37; ma vedi ora gli studi di A. Bartoli Langeli citati alla nota successiva.
2Su tali autografi vedi la precisa analisi e le puntuali osservazioni di A. BARTOLI LANGELI, Gli scritti da Francesco. L'autografia di un illitteratus, in Frate Francesco d'Assisi. Atti del XXI Convegno internazionale (Assisi, 14-16 ottobre 1993), Spoleto 1994 (Atti dei convegni della Società internazionale di studi francescani e del Centro interuniversitario di studi francescani, Nuova serie, 4), pp. 101-159, che fornisce un'edizione accurata e perspicace, le cui varianti e integrazioni, rispetto all'edizione di K. Esser (Die Opuscula des hl. Franziskus von Assisi. Neue Textkritische Edition. Zweite erweiterte und werbesserte Auflage besorgt von E. Grau, Grottaferrata [Romae] 1989 [Spicilegium Bonaventurianum, 13], pp. 139-146), offrono spunti per interessanti osservazioni e riflessioni; dello stesso Bartoli Langeli è un intervento ben più ampio e articolato su tali autografi: Gli autografi di frate Francesco e di frate Leone, Tournhout 2000 (Corpus christianorum - Autographa Medii Aevi, 5), pp. 11-75.
scritti, da lui vergati su quel piccolo ritaglio di pergamena,
un’impronta esclusivamente personale e di conferirgli un carattere
strettamente "privato". Uno scritto, dunque, non destinato alla
"pubblicazione", che anzi ne sembra consapevolmente e volutamente
escluso 3. Un dato questo che può, almeno in parte, spiegare perché i
testi contenuti nella cartula non abbiano trovato posto nelle prime
raccolte degli Scritti dell'Assisiate, organizzate tra gli anni Quaranta
del secolo XIII e i primi decenni del XIV 4 . Eppure essi avrebbero
potuto assumere notevole significato per gli scopi cui miravano i frati
Minori che nella prima metà del secolo XIV raccolsero testi e
testimonianze su Francesco d’Assisi con l’intento di presentare
un’immagine più fedele del santo e, comunque, alternativa a quella
proposta da Bonaventura e ufficialmente accreditata all’interno
dell’Ordine 5.
1. Una testimonianza straordinaria: la Cartula della Verna
2
3Ciò non significa affatto escludere l'ipotesi dell'esistenza, o almeno della redazione da parte di Francesco, di altri autografi, che potessero avere una destinazione "pubblica", o che avessero un carattere meno personalizzato; il che implica riflettere sul rapporto dell'Assisiate con la scrittura; in proposito rimando alle acute osservazioni di A. BARTOLI LANGELI, Gli autografi di frate Francesco.
4 La prima raccolta degli Scritti di frate Francesco è databile, con tutta probabilità, agli ultimi anni Quaranta del Duecento, quindi a circa Vent’anni dalla morte dell’Assisiate; vedi in proposito Luuigi PELLEGRINI, La raccolta di testi francescani del codice assisano 338: un manoscritto composito e miscellaneo, in Revirescunt chartae Codices documenta textus. Miscellanea in honorem fr. Caesaris Cenci OFM, curantibus A. Cacciotti et P. Sella, Romae, Edizioni Antonianum, 2002, (Medioevo 5), pp. 289-340.
5 Sui problemi filologici relativi a tali raccolte, o compilazioni, vedi E. MENESTÒ, La «questione francescana» come problema filologico, in Francesco d’Assisi e il primo secolo di storia francescana Torino, 1997, (Biblioteca Einaudi 1), pp. 165-201: 121-130.
Seguiamo il percorso tortuoso e, per alcuni tratti, ancora
inesplorato di questo piccolo e prezioso ritaglio di pergamena. In una
rubrica, vergata nel margine alto del verso, frate Leone scrive:
«il beato Francesco due anni prima della sua morte fece una
quaresima di San Michele arcangelo, dalla festa dell’Assunzione di
santa Maria vergine fino alla festa di san Michele di settembre e fu
fatta su di lui la mano del Signore. Dopo la visione e l’allocuzione
del serafino e l’impressione delle stimmate nel suo corpo fece
queste lodi».
L’indicazione cronologica è vaga: c’è solo la segnalazione,
indiretta, ma inequivocabile, dell’anno 1224. Il giorno e lo stesso mese
rimangono imprecisati, ma resta quello scritto, vergato da Francesco
con mano incerta e probabilmente tremante, fissato su un povero
ritaglio di pergamena: sono «le lodi», che irrompono dal suo spirito
finalmente pacificato, come espressione d’abbandono riconoscente a
Dio per «il beneficio a lui conferito». Frate Leone, che riceve in dono la
pergamena, la custodisce gelosamente presso di sé: il foglietto
conserva ancora i segni della piegatura in quarto, a cui era stato
sottoposto per conservarlo all’interno della tonaca. In un secondo
tempo Francesco, a richiesta dello stesso frate Leone, vergò sul verso
della pergamena un notevole Tau, la cui asta verticale appare
attraversata dal nome del frate, mentre sul lato destro di chi guarda
l’Assisiate scrisse una benedizione, disponendo il testo in uno schema
circolare e pluridimensionale, che richiama vagamente il cosidetto
“quadrato magico”. L’indicazione della rubrica è chiara nel segnalare
3
la destinazione della benedizione: «il beato Francesco scrisse di sua
mano questa benedizione a me frate Leone».
La testimonianza, vergata in inchiostro rosso dal compagno di
Francesco sulla Verna, segna tre momenti redazionali della cartula: la
composizione delle Laudes, la scrittura della benedizione,
l'apposizione del thau cum capite. La benedizione venne autografata da
Francesco sul verso della pergamena in un momento successivo
rispetto alle Laudes: la grafia più regolare e sicura, e le differenti
modalità di stesura 6 - più tormentata e immediata la scrittura delle
Laudes, più formalizzata quella della benedizione - sembrano indicare
momenti diversi, anzi segnalare due diversi stati d'animo. Ma rimane
significativo che la formula di benedizione - di cui i primi biografi,
come vedremo, cercano a loro modo di indicare le circostanze
esistenziali - venga scritta sulla stessa pergamena delle Laudes, quasi
ad indicare uno stretto e inscindibile rapporto tra i due testi. L'ipotesi
che si affaccia è che la cartula sia stata consegnata a frate Leone subito
dopo la composizione delle Lodi al Dio altissimo e che in un secondo
tempo il compagno abbia chiesto a Francesco, che scrivesse sul verso
della pergamena la sua benedizione a personalizzare il dono delle
laudes. Il ricordo o, meglio, la sensazione profonda suscitata in lui dal
gesto di Francesco di affidargli la fissazione per scritto dei forti
sentimenti espressi in quella vibrante preghiera di lode venne poi
4
6A proposito delle caratteristiche della scrittura vedi BARTOLI LANGELI, Gli scritti, p. 114, 128-132, dove viene risottolineata la il parallelo con il cosiddetto “quadrato magico", conferita alla formula di benedizione dalla particolare disposizione delle parole e delle loro singole parti, che consente una lettura «circolare e pluridirezionale»; cf. ora ID, Gli autografi, pp. 17-19, 30-41.
registrata nella rubrica apposta più tardi dal destinatario. Il che
avvenne probabilmente tra il 1257 e il 1258, prima che la cartula fosse
consegnata a Benedetta, abbadessa del monastero di Santa Chiara in
Assisi: è l'ipotesi di Chiara Frugoni, che il Bartoli Langeli si sente di
avallare 7.
Nel frattempo la notizia dell’esistenza dei due testi aveva trovato
un primo riscontro nel Memoriale (Vita secunda), di cui Tommaso da
Celano completò la redazione nel 1248 e venne poi ripresa nel 1260
dalle due Legendae bonaventuriane 8. Si trattava solo di un accenno,
inteso a sottolineare il potere taumaturgico di quella benedizione, ma
bisognerà attendere parecchi decenni perché i due testi fossero
riprodotti per scritto, essi, infatti, non compaiono nella prima raccolta
degli Scritti di san Francesco, redatta mentre Tommaso da Celano
componeva il suo Memoriale e inserita nel codice assisano 338: il che
può sembrare strano, se si pensa che proprio frate Leone fu il
probabile organizzatore di tale raccolta 9. I due testi non compaiono
5
7C. FRUGONI, Francesco e l'invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e a Giotto, Torino 1993, p. 76; cf. BARTOLI LANGELI, Gli scritti, pp. 108-110, che aggiunge giustamente che la cartula venne certo depositata presso il sacro convento di Assisi "dopo la redazione del ms. 338", dato che né le Laudes, né la benedizione vi sono trascritte; va però precisato che, quando venne ritta la raccolta dei testi di Francesco nel codice 338, la cartula era gelosamente conservata dallo stesso frate Leone che, quantomeno, collaborò ad operare quella raccolta: vedi in proposito quanto da me osservato in La raccolta di testi francescani.
8 Cf Memoriale, n.49, (cf. Fonti francescane. Scritti e biografie di s. Francesco d'Assisi. Cronache e altre testimonianze del primo secolo francescano. Scritti e biografie di s. Chiara d'Assisi, a cura di E. CAROLI, Terza edizione rivista e aggiornata, Padova 2011 [d’ora in poi FF], p. 490; Legenda maior, XI, 9, FF., pp. 680-681.
9 In proposito mi permetto di rimandare ancora al mio La raccolta di testi francescani.
neppure nei pochi codici che nei decenni tra lo scorcio del secolo XIII e
i primi del XIV trascrivono qualche testo del santo.
La riproduzione dei due autografi dovette attendere le
compilazioni dei primi decenni del secolo XIV, a partire da quella
contenuta nel manoscritto rinvenuto ed editato da Andrew George
Little nel 1914, nella quale lo sconosciuto autore della raccolta di testi
relativi a s. Francesco mostra il santo che consegna a frate Leone il
ritaglio di pergamena, sul recto della quale aveva scritto di suo pugno
le Laudes 10 . La Cartula era ormai emersa dall'ombra, in quanto era
esposta, sotto vetro, nella sacrestia del Sacro Convento di Assisi: ne
abbiamo notizia nel 1338, quando veniva redatto l'inventario delle
reliquie ivi custodite 11. Dunque fin dai primi decenni del secolo XIV
quella schedula era venuta in possesso del più importante e visitato
convento dell'Ordine, dove, come preziosa reliquia, era esposta allo
sguardo devoto dei pellegrini e all'osservazione dei visitatori.
Nel Sacro Convento appunto dovettero essere ricopiati i due testi
della Cartula dal raccoglitore delle informazioni su san Francesco, che
poi troveranno posto nei codici, che contengono la compilazione Fac
6
10 Cf. Un nouveau manuscrit franciscain ancien Philipps 12290 aujourd'hui dans la bibliothèque A.G. Little, decrit et étudié par A.G. LITTLE, in Opuscules de critique historique, III, 18, Paris 1914-1919, rist. anast. Assisi 2002 (Medioevo francescano. Reprints 1*) (riproduzione in francese di Description of the Franciscan Manuscript, formely in the Philipps Library, now in the possession of A. G. Little, in Collectanea Franciscana 1, edd. A.G. LITTLE, M.R. JAMES, M.H. BANNISTER, Aberdoniae 1914 [Britsh Society of Franciscan Studies, 5]), p. 70; per la descrizione della cartula e l’edizione delle Laudes vedi BARTOLI LANGELI, Gli scritti da Francesco, pp. 133-134, che, inoltre, fa notare la significativa variante nel testo dell'espressione posta in bocca al santo, rispetto agli analoghi racconti delle altre fonti.
11 L’inventario è contenuto nel ms Assisi 344, vedi BARTOLI LANGELI, Gli autografi, p. 17.
secundum exemplar, o Compilazione Avignonese 12 . Si tratta di un
complesso assieme di testi, ad introduzione del quale il compilatore
enuncia chiaramente l'intenzione di riunire nel più alto numero
possibile i disiecta membra della memoria di Francesco d'Assisi, ben
oltre, anzi in alternativa, agli elementi fissati dalla tradizione
ufficializzata, e in qualche modo cristallizzata, all'interno dell'Ordine
minoritico dalla Legenda di Bonaventura 13. In tale contesto trova posto
la più ampia collezione di scritti dell'Assisiate che sia stata compiuta
nei primi due secoli di storia francescana: sono diciassette scritti, fra i
quali anche i due contenuti nella Cartula: le Laudes Dei altissimi e la
Benedictio fratris Leonis, quest’ultima riprodotta due volte nella
compilazione 14 . Nello stesso torno di tempo i due testi vennero
trascritti in una raccolta di provenienza centroitalica, una
compilazione strutturata nell’ambiente riformistico dell’Italia centrale
7
12 Su tale compilazione e sui suoi contenuti vedi SABATIER, Compilation franciscaine d'Avignon, che trascrive anche l’edizione del prologo, l’inizio del quale ha dato il nome alla compilazione; lo stesso Sabatier (Sancti Francisci legendae veteris fragmenta) ha edito alcuni dei racconti contenuti nella compilazione (cf. CLASEN, Legenda antiqua, pp. 22-23, che alle pp. 172-176 fornisce l’elenco ordinato delle pericopi di cui è composta l’Avognonese (cf. ibid. Tafel F, pp. 13*-17* con l’elenco degli episodi contenuti nei singoli codici); sui diversi problemi riguardanti la compilazione, la trasmissione manoscritta le parziali edizioni, gli studi e i problemi della sua genesi e sviluppo vedi ora MENESTÒ, La «Compilatio Avenionensis»: una raccolta di testi francescani della prima metà del secolo XIV, “Studi medievali”, 44(2003), pp. 1423-1541.
13 Le intenzioni del raccoglitore sono ben evidenziate nel prologo (vedine la riproduzione in SABATIER, Compilation franciscaine d'Avignon, pp. 427-431).
14 Una prima volta viene inserita dopo i Nomina XII primorum fratrum Minorum, una seconda volta nella raccolta del corpus degli scritti di Francesco dopo le Laudes Dei altissimi. Si noti che la più ampia raccolta precedente di tali scritti, quella del codice Asssisano 338, trascrive solo dodici testi (vedi in proposito le tabelle in appendice a ESSER-OLIGER, La tradition , pp. 146-149 e cf. la tabella acclusa al mio La raccolta di testi francescani.
15 ed entreranno così definitivamente a far parte del corpus degli Scritti
del santo di Assisi.
L'alto e profondo valore autobiografico dei due testi contenuti
nella cartula venne dunque avvertito da chi s'impegnò a raccogliere le
memorie del santo, non appena i due scritti emersero dall'ombra, in
cui sembra averli consapevolmente tenuti il destinatario, frate Leone. I
due testi appaiono assolutamente caratteristici rispetto agli altri scritti
"privati" di Francesco: il verso della pergamena contiene quelle Laudes,
che, pur ricalcate sui testi biblici e liturgici, sono altamente
rappresentative di come Francesco traducesse in atteggiamento orante
l’angustia, che si avverte particolarmente profonda in quel preciso e
così significativo momento della sua esperienza umana e spirituale. La
tensione dialettica dei sentimenti e l'angoscia che ne derivava
sembrano perdere la loro carica dolorosa nel placarsi in un rapporto
diretto, personale e assolutamente rassicurante con Dio. La grafia
stessa, «tormentata e irregolare» - come ha giustamente osservato
Attilio Bartoli Langeli 16 - denuncia la difficoltà del momento.
Sta forse qui la risposta al quesito sul perché lo scritto sia stato
consegnato al compagno, autore della rubrica esplicativa. E pare così
capovolgersi l'interpretazione agiografica, secondo la quale
l’occasione della scrittura autografa e della consegna della cartula a
8
15I primi testimoni mss. giunti fino a noi di tale compilazione sono il codice del collegio romano di S. Isidoro 1/25 e quello del convento fiorentino di Ognissanti F. 19, l'uno e l'altro della seconda metà del secolo XIV; sugli Scritti del santo di Assisi contenuti in tale compilazione rimando al mio La trasmissione degli Scritti di Francesco d'Assisi, in Scritti, pp. 39-72; e vedi ora in ID., Gli scritti di frate Francesco, in Fancesco e i suoi agiografi, pp. 425 457.
16 BARTOLI LANGELI, Gli scritti, p. 114.
frate Leone sarebbe stato il momento difficile attraversato dal socius: la
maligna et gravis temptatio, non carnis, sed spiritus 17. A tale “tentazione”
non accennano affatto le note di mano di fra Leone. Secondo le
annotazioni del destinatario le Laudes rappresentano invece un inno di
ringraziamento a Dio, da parte di Francesco, pro beneficio sibi collato 18.
Il testo diventa così, nel momento e nell'atto stesso di consegnarlo al
socius, limpida testimonianza di un rapporto personale e profondo.
Presenze e assenze di scritti di Francesco nelle prime raccolte
assumono un significato particolare, che meriterebbe di essere
affrontato in tutti i suoi risvolti, ma non in questa sede, dove basterà
notare che gli autografi contenuti nella cartula, nonostante il loro
carattere di scritto personalissimo, sono costantemente inseriti in tutte
le raccolte di testi del santo, organizzate a partire dalla metà del secolo
XIV, mentre gli altri due testi di carattere "privato" - l'Epistula ad
Ministrum e quella ad Antonio - sembrano alternarsi nelle trascrizioni
9
17Così è detto sia nel racconto della raccolta del manoscritto Little (Un nouveau manuscrit franciscain, p. 70), sia nel Memoriale n. 49, sia nella Legenda maior XI, 9 (FFit., nn. 635, 1197); la magna tentatio andrebbe piuttosto riferita non a Leone, ma a Francesco, nel senso, come si è accennato sopra, di un momento di angosciosa tensione dialettica dei sentimenti, dovuta forse anche alle “difficoltà” ad accettare le modificazioni intervenute nella sua fraternità, con la quale si era instaurato un tormentato rapporto, che trova eco in più di una fonte e che s’intravede anche nelle recise prese di posizione del Testamento; in proposito vedi G.G. MERLO, Le stimmate e la “grande tentazione”, in ID., Intorno a frate Francesco. Quattro studi, Milano 1993, pp. 131-156.
18Vedi la trascrizione della ribrica in LAPSANSKI, The «cartula», p. 35 e il più recente studio di BARTOLI LANGELI, Gli autografi, pp. 31-32; ID., Gli scritti autografi, in FRANCESCO D’ASSISI, Scritti, pp. 108-109.
19. L'altro scritto "privato" di Francesco, la lettera a fra Leone, ebbe
fortuna ancora minore: se ne ebbe la prima notizia in una
riproduzione di frate Sivestro Bartolucci nel 1604 e una prima
edizione ad opera di Luca Wadding nel 1623, dopo di che lo scritto
andò disperso e solo all’inizio del secolo XX venne consegnato da
Leone XIII al Capitolo della Cattedrale di Spoleto 20.
La storia della tradizione manoscritta di un testo è condizionata
da diversi fattori e da fortuite contingenze, ma lo è soprattutto la
conservazione dei testimoni di tale tradizione, che è alla base dello
stato in cui i testi stessi sono giunti fino a noi. Lo studio degli
apparentemente strani percorsi della trasmissione degli scritti del
santo di Assisi insegna che tale trasmissione è regolata dalla
diversificazione degli interessi e delle attenzioni sollecitati dai motivi
ideali che animarono i diversi ambienti del francescanesimo nel corso
dei primi due secoli della sua storia 21.
2. La prima fraternitas alla Verna
10
19La lettera ad Antonio non viene riprodotta nei codici di area centro italica. E' un dato molto significativo: la lettera circolava nella provincia minoritica di Sassonia attraverso la compilazione avignonese, che aveva inserito lo scritto nel contesto di una breve serie di episodi relativi ad Antonio.
20 Per una precisa sintesi della vicenda della lettera vedi BARTOLI LANGELI, Gli scritti, pp. 110-113; ID., Gli autografi, pp. !9-20.
21 Mi permetto di rinviare in proposito a PELLEGRINI, Contesti, tempi e ambienti della diffusione di un testo: a proposito della tradizione manoscritta della prima Regola minoritica, in Roma, magistra mundi.1010 Itineraria culturae medievalis. Mélanges offerts au Pèr L. E. Boyle a l'occasion de son 75e anniversaire, édités par J. Hamesse, Louvain-La-Neuve 1998 (FIDEM. Textes et Etudes du Moyen âge, 10, 2)., pp. 667-685; ID, Gli Scritti di frate Francesco.
Nelle sue varie parti la cartula segnala un complesso gioco di
rapporti personali e di ricordi profondi, che sulla Verna sembrano
trovare l'ambiente più adatto per la realizzazione e l'espressione:
circostanze di tempo e di luogo di un'ideale fraternitas, nel contesto di
quella singolare convivenza di solitari, legati da forti e profondi
rapporti. Ma c'è anche lo scambio quotidiano che le fonti sembrano
emblematizzare nel gesto semplice - registrato nel racconto della
raccolta Little e riportato dal Memoriale di Tommaso da Celano e da
Bonaventura - di farsi portare chartam et atramentum, che lascia
intravedere la volontà di rendere possibile un rapporto costante e
profondo nella salvaguardia delle esigenze di una vita contemplativa:
il materiale scrittorio era, pur nella sua elementarità, lo strumento
adatto per la comunicazione reciproca.
Il ricorso alla scrittura era divenuto mezzo ordinario di
comunicazione per Francesco negli ultimi anni della sua vita, talché
«in ogni momento, pure in cammino, Francesco poteva dire,
specialmente a frate Leone: “portami carta, penna e inchiostro”;
oppure, “prendi carta, penna e inchiostro e scrivi”». In proposito ne
sarebbe «riprova la pronta disponibilità di materiali scrittori, anche
nelle condizioni che possiamo immaginare le più disagiate: si pensi
alla quaresima della Verna». L'osservazione, quanto mai opportuna,
trova sostegno nelle fonti dell’epoca ed è ben inserita nel contesto
delle consuetudini epistolari di quel periodo, con particolare
riferimento «al genere delle lettere monastiche» 22.
11
22 Ho riprodotto queste considerazioni da BARTOLI LANGELI, Gli scritti, p. 154-155.
Di fatto proprio lì, alla Verna tale materiale c'era e doveva essere
proporzionale al programmato tempo di soggiorno. Mi sembra che
non sia spingersi troppo in là nelle ipotesi pensare ad una quantità di
tale materiale, che consentisse quella comunicazione, anche con
l'esterno, di cui, però, non abbiamo traccia nelle fonti, che anzi
sembrano voler accentuare, e sublimare, l'assoluto isolamento di
Francesco; ma i testi agiografici sono tutti protesi a concentrare la loro
attenzione sul prodigioso fenomeno delle stimmate e sull’atmosfera di
solitudine che lo circonda. Unico spiraglio di qualche possibile
rapporto comunicativo è appunto il materiale scrittorio (charta et
atramentum), che Francesco chiede gli sia portato e la disponibilità di
tale materiale, che consente al socius di consegnargli la cartula, sulla
quale Franceso vergherà i due brevi scritti.
Le fonti stesse accennano, in modo più o meno esplicito, alla
presenza di altri socii alla Verna accanto a Francesco in quel settembre
del 1224. Leggendo tali fonti sembra di poter individuare l'esistenza di
una pur ridottissima fraternitas, in cui le occasioni d'incontro non
mancavano, e che si potrebbe immaginare organizzata sui moduli
proposti nella Regula pro eremitoriis: una fraternitas strutturata in modo
tale da garantire il più assoluto ritiro, anzi isolamento, ai frati che
fanno temporaneamente la loro esperienza eremitica, ma anche da
consentire gl’imprescindibili rapporti con l'esterno attraverso altri
frati a ciò deputati, in un'alternanza di funzioni, onde evitare qualsiasi
12
irrigidimento dei ruoli 23 . La presenza del materiale scrittorio alla
Verna mi pare in proposito molto eloquente, qualora si pensi che in
questi ultimi anni di vita Francesco comunicava soprattutto attraverso
lo scritto.
Ma seguiamo con ordine il succedersi delle indicazioni nelle fonti.
Abbiamo un primo accenno ad un gruppo di frati accanto a Francesco
nello testo agiografico redatto da Tommaso da Celano a quattro anni
di distanza dall’evento. Il biografo non indica un preciso luogo di
ritiro del santo quando, avendo deciso di «dedicarsi alla beata
solitudine della contemplazione [...], prese con sé pochissimi
compagni» (assumpsit secum socios valde paucos) 24. La testimonianza è
importante: all’agiografo non interessa, per il momento, segnalare con
esattezza un determinato ambiente, ma una situazione agognata e
cercata: locum quietis et secretum solitudinis petiit; termini pregnanti,
indicativi della ricerca di condizioni che avvolgano il santo,
consentendogli quella quies interiore, la quale sola gli può permettere
di penetrare nel secretum (separatezza, intimità profonda) dell’essere
solo con se stesso (solitudinis). A tale scopo il Celanese presenta e isola
accanto a Francesco un gruppetto di socii selezionato e omogeneo.
Sono «compagni, ai quali era noto, più che agli altri il suo santo modo
di vivere» (socii, quibus eius conversatio sancta magis quam caeteris nota
13
23Vedi il testo della Regula pro eremitoriis in FRANCESCO D’ASSISi, Scritti. Critice edidit C. Paolazzi, Grottaferrata (roma) 2009, pp. 344-345; mi permetto di rimandare in proposito al mio L'esperienza eremitica di Francesco e dei primi francescani, in Francesco d'Assisi e Francescanesimo dal 1216 al 1226 dal 1216 al 1226. Atti del IV Convegno internazionale (Assisi, 15-17 ottobre 1976), Assisi 1977 (Società internazionale di Studi francescani), pp. 281-313, pp. 293-299.
24Vita beati Francisci, n. 91, FF, p. 367; FFit., n. 479.
erat). Egli, inoltre, si sofferma sulle motivazioni di tale scelta: «perché
lo salvaguardassero dalle visite e dal disturbo degli uomini e fossero
custodi amorosi e fedeli della sua quiete» (ut tuerentur eum ab incursu
et conturbatione hominum et suam quietem in omnibus diligerent et
servarent Balza immediatamente agli occhi la coerenza con le
disposizioni della Regula pro eremitoriis: i compagni devono garantire
la solitudine orante e meditativa del santo, proteggendo Francesco dal
mondo esterno che rischia di turbare il suo impegno contemplativo.
Frate Tommaso raffigura il gruppetto raccolto attorno al santo come
una piccola fraternità connotata da rapporti di profonda e reciproca
fiducia, dunque una minuscola comunità accuratamente selezionata
sulla base degli intenti cui mira l’Assisiate nel suo «abbandonare le
folle che ogni giorno accorrevano devotamente a lui». Il racconto è
tutto mirato ad evidenziare il profondo bisogno di Francesco di ritirasi
nei contemplationis beatis secessibus. E' questo un punto chiave della
riflessione e interpretazione del primo biografo di Francesco:
un'interpretazione che nello sviluppo successivo dei motivi
agiografici, si manterrà costante, arricchendosi, di volta in volta, di
particolari, tutti funzionali a sottolineare la richiesta, anzi
l'imposizione da parte di Francesco di essere lasciato assolutamente
solo e indisturbato 25 . La narrazione del Celanese si snoda nel
presentare il protagonista in totale solitudine, mentre in
quell’indeterminato eremitorium si affida alle sortes apostolorum, cioè
14
25Si pensi solo ai particolari - sempre orientati in tale direzione - di cui si arricchisce il racconto nel capitolo 9 degli Actus beati Francisci (FF, pp. 2103-2109).
all’apertura del Vangelo per coglierne i suggerimenti-guida per quella
specifica circostanza 26.
Non siamo ancora alla Verna, o almeno l’agiografo non ne fa
menzione. C’è un’interruzione nello svolgersi degli avvenimenti tra
quel ritiro, protetto da pochi e scelti compagni, e l’improvvisa e
immediata esposizione del’evento della Verna. Tale interruzione è
segnalata anche dalle indicazioni cronologiche: l’agiografo fa
riferimento a un generico tempore quodam per il temporaneo soggiorno
nella solitudine eremitica con un ridottissimo numero di socii, mentre
dà una ben definita indicazione temporale (duobus annis antequam
spiritus Deo redderet) per l’asperienza delle stimmate alla Verna. Qui
veramente il santo appare assolutamente solo. Una solitudine
ricercata con cura, prima, ma soprattutto dopo la straordinaria
esperienza, i cui effetti visibili nel vivo della sua carne Francesco tiene
gelosamente celati: solo fortuite e fortunate coincidenze consentono a
un paio di frati la constatzione diretta. La solitudine anche psicologica
del santo è fortemente evidenziata nella rimarcata sottolineatura della
diffidenza nei confronti di quanti lo circondavano, ostentando un
falso apprezzamento 27.
Tommaso da Celano dà alla Verna la denominazione di
eremitorium: è l'unico caso nella prima fatica biografica del Celanese in
15
26Vita beati Francisci, nn. 92-93 ( FF., nn. 481-483).
27 Un’analisi attenta e critica della parte dedicata da Tommaso da Celano all’evento della Verna è stata condotta da G.G. MERLO, Le stimmate e la “grande tentazione”, in Id. Intorno a frate Francesco, Milano 1993, pp. 131-156: 142-152, che mette in evidenza i passaggi nei quali l’agiografo prospetta lo stato d’animo di Francesco e la sua interiore e conflittuale tensione nei confronti del «gruppo dirigente e di certi sviluppi dell’Ordine».
cui viene definito con tale termine uno specifico luogo di soggiorno di
Francesco. Ciò è tanto più significativo, in quanto è trasparente nelle
fonti successive la tendenza a caratterizzare le sedi romitoriali, in cui
vengono ambientati i singoli episodi, non con le connotazioni che
effettivamente avevano all'epoca di Francesco, ma sulla base delle
strutture ormai realizzate quando le stesse fonti vennero scritte. Nel
continuo e quasi inquieto muoversi di Francesco da un posto all’altro,
che lo porta fino alle terre d’oltremare, la Verna è l'unico luogo dove la
Vita beati Francisci colloca esplicitamente un prolungato soggiorno
dell’Assisiate. Un altro luogo con caratteristiche eremitiche, dove il
Celanese nella sua prima opera agiografica indica una sosta di
Francesco, è Sant'Urbano; l’autore lo segnala esplicitamente col
denominativo di eremo: cum tempore quodam apud eremum Sancti
Urbani egritudine gravissima laboraret 28. Si tratta di un vero e proprio
eremo minoritico, organizzato con una precisa struttura per
un'esperienza solitaria, funzionale alla preghiera meditativa, o non
piuttosto un generico ambiente solitario, dove Francesco tenta di
riprendersi dalla sua malattia? Difficile dare una risposta precisa,
tanto più che il ricordo di Sant'Urbano scomparirà nella seconda
biografia del Celanese, assieme all'altro luogo di possibile ritiro di
Francesco, l'isola del Trasimeno, mentre accanto alla Verna
emergeranno, come eremitoria, Poggio Bustone, Sarteano, Fonte
16
28Ibid., n. 61, FF, pp. 336-337; FFit., n. 429.
Colombo, Greccio; la stessa Porziuncola verrà ormai connotata come
tipico luogo di assoluto silenzio e di solitudine di stampo eremitico 29.
La Verna rappresenta negli anni immediatamente successivi alla
morte di Francesco, quelli della redazione della Vita beati Francisci, un
luogo forte della sua memoria, l'unico in cui si conserva il ricordo di
un soggiorno prolungato e altamente significativo. Per altri luoghi
vengono registrati singoli episodi, di cui pure è vivo il ricordo. Si
pensi a Greccio, dove si svolge la suggestiva scena del Natale, ma che
non è indicato come luogo di soggiorno di Francesco: è invece un
castrum, in cui il santo sosta periodicamente presso il nobile Giovanni.
A Greccio, secondo le informazioni del primo agiografo, venne ben
presto costruita una chiesa in onore di san Francesco. Nessun luogo di
culto pare fosse ancora edificato alla Verna.
Attraverso le fonti successive assistiamo alla progressiva
realizzazione di elementari strutture. Gli Actus beati Francisci – un
testo redatto in varie fasi tra gli anni Venti e Trenta del XIV secolo -
parlano di un pauperculum tugurium de ramis arborum, un capanno
preesistente alla venuta di Francesco, fatto costruire da Orlando di
Chiusi nel momento stesso in cui accompagnava, con una schiera di
armati, i due frati inviati da Francesco a ispezionare il luogo per
verificare se fosse «adatto alla contemplazione». Sempre gli Actus
informano che in seguito il santo vi avrebbe fatto aggiungere una
paupercula cella per sé e accennano alla cella di frate Leone, che è il
17
29Vedi PELLEGRINI, L'esperienza eremitica, 301-305. per la Porziuncola e per i singoli eremi vedi il mio I luoghi di frate Francesco, Milano 2010.
vero protagonista degli episodi della Verna narrati dagli Actus 30. La
Legenda Perusina o Compilazione di Assisi alla Verna parla di un luogo dei
frati con celle separate per alcuni di essi, compreso Francesco; l’autore
infatti precisa che una di tali celle, destinata ai pasti e coinvolta in un
incendio, «era lontano dal luogo dei frati» (longe erat a loco fratrum) 31.
È evidente in queste fonti tardive la tendenza a retroproiettare
all’epoca di frate Francesco il complesso delle strutture romitoriali,
per non dire conventuali, ormai realizzate, quando le fonti stesse
venivano redatte.
Tutto comunque anche in questi testi è proteso alla forte
sottolineatura della funzionalità assoluta della Verna e delle sue
elementari strutture abitative a garantire il profondo bisogno di
solitudine mistica di Francesco. Egli, però, non appare solo, se non
nella Vita beati Francisci, che pure preventivamente - accennando alle
abitudini del santo ad alternare la vita attiva e quella contemplativa -
precisa che, portandosi in quell’indistinto eremo, «prese con sé
pochissimi compagni» (assumpsit secum socios valde paucos), il compito
dei quali era quello di garantire l’assoluto isolamento del santo. Nella
sua prima fatica agiografica Tommaso da Celano non solo evita di
dare una denominazione a quell’eremo, ma non fornisce alcun
elemento d’identificazione di tali socii, che i successivi racconti
agiografici pongono accanto a Francesco sulla Verna, ne fanno
18
30 Actus beati Francisci, cap. 9, (Fontes franciscani, a cura di E. Menestò, S. Brufani, G. Cremascoli, E. Paoli, L. Pellegrini, Stanislao da Campagnola. Apparato critico della fonti a c. di G. M. Boccali, S. Maria degli Angeli-Assisi 1995, p. 2105).
31 Compilazione di Assisi, n. 87, (FF, n. 1622).
emergere progressivamente i nomi e ne fissano i ruoli attivi a loro
assegnati. Una prima precisazione si riscontra nel racconto delle sortes
apostolorum, che la Legenda bonaventuriana - pur ricalcando, in parte
anche espressivamente, la Vita beati Francisci - colloca direttamente alla
Verna; anzi Francesco non apre da sé il libro dei vangeli, ma ne affida
l’incarico a un compagno 32 . Rilievo ancora maggiore, e da veri
protagonisti, acquistano i socii nel seguito del racconto della visione
del serafino: dopo l'impressione delle stimmate, narra Bonaventura,
Francesco vocavit aliquos ex fratribus, tra essi frate Illuminato, il quale
risolve in positivo il dubbio di Francesco sull'opportunità di rivelare
l'evento 33. L’agiografo non precisa le circostanze di tempo e di luogo,
anche se tali circostanze potrebbero essere lasciate intendere dal fatto
che il racconto è inserito tra l'evento della stimmatizzazione e la
discesa di Francesco dalla Verna, dopo la quaresima in preparazione
alla festa di San Michele. Questo racconto, che ha come prima
testimonianza scritta la Legenda di Bonaventura, verrà ripreso
nell’aggiunta successiva, o appendice a I Fioretti, dal titolo Delle sacre
sante istimate del beato Francesco e delle loro considerazioni 34 . La
testimonianza è tardiva, ma non per questo inattendibile. A renderne
problematica l’attendibilità è semmai il confronto con l’insistito
accenno della Vita beati Francisci di Tommaso da Celano a proposito
degli accorgimenti di Francesco per occultare le stimmate, persino ai
19
32Legenda maior, XIII, 2, (FF, n. 1224).
33 Ibid., XIII, 4, (FF, n. 1227).
34 Delle sacre sante istimate (FF, n. 1922).
suoi propinqui e familiares 35. La contraddizione è evidente e stridente,
pare avvertirla lo stesso Bonaventura, che, in coerenza con quanto
affermato dal Celanese – fonte quasi unica dalla quale l’autore attinge
le sue informazioni, che poi rielabora per adattarle alle esigenze della
sua revisione della vita e dell’esperienza di Francesco - segnala che il
santo, « benché in altre circostanze fosse solito dire: il mio segreto
resta in me» (licet alias dicere solitus esse: secretum meum mihi), in quella
specifica circostanza cum multo timore riferì della visione.
Altri due nomi vengono inseriti nel trecentesco racconto degli
Actus beati Francisci: quelli di frate Masseo e di frate Angelo 36 . Ma
quale valore attribuire ai racconti di fra Ugolino da Monte Santa
Maria (oggi Montegiorgio), che tra gli anni Venti e Trenta del Trecento
compilò da fonti diverse gli Actus? La sua credibilità è quanto meno
problematica, data l'evidente tendenza ad amplificare a dismisura il
meraviglioso in una molteplicità di eventi mirabili e in una nutrita
serie di particolari, che tendono a evidenziare lo strettissimo rapporto
tra il santo e frate Leone, rappresentato nel ruolo di coprotagonista,
attivo fino all'indiscrezione, accanto a Francesco. Si rilegga il lungo
passaggio in cui il fido compagno assiste a diversi fenomeni di
levitazione del santo nella solitudine contemplativa della Verna.
L’autore di questa parte degli Actus avalla con la testimonianza del
socius di Francesco la veridicità degli episodi inseriti nel periodo di
soggiorno di Francesco alla Verna. Ma il narratore elenca gli
20
35Vita beati Francisci, nn. 95-96, (FF, nn. 486-487); Memoriale., nn. 135-139 (FF, nn.719-720).
36 Al racconto della Verna è dedicato il capitolo 9 degli Actus beati Francisci, Fontes franciscani, p. 2105-2009.
intermediari che trasmettono la notizia: da Leone a Giacomo della
Massa, da costui a Ugolino da Montegiorgio, per raggiungere infine,
attraverso frate Ugolino, il narratore degli Actus, o almeno dei racconti
in questione. La catena delle testimonianze lascia ampio spazio a quei
processi d’amplificazione, anzi di distorsione, propri del passaggio
delle notizie di bocca in bocca, o, se si preferisce, da testimone a
testimone, dato che la clausola di questi racconti negli Actus ha
proprio lo scopo di avvalorare i racconti stessi con precise garanzie
testimoniali.
Un altro socius è segnalato sulla Verna accanto a Francesco, frate
Silvestro, il cui nome risulta dalla Lettera di frate Masseo, che si dilunga
nel riferire il saluto o, meglio, l’addio di Francesco alla Verna, nel
momento di lasciare il luogo, raccomandando che non fosse mai
abbandonato dai frati 37 . Lo scritto è con tutta evidenza una tarda
amplificazione di un racconto dei Fioretti, o, per essere più precisi,
della parte conclusiva della terza fra le Cinque considerazioni delle sacre
sante istimate, le quali sono un’aggiunta al testo degli Actus, di cui I
Fioretti sono un libero volgarizzamento 38. La falsificazione era stata
già ampiamente dimostrata, quando nel 1924 il frate Minore Saturnino
Mencherini redigeva la sua preziosa raccolta dei documenti alvernini
21
37 MENCHERINI S. (SATURNINO DA CAPRESE), Codice diplomatico della Verna e delle SS. Stimmate di S. Francesco d'Assisi nel VII centenario del gran prodigio, Firenze 1924 (Documenti francescani III), (d’ora in poi M) pp. 4-6
38 Delle sacre sante istimate, FF.it, n.1924.
nel Codice diplomatico della Verna 39 . Questo testo tardivo venne
probabilmente elaborato, assieme ad altri, nel secolo XVII allorché
l'osservante sardo, Salvatore Vitale, collezionava il materiale a
supporto di quanto andava narrando e descrivendo nella sua opera
Monte serafico della Verna, pubblicata infine a Firenze nel 1628.
Abbiamo percorso tutto il cammino attraverso le fonti, nel
tentativo di cogliervi indizi sulla composizione e strutturazione del
gruppetto minoritico sulla Verna nell'agosto-settembre 1224. Dalla
prima testimonianza, quella di Tommaso da Celano ai racconti degli
Actus corre quasi un secolo. Un periodo di tempo, che gli Actus
cercano di colmare con la concatenazione dei testimoni. Dobbiamo
riconoscere che le fonti sono tra loro tutt'altro che ripetitive: da quegli
innominati socios valde paucos del Celanese, si giunge ai quattro
distintamente nominati e ben noti socii degli Actus. Un percorso
narrativo delle fonti, attraverso il quale si vanno progressivamente
profilando strutture e ruoli dell'unico, tra i luoghi di passaggio o di
soggiorno di Francesco, che già nel 1228 Tommaso da Celano aveva
22
39 La falsificazione sembra fuori discussione anche per CRESI, Supplemento, p. 447, che pur sostiene che la tradizione, di cui il documento è espressione, sia "degna di fede"; mi permetto di esprimere qualche perplessità, visto che le pezze d'appoggio a sostegno dell'attendibilità di tale tradizione sono appunto il racconto o, meglio, l’accenno contenuto ne I Fioretti di S. Francesco e l'attento, ma certamente non contemporaneo, cronista Mariano da Firenze. Il che sia detto senza voler utilizzare la contemporaneità come criterio unico di attendibilità, ma quando un testo è stato redatto a tre secoli di distanza dagli eventi bisognerà pur vagliare le fonti da cui ricava le notizie. In questo caso non si possono ipotizzare altre fonti, se non appunto i Fioretti ed eventualmente una copia più antica, rispetto a quella che conosciamo, della supposta lettera di fra Masseo: come si vede c'è il rischio di una petizione di principio. Da notare che lo stesso Mencherini aveva precedentemente preso posizione nei confronti del Minocchi e in difesa dell'autenticità della lettera (SATURNINO DA CAPRESE, L'addio di S. Francesco), salvo poi ricredersi e dare ragione allo studioso casentino (cf. M, p. 7).
configurato come un vero e proprio eremitorium, benché limitato
cronologicamente al periodo in cui Francesco vi trascorse la quaresima
di San Michele, durante la quale ebbe la straordinaria esperienza della
stimmatizzazione.
3. Verso un insediamento minoritico stabile
Anche nel caso della Verna e delle strutture originariamente
costituitevi per consentire periodi di sosta contemplativa, le fonti
vanno lette con avvertenza critica e le informazioni che forniscono
esigono più di una cautela. Nel caso specifico della Verna, però, e delle
povere e semplici strutture abitative si nota un certo rispetto per i dati
della memoria: ad un attenta lettura delle informazioni circa il
gruppetto di socii, che si trovano accanto a Francesco nella quaresima
extra liturgica del 1224 e a proposito delle elementari strutture di
accoglienza, al di là di alcune precisazioni che vengono inserite
progressivamente nelle fonti agiografiche, non si vede una diversità
fra le indicazioni offerte da Tommaso da Celano nel 1228, e le
informazioni tardive degli Actus e della Compilatio Assisiensis. L’unica
differenza notevole in quest’ultimo testo, rispetto alle altre fonti, è
l’inserimento dell’indicazione di un locus fratrum, improbabile
all’epoca del soggiorno di Francesco. Semmai va notato come nelle
fonti più tarde si sviluppi una trama di racconti intessuti di
meraviglioso in risposta all’insorgere, nei frati e nel popolo,
dell’esigenza di fatti prodigiosi, anch'essa legata al tenace e incisivo
ricordo di un evento straordinario. Ma lo sviluppo di tale trama
23
narrativa non modifica i dati relativi alle modalità di vita e di
relazione di quel primo gruppetto.
Un semplice confronto con quanto è narrato a proposito
dell'eremo di Greccio è illuminante. Tommaso da Celano indica che in
seguito alla celebrazione del Natale da parte di Francesco venne
costruita una chiesa. Lo stesso Celanese nel Memoriale del 1246
modifica le prospettive, trasformando Greccio in un vero e proprio
insediamento eremitico, dove ambienta alcuni episodi che hanno a
protagonista il santo di Assisi. Presenta così un eremo ben articolato
nelle sue strutture abitative: c'è un luogo apposito per la mensa, vi
sono celle, c'è una porta d'ingresso al romitorio 40 . La Compilatio
Assisiensis è ancor più meticolosa nell'indicare la cella dove dimorava
Francesco: è la cella ultima post cellam maiorem et antiquam, nella quale
dormiva il suo socius; la cella del santo è appartata rispetto al
complesso romitoriale, in quanto vi è interposto un atrio 41 . E'
evidente che sia Tommaso da Celano nel 1248, sia l'anonimo
compilatore nei primi decenni del secolo XIV, o il testo da cui preleva i
suoi racconti, descrivono l'insediamento quale si presentava all'epoca
in cui scrivevano. Per La Verna invece i ricordi relativi all'ambiente e
ai suoi essenziali abitacoli, come pure al piccolo gruppo di socii, che è
accanto a Francesco, sembrano fissati al momento in cui si svolsero i
fatti, benché gli episodi ambientati alla Verna si vadano moltiplicando,
amplificando e rivestendo di meraviglioso.
24
40Memoriale, n. 61, AF, pp. 167-168; (FF, n. 647).
41Compilatio Assisiensis, n. 119, (FF, n. 1673).
Eppure le strutture abitative e la stessa composizione della
fraternità minoritica alla Verna avevano subito nel frattempo
numerose e notevoli trasformazioni, di cui ci limiteremo a ripercorrere
la vicenda soltanto per giungere a una miglior definizione del primo,
stabile insediamento dei frati Minori. In proposito la più antica fonte
documentaria risale a una quindicina d’anni dopo l’evento delle
stimmate: il 16 giugno 1239 Marcellino, vescovo di Arezzo, emetteva
un diploma, con il quale concedeva quaranta giorni di indulgenza a
chiunque direttamente o indirettamente sostenesse con le proprie
elemosine i frati della Verna 42. Il documento è dunque una lettera
d’indulgenza, formulata secondo le norme restrittive per tali
interventi, stabilite da oltre un ventennio dal concilio Lateranense IV
del 1215. Tutto sembra assolutamente normale. Singolare è l'occasione
offerta ai fedeli per lucrare l'indulgenza: non la dedicazione di una
basilica, o il suo anniversario, secondo quanto previsto esplicitamente
dalle disposizioni conciliari, ma l'elemosina fatta ai frati, una delle
circostanze, pur non esplicitamente previste, per le quali il concilio
aveva raccomandato estrema moderazione nell'elargire indulgenze 43.
Esaminiamo il diploma episcopale nelle sue diverse articolazioni
e negli specifici contenuti. L'arenga che introduce la lettera - Quoniam
ut ait Apostolus seguita da una citazione, che accosta un passaggio
della lettera ai Romani (14,10) a una citazione dalla Lettera ai Corinti (5,
25
42Edita in M, pp. 13-14.
43Cf. Conciliorum oecumenicorum decreta, a c. di G. ALBERIGO (e altri). Edizione bilingue, Bologna 2002 p. 263-264; Vedi in proposito «Misericorditer relaxamus». Le indulgenze fra teoria e prassi nel Duecento, a cura di L. PELLEGRINI e R. PACIOCCO, “Studi medievali e moderni” 3, 1(1999), passim.
10) - era stata indicata e prescritta dal canone 62 del concilio
Lateranense del 1215 per i casi in cui i vescovi volessero autorizzare e
sostenere, con relativa indulgenza, la richiesta di elargizioni allo scopo
di favorire la venerazione delle reliquie e l’ampliamento degli spazi
sacrali che le contengono 44 . Di fatto il diploma è rilasciato per
incrementare la raccolta delle elemosine, anzi col preciso ed esplicito
intento di sollecitare la generosità dei fedeli. In esso, però, non vi è
alcun accenno a reliquie, o a eventi venerandi, collegati alla Verna. La
denominazione data al luogo non è indicativa di alcun particolare
carattere sacrale, come invece si può riscontrare nei successivi
documenti, a partire dal 1250. Il diploma episcopale usa la semplice
denominazione saxo de Verna. La sua attenzione è tutta concentrata sui
«frati Minori che dimorano [alla Verna]» (fratres Minores [ibi] morantes),
sulla loro estrema e volontaria povertà, talché «a causa della
solitudine del luogo non avevano di che sostentare la loro miserevole
vita» (propter ipsius loci solitudinem non habeant unde valeant eorum vitam
miserabilem sostentare). Estrema e penuriosa povertà e grande
solitudine: una situazione che non adombra assolutamente più o
meno immaginari afflussi di pellegrini, che accorrono alla Verna per
venerare il luogo delle stimmate.
C'è invece una comunità religiosa - non sappiamo di quali
dimensioni - la cui sopravvivenza va salvaguardata ad ogni costo. E
qui sta la ragione vera e profonda per la quale il vescovo rilascia il suo
diploma e concede l'indulgenza, singolare per le circostanze
26
44Conciliorum oecumenicorum decreta, p. 263.
specifiche, non per l'entità, che si mantiene rigorosamente entro i
limiti fissati dal Lateranense IV. L'indulgenza serve ad incoraggiare i
fedeli non perché visitino un luogo particolarmente sacro, ma perché
portino o facciano portare elemosine a sostentamento dei frati. C'è nel
documento un altro dato interessante: i frati si recano per la questua
nelle località della diocesi e il diploma episcopale serve non solo da
lettera di presentazione e autenticazione dello status di appartenenza a
quella comunità, ma come sollecitazione ai prelati ecclesiastici per
un'accoglienza cordiale e affinché diano garanzie sui frati stessi ai
propri fedeli. Il vescovo esorta i prelati a sollecitare diligentius il
popolo ad essi affidato, affinché sia generoso con i frati. Vi è un altro
particolare interessante: l’invito ai fedeli a recarsi alla Verna. Nel
rivolgere tale invito, però, il diploma episcopale non fa alcun, benché
larvato, accenno a qualsiasi carattere di pellegrinaggio, che debba, o
possa assumere la salita a quel monte: manca persino quell'avverbio
devote, che viene normalmente utilizzato in simili casi. L'invito sembra
unicamente orientato a rompere l’isolamento che mette a repentaglio
la sopravvivenza della giovane comunità alvernina.
Quale motivo spinse il vescovo a interesarsi delle condizioni di
vita del gruppo minoritico residente alla Verna? Il presule Marcellino
era stato trasferito dalla cattedra episcopale di Ascoli a quella di
Arezzo nel 1236. In quegli anni egli appare affaccendato in impegni
ben più gravi e urgenti, preso com’è nel vortice del contrastato
rapporto con le emergenti forze comunali e con il riottoso gruppo dei
suoi vassalli, tra i quali c’erano anche i signori di Chiusi, cioè quel
27
dominus Orlandus de Clusio, che le fonti minoritiche del Trecento
presentano in qualità di donatore del monte della Verna a Francesco e
che il successore di Marcellino priverà del feudo per infedeltà al suo
signore; avremo modo di vederlo con maggiori dettagli. Il vescovo era
coinvolto a pieno tempo negli spinosi problemi dello scontro fra la
curia papale e Federico II, sul quale proprio in quell’anno 1239 si era
abbattuta la definitiva scomunica di Gregorio IX; Marcellino infatti
assieme al ruolo di vescovo d’Arezzo, deteneva quello di rettore della
Marca, dove era impegnato a contrastare le forze politiche aderenti
alla parte imperiale. In tale veste nel 1248 si troverà a comandare le
truppe pontifice sul campo di Osimo: sconfitto, verrà catturato e fatto
giustiziare dall’imperatore, come ribelle 45 . Per concretizzare il suo
impegno accanto al pontefice nella lotta contro l’imperatore e nel
tentativo di incanalare in tale direzione le forze della città e del
contado, era importante contare su alleati attivi e influenti, quali erano
appunto i frati Minori, forti di numerose e corpose presenze nella
diocesi di Arezzo: presso la città episcopale i Minori nel 1232 - pochi
anni prima dell’elezione di Marcellino alla cattedra episcopale aretina
- avevano trasferito il primitivo insediamento, inizialmente ubicato
forse presso l'ospedale de Ponte «nel borgo fuori città», a Monte del
28
45Sulle problematiche relative ai rapporti tra il comune aretino e la nobiltà locale vedi TABACCO, Nobiltà e potere ad Arezzo in età comunale, "Studi medievali", 3a serie, 15(1974), pp. 1-24; per quanto riguarda specificamente il vescovo Marcellino si veda PASQUI, Documenti per la storia della città di Arezzo nel medioevo, II, Firenze 1916, (Documenti di storia italiana, 14), IV, Croniche (secolo XIV-XV), Arezzo 1904, pp. 283-284; nel II volume della stessa opera sono riportati diversi documenti riguardanti Marcellino; per un sintetico profilo biografico vedi TAFI, I vescovi di Arezzo, Cortona 1986, pp. 69-70; di ulteriori informazioni sul vescovo aretino sono debitore a G.P. Scharf, che ha condotto una ricerca su Potere e società ad Arezzo nel XIII secolo (1230-1300) per la sua tesi di dottorato, che mi ha consentito di consultare.
Sole, a ridosso delle mura urbane 46 . Nel territorio diocesano di
Arezzo erano dislocate altre sedi minoritiche: si era ormai consolidato,
per volontà del ministro generale, frate Elia, il romitorio delle Celle,
presso Cortona, e si andavano strutturando altri insediamenti dei frati
Minori, come quello di Castiglion Fiorentino 47 . Non mancavano
consolidate presenze minoritiche, alle quali chiedere il sostegno contro
gli avversari; essi potevano, inoltre, essere punti di riferimento per
rianimare e controllare la vita e le rinnovate esperienze religiose dei
laici, allo scopo di incanalarle entro alvei sicuri e funzionali al
controllo da parte della gerarchia ecclesiastica.
In tale quadro cosa rappresentavano i fratres Minores in Saxo de
Verna morantes? Quello della Verna è l'unico insediamento minoritico
documentato nella prima metà del secolo XIII tra il Casentino e l’alta
valle Tiberina 48. L'accenno della lettera episcopale al fatto che essi si
aggirino per le questue risulta in proposito indicativo: oltre fornire
elementi per evidenziare aspetti particolari della vita dei componenti
la comunità alvernina, chiarisce il senso dell'intervento episcopale a
sollecitazione della generosità nei confronti di tali frati. Non si tratta
di un gruppo di solitari, che vivono la propria esperienza religiosa nel
29
46 Vedi in proposito NICO OTTAVIANI, Francesco d'Assisi e francescanesimo in territorio aretino (secc. XIII-XIV), Arezzo 1983, pp. 25-29.
47Per un quadro complessivo con i riferimenti alla relativa documentazione e bibliografia cf. ivi, pp. 47-60; per la problematica relativa al progressivo sorgere, svilupparsi e consolidarsi delle sedi minoritiche in Toscana mi permetto di rinviare anche al mio Per una discussione sui primi «insediamenti francescani» in Toscana, in La presenza francescana nella Toscana del '200, Firenze 1991 (Quaderni di vita e cultura francescana, 1) pp. 63-79.
48 Cf. NICO OTTAVIANI, Francesco d'Assisi e francescanesimo, pp. 52-53; l'altra sede minoritica, quella di Poppi, appare documentata solo a partire dagli anni Sessanta del secolo.
più assoluto isolamento: essi hanno, anzi si procurano numerose
occasioni di contatto con la gente in un ambito d’azione, che va ben al
di là dell'angusto spazio del romitorio, nei cui dintorni, per un raggio
abbastanza ampio, non vi sono altre sedi minoritiche. Essi, è vero, non
risultano impegnati in un'azione pastorale, se non quella che
indirettamente può derivare da una testimonianza di vita vissuta
all'insegna della sequela di Cristo nella povertà. Lo evidenzia
l'immagine usata in proposito nella parte centrale del documento (la
narratio) che, attingendo al più alto livello tra i modelli della
tradizione monastica, presenta i frati della Verna ad esempio vivente
del nudi nudum Christum sequi 49. Il senso dell’intervento episcopale è
tutto orientato a consentire la sopravvivenza di una testimonianza,
imprescindibile, o almeno estremamente importante in quanto polo di
riferimento per la vita cristiana dei fedeli di una vasta porzione della
diocesi. L'elemosinare dei frati, lungi dall'essere considerato una
fastidiosa intrusione nel contesto dei rapporti tra il clero e i fedeli e
un'attività anomala per chi si è dedicato alla vita contemplativa, viene
accolto dal presule come impegno coerente alla scelta di povertà, che
esige risposte positive da parte dei responsabili delle chiese e dei loro
fedeli. L'intervento episcopale induce a supporre diffidenze da parte
del clero e del popolo, proprio perché doveva funzionare da
documento di identificazione per i frati - che si può supporre
sollecitato dagli interessati - destinato a salvaguardarli da qualsiasi
30
49Su questo tema e sui relativi passi delle fonti patristiche e medievali vedi R. GREGOIRE, L'adage ascetique "nudus nudum Christum sequi", in Studi storici in onore di O. Bertolini, I, Pisa 1972, pp. 395-409.
angheria o da atteggiamenti di diffidenza e a garantire il loro stretto e
leale rapporto nei confronti della suprema gerarchia ecclesiastica
diocesana. S’intravedono dunque quelle difficoltà e situazioni di
precarietà, nelle quali si dibattevano le sedi eremitiche dei frati
Minori, a fronte del vivace attivismo dei loro insediamenti urbani, ma
viene rimarcata anche la loro funzionalità religiosa, riconosciuta
ufficialmente dall’autorità ecclesiastica.
La comunità della Verna era di recente costituzione, benché sulle
sue origini sia possibile formulare solo vaghe ipotesi. Possiamo
soltanto notare una coincidenza: il diploma episcopale venne
rilasciato nel contesto di prese di posizione contraddittorie, anzi
antitetiche all'evento straordinario della stimmatizzazione. Da almeno
un paio d'anni si era scatenata una polemica, senza esclusione di colpi,
sull'autenticità di tale evento, con ripercussioni ad ampio raggio: ne
siamo documentati anche per la Moravia. Ce lo testimoniano tre
lettere di Gregorio IX, una delle quali è indirizzata al vescovo di
Olomuc, un'altra ai superiori dei frati Predicatori, affinché prendano
provvedimenti nei confronti di un frate del loro Ordine, il quale era
giunto a minacciare la scomunica in nome del pontefice ai frati Minori
che avessero sostenuto la veridicità delle stimmate di Francesco; la
terza è rivolta a tutti i fedeli e assume il carattere di conferma
autorevole della verità dello straordinario fenomeno, presentato come
motivo precipuo della canonizzazione di Francesco 50 . È stata
tramandata anche una lettera dello stesso pontefice, che contiene la
31
50 M, pp. 8-13; cf. BF, I, pp. 211-214.
concessione d’indulgenze a chi visiti La Verna e le altre chiese
dell'Ordine il 17 settembre 51, ma si tratta evidentemente di un falso,
dato che la festa delle Stimmate (17 settembre appunto) venne istituita
da Benedetto XI nel 1304 52.
Quando il vescovo di Arezzo emette il suo diploma, il problema
delle stimmate aveva suscitato accesi dibattiti, che avevano coinvolto
non solo frati Minori e Predicatori, ma qualche esponente dell’autorità
ecclesiastica e lo stesso pontefice. Forse in tale contesto si costituì la
comunità alvernina, quasi una risposta a dubbi e polemiche; l'Ordine
minoritico, o almeno un gruppo di frati, mostra così di voler serrare le
fila attorno al luogo dell'evento, per conservarne e consacrarne la
memoria. Di tale evento, però, nel documento episcopale non vi è
neppure il più larvato accenno. Quello che conta per il presule aretino
- e anche per noi in questa sede - era la comunità minoritica stabilita
alla Verna. Una comunità che probabilmente proprio allora si stava
organizzando in strutture abitative stabili, dopo un probabile periodo
di soggiorni temporanei 53, che non hanno ovviamente lasciato alcuna
traccia, neppure, lo si è visto, nelle fonti biografiche di Francesco, a
differenza di quanto era avvenuto per altri eremi minoritici.
32
51 L’unica testimonianza su tale lettera pontificia è il tardivo riferimento di Marco da Treviso nel 1428 (cf. M, pp. 12-13).
52 Cf. WADDING Annales Minorum, p. 44; si noti che nelle tre lettere per La Verna Innocenzo IV non ricorda la festa delle Stimmate fra le varie, per le quali concede l'indulgenza..
53Arthur Fisher avanza l'ipotesi che in un primo tempo i frati non risiedessero alla Verna in periodo invernale e che le prime strutture di caratere conventuale siano state avviate negli anni Cinquanta del secolo XIII (FISHER, The observants' transformation of the convent of La Verna, "Collectanea Franciscana", 51(1981), pp. 107-149: 109-112, a nota 10 l’autore discute le ipotesi degli studiosi precedenti).
4. Un santuario in divenire
Negli anni immediatamente successivi al diploma episcopale
vanno sorgendo le prime costruzioni. Lo testimoniano una serie di
lettere di Innocenzo IV, a partire dalla Quoniam ut ait del 17 novembre
1250, indirizzata Universis Christi fidelibus 54 . Non mi dilungherò a
discutere se l'oggetto dell'indulgenza concessa dal pontefice fosse la
costruzione, o - come è stato sostenuto - l'ampliamento-
prolungamento della chiesetta preesistente, che sarebbe stata fatta
costruire da Francesco 55 . Accantonando il favoloso racconto dei
Fioretti e le tardive affermazioni di Mariano da Firenze che narrano
del santo, intento a costruire la chiesetta, prendiamo in considerazione
33
54M, pp. 14-15.
55Che si trattasse, non della prima costruzione, ma semplicemente di un ampliamento e prolungamento della preesistente chiesa di Santa Maria degli Angeli è vigorosamente sostenuto da MATTEUCCI, La Verna di frate Francesco e della sua prima gente poverella, Santuario della Verna 1964, pp. 137-143; alle pp. 94-97 le indicazioni delle fonti dalle quali si ricaverebbe la prova della costruzione della primitiva chiesa ad opera di Francesco; tali fonti sono Mariano da Firenze e «il simpatico racconto dei Fioretti»; viene persino fissata (pp. 103-108) la data di tale costruzione, 1216-1218, data che viene ricavata sulla base della ricostruzione secentesca di Monte Serafico della Verna nel quale N. Sig. Giesù Cristo impresse le Sacre Stimmate nel verginal corpo del Serafico P. S. Francesco, descritto dal R. P. E. Salvatore Vitale, Sacerdote, Predicatore della Regolare Osservanza de' Frati Minori della santa Provincia dei Sardigna, Firenze 1628, a proposito del quale basterà qui riproporre il giudizio del Cresi: «Salvatore Vitale pubblicò tra il 1626 e il 1630 quattro opere sulla Verna, che per la storia del santuario non sono un progresso, ma un regresso», salvo poi citarlo come unico riferimento a sostegno della costruzione della prima chiesa ad opera di Francesco (CRESI, Per la storia "Studi francescani", 59(1962), pp. 391-399, specificamente p. 391, note 6, 8; si noti che il Cresi stesso è ancor più netto nel suo giudizio negativo sul Vitale: «è provato, purtroppo, che il Vitale, più che ai documenti d'archivio si appoggiava alla propria fantasia», Supplemento al "Codice diplomatico della Verna e delle SS. Stimmate" di P. Saturnino Mencherini, "Studi francescani”, 60(1963), pp. 446-455: 444-448 ).
la lettera di Innocenzo IV; essa è il primo documento che accenni a
lavori edilizi alla Verna.
I termini del documento pontificio mi sembrano inequivocabili: «i
diletti figli ministro e i frati dell’Ordine dei Minori del santo monte
della Verna nella diocesi di Arezzo hanno iniziato a costruire, come ci
è stato riferito, una chiesa con altri edifici, adatti alle loro esigenze, in
cui poter celebrare le divine lodi» 56. Si tratta dunque dell’avvio della
costruzione della chiesa per il servizio liturgico e degli ambienti
conventuali. Con il consueto formulario, Quoniam ut ait, il pontefice
concede i soliti quaranta giorni di indulgenza ai fedeli che
concorreranno, affinché l'opera venga portata a termine. C'è nella
lettera pontificia qualcosa di più interessante: per la prima volta, viene
sottolineata in un documento la sacralità del monte, mons sanctus
Averne, benché non vi sia alcun riferimento specifico ai motivi di tale
sacralità, che dunque sembrerebbero dati per scontati e ben noti. Il
successivo documento rilasciato dal pontefice in data 3 dicembre dello
stesso anno 57 non sembra confermare tale ipotesi. Leggiamo la
narratio:
34
56 Dilecti filii minister et fratres Ordinis Fratrum Minorum montis sancti Averne Aretine diecesis, ibidem, sicut accepimus, ecclesiam cum aliis edificibus suis usibus opportunis ceperunt construere, in qua divinis possint laudibus deservire; il Matteucci propende per una preesistente costruzione in muratura di elementari strutture abitative per i frati, contro il parere dello stesso Mariano da Firenze (MATTEUCCI, La Verna, pp. 149-152; cf. anche FISHER, The Observants' transformation, pp. 109-110: con discussione su chiesetta fatta costruire da Francesco).
57 M, p. 216; questo documento è stato edito per la prima volta da F.A. DE LATERA, Ad Bullarium Franciscanum ... supplementum, Romae 1780 (rist. anast. USA Nabu Press. 2011), pp. 25-26.
«Benché tutti i luoghi del vostro Ordine siano sotto la protezione
della sede apostolica, tuttavia noi portiamo un particolare affetto al
luogo nel quale voi vi siete dedicati al servizio di Dio; questo
soprattutto perché il beato Francesco, istitutore del vostro Ordine,
quando era ancora rivestito di carne mortale, dimorava volentieri
in quel luogo, lontano dall’abitato, per servire il Signore» 58.
Nessun benché minimo riferimento alla stimmatizzazione, in
compenso il documento sembra indicare un'assidua frequentazione
della Verna da parte di Francesco. Tale il motivo esplicito della
concessione di una speciale protectio apostolica. Dunque il luogo è
particolarmente sacro e con esso il pontefice stabilisce un legame
privilegiato sulla base di una ormai consolidata tradizione di soste
(frequenti e prolungate? libenter morabatur) di Francesco. Il pontefice
due giorni dopo invia dilectis filiis fratribus Ordinis Minorum
commorantibus apud sanctum montem Arverne una terza lettera, con la
quale concede i soliti quaranta giorni di indulgenza a chi ad locum
ipsum cum devotione accesserit in occasione della "solennità" di san
Francesco 59.
35
58 Licet cuncta Ordinis vestri loca generaliter sub Apostolica protectione consistant, ad locum tamen in quo apud sanctum montem Arverne divino mancipati estis obsequio, ex eo precipue specialem habentes affectum, quod beatus Franciscus vestri Ordinis institutor, adhuc carne mortalitatis indutus, in ipso loco ab hominum habitatione remoto, libenter ad serviendum domino morabatur. (ibid.)
59M, p. 16; la data del Mencherini, 3 dicembre, è corretta in 5 dicembre da THOMSOM, Checklist of papal letters relating to the Orders of St. Francis. Innocent III–Alexander IV, Roma 1971, p. 89.
Tre lettere emesse dalla curia pontificia a favore dello stesso luogo
nel giro di poco più di quindici giorni possono sembrare un fatto
eccezionale, ma si tratta di riproduzioni in originale dello stesso
documento, indirizzate a destinatari diversi: a tutti i fedeli la prima
lettera, che perciò si configura come una vera e propria enciclica; la
seconda ai frati Minori; la terza ai frati della Verna. Anche l'oggetto
delle decisioni contenute nella dispositio è diverso: indulgenza per la
costruzione della chiesa e, in seguito, per chi si rechi alla Verna nella
festa di san Francesco, concessione di una particolare protectio
apostolica ad un luogo considerato singolarmente sacro. Nulla di
eccezionale per quanto riguarda le lettere del 17 novembre e del 5
dicembre, che si inseriscono perfettamente nel quadro dei documenti
emessi dalla cancelleria pontificia di Innocenzo IV, particolarmente
attiva a favore delle chiese dei frati Minori e Predicatori 60. Singolare
risulta invece il documento del 3 dicembre, in quanto sancisce un
rapporto di "predilezione" da parte del pontefice nei confronti di un
luogo consacrato dalla frequente presenza di Francesco. Proprio per
questo stupisce l'assenza di qualsivoglia riferimento allo straordinario
fenomeno della stimmatizzazione.
Prima di trarre conclusioni bisogna prendere in considerazione un
altro documento: l’8 settembre 1253 Rinaldo di Ienne, vescovo d'Ostia
e cardinale protettore, cioè rappresentante ufficiale del pontefice per
36
60Rimando in proposito a DEL FUOCO, Indulgenze papali e ordini mendicanti nel secolo XIII: prime note, in «Misericorditer relaxamus». Le indulgenze fra teoria e prassi nel Duecento, a cura di L. PELLEGRINI e R. PACIOCCO, “Studi medievali e moderni” 3, 1(1999), pp. 101-148; per un controllo più dettagliato vedi le tabelle in appendice allo stesso contributo.
l'Ordine minoritico, rilasciava una lettera 61 rivolta Universis ministris,
custodibus et guardianis ac ceteris fratribus Ordinis fratrum Minorum. Tale
documento si poneva in ideale continuità con la lettera d’Innocenzo
IV del 3 dicembre 1250, in cui era stata proclamata la sacralità del
monte della Verna. Nella missiva di Rinaldo, però, tale sacralità
veniva posta, per la prima volta, in esplicito e diretto collegamento
con l'impressione delle stimmate, che nel documento assumevano un
significato salvifico per tutta la Chiesa, anzi per l’intera società,
aggravata da vecchiaia e minacciata da imminente rovina: extremo iam
instante seculi senescentis interitu. Il misterioso evento era rievocato con
espressioni di gioiosa esaltazione, funzionali a scoraggiare qualsiasi
tentativo di manomissione, o peggio di abbandono da parte dei frati
del sanctum Alvernae montis locum. La sacralità del luogo, e quindi la
sua intangibilità, veniva estesa a tutto ciò che al luogo apparteneva,
con il divieto nei confronti di ogni forma di «abbandono, riduzione,
asportazione senza un mandato speciale della sede apostolica».
L'intervento del cardinale protettore dell'Ordine sembra indicare un
momento difficile per la comunità minoritica alla Verna. Lo conferma
Salimbene: «credo che quel luogo sarebbe stato abbandonato, come mi
disse, se non fosse stato tenuto aperto a suo favore» (Credo quod locus
ille derelictus fuisset, sicut dixit mihi, nisi beneficio eius fuisset retentus); il
cronista, che sta parlando di frate Lotario, già responsabile gerarchico
della custodia di Pisa – la circoscrizione territoriale dei frati Minori
che faceva capo al convento pisano ed era inclusa nella provincia di
37
61M, pp. 16-17.
Toscana - riferisce fatti collocabili tra il 1247 e il 1265 62. Il momento di
crisi della comunità della Verna si colloca del resto in un periodo di
grave difficoltà per gli eremi minoritici, che viene di volta in volta
superato quando una personalità di rilievo per sua scelta, o per
imposizione da parte dell'autorità dell'Ordine, pone la propria dimora
nell'uno, o nell'altro di tali eremitori 63.
Nel contesto di tale situazione, e del riesplodere della polemica
sulle stimmate 64, per la prima volta l'autorità ecclesiastica stabilisce
ufficialmente il raccordo tra l'evento delle stimmate e La Verna:
Rinaldo di Ienne, divenuto papa col nome di Alessandro IV, a pochi
mesi dalla sua elezione al soglio pontificio, l’8 aprile 1255 farà
riconfermare ad verbum (alla lettera) dalla cancelleria pontificia il
documento che aveva fatto redigere nelle vesti di cardinale protettore
dell'Ordine minoritico 65. Il documento, nella forma in cui si presenta
38
62 Il cronista nel ricordare fra Lotario, dice Qui antiquitus fuerat custos meus in Pisana custodia: il 1247 è l'ultimo anno della residenza di Salimbene a Pisa; in riferimento al 1265, l'anno del pellegrinaggio del cronista ad Assisi, in ritorno dal quale egli visita La Verna, Salimbene soggiunge che frate Lotario vivebat adhuc et abitabat ibi infirmus et senex (SALIMBENE DE ADAM, Cronica. Testo latino a cura di Giuseppe Scalia traduzione di Berardo Rossi, Parma, 2007 p. 1538).
63Basti pensare a fra Elia per le Celle di Cortona, o a Giovanni da Parma per Greccio.
64Sono del 1255 due interventi di Alessandro IV contro coloro che polemizzano nei confronti delle stimmate (M, pp. 20-23); sulla polemica a proposito delle stimmate vedi PACIOCCO, Il papato e i santi canonizzati degli Ordini mendicanti. Significati, osservazioni e linee di ricerca (1198-1303), in Il papato duecentesco e gli Ordini mendicanti. Atti del XXV Convegno internazionale (Assisi 13-14 febbraio 1998), Spoleto 1998, pp. 319-320; *VAUCHEZ, Le stimmate di san Francesco; FRUGONI, Francesco e l'invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e a Giotto, Torino 1993, pp. 280-284.
65 M, pp. 17-20, che discute anche i problemi paleografici del documento; vedi in proposito anche CRESI, Supplemento, pp. 447-448. Questo documento e i successivi, dei quali in seguito proporrò un’analisi critica, sono conservati nell’Archivio della Verna, purtroppo senza un ordine di collocazione.
allo stato attuale, pone notevoli problemi paleografici e diplomatistici,
che qui non possiamo esimerci dall'affrontare. Sulla provenienza dalla
curia pontificia del supporto scrittorio non vi può essere dubbio; lo
dimostrano i caratteri estrinseci: il tipo di pergamena, ma soprattutto
la plica, cioè il breve tratto di pergamena ripiegato in calce, in cui sono
praticati due fori, attraverso i quali passa il filo serico a cui è appeso il
sigillo di papa Alessandro, tuttora conservati. La scrittura, però, e
almeno parte del contenuto non hanno nulla da vedere con la
cancelleria pontificia del secolo XIII. Fortunatamente il documento
originale fu riprodotto a stampa prima di venire manomesso. La
prima di tali riproduzioni risale al 1513: la lettera pontificia venne
dunque falsificata dopo tale data. È di assoluta evidenza a primo
colpo d’occhio, quanto il Mencherini ha già segnalato un ottantina
d’anni fa: la pergamena è stata «erasa, riscritta e interpolata». Il
motivo dell'operazione risulta evidente dalle aggiunte rispetto al
testo. A parte l'enfatica interpolazione del paragone con i monti sacri
del testo biblico, l'Horeb e il Golgota, al falsario interessava
soprattutto l'aggiunta finale, nella quale viene attribuita al pontefice la
proibizione di manomettere in alcun modo i beni ormai cospicui (nel
secolo XVII) di spettanza della comunità minoritica della Verna e di
tagliare o asportare legna dai boschi che circondano il monte 66. Tale
aggiunta alla fine del documento rende ancor più impresentabile la
falsificazione, in quanto costrinse il falsario, che evidentemente non
39
66Tali aggiunte sono evidenziate in corsivo nell'edizione del Mencherini (pp. 19-20), al quale rimando per i riferimenti alle riproduzioni a stampa, segnalati in calce alla sua trascrizione.
aveva ben calcolato lo spazio, a disallineare la scrittura, riducendo
notevolmente l'intervallo fra le righe e distorcendo, di conseguenza,
l’allineamento. La grafia, nonostante qualche malaccorto sforzo
imitativo, denuncia che l'autore di tale falsificazione è lo stesso che
redasse il già ricordato falso dell'Addio alla Verna.
Se si sfronda la lettera papale in questione dalle aggiunte del
falsario, risulta con chiarezza che essa è la riproduzione letterale del
documento emesso a favore della Verna due anni prima dallo stesso
autore, quando era ancora cardinale vescovo di Ostia. E' dunque con
Alessandro IV che si ha l'ultimo e definitivo passo nel percorso della
progressiva trasformazione della Verna, da parte della suprema
autorità ecclesiastica, come luogo di culto sacro alla memoria delle
stimmate di Francesco. Anche il vescovo di Arezzo in una lettera
dell'anno successivo, che ricalca sostanzialmente le disposizioni del
documento episcopale del 16 giugno 1239, riproporrà i temi della
ormai definitiva consacrazione del monte alle stimmate del santo di
Assisi 67.
5. Una data "storica" e la storia di un falso
La data dell’8 settembre 1253, allorché Rinaldo d'Ostia inviava la
sua lettera ai responsabili dell’Ordine dei frati Minori, segnava una
svolta decisiva per la storia del monte, in quanto lo trasformava da
umile e forse oscuro eremitorio francescano in un santuario e meta di
pellegrinaggio. In quella precisa data iniziava dunque una nuova
40
67M, pp. 29-31, nota 1.
storia per La Verna, o meglio il pluriennale e progressivo processo di
sacralizzazione giungeva alla sua piena maturazione attraverso la
sanzione ufficiale della dedicazione della Verna a santuario consacrato
alla memoria del santo di Assisi e all'evento straordinario della sua
stimmatizzazione.
Tale data segnava profondamente anche la memoria della
comunità minoritica in un gioco di coincidenze che non paiono
fortuite, ma che esigono una migliore definizione. L’8 settembre si
celebrava la festa della Natività di Maria, una ricorrenza liturgica che
si poneva nel bel mezzo di quel periodo, nel quale i primi biografi , a
partire dal secondo testo agiografico di Tommaso da Celano (il
Memoriale), narrano che Francesco si preparava alla festa di san
Michele (29 settembre) con una speciale quaresima che iniziava con
l’altra festa mariana, quella dell’Assunzione. Il Celanese, però, nel
racconto dell’evento delle stimmate - inserito nel cosidetto Tractatus de
miraculis che è probabilmente un’aggiunta alla seconda redazione del
Memoriale 68 - riprende alla lettera l’unico e generico riferimento
cronologico, che aveva già indicato nella Vita beati Francisci: «due anni
prima che rendesse al cielo il suo spirito» 69 . La collocazione
dell'evento delle stimmate nella quaresima di S. Michele si andò
affermando solo in seguito e venne accolta e definitivamente fissata,
41
68 Cf. F. ACROCCA, Due diverse redazioni del «Memoriale in desiderio animae» di Tommaso da Celano? Una discussione da riprendere, “Collectanea franciscana” 74 (2004), pp. 5-21 e vedi ora Thomas de Celano, Memoriale. Editio critico-synoptica duarum redationum ad fidem codicum manuscriptorum, curaverunt F. Acrocca A. Horowsky, Roma 2011.
69 I tempi della quaresima di S. Michele sono indicati nel Memoriale, n. 197, (FF, n. 785); per la ripresa della generica datazione delle stimmate confronta il Tractatus de miraculis ( n. 4, FF, n. 829) con Vita beati Francisci n. 94 (FF, n. 94).
con ulteriori precisazioni cronologiche, nel 1260 nella biografia di
Bonaventura da Bagnorea, nella quale egli fonde i due diversi
passaggi della prima biografia celanese, quello relativo alla
consuetudine di Francesco di praticare la quaresima di San Michele, e
il racconto della stimmatizzazione. Per l’evento delle stimmate,
inoltre, il Bagnorese prende come riferimento cronologico un’altra
festa liturgica: l’esaltazione della croce (quodam mane circa festum
Exaltationis sancte Crucis) 70.
È interessante notare come all'8 settembre – data dell’emissione
della lettera di Alessandro IV - viene collocata la donazione della
Verna a Francesco da una fonte, che, a quanto mi risulta, non è finora
stata presa in considerazione, se non in modo assolutamente
marginale: il Catalogus Generalium ministrorum Ordinis Fratrum
Minorum. Il codice Laurenziano (già di S. Croce) Sin. Plut. XXVII
nell'introdurre il Catalogus ha, fra le altre, la seguente annotazione:
«nell’anno del Signore 1218 venne accettato il luogo del sacro monte
della Verna nella festa della natività della gloriosa Vergine» (Anno domini
MCCXVIII acceptus fuit locus sacri montis Alverne in nativitate Virginis
Gloriose) 71 . La redazione del Catalogus risale al generalato di fra
Michele da Cesena (1316-1322), dato che il codice in questione ha
come ultima data il 1316, anno nel quale fra Michele venne eletto alla
42
70 Legenda maior, XIII, 1, (FF, n. 1223).
71Catalogus Generalium ministrorum Ordinis Fratrum Minorum, ed. O. HOLDER-EGGER, Hannoverae 1913 (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, 33), p. 657.
dirigenza dell’Ordine 72 . Salta immediatamente all'occhio sia la
convergenza cronologica dell’8 settembre, con la lettera di Rainaldo
d’Ienne/Alessandro IV, sia la discrepanza dell’anno, 1218, rispetto
alla datazione, 8 settembre 1213, a cui viene fissata la donazione della
Verna a Francesco da parte di Orlando conte di Chiusi nel noto e
discusso documento, nel quale appare registrata la conferma di tale
donazione da parte dei figli del nobile clusino. Il fatto che la nota
introduttiva del Catalogus registra gli elementi della datazione in
lettere romane potrebbe spiegare la discrepanza nell’indicazione
dell’anno; è stata, infatti, avanzata l'ipotesi, pur con molta cautela, che
nel codice Laurenziano sia stata aggiunta per errore del copista, o
redattore, una V che avrebbe trasformato il MCCXIII dell’atto di
conferma della donazione in MCCXVIII. Sulla consistenza, o meno, di
tale ipotesi torneremo in seguito. Annotiamo subito che si potrebbero
supporre altri errori nella trascrizione di tale elemento della
datazione, se lo si confronta con alcuni documenti, che avremo modo
di esaminare. Per giungere a conclusioni meno ipotetiche dobbiamo
innanzitutto procedere ad un’attenta analisi del documento di
conferma della donazione, sul quale il Mencherini aveva avanzato a
43
72 Per i problemi relativi a questa e alle successive redazioni del Catalogus vedi ibid., pp. 653-657.
suo tempo più di una riserva, avendone notato alcune incongruenze
paleografiche e diplomatistiche 73.
Nell’atto di conferma della donazione le singole parti del
formulario, consuete per tale tipologia documentaria, trovano perfetto
riscontro in un altro documento: la copia autenticata di
un'imbreviatura notarile (cioè il documento originale), conservata
nell'archivio della Verna. Nella copia dell’imbreviatura i quattro figli
di Orlando di Chiusi - Orlando, Cungio, Bandino e Guglielmino - si
impegnano solidalmente alla restituzione della dote di Serafina,
moglie di uno di loro, qualora il marito dovesse morire prima di lei 74.
I nomi dei quattro fratelli ricorrono come attori anche nel documento
di conferma della donazione a Francesco del monte della Verna. La
data cronica all'inizio dei due documenti è la stessa: Anno Domini
millesimo ducentesimo septuagesimo quarto, indictione 2a, Gregorio X papa
residente, nemine imperante, die lune nona mensis iulii; anche la data
topica che conclude i due atti è corrispondente, pur con qualche
44
73M, pp. V-VI, nota 1; dubbi sull'autenticità esprime anche PAGNANI, I viaggi di S. Francesco d'Assisi nelle Marche, Milano 1962 (Deputazione di Storia patria nelle Marche. Studi e testi, 2), p. 42; sottolinea le riserve del Mencherini anche OCTAVIANUS A RIEDEN, De Sancti Francisci Assisiensis Stigmatum susceptione: disquisitio historico-critica luce testimoniorum saeculi XIII, "Collectanea franciscana", 34(1964), pp. 5-62: 21-22, nota 173, che comunque ritiene verisimile la concessione in uso del luogo da parte del conte Orlando; in difesa dell'autenticità si era precedentemente schierato LAZZERI, L'atto di conferma della donazione della Verna (1274), in Ricordo del settimo centenario, pp. 7-29. Un riassunto della controversia è in MATTEUCCI, Da messer Orlando di Chiusi il dono del monte Verna e due edifici sacri sulla scogliera delle Stimate, Santuario della Verna (Arezzo) 1964, pp. 19-22; alle pp. 26-35 vengono ribadite le "prove" a favore dell'autenticità del documento addotte dal Lazzeri, dal quale sono riportate anche le più antiche testimonianze sull'esistenza del documento stesso; non si pronuncia CRESI, Supplemento, che però alle pp. 448-449 avanza delle obiezioni alle riserve del Mencherini.
74 Edito in M, pp. 39-40.
significativa variante: «predicta omnia et singula acta fuerunt in
Clusio palatio dicti comitis Orlandi et fratrum» (in corsivo le aggiunte
del documento di conferma della donazione rispetto alla copia
dell'imbreviatura notarile); i nomi dei testimoni presenti all’atto di
conferma corrispondono perfettamente a quelli della copia notarile
del’imbreviatura, mentre si nota una variazione nel nome del notaio.
Sembrano dunque due documenti perfettamente coevi - giorno, mese,
anno (9 luglio 1274) - fatti redigere dagli stessi attori, i quattro figli di
Orlando, e redatti nel medesimo luogo alla presenza degli stessi
testimoni. Nel documento di conferma della donazione si notano,
però, alcune differenze, a partire dal dato identificativo del primo dei
quattro fratelli, indicato nel documento di restituzione della dote
semplicemente come: «Orlando di un certo signor Orlando di
Chiusi» (Orlandus cuiusdam domini Orlandi de Clusio), mentre nella
conferma della donazione diventa: «Orlando de Catanis del fu signor
Orlando, conte di Chiusi» (Orlandus de Catanis quondam domini Orlandi
comes de Clusio). Si noti l’aggiunta del titolo di “conte”, come nella
data topica. La dose dei titoli è rincarata nella narratio, il passaggio
dove i quattro fratelli ricordano l’antefatto della conferma, cioè il dono
del monte della Verna a Francesco, elargito libere et absque ulla
obbligatione dal loro padre, che viene presentato come: «Orlando conte
di Chiusi, milite palatino dell’imperatore» (Orlandus, Clusii comes,
imperatoris miles palatinus).
Il confronto tra i due documenti segnala nell’atto di conferma
della donazione altre vistose differenze di carattere diplomatistico
45
rispetto all’atto d’impegno di restituzione della dote: innanzitutto il
nome del notaio è Amicuccius filius Petri Amicucci, mentre nel
documento di conferma si legge Amicuccius filius ser Amici 75 . Si
notano altre anomalie: nell’atto di conferma della donazione della
Verna a Francesco, Amicuccio si firma come rogatario, il notaio che
procede direttamente alla redazione del documento, mentre nell’atto
riguardante la restituzione della dote lo stesso Amicuccio è solo
l’estensore della copia autenticata, redatta in un secondo tempo,
dell'imbreviatura di un altro notaio, Giovanni, l’effettivo rogatario di
quell’atto.
I titoli altisonanti attribuiti ad Orlando nel documento di
conferma della donazione non possono che mettere in guardia: un atto
notarile autentico non avrebbe consentito l'usurpazione del titolo di
comes, che, a quanto pare, venne acquisito dai signori di Chiusi solo in
epoca successiva 76 , tanto meno il notaio avrebbe attribuito
l’onorificenza di imperatoris miles palatinus; né l'uno, né l'altro titolo
infatti ricorrono nel documento originale relativo a Serafina.
Interessante in proposito un diploma episcopale del 29 ottobre 1261:
46
75Cf. la sottoscrizione del notaio nei due documenti, riprodotti in M, pp. 38-40 e vedi la discussione del problema del notaio ibid., pp. V-VI, nota 1.
76 Sull'origine e lo sviluppo della consorteria nobiliare dei signori della Verna vedi DELUMEAU, Arezzo espace et sociétés 715-1230. Recherches sur Arezzo et son contado du VIIIe au debut du XIIIe siècle, Roma 1996, pp. 198, 300, 446, 574-575, 952, 962, 1024, 1239; a p. 140 l'autore ricorda, senza però citare il documento, la donazione della Verna a Francesco da parte dei nobili della "massa Verona", un'identificazione, che pone qualche problema, tuttora irrisolto. Ringrazio Gian Paolo Scharf per le segnalazioni e per avermi fatto notare che il titolo di conte nella zona è inusitato nel secolo XIII per chi professa di vivere lege romana, come affermano nel documento autentico i figli del dominus Orlando. Al giovane studioso devo anche altre preziose informazioni in proposito.
in esso il nobilis dominus Orlandus de Cluse, padre degli attori del
documento del 1274, e i suoi due fratelli, Nicola e Alberto, risultano
vassalli del vescovo di Arezzo, Guglielmino, e non hanno in alcun
modo il titolo comitale. I loro rapporti con il vescovo sono tutt'altro
che improntati a lealtà. Le denunce del loro signore sono pesanti e
configurano un'aperta ribellione: essi non solo si rifiutano di prestare
al vescovo i servizi dovuti in forza del giuramento di fedeltà, ma
hanno depredato i possessi episcopali e fatto prigionieri i vassalli del
prelato Aretino. In una parola c'è guerra aperta tra il presule e i tre
fratelli, di cui Orlando è il rappresentante e il principale responsabile
della ribellione 77 . La vicenda si concluderà l’anno successivo con
l’assedio da parte del vescovo, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio
1262, e la capitolazione del castello di Chiusi, roccaforte della famiglia
ribelle. Siamo ormai a quasi cinquant’anni dalla presunta donazione
della Verna a Francesco. Orlando era in grado di compiere rischiose
azioni militari e tentare di resistere all’esercito del vescovo suo
signore; difficile immaginarlo come un vecchio, quale dovrebbe
essere, se nel 1213 fosse già stato titolare della supposta contea e
avesse potuto liberamente disporre dei propri beni.
Soffermiamoci un momento su questa vicenda. Il vescovo a cui
Orlando e i fratelli si ribellano è Guglielmino di Gualtieri,
appartenente alla potente consorteria degli Ubertini. Il presule è una
delle figure più complesse e significative nella storia dell’episcopato
47
77 Il documento è trascritto in PASQUI, Documenti per la storia della città di Arezzo nel medioevo, II, Firenze 1916, (Documenti di storia italiana, 14), IV, Croniche (secolo XIV-XV), Arezzo 1904, pp. 358-359.
aretino del secolo XIII, non solo per il suo ultraquarantennale
episcopato (1248-1289) e per l’impegno di definire e difendere i diritti
vescovili, giovandosi all’occorrenza dell’aiuto militare del comune,
ma anche per l’impegno pastorale nella riorganizzazione del clero e
del laicato della città episcopale; a questo scopo si giovò dei frati
Minori, verso i quali fu largo di favori e protezione, anche contro le
recriminazioni del clero, che cercava di contrastare i religiosi
nell’esercizio dei ruoli della cura animarum. Fu proprio questo vescovo
a consacrare nel 1260 la chiesa di Santa Maria degli Angeli alla Verna 78.
I rapporti di Guglielmino degli Ubertini con la consorteria dei
signori chiusini si collocano nel contesto dello scontro tra interessi
diversi e contrastanti: i diritti episcopali, la pressione del comune di
Arezzo sui poteri signorili del contado e le mire espansionistiche, o
difensive, dei signori di Chiusi; la parte vincente non poteva che
essere, nel caso, quella del vescovo, che si trovava in posizione di
forza, in quanto signore feudale dei Cattani, la famiglia di Orlando. Il
presule, inoltre, poteva contare sull’alleanza con il comune nella fase
della sua maggiore espansione e della progressiva affermazione del
proprio potere sui feudatari del contado. In tale situazione diviene
ancora più improbabile la conferma della donazione da parte dei figli
di Orlando, che, in quanto infedeli al loro signore, erano stati privati
del feudo nel quale era situato il monte della Verna. La donazione del
48
78 Vedi in proposito LAZZERI, Guglielmino degli Ubertini; per i rapporti con i frati Minori vedi pp. 160-163.
luogo ai frati Minori avvenne dunque con altre modalità e in un
diverso gioco di poteri nel Casentino.
Il racconto della “donazione” della Verna a Francesco è narrato
per la prima volta negli Actus beati Francisci, ripreso e volgarizzato nei
Fioretti. Si noti però che nelle due fonti ad Orlando di Chiusi è
attribuito il titolo di dominus (messer nei Fioretti) e non di comes 79 .
Dunque nel terzo/quarto decennio del Trecento - quando furono
redatti gli Actus e quando, di lì a pochi decenni, il testo degli Actus
venne volgarizzato nei Fioretti - i signori di Chiusi non avevano
ancora il titolo comitale loro attribuito nel documento in discussione.
Si noti che al momento della redazione dei Fioretti era ormai passato
quasi un secolo dalla data della supposta conferma della donazione
della Verna a Francesco da parte dei figli di Orlando, nella quale, non
solo si attribuisce al nobile Orlando e ai suoi figli un titolo che i nobili
di Chiusi non avevano all'epoca a cui sono riferiti gli avvenimenti e
neppure in seguito, almeno fino agli anni Settanta del secolo XIV,
quando furono redatti i Fioretti, ma si fa risalire al 1213 un atto di
donazione che, con tutta probabilità il "conte Orlando" in questione
non poteva compiere.
A questo punto dobbiamo evidenziare i processi mentali che
hanno indotto la differenza nel nome e nella funzione dei notai nel
documento di conferma della donazione rispetto a quello in cui gli
stessi attori, i figli di Orlando, si impegnano alla restituzione della
dote: l’autore o trascrittore del presunto atto di conferma ha operato
49
79Actus beati Francisci, pp. 174-178, FF, pp. 2104-2105.
una confusione di persone, scambiando per rogatario Amicuccio, che
invece nel documento d’impegno della restituzione della dote appare
come l’estensore di una copia autenticata 80. La cattiva lettura dei dati
identificativi del notaio che aveva autenticato tale copia, cioè
l’interpretazione di ser come abbreviazione di Petri (Amicuccius filius
Petri Amicucci, invece di Amicuccius ser Amici dell’atto che ha per
oggetto la dote di Serafina)81 ha indotto un duplice errore: il signor
Amico, padre del notaio del borgo di Campli che ha prodotto la copia
dell’imbreviatura, è diventato Pietro Amicuccio. Si noti che Amicus
notarius de burgo Campli, il padre dell’Amicuccio, l’autenticatore della
copia che ha costituito il nostro elemento di confronto, appare come
rogatario di un atto, risalente al 14 dicembre 1271 e oggi conservato
nell’archivio della Verna.
Troppe le anomalie per dare fede a questo documento, che, oltre
tutto, conferma una donazione, che avrebbe trovato totalmente
estraneo, anzi contrario Francesco d'Assisi, soprattutto per l’entità
della donazione e per le condizioni, che rendevano effettivamente
proprietario l’Assisiate: dedit, donavit, concessit libere et absque ulla
obbligatione. Frate Francesco era troppo coerente e intransigente nella
difesa di una povertà, che aveva come espressione primaria
l’espropriazione totale e irreversibile. Siamo perciò di fronte a un
falsario, il quale non fa che ricalcare, parola per parola il documento
50
80Le anomalie a proposito del notaio, benché da un altro punto di vista, erano già state notate dal Mencherini, cf. M, pp. V-VI, nota 1; osservazioni puntuali in proposito sono in BUGHETTI, Settimo centenario, pp. 374-375.
81Sono grato ad Attilio Bartoli Langeli, che ha visionato con me le pergamene e che mi ha condotto a tali conclusioni.
genuino che aveva sottocchio, quello appunto fatto redigere dai
quattro figli di Orlando il 9 luglio 1274. Il calco sembrerebbe perfetto:
il falsario, per non commettere errori, traspone nella sua falsificazione
tutti gli elementi relativi alla datazione e riproduce fedelmente i nomi
dei testimoni, benché ometta di trascrivere olim a proposito di uno dei
testimoni stessi: Guidone olim domini Raineri. Altra differenza rispetto
alla copia autenticata quel quondam, invece di quidam: un errore di
lettura da parte del falsario, che finisce così per dare come già defunto
il supposto “conte” Orlando di Chiusi, mentre costui risulta ancora
ben vivo sia nell’ imbreviatura originale, sia in un documento rogato
due anni e mezzo prima (14 dicembre 1271) dai quattro fratelli su
consenso del loro padre.
L’autore del falso aveva i suoi buoni motivi nel confezionare la
falsificazione: attribuire la donazione ad Orlando, insignito con il
titolo comitale, faceva buon gioco per giustificare la munificenza di un
dono, che di nuovo riaffermava - conferendo un valore sacrale, col
chiamare in causa direttamente san Francesco - i contestati o, almeno,
poco rispettati diritti che i frati nel frattempo avevano acquisito su
tutto il monte della Verna. L'impressione netta - ma ormai è ben più
che un'impressione - è, infatti, che si tratti di un falso intenzionale,
come dimostrerebbe l'impegno per dare un aspetto antico al supporto
scrittorio. Si tratta appunto di una pergamena anticata, sulla quale
vengono riprodotti gli elementi ricavati da un documento autentico,
cercando di imitarne anche la scrittura.
51
L'indagine andrebbe ulteriormente approfondita e ampliata, per
giungere a definire il tempo in cui venne prodotta la falsificazione e
per scoprire eventualmente il falsario. Il sospetto è che la pergamena,
sulla quale il falso è riprodotto e dalla quale dipendono le copie
successive 82 , sia effettivamente l'originale della falsificazione 83 . In
proposito sarebbe interessante procedere all'analisi delle scritture dei
frati del Seicento, tuttora conservate presso l'archivio della Verna. Per
il momento il sospetto cade sull'autore del Monte serafico della Verna,
Salvatore Vitale, che, nella sua opera stampata a Firenze nel 1628, non
solo mostra di conoscere e per primo riproduce e utilizza questo e altri
documenti falsi, o falsificati, ma nella trascrizione del documento
autentico del 1274 (quello relativo alla dote di Serafina) commette lo
stesso errore, in cui incorre il falsario nel riprodurre i dati relativi al
notaio Amicuccio. Il Vitale fa un altro errore più sotto, dove invece di
ser Iohannis trascrive Petri Iohannis84: è una conferma della cattiva
lettura a cui abbiamo accennato sopra a proposito del documento di
conferma della donazione della Verna a Francesco: ser letto come
abbreviazione di Petri. Se il sospetto si rivelasse fondato, il Vitale
aveva buon gioco, in quanto si basava su una tradizione risalente ad
52
82Vedi in proposito quanto annota il Mencherini (M, p. V).
83Lodevole l'impegno di Zeffiro Lazzeri per rintracciare le più antiche testimonianze documentarie dell'esistenza del documento in questione, da lui considerato autentico. Pur con tale impegno, che ha senz'altro il merito di fornire elementi per ricostruire la storia della trasmissione del nostro documento (L'atto di conferma, pp. 87-101), il Lazzeri non riesce ad essere persuasivo nel sostenerne l’autenticità.
84Vedi in proposito la trascrizione del documento in Monte Serafico della Verna nel quale N. Sig. Giesù Cristo impresse le Sacre Stimmate nel verginal corpo del Serafico P. S. Francesco, descritto dal R. P. E. Salvatore Vitale, Sacerdote, Predicatore della Regolare Osservanza de' Frati Minori della santa Provincia de’ Sardigna, Firenze 1628, pp. 22-23.
almeno un settantennio prima, relativa all'esistenza di uno scritto che
documentava la donazione della Verna a Francesco; di tale tradizione
si ha una prima, seppure molto vaga, testimonianza storiografica nel
Nuovo dialogo della Verna di Agostino di Miglio, pubblicato a Firenze
nel 1568, ma forse si può risalire fino al 1447, sulla base di una
relazione dei magistrati dell'Arte della Lana di Firenze, nella quale si
fa riferimento a una sentenza del 13 gennaio 1447 a favore dei frati
della Verna, in lite con la comunità di Chiusi 85 . Non è certo da
escludere che proprio nel contesto di tale vertenza sia stato fabbricato
il falso documento, di cui avremmo la prima trascrizione nell’opera
del Vitale.
6. Una datazione problematica
Nella falsificazione la data della donazione della Verna a
Francesco da parte dell’ormai evidentemente ipotetico “conte” è
fissata all’8 maggio 1213. Tale datazione è frutto di un’invenzione, o
meglio di un elaborato calcolo che certamente rimanda alle fonti che il
falsario ha utilizzato. L’autore del falso nello stabilire il suo calcolo si
affidò alla tradizione storiografica francescana, che aveva fissato il
viaggio di Francesco a San Leo nel periodo immediatamente
precedente la sua partenza per il Marocco, cioè nella primavera del
1213. Il falsario dovette avere sottocchio la minuziosa descrizione del
viaggio, che il frate Minore Luca Wadding nei suoi Annales –
53
85 Cf. LAZZERI, l'atto di conferma, p. 88 il riferimento all’opera di A. di Miglio; alle pp. 93-96 viene riprodotta la relazione dei magistrati della Lana; sarebbe opportuna in proposito una più attenta verifica.
pubblicati tre anni prima dell’opera del Vitale - aveva da poco tentato
di ricostruire, tappa per tappa, assemblando le fonti più disparate e
disseminando il percorso di più o meno favolosi miracoli e di
assolutamente improbabili fondazioni di conventi 86 . Francesco
neppure pensava a fondare sedi stabili in quel periodo della sua vita,
quando i suoi frati vivevano alla giornata, alloggiando, nel loro
itinerare da luogo a luogo, negli ospizi per poveri, malati e pellegrini,
o nelle case in cui prestavano i loro servizi. Servendosi della
descrizione del Wadding l'inventore del nostro documento, o il suo
primo trascrittore, ha tentato di ricostruire la data della presunta
donazione del conte Orlando, tenendo ovviamente conto che
l'episodio viene collocato dagli Actus e dai Fioretti nel contesto di una
festa per l'investitura di un cavaliere e quindi ai primi di maggio. Il
giorno specifico del mese avrebbe potuto, per di più, richiamare
quello in cui nel mese di settembre si celebra la festa della Natività di
Maria, che, lo si è visto, è indicato nella nota introduttiva al Catalogus
ministrorum generalium, come data della donazione da parte di
Orlando ed è anche la data, in cui era stato emanato l'importante
documento del cardinale Rinaldo d'Ostia a definitiva consacrazione
della Verna.
54
86Gli Annales del Wadding, vennero editi a Lione nel 1625; pp. 169-180 dell'edizione Quaracchi, I, Ad Claras Aquas (Quaracchi) 1931; le tappe del viaggio presentate dal Wadding sono Foligno, Trevi, Spoleto, Terni, Sant'Urbano, Narni, Amelia, San Gemini, seguono le indicazioni delle soste lungo la strada verso e attraverso la Toscana: sono segnalate Poggibonsi, Siena, Borgo San Sepolcro, per giungere poi velocemente a indicare il superamento dell'Appennino e, attraverso il percorso della valle del Marecchia, l'arrivo a San Leo.
Abbiamo già segnalato come sia stata avanzata l'ipotesi, pur con
molta cautela, che nel codice Laurenziano, in cui è riprodotto il
Catalogus ministrorum generalium con le note introduttive, sia stata
aggiunta per errore del copista, o del redattore del Catalogus, una “V”
rispetto alla data contenuta nel documento di conferma della
donazione, ottenendo così come risultato MCCXVIII invece di
MCCXIII. Appurata la falsificazione, l’ipotesi risulta assolutamente
insostenibile, in quanto la nota introduttiva è del secolo XIV (lo
testimoniano le varie mani del codice 87), dunque molto prima che il
falso documento della conferma della donazione venisse
confezionato. Si potrebbe allora invertire l’ipotesi, supponendo che
non sia stato il copista o l’autore della nota del Caalogus ad aggiungere
una “V” nell’indicazione dell’anno della donazione rispetto al
documento di conferma, ma che il falsario, avendo sotto gli occhi il
Catalogus avesse per errore omesso una “V”. Ma è ormai ipotesi
superflua, anzi fuorviante, dato che nel Catalogus l’episodio è datato in
festo Nativitatis Virginis Gloriose, cioè l’8 settembre, altro elemento della
datazione che risulta problematico. Come risolvere la questione? Con
tutta probabilità il Catalogus confonde le cose, ripescando, per datare
la donazione, il riferimento liturgico alla festa mariana, alla quale,
secondo una tradizione, veniva correlato l'evento delle stimmate.
Infatti quando veniva redatta l’opera, o piuttosto quando venne
inserita la nota introduttiva, si era da tempo affermata la tradizione,
secondo cui tale evento avvenne durante la Quaresima di san Michele,
55
87Cf. l’introduzione al Catalogus in MGH, SS, 33, p. 653-654.
nel bel mezzo della quale ricorre appunto la festa della Natività di
Maria, alla cui ottava fa specifico riferimento un’epigrafe del 1264, di
cui discuteremo tra breve.
La tradizione relativa al “donazione” della Verna da parte di
Orlando era stata di fresco fissata nel racconto degli Actus beati
Francisci, da cui l'autore della nota all'inizio del Catalogus ha potuto
attingerne la notizia. Ecco come gli Actus narrano il susseguirsi degli
eventi: Francesco, in un suo viaggio verso la Romagna, si ferma a San
Leo (il castrum Montis Feretri), dove si celebrava la festa per
l’investitura dei nuovi cavalieri (militie nove magna solemnitas).
L’Assisiate decide di parteciparvi e in tale occasione incontra il de
Tuscia dominus Orlandus, «molto ricco e nobile», che «per le cose
mirabili che aveva ascoltato di san Francesco, ne aveva concepito
grande devozione e desiderava vederlo e ascoltarlo»; conquiso dalla
predica di Francesco e in seguito a un colloquio con lui, il nobile
signore gli offre in dono il monte della Verna; canclusa la festa,
Orlando fa ritorno nelle sue terre di Toscana e, come d’accordo,
l’Assisiate gli invia due fidi compagni per prendere in possesso
(capere) la Verna; i due frati, visionato il luogo e vistolo adatto al ritiro
contemplativo, ritornano da Francesco, che sale alla Verna
accompagnato dai frati Leone, Masseo e Angelo, e vi celebra la
Quaresima di San Michele, durante la quale Francesco riceve le
stimmate. L’autore degli Actus ripropone la data approssimativa
dell’evento che Bonaventura aveva indicato nella Legenda beati
56
Francisci (Legenda maior), cioè circa festum Exaltationis sanctae Crucis 88.
Si noti che nel racconto degli Actus l’accettazione del dono della Verna
da parte dei due frati e la salita al monte da parte di Francesco e dei
suoi compagni per la Quaresima di san Michele, durante la quale
viene posto l'evento delle stimmate, si susseguono senza interruzione
in perfetta continuità cronologica. Tale continuità non è esplicitata
negli Actus, ma l’anonimo autore delle Considerazioni delle stimmate,
poste in appendice ai Fioretti, colloca esplicitamente nel 1224 - l'anno
dell’evento delle stimmate – il viaggio di Francesco in Romagna e la
donazione della Verna da parte di messer Orlando 89 . Inutile qui
discutere sull’assoluta improbabilità che Francesco nel 1224 , colpito
com’era da gravi e dolorose malattie, fosse in grado di sostenere il
viaggio da Assisi (indicato più genericamente con Valle Spoletana) alla
Romagna.
Come si vede, è molto problematico muoversi tra la molteplicità e
diversità degli elementi cronologici forniti dalle fonti per la
“donazione” della Verna a frate Francesco. A complicare ancor di più
le cose ci sono le molteplici contraddizioni sulla cronologia della
donazione: 1213 come è indicato nel falso documento di conferma, o
1218 come vuole la nota introduttiva del Catalogus, oppure 1224
secondo l’indicazione dei Fioretti? D’altra parte la stessa datazione
relativa al giorno in cui Francesco ebbe le stimmate si muove tra la
genericità e l’approssimazione.
57
88Actus beati Francisci, 9, 4, Fontes, pp. 2103-2109.
89Prima considerazione (FF, pp. 1234-1236).
7. Un’interessante e autentica testimonianza
È opportuno fissare l'attenzione proprio su quell'8 settembre, festa
della Natività di Maria. Tale festa, in forza della disposizione del
concilio Lionese I (1245) di istituirne la celebrazione dell'ottava 90, nel
calendario romano era stata elevata al rango delle solennità, la cui
celebrazione liturgica continuava nei sette giorni successivi (otto
compreso quello della festa). La celebrazione aveva assunto un
significato particolare per l'Ordine minoritico: aveva, infatti, segnato il
termine ultimo per lucrare l'indulgenza concessa da Gregorio IX in
occasione della traslazione del corpo di san Francesco 91 ed era tra le
quattro festività della Vergine, in occasione delle quali i pontefici, a
partire da Onorio III, avevano concesso indulgenze a chi visitasse le
chiese minoritiche 92 . Si trattava dunque di un riferimento liturgico
forte, al quale venne collegato ben presto l'evento delle stimmate.
A questo risulta interessante l'epigrafe in cui è indicata la data
della costruzione del primo oratorio dedicato alle Stimmate nel 1264:
essa colloca l'evento della stimmatizzazione sub anno domini MCCXXV
infra octavam Nativitatis eiusdem Virginis. A parte la discrepanza di tale
data rispetto a quella indicata dalle bio-agiografie precedenti, il 1224,
va notato che quel Nativitatis risulta dalla correzione di un precedente
58
90Rimando in proposito all'esauriente voce di W. WEHR, Natività di Maria S.ma, in Enciclopedia Cattolica, VIII, Città del Vaticano 1952, coll. 1678-1682.
91Cf. BF, I, p. 65.
92Vedi in proposito le tabelle in appendice al contributo di PACIOCCO, Indulgenze papli, visita di chiese e santità(1259-1261), in «Misericorditer relaxamus», pp. 149-214.
Assumptionis. Correzione che sembra apportata dal lapicida stesso, il
quale si era accorto (o gli avevano segnalato) di aver riprodotto per
errore un elemento della datazione della fondazione dell'oratorio,
posta in intestazione all'epigrafe: Anno domini MCCLXIIII, feria V post
festum Assumptionis gloriose Virginis Marie. La festa della Natività di
Maria (8 settembre) è dunque ancora il riferimento liturgico per datare
la stimmatizzazione di san Francesco, che il ministro generale
dell'Ordine, Bonaventura da Bagnorea, aveva di recente datato circa
festum exaltationis sancte crucis (14 settembre) nel suo lavoro bio-
agiografico 93, che da appena un anno aveva ottenuto l'approvazione
ufficiale da parte del capitolo generale riunito a Pisa il 20 maggio
1263. La datazione indicata da Bonaventura per approssimazione (si
noti quel circa) si collocava appunto infra octavam Nativitatis Virginis,
che si concludeva il 15 settembre. E' molto significativo che il
committente dell'epigrafe fissi la sua attenzione appunto sulla festa
della Natività di Maria, benché anch'egli proceda per
approssimazione. Evidentemente non era ancora stata definita, nel
progressivo evolvere della memoria storica, la data dell'"apparizione
del serafino", a cui l'epigrafe fa esplicito riferimento 94.
Benché il testo di Bonaventura avesse cominciato a circolare,
sembra ancora prevalere la data dell'8 settembre, nella quale Rinaldo
di Ienne una decina d'anni prima aveva fatto redigere il primo
59
93Legenda maior, XIII, 3, FF, p. 891.
94Vedi la trascrizione dell'epigrafe nella voce Stimmate, La Verna, di BARFUCCI, in Dizionario francescano. seconda edizione riveduta e ampliata, a cura di E. CAROLI, Padova 1995, coll. 2187-2203; si noti però che purtroppo il Barfucci commette l'errore di trascrivere infra octavam Nativitatis Christi, invece di infra octavam Nativitatis Virginis (col. 2199).
documento di consacrazione ufficiale della Verna all'evento delle
stimmate. Non è del tutto improbabile che il documento del cardinale
ostiense sia stato emesso in tale ricorrenza, in quanto particolarmente
significativa per l'Ordine minoritico, di cui era protettore. Senza
inoltrarci ulteriormente nel gioco delle ipotesi, basterà evidenziare
come la data d’emissione della lettera di Rinaldo si ponga al centro di
una serie di coincidenze con la festa liturgica, quella della Natività
della Vergine, alla quale ormai si faceva riferimento per fissare la data
della stimmatizzazione.
Varrà allora la pena tornare, e conclusivamente, al testo del
documento di Rinaldo d'Ostia, per rileggervi una parte importante
della dispositio: «comandiamo che voi poniate in quel luogo dei frati
che lì prestino un devoto servizio al Signore, in quanto non vogliamo
che per nessuna ragione quel luogo venga abbandonato dal vostro
Ordine» 95 . È la sanzione definitiva, da parte del rappresentante
ufficiale della suprema autorità ecclesiastica per l'Ordine minoritico,
del rapporto stimmate-sacralità della Verna-presenza stabile di una
comunità francescana. La storia successiva del santuario sarà tutta nel
segno di questa disposizione, il che giustifica, al di là di ogni ipotetica
coincidenza, il segno forte lasciato da quella data dell'8 settembre
nella memoria della Verna.
8. Considerazioni conclusive
60
95 mandantes quatenus in predicto loco, quem nulla ratione volumus destitui vel ab ordine derelinqui, fratres aliquos statuatis, qui iugem ibidem exibeant domino famulatum (M, p. 19).
Tra la presenza di Francesco e dei suoi compagni alla Verna nel
settembre 1224 - durante la quale avvenne il grande e misterioso
evento della stimmatizzazione - e il diploma episcopale del 1239 c’è
una frattura di quindici anni: una frattura che non è solo di carattere
documentario, ma sembra attenere alla vicenda della presenza
minoritica. La lacuna documentaria non è troppo strana, se si pensa
alla situazione della documentazione riguardante gli insediamenti
minoritici, che spesso, o normalmente, appare quando la sede dei
Minori è già consolidata. Certo ci si sarebbe attesi una continuità di
vita e di presenza francescana alla Verna nel segno del ricordo
dell'evento delle stimmate. La documentazione non lascia
assolutamente intravedere alcun rapporto tra quell’evento e la piccola
e povera comunità minoritica, residente alla Verna; vi sono anzi
significativi silenzi fino all'8 settembre 1253. Nel frattempo si è andata
strutturando una sede stabile dei frati Minori, che però sembra vivere
in gravi difficoltà - come ben evidenzia il diploma episcopale del 1239
- e sul punto di essere abbandonata: le lettere di Rinaldo d'Ostia/
Alessandro IV sono in proposito molto eloquenti, benché da qualche
anno i frati avessero cominciato a realizzare le strutture essenziali per
la stabile dimora di una comunità religiosa, come si evince dalla
lettera di Innocenzo IV nel novembre 1250. Gli anni tra Cinquanta e
Sessanta del secolo XIII segnano il periodo decisivo per l'insediamento
alvernino: l'intervento autorevole e la sanzione definitiva della
consacrazione del luogo all'evento delle stimmate da parte del
cardinale protettore, Rinaldo d'Ostia - confermati a meno di due anni
61
di distanza dallo stesso divenuto pontefice col nome di Alessandro IV,
- danno l'impulso alla costituzione definitiva dell'insediamento,
vietandone nel modo più assoluto l'abbandono e garantendone in tal
modo la stabilità, e alla sua definizione come santuario sacro alle
Stimmate.
Negli anni successivi si moltiplicano i documenti in favore della
Verna, a testimonianza del fervore delle opere di strutturazione della
sede minoritica attorno a quello che ormai è divenuto un santuario. Il
23 maggio 1256 è datato un diploma del vescovo di Arezzo,
Guglielmo degli Ubertini, che mette in netto risalto l'evento
straordinario delle stimmate a consacrazione del sanctum locum montis
Alvernici 96. Seguono a brevissima distanza due lettere d'indulgenza di
Alessandro IV dell'agosto del 1256 e del 1257, che però non
rappresentano un'eccezione rispetto alle indulgenze concesse, proprio
in quegli stessi anni, dallo stesso pontefice alle chiese dei frati minori 97. Il formulario è quello generalmente utilizzato nelle lettere di
indulgenza. Anche le indulgenze e le festività per le quali vengono
concesse non variano rispetto a quelle a favore di altre chiese
francescane. Tali documenti testimoniano inequivocabilmente che
ormai la chiesa per l'ufficiatura liturgica dei frati e per l’accoglienza
dei fedeli è stata realizzata.
62
96Cf. M, pp. 29-30.
97Le due lettere, Cum ad promerenda del 25 agosto 1256 e Sanctorum meritis del 29 agosto 1257 sono edite in M, pp. 31-32. Sulle indulgenze concesse da Alessandro IV alle chiese dei Mendicanti e in particolare dei frati minori vedi DEL FUOCO, Indulgenze papali.
La già ricordata epigrafe, che segna la data della costruzione del
primo oratorio dedicato alle Stimmate nel 1264, dimostra chiaramente
che il giorno di ricorrenza della stimmatizzazione di Francesco non
era ancora esattamente fissato, nonostante la biografia bonaventuriana
avesse di fresco indicato autorevolmente un riferimento cronologico e
liturgico: circa festum exaltationis sancte crucis (14 settembre). Ma era
evidente il carattere di tale riferimento, pensato per conferire
all'evento maggior forza simbolica 98 . Interessante anche il
personaggio che l'epigrafe presenta come "fondatore" dell'oratorio:
Simone, figlio di Guido, conte palatino di Tuscia. Si tratta di Simone di
Battifolle, iniziatore della linea dei conti di Poppi, che quattro anni
prima troviamo schierato accanto ai ghibellini senesi nella battaglia di
Montaperti (1260) contro il fratello Guido Guerra di Davola, che
combatte nel campo guelfo dei fiorentini. Tali contrapposizioni
continueranno, pur nella modifica degli schieramenti, fino a
Campaldino (1289), battaglia in cui trovò la morte anche il vescovo
Guglielmino degli Ubertini. I dissidi tra i rappresentanti dei Guidi si
protrarranno fin ben addentro nel secolo XIV 99.
Ma torniamo al titolo di conte palatino, che il nostro falsario
attribuisce ad Orlando di Chiusi: né costui, né i suoi figli se ne
potevano fregiare, visto che tale titolo veniva concesso dal vescovo, il
63
98Legenda maior, XIII, 3, FF, p. 891.
99Sulla vicenda della famiglia dei Guidi vedi E. SESTAN, I conti Guidi e il Casentino in ID., Italia medievale, Napoli 1966, pp. 356-378; secondo il CRESI Simone di Battifolle, conte di Poppi, avrebbe fatto costruire, oltre le due cappelle sul luogo delle stimmate, la cella di S. Francesco e, come struttura separata dal convento, cinque celle per i frati, che dovevano officiare la cappella delle Stimmate (Supplemento, p. 455; pp. 395, 396-397).
quale, come si è visto, aveva destituito del feudo Orlando stesso e i
suoi fratelli. D’altra parte, lo abbiamo già ricordato, la stessa fonte a
cui attinge il falsario non dà a Orlando il titolo di conte e tanto meno
quella di “conte palatino”.
L’epigrafe di cui ci stiamo occupando mostra senza ombra di
dubbio che l’ambiente minoritico della Verna era legato ai Guidi di
Poppi. Né Orlando, né i suoi figli risultano in alcun modo aver
rapporti privilegiati con i frati Minori alvernini e, tanto meno, sono
cointeressati alla costruzione e sistemazione degli ambienti
santuariali, o coinvolti negli interventi sulle strutture abitative. Il che
costituisce - se ancora ve ne fosse bisogno - un ulteriore elemento a
comprova di quanto abbiamo fin qui sostenuto a proposito della
presunta donazione e della sua conferma. Non si dimentichi, per altro,
che proprio tre anni prima Orlando e i suoi fratelli erano stati privati
dei feudi dal vescovo, loro signore.
Nel territorio attorno al monte della Verna i giochi di potere sono
molteplici e contrastanti: oltre la presenza di diverse signorie che si
contendono terre e uomini, c’è l’intervento del vescovo, che rivendica
diritti di vario genere. Attori più o meno potenti sono gli Ubertini, i
Guidi di Romena, alla cui consorteria apparteneva Simone, e
soprattutto il potente monastero di Camaldoli. Nel 1264 il monte della
Verna e il territorio circostante era nelle mani dei Guidi: il che fa
capire come siano loro i principali o, addirittura, gli unici attori degli
interventi sulle strutture del santuario e del romitorio. Ma
probabilmente dietro di loro c’è il vescovo, di cui i Guidi sono la longa
64
manus per contrastare le mire del monastero camaldolese; l’eremo
della Verna veniva dunque coinvolto in una lotta per il potere nel
Casentino e forse i Guidi lo utilizzarono come controaltare nei
confronti del potere monastico dominante nella zona 100.
La storia dell'insediamento della Verna appare dunque inserita in
una dinamica politica e istituzionale certamente più complessa di
quanto si sia soliti ricostruire, affidandosi a tradizioni tardive e a
documenti, che ad un’attenta analisi si rivelano falsi, o pesantemente
falsificati 101 . La stessa vicenda della memoria agiografica della
stimmatizzazione sul monte della Verna appare molto meno lineare di
come non venga solitamente presentata. Tale vicenda è speculare
rispetto all'evolversi del culto delle Stimmate, che, paradossalmente,
prende slancio proprio dalla polemica "teologica" sul fenomeno, di cui
abbiamo la prima testimonianza nelle lettere di Gregorio IX del 1237.
Il silenzio del papato fino a quella data appare indicativo di un culto
che non ha ancora preso piede. Il che avverrà solo a partire dagli anni
Cinquanta del secolo: in tal senso risulta di nuovo fondamentale la
lettera di Rinaldo d'Ostia. È il decennio in cui le strutture
dell'insediamento subiscono le modificazioni necessarie per
conferirgli il carattere di santuario dedicato alle Stimmate, che di lì a
65
100 Ringrazio Gian Paolo Scharf per le indicazioni in proposito: da lui attendiamo un annunciato volume che metta in luce gli intricati problemi dei rapporti tra i Guidi, Camaldoli e il vescovo di Arezzo, nei quali viene coinvolto l’eremo della Verna.
101Devo purtroppo far notare che la già citata voce di BARFUCCI, Stimmate, nel Dizionario francescano nella parte relativa a s. Francesco si affida in modo acritico al racconto degli Actus/Fioretti e non accenna minimamente ai problemi relativi alla discussione sulla documentazione, a proposito della quale già il Mencherini aveva espresso ampie riserve.
pochi anni (1264) avrà anche un ambiente sacro sul luogo del
misterioso evento.
L'insediamento stesso subì i contraccolpi dello sviluppo della
memoria agiografica e del culto, a partire dal misterioso e riverente
silenzio, che aveva avvolto l’esperienza delle stimmate negli ultimi
due anni della vita di Francesco e delle contrastanti reazioni che la sua
evidenziazione suscitò nei vari ambiti e ai diversi livelli dell'Occidente
cristiano. La storia della comunità minoritica della Verna diviene così
l'emblema di una vicenda che è fatta di ricerca di silente ritiro nella
testimonianza della povertà minoritica, ma anche del sorgere e dello
svilupparsi di un culto, che solo lentamente e faticosamente prese
piede persino nell'ambiente che si sarebbe portati a pensare come il
più geloso custode della memoria di un “prodigio”, assunto come
emblematico sigillo (bulla) di una nuova Regola di esperienza e vita
religiosa.
66