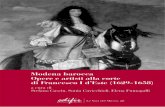Pier Leone Ghezzi, Anton Francesco Gori e Francesco Vettori : un inedito progetto editoriale sulle...
-
Upload
fondazionetrossiuberti -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Pier Leone Ghezzi, Anton Francesco Gori e Francesco Vettori : un inedito progetto editoriale sulle...
Amministrazione e abbonamentiFabrizio Serra editore
Casella postale n. 1, succursale n. 8, i 56123 Pisa,tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, [email protected]
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabilipresso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net
Print and/or Online official subscription rates are availableat Publisher’s web-site www.libraweb.net.
*
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 4 del 3 aprile 2008Direttore responsabile: Fabrizio Serra
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o perestratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm,
la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2013 by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale,Edizioni dell’Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa,
Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.
*
www.libraweb.net
i s sn 1972-6538i s sn elettronico 1974-4900
SOMMARIO
Eliana Carrara, Il corpus grafico di Giovanni Antonio Dosio : dall’antico alle regole 9
Bruno Gialluca, Gli Antichi Sepolcri e Ivan Pas ˇtric (Giovanni Pastrizio). Ricerche sopra la produzione estrema di Pietro Santi Bartoli 23
Veronica Carpita, Pier Leone Ghezzi, Anton Francesco Gori e Francesco Vettori : un inedito progetto editoriale sulle lucerne antiche 107
Esther F. Rogmans, The National Museum of Antiquities in Leiden, The Nether- lands, and its Etruscan Bucchero Pottery from the Museo Corazzi 133
note, discussioni, recensioni
Federica Missere Fontana, Testimoni parlanti. Le monete antiche a Roma tra Cin- quecento e Seicento (Veronica Carpita) 151
Ettore Spalletti, La Galleria di Pietro Leopoldo. Gli Uffizi al tempo di Giuseppe Pelli Bencivenni (Miriam Fileti Mazza) 159
Indice dei nomi 163
Norme redazionali della Casa editrice 167
PIER LEONE GHEZZI, ANTON FRANCESCO GORI E FRANCESCO VETTORI :
UN INEDITO PROGETTO EDITORIALE SULLE LUCERNE ANTICHE
Veronica Carpita
Nel cospicuo Fondo Gori conservato alla Biblioteca Marucelliana di Firenze, il carteggio inedito di Francesco Vettori, composto da 814 lettere inviate al prelato
Anton Francesco Gori, rivela la singolare storia di un’impresa antiquaria mai pubbli-cata che coinvolse uno dei più celebri artisti del xviii secolo, Pier Leone Ghezzi (1674-1755). 1
1. Le lettere di Vettori a Gori
Del cavalier Francesco Vettori (1692-1770), romano appartenente ad una nobile famiglia di origini fiorentine, conosciamo ben poco. Definito dall’amico Ghezzi « erudito in let-teratura et anche nelle antichità, tanto in intagli e camei, come anche nelle medaglie », 2 Vettori donò il suo museo a Benedetto XIV (1740-1758) che nel 1756 creò il Museo Sacro della Biblioteca Apostolica Vaticana, nel quale confluirono anche altre collezioni priva-te, fra cui quella Carpegna. Nel 1757 il cavaliere fu nominato dal pontefice primo Prefet-to a vita del Museo. 3 Numerosi reperti antichi della sua collezione furono disegnati da Ghezzi, 4 mentre la sua ricca biblioteca fu acquistata dall’Elettore Palatino. 5
Molto più nota e oggetto di recenti studi è la personalità di Anton Francesco Gori (1691-1757). 6 Di famiglia agiata e indirizzato agli studi letterari, Gori riconobbe ad Anton Maria Salvini e Filippo Buonarroti il ruolo di precettori che lo iniziarono allo studio dei monumenti antichi, in particolare delle antichità etrusche. Le fatiche storiche e antiqua-rie dell’erudito furono ricompensate dal granduca Gian Gastone che nel 1730 lo nominò
1 Biblioteca Marucelliana di Firenze (d’ora in poi bmf), Fondo Gori, mss. A xiii 1, A lxii, A lxiii, A lxxvii, A ccxi, A ccxii, A ccxiii, A ccxlvii, A cclii, B viii 8, B viii 9, B viii 10, B viii 11, B viii 12.
2 La frase di Ghezzi compare in una delle sue celebri caricature del 1744 conservata alla Biblioteca Apostoli-ca Vaticana (d’ora in poi bav), Ottob. Lat. 3119, f. 86, citata in Lucia Guerrini, Marmi antichi nei disegni di Pier Leone Ghezzi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1971, pp. 44-45.
3 Guerrini, op. cit., pp. 27, 44-45.4 Dei numerosi codici ricchi di disegni del Ghezzi, oggi in gran parte alla bav, la Guerrini (op. cit.) pubblica
una selezione di fogli tratti dai codici Ott. Lat. 3106-3109, ma anche dal ms. 2136 della Biblioteca Angelica e dal codice Ghezzi del British Museum. Per il Museo del Vettori vedi anche bmf, Fondo Gori, ms. A xv : Singularia vetusta … in Museo Victorio, Roma 1739.
5 Vedi bmf, Fondo Gori, ms. B i, 9, 8 : Spoglio di sue carte che esistevano nella Libreria del Comm. Francesco Vet-tori, la quale fu acquistata dall’Elettore Palatino.
6 Per le successive notizie biografiche ho attinto da Fabrizio Vannini, ad vocem, dbi, lviii, Roma, Trecca-ni, 2002, pp. 25-28. Segnalo anche L’epistolario di Anton Francesco Gori. Saggi critici, antologia delle lettere e indice dei mittenti, a cura di Cristina De Benedictis, Maria Grazia Marzi, Firenze, University Press, 2004 ; Clara Gambaro, Anton Francesco Gori collezionista. Formazione e dispersione della raccolta di antichità, Firenze, 2008.
veronica carpita108
pubblico professore di storia sacra e profana nello Studio fiorentino. 1 L’enorme bagaglio di conoscenze sulla storia, sulla letteratura e sui monumenti antichi della Toscana lo sti-molò ad intraprendere la pubblicazione di un cospicuo numero di opere. Nota è la sua frequentazione del gruppo di eruditi dalle cui riunioni nacque la celebre Società Colom-baria fiorentina (15 maggio 1735). Considerato uno dei padri dell’etruscologia, Gori viag-giò pochissimo ma fu in contatto con centinaia di corrispondenti sparsi in tutta Europa.
Il carteggio del Vettori al prelato fiorentino (non sono note purtroppo né le minute né le lettere originali del Gori) costituisce una fonte ricchissima d’informazioni sull’attività della Repubblica delle Lettere romana della prima metà del xviii secolo, in particolare per ciò che concerne gli studi sulle antichità. Dalla lettura delle numerose missive emer-ge chiaramente il ruolo di attivo mediatore che il cavaliere esercitava nei confronti delle opere pubblicate dal Gori. Autore di una dozzina di operette erudite perlopiù anoni-me, 2 Vettori inviava regolarmente al corrispondente fiorentino le novità editoriali uscite sul mercato romano, nonché un gran numero di calchi di gemme e disegni di ogni sorta di reperto antico (iscrizioni, camei, medaglie, dittici, lucerne, oggetti e vetri sacri) e lo teneva costantemente informato su tutto ciò che accadeva nel mondo dell’erudizione romana. Per uno studioso di antichità come Gori che « non si mosse mai dalla patria to-scana », 3 dovettero essere di fondamentale importanza le accurate descrizioni delle sco-perte archeologiche romane fornite dall’assiduo e puntuale corrispondente dall’Urbe.
Nonostante i due non si fossero probabilmente mai incontrati, Vettori con generosità e solerzia proponeva all’amico prelato di cimentarsi in nuovi studi e pubblicazioni, met-tendo a disposizione la sua fitta trama di conoscenze nel mondo romano degli editori, dei disegnatori e incisori, nonché dei nobili e cardinali, ai quali poter proporre il duplice ruolo di dedicatari e finanziatori. È stato proprio grazie al cavalier Vettori che Gori ha potuto pubblicare una delle sue opere più note, il Monumentum sive columbarium liberto-rum et servorum Liviae Augustae et Caesarum Romae detectum in via Appia anno 1726 (Firenze 1727). 4 L’opera è dedicata alla sensazionale scoperta di un grande colombario nella vi-
1 Nel 1746 Gori fu nominato prevosto del battistero di San Giovanni, carica che detenne fino alla morte.2 Fra le opere di Francesco Vettori, la cui paternità è spesso desunta da altre fonti, ricordo : Veteris gemmae ad
christianum usum exscalptae brevis explanatio ad Academicos Etruscos Cortonenses, Romae, ex typographia Rochi Bernabò, 1732 (ebbe altre due edizioni) ; Observationes seu Praelusiones in tabulam nummariam Musei Victorii, Ro-mae, ex officina typographica Antonii de Rubeis, 1736 ; Il fiorino d’oro antico illustrato. Discorso di un accademico etrusco, In Firenze, nella stamp. di S.A.R. per i Tartini e Franchi, 1738 ; Dissertatio glyptographica : sive Gemmae duae vetustissimae emblematibus et graeco artificis nomine insignitae quae exstant Romae in Museo Victorio, explicatae et illustratae,, Romae, typis Zempelianis, 1739 ; Sanctorum septem dormientium historia ex ectypis Musei Victorii expressa. Dissertatione et veteribus monimentis sacris profanisque illustrata, Romae, ex typographio Pagliariniano, 1741 ; Animadversiones in lamellam aeneam vetustussimam Musei Victorii, Romae, ex typographia Zempeliana, 1741 ; Numismata Hieronymi equitis Odam ex Museo Victorio prolatum, Romae, J. Zempel, 1742 ; De vetustate et forma monogrammatis sanctissimi nominis Jesu dissertatio antiquis emblematibus, non antea vulgatis, ex Museo Victorio re-ferta, Romae, typis Zempelianis, 1747 ; Epistola ad virum clarissimum Paullum Mariam Paciaudi clericum regularem de Musei Victorii emblemate et de nonnullis numismatibus Alexandri Severi secundis curis explanatis, Romae, typis Zempelianis, 1747 ; Ornatissimo viro Paullo Mariae Paciaudi ... felicitatem, Romae, Joannes Zempel, 1748 ; Disser-tatio apologetica de quibusdam Alexandri Severi numismatibus ad viros doctos cultores sincerae veritatis, Romae, ex typographio Zempeliano, 1749 ; Dissertatio philologica qua nonnulla monimenta sacrae vetustatis ex Museo Victorio depromta aeri incisa tabula vulgantur, expenduntur, illustrantur, Romae, ex typogr. Palladis, 1751 ; Del culto supersti-zioso di Cibele, detta da gli antichi la gran madre, In Roma, nella stamperia di Apollo, 1753.
3 Vannini, op. cit., p. 28. 4 Il titolo completo è Monumentum sive columbarium libertorum et seruorum Liuiae Augustae et Caesarum Romae
detectum in Via Appia, anno 1726 ab Antonio Francisco Gorio ... ; adjectis notis clariss. V. Antonii Mariae Salvinii, Florentiae, typis Regiae Celsitudinis, 1727.
ghezzi, gori e vettori: un progetto sulle lucerne antiche 109
gna di un tal Giuseppe Benci, andato purtroppo distrutto poco dopo il suo ritrovamen-to. Dal carteggio della Marucelliana apprendiamo che Gori non vide mai il monumento e cruciale risultò l’aiuto del Vettori che gli fornì accurate descrizioni autoptiche, alcune piante del sito e le trascrizioni di centinaia di iscrizioni. Il cavaliere coordinò inoltre tutto l’apparato iconografico dell’opera che, scritta e stampata a Firenze, poté contare sullo studio in situ tanto del Vettori quanto del suo fidato disegnatore, Gerolamo Odam (1681-1741). 1
2. I progetti intorno al secondo volume de Le antiche lucerne sepolcrali di Pietro Santi Bartoli
Non appena Gori ebbe terminato l’opera dedicata al Colombario dei Liberti di Livia, uscita dai torchi alla fine del 1727, 2 Vettori gli propose una nuova impresa antiquaria che tuttavia, come vedremo, dopo una gestazione di ben dieci anni, non venne mai alla luce. Il 7 febbraio 1728 Vettori infatti scriveva all’amico fiorentino :
Potrei presentare a V. S. altra bella fatica, e da averne onore, e credo poterlo fare con tutta facili-tà ; questa consiste nell’illustrare circa 100 lucerne sepolcrali, tutte inedite, e belle, le quali sono anche disegnate esattissimamente bene, e con tutto che non abbia occasione io di far risultare. La persona che le possiede per altre cose, che farle in avvenire intenderà anche Lei meglio, che di presente con tutto ciò, perché dobbiamo far bene, secondo il precetto, a quelli ancora, che oderunt nos, perciò la offerisco alla sua penna eruditissima, che più stimo assai d’ogni altra cosa, che per la mente mi passi, ma meglio ancora si discorrerà in avvenire, desiderando il possessore di farle intagliare giù in Roma. 3
Il Gori dovette prontamente accettare il nuovo progetto perché nella missiva inviata dal Vettori in data 21 febbraio 1728 leggiamo :
Circa la raccolta delle lucerne, che li praticcai, si contenti dirmi come vorrà contenersi, cioè se vorrà, che l’intaglino qui a conto suo in rame, facciendone costì qualche società, o pure se qua vuole che alcuno se ne prenda l’assunto, che non stimo tornarebbe vantaggioso a V. S. per quello ho inteso ; montarà la spesa di ogn’uno de rami a circa 4 scudi, l’uno per l’altro, tenendoli alla misura di quelle di Pietro Santi Bartoli, se bene non ho parlato fin ora con l’intagliatore, aspettan-do di sentire per qualche cosa di determinato e le spiegazioni si dovrebbero fare in toscano per accompagnare, e fare quasi un secondo tomo alle sopradette. 4
La corrispondenza, oltre a fornire dati preziosi che attengono alle diverse fasi editoriali, rivela il progetto di ampliare la nota raccolta di lucerne dell’incisore perugino Pietro Santi Bartoli (1635-1700) : 5 Le antiche lucerne sepolcrali figurate raccolte dalle cave sotterranee e
1 Romano, discendente da una famiglia originaria di Toul in Lorena, Odam compì il suo apprendistato pittorico presso Carlo Maratta e Pier Leone Ghezzi, studiando contemporaneamente architettura sotto la guida di Carlo Fontana. Ben introdotto nell’entourage degli antiquari e collezionisti romani tanto da riuscire protagonista di una gratificante ascesa sociale, Odam radunò un gran numero di sculture provenienti da tutti i più fruttuosi scavi condotti all’epoca sul Palatino, sull’Aventino, lungo la via Appia, ecc. Prima di fornire i disegni preparatori alle tavole di corredo dell’opera del Gori, Gerolamo Odam aveva illustrato il celebre vo-lume di Philipp Von Stosch, Gemmae antiquae caelatae (Amsterdam 1724). Per le notizie biografiche sull’artista rimando a Guerrini, op. cit., pp. 40-41 e più recentemente a Maria Barbara Guerrieri Borsoi, Il cavaliere Girolamo Odam : erudizione e disegni di un arcade romano, « Studiolo », 7, 2009, pp. 161-180.
2 Le fasi dell’elaborazione dell’opera sono ricostruibili nei minimi dettagli dalle lettere del Vettori : bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, cc. 4 sgg. 3 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 128r.
4 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 131v.5 Su questa figura di artista notissimo in vita, protetto e stimato dai più eminenti personaggi della seconda
veronica carpita110
grotte di Roma, nelle quali si contengono molte erudite memorie, disegnate ed intagliate nelle loro forme da Pietro Santi Bartoli, divise in tre parti con l’osservationi di Gio. Pietro Bellori, in Ro-ma nella stamparia di Gio. Francesco Buagni, 1691. Una descrizione assai particolareggiata dell’opera, che ne attesta l’immediato successo, è contenuta in una lettera che La Teu-lière, direttore dell’Académie de France, scrisse da Roma al surintendant des Bâtiments Édouard Colbert, marchese di Villacerf, il 30 dicembre 1692 :Il y a véritablement un Italien [Pietro Santi Bartoli] qui excelle pour les choses antiques, mais il ne grave qu’en petit. Il a paru depuis cinq ou six mois un ouvrage de sa main sur les lampes antiques de terre cuitte, ou de metal, que l’on trouve ordinairement dans les tombeaux Anciens. Comme elles sont ornées de petites figures qui répresentent des cérémonies, des jeux ou de leurs Divinités, et que par cette raison il y a de l’érudition dans la pluspart, le Sr Pietro Bellori a fait des observations sur chascune. Tout l’ouvrage fait un volume in quarto d’un bon pouce d’espais ; il est divisé en trois parties, qui contiennent en tout 116 petites planches de cinq à six pouces de hauteur, sur quatre ou quatre et demy de large. Je vous aurois envoyé ce livre, si je n’avois creu faire plus sagement d’attendre vos ordres, Monsieur. 1
Non uno bensì due esemplari furono richiesti dal marchese di Villacerf il quale, durante il suo mandato conclusosi alla morte nel 1699, acquistò tramite La Teulière pressoché tutte le suites di stampe di Bartoli. Il direttore dell’Académie de France informava il su-periore a Parigi della speciale riconoscenza dell’artista :
Il m’a promis encore quatre petites estampes qu’il a gravées depuis peu pour ajouster à son livre « Lampes sépulcrales » que vous avez vu, Monsieur ; des quatre planches qu’il m’a fait voir, il ne reste que la dernière à finir. J’auray soing, comme je dois, de vous envoyer des premiers exemplai-res de ces curiosités à mesure qu’elles paroistront. 2
Alle quattro incisioni di lucerne promesse si aggiunse l’impegno di una quinta. 3 Si trat-tava di prove di stampa che l’artista tirava per verificare in corso d’opera la bontà dell’in-cisione e per apportarvi i dovuti ritocchi ; solitamente tali prove erano custodite gelosa-mente dagli incisori per il timore di plagi. 4 Tra i numerosi riferimenti a queste stampe
metà del xvii secolo, autore di celebri suites di stampe dall’antico, mi permetto di rimandare al mio Agostino Scilla (1629-1700) e Pietro Santi Bartoli (1635-1700) : il metodo scientifico applicato allo studio dei fossili e la sua trasmis-sione ai siti e monumenti antichi, « Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filolo-giche. Rendiconti », 9, s. 17, 2006, pp. 307-384 (con bibliografia precedente).
1 Anatole de Montaiglon, Correspondance des directeurs de l’Académie de France a Rome avec les surinten-dants des bâtiments, publiée d’après les manuscrits des Archives nationales, i, Paris, Charavay fréres, 1887, p. 345.
2 Lettera inviata da Roma in data 14 febbraio 1696, in De Montaiglon, op. cit., ii, p. 207.3 Lettera spedita da Roma datata 5 giugno 1696, in De Montaiglon, op. cit., ii, p. 236.4 « Pour les estampes que vous me demandez, Monsieur, je ne saurois vous satisfaire présentement, à mon
grand regret, parceque Pietro Santi n’en a point d’imprimées. Celles que je vous ay envoiées ne sont que des épreuves qu’il avoit fait tirer pour voir s’il y avoit quelque chose à retoucher à ses planches. Il n’en avoit que quatre exemplaires ; c’est par une grâce particulière qu’il me donna ceux que vous avés reçeus. J’ay creu ne devoir pas abuser de son honnesteté en luy demandant d’autres, de peur de m’exposer de n’en plus recevoir de cette nature et vous priver par là, Monsieur, de voir plus tost que le reste du Monde tout ce qu’il faira de nouveau. Comme il prétend donner bientost au public son second volume, je vous l’envoyerayai dès lors qu’il paroistra, et je ne manqueray pas d’envoyer à même temps les estampes en question. Je tascheray même de persuader, par occasion, de les faire impremer pour son propre intérest en faveur de ceux qui ont son premier volume pour les exiter à les demander, d’autant plus qu’il en a encore gravé quatre, outre celles que vous avés veu, et qu’il en a d’autres nouvelles à graver » (La Teulière da Roma il 31 luglio 1696 à Colbert, in De Montaiglon, op. cit., II, p. 251. Il « second volume » fa riferimento a Gli antichi sepolcri overo mausolei romani et etruschi trovati in Roma et altri luoghi celebri nelli quali si contengono molte erudite memorie, raccolti, disegnati et inta-gliati da Pietro Santi Bartoli (Roma 1697), la cui tanto attesa pubblicazione venne ritardata a causa delle precarie
ghezzi, gori e vettori: un progetto sulle lucerne antiche 111
di lucerne presenti nella corrispondenza scambiata fra i due, merita citare ancora un passo di La Teulière :
Pour le cinq lampes, il [Bartoli] m’a dit en avoir dessiné une trentaine qu’il prétend donner au public, mais qu’il n’en a gravé que dix, qu’il espère en trouver encore d’autres ; tous les curieux luy en fournissant tous les jours de nouvelles, où ils trouvent de l’erudition pour ce qui regarde les mœurs des Anciens, ce qui pourroit donner matière à un second volume, ce qui est une raison pour ne pas les donner séparées. Il me dit, de plus, avoir trouvé une personne capable pou rempla-cer le Sr Bellori sur l’interprétation des figures qui se trovent sur ce lampes, et qu’il m’informera de toutes ses nouvelles découvertes comme il a fait jusqu’à présent. 1
In effetti, l’invio delle prove di stampa delle altre cinque lucerne non è documentato nel-la corrispondenza ed è altresì probabile che Bartoli abbia deciso di non diffondere alcu-na ulteriore incisione, nella speranza di dare alle stampe il secondo volume de Le antiche lucerne sepolcrali figurate. Questo progetto, concepito forse insieme a Francesco Bianchi-ni per il quale Bartoli illustrava in quei mesi La Istoria Universale Provata con monumenti, e figurata con simboli de gli antichi (Roma 1697), 2 non arrivò mai a concretizzarsi, anche se è possibile recuperarne alcune tracce. 3 Dunque a pochissimi clienti fidati Bartoli aveva consegnato delle prove di stampa di sei lucerne da aggiungere in calce al primo volume che avevano acquistato ; in questa maniera l’incisore dimostrava la propria riconoscenza ad un ristretto e selezionato numero di amici e contemporaneamente promuoveva il secondo libro delle lucerne che sarebbe dovuto comparire.
Ad ogni buon conto, quel primo ed unico volume dedicato alle antiche lucerne ebbe larghissima fortuna, tant’è che le 116 tavole vennero ristampate nel 1704 da Domenico De Rossi e nel 1729 dal figlio Lorenzo Filippo, 4 dopo che l’anno precedente erano state riprodotte in una edizione latina comparsa a Leida. 5
condizioni di salute del Bellori. L’erudito avrebbe dovuto scrivere il commento alle tavole di Bartoli, ma il volume ne rimase privo per la morte dello stesso Bellori (19 febbraio 1696). Il progetto editoriale sulle vestigia sepolcrali comprendeva tre volumi : quello delle lucerne, quello dei sepolcri e quello delle pitture. Quest’ulti-mo fu pubblicato nel 1680 (Le pitture antiche del sepolcro de Nasonii nella via Flaminia disegnate, ed intagliate alla similitudine degli antichi originali da Pietro Santi Bartoli descritte, & illustrate da Gio. Pietro Bellori).
1 Lettera inviata datata Roma, 23 luglio 1697, in De Montaiglon, op. cit., ii, pp. 325-326.2 Carlo R. Chiarlo, Considerazioni sull’apparato illustrativo de’ La Istoria Universale : le immagini relative
ai monumenti classici, in Unità del sapere, molteplicità dei saperi. Francesco Bianchini (1662-1729) tra natura, storia e religione, a cura di Luca Ciancio, Gian Paolo Romagnani, Verona, QuiEdit, 2010, pp. 245-258.
3 Infatti il Cicognara (Catalogo ragionato dei libri d’arte e d’antichità posseduti dal conte Cicognara, Pisa, presso Niccolo Capurro, 1821, ii, pp. 173-174, cat. 3609) precisa a proposito delle tavole contenute nella prima edizione del volume dedicato alle lucerne in suo possesso : « vi sono altre sei tavole addizionali non numerate le quali trovansi in pochi esemplari di questa prima, e in nessuno delle susseguenti edizioni ». Si veda anche quanto detto infra a proposito dell’opera Collectanea Antiquitatum Romanarum. Colgo l’occasione per segnalare che Elena Vaiani ha in corso di pubblicazione un saggio sopra Un taccuino inedito di disegni di lucerne alla British Library, che la studiosa attribuisce a Pietro Santi Bartoli.
4 Dopo la morte di Pietro Santi Bartoli (7 novembre 1700), le 119 matrici in rame de Le antiche lucerne sepol-crali figurate risultano nell’inventario dei beni dell’artista (rintracciato dalla scrivente e di prossima pubblica-zione). Infatti il nome di Giovan Francesco Buagni, che compare in calce al frontespizio della prima edizione, era lo stampatore e non l’editore. È probabile che il figlio Francesco abbia ricevuto i rami come parte dell’ere-dità a lui spettante e li abbia venduti fra il 1702 e il 1704 all’editore Domenico De Rossi. Cfr. Indice delle stampe intagliate in rame a bulino, e in acqua forte esistenti nella Stamparia di Lorenzo Filippo de’ Rossi. Contributo alla storia di una Stamperia romana, a cura di Anna Grelle Iusco, Roma, Artemide, 1996, pp. 55, 387.
5 Veterum lucernae sepulcrales collectae ex cavernis et specubus subterraneis urbis Romae, figuris Aeneis expressae : in quibus multa eruditionem monumenta continentur, divisae in tres partes delineatae secundum formas suas a Petro Sanctio Bartolio. Cum observationibus Joannis Petri Bellorii. Ex italico in latinum sermonem transtulit Alexander Duke-rus. Editio novissima, correctior & emendatior. Lugduni Batavorum, excudit Petrus Vander A.A., Bibliop. 1728.
veronica carpita112
3. Le lucerne del cavalier Ghezzi e del professor Gori, tra attriti e risarcimenti
Torniamo adesso alla raccolta di lucerne progettata dal Vettori per il Gori al principio del 1728 come secondo volume alla pubblicazione del Bartoli. Grazie alla corrisponden-za dell’erudito romano emergono numerosi dettagli circa le spese editoriali, l’onorario, la lingua scelta per il commento, il confezionamento delle tavole e del testo :
Circa la raccolta delle Lucerne si farà diligenza perché se qualcuno applicarà alla spesa della stampa dei tomi, e chi sa che il med.o de Rossi non l’accetti, dunque per abbreviare la strada, e giachè V.S. non ricusa la fatica d’illustrarle, mi avvisi pure liberam.e il num.o degli esemplari, che vorrà dopo perfezzionata l’opera, acciò concludendo abbia soddisfare l’una parte e l’altra, e si ricordi che il domandare precisam. in principio del trattato, non sconclude punto ; onde faccia le sue riflessioni, e poi m’avvisi ; in ordine poi allo scriverla latina, farà certo più commercio, precisam. agl’oltramon-tani e motivai solo perché chi si trova il tom. del Santi Bartoli, accompagnerebbe il suo nella lingua med., ma qui non credo consisterà alcuna difficoltà. La difficoltà io la restringo ad un altro punto, cioè, che stampandosi costì l’opera, che non può farsi a meno per causa delle correz., se dovrà ella mandar qua i corpi stampati per aggiungere i rami a suoi luoghi, o se di qua dovranno mandar costì i rami per farli tirare, che l’una, e l’altra cosa merita riflessione, ma il tempo darà consiglio. 1
Il nome dell’editore De Rossi che Francesco Vettori ipotizzava nella missiva, era con-fermato con soddisfazione pochi giorni dopo : « tenga per sicuro il negozio con il Rossi, circa le lucerne ». 2 Che la più importante famiglia di editori romani si fosse fatta carico delle spese è riscontrabile anche nell’indice delle stampe di Lorenzo Filippo del 1729, dove si legge : « Si stà facendo una nuova aggiunta al libro delle Lucerne antiche ». 3 Il lavoro intorno all’edizione cominciò immediatamente e da Roma Vettori inviò al corri-spondente fiorentino i primi settanta disegni di lucerne. 4
La corrispondenza del cavaliere curiosamente omette l’identità del disegnatore, rive-lata solo nella missiva dell’8 maggio, dietro intuibili sollecitazioni del Gori :
Dovrebbe questa lettera esserle grata quanto ogn’altra scrittale fin ora, perciò togliendo ogni su-perfluo esordio, le darò nuova, come, credo d’aver fissato il trattato delle consapute lucerne, colla
1 bmf, Fondo Gori, ms. A 63, c. 78r, lettera inviata da Roma in data 28 febbraio 1728.2 Lettera del Vettori da Roma il 6 marzo 1728 (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 136r ; vedi anche la successiva
lettera del 13 marzo alla c. 138r-v). Tra le annotazioni di Gori che registravano in latino le informazioni più importanti tratte dalle lettere di Vettori, leggiamo : « Epistola dic. 8 [sic] Martii 1728. Conventione firmatum ut, Lucernas antiquas incidendas curabit suis sumptibus Rubeus Bibliop. et dabit premium triginta exempla-ria. Lucernas […] delineavit accuratissime Eques Petrus Leo Ghezius Pictor celeberrimus Romae, qui etiam complures […] lucernas possidet. » (bmf, Fondo Gori, ms. A 77, c. 207v).
3 Indice delle stampe intagliate in rame a bulino, e in acqua forte esistenti nella Stamparia di Lorenzo Filippo de’ Rossi, Roma, 1735, p. 19, in Indice delle stampe intagliate, cit., pp. 178-179, 389, dove la studiosa puntualizza che la voce compare già nell’Indice del 1729.
4 « Sento con piacere grandissimo che abbia ricevuto dal S.r March.e Niccolini l’involto de 70 disegni invia-toli, e godo che le siano piaciuti, come pure al S.r Andreini : il num.o de 100, si compirà senz’altro, ma non posso altro dirle se questo che mi richiede, fino al ritorno in Roma della persona, che li ha dati, il che seguirà fra poco, e presto sentirà il progresso del trattato : ella ne tenga tutto quel conto che devesi mag.re delle cose proprie, e solleciti a rimandarle, e per meglio discorrerla per Lettera, potrà farmi a ciaschedun foglio il num.o romano da una parte con il lapis piombino, acciò possa con facilità cancellarsi, senza machiarsi il foglio, che però potrà farne appresso di se un indice, e una breve descriz.e, che li servirà per studiarvi sopra rimandan-domi i disegni originali, e qua non mancarà di chi prevalersi per l’intaglio » (lettera del Vettori da Roma il 1° maggio 1728, bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 152r).
ghezzi, gori e vettori: un progetto sulle lucerne antiche 113
riserva, se così sarà di sua soddisfaz.e [illeggibile] stabilito, che V. S. averà per le sue illustraz., il num. di 30 corpi, poiché saranno stampate, com’ella già mi motivò tempo fa, e resta ancora stabi-lito, che qua il Rossi attenderà alla spesa dell’intaglio delle 100 lucerne, pensando esso a farle tirare in carta a tutte sue spese, qui in Roma, dovendo V. S. pensare a far stampare costì tutte le sue note, le quali con num.i chiamaranno le tavole, come nel S.ti Bartoli, e così dovrà ella pensare alla spesa della carta per tutto quello s’apparterno alli caratteri ; per quello poi monteranno queste spese : si daranno a cotesti stampatori tanti corpi de libri alla ragione di tanto per cento, che si fissarà nel pregresso del trattato, e per meglio spiegarsi : si manderanno di qua tanti corpi delle stampe, che loro vorranno per loro rimborso, e di costì dovranno essi loro mandare in Roma tanti corpi delle note, come si restarà d’accordo. Potrà ora, se così le piacerà di avanzare il trattato, che mi pare per una parte e l’altra ragionevol cosa, sentire costì lo stampatore, e dirmi le sue pretensioni circa il num.o dei corpi delle stampe, che di qua vorranno, ed in appresso si discorrerà del resto. Fissi intanto il num.o de’ libri, che pensa stampare, che questo servirà loro di regola per domandare, e qua similm.e per condurre a fine il negoziato. Sono questi disegni del Cav. Pietro Leone Ghezzi pittore celebre qui in Roma, il quale è anco possessore della maggior parte delle med.e lucerne, ma rimandando ella i disegni numerati, si dirà poi meglio [illeggibile] per num.o di chi saran-no. Ora potrà intendere quello [che] scrissi tempo fa, in cifra perché egli con il Rossi daranno il compim.o al Colomb.o, e forse tenne adietro alla dedica al Cav. Di Polignach, che meditava V.S., ma dove trattasi del publico vantaggio delle lettere, ceda pure il privato, ed attendasi con calore all’impresa : egli me li ha dati volontieri e questo risarcirà il passato. 1
Ebbene, che cosa aveva scritto « in cifra » il Vettori al Gori ? Perché l’invio dei disegni delle lucerne da parte del Ghezzi doveva risarcire un danno passato ? La spiegazione sembra essere racchiusa nella vicenda editoriale del citato Monumentum sive columbarium liber-torum et servorum Liviae Augustae et Caesarum Romae detectum in via Appia anno 1726 del Gori, pubblicato a Firenze nel 1727 con la fondamentale collaborazione del Vettori e di Girolamo Odam. A darcene conto è ancora una volta la corrispondenza del cavaliere. La scoperta della necropoli oggi scomparsa, comunemente chiamata il colombario dei liberti e degli schiavi di Livia, aveva immediatamente destato in molti il desiderio di do-cumentarla. L’opera del Gori venne dunque concepita in concorrenza con un’altra scrit-ta da Francesco Bianchini e corredata da sette tavole disegnate da Antonio Buonamici e incise da Girolamo Rossi. 2 In una lettera datata 3 maggio 1727, che da Roma il Vettori indirizzava al Gori, si annunciava l’avvenuta pubblicazione del volume di Bianchini, sol-lecitando il prelato fiorentino a non posticipare ancora l’uscita del suo. 3 Tuttavia Gori non dovette essere molto preoccupato dal colombario del Bianchini, perché la sua ope-ra sarebbe stata in latino, assicurandosi così il mercato straniero, ed avrebbe contenuto quasi ottanta testi epigrafici in più. Quel che invece poteva costituire un serio danno, gli era stato anticipato dallo stesso Vettori nel febbraio 1727 :
Circa la dedica, questa si consigli seco stesso, solo voglio soggiungerli una cosa già che mi motiva il Card.e di Polignac, ed è questa che forse il Sig. Ab.e Andreini, che è informato per il passato di [illeggibile], ne restarà maravigliatissimo, ma oggi le amicizie son finte, e l’esperienza n’è pur-troppo maestra. Il Cav. Ghezzi, che tempo fa appuntò gli disegni, che la prima volta il med. S.r Ab.e rimandò in Roma, se bene non si vidde, altro che in mia Casa, dove si trovò, allor che gli
1 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 154r-v, da Roma, 8 maggio 1728.2 Camera ed iscrizioni sepulcrali de’ liberti, servi, ed ufficiali della casa di Augusto scoperte nella via Appia, ed illu-
strate con le annotazioni di monsignor Francesco Bianchini veronese l’anno mdccxxvi, in Roma, appresso Giovanni Maria Salvioni, nell’Archiginnasio della Sapienza, 1727 (ristampa anastatica con una nota di lettura e una tavola di confronto di Jerzy Kolendo, Napoli, c. 1991).
3 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 56v.
veronica carpita114
riscosse da il Procaccia, e ne mandai al med. [illeggibile] il viglietto originale ostensibile, che fu causa, che l’opera si proseguisse, come felicem.e è andata avanti, tanto che è prossima a uscire alla luce ; ora intendo, che il med.o Ghezzi sia il promotore dell’impressione che se ne farà dal De Rossi alla Pace, ma questo non le dia pena, che spero non darà molta suggez.e alle loro fatiche ; il punto è che il med.o è amiciss. del Card.e di Polignac, e non so, se l’abbia prevenuto, o se possa divertirlo, arrivandolo a penetrare, perciò faccia i suoi conti, mentre così passano le cose. 1
Ghezzi pur essendo a conoscenza del progetto di pubblicazione del colombario da parte del Gori, aveva deciso di entrare in concorrenza con il prelato facendo stampare i suoi disegni dal De Rossi e contando sull’appoggio del cardinale Melchiorre di Polignac, am-basciatore del re di Francia e promotore degli scavi del colombario. Il ruolo del cardinale aveva fatto sperare fino a quel momento al Gori la possibilità di dedicare a lui il suo volu-me, ottenendo così il finanziamento delle spese di pubblicazione. Il progetto editoriale del Ghezzi fece definitivamente svanire le sue speranze. Nell’ottobre 1727, l’intenzione del cardinale di Polignac di far proseguire gli scavi nelle adiacenze del colombario, indu-ceva il Vettori a stimolare l’amico fiorentino. 2 Data infatti l’impossibilità di accedere alle nuove scoperte gelosamente custodite per essere illustrate nell’opera del Ghezzi, il Gori doveva dare alle stampe il suo colombario quanto prima. Non sappiamo con precisione la data, ma il volume fiorentino dedicato all’arcivescovo Marco Antonio Ansideo uscì fra l’ottobre e il dicembre del 1727, appena prima che gli scavi rivelassero la seconda parte del colombario. 3 La necessità di completare il colombario del Gori con le nuove scoper-te, fece ipotizare al Vettori la ristampa dell’opera con le aggiunte, oppure la stampa di un secondo tomo contenente solo le novità. 4 Tuttavia la progettazione dell’impresa, di cui la corrispondenza reca traccia fino al 1734, dovette arenarsi per svariati motivi : né il Gran Duca 5 né il De Rossi, già impegnato con il colombario del Ghezzi, erano disposti a finanziare l’impresa ; in secondo luogo Odam si dimostrò inaffidabile nel compito di
1 Ivi, c. 34v (Roma 15 febbraio 1727).2 « Direi che V. S. solleciti più che può la sua edi.e perché forse oggi si darà mano alla cava nella vicina vigna
a questa del Colomb.o, in cui senza dubbio sarà il rimanente di questa fabrica, e tardando la pubblicaz.e ella s’impegna al rimandare ancora, che sarà molto difficile averlo, perché vi s’interessa il Card. Di Polignac, che farà tener sempre chiuso » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 100v, lettera da Roma il 2 ottobre 1727).
3 « In [illeggibile] Colomb.o, è quasi terminata la nuova scoperta, dove anno trovato circa 50 altre inscri-zioni, la scala, alcune terre cotte, alcuni metalli, fra questi due pezzetti assai piccoli ma dorati, egizi, et alcuni lacrimatorj di vetro, et dicono una stufa, la quale non ho veduto ; se questo è, comprovasi, che sopra il vecchio Colom.o vi fosse abitaz.e, destinata forse per il custode del sepolcro : le cose perciò finora caminano con somma gelosia, ne posso pro[…]rmi di cosa alcuna per più, e varj riflessi : il Card.e di Polignac, credo, riceverà la dedica di quello [che] si stampa dal De Rossi, essendo interessato nella cava che corre a nome suo, perciò la rimessa è totalmente aliena » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 127r-v, lettera del Vettori da Roma in data 7 febbraio 1728).
4 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 129r (Roma 14 febbraio 1728) : « L’ediz.e del Colomb.o che si farà dal Rossi con tutte le nuove scoperte, sento che sarà brevem.e spiegata, e illustrata dal Pre. Ab.e della Pace qui di Roma, ch’è Generale de Rocchettini, e si farà in lingua toscana, prima però, che si pubblichi vi converrà forse tutto l’anno presente, lavorandosi lentamente, e dopo, che sarà fuori, potrà V. S. a suo bell’agio, o ristampare il suo con le aggiunte, o pure dare in un secondo tomo le cose nuove solamente ; che molto ancora vi sarà da scrivere, perciò nel leggere, noti pure tutto ciò, che troverà di più intorno agl’ufficj de Liberti, per servirsene poi a suo tempo, che tutto sarà vantaggio, trovandosi la sel.ne già fatta ».
5 Vettori scrive da Castel Gandolfo il 22 ottobre 1728 : « Mi dispiace sentire quel pretereaque nihil in proposi-to della presentaz.e del Colomb.o al G. Duca, parendomi troppo poco la sola lode, o ammiraz.e. ma che paia strano a V. S. sentire, e vedere le ricompense esorbitanti ad ogn’altro, che agl’amatori delle lettere, questo mi giunge nuovo, credendo che più volte avrà letto il Boetio Severino de Consolatione Philosophiae, dove molti belli casi si leggono. » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 189v).
ghezzi, gori e vettori: un progetto sulle lucerne antiche 115
disegnare i reperti ; 1 e in ultima analisi alcun successo ebbe il suggerimento del Vettori all’Odam di donare i disegni del colombario al cardinale Pietro Ottoboni (1689- 1740) nella speranza che accettasse di essere il dedicatario dell’opera. 2
Nel frattempo l’attesa pubblicazione del colombario del Ghezzi, uscito nell’agosto del 1731, 3 si rivelò deludente poiché, come disse Vettori al Gori, « quanto mai sia scorretta, non saprei spiegarlo, e lo dico con rossore, parendo, che più esatta non dovrebbe uscire da altri luoghi e pure l’ediz.e di V. S. è molto più corretta di questa ». 4 Il costo proibitivo dell’opera finanziata dal cardinale di Polignac, formata da 40 tavole di grande formato con ampie spiegazioni, 5 il cui maggior pregio consisteva nell’apparato illustrativo piut-tosto che nell’attendibilità delle trascrizioni epigrafiche, 6 limitava già in partenza la for-tuna dell’opera, inducendo probabilmente Gori, impegnato nel frattempo in altri studi, ad abbandonare il progetto di aggiornamento del suo volume. Uno dei tanti impegni editoriali che assorbivano completamente le energie dell’erudito fiorentino in quei mesi era appunto il commento alle lucerne del Ghezzi, presentato dal Vettori come un affare comune, capace di sanare gli attriti del passato. Le lunghe e complesse fasi dell’accordo editoriale furono negoziate dal cavaliere a partire dal maggio 1728 :Quanto alla raccolta delle lucerne risponderò con poche parole alli diversi progetti, avendo oggi appunto parlato al C.r Ghezzi, il quale mi dice, che con il Rossi non si è preso mai positiva parola, ma è stato fin ora puro discorso, perciò giacchè cotesti stampatori pigliaranno volontieri sopra di se il peso de rami, e de caratteri ancora nell’istesso tempo, fermi pure con essi loro il partito, e si taglieranno in questa forma tante cavillaz., e sua restarà la dedica com’ella vuole, mentre il med.o è stracco per altre faccende del sud.o Rossi : essendo che la misura de disegni corrispondono per appunto a quelle del S.ti Bartoli, perciò non saprei approvare che si scrivessero in latino le note, dovendo queste servire di seguito a quelle. Vorrebbe per altro il med.o S.r Ghezzi, se fosse pos-sibile, che qua s’intagliassero i rami, et assisterebbe il med.o alla correzz.e di chi opera, veda se vorrebbero accudire i med.i stampatori a questo, altrimenti converrà che mandino qua i fogli di mano in mano che s’intagliano per farli correggere, e rivedere. Procuri intanto di sollecitare ciò che le dissi per ritornarmi i disegni originali, acciò si possa continuare il num.o de med.i fino al compim.o de 100, e perché non se ne facciano inutilm.e de duplicati, et io le dissi la congiunz. per la quale potrà rimandarli sicuri. Ella si conservi, e dopo che averà concluso quanto andavo sopra dicendo, credo che sarà bene, che ne ringrazi l’autore, ma ne veda prima la conclusione. 7
1 Cfr. le lettere del Vettori inviate al Gori da Roma in data 26 aprile 1732 (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 9, c. 148r), 16 agosto 1732 (ivi, c. 163v), 19 agosto 1732 (bmf, Fondo Gori, ms. A 63, c. 159r), 24 gennaio 1733 (ivi, c. 171r), 6 marzo 1734 (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 9, c. 218v), 3 aprile 1734 (ivi, c. 226v).
2 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 9, c. 228v (Roma 10 aprile 1734).3 Questo il titolo completo : Camere sepolcrali de’ liberti e liberte di Livia Augusta e d’altri Cesari, Roma, Loren-
zo Filippo De Rossi, 1731.4 Lettera spedita da Roma il 25 agosto 1731 (bmf, Fondo Gori, ms. A 63, c. 147v). Cfr. ibidem quanto Vettori
lamenta a proposito dell’opera del Ghezzi : « Gran disgrazia di q.ti monumenti che capitano male così : in somma di quest’opera si lodarà sempre la magnificenza, per la spesa grandissima con cui è stata eseguita, ma non la fedeltà, essendo nel transcriverle più d’una inscriz.e stata alterata : di q.to si compiaccia non parlarne, e lasci che altri facciano la giustizia alle sue fatiche ».
5 Vedi la missiva del Vettori da Roma in data 4 febbraio 1729 : « Il Colomb.o di Roma ancora stà in mano di chi lo illustra, che è un certo Ab.e Aloisia Napolitano, e non già il Pre. Ab.e della Pace Rocchettini, come parmi averle detto, perché anno mutato idea, e vogliono fare le note generali » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 203r).
6 Con una lettera inviata da Roma il 1° settembre 1731, Vettori inviò al corrispondente fiorentino la tra-scrizione delle iscrizioni inedite pubblicate nelle Camere sepolcrali del De Rossi, commentando che esse sono disposte « non seguitando l’ordine di Mons. Bianchini, né le categorie di V. S., ma essendo messe giù iure cervellotico, senza verun metodo » (bmf, Fondo Gori, ms. A 63, c. 149 r-v).
7 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 156v (missiva da Roma in data 15 maggio 1728).
veronica carpita116
Proprio con l’autore dei disegni, il cavalier Ghezzi, Francesco Vettori dovette impiegare tutte le sue doti di paziente mediatore. 1 La richiesta dell’artista di ottenere trenta copie dell’edizione dovette apparire eccessiva agli stampatori medicei ai quali Gori aveva affi-dato l’opera, 2 e così il compenso venne riformulato al ribasso. 3 Alla fine del settembre 1728, Gori puntualizzò le condizioni dell’accordo economico, prontamente riferite da parte del Vettori al Ghezzi : 4
Parlai al S.r Ghezzi in questi giorni per il consaputo affare, quale trovai poco disposto a parlare, pure in fine alle sue instanze, che le ne feci, per venire a conclusione, disse, che si contanterebbe di due esemplari, stampato che sia il libro, e circa la ricognizione, si contentarà della med.a, che sarà accordata a V.S., onde potrà concludere, ed a 9.bre mi avvisarà poi, acciò possa comunicare qualche cosa al med.o. Ha esagerato però molto circa l’esattezza de disegni, quale meriterebbero altra ricognizione, ma anche a mio intuito, se ne starà a quanto ho detto di sopra : egl’è valent’Uo-mo, e si conosce, ne si può con esso trattare come con il mio S.r Cav.r Odam, che ci fa godere qualche vantaggio. 5
Le trattative ben condotte dall’erudito romano con l’esigente cavalier Ghezzi, che « non è huomo da trattarsi così facilmente », 6 subivano tuttavia fastidiose battute d’arresto a causa degli sviluppi fiorentini mal controllati dal prelato. 7 Le risposte del Gori, pro-babilmente con fare più temporeggiatore che conciliatore, non riuscivano a risolvere
1 « Ho combattuto lungam.e il C.r Ghezzi, che non voleva in verun conto spiegar il suo genio circa gl’esem-plari delle lucerne, ma finalmente ne ho ricavati ch’egli di sua porzione ne vorrebbe 30 esemplari, ripigliandosi ancora li suoi disegni originali. Ora potrà meglio discorrerla costì, e mi dice che nel numerare i disegni, non li segni altrim.i con il lapis piombino, come le dissi, ma del lapis nero, che più facilm.e si cancelli » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 158v, da Roma il 22 maggio 1728).
2 Al riguardo si legga anche il passo dell’epistola del Vettori scritta a Roma il 26 giugno 1728 : « ella non mi replica altro sul discorso delle lucerne, doppo la domanda del S.r Ghezzi, ed egli mi fa instanza di risaperne qualche cosa, però se da cotesti stampatori ne ha ricavato la loro intenzione circa i corpi che vorranno accor-darli per li suoi disegni, farà bene a dirmelo. » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 167v).
3 « Il S.r Ghezzi mi dice, che si contentarà delli 2 o 3 esemplari, come m’accenna V.S., e giachè in denaro vorrebbono sodisfarlo, per il restante prenderebbe l’equivalente della stima de corpi delle lucerne, che do-mandava, ma mi ha detto ancora, che se ne starà a quello, che concluderà V.S., perciò potrà intendersela con cotesti stampatori, e siffare una cosa discreta, e poi me ne scriva, che gli leggerò il cap.[itol]o, e non credo, che replicarà » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 172r, lettera da Roma il 10 luglio 1728).
4 « Il C.r Ghezzi disse tempo fa alcuna cosa circa le sue pretensioni, che parmi averle accennato : ora le farò sentire il capit.o dalla sua lettera, per ricavarne risposta definitiva » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 184r : lettera del Vettori da Roma datata 25 settembre 1728).
5 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 187v (da Roma il 2 ottobre 1728).6 « Il S.r Ghezzi non è huomo da trattarsi così facilmente, ed egli è solito aver de’ grossi regali per bagattelle,
ed ultimamente ho veduto nelle sue mani un medaglione d’oro con il ritratto del Re di Polonia mandatole in regalo per aver assistito solam.e a quelli, che lavoravano un arazzo con il ritratto del med.o Re, e poteva certam.e pesare circa 2 libre. Dico questo acciò formi il concetto della persona con la quale non si può trattare tanto minutam.e le cose. Ma vedrò con modo, e con tempo di riacquistarlo. » (lettera del Vettori da Roma il 29 gennaio 1729, in bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 201v).
7 « Mi par di conoscere dalla sua de 12 corr.e, che cotesti ministri della Stamperia di S. A. R. siano già stan-chi dell’opera delle lucerne, che li progettai : io non volevo rispondere altro su questo punto ; tuttavia, perché ogn’altra cosa, che V.S. mi ha scritto l’ho comunicata al S.r Ghezzi, in fine ho stimato di parteciparle ancor questa. Se bene altre volte mi ha scritto l’istesse cose egli è andato altam.e in collera, quasi che costì diffidano della scelta delle cose, e che i disegni non siano essere tutti dell’istessa qualità, e che infine egli sia per recedere da ciò che altre volte l’ho detto ; che non è capace, per ciò che io lo conosco, di farlo. Perciò se vorrà scriverle, le scriva pure, ma io non m’impegno di ciò che potrà contenere la sua risposta : queste che io dico in persona del med.o, potrei dire, con più ragione io stesso ; ma facciamo pure che non è bene entrare in querele. » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 199r, da Roma il 22 gennaio 1729).
ghezzi, gori e vettori: un progetto sulle lucerne antiche 117
l’imbarazzante situazione : 1 ancora tre anni più tardi, quando ormai la centuria delle lucerne era pronta e si attendeva all’incisione delle prime tavole, le divergenze risorsero più aspre che mai :
Il S.r Ghezzi era intestatissimo di non dare i disegni delle lucerne, senza la ricompensa di scudi cento, che forse averà scritto costà ad alcuno. Ma pure mi è riuscito di ridurlo a contentarsi delli scudi cinquanta, ma delli esemplari mi ha detto volerne per se quattro, non due : a me pare che possono accordarsele, ma non le ho dato risoluzione, e V.S. potrà conferire il negozio con chi si prenderà l’assunto della spesa, a me ne darà poi con suo comodo avviso, e l’avverto che gl’origi-nali disegni dovranno rimandarsi indietro, doppo che se ne saranno serviti. 2
Nel marzo 1732, l’estenuante diverbio venne definitivamente sanato da un accordo, me-diato per l’ennesima volta dal pacificatore Vettori :
Il trattato con il S.r Ghezzi resta concluso, essendosi concordato ne i scudi 50 e 4 esemplari, ed egli vuole che io le dica, che viene a questo accordo perché tratto io questo negozio, che altrimenti sarebbero molto più alte le sue pretensioni, ne io le dico questo per farmi merito seco lei, cono-scendomi ella molto bene a quest’ora, ma perché così egli desidera che io le scriva. 3
Nei tre anni successivi il lavoro di Gori sulle lucerne non registrò avanzamenti signifi-cativi cosicché Ghezzi incalzava Vettori affinché si prendesse partito ed eventualmente lo si lasciasse libero di accettare altre proposte di pubblicazione delle sue lucerne. 4 Gori dovette confermare a Vettori le sue intenzioni di procedere con l’edizione, ma al solleci-to di corrispondere i 50 scudi concordati, 5 propose di rinegoziare l’accordo :
comunicai la sua lettera [a Ghezzi], la quale sentì volentieri, e vedo che non è lontano da accettare il progetto che V.S. gli fa ; dice pertanto che riceverà il cammeo della Baccante purché sia tale qua-le ella lo descrive, e d’indubitata antichità, e con esso il libro delle Statue del Museo del G. Duca e la riverisce ossequiosamente. 6
L’anello con la Baccante che Vettori ricevette giudicandolo « bello, e antichissimo fuor da ogni dubbio » 7 non piacque a Ghezzi che chiese, e ottenne, i tre tomi del Museum Florentinum oltre a due esemplari (non più quattro) del volume delle lucerne. 8
4. I disegni di Pier Leone Ghezzi tra Roma e Firenze
Le vicende relative al corredo illustrativo del progetto prendono le mosse dalla citata lettera di Vettori che in data 1 maggio 1728 registrava l’invio a Firenze di 70 disegni di Ghezzi. Questi tornarono a Roma nel settembre dello stesso anno, 9 dopo che il cava-
1 « Comunicavo al S.r Ghezzi quanto, mi scrive, e credarei di capacitarlo ; ma io mi ricordo d’averle scritto da principio, che egli sarebbe stato a quello che loro avessero stimato proprio ; onde non dubito, che queste repliche ancora l’abbiano esacerbato, non essendo egli uomo da stiracchirsi come ne averà talora da altri relazione » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 203v, da Roma il 4 febbraio 1729).
2 bmf, Fondo Gori, ms. B viii.9, c. 138r (da Roma il 16 febbraio 1732).3 Ivi, c. 141v (da Roma l’8 marzo 1732).4 Lettera di Vettori da Roma il 12 febbraio 1735 (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 10, c. 23r). Effettivamente alcuni
disegni di lucerne conservati nell’Ott. Lat. 3102 furono incisi da Piranesi (Carlo Gasparri, La Galleria Piranesi da Giovan Battista a Francesco, « Xenia », 3, 1982, pp. 91-107, 99).
5 Lettera di Vettori da Roma il 5 marzo 1735 (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 10, c. 21v).6 Lettera di Vettori da Roma il 19 marzo 1735 (ivi, c. 24r).7 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 10, c. 26r (Roma il 16 aprile 1735) ; ivi, c. 38r (Roma l’11 giugno 1735).8 Ivi, c. 30r (Roma il 23 aprile 1735).9 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 184r (da Roma il 25 settembre 1728).
veronica carpita118
liere ne aveva sollecitato la restituzione « per il proseguim.to, [e] per sfuggire la fatica inutile di duplicarli, dicendomi il S.r Ghezzi, che non s’è serbato ne pure la misura de fogli, cioè della luce de med.i disegni ». 1 Ai primi di maggio del 1729 Gori ricevette altre 23 immagini di lucerne, 2 restituite dopo molte pressioni nel settembre. 3
Testimone del lavoro di studio del prelato su questi 93 disegni di lucerne è la Descri-zione di lxix Lucerne antiche disegnate dal Cav.r Ghezzi, comprate a mia instanza dai Ministri della Stamperia Granducale. L’anno 173…. 4 Gli appunti, stilati dietro suggerimento del Vet-tori, 5 si riferiscono alle 70 (ma la Descrizione ne elenca 69) lucerne disegnate dal Ghezzi e inviate dall’erudito romano nel maggio del 1728, e contiene anche un elenco sommario delle 23 inviate l’anno successivo. 6
Dalle citate missive di Vettori risalenti alle fasi iniziali del progetto editoriale (1728), ricaviamo che l’intaglio dei rami sarebbe dovuto avvenire a Roma, sotto la direzione dello stesso Ghezzi e a spese dell’editore De Rossi. Benché il cavaliere affermasse di te-ner « per sicuro il negozio con il Rossi », 7 Gori doveva contemporaneamente adoprarsi affinché tutte le fasi della composizione dell’opera (la spesa dei caratteri, della stampa del testo, dell’intaglio dei rami e della loro impressione) si svolgessero a Firenze per cura della stamperia medicea. 8 L’erudito fiorentino sperava evidentemente nella pro-tezione dell’ultimo Granduca de’Medici al quale – caduta la candidatura del cardinale Melchiorre di Polignac – avrebbe voluto dedicare l’impresa. 9 Per suscitare l’interesse di Gian Gastone (1723-1737) e convincerlo a finanziare il volume, Gori aveva pensato in primo luogo di pubblicare delle lucerne etrusche e in seconda battuta di convincere il De Rossi a concedere i rami del Bartoli agli stampatori fiorentini. Purtroppo entrambi i tentativi non sortirono gli effetti sperati. Le difficoltà di reperire pezzi etruschi ren-deva impossibile ricorrere alla pur sempre efficace retorica dell’Etruria 10 e gli interessi
1 Ivi, c. 162v (da Roma il 29 maggio 1728) ; vedi anche la lettera di Vettori a c. 179v datata 4 settembre, in cui raccomanda al Gori di « ben involtare i disegni delle lucerne, acciò non patiscano ».
2 Dell’invio parlano due missive (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 213r, da Roma il 9 aprile 1729 ; ivi, c. 219r, da Roma il 30 aprile 1729) ; che i disegni fossero giunti nelle mani del Gori lo testimonia una terza lettera del 7 maggio (ivi, c. 222r).
3 « Io li raccomando i disegni di quelle lucerne, perché il S.r Ghezzi (huomo di gran fuoco) è formalizzato molto di tanta dilazione ; veda che almeno tornino ben condizionati. » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 239r, da Roma il 13 agosto 1729) ; vedi anche le missive del 28 maggio 1729 (ivi, c. 227v), del 2 luglio (ivi, c. 236r) e del 30 luglio (bmf, Fondo Gori, ms. A 63, c. 223r). Il 17 settembre finalmente Vettori scrisse al Gori la conferma che alla dogana era stato recuperato l’involto contenente i disegni (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 247v).
4 bmf, Fondo Gori, ms. A 6, cc. 286-362. 5 Vedi la già citata lettera del Vettori da Roma 1 maggio 1728 : « potrà farne appresso di se un indice, e una
breve descriz.e, che li servirà per studiarvi sopra rimandandomi i disegni originali, e qua non mancarà di chi prevalersi per l’intaglio. » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 152r).
6 Mentre le lucerne del primo e più cospicuo nucleo furono descritte dal Gori con accuratezza e il loro elenco è arricchito da piccoli disegni di dettagli utili al loro studio, delle successive fu frettolosamente stilata una lista dal titolo Lucerne di Roma, inserita dopo la descrizione della trentesima lucerna.
7 Missiva citata del 6 marzo 1728. 8 Lettera del Vettori da Roma il 17 luglio 1728 (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 173v) : « dovendo ella di-
scorrere con cotesti stampatori, potrebbe anche sentire di che opinione sono, circa il fermare l’intagliatore, venendone richiesto da queste nostre [illeggibile] a cui ne fu parlato da principio ». Vedi anche la missiva del 18 settembre 1728 in cui Vettori ribadisce : « Qua l’incisore a cui ne fu parlato resta ancora con l’aspettativa di qualche risoluzione, la quale con suo comodo se li potrà dare. » (ivi, c.183r). Dal 1732 Rosso Antonio Martini era il soprintendente della stamperia granducale.
9 « Anzi voglio sperare che forse potrà anche farle passare in camera di S. A. R. i disegni delle lucerne per coadiuvare l’intento », lettera di Vettori da Roma il 30 aprile 1729 (ivi, c. 217v).
10 Lettera di Vettori da Roma il 4 settembre 1728 (ivi, c. 181r) : « non so se potrà riuscire l’avere nell’opera
ghezzi, gori e vettori: un progetto sulle lucerne antiche 119
imprenditoriali del De Rossi alla ristampa in proprio dei rami delle Antiche lucerne sepolcrali vanificavano le speranze di far arrivare a Firenze le matrici incise da Bar-toli. 1
Nel frattempo, a Roma Pier Leone Ghezzi lavorava a nuovi disegni di lucerne. Dei 93 complessivamente ricevuti, Gori aveva selezionato quelli con i reperti più interessanti dal punto di vista dell’iconografia e della lavorazione : 2 Vettori infatti, aggiornandolo sull’incremento della centuria, gli comunicava nel maggio del 1730 di aver raggiunto il numero di 80 pezzi circa 3 e si era impegnato ad arricchire l’opera anche con alcuni candelabri. 4 L’annuncio del compimento della centuria venne dato alla fine del 1730, 5 ma non dovette sollecitare una pronta risposta del Gori, tant’è che Vettori scrisse nuo-vamente nel marzo dell’anno successivo : « per l’opera delle Lucerne è oramai compiuta, essendone disegnate circa il num.o di 120. Se bene alcune se ne potranno levare per contenersi nella centuria ». 6
Tra la metà del 1731 e l’inizio del 1732 Gori dovette convincere i ministri della stam-peria granducale a comprare le Lucerne antiche disegnate dal Cav.r Ghezzi 7 e a Firenze, come attesta la missiva di Vettori dell’8 marzo 1732, fu spedita una prima serie di disegni definitivi di Pier Leone, cui fece seguito l’anno successivo un ulteriore invio : 8
delle lucerne alcuna di esse con inscrizione etrusca, o greca, perché le stampate, in greco sono pochiss.e, in etrusco non ho memoria di averle vedute, ma le diligenze si faranno ».
1 Missiva di Vettori da Roma il 28 maggio 1729 (ivi, c. 227v) : « quanto alli rami delle lucerne del Santi Bartoli, sento che non vi sarà modo d’averli dal Rossi, tanto più che fa di buon luogo l’istanze replicate, che han fatto al S.r Ghezzi per farnegli med.o la continuazione con questo secondo tomo, pure sentirò anche meglio, ma veramente ne sentirebbe il med.o Rossi gran danno, per la vendita, che vorrebbe fare del tutto ».
2 Lettera di Vettori da Roma il 18 settembre 1728 (ivi, c.183r) : « Circa le lucerne dopo che l’averò ricevute, si potrà meglio discorrere dello scarto, che pensa farne, certo, che i dindaroli senza fig.re si possono lasciare in dietro, e basterà solo l’accennarli ». Si legga anche il passo della missiva inviata da Castel Gandolfo il 22 ottobre 1728 (ivi, c. 189r-v) : « il num.o delle 100 lucerne non dubito, che si compirà, e prima di partire da Roma, feci già lo scarto dei disegni, che mi parvero di poca, o niuna erudizione, in modo che restò il num.o sotto le 40, che si ricordarà era molto maggiore ; io non vedrò il med.o [Ghezzi] fino alla metà di 9.bre, e farò che disegni i candelabri Barberini, anzi una bella base triangolare d’altro candelabro, che ho veduta nel cortile del Palazzo Mediceo in campo marzio ». 3 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 9, c. 27r.
4 « Nulla posso dire a V. S. intorno alle cose che mi richiede circa le tav.e da aggiungersi alle lucerne. Se non che so esservi nella Casa Barberina due candelabri anticheggianti di marmo molto belli, e di forma rotonda, quali non sono cogniti al mondo letterario, ed a suo tempo si faranno disegnare. » (bmf, Fondo Gori, ms. A 63, c. 225r : Vettori da Roma il 31 luglio 1728). « […] nel Museo Sabbatini ho veduto un piccolo candelabro di metallo, dell’altezza di circa 2 palmi, che corrisponde giustamente alle nostre lucerne domestiche, nel mezzo del quale, […] vedesi un piccolo animaletto, quale allora non considerai molto, osservando solamente che in quel sito, solo v’era posto per uso di manubrio, per commodo di trasportare con facilità il candelabro dove si vuole, si che avanti ogni Lare portavasi, accommodava l’istesso candelabro oltre l’uso domestico, e quello del fu Sabbatini, lo vedrà disegnato con la raccolta delle lucerne. » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 9, c. 20r : Vettori da Roma il 29 aprile 1730). Vedi anche supra, nota 2.
5 « Per le lucerne veda V.S. che cosa vuol fare, che il num.o è già pieno, e mi avvisi. » (ivi, c. 77v, da Roma il 9 dicembre 1730). 6 bmf, Fondo Gori, ms. A 63, c. 135r, da Roma il 17 marzo 1731.
7 Vedi supra il citato ms. A 6, cc. 286-362, il cui titolo con data incompleta « 173… » deve integrarsi con la cifra 1 o 2.
8 Lettera di Vettori da Roma il 25 aprile 1733 (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 9, c. 181v-182r) : « L’opera delle lucerne è per se stessa compiuta e solo mancano i candelabri Barberini, i quali ancora non sono stati disegnati per negligenza crassa, ed il ricordarlo serve ben poco, ma piacendo al S.r, stimolarò il S.r Ghezzi fortemente al suo ritorno da Nettuno, che seguirà fra 8, o 10 giorni, come mi disse. Però io stimarei che sarebbe bene dar mano, ricevendo intanto i disegni delle lucerne, per non perder tempo e si potranno interim disegnare i candelabri, perché l’intagli non si posson fare tutti in una sola volta, e in questo mezzo farò ogni sforzo per averli, e credo sicuramente poterli promettere. Onde questo sarebbe il mio parere ».
veronica carpita120
quanto alli disegni originali, se potranno salvarsi, o tutti, o in parte sarebbe bene, e l’averei ca-rissimo, perché sono molto esatti, e più volte succede, che gl’intagliatori ad alcuni disegni anno maggior cura ; onde potrebbono raccomandarsi quando poi non si potranno salvare intieramen-te, forse ancora macchiati, non saranno da gettarsi nel fuoco ; sicché si starà a V.S. 1
Il lavoro degli incisori fiorentini, i più dotati dei quali erano in quegli anni già impegna-ti alle tavole del Museum Florentinum e del Museum Etruscum, 2 non dovette soddisfare Gori e così il lavoro d’intaglio venne affidato ad un artista romano che nelle lettere di Vettori non è mai nominato. Dopo che i disegni delle lucerne furono rispediti a Roma, nell’aprile-maggio 1735 due di essi vennero consegnati all’intagliatore per farne una pro-va 3 e i restanti rinviati a Firenze :
Vi sono ancora i disegni delle lucerne e sono in numero di 118 ; che gl’altri due pel compimento delle 120 sono appresso l’intagliatore, a cui ho commesso le prove, e promette gran cose. 4
Alle richieste di Gori di incidere due lucerne in un medesimo rame per dimezzare la spesa, Vettori replicava che l’operazione avrebbe nuociuto all’estetica e alla leggibilità delle tavole, nonché all’intenzione di realizzare il secondo volume alle Antiche lucerne sepolcrali dove in ciascun rame figurava una sola lucerna. 5 A questo scopo infatti Vettori aveva consegnato all’intagliatore il suo volume di Bartoli « acciò veda quello che deve imitare ». 6 Il 17 giugno 1735 partivano da Roma « le prime prove da i disegni delle lucer-ne » i cui « rami si potrebbero in qualche parte addolcire ». 7
1 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 9, c. 141v.2 Anton Francesco Gori, Museum Florentinum exhibens insignora vetustatis monumenta quae Florentiae sunt
Ioanni Gastoni Etruriae magno duci dedicatum, Florentiae, ex typographia Michaelis Nestenus et Francisci Mou-cke, 1731-1766, 12 voll. Idem, Museum Etruscum exhibens insignia veterum Etruscorum monumenta nunc primum edi-ta et illustrata observationibus Antonii Francisci Gorii publici historiarum professoris, Florentiae, in aedibus auctoris regio permissu excudit Caietanus Albizinius typographus, 1737-1743, 3 voll.
3 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 10, c. 26r-v (Roma 16 aprile 1753), c. 30r-v (Roma 23 aprile 1735), c. 32r-v (Roma 7 maggio 1735). 4 Ivi, c. 32r (Roma 7 maggio 1735).
5 Lettera del Vettori da Roma il 16 aprile 1735 (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 10, c. 26r-v) : « se mi darà i dise-gni vedrò di ordinare la prova all’intagliatore, ma che due lucerne si possano fare in un rame col medesimo prezzo, io non lo spero, e non so vedere che garbo possano pigliare queste tavole con due lucerne intagliate in ciascheduna di loro. Oltre di che se il libro dovrà accompagnare quello del Santi Bartoli, io vedo che riuscirà sempre una deformità questa variazione. Io già dissi che ero restato con l’intagliatore d’imitare l’intaglio, e le misure de rami del libro già intagliato. Mi avvisi dunque ciò che occorrerà e mi faccia vedere in che maniera intende che si possano collocare le due lucerne in una istessa tavola acciò si possa parlare coll’intagliatore, né io mi posso persuadere che V.S. vorrà che s’impiccioliscano le lucerne nell’intagliarle ». Si legga anche la suc-cessiva missiva scritta da Roma il 23 aprile 1735 (ivi, c. 30r-v) : « vedrò di ordinare la prova di una di esse lucerne […], ma quanto all’intaglio io torno a dire che non mi partirei dall’esemplare del Santi Bartoli, non sapendo come collocare due delle dette lucerne in un medesimo rame ; e però quando voglia che se ne faccia la prova in questa forma la prego, come già le dissi a mandarmene un’idea segnata in carta della misura che dovranno essere e non lasciarò di farla eseguire ».
6 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 10, c. 35r-v (Roma 21 maggio 1735).7 Lettera del Vettori da Roma il 17 giugno 1735 (ivi, c. 40v-41r) : « Ecco accluse delle prime prove de i disegni
delle lucerne che mi restarono. Questi rami si potrebbero in qualche parte addolcire, e mi pare che restareb-bono bene : ella li consideri e li faccia considerare, e poi mi mandi la sua risoluzione. Presentemente i rami sono appresso di me. Volendo che l’opera si continui da questo professore ci vorrà una ventina di scudi alla mano per la compra de rami e per suo assegnamento, non tornando conto all’artefice il farne due per volta, né tornarebbe bene per l’opra, atteso che dandosi l’acquaforte a 15 o 20 rami per volta verranno senza dubbio molto più uguali ».
ghezzi, gori e vettori: un progetto sulle lucerne antiche 121
Le prove di stampa non accontentarono Gori 1 che un mese più tardi riceveva « altre prove delle lucerne consapute, migliorate un poco ». 2 Queste non furono giudicate posi-tivamente se il 17 settembre 1735 Vettori spediva a Firenze « i due rami delle lucerne, e la ricevuta della spesa per essi ». 3 Negli appunti che Gori stilava dalle lettere del corrispon-dente romano, troviamo il seguente : « Gio. Ba. Sintes intagl.e in rame per le lucerne », scritto probabilmente quando il prelato ebbe tra le mani le due matrici. 4 Il poco noto Giovan Battista Sintes (1680 ca-1760) fu incisore romano allievo di Benoit Farjat ; era spe-cializzato nella traduzione da architetture e apparati, da pitture con soggetti sacri, ma occasionalmente lo troviamo impegnato anche in incisioni dall’antico. 5
I disegni di Ghezzi acquistati dai ministri della Stamperia granducale risultano regi-strati nell’inventario dei beni della Stamperia del 1751 insieme alle due lastre intagliate dal Sintel : « N. 118 Disegni di Lucerne antiche fatti dal Cavalier Leone Ghezzi romano da incidersi e farne un libro » e « 2. Rami in quarto incisovi Lucerne antiche per stamparsi in una Raccolta già preparata ». 6 Ai due rami fu riservata la sfortunata sorte dei depositi di matrici di proprietà medicea che rimasero fino al 1771 nella Guardaroba granducale per essere poi disperse. 7 Dall’inventario delle incisioni della Galleria fiorentina redatto da Pelli Bencivenni a partire dal 1779, pare che non si siano conservate prove di stampa. 8
1 Lettera del Vettori da Roma il 25 giugno 1735 (bmf, Fondo Gori, ms. A 252, cc. 20v-21r) : « dicendomi ella che non crede possano piacere gl’intagli delle lucerne, non so a che cosa dovrò servirmene : io farò addolcire i rami e vedrò di mandarne altre prove sabato prossimo, parendomi dall’altra parte, che non dovrà servire questo [illeggibile], se non a quest’effetto, cioè di pagare l’intagliatore, essendo il S.r Ghezzi sudisfatto in altro modo secondo il concertato ».
2 Lettera del Vettori da Roma il 9 luglio 1735 (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 10, c. 42r) : « Accludo altre prove delle lucerne consapute, migliorate un poco, ma non a modo mio ; è certo che si accosta assai al taglio del Santi Bar-toli, ma è eruditissimo. La maniera di quell’uomo era sua particolare, e questa gente stima di guastarsi la mano con quest’opera, finita la quale pare loro che non gli debba servire quella maniera non essendo così frequente l’occasione dell’intagliare le cose antiche. Onde più volentieri l’intaglierebbero a gusto loro, che obligandosi a quell’imitazione, che è per loro molto penosa : il giovane però si obliga di acostarsi sempre più agl’originali del Bartoli. Io dico che loro costì si compiacciano giudicare e risolvere su quello che vedono, e non su quello che è da sperare. Se vorranno che si seguiti, mi manderà l’ordine, e con comodo i disegni ». Tutti gli antiquari del xviii se-colo condividevano il rammarico per l’assenza di un degno successore di Pietro Santi Bartoli considerato insupe-rato disegnatore e incisore di ogni sorta d’antichità. Per l’assai vivo dibattito sulla fedeltà dell’immagine a stampa rispetto all’originale, alimentato da Maffei, Bianchini e Gori, vedi Lucetta Levi Momigliano, I disegnatori e gli incisori in Piemonte per il Museum Taurinense e i Marmora Taurinensia, in Scipione Maffei nell’Europa del Settecento, Atti del convegno, Verona, 23-25 settembre 1996, a cura di Gian Paolo Romagnani, Verona, Cierre, 1998, 597-617.
3 Lettera del Vettori da Roma il 17 settembre 1735 (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 10, c. 54r).4 bmf, Fondo Gori, ms. B vii 24, c. 9r.5 All’epoca aveva intagliato alcune tavole delle Numismata summorum pontificum templi Vaticani fabricam
indicantia, pubblicate a Roma da Filippo Buonanni nel 1715 e del primo tomo del Museum Florentinum di Gori (Firenze 1731). Negli anni successivi avrebbe lavorato alle nuove tavole monetali della riedizione delle Numi-smata imperatorum Romanorum praestantiora di Vaillant (curate da Francesco Baldini, stampate a Roma nel 1743) e alle incisioni delle Gemmae antiquae litteratae di Francesco Ficoroni (Roma 1757).
6 asf, Miscellanea di Finanze 294, doc. 4 : « Repertorio di tutti gli Effetti e Mercanzie appartenenti alla Stamperia Granducale, che nella medesima esistevano il di 31 Luglio 1751 distinti in varie classi », cc. 103 e 123, in Alessandra Baroni, I Medici e l’incisione : le origini della collezione di stampe degli Uffizi, Doctoral thesis, Utrecht University, 2008 <http ://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2008-0307-200418/baroni.pdf>, pp. 202 e 208 ; vedi anche p. 111.
7 Cfr. Alessandra Baroni Vannucci, The Medici Collection of Engraved Plates, « Print Quarterly », xx, 2003, 4, pp. 349-368.
8 Giuseppe Pelli Bencivenni, Inventario generale delle stampe staccate e Libri ornati con esse della R. Galleria compilato nel 1779.1782.1783, Firenze, gdsu, ms. 463/18 1.2., trascritto dalla Fondazione Memofonte e consul-tabile all’indirizzo < http ://www.memofonte.it/home/files/pdf/inventario_generale_delle_stampe_staccate1779_1783.pdf>.
veronica carpita122
Pure i 118 disegni di Ghezzi dovettero disperdersi con le matrici, non avendone rinvenu-ta traccia negli antichi inventari del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. 1
Tuttavia nella vastissima produzione grafica di Pier Leone, in gran parte rilegata in 25 volumi che l’artista vendette il 10 gennaio 1747 al pontefice Benedetto XIV, esiste un codice di disegni interamente dedicato alle lucerne (bav, Ott. Lat. 3102). 2 Il volume è composto da cinquantadue disegni di lampade, precedute dal candelabro Barberini al quale è dedicata una lunga descrizione introduttiva e la cui riproduzione non fu mai spedita a Firenze. Altre sei lucerne sono ritratte nell’Ott. Lat. 3109 (cc. 29, 30, 35). I re-perti, disegnati a matita, inchiostro e acquerello, rispettano la presentazione frontale adottata nelle incisioni di Pietro Santi Bartoli in modo da rendere chiaramente leggibile l’iconografia che nella maggior parte dei casi decorava la parte superiore della lucerna. Ponendo a confronto la citata Descrizione compilata da Gori con questi disegni di Ghez-zi, abbiamo potuto riconoscere con sicurezza poco più di venti lucerne, 3 mancando per altri casi elementi di certa individuazione. Possiamo dunque ipotizzare che l’Ott. Lat. 3102 contenga i reperti scartati da Gori e da Vettori perché « di poca, o niuna erudi-zione » 4 e dunque restituiti a Pier Leone. Se così fosse, i disegni pur privi delle preziose didascalie che Ghezzi era solito apporre sui suoi fogli dall’antico (contenenti informa-zioni sull’iconografia, sul luogo e data del ritrovamento e sul collezionista), potrebbero convincentemente datarsi ante 1728 fino al 1733. Infatti quando nel febbraio 1728 Vettori propose al prelato fiorentino la « bella fatica » delle lucerne, si riferiva a disegni in parte già realizzati. 5
Questo dettaglio induce a riconsiderare la funzione dei disegni dall’antico di Ghezzi non preparatori per opere stampate (come le citate Camere sepolcrali de’ liberti e liberte di Livia Augusta e d’altri Cesari del 1731), fino ad oggi ritenuta limitata ad un uso personale, a supporto dell’attività di consulente e perito. 6 A sostegno dell’ipotesi che buona parte dei disegni antiquari di Ghezzi sia stata concepita con finalità editoriali attualmente sconosciute, rimandiamo ancora una volta ad una missiva di Vettori che nel marzo 1729 proponeva a Gori tre nuovi progetti editoriali : la ristampa della cinquecentesca Mytho-logiae, siue Explicationum fabularum libri decem di Natale Conti con immagini di gemme ; una nuova raccolta di circa 700 monete pontificie « già tutte in essere, ricavate in dise-gno sopra le med.e monete originali con molta fatiga, e raccolte in libri, e sono ancora all’oscuro » ; e infine « una raccolta di 200 bassi rilievi inediti, e scelti, da illustrarsi poi da V.S. ». 7 Nessuna delle proposte trovò seguito, ma appare plausibile che Vettori pensasse
1 Per gli antichi inventari del Pelli vedi <http ://www.memofonte.it/ricerche/collezione-mediceo-lorene-se.html>.
2 Come chiarito da Josephine von Henneberg, la vendita includeva 6500 calchi di antichi camei e intagli, 25 volumi di disegni antiquari, ritratti e caricature di mano dello stesso Ghezzi e un codice dal titolo Disegni originali cavati dall’antico da Pietro Santi Bartoli e da altri celebri professori. I volumi furono collocati nel Fondo Ottoboniano Latino della Biblioteca Vaticana insieme al restante materiale proveniente dal recente acquisto della biblioteca Ottoboni, e catalogati con i numeri 3100-3125. Josephine von Henneberg, Architectural Draw-ings of the late italian Renaissance : the Collection of Pier Leone Ghezzi in the Vatican Library (Cod. Ottob. Lat. 3110), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1996. Vedi anche Giulia Fusconi, Da Bartoli a Piranesi : spigolatura dei codici Ottoboniani latini della raccolta Ghezzi, « Xenia », iii, 1994, pp. 145-172.
3 Circa 20 nel codice alla bav, Ott. Lat. 3102 e 2 nel codice bav, Ott. Lat. 3109.4 Vedi supra p. 119 nota 2. 5 Vedi supra p. 109 nota 3.6 Sui volumi con disegni di gemme, questo è il giudizio di Carlo Gasparri, Gemme antiche in età neoclassi-
ca : egmagmata, gazofilaci, dactyliothecae, « Prospettiva », 8, 1977, pp. 25-35, 27.7 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 207v-208r (da Roma il 12 marzo 1729).
ghezzi, gori e vettori: un progetto sulle lucerne antiche 123
all’enorme work in progress di Ghezzi. Le frequenti visite agli scavi e alle collezioni più illustri di Roma, gli acquisti per la sua personale collezione e la sua attività di perito offrivano a Pier Leone innumerevoli occasioni di ritrarre piccole antichità e di disegnare vedute o rilievi topografici. Così negli anni radunò in volumi le centinaia di fogli che andava producendo : le gemme furono raccolte principalmente negli attuali Ott. Lat. 3100, 3101, 3103, 3104, 3106, 3107, 3108, i disegni di monete papali e senatorie nei codici dal 3120 al 3125, i bassorilievi per la maggior parte nel 3109. 1
5. Le lucerne di Giovan Battista Passeri e l’abbandono del progetto Gori-Ghezzi
Oltre alle descritte difficoltà negli accordi, la pubblicazione della centuria delle lucer-ne si arenò definitivamente a causa di una concomitanza di eventi. Nel 1737 moriva il Granduca senza lasciare eredi della casata medicea e contemporaneamente l’avvocato e letterato Giovan Battista Passeri (1694-1780), amico e corrispondente di Gori, 2 decideva di dare alle stampe in tre volumi la sua ricchissima collezione di lucerne antiche : Lu-cernae fictiles Musei Passerii, sumptibus Academiae Pisaurensis (Pisauri in aedibus Gavelliis, 1739-1751). Grazie alle lettere dello stesso Passeri e del suo collega Annibale degli Abati Olivieri Giordani conservate alla Marucelliana, possiamo seguire tutte le fasi di elabo-razione di quest’opera antiquaria e apprendiamo che Gori, intendendo probabilmente arricchire la centuria del Ghezzi, già nel 1732 aveva contattato l’Olivieri per ottenere alcune lucerne del Passeri :
Quanto alle lucerne del Sig. Avv. Passeri, posso dirle, che siccome l’anno scorso non convennero insieme, fù discorso nella Accademia di nostra, di farne fare l’edizione a spese dell’Accademia, ed io pressai molto perché si facesse. La cosa non è stata ancora perfettamente risoluta, ma ella ben veda che né il Sig. Avv. Passeri, né io siamo in stato prima che sia conchiusa o sconchiusa questa cosa, di fare passo alcuno. Spero però che tre o quattro mesi la cosa si determinerà affatto ed in caso che non abbia luogo il partito progettato, io farò il possibile perché il Sig. Avv. Passeri si accordi con lei. 3
Da una missiva inviata dal Passeri all’Olivieri nel luglio 1735 e conservata nel carteggio del Gori, ricaviamo la consistenza della collezione delle lucerne pesaresi :
Qui in Pesaro abbiamo assai idoletti etruschi, patere di terra cotta con lettere e fatti del etrusci ; io ho una raccolta di 500 lucerne di terra istoriate, che vien da tutti reputata cosa bella in questo
1 Anche Piranesi si avvalse dei disegni dell’amico Ghezzi per alcune sue opere : Gasparri, La Galleria Pi-ranesi, art. cit., p. 99.
2 Il rapporto di stima e fiducia reciproca è testimoniato dalla corrispondenza e dalla collaborazione di Passeri ad alcune opere curate da Gori : Museum etruscum exhibens insignia veterum etruscorum monumenta aereis tabulis 100. nunc primum edita et illustrata observationibus Antonii Francisci Gorii ... Adcedunt v.c. Io. Baptistae Passe-rii i.c. pisaurensis dissertationes v. quas subiectus elenchus declarat nunc primum editae. Volumen tertium, Firenze 1743 ; Thesaurus gemmarum antiquarum astriferarum quae e compluribus dactyliothecis selectae aereis tabulis 200 insculptae observationibus inlustrantur adiectis parergis 60. Atlante farnesiano prolegomenis. Diatribis 3. Dissertationibus 15. et indici bus. Interprete Io. Baptista Passerio cura et studio Ant. Francisci Gori, Florentiae, ex officina typogr. Albizinia-na, 1750, 3 voll. ; Diptycha ecclesiastica anaglypho opere ex ebore sculpta cum observationibus I. B. Passeri et A. F. Gori, Florentiae, ex Officina Albiziniana, 1756. Dopo la morte di Gori, Passeri completò e dette alle stampe nel 1759 il Thesaurus veterum dypticorum consularium et ecclesiasticorum intrapreso dall’amico fiorentino nel 1754 e portò a termine il suo progetto di pubblicare il trattato di musica Lira Barberina di G. B. Doni (Firenze 1763).
3 Lettera di Annibale degli Abati Olivieri Giordani da Pesaro il 1° dicembre 1732 (bmf, Fondo Gori, ms. B vii 21, c. 152r-v).
veronica carpita124
genere. Io non so se così fatte cose possan pur servire a nulla al Sig. Abate Gori ; tuttavia desidero che e’ sappia che le abbiamo. […] In somma tutto quello che io ho sarà a requisizione di questo degnissimo uomo, e così benemerito delle lettere. 1
Ancora nel 1736, grazie al fidato mediatore Annibale Olivieri, il prelato fiorentino era in trattativa per ottenere da Passeri il permesso di pubblicare le sue lucerne « più belle », ovvero le più integre, erudite e insolite :
Quanto alle Lucerne del Sig. avvocato Passeri, già nella altra mia le accennai due difficoltà, le qua-li avrei volute veder prima spianar, che parlarne. Mi si aggiunge ora la terza, ed è che difficilmente vorrà il Passeri lasciar sfiorar la sua Raccolta, perché avendo egli intenzione di pubblicarla tutta, il lasciar prima uscir le più belle, pregiudicherebbe molto a tutte le altre. Per ora non la voglio annoiare di più, ma se ella mi dà licenza, mi prenderò la libertà di suggerirle un mio pensiero al quale se ella aderisce, avrebbe maniera di fare l’opera sua più bella, di contentare affatto gli aman-ti di queste cose à quali piacciono più le Raccolte intere che le sciolte benché più varie. Ma prima aspetto di avere la sua permissione. 2
Il suggerimento di Annibale Olivieri fece maturare all’erudito fiorentino un ambizioso progetto :
Pruovo infinito contento nel sentire che ella abbia abbracciato il pensiero di fare una raccolta […] di lucerne antiche, come io le suggerij o sia in due o sia in cinque tomi, è lo stesso purché ci siano tutte anzi appruovo molto il farle in cinque tomi, e la ragione si è perché volendola fare in due, verrebbe il libro troppo largo, cosa che incommoda assai, ed io lo pruovo nel Museo fiorentino, che adoprerei più spesso, se non fosse così disadatto. 3
Nell’opera in più tomi avrebbero dunque trovato spazio tanto le lucerne romane dise-gnate da Ghezzi e commentate da Gori, quanto quelle del museo Passeri, commentate dallo stesso avvocato. 4 Dal 1736 Passeri aveva cominciato a studiare e far disegnare le sue lucerne ed aveva incaricato l’incisore Giuseppe Gavelli di farne delle illustrazioni all’ac-quaforte. 5 Ancora nei primi mesi del 1737, Gori insisteva con Olivieri per pubblicare nel-la sua raccolta le lucerne di Passeri, cercando a questo fine anche l’appoggio del romano
1 bmf, Fondo Gori, ms. B vii 24, c. 692r-v (da Pesaro, 3 luglio 1733).2 Lettera di Olivieri da Pesaro, 18 marzo 1736 (bmf, Fondo Gori, ms. B vii 21, c. 125v-126r). 3 Da Pesaro il 13 maggio 1736 (ivi, c. 135v).4 Si legga la missiva da Pesaro, 23 marzo 1736 (ivi, cc. 127r-v) : « Ho già parlato al Sig. Avv. Passeri per le sue
lucerne, egli non si cura di compenso in denaro, bastandogli solamente qualche esemplare di questa edizione, e qualche altro libro, che si è benignamente espresso di rimettersi affatto a me. Darà volentieri i disegni delle lucerne, ma tutte, e con le sue osservazioni [lacuna] d’affidare ma torno di nuovo [a] dirle, quando avrò avuto risposta all’ultima mia, mi prenderò la libertà di consigliarla di tenere una, la quale se lo [lacuna] la sua opera più pregiabile [lacuna] estremamente l’Avv. Passeri il quale quando io gliele detti ne fu appagatissimo ma essendo altresì oltre [lacuna] sopra il disegno ».
5 Lettera di Passeri a Gori da Pesaro il 24 giugno 1736 (bmf, Fondo Gori, ms. B vii 24, c. 22 r-v) : « Ho tardato sin ora a rispondere alla gentilissima di V.S. Ill.ma non solo perché in questo tempo sono stato in gran parte fuori di città, ma perché aspettavo che l’intagliatore Gavelli mi desse qualche risoluta risposta sopra l’incisione delle lucerne delle quali almeno una ne avrei voluto veder intagliata per saper qual conto si potesse fare di quest’uomo. Ma egli è così freddo et irresoluto che mi ha tenuto fin ora in sospensione. Ieri finalmente venne da me e mi disse che in breve mi avrebbe fatta la prima pruova in acquaforte, che io sommamente desidero d’avere per inviarla a V.S. Ill.ma. Lo studio delle lucerne è rimasto finora interrotto essendomi dato tutto all’altro di raccogliere ed illustrare con alquante note le iscrizioni antiche di Todi, […]. Fatta che avrò la prima bozza delle note medesime la porrò in disparte per considerarle poi a miglior tempo e ripiglierò lo studio che avevo cominciato sopra le lucerne. La generosa eccitazione che da V.S. Ill.ma ricevo per la prosecuzione di questo studio è il più bell’appoggio che io abbia per continuarlo, venedomi da persona di tanta dottrina e credito et alla quale come a gran benefattore del nostro secolo e de bei studi io professo tanta venerazione ».
ghezzi, gori e vettori: un progetto sulle lucerne antiche 125
Alessandro Gregorio Capponi. 1 Tuttavia il corrispondente ribadiva le condizioni dettate dall’avvocato pesarese :
Il suo pensiere sarebbe ottimo, ma il Sig. Avv. Passeri, per quanto mi disse ieri mattina, non è per accudirci a meno che ella non convenga seco delle condizioni che altra volta io le espressi. E sono che debbano stamparsi tutti i suoi Prolegomeni e note, restando a lei sempre libero campo di aggiungere tutto quello che ella stimerà proprio e che debba a lui darsi una quantità determinata di esemplari di tutta l’opera. Questo è quanto da lui ricavai. Quando ella continui nel medesimo pensiero, potrassi discorrere più maturamente e stringere partito. 2
L’esitante progetto di Gori circa la pubblicazione delle lucerne, ancora in vita nel di-cembre del 1737, 3 dovette essere definitivamente abbandonato l’anno successivo quando Passeri, per mezzo di Olivieri, chiese all’erudito fiorentino di consigliare loro un dise-gnatore e incisore per le tavole dell’opera del pesarese. 4 L’edizione finanziata dall’Ac-cademia Pesarese e sostenuta da un’associazione di sottoscrittori, sarebbe rapidamente approdata ai torchi, mentre il progetto di Gori (oberato dalla mole delle altre sue pub-blicazioni) rimase orfano di risorse. Alla morte dell’ultimo granduca mediceo (9 luglio 1737) fece inaspettatamente seguito agli inizi del 1738 la nomina del medico Antonio Cocchi a primo antiquario della Galleria, un evento che riempì di amarezza e disillusio-ne l’emarginato Gori, ampiamente fiducioso dell’incarico. 5
6. Lo studio delle lucerne antiche tra xvii e xviii secolo
La ricostruzione documentaria degli avvenimenti, la raccolta e l’analisi dei materiali superstiti destinati al lavoro editoriale permettono di ricostruire in parte il metodo di lavoro sulle lucerne antiche adottato da Gori, da Vettori e da Ghezzi, e di contestualiz-zarlo all’interno delle opere a stampa che indagavano quella stessa tipologia antiquaria.
1 In una lettera di Olivieri al Gori scritta a Pesaro il 9 aprile 1737 leggiamo : « Avrò caro di sentire se il S. Cav. Capponi riesce nell’ottenere dall’avv. Passeri le sue lucerne ; secondo che ella mi ha imposto, io non ho fatto a lui parola di ciò e perciò ne domando a lei nuove. » (bmf, Fondo Gori, ms. B vii 21, c. 145r).
2 Lettera di Olivieri a Gori, da Pesaro il 10 febbraio 1737 (bmf, Fondo Gori, ms. B vii 24, c. 33v). Le insisten-ze da parte del fiorentino non dovevano sortire alcun effetto come Olivieri puntualizza ancora nell’aprile 1727 : « Ella tenga pur per sicuro che le lucerne del Sig. Avv. Passeri non esciranno di sua mano, e per verità gli stanno molto bene non meno per la copia che ne ha, che a più continui accrescimenti che ne fa, quanto per la sua intelligenza. Egli non ha stesi ancora tutti i suoi prolegomeni, né tutte le sue note, ma per quel poco che capisco io, le assicuro similmente che dopo aver udita una sua spiegazione, le quali sono brevi e sugose, le assicuro dico che le note del Bellori fanno pietà. Se egli in tutte sia uguale nol so ; so bene che quelle che ho veduto sono impareggiabili. » (Lettera a Gori da Pesaro, 29 aprile 1737 : bmf, Fondo Gori, ms. B vii 24, cc. 37v-38r).
3 Vedi la lettera di Olivieri a Gori da Pesaro il 15 dicembre 1737 : « Non mancherò di avvisarla a suo tempo della ultima risoluzione che si prenderà riguardo alle lucerne. » (bmf, Fondo Gori, ms. B vii 21, c. 153v).
4 Vedi la missiva dello stesso scritta a Pesaro il 15 marzo 1738 (ivi, c. 158v) : « Le lucerne sono ora il pensiero più grande di molti di noi, e la prego intorno ad esse di un favore ; ella mi esiti un disegnatore. Vorrei uno che fosse capace di disegnarle, ed intagliarle ancora. Gli si daranno in corte due camere per sua abitazione, se gli pagherà l’accesso a Pesaro, e il recesso, se gli somministrano Rami per intagliare. Il lavoro sicuro sarà 100, o 110, che faranno il primo Tomo. Se la cosa non precipitasse, come non credo, sarà per tutto il lavoro 600 e forse più ». Su consiglio di Gori andarono a Pesaro per lavorare all’opera delle lucerne gli artisti Giuseppe Menabuoi e Vincenzo Franceschini.
5 Per queste vicende rimando a Miriam Fileti Mazza, Bruna Tomasello, Antonio Cocchi primo antiqua-rio della Galleria Fiorentina 1738-1758, Modena, Panini, 1996. Vedi anche la lettera consolatoria inviata al prelato dall’Olivieri in data 15 marzo 1738 (bmf, Fondo Gori, ms. B vii 21, c. 158r).
veronica carpita126
Infatti, nel corso del xvii e xviii secolo furono dedicati alle lucerne famosi e importanti studi monografici da parte di illustri eruditi e antiquari : dal De lucernis di Liceti, fino ai tre tomi delle citate Lucernae fictiles Musei Passerii.
Nella roccaforte padovana dell’aristotelismo, il medico Fortunio Liceti (1577-1657) pubblicava nel 1621 il De lucernis antiquorum reconditis, un commentario in quattro libri riedito nel 1652 e nel 1662 con l’aggiunta di due libri e di molte illustrazioni. 1 Il lavoro che Liceti intraprese e arricchì nel tempo può definirsi una grande collezione di fon-ti antiche e contemporanee (incluse infatti ampi stralci della sua corrispondenza con eruditi e collezionisti di lucerne) sull’uso rituale e misterico delle lucerne presso i po-poli antichi (senza alcuna distinzione fra Romani, Greci, Egizi, Ebrei, ecc.), sulla natura del combustibile, sulla durata del fuoco nei sepolcri, sui proprietari delle lucerne, sulle iconografie raffiguratevi. In particolare è il sesto libro, l’ultimo e il più ampio, a essere corredato da numerose incisioni di lucerne, circa cento, i cui disegni erano arrivati a Liceti da Padova, Verona, Napoli e soprattutto Roma. 2 Lo studioso compose una sorta di florilegio di testi sull’argomento che corredò di immagini tratte da pezzi antichi che nella maggior parte dei casi non aveva mai visto direttamente. La sua analisi dei singoli reperti si basava essenzialmente sulle notizie ricevute dal collezionista del pezzo che egli completava con la sua erudizione sui testi antichi. È da imputare alla mancata indagine autoptica degli oggetti la massiccia presenza di falsi, di pastiches e di pezzi evidentemen-te integrati all’interno dell’opera.
Pur mancando di un apparato iconografico, giova qui citare anche la breve Dissertatio de veterum lucernis sepulchralibus (1670) del celebre umanista Ottavio Ferrari (1607-1682), professore di umanità latina e greca dell’ateneo patavino. Sottoponendo le fonti anti-che e contemporanee al vaglio della logica e diffidando di convincimenti superstiziosi, Ferrari prendeva di mira l’acritica crestomanzia compilata da Liceti, dimostrando per la prima volta l’infondatezza della diffusa credenza nelle lucerne perpetue alimentate da un olio inestinguibile. 3
1 Giovanni Maria Del Basso, Fortunio Liceti, erudito ed antiquario, 1577-1657, con particolare riferimento agli studi di sfragistica, « Forum Iulii », 15, 1991, pp. 133-153. Liceti compì i suoi studi medici e filosofici a Bologna, inse-gnando poi a Pisa e a Padova dove, se si eccettua un decennio trascorso a Bologna (1636-1645), rimase fino alla morte. Interprete dei più autorevoli di Aristotele, Liceti si dedicò allo studio di diverse questioni naturalistiche e filosofiche, non disdegnando tuttavia di coltivare interessi eruditi.
2 Vedi la Praefatio al Liber sextus della seconda edizione : « Quoniam post primam editionem superiorum priorum quatuor librorum De Reconditis Antiquorum Lucernis, plerique Viri praestantes, alias a me non visas, nec adnotatas, pulcherrimi tamen artificij Lucernas habuere, vetustiorum seculorum historijs, ritibus, atque symbolis affabre figuratas, hieroglyphicisque nobilibus ornatas ; quorum explicatio plurimum oblec-tationis, & emolumenti potest afferre literatorum Reipubblicae ; placuit viris eruditissimis, illarum Lucerna-rum icones ad me trasmittere, vel etiam descriptiones puras ; meaque sensa de propositis efflagitare. Quibus quum pro virili satisfacere tentaverim, meaque cogitata viri praecelsi iam aequi bonique consulerint, operae pretium fore duxi, novas istas elucubrationes ista secunda voluminis editione publica iuris efficere, non ad ornamentum solum, verum etiam ad antea propositorum omnium confirmationem » (De lucernis antiquorum reconditis libb. sex. in quibus earum recens inuentarum adhuc ardentium obseruationes multae primum afferuntur, Vtini, ex typographia Nicolai Schiratti, expensis Francisci Bolzettae bibliopolae Patauini, 1652, coll. 559-560). Nell’Urbe Liceti poteva contare sull’alacre attività di raccolta e documentazione grafica del cavalier Cassiano dal Pozzo e di Giovan Battista Casali, spesso citati nell’opera del ligure come generosi dispensatori di disegni di lucerne. Uno studio approfondito dell’opera e dei manoscritti del Liceti, restituirebbe la complessa rete di rapporti eruditi, di scambi antiquari e di circolazione di idee tessuta attorno al naturalista.
3 Anche Ulisse Aldrovandi sosteneva la tesi delle lucerne perpetue (Biblioteca Universitaria di Bologna, ms. Aldrovandi 21, iv, cc. 306-307, Ulyssis Aldrovandi ad Julium Jacobonum epistola. De lucernis in antiquorum sepulchris perpetuo ardentibus, missiva del 31 gennaio 1583)
ghezzi, gori e vettori: un progetto sulle lucerne antiche 127
Venti anni più tardi, Michel Ange de La Chausse, console di Francia a Roma, dava alle stampe il Romanum Museum : Sive Thesaurus Eruditae Antiquitatis (1690), una raccolta illu-strata delle più singolari antichità conservate nei musei dell’Urbe. Il quarto capitolo del corpus era dedicato alle lucerne antiche in metallo, dalla foggia più elaborata rispetto alle lucerne in terracotta. Il commento costruito principalmente su testi di autori latini e poco interessato all’analisi degli oggetti, accompagnava 15 incisioni di lucerne in buo-na parte realizzate da Pietro Santi Bartoli. 1
Quando lo stesso Bartoli pubblicava nel 1691 in proprio Le antiche lucerne sepolcrali corredate da 118 tavole (riutilizzando anche i rami preparati per il Romanum Museum), il lettore sfogliava un’opera innovativa. L’agile formato, i testi in italiano, il rinvio alle opere di Liceti e di Ferrari che consentiva di eludere un pesante apparato di citazioni latine e di commento ad esse, la chiara organizzazione in tre classi iconografiche (riti e giochi funebri ; deità ; simboli, emblemi e lucerne cristiane), gli snelli commenti di Giovan Pietro Bellori posti all’inizio di ciascuna delle tre sezioni, la ripresa frontale dei reperti che evidenziava le figure impresse sul disco e gli elementi decorativi, erano tutte scelte editoriali che, privilegiando il ricco apparato iconografico, ampliavano di fatto il pubblico destinatario dell’opera. Per la prima volta l’interpretazione delle immagini (ancora esclusivamente collegata all’uso funerario) era supportata dallo studio autopti-co dei reperti e dalla loro relazione iconografica con antichità di diversa tipologia (mar-mi, mosaici, terrecotte, bronzetti). 2
Nel mezzo secolo che separa Le antiche lucerne sepolcrali dai volumi delle Lucernae fic-tiles Musei Passerii, non venne pubblicata alcuna opera monografica sull’argomento ; tut-tavia queste piccole antichità trovarono spazio all’interno di importanti corpora antiqua-ri. Il primo è quello di Lorenz Beger, direttore del Gabinetto di Antichità di Berlino : nel terzo volume del Thesaurus Brandenburgicus selectus (1701) erano illustrate e rapidamente commentate 31 lucerne facenti parte delle antichità del defunto Bellori, recentemente acquistate da Beger per conto del principe Elettore del Brandeburgo Federico III (1696). 3
Nel 1719 il celebre abate francese Bernard de Montfaucon pubblicava il tomo v della sua monumentale Antiquité expliquée et representée en figures, nel quale la seconda parte era consacrata ai riti funebri dei popoli antichi e alle lucerne. 4 Infrangendo il generale criterio iconografico dell’Antiquité in base al quale, indipendentemente dalla tipologia, i reperti erano assegnati a una delle cinque classi prestabilite (divinità, sacrifici, vita civile, guerra e funerali), l’abate maurino preferì organizzare le 65 tavole di lucerne in un’unica
1 Sono 13 le tavole firmate dall’artista ; le altre due, anonime, si distinguono per un trattamento secco e inespressivo. Per il recueil di De La Chausse, Bartoli realizzò molte altre tavole (cfr. Pierre Jean Mariette, Traité des pierres gravées, Paris, 1750, pp. 279-284).
2 Di tutte le lucerne si comunicava il proprietario (in massima parte gli stessi Bartoli e Bellori) e spesso il luogo di ritrovamento. Fanno eccezione sei lucerne che non vennero ritratte dal vivo, ma da disegni preesi-stenti (due inviati da Perugia, due conservati nella biblioteca di Carlo Antonio dal Pozzo, uno in possesso di Bartoli e uno ritraente una lucerna portata a Firenze dal cardinale Leopoldo de’ Medici).
3 Thesauri regii et electoralis Brandenburgici volumen tertium : continens antiquorum numismatum et gemmarum, quae cimeliarchio regio-electorali Brandenburgico nuper accessere rariora : ut & supellectilem antiquariam uberrimam, id est statuas, thoraces, clypeos, imagines tam deorum, quam regum & illustrium, item vasa & instrumenta varia, eaque inter, fi bulas, lampades, urnas, quorum pleraque cum Museo Belloriano, quaedam & aliunde coëmta sunt..., Coloniae Marchicae typis et impensis Electoralibus excudit Ulricus Liebpert ... 1696-1701, iii, 1701, pp. 435-454. Buona parte delle lucerne belloriane era già stata pubblicata ne Le antiche lucerne sepolcrali.
4 Edizione consultata : L’antiquité expliquée et representée en figures. Tome v, Qui comprend les funerailles, les tombeaux …, seconde édition, revue et corrigée, Paris, 1722, partie ii, livre ii, pp. 202-234.
veronica carpita128
sezione. Se questa appare una scelta rispettosa di un’ormai consolidata metodologia catalografica, originale è la proposta di Montfaucon di individuare tre tipi di lucerne in base al loro uso : cultuale, domestico e sepolcrale. 1 Poiché tuttavia la forma e la deco-razione era spesso difficile da associare in maniera esclusiva ad uno dei tre impieghi, la classificazione delle lucerne si adeguava al più generale criterio delle categorie icono-grafiche. 2 Il lavoro enciclopedico dell’Antiquité, sorta di manuale e repertorio figurato di tutta l’antichità conosciuta nel quale si operò il collage di migliaia di immagini edite e non, si svolgeva quasi esclusivamente sul tavolo di lavoro di Montfaucon all’interno dell’abbazia di Saint-Germain : 3 nella stragrande maggioranza dei casi, l’abate non ave-va mai visto le antichità di cui scriveva. Della mancanza di autopsia (e in alcuni casi di autenticità) traeva vantaggio la quantità dei pezzi catalogati, tanto che nell’Antiquité trovava posto il più gran numero di lucerne mai pubblicate (quasi duecento). 4
Il terzo corpus con una sezione dedicata alle lucerne è la controversa Collectanea an-tiquitatum Romanarum (1736) con il commento di Ridolfino Venuti a centoquattro tavole finanziate dal medico e collezionista Antonio Borioni. 5 L’opera costituisce una raccolta illustrata di piccole antichità appartenenti a Borioni e ad altri collezionisti e si avvale di incisioni appositamente commissionate e di molte altre già esistenti. 6 In questo etero-geneo corpus, una ventina di tavole recano la firma di Bartoli, 17 delle quali raffigura-no lucerne. 7 Come riferisce Borioni, « tertia demum classis veteres aeneas figulinasque Lucernas continebit, quae aere incisae a celeberrimo Petro Sancte Bartoli, & inter ejus Schedas adinventae, publicam pene fugerant lucem ». 8 Si trattava dunque dei rami che Bartoli aveva preparato per il citato secondo volume delle Antiche lucerne sepolcrali e probabilmente venduti dopo la morte di Francesco (1675-1730), figlio di Pietro Santi e anch’egli incisore. 9
1 Come attesta Pietro Santi Bartoli, gli antiquari erano consapevoli che non tutte le lucerne avevano fun-zione sepolcrale : « Resta il dirsi, che se alcuno non riputasse sufficiente il titolo di Lucerne Sepolcrali, con escluderne alcune poche non appartenenti a’ Sepolcri, sappia essere state così denominate dalla maggior parte, persuasi da altri à non tralasciarle » (Le antiche lucerne sepolcrali, cit., Al lettore benevolo).
2 Montfaucon, op. cit., partie ii, livre ii, p. 202. Vedi Elena Vaiani, L’Antiquité expliquée di Bernard de Mon-tfaucon : metodi e strumenti dell’antiquaria settecentesca, in Dell’antiquaria e dei suoi metodi, Atti delle giornate di studio, a cura di Elena Vaiani, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001 (« Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa », s. iv, « Quaderni », 2, 1998), pp. 155-175, 157.
3 Sul metodo di lavoro di Montfaucon rimando a Vaiani, art. cit.4 « Quoique nous donnions ici le plus grand recueil de ces lampes qu’on ait encore vu dans un même livre,
nous ne mettons pas toutes celles que nous avons gravées, soit dessinées ; cela nous meneroit trop loin : il suffit d’en donner de toutes les formes, & de n’en omettre aucune qui differe considerablement des autres. » (Montfaucon, op. cit., partie ii, livre ii, p. 203).
5 Collectanea antiquitatum Romanarum quas centum tabulis aeneis incisas et a Rodulphino Venuti academico etrusco cortonensi notis illustratas exhibet Antonius Borioni, Romae, ex typographia Rochi Bernabo, 1736. L’opera venne duramente criticata da Giovanni Grisostomo Scarfò (In collectanea antiquitatum Romanarum, quas centum tabulis aeneis incisas, et a Rodulphino Venuti academico Etrusco Cortonensi notis illustrata, exhibet Antonius Borioni ; observationes criticae, Impressae Venetiis, per Modestum Fentium, 1739 mense Januario), cui seguì la replica di Venuti (Risposta alla critica fatta dal p.d. Giovan-Crisostomo Scarfó dottor teologo basiliano al libro dell’illustrissimo signore abate Ridolfino Venuti intitolato Collectanea Romanarum antiquitatum, Parigi, 1740).
6 Sull’assemblaggio eterogeneo compiuto in quest’opera e più estesamente per la sua descrizione si veda Mariette, op. cit., pp. 292-298. Di Borioni è nota una caricatura di Pier Leone Ghezzi che reca la seguente didascalia : « Antonio Borioni Spetiale alli Greci, il quale fa l’intenditore di cose antiche e quanto farebbe me-glio a fare i servitiali alle budella e non alla Borsa e per soprannome si chiama lo spetialetto fatto da me Cav. Ghezzi di 8bre 1739 » (bav, Ott. Lat. 3116, c. 29).
7 Collectanea antiquitatum Romanarum, cit., tavv. 85-102. 8 Ivi, Praefatio, pp. v-vi.9 Vedi supra p. 111 nota 4.
ghezzi, gori e vettori: un progetto sulle lucerne antiche 129
Nell’estate del 1735 Gori informava Vettori circa l’imminente pubblicazione curata da Ridolfino Venuti, pregandolo di indagare sugli inediti rami di Bartoli. Vettori rassicurò il prelato fiorentino sulla modestia dell’opera 1 e gli inviò una « notarella […] datami dal Sr abate Venuti, e contiene il soggetto delle lucerne che egli illustra, scritta come vede di suo carattere ». 2
L’esile commento di Venuti a circa 20 lucerne non poteva certo impensierire Gori : aveva progettato infatti una dissertazione in lingua latina, intitolata De luminibus, 3 che avrebbe dovuto comprendere le più remote origini, cioè i riti del fuoco sacro sui quali esisteva una vasta e antica letteratura. 4 A questo scopo, tra il 1728 e il 1730, Vettori gli aveva assiduamente trasmesso titoli di opere, brani di autori antichi e moderni, 5 descri-zioni, disegni e calchi di gemme e piccole antichità recanti iconografie connesse al fuoco, ai suoi rituali e simbologie, 6 nonché relazioni sopra lucerne della sua collezione o che aveva potuto studiare dal vivo. 7 Il fitto dialogo tra i due corrispondenti, di cui purtroppo conosciamo una sola voce, prova la loro consapevolezza circa le diverse funzioni delle lucerne : come già precisato da Montfaucon, oltre a quelle sepolcrali esistevano altre tipologie impiegate per scopi di culto e usi domestici. 8 Lo studio sulle funzioni di questi reperti si estendeva poi a confronti con numerosi candelabri che Vettori intuiva fungere da basi per le lucerne, come pure ad accostamenti con gemme e rilievi che potessero documentare i diversi contesti d’uso. 9 Le indagini di Vettori si concentrarono anche sugli aspetti materici e fattuali delle lucerne. Le sue accurate descrizioni autoptiche trasmes-se al lontano corrispondente approfondivano dettagli non riproducibili graficamente :
1 « Dissi al Sr. Ghezzi delle tavole che darà fuori il Sr. Abate Venuti, ma egli mi ha detto, che per conto delle lucerne io stia sicuro che non v’è cosa di rimarco, e dice averle vedute intagliate. » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 10, c. 38v, da Roma l’11 giugno 1735).
2 Ivi, c. 44v, da Roma il 16 luglio 1735. La «notarella» non è più acclusa alla missiva.3 Il Vettori consigliava il corrispondente di scrivere in italiano « perché chi si trova il tomo del Santi Bartoli,
accompagnerebbe il suo nella lingua med. » (bmf, Fondo Gori, ms. A 63, c. 78r, lettera cit. da Roma 28 febbraio 1728). Alla preferenza di Gori per il latino che avrebbe garantito una maggiore diffusione dell’opera tra gli « oltramontani », il cavalier Vettori tornava a precisare : « essendo che la misura de disegni corrispondono per appunto a quelle del S.ti Bartoli, perciò non saprei approvare che si scrivessero in latino le note, dovendo que-ste servire di seguito a quelle. » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 156v, missiva cit. da Roma 15 maggio 1728). Per il titolo dell’opera, si veda il passo di una lettera spedita da Roma il 27 ottobre 1731 a Gori da un anonimo erudito romano, identificabile in mons. Bianchini : « Se nel leggere incontrerò nulla, che faccia a proposito del suo trattato De Luminibus, non mancherò di comunicarglielo. » (bmf, Fondo Gori, ms. A lxxvii, c. 64v).
4 « Mi piace sommam.e il pensiere della dissertazione, che vuol premettere alle lucerne, e l’ordine ancora che li vuol dare, e per cominciar ab ovo il discorso, osservi il cap. 24 del lib. 13 delle varie lezzioni del mio Piero [illustre antenato di Francesco Vettori], che tanto nella p.a, quanto nella 2.da ediz.e è il med.o, e potrà forse servirle, spie-gando quid fit lucere, e d’onde si dica e nel leggere poi il lib. del S.r Boldetti ho notato nel cap. xvi del lib. 2.do, (che tutto, benchè breve discorre delle lucerne di terra cotta) n.a pag. 525 la legge menia spiegata da Liceto, che assegna le lucerne a i sepolcri per distinzione de nobili, e potrà ella meglio sodisfarsi in fonte circa il fuoco destinato per i sacrificj, e de suoi vasi, non so come potrà inserirveli rapportati alle lucerne, se non parla de sacrificj notturni, circa la statua della Vestale, che custodisce il fuoco, mi ricordo d’aver veduto più volte negl’intagli questo sogget-to, e si potrà metter nell’ordine qualche cosa. » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 162r, da Roma il 5 giugno 1728).
5 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 164r e sgg. (Roma 12 giugno 1728) ; ivi, c. 167r e sgg. (Roma 26 giugno 1728) ; ivi, c. 173r e sgg. (Roma 17 luglio 1728) ; ivi, c. 179v e sgg. (Roma 4 settembre 1728).
6 Ivi, c. 184r e sgg. (Roma 25 settembre 1728) ; ivi, c. 187r (Roma 2 ottobre 1728) ; bmf, Fondo Gori, ms. B viii 9, c. 20r (Roma 29 aprile 1730).
7 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 164r e sgg. (Roma 12 giugno 1728) ; ivi, c. 203r (Roma 4 febbraio 1729) ; bmf, Fondo Gori, ms. A 63, c. 215v e sgg. (Roma 5 marzo 1729 ; lettera sciolta).
8 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 9, c. 20r (Roma 29 aprile 1730).9 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 199r (Roma 22 gennaio 1729) ; ivi, c. 201r (Roma 29 gennaio 1729) ; e supra
alla nota 4.
veronica carpita130
Io ho una fig.a di donna a cavallo in frammento di lucerna di terra cotta, con la face in mano, la quale crederei probabilm.e potesse rappresentare l’aurora, e presso il cavallo si vede una fig.a molto più piccola, per figurare la distanza, che forse sarà il rustico, che và alli lavori della campa-gna, essendo abito certam.e rurale, e vi sono alcuni instrum.i, che si esaminaranno nel disegnarli ; è stato danno che sia così rotta, essendovi in alto alcuni caratteri, che non si possono, ne si po-tranno rilevare : il più curioso di questo frammento si è, chegl’è sottiliss.o, e nella parte rovescia si vedono chiarissimam.e tutte le linee della mano, che la calcò sulla forma : da questo pare si possa argomentare, che simili lucerne furono fatte con le stampe, o forme che vogliam’dire, e termina-te poi così bene, com’è questa, con lo stecco, come fanno i nostri modellatori. 1
In un’altra lunga relazione Vettori ricostruiva per la prima volta la funzione delle pic-cole borchie decorative inserite nei fori delle lucerne come coperchi e tornava sulle fasi della fabbricazione artigianale :
Avrà V.S. osservati ne’ med.i disegni quella tavola in cui sono quelle molte borchie di terra cotta, istoriate a basso rilievo : questa è una nuova scoperta, e come averà fatto osservazione da altri fin ora non conosciuta : meglio lo spiega la lucerna, della quale si è dato ancora lo spaccato, per far vedere in che modo potevano fermarsi su le lucerne queste terre cotte, ed a che uso servivano. Di queste simili borchie se ne trovano molte, forse, come che nella più parte delle lucerne vi dovean essere, ma per essere cose fragili, tutte si trovano dalle med.e lucerne separate : ne ho fatto dise-gnare alcune delle più belle, acciò possa diffondersi su questo, perché merita d’essere avvertito. Da qui si conosce chiaramente a che cosa servono quei buchi su le lucerne, che paiono di più, o per dir meglio parevano superflui. Perché, oltre quello del lucignolo, e l’altro da infondere l’oglio, dover necessariam.e, e per più polizia, e bellezza della lucerna, esservi l’altro, in cui andava im-pernato questo copertoio, che girato attorno veniva a coprire li due buchi, il primo, in cui era impernato, e l’altro, per il quale infondevasi l’oglio, finchè restava del tutto coperta con queste simili terre cotte, che le rendevano ancora ornam.o. Forse mi sarò troppo diffuso in questo, ma è necessaria talvolta la verbosità, quando in voce non si può supplire, che però vi faccia sopra riflessione, acciò non creda superflua quella tavola, che anzi è necessaria, per far risultare la cosa. In qual modo poi potessero mettervi questi simili copertoi, con facilità s’intende, imaginandosi, com’egl’è vero, che le lucerne facevansi in due tempi, cioè il di sopra da se, ed il fondo da se, quali poi univano insieme, e prima di unirli vi passavano dunque queste terre cotte, il perno delle quali potevano con facilità ribattere di sotto, acciò che non potessero uscire, come meglio mostra poi lo spaccato di quella, che si è data ancora in disegno intiera per far vedere l’arte, e la polizia del lavoro. Simile a questa non se n’è vista altra fin ora che io sappia. 2
Rispetto dunque alla tradizione di studi sulle antiche lucerne, l’approccio metodologico di Vettori segna un significativo scarto tanto nella selezione dei materiali quanto nelle modalità della loro rappresentazione. Al prevalente interesse iconografico e simbolico di Gori, desumibile dai suoi appunti tratti dai disegni di Ghezzi, 3 Vettori obiettava ar-gomentando la necessità di includere lucerne frammentarie o esteticamente poco inte-ressanti, portatrici tuttavia di preziose informazioni sulla loro fabbricazione e sul loro utilizzo. 4 Il cavaliere si preoccupava inoltre di proporre al futuro lettore delle immagini
1 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 164r-v (Roma 12 giugno 1728).2 bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 227v-228r (Roma 28 maggio 1729). 3 Mi riferisco alla Descrizione di lxix Lucerne antiche disegnate dal Cav.r Ghezzi di cui supra p. 118 nota 4, dove
riconosciamo le lucerne descritte da Vettori (c. 322v n. 11 e c. 323r nn. 19-21), ma le sue osservazioni non sono neppure accennate.
4 Si legga anche « La lucerna nella quale sono impresse le linee della mano dell’artefice, è quella in cui si vede la fig.a di donna a cavallo, la qual lucerna essendo rotta, mostra visibilissim.e nel di sotto della lamina
ghezzi, gori e vettori: un progetto sulle lucerne antiche 131
comprensibili, funzionali e comprovanti le tesi discusse. Per questa ragione commis-sionò a Ghezzi la realizzazione dell’intero e dello spaccato di una lucerna con i suoi coperchi o borchie, garantendo a Gori di vigilare sull’« esattezza de’ disegni ». 1
Questi riproducevano anche eventuali iscrizioni o bolli impressi sulle lucerne, che Gori trascrisse nei suoi appunti e che in tre casi ipotizzò potessero indicare il nome dell’artefice. 2 Già Liceti aveva interpretato queste iscrizioni come nome del figulus, del defunto, o del servo custode, ma la questione venne ripresa solo da Montfaucon e più compiutamente da Giovan Battista Passeri. 3
I tre tomi delle Lucernae fictiles Musei Passerii (1739-1751) con oltre 300 tavole di cor-redo iconografico, sono una delle opere più vaste mai date alle stampe consacrate ad una singola sezione di un museo privato. L’impresa avrebbe dovuto includere anche un quarto volume dedicato alle lucerne cristiane, di cui si conserva il manoscritto presso la Biblioteca Oliveriana di Pesaro. 4 Molteplici sono gli aspetti d’interesse di quest’opera, primo fra tutti la dichiarazione dell’autore che le sue lucerne provengono da scavi e ritrovamenti della zona di Pesaro. 5 L’opera si inserisce nella tradizione dei monumenta Patriae che, prima con le Accademie poi con le Deputazioni, ancor oggi promuove lo studio della storia patria locale. Passeri garantiva così di non prescindere dall’analisi autoptica delle lucerne e dalla fedeltà delle riproduzioni, tanto da rimproverare nelle Antiche lucerne sepolcrali il fatto che
[…] tabulae alioqui admirandae venustatis non sine reprehensione sunt. Quippe Bartolus illas non ex ipsis autographis, sed ad fidem tumultuarii schematis exaravit, nec pauca, quae minus perspi-cua forent, de ingenio supplevit, omniaque ad sui characteris leporem efformavit, uti prototypo-rum, qui ad nos pervenerunt, collactione comperimus ; utque semel Etruscas urnas delineaverat, novi styli pulcritudine captus Romanos milites, atque athletas semper Etrusco more calceavit. 6
L’introduzione dell’opera di Passeri è organizzata con chiarezza e concisione in quindici sezioni dove le teorie dell’autore non riguardano solo le lucerne pubblicate, bensì tutta la tipologia di queste piccole antichità. Nell’ordine sono discusse : l’origine e l’antichi-tà delle lucerne, la loro introduzione in Italia, le terminologie nelle lingue antiche, la
istoriata, precisam.e le 3 linee maggiori della mano restatevi impresse. Ed è tra quelle, che ultimamente le ho mandato in disegno. Quanto il piccolo copertoino delle lucerne, che le accennai da avvertirsi, io non dubito che potesse comodam.e rigirarsi nelle lucerne istoriate, perché il basso rilievo, communem.e è quasi piano. Ma ogni regola ha la sua eccez.e, ed io non dico che in tutte fossero queste ornam.i, ma in alcune solam.e, cioè in quelle che ne danno l’indizio con la multiplicità di quei fori, che vi si osservano. » (bmf, Fondo Gori, ms. B viii 8, c. 229v, da Roma 11 giugno 1729).
1 Ivi, c. 187v (Roma 2 ottobre 1728) ; bmf, Fondo Gori, ms. B viii 9, c. 128r (Roma 22 dicembre 1731).2 Descrizione di lxix Lucerne antiche disegnate dal Cav.r Ghezzi, cit., cc. 312r n. 21, 322v n. 10, 323r n. 20, 325r n.
32, 326r n. 33, 327r n. 34, 328r n. 35, 333r n. 40, 337r n. 44, 343r n. 50, 344r n. 51, 345r n. 52, 347r n. 54, 348r n. 55, 350r n. 57.
3 Un cenno sulle firme degli artefici è anche in Marco Antonio Boldetti, Osservazioni sopra i cimiteri de’ santi martiri, ed antichi cristiani di Roma. Aggiuntavi la serie di tutti quelli, che sino al presente si sono scoperti, e di altri simili, Roma, 1720, p. 525. Montfaucon (op. cit., partie ii, livre ii, p. 205) corresse l’errata interpretazione di Beger che non riconobbe un’iscrizione dell’artefice di una lucerna. Nelle Antiche lucerne sepolcrali, due tavole di Bartoli recano l’iscrizione con il marchio di fabbrica (i, 31 e ii, 17), ma Bellori non ne fece commento.
4 Manca uno studio approfondito su questa interessante figura di erudito ; rimando pertanto ai riferimenti in Ulrico Agnati, Per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino, Roma, L’‘Erma’ di Bretschneider, 1999, pp. 248-249 e segnalo la ricerca in c.d.s. condotta da Maria Elisa Micheli e Anna Santucci sui pezzi veri e falsi della collezione di lucerne di Passeri custodita oggi nel Museo Oliveriano di Pesaro.
5 Passeri, Lucernae fictiles, cit., i, p. ii.6 Ivi, i, p. iii. Oltre a Giuseppe Menabuoi, alcune tavole sono state disegnate dallo stesso Passeri.
veronica carpita132
descrizione delle parti di cui le lucerne sono composte (crater, discus, nasus, ansa, in-fundibulus), gli accessori (borchie e basi), le officine e i marchi di fabbrica, i materiali di produzione, le figurazioni e le età delle lucerne figurate, la divisione in quattro classi in base all’uso (lucernae sacrae, publicae, domesticae, sepulcrales) e infine il criterio di organiz-zazione dei reperti nei tre tomi. 1 Tralasciando l’incoerenza tra le dichiarazioni di Passeri e la sua attività di falsario e collezionista di pezzi contraffatti, 2 dalle sue Lucernae fictiles emerge l’attenzione prevalente al dato materico rivelatore di preziose informazioni sui processi di produzione, sulla provenienza, sui commerci e sulle datazioni dei reperti.
L’incompiutezza del lavoro di Gori sulle lucerne non ci permette di dare un giudizio approfondito sulla metodologia che l’erudito fiorentino aveva concepito per il suo De luminibus. Certo è che, nonostante le osservazioni inviate da Vettori, l’impossibilità di avere tra le mani le antichità oggetto della sua dissertazione costituiva un forte limite che lo avrebbe probabilmente indotto a prediligere una tradizionale lettura iconografica fondata sugli scripta più che sui monumenta. 3
Il prezioso carteggio di Vettori a lui indirizzato è un tassello che amplia la nostra percezione del variegato orizzonte in cui si muovevano gli antiquari della prima metà del xviii secolo, nella fase cruciale del passaggio dall’erudizione classificatoria e compa-rativista all’analisi autoptica, dalle dotte disquisizioni iconografiche alle indagini arche-ologiche. Questa nuova sensibilità, che alla metà del secolo avrebbe trovato la sua con-sacrazione nel Recueil d’antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines (1752-1767) del Comte de Caylus, 4 aveva cominciato ben prima a farsi strada grazie al ruolo motore dei membri della Repubblica delle lettere, molti dei quali restano ancor oggi tutti da indagare.
1 Cfr. Carlo R. Chiarlo, Giovan Battista Passeri : problemi di metodo, in Dell’antiquaria e dei suoi metodi, cit., pp. 177-193.
2 Francesco Vittorio Lombardi, Il mondo romano antico nella figura del pesarese Giovan Battista Passeri, in L’Antichità classica nelle Marche tra Seicento e Settecento (« Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le Marche », 93, 1988), Ancona, 1989, pp. 276-293 e Micheli, Santucci, op. cit., c.d.s.
3 Si consideri l’osservazione di Pelli Bencivenni circa il Museum Florentinum, cit. : « Rispetto poi alla parte letteraria il Gori parve troppo verboso, e meno profondo, e sagace, di quello che sarebbe stato il Buonarroti suo maestro se avesse potuto attendere a questo lavoro, ma scriveva bene il latino, e l’eleganza dello stile coprì i suoi difetti. » (Saggio istorico della Real Galleria di Firenze, Firenze, per Gaet. Cambiagi stamp. granducale, 1779, ii, p. 371).
4 Per l’inquadramento di questi temi rinvio al fondamentale volume di Alain Schnapp, La conquista del passato. Alle origini dell’archeologia, Milano, Leonardo, 1994.
composto in carattere dante monotype dalla
fabriz io serra editore, p i sa · roma.
stampato e r ilegato nella
tipografia di agnano, agnano p i sano (p i sa) .
*Luglio 2013
(cz 2 · fg 3)