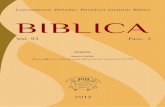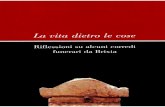Estetica dell’immanenza. Saggi sulle parole, le immagini e le macchine
Franco Purini e Francesco Moschini dispongono trasversalmente le parole e le cose
Transcript of Franco Purini e Francesco Moschini dispongono trasversalmente le parole e le cose
Quaderni di Cartone è una Collana che raccoglie idee, confronti e
contributi anche di carattere sperimentale, sul Design e più in generale sulla cultura del
progetto degli artefatti nella società contemporanea. I nuovi linguaggi, le nuove tecnologie,
le nuove funzioni dei prodotti della cultura materiale, si misurano sempre più con
condizioni al limite degli statuti disciplinari tradizionali.
Ciò ci spinge a comprendere forme e contenuti di tutte le espressioni delle trasversalità e
delle ibridazioni fra le arti visive, architettura e design.
.; 1'> nn
QUADERNI di CARTONE 02
•
MOVING BEVONO DESIGN Federica Dal Falco Antonella Greco
con Orazio Carpenzano, Enzo Cucchi Oscar Giannino, Massimo llardi Lucia Latour, Francesco Moschini Renato Nicolini, Ludovico Pratesi Marilù Prati, Franco Purini Tatti Sanguineti, Ettore Sottsass Antonino Terranova, Velasco Vitali
MOVING BEYOND DESIGN
""d . ,'-&1,...,, copyright .., es1gnpress , lel 11 .,,,, © Velasco Vitali per ATTO II
Ideazione Federica Dal Falco e Antonella Greco Bozze cci d i scena Federica Dal Falco
ISBN 978-88-89819-22-7
Progetto grafico Faccory LSD
Videoimpaginazione Valeria Di Giuseppe
Copertina su Fedrigoni, carta Sirio Bruno da gr 290 Pagine interne su Arcoprinc carta avorio da gr 85 Scampato da Tipografia Ceccarelli, Grocce di Castro VT (Italy) Fin ito di scampare nel mese di Novembre 2009
Nessuna parre di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'aurorizzazione sericea dei proprietari dei diritti e dell'editore.
7 P~~ErJTAZIONE Feder:.Jca pal Falco e Antonella Greco
9 PEI\:so!'lAGGI
10 ATPo I Franto purini e Francesco Moschini dispongono trasv-1ersalmence le parole e le cose
34 ATJto 1J Vela~co ,'itali scrive una lettera dal lagomare
40 ATJto 1JI
50
76
82
90
98
108
128
Noniosca\lte le previsioni meteo il d irettore Oscar Giannino ha decist0 di fare una passeggiata
ATJto1V Enz°' cuìchi e Ludovico Pratesi si incontrano per discutere sulle! sorti dell'ibrido
ATiù:o "( Via~gio ,n Italia di Tacci Sanguineci
Anto{I Mell"bori, di Renato Nicolini
ATifto { II Alta ll cucfla di Orazio Carpenzano
A Tiftto ( III La CQonfetnza di Lucia Lacou
ATI!ìro IX Incor;ncriterricoriali tra Massimo Ilardi e Anfucon\10 Terranova
ATitro S Anco1onei\ Greco e Ettore Sottsass. Intervista impossibile
PRESENTAZIONE Federica Dal Falco e Antonella Greco
Il volume raccoglie socco forma di cesto teatrale gli interventi di Franco Purini e Francesco Moschini, Oscar Giannino, Velasco Vitali, Enzo Cucchi e Ludovico Pracesi, Renato Nicolini e Marilù Prati, Orazio Carpenzano, Lucia Lacour con Alcroceacro, Massimo Ilardi e Antonino Terranova tenuti nell'ambito di Trasversalità. Incontri, performance video, uno degli eventi che hanno caratterizzato la manifestazione Roma Design più 2006.
L'insieme dei contributi di questo libro, proposti socco forma di cesto teatrale, restituisce una delle molteplici visioni degli elementi e dei processi che caratterizzano la cultura progettuale della contemporaneità, ma è anche, nel suo dipanarsi, l'insieme eterogeneo delle esperienze e dei luoghi mentali di artisti, professori, critici, architetti, un giornalista. Le reciproche influenze e contaminazioni sono indagate rileggendo le interazioni dei diversi percorsi creativi. La dinamica degli incontri riflette il tema proposto: il confronto era le esperienze teoriche ed artistiche ne scompone e ricompone i passaggi dialettici e le linee di ricerca. La scelta di restituire gli interventi adeguandoli ad un testo teatrale nasce da un'idea semplice: rompere lo schema tradizionale della "raccolta di contributi" utilizzando un dispositivo trasversale che rende interpretabile la scrittura con tante, possibili mise en scène. La trasformazione dei dialoghi in atti ha messo in risalto la capacità di dare identità, corpo e senso a mondi reali e virtuali e ha valorizzato l'ironia e la componente immaginifica contenuta nelle trascrizioni. Il racconto micologico-critico di Franco Purini e Francesco Moschini, i
•
8
monologhi autobiografici di Velasco Vitali, Tatti Sanguineti e Renaco Nicolini, la singolare interpretazione del tema di Oscar Giannino, la lezione sulla stereorealtà di Orazio Carpenzano, il carattere scientifico e progettuale della ricerca artistica di Lucia Latour e Altroteatro, i dialoghi Cucchi-Pratesi e Bardi-Terranova, in cui si mischiano timbri futuristi ed elementi che ricordano le opere di Ionesco, l'intervista impossibile di Antonella Greco a Ettore Sottsass; hanno acquistato, filtrati attraverso la struttura teatrale, un carattere più narrativo. Nel testo non c'è inizio e non c'è fine. Gli atti si producono a partire da un punto di vista su cui si innestano più voci, anche di personaggi inventati . La loro sequenza è intercambiabile e la trama complessiva, di stravagante complicazione, ha prodocco una sorta di rizoma verbale i cui nodi si collegano tramite analogie a volte remote. Così, i nostri ospiti sono diventati gli accori di un genere di rappresentazione ibrido, facto di monologhi e dialoghi con note di regia che valorizzano gli accenti vagamente surreali racchiusi nelle trascrizioni originarie. Il progetto delle scenografie simula una delle possibili rappresentazioni di Moving beyond design: sullo sfondo di un grande palcoscenico nero e spoglio sono proiettate immagini costruite intorno ad uno spunto narrativo, alla suggestione racchiusa in una frase. Le scene in bianco e nero nelle quali si assolvono uno nell'altro pattern, macerie, luoghi e figure sono un'omaggio alle fantasmagorie di Georges Méliès, ai "racconti a stazioni" in cui ogni quadro dà inizio a un nuovo episodio.
PERSONAGGI
In ordine di apparizione
Antonella Antonella Greco Federica Federica Dal Falco Franco Franco Purini Alcuni spettatori Francesco Francesco Moschini Primo signore Franco C. Franco Cervellini Secondo signore Terzo signore Vecchio Velasco Velasco Vitali Oscar Oscar Giannino Ludovico Ludovico Pratesi Enzo Enzo Cucchi Cameriere allampanato Cinquantenne bionda Spettatore vecchio stile Uomo Altra voce Ragazzino Figura vestita di nero Pubblico · Tatti Tatti Sanguineti Renato Renato Nicolini Il capitano del Freya delle isole Marilù Marilù Prati Orazio Orazio Carpenzano Ballerine Lucia Lucia Latottr Antonino Antonino Terranova Massimo Massimo !lardi Tutti Qualcuno Etcore Ettore Sottsass
Nella stanza quadrata, illuminata da una Ùtee obliqua sono sedute in circolo alcune persone. Dal piccolo anfiteatro si alza leggera la voce di una donna
ANTONELLA
(Capelli lisci castani. Vivace, parla veloce) Il tema di questi nostri incontri è la trasversalità, concetto che contamina, ibrida, manipola, trasforma città, oggetti, cinema, opere d'arte, come quel giardino dell'Eden dei fratelli Chapman dove i colori sono tenui e le pose ammiccanti di giovani elfi e deliziosi pupazzi con i capelli veri e vere scarpe da tennis, ma che poi sono mostri a quattro zampe e due busti o bambole a due tre teste ... o ancora corpi. La cannibalizzazione del corpo con Orlane, le protesi di Mathew Barney, i vestiti con le gobbe, i sederi , le pance finte. (Pausa, poi contintta) Un meticciato che alligna anche nei ruoli sociali: Baudrillard che teorizza l'esistenza di un sesso né femminile né maschile, né omosessuale né transessuale, ma di medierà tra tutte queste cose. Anche l'architettura si è meticciata e da molto tempo, con la storia, con l'arte,con la scienza, con una serie di linguaggi, saperi, discipline diverse. Abbiamo invitato io questo luogo dei personaggi emblematici che possano esprimere il loro punto di vista su cali unioni, trasfigurazioni, contaminazioni. Architetti e critici, come Franco Purini e Francesco Moschini, qui stasera, o artisti come Enzo Cucchi che parlerà con Ludovico Pratesi, o ancora il pittore Velasco Vitali con l'economista Oscar Giannino, danzatori e performer con Renato Nicolini e Marilì:1 Prati e il gruppo Altroteatro di Lucia Latour, critici e inventori di cinema, come Tatti Sanguineti; ci occuperemo di cinema, di documentari sugli artisti e sugli architetti, di videoarte. (Pausa, sorride e riprende)
14
I nostri ospiti di stasera non hanno bisogno di presentazioni. Avevamo
pensaco a una scaletta degli attributi di Franco Purini che provasse a
definirlo, come in un quadro settecentesco: architetto, professore,
accademico di San Luca, progettista urbano, artista, amico e
compagno di strada di artisti e letterati. In che modo Purini sia poi
coinvolto nel concetto di trasversalità può precisarlo Francesco
Moschini, architetto, professore, critico, gallerista; una galleria che
dalla fine degli anni '70 si è chiamacaAAM, Architettura Aree
moderna e che dalla sua fondazione quindi prevedeva la trasversalità,
il meticciaco, la compresenza di architetti e artisti in uno stesso luogo
espositivo, in mostre a tema allora chiamate Duetti.
Una seconda voce femminile si leva dal fondo
FEDERICA (Capelli ricci scuri. Sottile, parla scandendo le parole) Vorrei parlare della concezione di questo evento. La nostra idea è che
questi incontri riflettano il tema proposto e quindi siano degli attraversamenti di differenti territori culturali i cui mobili confini
vengono di volta in volta ridisegnati dai nostri ospiti. Li abbiamo
immaginaci come gli artefici di un tappeto complicato formato da
molti fili tiraci ed annodati in modi diversi. Un tappeto che nel suo
farsi viene mostrato a rovescio, con i nodi. La tessitura inizia stasera.
Al centro della stanza si proiettano le ombre di due uomini vestiti di scuro. Entrano uno dopo l'altro nell'occhio di bue e si accomodano su sedie metalliche. Il primo è Franco. Anche se di media statura, ha un aspetto imponente, autorevole. Il secondo, Francesco, è magro e sorridente. Fuma
FRANCO (Tira fuori dalla tasca un taccuino nero, lo apre. Nella stanza cala il silenzio. Il pubblico appare ipnotizzato. Sfoglia rapidamente qualche pagina. Le dita sembrano fondersi nella carta. Accenna un sorriso. Poi inizia a parlare) Vorrei partire da alcune considerazioni sul concetto di ibrido, di alcune
forme di ibrido che per me sono importanti. Il primo ibrido che vorrei
ricordare è Chirone, il centauro che abita sul monte Pelio, quel monte
15
bellissimo che sta dietro la città di Volos in Grecia. Ogni volta che si va lì, sembra di vederlo passare fra i platani, fra gli alberi. Chirone, un ibrido che
corregge con la ragione la forza impetuosa del cavallo, è l'emblema di una
forza eroica, incontenibile, che ha bisogno però, per poter sviluppare la sua
stessa forza, di innestare su di sé la ragione umana. E' quindi in qualche
modo un ibrido confessacivo ed è bello che ci sia nell'ibrido questo valore,
questa valenza. Un altro ibrido che a me è molto caro è Dafne. Dafne che si
autoinnesca germogli arborei per sfuggire alla presunta minaccia di Apollo.
E io mi sono sempre chiesto, perché? Da che cosa sta fuggendo Dafne per
aver bisogno di ibridarsi in quel modo, di cedere la sua corporeità
diventando un vegetale. In fondo Apollo vuole soltanto amarla e credo che
Apollo non fosse poi un corteggiatore volgare e violento. Questa fuga di Dafne in un'altra forma di esistenza vuol dire qualcosa di diverso e in
questo caso l'ibridazione nasconde il mistero dell'incapacità di accettare il flusso dell'esistenza. Quindi ibrido significa anche nascondersi. Ci si ibrida,
si cambia perché non si accetta quello che si è in un certo momento e si
vuole essere qualcos'altro. (Si ferma un attimo. Contimta con tono più vibrante) Poi c'è un altro ibrido che a me piace moltissimo, forse più dei primi due. E' Freddy Kruger che impianta su di sé delle armi taglienti. Ma
cagliare cosa significa) Non significa distruggere, ma scomporre, ridurre
una parte a frammenti, dotaci però di un ordine complessivo. Per me
questo rappresentano le lame di Freddy Kruger che non a caso sono bisturi, attrezzi in cui la violenza è pianificata e alla fine benefica. E in
fondo Kruger è uno che viene evocato dal desiderio, è un incubo di chi
vuole avere terrore. Non va da chi non lo desidera, non lo cerca.
(Pausa, riprende subito e sembra abbastanza divertito) Ci sono altri ibridi ancora più interessanti di Freddy Kruger. Come
Dracula, che ibrida la vita e la morte; che in qualche modo è un essere vivente e un morto; che ha desideri che non si possono compiere; che è
un entità intermedia e quindi costantemente metamorfica.
Dracula di giorno giace come un sasso, come qualcosa che sta fuori dal
mondo, mentre la notte riprende la sua capacità di muoversi, di
cambiare. Diventa nebbia, pipistrello, gelo, grumo di copi, diventa
tutto quello che può diventare essendo a metà strada un ibrido tra un
essere vivente e un morto. (Concentrato e veloce)
16
C'è poi l'ibrido per eccellenza, che tra l'altro è il fumo di due secoli di sperimentaziorù scientifiche vere, perché dietro a questo personaggio ci sono alcurù scienziati era cui un italiano. E' Frankenstein un corpo fatto di corpi, in cui c'è anche Dracula, perché questi corpi erano morti e sono stati richiamati alla vita. In qualche modo rappresenta, dal punto di vista dell'ibridazione, uno degli esempi più clamorosamente evidenti e insieme ambigui. Frankenscein è un essere vivente e non più un essere umano, che va alla ricerca di coloro che ne hanno generato i pezzi, ma che non possono riportare questi pezzi all'urùtà. (Quasi entusiasta) Ecco il dramma di Frankenstein: quando si rivolge al dottor Viccor von Frankenscein che l'ha creato, si rivolge a un padre che l'ha rifiutato, ma si rivolge in realtà ad una pluralità di padri, ad una pluralità di genitrici che non potranno mai ricongiungersi in una figura sola. E' un po' quello che succede in Biade Runner quando Rucger Hauer (Roy) uccide il creatore dei mutanti, dei replicanti.
ALCUNI SPETTATORI (Iniziano ad insegttire con gli occhi figure fluttttanti, forse si tratta di ologrammi)
FRANCO
(Si riaccomoda sttlla sedia) Cosa significa tutto ciòì Che gli ibridi sono di due specie. C'è l'ibridazione che crea un'unità: io innesto un germoglio in una pianta, creo una pianta di tipo diverso, oppure creo una razza canina nuova o un altro animale nuovo. Quell'animale è uno, nuovo e incero. Quindi perché ci sia vera ibridazione occorre operare un innesco sul tema dell'ibridazione. (Pattsa, riprende sostenuto) Quello che secondo me è più preoccupante, più oscuro, ma anche più importante per la creazione dell'arte, dell'architettura, della letteratura, è la
metamorfosi. Un concetto spaventoso, davvero agghiacciante se ci si pensa veramente. Nel poema di Ovidio che ogrù tanto rileggo, la metamorfosi significa la negazione dell'esistere. E' un esistere che nega profondamente nel suo esistere volta per volta cambiato, costantemente riformulato, un'essenza, una stabilità, una riconoscibilità. Quindi qualcosa che evolvendo uccide la stessa possibilità del pensiero. Sto pensando a certe immagini di Machew Barney quando si innesta dentro questa specie di memoria micologica, che secondo me è un emblema particolarmente perspicace.
17
(Movimento rapido del tronco ed ulteriore assestamento mila sedia) Ma anche ceree opere di Max Ernsc lo sono, se lette dal punto di vista di una cosa che fu un essere vivente: un morto che poi è stato craccaco, cagliato, rimontato, messo in un museo e trasformato in opera d'arte. (Convinto) Il ciclo metamorfico è qualcosa di insostenibile che non nasconde le potenzialità, ma le brucia e le nega. Così, quando scorriamo le parole d'ordine del nostro tempo; trasversalità, meticciato, contaminazioni, nomadismo - anche il nomadismo è una forma di transitività costante in cui io non sono mai me stesso perché sposto il luogo in cui mi identifico -le mutazioni di ctù si parlava sono altrettante modalità per sfuggire alla domanda sulla propria identità. Perché quello che spaventa non è il processo evolutivo metamorfico e ibridante, ma vedersi veramente quali si è. (Un velo di imbarazzo cala stt alcuni spettatori) Sto pensando ai quadri di Francis Bacon: lì c'è il terrore di scoprire cos'è l'essere umano, che cosa si è. E di fronte a questo terrore inaudito si mettono in atto le strategie del meticciato, del nomadismo, della metamorfosi, tutte spaventose, ma mai come il riuscire a vedersi veramente. Io do quindi un giudizio negativo e vorrei ridurre i concetti di cui abbiamo parlato a puri strumenti rivolti a me stesso. Utilizzarli come strumenti iniziatici e poi farli cadere, gettarli via, per vedere chi sono veramente; per vedere quel nucleo di eternità stabile, fisso, che non cambia mai da quando sono nato, che non riesco a vedere proprio perché ricorro a tutti questi espedienti che mi allontanano da ciò che io in realtà sono veramente. (Suona il cellulare, è la moglie che lo chiama)
FRANCO
(Amichevolmente) Laura, scusa ti chiamo dopo ...
FRANCESCO (Spenge una sigaretta e ne riaccende un'altra, parla veloce con un elegante accento settentrionale) Franco che ha il gusto per lo splatter e per il crash l'ha impostata tutta su questo tema. Ma nella straordinaria genealogia che ha creato, da Chirone fino a Frankenscein, si è dimenticato delle straordinarie trasformazioni dei lemuri.
18
ALCUNI SPETTATORI (Sembrano immersi in visioni remote, s1111na vegetazione galleggiante appaiono un Archaeoindris e un Megaladapis)
FRANCESCO
(Rapido) Ha costruito il suo discorso su figure riconoscibili, concrete, con una loro fisicità. A me interessa di più l'aspetto mentale della dimensione dell'ibrido, tutto da ricercare all'interno di categorie storico-critiche. Ma soprattutto credo che i concetti citaci - il nomadismo, il meticciato, la pluralità, la trasversalità - abbiano un'origine distorta. Vorrei cominciare una campagna contro l'uso e l'abuso di questi termini; una campagna come quella di papa Raczinger contro il relativismo. A partire dagli anni '60, dalla struttura de l'Opera Aperta di Umberto Eco si è spalancato un varco incredibile sul tema del rapporto fra aree e fruitore: con il fruitore che completa e termina l'opera. Basti pensare agli specchi di Pistoletto, dove il fruitore entra fisicamente nello specchio e completa l'opera
attraverso la restituzione della propria immagine. (Parla veloce, con ritmo) la disfatta dell'idea della contaminazione è iniziata con queste deformazioni della struttura ad opera aperta; da qui discendono tutte le aporie, tutte le incomprensioni che ci sono state intorno a questo tema. Un tema che negli anni '60 veniva definito come interdisciplinarità; mentre oggi usiamo questi termini, da flussi migracori. Io penso che il problema reale sia quello di
ricollocare in un alveo giusto i rapporti tra specifici diversi. (Rivolgendosi a Franco)
FRANCO (Con un mezzo sorriso) Ti faccio una domanda: non ti sembra che il concetto di molteplice sia ormai diventato un termine "politicamente corretto"?
FRANCESCO (Accende un'altra sigaretta. Un attimo di silenzio. Poi riprende con più forza) Sarei arrivaco anche a questo. Non vorrei più sentir parlare di ibrido, meticciato, nomadismo, concetti su cui stranamente si è accanito Achille Bonito Oliva, perché cucco ciò è una sorca di escamotage. E' un'operazione
19
che giustifica tutto quanto. Avete parlato di alcuni artisti straordinari e dell'idea della metamorfosi, però io penso che sia importante trovare argomenti che riconducano a una correttezza e una specificità inattaccabili dal confronto con l'altro da sé. Ecco allora che preferisco la chiarezza dello spiazzamento, del confronto, del rapporto adulto tra nomadi che dialogano tra di loro, l'affermazione di specifici che si confrontano tenendo salda la propria diversità. E questo lo dico a partire anche dalla mia drammatica esperienza personale, perché al tema del confronto era discipline diverse, all'idea delle contaminazioni io cempo fa ho creduto. In realtà avrei dovuto chiudere la galleria aam la sera del febbraio del 1978, quando ho visco che gli architetti venivano e guardavano solo gli architetti e gli artisti venivano e guardavano solo gli artisti. E' stato un fallimento.
ALCUNI SPETTATORI
(Si guardano, ricordano. Un uomo parla all'orecchio di una donna, lei annuisce)
FRANCESCO (Prosegue sostenuto) Poi ho continuato ad illudermi negli anni '90 con Thomas Scruth e con alcuni protagonisti di area tedesca che hanno tentato qualche forma di passaggio da una disciplina all'altra. Hanno provato a fuoriuscire dalla specificità, ma è una strada molto difficile e in realtà non ci è riuscite nemmeno Philip Johnson. (Pausa) Stù cui ruolo peraltro do un giudizio negativo perché si è sempre messo tristemente a capo di qualsiasi fenomeno quando già il fenomeno era diventato dilagante a livello universale. Negli ultimi anni però i suoi interventi sono tutti basaci sul tattile, sul duttile, sul rapporto psicofisico con l'oggetto creato, su una dimensione di corporeità che si rilegge nel tentativo di cerci scultori e di cerci architetti di passare da una dimensione propriamente scultorea a una dimensione architettonica e viceversa. (Con tono brillante) Credo che l'idea aymoniniana dell'architettura con una vocazione sculcorea non vada letta in chiave michelangiolesca, cioè del portar fuori dal blocco la scultura, perché in realtà essa è già intrinsecamente dentro al blocco di marmo; ma nell'idea vencuriana di dare corpo a questa finzione estrema I.:architercura si pone in maniera paradossale come oggetto scultoreo ed ecco allora che
20
Aymonino cir.a le veneri prefubbricate del raccordo anulare. Inoltre negli ultimi
progetti fa assumere all'oggetto architettonico questa vocazione scultorea e
credo che ci sia riuscito egregiamente nella Piazza Mulino a Matera, dove
confronta la gravitas del blocco urbano alla piacevolezza di un corpo martoriato e
in qualche modo indagato.
(Guarda Franco, pausa, leggero brusio in sala)
FRANCO ( Apre e chiude il taccuino nero, dove nel frattempo ha annotato qualcosa) Penso che quest'idea di trasversalità vada applicata in modo diverso da
come si applica adesso.
(Pausa) La trasversalità non è l'analogo della connessione. Vale a dire che connetto
una serie di cose di solito fra loro separate, stabilisco un nesso era le arti, tra aree e architettura. No, questa non è trasversalità, si tratta d i un altro
processo, è connettere elementi discanti. Credo che un esempio di
trasversalità potrebbe invece essere quello di studiare il design con gli strumenti delle scienze naturali, in particolare della biologia, piuttosto che
con gli strumenti di una trasversalità interna alle arei.
(Prosegue rafforzando il tono) Mi spiego: se tu consideri l'insieme, la sfera degli oggetti d i design,
come una popolazione di animali, come una fauna che colonizza
l'abitare, come se fossero germi, esseri viventi, allora utilizzi una
chiave trasversale per comprenderli.
ALCUNI SPETTATORI (Lunghe file di formiche attraversano lo sguardo di taluni seduti in prima fila)
FRANCO (Scientifico) Gli esseri viventi sono straordinariamente importanti, ma anche
straordinariamente dannosi. E secondo questo punto di vista, gli
oggetti di design si configurano come una popolazione parassitaria
che invade l'abitare. L'architettura non prevede cali infestazioni perché
ha alcre finalità e modalità e quando queste masse di batteri invadono
le strutture dell'abitare ne cambiano il valore e il senso. Ecco, secondo
me questo è un esempio di trasversalità: leggere il design attraverso
21
una metafora biologica. Gli altri sono solo esempi di connessione. In fondo l'unica trasversalità che io conosca prodotta negli ultimi
trent'anni è la teoria ecerotopica di Foucault che dice: "tu prendi le
cose e fai lo sforzo di considerarle come se fossero altre". (Con/orza) Questa è trasversalità. Altrimenti sono tutti pensieri di servizio, importanti
ma impliciti, che sono utili soltanto a farci capire le relazioni che esistono,
mentre la trasversalità è qualcosa di profondo e anche di pili difficile da
maneggiare. In questa idea del design, in fondo pericolosa, come una forma
di colonizzazione parassitaria dell'abitare umano da parte di oggetti che si autoprogettano, che si aucoriproducono, Citcerio, Mendini o Enzo Mari
funzionano da portatori passivi. Perché la grande quantità di oggetti già prodotti nella storia del design del '900 porta ad una riproduzione
automatica di altri oggetti. E Ciccerio funge da ponte, da veicolo, senza però
entrare veramente nella determinazione di questo organismo parassitario che è il d ivano che ha d isegnato. Questa secondo me è trasversalità. Così come
trasversalità è sicuramente il conflitto fra lo screecscyler e il designer, dove si innesca un sopraffarsi ciclico quando lo stilista copia dalla strada. E' un po' lo
stesso processo che c'è fra il mafioso vero e il mafioso rappresentato nel
cinema: una forma interessante d i trasversalità aggressiva, perché il mafioso si
vesce come i mafiosi del cinema, come George Ra.ft che poi però si ri-vesce
come i mafiosi che si sono visti al cinema, in un infinito gioco di specchi. (Continua abbastanza divertito) In realtà c'è una trasversalità conflittuale, che si rappresenta in forme secondo me
appropriate. Per quanto riguarda l'arte, non è r.anto interessante a mio awiso,
stabilire il rapporto che esiste era installazione, public are, videoarte, archiceccura, design, moda. Quanto invece capire se il museo ha ancora un senso e se l'arte
ormai è divenr.ata qualcosa che i veri artisti devono abbandonare e, se occorre ,
uccidere l'arte, liberarsene. Questa è trasversalità, questo è il pensiero trasversale:
è possibile per un artista uccidere l'arte? Ce la fa? E' necessario? O dobbiamo
accontentarci dei musei contemporanei, che sono macchine dentro le quali l'arte
muore in un modo indecente, invece di essere uccisa in un modo eroico?
ANTONELLA
(Si inserisce) Ma non l'aveva già fatto D uchamp: mettersi a giocare a scacchi invece di continuare a fare l'artista?
FRANCO
(La guarda)
22
:[ha fu.tto nei modi in cui poteva farlo nei primi anni del secolo scorso. Il problema di Duchamp non era grande come il nostro. Il nostro è un problema enorme. Si tratta dell'estinzione dell'arte per una sorca di eucanasia collettiva spaventosa, invece di una morte procurata e giustamente crudele. I musei che si costruiscono sono cimiteri in cui l'oggetto artistico, la presenza dell'arte, non c'è pù C'è casomai un suo simulacro assolutamente afusico che non si vede. Infu.tti gli artisti che vogliono avere visibilità devono fu.re cose sempre più crasversali, sempre più contaminate, in una specie di rincorsa continua perché manca la condizione prima, manca la possibilità di avere un rapporto vero, che è anche poi trasversale.
ANTONELLA (Rapida) Tu hai parlato di eterotopia di Foucault, Allora un altro esempio di trasversalità sono il fumetto e lo spazio dei videogiochi, per esempio, tutti da indagare rispetto al cinema ...
FRANCO (La interrompe) Non ci voglio interrompere, ma suggerirti un tema: in realtà no, perché quasi tutti i videogiochi non sono altro che la messa in ambito digitale dell'universo premoderno di Piranesi. Sono trabocchetti, agguati, carceri Piranesiane ripetute all'infinito.
ANTONELLA
(Con un tono di voce leggermente più alto) Anche Matrix ...
FRANCO ( Quasi serio) In realtà è Piranesi che sta sostenendo ancora oggi questo immaginario, che lo riattualizza. E' Piranesi dalla sua tomba che ancora trasmette. Io non vedo altro oltre Piranesi. Ancora una volta le carceri di Piranesi sono molto più forti di Macrix, su questo non c'è dubbio, sono molto più terrorizzanti. Se le guardi con un occhio che improvvisamente le vede per quello che sono, staccandoti dal modo in cui siamo abituaci a vederle e cioè come illustrazioni esteticamente
23
straordinarie, se riesci a cogliere quello che veramente succederebbe lì dentro, ci rendi conto della loro reale potenza. Io non credo che i videogiochi siano luoghi della trasversalità, come invece, per esempio, credo lo siano gli ospedali.
ANTONELLA
(Con estro) Tu hai citato i musei. Penso al lavoro di Mathew Barney al Guggenheim, alla parte del Crewmaster Cycle in cui fa interagire una persona con le gambe cagliate e le protesi. Mostra il corpo mutilato, lo contamina, lo metamorfizza e usa il museo come ospedale. Infatti, non a caso, ci sono le conigliette vestite anche da infermiere ...
FRANCO
( Rigirando tra le mani il taccttino) L'ospedale è uno dei luoghi dove l'ibridazione, la contaminazione, l'innesto, si esercitano in forme vere, non simulate, non estetiche. E' un luogo dove si fanno pratiche reali di crudeltà vera: il sangue è vero, non è il sangue splatter, il dolore è autentico, non rappresentato. Quindi quello è un luogo trasversale. (Continua guardandosi intorno) :[ospedale è un luogo che non fa parte del nostro ordine di valori. Un po' come la morte, l'ospedale è eliminato; come facciamo a parlare di trasversalità se eliminiamo questi luoghi ? Dovremmo parlarne perché lì è la trasversalità. Quindi è la trasversalità nel museo che dobbiamo uccidere insieme all'arte. Mentre la trasversalità nell'ospedale è quello che è, una fabbrica di orrori reale e quotidiana, non notturna. Nei film americani l'ospedale è una realtà notturna, invece dobbiamo pensare l'ospedale di giorno, nella sua normalità solare, come luogo di morte. Ecco la trasversalità, non le connessioni, ma la trasversalità.
ALCUNI SPETTATORI
(Le apparizioni si succedono rapide, un ttomo si alza)
FRANCO (Con tono leggermente ironico) Uno che connette è Franco Cervellini qui presence, che dovrebbe invece crasversalizzare. Uno che connette è Tonino, che adesso è andato via, ma dovrebbe trasversalizzare.
PRIMO SIGNORE (Voce bassa e tono serioso)
24
La connessione è una forma di pensiero progressivo.
FRANCO (Deciso) No, la connessione è uno strumento mentale, però di bassa intensità. E' proprio uno strumento, non una finalità . Q uando Antonella Greco e Federica Dal Falco parlano di trasversalità, indicano qualcosa di pit1 che una dimensione strumentale, indicano una sorta di finalità complessiva a cui si rivolge il mondo delle arti e anche delle azioni umane. Invece connessione è qualcosa che ci serve, ma non arriva a questo livello di complessità.
FRANCO (Fumando, rivolto a Franco) Come mai, Franco, c'è questa propensione al negativo che si vede nel modo con cui hai liquidato il tema del museo e ne hai sancito la sua impossibilità? In fondo tu ce l'hai con il museo.
FRANCO (Risponde rapido e deciso) No, il museo l'abbiamo già criticato nel convegno di quattro anni fa alla Triennale. Criticato in quanto luogo degenerato di un consumo superficiale. Ma secondo me ormai siamo più in là: è proprio l'istituzione museale in quanto tale, in quanto forma storicamente determinata che nasce in un certo incorno storico, in un cerco sistema di classi, in un certo ordine di valori che oggi vanno completamente respinti. Mancando la base, il museo decade dalla sua finalità istituzionale e va eliminato. (Pausa) Non so come si possa fare, perché poi è anche bello andare nei musei,
così come si fanno tante cose che è bello fare ma che non hanno più nessun senso vero. Ecco, il museo non è più criticabile perché è diventato il museo del libero consumo, come dicevamo quattro anni fa. Ma va
eliminato perché ha oltrepassato questa stessa soglia, è diventato un luogo di morte, di morte delle opere che ci scanno dentro.
ANTONELLA (Delicata, ma incisiva)
25
Infatti le opere spesso non ci sono. Si fanno continuamente musei, nuovi musei, che sono musei di se stessi, cioè dell'edificio, più che
altro dell'indotto economico che ha portato a cost ruire quel determinato museo, Bilbao, Pechino ...
FRANCESCO (Con fervore) Anche senza pensare all'arte contemporanea, pensa al museo di Meier dell'Ara Pacis, che è un museo che gira a vuoto. Cosa c'è là dentro? Che museo è quelloì Pensaci. Che cosa fa quell'oggetto lìì Non dico a che serve, ma che cos'è?
SECONDO SIGNORE (Ad alta voce) Io non toccherei l'argomento dell'Ara Pacis perché è una questione abbastanza diversa. Io penso a un museo vero, a Bilbao.
FRANCESCO (Convinto) E' il punto di svolta, è l'avvenimento che ha rivelato l'inconsistenza e la fine del museo nella nostra società. E' il canto di morte del museo. Viva Gerhy, che ha fatto in modo che ci si accorgesse di questo.
SECONDO SIGNORE (Quasi urlando) Quindi quello è un caso di omicidio utile e sano.
FRANCO (Aggiustandosi sidla sedia) Si, ma è un omicidio inconsapevole. Occorrerebbe farlo in modo
cosciente, sapendo quello che si sta facendo. Per esempio io non dico che ucciderei il design, ma lo studierei trasversalmente come un biologo studia l' influenza aviaria, perché di questo si tratta, è qualcosa che a mio avviso sta contaminando in modo spaventoso le nostre esistenze, governando e plasmando i rituali privaci e collettivi .
•
26
Questo fa il design, è una forma di canonizzazione dei rituali dell'esistenza che potrebbero avere ben altro valore se non ci fossero
oggetti di design. (Pausa, presegue con tono divertito) Mi ricordo che Mendini mi disse in una conversazione di tanti anni fa: "ho conosciuto una ragazza straordinaria che ha una casa in cui non c'è neanche un oggetto". Una ragazza che vuole una casa durissima, dove non c'è il lecco, non ci sono armadi, che tiene per terra le sue cose, le
sposta. È una persona che ha il rifiuto totale della dimensione parassitaria determinata dalla fauna degli oggetti di design. Questo secondo me è giusto; l'intuizione di questa ragazza che non conosco, che mi sarebbe piaciuto conoscere, è fondamentale. Bisogna liberarsi da questa forma di tutela. Una forma di trasversalità è il facto che lo spazio è tale quando chi c'è dentro esercita su di esso un dominio pieno. Ecco perché non c'è più spazio pubblico nella città contemporanea, perché non c'è più dominio pieno dell'abitante della città sullo spazio pubblico. E' espropriato, è diventato un appendice dello spazio di consumo o è diventato uno spazio performativo che segue logiche di tipo diverso, per esempio spettacolari, intrattenitive.
(Con fermezza) Questa secondo me è trasversalità e non connessione. Trasversalità significa allora essere attraversato, ossia dominare: lo spazio della città è attraversato dal consumo; l'ospedale è attraversato dal dolore nella sua solarità diurna, gli oggetti sono un virus ... Trasversalità significa quindi applicare una categoria di pensiero ad un ambito specifico.
TERZO SIGNORE (Rivolto a Franco) Tu hai visco qui la mostra del Moplen: quella è l'affermazione di una condizione che ha modificato le forme dell'abitare dal 1959 al 1969. Per l'uomo che ha subito questa modifica, assolutamente inconsapevole, non complice, si è trasformato il modo di vivere. Tra le altre cose abbiamo riscoperto nei documenti, nei vecchi Caroselli, che il signore Bramieri era il casalingo e la donna che interveniva anche un po' duramente su tutto ciò che lui rompeva di vecchio imponendo il nuovo era un architetto. Non lo sapevamo. Analogamente quella di Karim Rashid, sempre qui, è una mostra in cui una moltitudine di
27
oggetti, tanti da essere gli elementi su cui costruisce un affresco, sono gli elementi che navigano nel nostro quotidiano e modificano i nostri
comportamenti. Io concordo sulla questione del parassitario, in realtà c'è un rapporto simbiotico perché è parassitario l'oggetto, ma è parassita anche l'uomo che lo usa come protesi. Quindi è una condizione su cui io non esprimo un giudizio. Ed è una condizione in crescita esponenziale perché non è fatta solo di oggetti, materiali, ma è fatta anche di elementi immateriali, virtuali, che incidono nel rapporto con lo spazio. Uno spazio che Purini rivendica come condizione di cui l'uomo è padrone e che in realtà incidono ancora più pesantemente degli oggetti.
FRANCO (Puntualizza) Non ho usato la parola "padrone", ho detto "dominio". Dominare è qualcosa di più che possedere: significa esattamente informare di sé la cosa che si possiede. Lo spazio dell'uomo deve essere uno spazio a cui l'uomo imprime il senso del suo essere al mondo fino in fondo, non soltanto che usa o che è suo.
TERZO SIGNORE (Si alza, si siede in prima fila e prosegue con maggiore coinvolgimento) Ma oggi questo rapporto non è solo contaminato dagli oggetti materiali, ma anche da quelli immateriali. E' calcolato che attraversano ogni giorno la nostra vista 200.000 immagini. E' una condizione della contemporaneità. Poi l'artista, il designer e l'architetto, ma anche il narratore, hanno la forza di distruggere questa condizione, oltre che le loro discipline. Se da una parte io concordo con ce, dall'altra non voglio evitare di rappresentare questa condizione. Per cui se quest'anno Design Più si presenta in questa forma, l'anno prossimo potrà essere ancora più grande. Perché ci sia una consapevolezza. Altrimenti c'è un rapporto inconsapevole, il che è veramente dannoso. Sono i cuoi accendini che cambiano i cuoi comportamenti, lì modificano ma in forma inconsapevole. La funzione di una mostra, non di un museo, è quello di farci comprendere questo. Prendi la mostra sulla plastica: ognuno che passa
di lì dice "ce l'avevo". E ricorda come si è trasformata la propria esistenza.
28
FRANCO
(Alzando un po' il tono) Scusa, tu stai dando dell'esistenza umana una lettura connettiva di tipo sociologico. Ma io dico, chisseneimporta se trent'anni fa uno aveva un cerco oggetto, non è così importante, non significa nulla. Quello che è importante è che se tu trent'anni fa avevi un sogno, un desiderio, un progetto, dopo trent'anni sia riuscito a dargli una realtà
o se invece hai fallito. Non si fallisce mai come pensi tu. Tutto ciò è la schiuma del tempo che puoi scremare, non significa nulla; non puoi dare un valore a queste cose che ecceda la loro reale entità, altrimenti vai fuori strada. Altrimenti non vivi più la dimensione di pensiero critico e creativo. Il pensiero creativo è un pensiero che sostanzialmente si qualifica come distruttivo, non costruttivo a partire dalla memoria. Io questa mostra non andrò a veclerla, mi fa vivere molto meglio l'idea che gli oggetti d'uso che ho a casa, pochi, perché a me non piace averne tanti, siano qualcosa che mi è nemico e di cui mi devo liberare, non so quando, non so come, ma devo liberarmi di questa fauna aggressiva e parassitaria che mi impedisce di esercitare il pieno dominio sullo spazio che è solo mio.
TERZO SIGNORE
(Deciso) Ma la comprensione di quello che ti circonda adesso, in fondo, tu ce l'hai solo se guardi quello che ti circondava ieri. E' assolutamente così.
FRANCO
(Quasi infervorato) No, tu non stai parlando di comprensione, perché le cose si comprendono soltanto come quando leggi un libro, guardi un film. Lo leggi solo quando sei contrario a lui, ci vuole un principio positivo senza il quale vivere non serve a nulla. Tu hai una visione assecondante delle cose: cioè esistono le cose e io le assecondo. No, io le contrasto, non le voglio accettare, non le voglio legittimare.
TERZO SIGNORE (Guizzo negli occhi) Il problema è capire se le contrasti negandone l'esistenza o riprogettandole. E' tutto lì. La parola progetto non è priva di senso se
29
trasforma un'idea in un prodotto che prima non c'era. Non è una banalità, questa è una condizione che l'uomo vive da sempre.
FRANCO
(Con fare sostenuto) La parola progetto incorpora una dimensione balistica, è una parola che contiene la guerra, l'aggressività. La dobbiamo rifiutare, va sostituita con qualcun'altra che abbia meno carattere offensivo e antagonistico. Nasce così nella modernità la nozione di projet in francese e di project in Inghilterra. Nasce come un atto bellico.
TERZO SIGNORE
(Secondo guizzo negli occhi) Ma qual è l'esito? E' un bombardamento o un oggetto? O un prodotto?
FRANCO
( Risol11to) E' un bombardamento di oggetti.
TERZO SIGNORE
(Alzandosi in piedi) E' un bombardamento di oggetti. E allora tu di questo bombardamento di oggetti non te ne liberi se non con un altro bombardamento di oggetti. Non te ne liberi negandone l'esistenza.
FRANCO (Didattico) E' come con l'influenza aviaria, dobbiamo imparare a debellarla, ci vuole tempo. L'atteggiamento giusto è che non bisogna credere a nulla. Non bisogna credere nell'architettura in questi termini connettivi, ma appunto, nel senso di una vera trasversalità foucaultiana. Bisogna accettare il design nell'ottica di rimuoverlo. Così come bisogna andare nei musei sapendo che devono morire, perché altrimenti uccidono l'arte. Questa è trasversalità, questo è attraversamento delle cose. Altrimenti si tratta di assecondare e migliorare, ma a me questa prospettiva non interessa. Conosciamo bene da dove viene e dove arriverà, non sono fiori che spuntano da un vuoto pneumatico.
30
Questo tema bellissimo della trasversalità non va ridotto a quello della
connessione - che è uno strumento - e va invece inteso nella pienezza
oncologica del grande desiderio che nasconde di un modo di essere
d iversi nel mondo. Il design non ci rende più liberi, ci rende più
attrezzati, il che è un'altra cosa. Io voglio essere attrezzato, ma è diverso
dal voler essere libero. M i piace avere degli oggetti che mi servono, ma
non mi fanno libero, per essere libero io devo nutrire nei loro confronti
un atteggiamento ambivalente, duro, ostile e così diventano inutili.
(Breve pausa, moto rapidissimo del capo verso il terzo signore) Citami un oggetto di design che abbia saputo intercet tare un
infinitesimale frammento della nostra condizione umana. Pot remmo
citare decine d i fi lm, decine di libri, decine di architetture, ma non c'è
un oggetto di design che ci sia riuscito: dagli oggetti di Mendini agli
oggetti di Scarck, a quelli di chi vuoi. Hanno un ruolo riempitivo.
Consentirai con me che l'unico oggetco di design prodotto dalla
cultura giapponese nella seconda metà del '900 è la Katana con cui
Mishima ha fatto seppoku. E' l'unico che passa nella storia di tutti noi
come un oggetco emblematico che condensa il destino impregnandosi
di millenni di storia giapponese . .. Che altro ci ha dato il Giappone
nel design? Forse l'altro romanzo che contiene un riferimento a un
design straordinario è un racconto di Suzuki in cui una donna che si è
separata dal marito e vive in una casa sulla baia di Tokyo a un certo
punto prende un b icchiere, beve, e si accorge che dentro l'acqua c'è
del gesso, sente un sapore strano e comincia a pensare che nel
serbatoio dell'acqua di casa ci sia il cadavere di una bambina
scomparsa ... E quindi che c'è contaminazione dell'acqua raccolta in
questo bicchiere. E' un racconto d i una bellezza incredibile e di una
durezza estrema.
(Pausa) Per altro la straordinaria società giapponese che cosa ti ha proposto? Ma
anche la nostra: dimmi un oggetto del Made in icaly, che veramente, come
un'astronave semantica, abbia intercettato un brano della nostra storia. La cinquecento, la seicento, il moplen) Non credo, perché gli oggetti di design
sono cattivi. Faccio questo discorso perché ho studiato i contesti, sono un
lettore di riviste specializzate d i design, seguo il design, parlo con molti
designer che sono quasi tutti d'accordo con me. Tu non stai parlando di
oggetti, parli di oggetti nella rappresentazione letteraria e filmica o p ittorica
31
e quella è altra cosa. Q uando Pasolini parlava del cinema come arte
metonimica nella quale il tavolo che tu in un libro descriveresti a parole, lì lo
devi usare per quello che è e prendi un cavolo vero per rappresentare il tavolo
- in questo lui rintracciava l'essenza del cinema - chiarisci tutto.
(Pausa, poi prosegue rafforzando il tono) Quello che vedi nei film e nei romanzi non sono oggetti, ma oggetti
rappresentaci. Cerca invece di vedere gli oggetti per quello che sono nella loro
realtà di cose collaboranti, sociali, che hanno un loro progetto. Che è diverso dal progetco architetconico, le.:cerario, filmico. Questo mi sembra ovvio: non puoi
parlare degli oggetti di Proust, di Anconioni, di Van Gogh che ha
rappresentato sedie, cavoli, vasi di fiori, come parli degli oggetti che ci
circondano, che usi. I.:archi tectura è un campo che conosci bene, in cui la
presenza degli oggetti si rivela per quello che è, il dominio, per così dire, della
liturgia. Nella chiesa tu hai una serie di oggetti che sono oggetti disegnati,
alcuni oggetti di design veri e propri che però perdono il loro valore oggettuale
nel momento stesso in cui sono immessi nella temperatura liturgica e sono
giustamente ridotti a puri segni. Diventano qualcosa di cui sono portatori.
La liturgia esiste comunque, perché esiste il sacrificio anche nel deserto, anche
in assenza di oggetti. Nella dimensione liturgica g li oggetti perdono se stessi diventando quello che sono veramente, pura astrazione. Io direi astrazione
violenta e parassitaria, non me lo puoi contestare questo, formatrice di modelli
di comportamento collettivi e individuali a volte insostenibili. Ecco ci vorrebbe
una bella critica trasversale che veda gli oggetti per quello che sono.
FRANCO C.
(Inserendosi tra i due) Vorrei uscire dal paradosso per il quale l'unico oggetto di design è la Katana
con cui Mishima fa seppoku. Ci sacà pure qualche altra cosa da fare . . . (Verso Franco) Vorrei chiudere chiedendo a Franco Purini come interpreta, tra
ibridazione, contaminazione. la scena che Pasolini inserisce in
RoGoPag della crocifissione di Daniele da Volterra all'interno di uno
spezzone girato cucco in bianco e nero dove a un cerco momento c'è
Orson Wells. Si parli di quesco.
FRANCO
(Decisissimo)
•
32
No, io non ce ne parlo. Dico semplicemente che secondo me uno dei sensi veri dell'opera straordinaria di Pasolini è saper nominare le cose. Che poi è il compito nostro. Usarle. Non progettarle, perché la parola progetto si è intrisa di un realismo e di un tecnicismo insopportabili.
Facendo architettura noi nominiamo il mondo, le cose, quindi dobbiamo cominciare a nominare le cose per quello che sono. Quando dico design io nomino una fauna aggressiva e parassi caria che mi pone dei problemi. Penso che bisogna studiarla con gli strumenti della biologia considerandola come un'infezione. Dobbiamo guarirne, dobbiamo difenderci. Probabilmente non possiamo sterminarla, le malattie diventano latenti, i bacteri rimangono in accesa lì, maligni come sono.
ALCUNI SPETTATORI (Visione di sciami che attraversano la sala)
FRANCO Però con uno sguardo veramente trasversale noi scopriamo per esempio potenzialità straordinarie nel pensare il design, se lo consideriamo così. Perché allora dobbiamo individuare generi e specie: quindi non parlerò del settore merceologico dei divani, piuttosto che degli arredi per la casa, ma di grandi famiglie viventi che hanno un loro destino, un loro ciclo evolutivo e che hanno una loro finalità. Che vogliono dire qualcosa a noi, che noi dobbiamo ascoltare e non nominare. Ecco se su questo sei d'accordo capirai che per me il termine posto dalle due nostre ospiti, trasversalità, non è più semplicemente il connettere cose che sono diverse, quanto cercare nelle cose connesse qualcosa che le trascenda in virtù di una finalità superiore. Una finalità che non sia solo distruttiva, perché il pensiero
creativo è intrinsecamente distruttivo. (Appassionato) Io guardo, mi interrogo, voglio bene al mondo, però non lo voglio
assecondare. E questa cosa, la città enzimatica, non la voglio più sentire. La città è tutt'altro che enzimatica: è violenta è dura. E il
90% di noi sono esclusi dalla città. Questo dobbiamo saper dire, altrimenti che trasversalità c'è? La città ci soverchia: su due milioni e
600 mila abitanti a Roma, ci sono 200 mila persone che possono fare la vita che vogliono, tutte le altre sono costrette in una condizione tremenda. Basca fare un giro, ma non canto in periferia. Niente città
33
enzimatica, chiamiamola città dura che dobbiamo potentemente cambiare, questo è pensiero creativo. Questa è trasversalità, non la trasversalità all'acqua di rose, O il cavatappi ironico di Mendini, canto simpatico, gli voglio bene, ma chissenefrega. (Chiude il taccuino e lo rimette in tasca)
Applausi. Silenzio. Lenta evacuazione della stanza e ultimi saluti tra i partecipanti. Ma poco prima che il tecnico spenga tutte le luci, dal fondo del locale si alza ttna voce ferma che rimona nel vuoto
VECCHIO
(in teleconferenza appare un uomo incanutito, che sentenzia) Chi dunque ama il vero, dee i nomi definire dalle cose che rappresentano; e queste variando in ogni tempo e contrada, niuna definizione può essere più permanente di esse; ma giusta sarà, ogni qualvolta rappresenterà per l'appunto quella cosa, quale ella si era socco quel dato nome in quei dari tempi e luoghi.