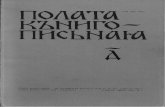Estetica dell’immanenza. Saggi sulle parole, le immagini e le macchine
Transcript of Estetica dell’immanenza. Saggi sulle parole, le immagini e le macchine
Copyright © MMVIIIARACNE editrice S.r.l.
via Raffaele Garofalo, 133 a/b00173 Roma
(06) 93781065
ISBN 978-88–548–1942–9
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: agosto 2008
Indice 7 Introduzione 13 Capitolo I
Intervalli bergsoniani 1. Vita 2. Natura 3. Intuizione 4. Immagini 5. Continuo
37 Capitolo II
Topologia del visibile 37 1. Cristalli di tempo 75 2. Lo spazio letterale 103 3. Illusione 115 Capitolo III
Strumenti meravigliosi 115 1. Jucunda spectacula: le macchinazioni gesuitiche 142 2. La costruzione dell’immanenza: il readymade 176 3. Macchina, occhio, corpo 199 Capitolo IV
Il posto delle parole 199 1. Fine della critica 223 2. La rivoluzione indifferente 231 3. Il taglio nell’immagine
5
Introduzione Mai la filosofia era parsa tanto fragile, più preziosa e più appassionante come nel momento in cui uno sbadiglio fa-ceva svanire nella bocca di Bergson l’esistenza di Dio.
M. Blanchot, Thomas l’oscuro
Un’estetica dell’immanenza costruita sulla diffusa e sfug-gente eredità concettuale del bergsonismo e delle sperimenta-zioni artistiche delle avanguardie storiche. È questa l’ipotesi messa alla prova nel tour de force saggistico del presente volu-me, sullo sfondo delle nuove forme della presenza svelate dalle filosofie della vita e dalla decostruzione della tradizione metafi-sica. Un’estetica dell’“anti-arte” del Novecento che, in forme eterogenee e secondo vettori spesso divergenti, ha radicalizzato l’unione di “mistica e meccanica” bergsoniana1, mostrando in-nesti imprevedibili tra la materia e la vita, tra l’umano e il tec-nologico, inventando dimensioni percettive e pratiche del con-cetto che congedano l’arte rappresentativa e formalistica della tradizione borghese.
Più che una genealogia storica, il filo conduttore di questi saggi è uno stile filosofico, l’esercizio di un “pensiero dell’immanenza”2, irriducibile alle modalità critiche dell’estetica post-kantiana e a quelle dialettiche dell’estetica
1 Cfr. H. Bergson, Le due fonti della morale e della religione, a cura di A. Pessina, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 195 e ss.
2 Punto di riferimento dell’attuale riflessione sulla nozione di “immanenza” è l’ultimo scritto di Gilles Deleuze: L’immanence: une vie …, in «Philosophie», n. 47, set-tembre 1995, pp. 3-7. Le posizioni deleuziane sono riprese con esiti originali da Giorgio Agamben (L’immanenza assoluta, in La potenza del pensiero, Neri Pozza, Vicenza 2005) e Roberto Esposito (Terza persona. Politiche della vita e filosofia dell’impersonale, Einaudi, Torino 2007, in particolare pp. 173-182).
7
Introduzione 8
post-hegeliana. I contorni di questo pensiero si delineano nelle quattro sezioni in cui è suddiviso il volume, dedicate rispetti-vamente all’immagine (Cap. II: Topologia del visibile), alle macchine disfunzionali gesuitiche e delle avanguardie (Cap. III: Strumenti meravigliosi) ed alle dislocazioni dei regimi discorsi-vi della critica filosofia e del linguaggio romanzesco (Cap. IV: Il posto delle parole). Il Capitolo I (Intervalli bergsoniani) è invece un corpo a corpo con alcuni concetti chiave della filosofia bergsoniana – “vita”, “natura”, “intuizione”, “immagine”, “continuo” – e rappresenta una messa a punto del lessico bergsoniano utilizzato poi nei capitoli seguenti.
Poiché la pratica di un “pensiero dell’immanenza” non si confonde con l’edificazione di un sistema filosofico, i saggi at-traverso cui si articola il presente volume vanno letti come un tentativo di plasmare la forma del pensiero sulla natura degli oggetti estetici presi di volta in volta in esame: il cinema ber-gsoniano di Roberto Rossellini, le fotografie museali di Thomas Struth e l’“illusione visiva” (Cap. II), le macchine barocche di Athanasius Kircher, i readymade di Marcel Duchamp e le scul-ture cinetiche di Jean Tinguely (Cap. III), i cultural studies, il romanzo futurista di Bruno Corra e il romanzo Thomas l’oscuro di Maurice Blanchot (Cap. III).
La natura di questi oggetti corrisponde alle caratteristiche at-tribuite da Henri Bergson ai piani di realtà colti dalla “percezio-ne”: una presenza eccentrica, un’immanenza tagliente e para-dossale, dischiusa da un sistema di azioni vitali irriducibili alle prestazioni della soggettività. La percezione, come organo spe-cifico assegnato da Bergson alle pratiche artistiche, non si apre sul reale ma si colloca, fende e allarga ciò che le abitudini sen-soriali e intellettive ritengono l’unica realtà possibile:
Vi sono in effetti, da secoli, uomini la cui funzione è giustamente quella di vedere e farci vedere ciò che noi non vediamo naturalmente.
Introduzione 9
Sono gli artisti […] L’arte servirà dunque a mostrarci che un’estensione delle facoltà di percepire è possibile3. Molti esponenti delle avanguardie storiche – tra questi i Fu-
turisti e Duchamp – e con essi artisti non appartenenti ai gruppi d’avanguardia e neo-avanguardia – ad esempio Rossellini e Struth – hanno assunto consapevolmente questa concezione del-la percezione e dell’arte, radicalizzandola al di là degli stessi suggerimenti estetici bergsoniani, che talvolta sembrano privi-legiare l’autonomia dell’arte dalla dimensione pratico-vitale e una “percezione di percezione” non più rivolta all’agire4. Attra-verso opere programmaticamente non-artistiche, Duchamp e Rossellini, Struth e Tinguely elaborano invece nuove modalità di azione, approfondendo la struttura degli atti vitali bergsonia-ni. La percezione invocata da Bergson è infatti una “percezione della presenza” e questa a sua volta si pone come un’operazione attualizzabile soltanto per mezzo dell’azione.
L’arte sperimentale e delle avanguardie coglie ed elabora costruttivamente il nucleo più profondo e innovativo del ber-gsonismo. In Bergson l’appello alla percezione è retto infatti da un esercizio topologico, corrispondente alle modalità di contatto tra tendenze immanenti alle dinamiche della vita, tendenze sempre orientate verso sbocchi attivi e informali5. Si tratta di una nuova geometria del vivente a cui corrisponde un’altrettanto imprevedibile pedagogia della percezione e del concetto6. A partire da Bergson, la filosofia diventa una pedagogia dell’esperienza vitale che abbandona l’orizzonte scolastico e si propone come terreno di coltura per ogni pratica
3 H. Bergson, La percezione del mutamento, in Pensiero e movimento, trad. it. di F. Sforza, Bompiani, Milano 2000, pp. 126-127. 4 «Di tanto in tanto, per qualche accidente felice, nascono uomini i cui senbsi e la
cui coscienza sono meno aderenti alla vita. La natura ha dimenticato di attaccare la loro facoltà di percepire a quella di agire […] Non percepiscono semplicemente in vista dell’agire, percepiscono per percepire, per niente, per il piacere» (ivi, pp. 128-129).
5 Il bergsonismo è «una dottrina dinamista che ammette solo tendenze orientate» (V. Jankélévitch, Bergson, trad. it. di G. Sansonetti, Morcelliana, Brescia 1991, p. 219)
6 Oltre che nell’Evoluzione creatrice e nei saggi di Pensiero e movimento, la topo-logia bergsoniana del vivente è elaborata nei testi raccolti in L’energia spirituale, trad. it. di G. Bianco, Cortina, Milano 2008, cfr. in particolare La coscienza e la vita.
Introduzione 10
dell’immanenza – sia essa artistica, come nel caso delle avan-guardie, o politica, come nel bergsonismo di Sorel e Papini.
Per un futurista bergsoniano come Umberto Boccioni non esistono più forme pure bensì “forme-forza” e “linee-forza” in-caricate di “dipingere la pura sensazione”7. Le tradizionali nor-me stilistiche e morfologiche sono sostituite da un’“intuizione della vita” ottenuta attraverso atti, gesti laceranti che fanno e-splodere i contorni degli oggetti:
Ora se noi vogliamo uscire dal vecchio concetto artistico e creare nuovi aspetti della realtà, se vogliamo distruggere l’episodio, e creare l’oggetto vissuto nelle sue forze, non analizzato nelle parti che lo compongono – analisi quasi sempre dannosa – noi vedremo che le li-nee, le forme e i colori dati come forze sono la sola espressione dina-mica possibile8. Mentre i Cubisti scompongono analiticamente e ricostrui-
scono intellettualmente la struttura delle apparenze sensibili, il Futurismo di Boccioni, Marinetti e Bragaglia “vive l’oggetto nelle sue forze”, ossia procede attraverso una pedagogia dell’azione vitale deformante, in vista di una geometria del vi-vente ottenuta per mezzo di “opere non-artistiche” (Duchamp).
La natura paradossale dell’anti-arte costruita sulla base della topologia bergsoniana – le macchine disfunzionali di Duchamp e Tinguely, le azioni artistiche di Marinetti, Boccioni e Depero, la Fotodinamica di Bragaglia – non va dunque ricondotta a mo-vimenti di trascendenza o di tensione verso l’assoluto, quanto alle contorsioni dell’immanenza, alla struttura aggrovigliata del-le “molteplicità continue” su cui si fonda l’ontologia bergsonia-na: «Godiamo, così, di poter rendere la vita nella sua unica, lo-gica, espressione e la realtà, nel suo più profondo carattere me-no realistico»9.
7 U. Boccioni, Pittura e scultura futuriste, a cura di Z. Birilli, Abscondita, Milano
2006, p. 147. 8 Ivi, p. 103. 9 G.A. Bragaglia, Fotodinamismo futurista, Einaudi, Torino 1970, p. 10.
Introduzione 11
L’arte “bergsoniana” a cui sono dedicati i saggi di questo volume si propone come tecnica di localizzazione e luogo di costruzione del reale, zona di contatto, “intervallo”10 – tra spa-zio e tempo, tra percezione e concetto, tra istinto e intelligenza e, in ultimo, tra l’uomo e i movimenti non-umani della materia vivente.
Nell’arte ispirata dalla filosofia bergsoniana gli oggetti este-tici – ad esempio il Grande Vetro duchampiano, vero e proprio manifesto del bergsonismo delle avanguardie (v. Cap. III, 2) – si concepiscono come laboratori della presenza, luoghi di spe-rimentazione e dunque d’innesto della percezione nella struttura della materia. Se i readymade di Duchamp e gli automi disfun-zionali di Tinguely, la gestualità macchinica del Futurismo ita-liano e i piani sequenza di Rossellini sono impregnati di ber-gsonismo, è perché essi abbracciano una topologia estetica or-fana dell’“artisticità”.
In Bergson, una “conversione” filosofica (epistrophé)11 sco-pre il “presente elastico” posto tra il virtuale e l’attuale (Mate-ria e memoria), lo “slancio vitale” nascosto tra istinto e intelli-genza (Evoluzione creatrice), l’“intuizione filosofica” che si a-gita tra la percezione e il concetto (Pensiero e movimento). Allo stesso modo, nell’anti-arte delle avanguardie è in gioco la preci-sione di un collocamento negli interstizi delle traiettorie di svi-luppo della vita, la pratica localizzante e attualizzante di “opere-macchina”, “opere-gesto”, “opere-concetto”, “opere-parenetiche”, mai “opere d’arte”12. Gli “intervalli” bergsoniani si proiettano e moltiplicano così nei “ritardi” e nell’“infra-sottile” di Duchamp, negli “stati intermovimentali” di Braga-glia, nelle “compenetrazioni” di Boccioni.
Dopo aver indagato nel Capitolo II la sfera delle immagini e nel Capitolo III la dimensione del “macchinico” – fondamentale luogo d’intersezione tra l’attività umana e la vita della materia –
10 “Intervallo” è un termine tecnico fondamentale dell’ontologia bergsoniana (v.
Cap. I). 11 H. Bergson, La percezione del mutamento,cit., p. 129. 12 Nel Capitolo III suggerisco una genealogia barocca per le pratiche macchiniche
delle avanguardie (v. Cap. III. 1)
Introduzione 12
il Capitolo IV esemplifica la posizione occupata dai linguaggi della critica e della letteratura all’interno di questa costellazione concettuale. L’esaurirsi del presupposto epistemico della “di-stanza critica” segnalato dalle metodologie dei cultural studies, l’indifferenza rivoluzionaria del protagonista del romanzo futu-rista di Bruno Corra e l’“immenso oblio” contenuto nella parola di Thomas l’oscuro di Blanchot sono altrettanti casi di imma-nentizzazione dell’esperienza, esperienze-limite di un “dentro” per il quale siamo ancora in attesa dei concetti adeguati.
Intervalli bergsoniani 1. Vita
Sullo sfondo della svolta bio-tecnologica del capitalismo a-
vanzato, la definizione e il rapporto del pensiero con la vita so-no nuovamente al centro della sperimentazione artistica e della riflessione filosofica1. Che si tratti di manipolazione genetica, di politica dei corpi o di estetica del post-umano, in gioco è la costruzione della vita, la produzione di un nuovo orizzonte del vivente in grado di sostituire le forme in decomposizione dell’umanità occidentale. Quando la natura, le funzioni e l’estensione della vita vengono investite dalle tecnologie politi-che, lasciar riposare il vivente nell’indeterminatezza di una de-finizione scolastica diventa infatti impossibile. Diventa allora necessaria una nuova “arte di vivere”2 che costringa a ripensare le prerogative assegnate dalla tradizione borghese all’attività ar-tistica e al pensiero concettuale.
A ben vedere, questo movimento verso la vita ripete, secon-do linee di sviluppo imprevedibili, una costellazione che a ca-vallo tra Ottocento e Novecento ha prodotto il vitalismo biolo-gico, la Lebensphilosophie, la transvalutazione nietzschiana dei valori, l’ontologia bergsoniana dello slancio vitale e i manifesti delle avanguardie storiche. In tutti questi casi, è la vita come campo estetico-politico che si affaccia al pensiero tra le maglie
1 Sul rapporto tra biologia e politica, cfr. in particolare R. Esposito: Immunitas.
Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino 2002, Bíos. Biopolitica e filosofia, Einaudi, Torino 2004, Terza persona. Politiche della vita e filosofia dell’impersonale, cit., Termini della politica. Comunità, immunità, biopolitica, Mimesis, Milano 2008.
2 G. Deleuze, Pourparler (1972-1990), trad. it. di S. Verdicchio, Quodlibet, Mace-rata 2000, p. 151.
13
Capitolo I 14
delle nuove forme di potere e dei nuovi saperi sul vivente. Al moltiplicarsi dei neovitalismi di stampo biologico e delle filoso-fie della vita – tra Driesch e Husserl, Simmel e Labriola, Dil-they e Scheler – si affiancano le sperimentazioni artistiche delle avanguardie storiche, anch’esse protese, sin dai primi manifesti futuristi, a scagliare le forme di vita della modernità lungo traiettorie ingovernabili: «Crediamo con Bergson che la vie dé-borde l’intelligence, cioè straripa, avviluppa e soffoca la picco-lissima intelligenza. Non si può intuire il prossimo futuro, se non collaborandovi col vivere tutta la vita»3.
Da questa prospettiva, il diritto enunciato da Foucault a ri-trovare «tutto quel che si può essere» vale come una ripetizione del programma futurista, e la creazione dei concetti di bio-storia, bio-politica e bio-potere prolunga il progetto bergsoniano di una “metafisica positiva” del biologico: «Diamo, dunque, al termine biologia il senso molto comprensivo che dovrebbe ave-re, che un giorno forse prenderà, e diciamo, per concludere, che ogni morale, pressione o aspirazione, è di essenza biologica»4.
Le conseguenze politico-antropologiche che le avanguardie storiche associano alla reinvenzione dell’agire a partire dalla tematizzazione delle strutture della vita suggeriscono che per «diventare tutto quel che si può essere» non è sufficiente ag-grapparsi, foucaultianamente, alle “forze che resistono”, riven-dicando i diritti al corpo, alla salute e alla felicità, capovolgendo la vita contro il sistema di potere che ne ha catturato la spontaneità5. Sulla scia di Nietzsche e Bergson, si tratta di affermare la positività e l’immanenza del vivente nel luogo stesso della sua costituzione: «Se ogni essere vivente nasce, si sviluppa e muore, se la vita è una evoluzione e se la durata è qui una realtà, non c’è anche una intuizione del vitale, e di conseguenza una metafisica della vita, che prolungherà la
3 F.T. Marinetti, Guerra sola igiene del mondo, in Teoria e invenzione futurista,
Mondadori, Milano 1983, p. 331. 4 Id., Le due fonti della morale e della religione, cit., p. 72. Cfr. inoltre Mélanges,
PUF, Paris 1972, pp. 463-502. 5 Cfr. M. Foucault, La volontà di sapere, trad. it. di P. Pasquino e G. Procacci, Fel-
trinelli, Milano 1978, p. 128.
Intervalli bergsoniani 15
metafisica della vita, che prolungherà la scienza del vivente?»6. Quanto al pensiero, esso è chiamato ad orientarsi verso delle tecniche di collocazione, tra misticismo e rivoluzione, quieti-smo e attivismo: pensare equivale a far posto alla vita. In ogni caso, una volta riconosciuta l’intersezione di conoscenza e vita, il concetto riformula il proprio inserimento nel reale, voltando le spalle alla teoria della conoscenza e collocandosi nel campo di tensione che va dall’eterno ritorno nietzschiano alla decisione sovrana di Carl Schmitt7. L’unione di mistica e meccanica in Bergson, la volontà di potenza nietzschiana, gli automi di Vil-liers de l’Isle-Adam e di Roussel, le “macchine celibi” di Du-champ e gli oltre-uomini artificiali o barbarici di Marinetti sono esempi significativi delle nuove positività che emergono a parti-re dalla prassi topologica del vivente. Della vita, della sua nudi-tà biologica o dei suoi abiti sociali, non interessa più la defini-zione sostanziale ma l’efficacia, la capacità di ampliamento o resistenza nei confronti dell’azione, la sua dislocazione su piani che riconfigurano gli equilibri tra i concetti e le convenzioni so-ciali.
Nella prospettiva delle tecniche di raccordo, inserimento, sovrapposizione e contatto della vita con il pensiero, la cono-scenza del vivente possiede la caratteristica di essere “limitata” ma non “relativa”8. Alla vita ci si rivolge non per imprigionarla in un sistema di principi e relazioni formali retti da criteri di ve-rità ma per sperimentare una pedagogia degli atti indivisibili e degli arresti, degli slanci e delle frammentazioni dell’azione. Se si accetta il presupposto che «noi siamo là dove noi agiamo», ovvero che in gioco ci sia il luogo di un’azione e non il “che co-sa” della descrizione di una sostanza, i rapporti tra corpo orga-nico e corpo inorganico, tra unità e dispersione della materia
6 H. Bergson, Pensiero e movimento, cit., p. 25. 7 «Vi sono dei modi di vivere, in cui le difficoltà sono enormemente accresciute, e
tale è la vita dei pensatori: a questo proposito, quando se ne racconta qualcosa, bisogna ascoltare attentamente, poiché qui si può intendere qualcosa a riguardo delle possibilità di vita» (F. Nietzsche, Frammenti postumi 1875-1876, cit. in G. Deleuze, Pourparlez, p. 15).
8 H. Bergson, Mélanges, cit., p. 494.
Capitolo I 16
producono circuiti al cui interno si dispiega la varietà dei mo-vimenti vitali e delle forme di esistenza ad essi corrispondenti9.
Nel contesto di questa attualità del vivente s’inserisce la rin-novata diffusione trasversale della filosofia bergsoniana, testi-moniata dal moltiplicarsi di traduzioni e pubblicazioni mono-grafiche10. Riflessi nello specchio anamorfico bergsoniano, i grandi temi del vitalismo occidentale – che si affacciano nel De anima aristotelico e nella filosofia stoica – assumono infatti configurazioni originali e si ritrovano spostati su un nuovo terri-torio: un pensiero della “densità” dell’essere d’ispirazione natu-ralistica, radicalmente non cristiano e non dialettico11. L’onto-topologia del corpo di Merleau-Ponty, la filosofia dell’immanenza deleuziana così come la biopolitica foucaultia-na affondano le loro radici in questo bergsonismo latente, di cui si tratta di recuperare la forza concettuale, strappandolo alla mortificazione esegetica e sviluppandone le implicazioni esteti-co-politiche.
9 Se «la superficie del nostro piccolissimo corpo organizzato (organizzato proprio
in vista dell’azione immediata) è il luogo dei nostri movimenti attuali, il nostro grandis-simo corpo inorganico è il luogo delle nostre azioni eventuali e teoricamente possibili» (Id., Le due fonti della morale e della religione, cit., pp. 188-189).
10 In Italia, questa tendenza è confermata dalla ripubblicazione delle principali ope-re bergsoniane presso le Edizioni Cortina e dal moltiplicarsi di traduzioni e monografie dedicate a Bergson o a temi bergsoniani: cfr. G. Deleuze, Il bergsonismo e altri saggi, a cura di P.A. Rovatti e D. Borca, Einaudi, Torino 2001; R. Diodato, Estetica del virtuale, Bruno Mondadori, Milano 2005; R. Barilli, Bergson. Il filosofo del software, Cortina, Milano 2005; G. Canguilhem, G. Deleuze, Il significato della vita. Letture del III capi-tolo dell’Evoluzione creatrice di Bergson, Mimesis, Milano 2006 e G. Fasolo, Tempo e durata. Il luogo del presente in Aristotele e Bergson, Alboversorio, Milano 2006. Il rin-novato interesse per la filosofia bergsoniana travalica tuttavia le frontiere italiane: cfr. J. Mullarkey, Bergson and Philosophy, Edinburgh University Press, Edinburgh 1999; Y. Conry, L’Évolution créatrice d’Henri Bergson, Harmattan, Paris 2000; Henri Bergson: esprit et langage, a cura di C. Stancati, Pierre Mardaga, Hayen 2001; K.H. Pearson, Philosophy and the Adventure of the Virtual. Bergson and the Time of Life, Routledge, London 2002. Per una rassegna bibliografica ragionata, che tiene conto della ricezione post-deleuziana di Bergson, cfr. S. Guerlac, Thinking in Time. An Introduction to Henri Bergson, Cornell University Press, Ithaca and London 2006, pp. 173-196.
11 «Cogliamoci nuovamente, invece, così come siamo, in un presente denso e, in più, elastico» (H. Bergson, Pensiero e movimento, cit., p. 119).
Intervalli bergsoniani 17
2. Natura Poiché è grazie a Deleuze che abbiamo imparato a leggere
con occhi nuovi Bergson, riconoscendo le vie attraverso le quali lo spiritualismo bergsoniano è confluito in un nuovo naturali-smo, è necessario interrogarsi sulla direzione da lui impressa al bergsonismo e mettere a fuoco la topologia bergsoniana del vi-vente a partire dalla lettura deleuziana12. Il concatenamento stoicismo-Spinoza-Bergson – e ai suoi margini l’aggancio dell’empirismo, di parte del positivismo francese e di Nietzsche – ha riaperto i giochi in filosofia, affiancando alla fenomenolo-gia e all’heideggerismo un nuovo stile di pensiero, nel senso ri-vendicato da Deleuze, «qualcosa che appartiene a coloro di cui si dice solitamente “non hanno stile”»13. Uno stile del “diveni-re-Bergson” impensabile e impraticabile senza la costruzione di un Bergson-macellaio, del Bergson che taglia il reale come il macellaio platonico taglia le sue carni14. Fare filosofia con il coltello, oltre che con il martello di Nietzsche. Tagliare e rita-gliare, seguendo le articolazioni del reale, poi piegare e cucire, facendosi bricoleurs della natura. Il bergsonismo deleuziano è un metodo di differenziazione e integrazione, di divisione e in-tersezione, un “empirismo superiore”.
Dopo aver strappato Bergson ai propri interpreti e aver lace-rato l’immagine convenzionale della sua filosofia, Deleuze ha raccolto i frammenti concettuali del bergsonismo e li ha ricom-posti in modo imprevedibile, in molteplici cifre intensive, ad
12 Nel 1956 Gilles Deleuze pubblica i saggi Bergson. 1859-1941 e La conception de
la différence chez Bergson, il primo nella collana Les Philosophes célèbres, diretta da Merleau-Ponty per le Éditions d’Art Lucien Mazenod, il secondo negli Études bergso-niennes (Albin Michel, Paris). Entrambi i testi sono raccolti in Il bergsonismo e altri saggi, cit. Più recente è la pubblicazione del corso di Deleuze del 1960 dedicato al terzo capitolo dell’Evoluzione creatrice (trad. it. in G. Canguilhem, G. Deleuze, Il significato della vita, cit.). Sull’evoluzione del pensiero deleuziano in riferimento alla lettura di Bergson, cfr. l’“Introduzione” di A. Sauvagnargues, in Annales bergsoniennes II. Ber-gson, Deleuze, la phénomenologie, a cura di F. Worms, PUF, Paris 2004, pp. 150-165.
13 G. Deleuze e C. Parnet, Conversazioni, trad. it. di G. Comolli e R. Kirchmayr, Ombre Corte, Verona 2007, p. 10.
14 H. Bergson, L’evoluzione creatrice, trad. it. di F. Polidori, Cortina, Milano, p. 130.
Capitolo I 18
esempio gli schemi di ordinamento del “piano d’immanenza” di Che cos’è la filosofia? Questo Bergson – finalmente riconse-gnato al clima avanguardista d’inizio secolo, a un vitalismo an-ti-umanistico e anti-cristiano – è un maestro di costruttivismo fi-losofico. La macelleria praticata da Deleuze sul corpo della tra-dizione filosofica ha prolungato così una linea di fuga del ber-gsonismo, mettendo in salvo l’empirismo, lo spinozismo e il na-turalismo sepolti nel clima hegeliano e fenomenologico della fi-losofia del dopoguerra.
Secondo Deleuze, il nucleo della filosofia bergsoniana è un “metodo di divisione” d’ispirazione platonica, fondato sull’intuizione e sulle regole che ne increspano la superficie: “problematizzazione”, “differenziazione” e “temporalizzazio-ne”15. Benché l’intuizione sia un atto semplice, essa «non e-sclude una molteplicità qualitativa e virtuale». Il metodo ber-gsoniano procede attraverso una critica dei falsi problemi e un’invenzione dei nuovi (problematizzazione); esso taglia e in-terseca, ricerca le differenze di natura e le articolazioni del reale (differenziazione); infine, esso traduce tutte le differenze di na-tura nel gergo della durata, raccogliendole in una temporalità che differisce da se stessa (temporalizzazione).
Deleuze descrive la struttura topologica dell’intuizione ber-gsoniana come un’esperienza densa delle molteplicità continue: semplicità e articolazione interna, un «qualcosa di semplice, di infinitamente semplice» che si riflette nella complessità della dottrina; “incommensurabilità” tra l’intuizione concreta e le forme della sua manifestazione concettuale. Il metodo rispec-chia in tal modo la natura della durata, coordinando successione e fusione, eterogeneità e continuità. Parodiando le regulae car-tesiane, Deleuze trova le norme del bergsonismo, ne esalta il pa-thos della precisione per farne un nuovo cartesianesimo, una metafisica metodizzata capace di sostituirsi alle filosofie dialet-tiche e fenomenologiche.
Alla durata come sostanza corrisponde dunque l’intuizione come metodo; e poiché la durata è la differenza interna alla na-
15 G. Deleuze, Il bergsonismo e altri saggi, cit., p. 25.
Intervalli bergsoniani 19
tura, l’intuizione è un metodo differenziante, che ripudia con-traddizione, alterità e negazione in nome della “differenza in sé” della temporalizzazione:
Sia la dialettica dell’alterità di Platone che la dialettica della con-traddizione di Hegel, implicano la presenza e il potere del negati-vo. L’originalità della concezione bergsoniana consiste nel dimo-strare che la differenza interna non si spinge, e non deve farlo, fi-no alla contraddizione, all’alterità e al negativo, perché, di fatto, queste tre nozioni sono meno profonde della differenza stessa, oppure sono dei punti di vista che la colgono solo dall’esterno16. Per seguaci e detrattori, il bergsonismo è dunque innanzitut-
to una filosofia della temporalità e un platonismo della durata. Così, in uno dei luoghi più densi del confronto tra Heidegger e Bergson, Derrida inchioda il bergsonismo all’ontologia del tempo che “da Aristotele a Bergson” è segretamente dominata dalla sovrapposizione di “presenza” e “presente”, Anwesenheit e Gegenwart. Poiché Bergson ha collocato l’ontologia nel passato puro, separando con un taglio netto la memoria dai paradossi dell’azione e della presenza, pare inverosimile ogni tentativo di districare il bergsonismo dal platonismo, riportando la sua me-tafisica sul piano dei processi vitali. In quanto filosofia dell’unità indivisibile delle molteplicità continue, il bergsoni-smo appare come una filosofia dell’uno e del molteplice, un platonismo come quello attribuito da Badiou all’ontologia di Deleuze.
E tuttavia, nonostante sia difficile resistere alla seducente impressione che quella di Bergson sia una filosofia della durata, un grido di protesta nei confronti della spazializzazione del pen-siero17, due presupposti fondamentali dell’interpretazione de-leuziana possono venire dislocati da una nuova lettura topologi-ca dell’ontologia di Bergson. In particolare, si tratta di abban-
16 Ivi, p. 137-138. 17 «La spazialità dunque e, in questo senso tutto speciale, la socialità, sono le vere
cause della relatività della nostra conoscenza: scartando questo velo interposto, ritor-niamo all’immediato e tocchiamo un assoluto» (H. Bergson, Pensiero e movimento, cit., p. 20).
Capitolo I 20
donare l’ipotesi che il bergsonismo sia riconducibile a un «pla-tonismo del metodo di divisione», un’idea sostenuta da Deleuze a scapito della concettualità aristotelica, e che i movimenti di “temporalizzazione” descritti da Bergson costituiscano uno “schematismo della differenza”, un residuo del kantismo e del trascendentalismo di Deleuze, che accetta l’idea del tempo co-me forma della sensibilità.
E se il bergsonismo fosse un’ontologia dei limiti, un costrut-tivismo topologico piuttosto che un pensiero del concetto che «non ha coordinate spazio-temporali, ma soltanto ordinate in-tensive»18? Bergson affronta apertamente la metafisica aristote-lica del continuo nella tesi di dottorato latina L’idea di luogo in Aristotele, un’opera alla quale è stata prestata sinora un’attenzione limitata19. A partire da questo testo, coevo rispet-to al Saggio sui dati immediati della coscienza, è possibile deci-frare i presupposti topologici del pensiero bergsoniano del limi-te. Qui Bergson sottopone a un commento dettagliato il IV libro della Fisica di Aristotele, soffermandosi sulla definizione di luogo come «superficie interna del contenente». Le implicazioni della tesi aristotelica sono paradossali: un corpo è posto in un luogo che lo contiene solo se il movimento è potenziale, non appena il movimento si attualizza il corpo perde il luogo che dovrebbe occupare: «un corpo è in possesso di un luogo a con-dizione di essere fuori dal luogo»20. Facendo propria questa premessa, Bergson assegna a un “limite mobile” che unisce at-
18 G. Deleuze, Che cos’è la filosofia, trad. it. di A. De Lorenzis, Einaudi, Torino
1996, p. 11. 19 H. Bergson, Quid Aristoteles de loco senserit, Alcan, Paris 1889; trad. it. L’idea
di luogo in Aristotele, in Opere, Mondadori, Milano 1986. Su questo testo cfr. F. Heid-sieck, Henri Bergson et la notion d’espace, cit., L. Couturat, Etudes sur l'espace et le temps de MM. Lechalas, Poincaré, Delboeuf, Bergson, Weber et Evellin, «Revue de métaphysique et de morale», n. 4, 1896; H. Barreau, Bergson et Zénon d’Élée, «Revue Philosophique de Louvain», n. 67, 1969; C. J. Connor, Zeno of Elea and Bergson’s Ne-glected Thesis, «Journal of the History of Philosophy», n. 12, 1974; M. Boudot, L’espace selon Bergson, «Revue de Metaphysique et de Morale», n. 85, 1980 e M. Za-natta, La théorie aristotélicienne du lieu selon Bergson, in Henri Bergson: esprit et lan-gage, cit. Fa eccezione il recente volume di G. Fagiolo, Tempo e durata, op. cit.
20 H. Bergson, L’idea di luogo in Aristotele, cit., p. 381.
Intervalli bergsoniani 21
tualità e potenzialità, il compito di distribuire e mettere in rap-porto (costruire) la memoria e la materia, il tempo e lo spazio21.
Come ricorda anche Brentano rifacendosi ad Aristotele, sia ciò che è spaziale sia ciò che è temporale «può esistere solo nel contesto di un continuum» i cui elementi principali sono «limiti che non esistono in se stessi ma soltanto in quanto appartengo-no al continuum»22. L’intenzione di Bergson è di ricollocare genealogicamente al centro dell’ontologia la topologia aristote-lica del continuo. Se i nemici di Aristotele sono gli atomisti, quelli di Bergson sono i filosofi che, come Spencer, riducono lo spazio a un teatro infinito del movimento e la materia alla di-scontinuità di elementi esterni gli uni agli altri. Aristotele ha «voluto che lo spazio, prematuramente emancipato ad opera di Leucippo e Democrito, fosse ricondotto nei corpi»; Bergson vuole che lo spazio “libero e svincolato” che fa da sfondo alla rappresentazione matematica del movimento sia nuovamente “sepolto ... nei corpi”23.
3. Intuizione Tanto per Brentano quanto per Bergson il limite non è un
concetto ma un’intuizione; e tuttavia, mentre Brentano descrive analiticamente la struttura dei limiti, Bergson s’installa dentro il loro spessore, ne mette alla prova il funzionamento. Di qui i molti fraintendimenti a cui è andato incontro il suo pensiero, la coesistenza di precisione intuitiva e magmatica variabilità con-cettuale. Invece di domandarsi che cosa sia l’intuizione, Ber-gson procede in senso topologico, indagando il dove degli atti d’intuizione. Dove accade l’intuizione? Nel soggetto, nella du-
21 Fra i filosofi che hanno introdotto e rielaborato in ambito epistemologico questo
aspetto dell’ontologia di Bergson, cfr. Gilbert Simondon, in particolare le nozioni di “trasduttività” e “individuazione”, G. Simondon, L’individuazione psichica e collettiva, a cura di P. Virno, DeriveApprodi, Roma 2001.
22 F. Brentano, Philosophical Investigations on Space, Time and the Continuum, a cura di B. Smith, Croom Helm, New York 1988, p. 176.
23 H. Bergson, L’idea di luogo in Aristotele, cit., p. 390.
Capitolo I 22
rata, nello spazio, nello spirito, nella vita, nell’essere? A secon-da delle risposte otterremo un bergsonismo psicologistico, me-tafisico, geometrico, spiritualistico, vitalistico, ontologico; a-vremo insomma la tradizione interpretativa bergsoniana.
In pagine decisive di Pensiero e movimento Bergson ricono-sce i pericoli associati all’uso del termine intuizione. Esso può trarre in inganno non a causa della sua vaghezza ma nel sugge-rire un luogo sbagliato per l’intuizione. Ad esempio, «uno Schelling, uno Schopenhauer […] poiché credevano che l’intelligenza operasse nel tempo, ne hanno concluso che oltre-passare l’intelligenza consistesse nell’uscire dal tempo»24. L’errore di queste posizioni è topologico: per Bergson è l’intelligenza che si accorda allo spazio empirico, mentre l’intuizione è ciò che si pone nel tempo. L’unica definizione a-deguata dell’intuizione la pone come il metodo di ciò che non ha metodo, il metodo dell’accorgersi “che si è nel reale”.
L’intuizione bergsoniana è una sorta di contro-riduzione tra-scendentale con la quale non si fa astrazione dell’esistenza ben-sì della sua non-collocabilità. Poiché il metodo è sempre dentro ciò di cui è metodo, lo “sforzo” non si riduce alla posizione vi-siva di uno “stare davanti” alle essenze25 ma è la prova di un’attività che si compie dentro e a partire da un luogo. L’intuizione è il come di questo dove, la descrizione degli atti vitali che penetrano gli oggetti di cui sono metodo, le funzioni di cui sono funzione; essa è una modalità del “sistemarsi” all’interno di ciò che s’intuisce, secondo il motto: «uno sforzo nuovo per ogni problema»26.
Dopo aver precisato, ancora una volta attraverso una ripeti-zione dell’ontologia di Aristotele, la molteplicità dei sensi attra-verso cui si parla abitualmente di “intuizione”, Bergson enume-ra alcuni dei luoghi in cui è possibile accorgersi di essere nel re-ale: l’esperienza, la “durata interiore”, l’universo materiale che «fa attendere la nostra coscienza», i concetti e, su tutti, il mo-
24 Id., La posizione dei problemi, in Pensiero e movimento, cit., p. 23. 25 Ibidem 26 Ivi, p. 24.
Intervalli bergsoniani 23
vimento. La collocazione più difficile, che richiede maggiore sforzo, corrisponde all’intuizione della “mobilità originale”, la capacità di prendere posto nella “sostanzialità del movimento”. L’intuizione è una pedagogia dell’abitare e dell’agire: intuire significa imparare a vivere nell’ombra proiettata dalle attitudini del corpo, imparare a “inserirci al suo interno”27, penetrare gli intervalli tra stati del mondo.
Il bergsonismo è un costruttivismo dell’intervallo: tra una simultaneità di stati del mondo e un’altra, tra uomo e natura, tra atti di pensiero e mobilità, esistono loci pieni, intervalli reali. Mentre «l’intelligenza scientifica […] necessariamente trascura ciò che accade nell’intervallo»28, filosofare significa pensare la vita dell’intervallo. Gli intervalli bergsoniani sono topoidi spa-zio-temporali, il risultato di una “penetrazione”, di un contatto tra i dualismi delle filosofie ingenue: spazio e tempo, materia e memoria, attuale e virtuale, natura e spirito. La penetrazione è più di un metodo e meno di una sostanza, essa corrisponde alle due facce dell’esperienza: dal punto di vista del soggetto è un contatto, da quello dell’oggetto è il modo di essere della durata. All’incrocio tra queste due dimensioni c’è l’esperienza, che nel-la sua declinazione filosofica si presenta come «una penetrazio-ne reciproca che è pura durata, refrattaria alla legge e alla dura-ta»29.
Bergson tematizza l’intuizione nel contesto dei modelli di sviluppo del discorso filosofico. Come si crea una filosofia? Qual è il segreto di un sistema filosofico? Come ogni macchina dotata della possibilità di deviare e imprimere direzioni inaspet-tate all’azione, una filosofia viva è una filosofia fondata su mo-vimenti piuttosto che su frasi e parole. Ogni “atto di pensiero”30 imprime un movimento specifico e dunque il senso con cui ha a che fare una filosofia non è per Bergson una “cosa pensata” ma un “movimento di pensiero”31. Poiché Bergson non è un feno-
27 Ivi, p. 101. 28 Ibidem 29 Ivi, p. 115. 30 Ivi, p. 112. 31 Ibidem
Capitolo I 24
menologo, ciò che gli preme non è realizzare una tassonomia noetica ma inserire gli atti di pensiero all’interno della mobilità stessa, agganciare la forma del senso alla struttura di ciò che è mobile e mutevole. Il pensiero è un ingranaggio attraverso cui sono trasmessi i movimenti vitali. Ogni pensiero corrisponde a una tipologia di movimento: “la pensée et le muovant”, un “concatenamento macchinico”32.
La costruzione di una risposta alla domanda “che cos’è un concatenamento?” ha occupato Deleuze nel corso della sua col-laborazione con Guattari. Deleuze radicalizza la “meccanica non meccanicistica” bergsoniana: il concatenamento realizza, bergsonianamente, una “simbiosi, una ‘simpatia’”33. Sympathi-ser, inserire debolmente il pensiero nella natura, imprimere di-rezioni di pensiero irriducibili alla coppia aggredire-subire, alla sintesi idealistica o alla contemplazione quietista: «La regola della scienza è quella già posta da Bacone: obbedire per coman-dare. Il filosofo non obbedisce né comanda, cerca di sympathi-ser»34. In che cosa consistono e come funzionano i legami pro-dotti da questa simbiosi? Che cosa significa agganciare alla mobilità stessa, attraverso una “simpatia”, dei movimenti di pensiero?
Sullo sfondo, il dilemma della localizzazione ontologica: in Bergson il confronto con il dove dell’intuizione, il dialogo con la concezione aristotelica del luogo; in Deleuze, il primato della geografia, della topologia del “fuori”, le pieghe e il nomadismo. Né Bergson né Deleuze condividono i territori della fenomeno-logia, i vissuti e la costituzione trascendentale della coscienza; la simbiosi che lega pensiero e movimento abita un luogo vitale ma non-umano.
Il bergsonismo è una interferenza del rapporto tra luogo e movimento. Sympathiser significa innanzitutto creare un lega-me tra pensiero e natura, tra forme degli atti di pensiero e strut-ture del movimento naturale. Ma il legame, la condizione di
32 G. Deleuze e C. Parnet, Conversazioni, cit., p. 76 e ss. 33 Ivi, p. 76 34 H. Bergson, Pensiero e movimento, cit., p. 117.
Intervalli bergsoniani 25
questo movimento superiore del pensiero in cui consiste la filo-sofia è un luogo in cui ci si colloca per intersecare movimenti vitali eterogenei, il luogo di una “familiarità con la natura” che sostituisce la diffidenza e la lotta.
La “macchina” espressiva in cui consiste il metodo bergso-niano è alimentata da concetti e immagini e posta in “un presen-te denso” ed “elastico”. A differenza delle “macchine celibi” descritte da Michel Carrouges35, ciò che conta per Bergson non è il “padrone della macchina” quanto il prolungamento, l’attesa (v. Cap. II, 1), la coscienza su cui poggia l’accoppiamento – un legame biologico piuttosto che gnoseologico – tra pensiero e natura.
Anche per quanto riguarda l’ontologia dell’intervallo, Du-champ ha prolungato il bergsonismo più di ogni pensatore si-stematico (v. Cap. III, 2). L’“infra-sottile” (infra-mince) è il pieno dell’eterogeneità, la differenza fisica interna a un diffe-renziale: «Calcolare la differenza tra i volumi d’aria spostati da una camicia pulita (stirata e piegata) e la stessa camicia spor-ca»36. Come suggerito nel commento all’immagine della “sotti-le pellicola trasparente” di Berkeley, l’intervallo bergsoniano è un dispositivo biologico, un luogo descrivibile da formalizza-zioni senza previsione; allo stesso modo, l’infra-mince du-champiano è l’oggetto di un calcolo paradossale, perchè fondato su entità qualitative eterogenee. “Calcolare la differenza” signi-fica per Duchamp “accoppiare per infra-sottile”, costruire la struttura della differenza interna: «Quando il fumo / di tabacco / sa anche / della bocca / che lo esala / i due odori / si accoppiano per / infra-sottile»37. L’assurdità dell’infra-mince è la stessa del-la natura per Bergson – «Ciò che è assurdo ai nostri occhi, non lo è necessariamente agli occhi della natura»38 – ed entrambe consistono nella struttura di una sottigliezza impensabile: «ma
35 Cfr. AAVV, Le macchine celibi/Bachelor Machines, a cura di H. Szeemann, Al-
fieri, Venezia 1975. 36 M. Duchamp, Scritti, trad. it. di M.R. D’Angelo, Abscondita, Milano 2005, p.
234. 37 Ivi, p. 235. 38 H. Bergson, Pensiero e movimento, cit., p. 196.
Capitolo I 26
ricordiamoci anche che mai un’idea, per docile che sia, avrà la stessa sottigliezza delle cose»39. Infra-mince e “sottile pellicola trasparente” non sono dunque metafore ma prodotti dell’intuizione, frutti dell’intervallo-penetrazione. Il bergsoni-smo è una metafisica della vita, il duchampismo un’arte della sottigliezza; per questa ragione entrambi abbandonano le essen-ze e la loro intuizione senza sforzo, abbracciando i meccanismi sferraglianti di una faticosa attività di localizzazione, di vita nel reale. 4. Immagini
«Prendiamo tutto ciò che il filosofo ha scritto, facciamo risa-
lire queste idee sparpagliate verso l’immagine da cui erano di-scese»40. Ciò che Bergson definisce “immagine” designa, all’interno dei legami di simpatia tra natura e pensiero, la forma più contratta del topoide spazio-temporale e dunque quanto di più prossimo – nella geometria metafisica bergsoniana, che so-stituisce la teoria della conoscenza e con essa il soggettivismo della tradizione post-kantiana – all’“intuizione generatrice” di una filosofia, al principio vitale di un sistema di pensiero. «Il fi-losofo non parte da idee preesistenti; tutt’al più si può dire che vi giunga»41; gli atti di pensiero sono correnti che attraversano le filosofie, movimenti espressivi sospinti dalla differenza di potenziale tra immagini chiuse su se stesse e idee distribuite.
Riusciamo a comprendere il significato attribuito da Bergson alla nozione d’“immagine” – come in Materia e memoria, un’esistenza «situata a metà strada tra la “cosa” e la “rappresen-tazione”», “quasi materia” e “quasi spirito” – soltanto se collo-chiamo i gorghi delle immagini bergsoniane nella corrente che fluisce a partire da nuclei intuitivi aniconici. Come pietre lungo il corso di un fiume, le idee scompongono il movimento vitale
39 Ibidem 40 Ivi, p. 111. 41 Ivi, p. 112.
Intervalli bergsoniani 27
iniziato dall’intuizione. Per Bergson le immagini sono “media-trici” in quest’accezione topologica. Sono “situate a metà stra-da”, poste nella corrente che collega la vita della materia all’attività delle facoltà cognitive. Né segni né simboli, né meta-fore né allegorie, le immagini sono costruzioni paradossali, quasi-rappresentazioni accessibili per mezzo di una geometria concettuale dei processi vitali.
Accostarsi ad una filosofia significa per Bergson lasciarsi al-le spalle metodi storicistici ed interpretazioni sistematiche, a vantaggio di una topologia delle immagini:
Ma, nella misura in cui cerchiamo ulteriormente di situarci nel pensie-ro di un filosofo, anziché aggirarlo, vediamo la sua dottrina trasfigu-rarsi. Inizialmente la complicazione diminuisce. Poi le parti si compe-netrano le une nelle altre. Infine tutto si riporta a un unico punto42. La giusta collocazione del pensiero dentro il movimento tra-
sforma le immagini-rappresentazioni, specchi immobili ed illu-sionistici della natura, in specchi mobili ed anamorfici. Il punto unico è in realtà un prisma allungato, possiede lo spessore dell’intervallo. Soltanto in questo modo la “semplicità” dell’intuizione invocata da Bergson non tradisce la “precisione del pensiero”, descrivendo la natura di intervalli reali: «nessun vuoto, né interstizi, né un’ulteriore spiegazione»43.
Quale “immagine mediatrice” descrive l’intuizione di ciò che accade nell’intervallo, ovvero la realtà più sottile, l’ingranaggio più preciso? Un esempio del procedimento filoso-fico seguito da Bergson è rappresentato dall’immagine che a suo avviso racchiude il nucleo della filosofia di Berkeley:
Mi sembra che Berkeley percepisca la materia come una sottile pellicola trasparente situata tra l’uomo e Dio. Essa resta traspa-rente fintanto che i filosofi non se ne occupano e allora Dio si mostra attraverso di essa. Ma appena i metafisici, o anche il senso comune nella misura in cui è metafisico, la toccano, immediata-mente la pellicola si offusca e si ispessisce, diviene opaca e forma
42 Ivi, p. 100. 43 Ivi, p. 3.
Capitolo I 28
uno schermo, poiché parole astratte come Sostanza, Forza, Esten-sione ecc., scivolano dietro di essa, vi si depongono come uno strato di polvere e impediscono di percepire Dio in trasparenza. L’immagine è appena indicata da Berkeley, benché egli abbia det-to, in termini propri che “solleviamo la polvere e che ci lamen-tiamo in seguito di non vedere”44. La “sottile pellicola trasparente” è un’immagine che Bergson
distingue sia da una metafora che da una interpretazione. A dif-ferenza di una metafora l’immagine non possiede densità sim-bolica, a differenza di un’interpretazione non esplica ma chiude, non distende ma interseca il pensiero. L’immagine riduce, inca-nala con la sua semplicità l’intuizione generatrice: «È in concet-ti che il sistema si sviluppa, è in un’immagine che si rinchiude quando lo si respinge verso l’intuizione da cui discende»45. Le parole astratte che si posano sulla pellicola trasparente corri-spondono alla soluzione trovata da Berkeley per un problema specificamente bergsoniano: che cosa accade nell’intervallo tra stati del mondo? La pellicola-schermo su cui i filosofi e il senso comune lasciano scivolare la polvere delle parole occupa l’intervallo tra uomo e natura, in Berkeley tra uomo e Dio. La pellicola-materia è sottile e trasparente, ma la sua struttura la predispone al contatto con le forze del “fuori”.
Vetro e polvere sono due ingredienti fondamentali della macchinazione artistica più affine alla filosofia bergsoniana: il Grande Vetro di Duchamp (v. Cap. III, 2)46. Quest’opera, im-pregnata di bergsonismo, abbandona i supporti tradizionali dell’arte visiva e sceglie il vetro come sua dimensione. Il Gran-de Vetro è uno schermo-macchina posto all’interno dell’intervallo bergsoniano. La modalità principale del suo fun-zionamento è un’alterazione del continuo temporale ottenuta per mezzo di procedure di differimento: «Usare “ritardo” invece di quadro o pittura; quadro su vetro diventa ritardo di vetro –
44 Ivi, p. 110. 45 Ivi, p. 111. 46 Il Grande vetro, ovvero La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, 1915-
1923 (v. fig. 1, p. 175).
Intervalli bergsoniani 29
ma ritardo di vetro non vuol dire quadro su vetro. –»47. Nell’intervallo il ritardo conserva (memoria) e sedimenta (pol-vere). Come le immagini bergsoniane, la polvere incorporata nel Grande Vetro duchampiano offusca la nitidezza della rap-presentazione e al contempo conserva la vita, strutturando er-meticamente i movimenti vitali: «Coltivare della polvere su ve-tri. Polvere di 4 mesi, 6 mesi che dopo si chiude ermeticamente = Trasparenza»48.
L’ontologia di Bergson pensa una pienezza vitale che si scompone nei paradossi geometrici della presenza. L’intervallo è un luogo denso ed elastico, non uno stato del mondo sincroni-co. La matematica resta pertanto «all’interno della sua funzio-ne» soltanto quando si limita ad operare attraverso l’astrazione di punti sovrapponibili senza spessore, «la supera invece quan-do pretende di ricostruire ciò che avviene nell’intervallo»49. La meccanica classica utilizza coordinate che presuppongono l’omogeneità tra dimensioni eterogenee – lo spazio e il tempo, movimento e mutamento – e la sovrapponibilità punto per punto degli intervalli che li delimitano. Al di fuori di questi presuppo-sti non è possibile il calcolo. Ma dalla finzione dell’incontro tra due movimenti in un “punto X” senza dimensione, e senza di-mensione perché senza vita, non si deduce la vita dell’incontro, la struttura di ciò che accade dentro l’intervallo: dal punto di vi-sta della scienza, l’intervallo di durata semplicemente non con-ta.
In Materia e memoria, Bergson paragona le immagini a “pellicole superficiali”50. In quest’opera, un’immagine centrale limita la scena della rappresentazione: è l’immagine del “mio corpo”, il dispositivo sensorio-motorio capace di rivolgersi sia all’esperienza interna, tramite sensazioni affettive, sia a quella
47 M. Duchamp, Scritti, cit., p. 31. 48 Ivi, p. 63. 49 H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, trad. it. di F. Sossi, Corti-
na, Milano 2002, p. 75. 50 H. Bergson, Materia e memoria, trad. it. di A. Pessina, Laterza, Roma-Bari 2004,
p. 49.
Capitolo I 30
esterna, trasformando e rilasciando i movimenti ricevuti in fun-zione dell’azione possibile o attuale sulle altre immagini.
In quanto sede di affezione oltre che fonte d’azione, il corpo è una “pellicola superficiale” alla cui conoscenza rappresentati-va si aggiunge quella affettiva dell’interno: alla percezione-immagine del “fuori” si affianca la sensazione-affezione del “dentro”; «se la percezione misura il potere riflettente del corpo, l’affezione ne misura il potere assorbente»51. Il corpo è un mec-canismo di limitazione che taglia il continuo dell’estensione. Alla logica del continuo Bergson affianca un’ontologia dell’intervallo e una psicologia metafisica degli stati affettivi. Se un dialogo è possibile tra il bergsonismo e la fenomenologia, esso riguarda la costituzione del corpo umano e la localizzazio-ne delle affezioni in “centri di indeterminazione” della mate-ria52.
Ciò che conta in Bergson è la “potenza di azione” della vi-ta53, la quale coincide con la costruzione di centri d’indeterminazione in grado di assorbire e rilasciare i movimen-ti. Nel caso delle forme più semplici della materia vivente, as-sorbimento e azione sono localizzati negli stessi organi. L’indeterminazione è dunque minima e l’organismo si nutre e si ripara senza sosta54. Quando cambia la sede degli intervalli, si ridistribuisce la distanza tra le azioni e le percezioni dei corpi. Il corpo umano non è perciò un “allotropo empirico-trascendentale” (Foucault) ma una macchina vivente che, grazie all’apparato nervoso, ha ripartito in modo originale la percezio-ne e l’azione: «la catena degli elementi nervosi che riceve, fer-ma e trasmette dei movimenti, è precisamente la sede e dà la misura di questa indeterminazione»55. Il termine “indetermina-zione” non ha valore in sé, ma come descrizione dello spessore che separa i corpi e riempie l’intervallo tra affezione e perce-
51 Ivi, p. 45. 52 Sul rapporto tra bergsonismo e fenomenologia, cfr. É. During, Présence et répéti-
tion: Bergson chez les phénoménologues, «Critique», n. 678, 2003, pp. 848-864. 53 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 51. 54 Ibidem 55 Ivi, pp. 51-52.
Intervalli bergsoniani 31
zione, tra percezione e azione, tra movimenti interni (volontà) ed esterni (azione). A dispetto delle abitudini interpretative, bi-sogna imparare a riconoscere nella memoria un dispositivo di limitazione e separazione. Faremmo infatti un torto a inchiodare il bergsonismo a una metafisica pre-critica della durata. Ber-gson non è il metafisico della durata ma il pedagogo dell’intuizione della durata.
Intuire e conoscere la durata sono due compiti del tutto dif-ferenti. Nel primo caso è in gioco una pratica di localizzazione. Bisogna imparare ad installarsi nella durata, a vivere là dove la vita è tale e non conoscenza o trascendenza. Questo luogo è di-schiuso dal punto di contatto tra coscienza e cose, non dalla co-noscenza della realtà. Grazie alla sua struttura biologica, l’uomo può collocarsi con precisione in questo punto di contatto, nel territorio ontologico di ciò che avviene là dove si dispiegano le differenze di natura.
Imparare a riconoscere anche nella memoria un dispositivo di limitazione significa cogliere la memoria nella sua funzione di creazione sintetica del continuo spaziale e di ritardo dell’azione. La memoria non è ciò che esiste in sé, e pertanto il bergsonismo si distingue da un platonismo degli archetipi. Essa è un dispositivo che “inserisce il passato nel presente”, l’immagine confusa di ciò che accade nell’intervallo tra movi-menti vitali: «La memoria, praticamente inseparabile dalla per-cezione, inserisce il passato nel presente»56.
La memoria possiede uno spessore, o meglio è essa stessa un dispositivo di contatto che occupa l’intervallo tra la percezione e la sensazione, «tra la coscienza e le cose, tra il corpo e lo spi-rito»57. Se nel caso degli esseri umani è la topologia della me-moria ad organizzare il contatto vitale, nel caso dei vegetali è una “membrana di cellulosa” che isola le cellule e le condanna all’immobilità. Il vegetale è un vivente incapace di muoversi nell’ambiente a causa della struttura del suo intervallo cellula-
56 Ivi, p. 58. 57 Ivi, p. 52.
Capitolo I 32
re58. Di contro, la vita animale sorge con la mobilità nello spa-zio, in seguito all’invenzione di una nuova pellicola: «Nella sua forma più rudimentale, l’animale si presenta come una piccola massa di protoplasma avviluppata tutt’al più in una sottile pelli-cola albuminoide che gli consente piena libertà di deformarsi e di muoversi»59. La metafisica si converte per Bergson nell’onto-topologia dell’infra-mince dei viventi; l’arte inventa distinzioni dense e indistinzioni senza spessore, così come ogni vivente costruisce l’intervallo tra se stesso e l’ambiente e, più in profondità, tra il proprio potere di azione e la propria di inazio-ne virtuale. 5. Continuo
La costruzione della densità dell’intervallo è dunque il com-
pito a cui è votato il bergsonismo. Eppure, già a livello percetti-vo la pienezza della vita è messa a repentaglio dagli imperativi sociali e dalle forze reattive. L’“immagine completa” degli og-getti è distorta dalle esigenze dell’azione “razionale” e dai vin-coli del vivere sociale. La vita è una, ma le convenienze sociali impongono schemi funzionali e limitazioni arbitrarie del conti-nuo. Per questa ragione, soltanto un’ “educazione dei sensi” – al contempo artistica e filosofica – può riempire i vuoti creati dalle divisioni introdotte dall’intelletto e riscoprire la libertà di una pedagogia del contatto con la vita, di una percezione refrattaria alla legge e alla misura: «Attraverso l’estensione e la rigenera-zione della nostra facoltà di percepire […] ristabiliremo la con-tinuità nell’insieme delle nostre conoscenze»60.
La filosofia concorre con l’arte ad educare i sensi, amplian-do la percezione e raffinando i suoi strumenti. Più precisamente, la filosofia svolge un ruolo preliminare, svincolando la perce-zione dal giogo dei concetti e liberando i percetti:
58 H. Bergson, L’evoluzione creatrice, cit., p. 93. 59 Ibidem 60 H. Bergson, La percezione del mutamento, cit., p. 132.
Intervalli bergsoniani 33
Le diverse percezioni dello stesso oggetto che i miei sensi forniscono, non ricostruiranno, dunque, riunendosi, l’immagine completa dell’oggetto; esse resteranno separate le une dalle altre attraverso degli intervalli che misurano, in qualche modo, altrettanti vuoti nei miei bi-sogni: è per colmare questi intervalli che è necessaria una educazione dei sensi61. Tutte le vie descritte da Bergson per “riempire gli intervalli”
sono collegate dal presupposto che in ogni caso sia indispensa-bile rintracciare l’indivisibilità di ciò che muta; non l’unità del molteplice ma l’articolazione della continuità del divenire. In quanto ontologia del continuo, il bergsonismo segue «la realtà concreta in tutte le sue pieghe»62, i concetti non introducono di-scontinuità ma saturano gli intervalli dell’essere. In ciò il ber-gsonismo si differenzia profondamente da ogni impostazione trascendentale, ad esempio dalle discontinuità epistemiche mar-cate da Foucault o dalla decostruzione della presenza di Derri-da. L’intervallo bergsoniano non nasconde infatti alcun potere di negazione. Da una negazione non può nascere alcuna idea63, mentre dentro l’intervallo sono custoditi il potere di afferma-zione e lo svolgersi della vita. Il bergsonismo satura l’infra-mince, penetra le zone d’indeterminazione spalancate dalle dif-ferenze di natura.
Il movimento decostruttivo può venire recuperato soltanto all’interno del primo livello del metodo bergsoniano: i “misti mal analizzati”, le false opposizioni e i “falsi problemi” nascon-dono il privilegio delle differenze di grado o d’intensità. Negli intervalli tra gradi e intensità non esistono che vuoti arbitrari. Questi intervalli non sono né limiti densi, né misti spazio-temporali, né luoghi ontologici, né atti o unità di movimento. Essi non sono nemmeno vuoti fisici, ma soltanto tracce di un principio di differenziazione specificamente umano, introdotto
61 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 39 (corsivo mio). 62 Ivi, p. 197 63 Id., L’evoluzione creatrice, cit., p. 237.
Capitolo I 34
dall’intelligenza come «reazione contro questa eterogeneità che costituisce il fondo della nostra esperienza»64.
Addirittura, è l’umano stesso a scaturire da un fondo natura-le in seguito all’invenzione di un intervallo originale. Ancora prima di orientarsi alle esigenze sociali dell’azione, l’intelligenza incarna una delle soluzioni trovate dalla vita per suddividere la continuità materiale: «L’intelligenza si rappre-senta chiaramente solo il discontinuo»65. Come Bergson chiari-sce nell’Evoluzione creatrice, l’uomo è innanzitutto Homo fa-ber66. Al fine d’intervenire sulla materia inerte e manipolare i solidi, l’intelligenza escogita la discontinuità degli strumenti ar-tificiali. Le caratteristiche dell’intelligenza corrispondono una ad una a quelle delle procedure introdotte dall’attività di fabbri-cazione: la natura è sezionata in unità provvisorie, in entità este-se reciprocamente esterne; queste sono a loro volta indefiniti-vamente suddivisibili e delimitate da bordi netti. Sullo sfondo, uno spazio omogeneo in cui ogni oggetto trova la propria collo-cazione e può venire prelevato, scomposto e ricomposto a pia-cimento secondo le esigenze dell’azione funzionale.
Manipolare oggetti e rappresentarsi concetti, trasformare la materia in strumento di azione e costruire un mondo intelligibile sono per Bergson attività parallele. Gli elementi del mondo in-tellettuale sono soltanto “più leggeri, più diafani”67 rispetto alla natura inorganica, ma le forme sono le stesse e prolungano abi-tudini contratte dall’intelligenza. L’arbitraria potenza di taglio dell’intelligenza e la “geometria naturale” di questo mondo di solidi, in cui ogni oggetto occupa una posizione stabile e su cui è possibile agire con sicurezza, si specchiano l’una nell’altra. L’intelligenza dell’Homo faber è ciò che pensa questo tipo di discontinuità attraverso un atto positivo della mente68.
I paradossi del movimento enunciati da Zenone di Elea, dal-la cui soluzione prende avvio la filosofia di Bergson, riguardano
64 Id., Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., p. 64. 65 Id., L’evoluzione creatrice, cit., p. 129. 66 Ivi, p. 128. 67 Ivi, p. 134. 68 Ivi, p. 129.
Intervalli bergsoniani 35
anch’essi la costruzione degli intervalli. Benché Bergson, nell’esporre le proprie tesi, sottolinei la contrapposizione tra la spazialità della traiettoria e la temporalità degli atti di movimen-to, il vero grimaldello teorico è rappresentato da un territorio in-termedio, che coincide con la riformulazione della nozione d’intervallo, non con la metafisica della temporalità pura.
Per confutare la realtà del movimento, Zenone sovrappone gli atti indivisibili di cui è composto il movimento allo spazio percorso dal mobile. Achille non raggiungerà mai la tartaruga e la freccia non colpirà mai il suo bersaglio, come sostiene Zeno-ne, se «l’intervallo che separa due punti è divisibile all’infinito, e se il movimento fosse composto da parti come quelle dell’intervallo stesso»69. L’intervallo di spazio prodotto dalla divisione all’infinito è di diritto privo di limitazione interna, perciò «non c’è affatto bisogno di supporre un limite alla divi-sibilità dello spazio concreto»70. In esso, dei tagli a-dimensionali, i punti che misurano gli intervalli in cui si scom-pone il percorso dei mobili, disegnano confini netti tra parti e-sterne tra loro.
L’essenziale di questo procedimento è l’attività di divisione che crea la molteplicità quantitativa delle parti. Essa procede at-traverso i propri limiti e definisce i propri intervalli: limiti ine-stesi, perché a-dimensionale è la potenza irrelata da cui proven-gono i tagli; intervalli omogenei, perché ottenuti senza rispetta-re le articolazioni naturali delle cose e le qualità topologiche degli intervalli. Perché vi siano delle parti nel movimento, come presupposto da Zenone, è necessario che ciò che non è divisibi-le venga invece diviso, e che limiti arbitrari vengano imposti a ciò che possiede una organizzazione reale. «Si può dividere una cosa, ma non un atto»71, o meglio, un atto si divide in altro mo-do rispetto a una cosa.
69 Id., Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., p. 74. 70 Ivi, p. 75. 71 Ivi, p. 73.
Topologia del visibile 1. Cristalli di tempo
Me ne infischio di fare dell’arte.
Roberto Rossellini, Intervista con i «Cahiers du cinéma»
Il dominio del limite (peras, limes, Grenze). Jacques Derrida, Timpano, in Margini della filosofia
«Come un corpo può presentarsi allo stato amorfo o cristal-lizzato, l’arte di Rossellini sa dare ai fatti, di volta in volta, la loro struttura più densa ed elegante: non la più gradita o “bella” ma la più acuta, la più diretta o la più tagliente»1. Anticipando le posizioni di Deleuze, il quale scorge nell’“immagine-cristallo” la forma specifica dell’“immagine-tempo” inaugurata da Rossellini e dal neorealismo italiano, Bazin ricorre ai proces-si di cristallizzazione per descrivere lo stile di ripresa di Rossel-lini. Nonostante il cinema di Rossellini non abbia nulla a che
1 A. Bazin, Difesa di Rossellini, testo pubblicato in «Cinema nuovo», 1955, n. 65 e ristampato in P. Baldelli, Roberto Rossellini, Edizioni Samonà, Roma 1972, p. 323. La versione francese è raccolta in A. Bazin, Qu’est-ce que le cinéma, Èditions du Cerf, Poi-tiers 1975, p. 356.
37
Capitolo II 38
e di pensiero.
spartire con la perfezione formale delle gemme, nonostante l’apparenza amorfa e il non-finito delle sue immagini, nonostante l’assenza di movimenti geometrici dei personaggi e della macchina da presa, nonostante la verità sia per Rossellini “sempre sbracata, sfocata, sbrindellata”2, secondo Bazin la sua arte si basa su principi genetici simili a quelli che regolano la nascita dei cristalli. Il cinema di Rossellini produce immagini acute, pietre da taglio, immagini-rasoio. Da questo punto di vista, la decisione di Rossellini di abbandonare le teorie estetiche per dedicarsi ad opere didattiche si spiega con la necessità di lasciarsi alle spalle i “falsi problemi”3 artistici e girare film “acuti”, lam
Bazin associa esplicitamente la forma cristallina delle im-magini a un’ontologia bergsoniana della durata: «Per la prima volta, l’immagine delle cose è anche quella della loro durata»4. L’immagine fotografica su cui si basa la tecnica cinematografi-ca è temporalità resa visibile, un cristallo che assorbe il tempo e lo metamorfosa in strutture spaziali. La fotografia non riproduce artisticamente una realtà esterna ma lascia sedimentare il tempo, gli attribuisce un’estensione. Il tempo è un ambiente fluido e magmatico; non si srotola come una superficie liscia ma scorre come un fiume, incontrando ostacoli, dividendosi in correnti, avvitandosi in mulinelli e rivoli eccentrici5. L’ultimo episodio di Paisà, l’intersezione dei flussi spazio-temporali del fiume e delle azioni dei partigiani lungo il delta del Po, è un esempio e-clatante d’immagine-tempo: le prerogative della scena e della narrazione tradizionali vengono soppiantate da un tessuto di temporalità eterogenee, sostenute dai movimenti differenziati del fiume, degli oggetti e degli uomini.
2 R. Rossellini, Film vecchi e nuovi orizzonti, in Il mio metodo. Scritti e interviste, a
cura di A. Aprà, Marsilio, Venezia 1987, p. 351. 3 Id., Intervista con i «Cahiers du cinéma», in Il mio metodo, cit., p. 177. 4 A. Bazin, Qu’est-ce que le cinéma, cit., p. 14, trad. it. mia. 5 Per una ricognizione dell’insistente motivo del gorgo in Europa 51, cfr. E. Dagra-
da, Le varianti trasparenti. I film con Ingrid Bergman di Roberto Rossellini, LED, Mi-lano 2005, pp. 176-177.
Topologia del visibile 39
Nel gergo tellurico di Bachelard, a sua volta intriso di ber-gsonismo, i cristalli e le gemme sono «i solidi più naturali, i meglio definiti, i soli che possiedono una durata in qualche mo-do visibile»6. In Rossellini, più che uno spiritualismo o un reali-smo, una morale o un’estetica, è presente una filosofia della na-tura e, al suo interno, il problema del rapporto tra il tempo del mondo e quello dei soggetti. Anche la storia non rappresenta per Rossellini un’unità in sé ma risulta dall’intersezione di a-zioni umane e forze naturali. In La prise de pouvoir par Louis XIV, l’arte minerale di Rossellini vale come tecnica d’integrazione dei circuiti temporali: l’organizzazione colberti-sta delle forze produttive cristallizza la sua efficacia nella ceri-monialità estetica della corte di Luigi XIV, che a sua volta inte-ragisce, nella scena finale, con la temporalità atopica del libro: La massima di La Rochefoucauld letta in solitudine da Luigi XIV aggiunge al racconto i ritmi dell’esistenza individuale, in-terferendo con la costruzione ieratica della sovranità del potere.
Assumendo il punto di vista della costruzione temporale dei fenomeni, Rossellini può collocarsi con libertà nel tempo stori-co, di cui non rispetta l’integrità monumentale o la paradigmati-cità ideologico-politica. Ciò spiega la facilità con cui il Rossel-lini dei film per la televisione smantella l’intera storia dell’umanità e la riassembla seguendo la trama di alcune com-ponenti privilegiate7. Che si tratti della lavorazione del ferro o delle vita privata di Garibaldi, la storia politica si dissolve in un repertorio enciclopedico di flussi temporali, ognuno dotato di intensità ed elasticità propria, come la pluralità delle durate ber-gsoniane.
La passione di Rossellini per l’Oriente e la sua denuncia del-la “schiavitù delle idee”, dei “falsi problemi” e della “politiciz-zazione” dell’Occidente8 vale come una presa di coscienza di
6 G. Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, Librairie José Corti, Paris
1948, p. 290, trad. it. mia. 7 R. Rossellini, Un cinema diverso per un mondo che cambia, in Il mio metodo, cit.,
p. 305. 8 «Tutti sono disgraziatamente troppo contaminati dalle idee politiche. Il mondo di
oggi è un mondo eminentemente politicizzato, ed è politicizzato perché vive sotto
Capitolo II 40
questo naturalismo della temporalità: «L’uomo, nella società moderna e nel mondo intero, salvo forse in Asia, è diventato l’ingranaggio di una macchina gigantesca, immensa. È diventa-to uno schiavo […] La schiavitù delle idee»9. Come si combat-tono le false idee? Innazitutto, come in Oriente, scongiurando la concezione borghese dell’arte:
Vede, da noi un artista quasi sempre è latore di un messaggio: una rappresentazione per gli altri (a volte un’aggressione). In India l’arte è sempre una specie di gioia intima […] L’indiano resta sempre in inti-mità con le grandi cose nel gesto più banale, nell’atto più quotidia-no10.
Questo naturalismo, che intercetta il progetto biopolitico fou-caultiano, giustifica il disprezzo dell’ultimo Rossellini per il di-battito critico di matrice ideologica ed estetica, oltre che la sua preferenza per un’arte didattica. Ma che cosa deve insegnare quest’arte? Non certo le tecniche di rappresentazione della veri-tà, sia essa intesa in senso storico o spirituale, bensì il metodo della ricerca di un godimento, un’ars erotica in cui «la verità è estratta dal piacere stesso»11, l’“intimità” tra le molteplici com-ponenti della temporalità: i tempi lunghi delle “grandi cose”, i
un’insegna ipocrita che è l’insegna della libertà, tanto è vero che il mondo ha sempre avuto la libertà fino a che non l’ha enunciata. Dal momento che la parola libertà è stata pronunziata e che si è fatta la prima rivoluzione nel mondo sotto l’insegna della libertà, da quel momento si sono messi in atto tutti i metodi per ammazzare la libertà» (ivi, p. 317). Il rifiuto rosselliniano della “politicizzazione delle idee” a vantaggio della presen-tazione diretta della vita affettiva e della collocazione spazio-temporale dei corpi indivi-duali e sociali, testimonia l’implicito riconoscimento del terreno biopolitico su cui si gioca la partita politica dell’Occidente.
9 R. Rossellini, Intervista con i «Cahiers du cinéma», cit., p. 178. 10 Id., Uomini drappeggiati e uomini cuciti, in Il mio metodo, cit., p. 185. 11 M. Foucault, La volontà di sapere, trad. it. di P. Pasquino e G. Procacci, Feltri-
nelli, Milano 1988, p. 53. Qui Foucault contrappone l’ars erotica orientale alla scientia sexualis occidentale. La prima, come nella società arabo-musulmana e nella Roma anti-ca, estrae la verità dal piacere stesso, «secondo la sua intensità, la sua qualità specifica, la sua durata, le sue riverberazioni nel corpo e nell’anima» e «non è in relazione ad una legge assoluta del lecito e del proibito» (ibidem). L’orientalismo di Foucault, come quello di Rossellini, ricorre al linguaggio bergsoniano della durata e delle qualità inten-sive.
Topologia del visibile 41
tempi brevi dei gesti quotidiani, i tempi biologici dei corpi e quelli ecologici della vita animale12.
Ars erotica
Riprendiamo la formulazione di Bazin: Rossellini crea im-
magini dense e cristallizzate, come corpi taglienti ed acuti. Si-nora abbiamo esaminato esclusivamente un presupposto della posizione di Bazin: i corpi filmati da Rossellini sono cristalli di tempo, tempo stilizzato che penetra le cose e i personaggi con l’intensità di una memoria piuttosto che con la violenza imper-sonale della storia. Nel riprendere il topos del cristallo di tem-po13, Deleuze rilancia la riflessione di Bazin ma, con l’aiuto di Rossellini, la spinge dal sublime all’incommensurabile:
Come dirà Bazin, l’immagine cinematografica si contrappone all’immagine teatrale in quanto va dal fuori al dentro, dalla scena al personaggio, dalla natura all’uomo (anche se muove dall’azione uma-na, ne muove come da un fuori, anche se muove dal volto umano, ne muove come da una Natura o da un paesaggio)14. L’immagine è un pezzo di natura, temporalità setacciata dai
mezzi di riproduzione, ma tale natura è un’allucinazione piutto-sto che un pezzo di realtà o un rapimento mistico; è un limite, una potenza sovra-umana che Rossellini non fa rientrare negli schemi del sublime: nel suo cinema l’incommensurabilità del personaggio al cospetto delle forze e delle traiettorie temporali della natura – l’ascesa del vulcano da parte di Karin in Strombo-li – non rimanda a “idee della ragione” interne al personaggio stesso. Natura e facoltà cognitive non sono concatenate, Karin
12 Marxismo e cattolicesimo non interessano Rossellini sul piano ideologico, ma in quanto progetti di riorganizzazione delle durate, dei rapporti sociali e dell’uomo con la natura. La cinematografia di Rossellini si conclude con Il messia e con il progetto – mai portato a termine – di un film su Marx, senza che ciò significhi un suo ritorno all’ordine.
13 Gilles Deleuze riprende questo concetto da Félix Guattari, L’incoscient machini-que, Ed. Recherches, Paris 1979. Cfr. G. Deleuze, L’immagine-tempo. Cinema 2, trad. it. di L. Rampello, Ubulibri, Milano 1989, p. 97.
14 G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., p. 181.
Capitolo II 42
non accede a nessuna rivelazione sul suo destino. La natura è indifferente e non dialettizzabile.
In Cinema 1 e Cinema 2, una ricapitolazione enciclopedica dell’estetica post-baziniana, il cinema di Rossellini occupa una posizione ambigua. Da un lato, Paisà introduce la “nuova im-magine” che sostituisce l’immagine-movimento del cinema classico: la realtà è dispersiva e lacunare, non forma una totalità modificabile dalle azioni dei personaggi. In questa situazione – segnata dalla rottura del legame senso-motorio tra personaggio e natura e tra personaggio e società, ciò che Deleuze definisce crisi dell’“immagine-movimento” del cinema classico – sono possibili soltanto incontri frammentari e traiettorie spezzate. I-noltre, al mondo-ambiente del cinema d’azione si sostituisce un “regno dei cliché”, una densa coltre di false idee in cui sono immersi i pensieri e le emozioni dei personaggi. La tetralogia rappresentata da Germania anno zero, Stromboli terra di Dio, Europa 51 e Viaggio in Italia, radicalizza queste tendenze, con-ducendo il neorealismo alla sua perfezione15.
Non potendo agire, i personaggi di Rossellini diventano dei veggenti, quel che conta è per loro imparare a guardare, elabo-rare le conseguenze dell’impossibilità della presa sul reale:
Un nuovo tipo di personaggi per un nuovo cinema. Poiché quel che capita loro non gli appartiene, non li riguarda che a metà, essi sanno estrarre dall’avvenimento la parte irriducibile all’accadere: quella par-te di inesauribile possibilità che costituisce l’insopportabile, l’intollerabile, la parte del visionario16.
Il “cinema del veggente” rosselliniano racchiude i caratteri
salienti dell’immagine-tempo: primato della ripresa sul mon-taggio, centralità di situazioni puramente ottiche e sonore, per-sonaggi “stranamente vibranti”, colti “durante una mutazio-
15 Ivi, p. 12. 16 Ivi, p. 31. L’esempio più volte ripreso da Deleuze è quello della visione della
fabbrica da parte della protagonista di Europa 51; cfr. Gilles Deleuze, L’immagine-movimento. Cinema 1, trad. it. di J.-P. Manganaro, Ubulibri, Milano 1984, p. 145, L’immagine-tempo, cit., pp. 12, 32, 59.
Topologia del visibile 43
ne”17, sistematicità dei falsi raccordi, privilegio della dimensio-ne corporea e mentale rispetto alle interazioni tra personaggio e ambiente, ricorso alle esperienze-limite e agli “spazi qualsiasi”.
Benché Rossellini inauguri il regime dell’immagine-tempo – della cui struttura cristallina Deleuze si occupa nelle parti cen-trali del secondo volume – i riferimenti alla sua cinematografia scompaiono sino ai capitoli conclusivi di Cinema 2. Qui, insie-me al Dreyer di Gertrud, Europa 51 e Giovanna d’Arco al rogo vengono definiti “una svolta” interna all’immagine-tempo, una fuoriuscita dai canoni della produzione artistica in direzione di un cinema di “pura credenza”, in grado di ricostruire all’esterno dei confini dell’arte il legame perduto tra uomo e mondo: «solo la credenza del mondo può legare l’uomo a ciò che vede e sen-te. Bisogna che il cinema filmi, non il mondo, ma la credenza in questo mondo, il nostro unico legame»18. Lungo questa strada, il cinema post-estetico di Rossellini – la cui prodigiosa sempli-cità equivale alla neutralità visiva dei readymade duchampiani piuttosto che una pratica ascetica dell’immagine – non incontra la spiritualità cristiana ma una radicale pedagogia audio-visiva. Così, per Deleuze il Rossellini dei film televisi offre una «prima manifestazione di grande pedagogia» degli atti di parola e della costruzione stratigrafica degli spazi: «è come se Rossellini a-vesse saputo reinventare una scuola elementare, assolutamente necessaria, con la sua lezione di cose e la sua lezione di parole, la sua grammatica del discorso e la sua manipolazione di ogget-ti»19. Si tratta di una didattica dell’“andirivieni tra parola e im-magine”, di un’archeologia, nel senso foucaultiano, degli atti di parola e degli spazi stratificati (il riferimento è soprattutto a La prise de pouvoir par Louis XIV).
Ciò che è più importante, a partire dall’ultimo Rossellini, dalla sua archeologia della composizione conflittuale di traietto-rie spaziali e di parola, l’immagine-tempo esplode nelle sue componenti visive e sonore, sotto la spinta di “interruzioni irra-
17 G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., p. 31. 18 Ivi, p. 192. 19 Ivi, p. 273.
Capitolo II 44
zionali”, di soglie tra epoche e immagini che non si concatena-no più secondo gli schemi senso-motori dell’azione e della narrazione classica:
Il nuovo regime dell’immagine si costruisce su questa base pedagogi-ca […] le sequenze non si concatenano più attraverso interruzioni ra-zionali, che portano a termine la prima o danno inizio alla seconda, ma si ri-concatenano su interruzioni irrazionali, che non appartengono più a nessuna delle due e hanno valore per se stesse (interstizi)20. Stranamente, nonostante il Rossellini di Deleuze radicalizzi
le proprietà dell’immagine-tempo, il suo cinema non si presta ad un’analisi condotta secondo le articolazioni formali dell’immagine-cristallo, che si racchiudono nelle figure dello specchio e del germe21. Nel primo caso, le azioni dei personag-gi sono interamente assorbite dalla moltiplicazione delle imma-gini virtuali prodotte dagli specchi (la casa degli specchi de La signora di Shangai), nel secondo un piccolo germe funziona come polo di cristallizzazione di un ambiente amorfo che lo cir-conda (il segreto alchemico del cristallo rosso di Cuore di ve-tro). Anche a partire dagli stati che assume il cristallo – cristallo perfetto in Ophuls, cristallo incrinato in Renoir, cristallo in via di formazione in Fellini o in decomposizione in Visconti22 – non si giunge alle immagini di Rossellini. Il regista che, secon-do Deleuze, ha condotto alla perfezione l’immagine-tempo, non sembra in grado di offrire modelli di immagini-cristallo. Per quale ragione?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo esaminare i pre-supposti della concezione deleuziana del cristallo di tempo e metterli a confronto con le immagini taglienti che Bazin attri-buisce a Rossellini. In Deleuze l’immagine cristallina vale come presentazione diretta del tempo – contrapposta a quella indiretta dell’immagine-movimento – soltanto a patto di concepire il
20 Ivi, p. 274. 21 A queste due figure corrispondono rispettivamente le modalità dell’opera riflessa
nell’opera e dell’opera colta nel suo farsi – ovvero l’opera allo specchio e l’opera in germe (ivi, p. 88 e ss.)
22 Ivi, pp. 97-112.
Topologia del visibile 45
tempo come una scissione che sgorga da un limite esterno ad esso, l’interruzione irrazionale, il “punto di indiscernibilità”:
Il tempo consiste in questa scissione, è essa, esso che si vede nel cri-stallo […] Nel cristallo si vede l’eterna fondazione del tempo, il tem-po non-cronologico, Kronos e non Chronos. È la potente vita non-organica che rinserra il mondo. Il visionario, il veggente, è colui che vede nel cristallo […] Nel cristallo si vede dunque uno sdoppiamento che il cristallo stesso continua a far girare su di sé23.
Di là della classificazione degli stati del cristallo, degli atti della sua formazione e delle figure di ciò che si vede in esso, la fun-zione che Deleuze attribuisce al cristallo è lo scambio – in sé extra-temporale, una commutazione ontologica – dei regimi di immagini:
Il tempo deve in ogni istante sdoppiarsi in presente e passato, differen-ti per natura uno dall’altro […] l’immagine cristallo non era il tempo ma si vede il tempo nel cristallo […] il cristallo vive sempre al limite […] non cessa di scambiare le due immagini distinte che lo formano: l’immagine attuale del presente che passa e l’immagine virtuale del passato che si conserva24.
Nel regime delle immagini-tempo le immagini vengono dis-
sociate e riconcatenate da un neutro senza spessore corporeo o temporale: il cristallo. Il cristallo è uno strumento ottico che mostra “la forza del fuori”25, l’operatore disgiuntivo puro, il meccanismo più segreto delle funzioni trascendentali che pro-ducono il tempo non-cronologico. Se il presente si sdoppia in passato e futuro, biforcandosi nei getti divergenti della pura vir-tualità di ciò che non può più agire e della pura attualità di ciò che può solo agire, è perché a fondamento del tempo Deleuze pone uno schematismo logico-trascendentale, una facoltà non-temporale in grado di scindere il tempo, di produrre «l’interruzione irrazionale, l’interstizio o l’intervallo»26, il cri-
23 Ivi, p. 96. 24 Ibidem 25 Ivi, p. 234. 26 Ivi, p. 275.
Capitolo II 46
stallo: «Non crediamo più a un’associazione di immagini, che supera anche dei vuoti, crediamo a interruzioni che acquistano un valore assoluto e si subordinano ogni associazione»27.
Questa concezione del tempo rappresenta un’interpretazione della descrizione bergsoniana del circuito tra l’attuale e il vir-tuale; dove il cristallo sostituisce il circuito, e la differenza di natura che Bergson assegnava al passato nei confronti del pre-sente, è riscritta da Deleuze con l’ausilio delle caratteristiche morfologiche dei cristalli. Il paradigma cristallino, luce struttu-rata e visione visibile, intensità luminosa istantaneamente effi-cace, offre a Deleuze la possibilità di mostrare delle funzioni puramente logico-trascendentali di trasformazione delle imma-gini. Il kantismo deleuziano – «Bergson è molto più vicino a Kant di quanto non creda egli stesso»28 – elaborato nella teoria delle sintesi temporali di Differenza e ripetizione e delle lezioni su Kant29, fa del tempo una forma pura, incastonata in una di-mensione trascendentale e non cosmologica o biologica: «Nel cinema moderno, al contrario, l’immagine-tempo non è più né empirica né metafisica, è “trascendentale” nel senso kantiano del termine: il tempo esce dai suoi cardini e si presenta allo sta-to puro»30.
Mentre nel sistema delle immagini-movimento – elaborato in Cinema 1 e ricalcato sul primo capitolo di Materia e memo-ria – è il corpo che funge da centro senso-motorio, assorbendo percettivamente le immagini e restituendole in vista dell’azione possibile sulle cose, nel regime delle immagini-tempo descritto in Cinema 2 il meccanismo genetico è costituito da un interval-lo cristallino, da un’interruzione-rifrazione31 che sostiene lo
27 Ivi, p. 234. 28 Ivi, p. 97. 29 Cfr. G. Deleuze, Differenza e ripetizione, trad. it. di G. Guglielmi, Cortina, Mila-
no 1997, pp. 115-129 e Fuori dai cardini del tempo. Lezioni su Kant, a cura di Sandro Palazzo, Mimesis, Milano 2004.
30 Id., L’immagine-tempo, cit., p. 300. Cfr. il rimprovero al mancato kantismo dello “stile trascendentale” di Paul Schrader, ibidem, nota 22.
31 Cfr. la corrispondenza tra questo livello ontologico “superiore” e la funzione sin-tetica più elevata assegnata da Deleuze alla “cesura” o “incrinatura” nella terza sintesi temporale di Differenza e ripetizione: «È famosa la risposta di Kant: la forma sotto la
Topologia del visibile 47
“stato puro” delle “immagini trascendentali” del tempo con cui il cinema moderno deve fare i conti. Poiché sono viste dentro il cristallo, ossia colte nella regione “pura” della loro genesi, que-ste immagini vengono descritte da Deleuze come “situazioni puramente ottiche”. Esse abitano la dimensione trascendentale dischiusa dalle sintesi-rifrazioni del cristallo. Come in Kant, in Deleuze è una logica trascendentale che fa deragliare la voca-zione mimetica del cinema moderno, sostituendo incessante-mente i movimenti vincolati dell’immagine-movimento con i movimenti liberi della presentazione diretta del tempo, una cre-azione delle forme pure del tempo32.
Più che un commento a Bergson, le tesi di Deleuze vanno lette come una riscrittura del kantismo e, più segretamente, co-me risposta all’influente lettura heideggeriana dell’ontologia di Kant, all’interpretazione dello schematismo kantiano quale pura “veduta” (Anblick) del tempo33. E infatti, la posizione di Deleu-ze si sovrappone spesso a quella heideggeriana, ricalcandone l’argomentazione e la terminologia: la «conoscenza ontologica […] crea la veduta pura»34, ossia immagini pure del tempo35; queste non vanno riportate alla presenza – gli schemi senso-motori dell’immagine-movimento deleuziana – ma sono una
quale l’esistenza indeterminata è determinabile dall’Io penso, è la forma del tempo […] Le conseguenze che ne derivano sono radicali: la mia esistenza indeterminata può essere determinata solo nel tempo, come l’esistenza di un fenomeno, di un soggetto fenomeni-co, passivo o recettivo che appare nel tempo […] Ma che cosa significa forma vuota del tempo o terza sintesi? Il principe di Danimarca dice che “il tempo è uscito dai propri cardini” […] Il tempo cessa di essere cardinale e diviene ordinale, puro ordine del tem-po. Hölderlin dice che cessa di ‘rimare’, poiché si distribuisce in modo ineguale da una parte e dall’altra di una ‘cesura’ rispetto alla quale principio e fine non coincidono più […] La cesura, e il prima e il dopo che essa ordina una volta per tutte, costituiscono l’incrinatura dell’Io (la cesura è esattamente il punto d’origine dell’incrinatura)» (G. De-leuze, Differenza e ripetizione, cit., pp. 115, 119).
32 Questa logicizzazione dell’intervallo è affine alla prassi cinematografica di Go-dard: un formalismo dell’interruzione – l’enciclopedia dei falsi raccordi di Godard – a cui corrisponde un cinema teorematico e progammatico.
33 Cfr. M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica, trad. it. di M. E. Reina, Laterza, Roma-Bari 2000.
34 Ivi, p. 106. 35 Ivi, p. 94.
Capitolo II 48
presentazione diretta del tempo, una exhibitio originaria36; lo schematismo dei concetti – ossia le categorie che in Deleuze so-stengono l’azione e la rappresentazione – si fonda sulla «libertà di movimento dell’immaginazione trascendentale» e questa sul tempo come immagine pura; il tempo-immagine kantiano – l’immagine-tempo di Deleuze – è “autoaffezione pura”, ossia la sua struttura rimanda soltanto a se stessa, come nel caso del cri-stallo. La divergenza fondamentale tra Deleuze e Heidegger, che spiega la dissonanza tra il bergsonismo di Deleuze e quello rosselliniano, riguarda soltanto la collocazione di questo tempo-cristallo37.
Dov’è dunque il tempo? Dove sono collocate le immagini-cristallo di Deleuze e le immagini-veduta di Heidegger? Per Heidegger nella temporalità “esistenziale” dei soggetti finiti. L’autoaffezione pura non rimanda all’autonomia del conoscere ma alla gettatezza del soggetto finito: «l’Io è “stabile e perma-nente” solo nella misura in cui è temporale, ossia in quanto se-stesso finito»38. La decisione fondamentale di Heidegger, il suo smarcarsi da Kant, è una scelta topologica: il tempo in quanto autoaffezione pura, struttura ontologica originaria, «lungi dal trovarsi “nell’animo”»39 è posto in un soggetto finito di cono-scenza, nel soggetto esistenziale dell’ermeneutica heideggeria-na.
E per Deleuze, dov’è il tempo? In quale montatura sono in-castonati i suoi cristalli di tempo? Riprendendo e stravolgendo – questa volta in chiave spinozista – un altro motivo bergsoniano, quello della “macchina d’acciaio” e del misticismo macchinico del Bergson de Le due fonti della morale e della religione, De-leuze colloca i propri cristalli di tempo negli ingranaggi sfavil-lanti di un “automa spirituale”: «il grande automa spirituale che
36 Ivi, p. 118: l’essenza dell’immaginazione trascendentale consiste nella sua capa-
cità di «intuire senza la presenza». 37 Nella prospettiva aristotelica ripresa da Bergson, è il dove, il “luogo”, la posta più
alta in gioco nella speculazione ontologica sul tempo e il movimento; cfr. L’idea di luo-go in Aristotele, cit.
38 Ivi, p. 166. 39 Ivi, p. 165.
Topologia del visibile 49
segna l’esercizio più alto del pensiero, la maniera in cui il pen-siero pensa e pensa se stesso, nello sforzo fantastico di un’autonomia»40. Giunto al nodo dell’autoaffezione del tempo, della sua originarietà e autoreferenzialità, Deleuze dà un calcio alla scala heideggeriana, abbandona le relazioni conoscitive fi-nite e si arrocca nell’autonomia spinozista del pensiero in sé. Per questa ragione, il «cinema è l’automatismo diventato arte spirituale»41.
Tohiishi
E Rossellini, dove colloca i suoi cristalli di tempo? Se il “ci-
nema del veggente” di Rossellini è caratterizzato dalla presenta-zione diretta del tempo, quale forma del tempo si scorge dentro i suoi cristalli? Per quale ragione il suo bergsonismo non si la-scia catturare dalla rete concettuale del bergsonismo deleuzia-no?
A differenza di Deleuze, che riconduce il bergsonismo all’automatismo superiore di un’ontologia trascendentale kan-tiano-spinozista – la cui funzione principale è di mantenere in funzione il circuito del virtuale e dell’attuale – Rossellini collo-ca i suoi cristalli di tempo nella struttura della molteplicità con-tinua propria della durée bergsoniana. Bazin nota la “densità” dei “fatti” caratteristica del cinema di Rossellini, e la paragona a quella di un corpo cristallizzato. Allo stesso modo, per Bergson “ogni durata è spessa”42, dal momento che lo spessore è proprio di ciò che non si può dividere, degli atti di cui si compongono i movimenti: «si può dividere una cosa, ma non un atto»43. Bazin osserva come la specificità del neorealismo di Rossellini consi-sta nel vietarsi «di dissociare ciò che la realtà ha unito»44 e nel considerare «la realtà come un blocco, non certo incomprensibi-
40 G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., p. 290. 41 Ibidem. 42 H. Bergson, Durata e simultaneità, trad. it. di F. Polidori, Cortina, Milano 2004,
p. 53. 43 Id., Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., p. 73. 44 A. Bazin, Difesa di Rossellini, p. 321.
Capitolo II 50
le ma indissociabile»45. Forse a causa del peso esercitato sull’agilità del giudizio dalla sua ontologia dell’immagine foto-grafica, Bazin non ha esplorato tutte le conseguenze di queste intuizioni critiche. Cerchiamo pertanto di ripartire là dove si è arrestato Bazin, la cui concezione del neorealismo è comunque «infinitamente più ricca di quella che combatteva»46.
Costruire immagini-cristallo significa per Rossellini realiz-zare delle immagini dense, “immagini-fatto”, spesse come la durata bergsoniana. Per raggiungere questo risultato è necessa-rio innanzitutto abbandonare le tecniche di dissociazione esco-gitate dal cinema classico, dimenticare le regole formali di di-stribuzione dei corpi nel quadro e delle sequenze in un montag-gio e rifiutare la scienza dei raccordi e dei falsi raccordi. L’anti-formalismo di Rossellini, la sua ostilità per quanto è linguaggio cinematografico e convenzione narrativa, è un sintomo dell’impulso più profondo da cui scaturisce il suo “metodo”47. Lo spessore delle sue immagini corrisponde all’eterogeneità qualitativa propria della durata bergsoniana. Il tempo-durata si distingue dal tempo cronologico così come il cinema di Rossel-lini dal cinema classico. La durata non è un mezzo omogeneo, composto di sezioni raccordabili attraverso elementi di transi-zione, il cinema di Rossellini non si basa sull’unità formale di inquadrature raccordate ad altre inquadrature. La durata è per-corsa da forze e qualità che ne increspano la superficie, le ripre-se di Rossellini mostrano ambienti (naturali o sociali, collettivi o individuali) e situazioni emotive non ulteriormente analizzabi-li, fatti puri, blocchi intensivi di realtà, una topologia delle forze piuttosto che una geometria del movimento.
L’eterogeneità della durata, una continuità di un atto e non uno stato, presuppone in Bergson la fusione di elementi distinti. La durata è ciò che si conserva in modo indivisibile nelle conti-nuità dei mutamenti interni, un progresso dinamico opposto a
45 Ivi, p. 320. 46 G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., p. 11. 47 «La tecnica non è niente, è una sciocchezza» (R. Rossellini, Il mio metodo di la-
voro, in Il mio metodo, cit., p. 410).
Topologia del visibile 51
una successione o a una rappresentazione simbolica48. Allo stesso modo, il metodo di Rossellini presuppone la continuità del suo stile di ripresa. Una continuità posta in una dimensione profonda del metodo, che si sottrae alle analisi condotte secon-do i criteri del “linguaggio” cinematografico. Così, la continuità della costruzione della scena non impone a Rossellini la centra-lità dogmatica del piano-sequenza, che può venire abbandonato o frammentato a seconda delle esigenze drammaturgiche49. Fondamentale è però che la scena possieda “il ritmo giusto”50, una condizione che si ottiene creando una continuità di movi-mento tra le due componenti non dialettizzabili delle immagini cinematografiche: i movimenti dei corpi e delle cose e i movi-menti della macchina da presa: «col montaggio c’è un ritmo che non è naturale, che è totalmente costruito. Muovendo la mac-china da presa si ottiene un ritmo naturale»51. La somma di questi due elementi, l’eterogeneità qualitativa e la continuità, determina in tutta la sua complessità la nozione bergsoniana di molteplicità continua e caratterizza anche lo “stile” di Rosselli-ni.
Questo tipo di molteplicità è descritta da Bazin attraverso il celebre paragone con il guado di un torrente: le pietre da taglio che compongono un ponte «s’incastrano perfettamente per for-mare la volta. Ma dei blocchi di pietre sparpagliati in un guado sono e rimangono delle pietre, la loro realtà di pietra non è alte-rata dal fatto che, saltando dall’una all’altra, me servo per gua-dare il torrente»52. Il paragone riproduce esattamente la distin-zione bergsoniana tra le due molteplicità: da un lato una divi-sione della materia e la sua ricomposizione nella struttura archi-tettonica di un ponte (molteplicità quantitativa del tempo spa-zializzato); dall’altro la continuità indivisibile del movimento del guadare –attraversare un torrente in questo modo significa
48 H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., pp. 80-81. 49 Il “nuovo tipo di drammaturgia” invocato da Rossellini come ambizione suprema
del suo metodo; cfr. R. Rossellini, Il mio metodo di lavoro, cit., p. 418. 50 Ivi, p. 409. 51 Ivi, p. 414. 52 A. Bazin, Difesa di Rossellini, cit., p. 322.
Capitolo II 52
trovare una misura ritmica continua del movimento – ottenuta combinando fatti complessi e chiusi in sé, le pietre del torrente (molteplicità qualitativa della durata).
Chi ha avuto modo di frequentare i giardini giapponesi in cui sono collocati i piccoli padiglioni in cui si svolge la cerimonia del tè sarà rimasto colpito da questo paragone, che rimanda in-consapevolmente sia all’estetica zen che all’orientalismo di Rossellini. Nella cerimonia del tè occupa infatti un posto privi-legiato il sentiero di pietre grezze che conduce alla capanna do-ve si svolge la cerimonia del tè. L’andatura a cui costringono questi sassi (tohiishi), con il suo ritmo inconsueto, escogitato per introdurre alla temporalità densa della casa del tè, ricorda da vicino l’arte naturalistica dei movimenti di macchina di Rossel-lini. A causa dello spostamento dell’osservatore lungo il sentie-ro irregolare di pietre, l’esperienza dell’intero giardino è posta in una dimensione temporale eccentrica, indisponibile alla con-templazione statica o alla costruzione di una veduta sincronica del paesaggio. La mobilità altera lo spazio, inaugurando nuovi regimi temporali.
Rifiutandosi di comporre l’inquadratura secondo macro-strutture narrative fondate su micro-unità visive, Rossellini mira ad agganciare il movimento della macchina da presa alla durata delle cose e dei corpi, estraendo in tal modo la loro temporalità dalla loro mobilità. L’intersezione tra questi movimenti scatena le tonalità emotive (le “affezioni” di Bergson), ora incontri rive-latori, ora azioni tragiche; in ogni caso, rappresenta una costru-zione dinamica di unità indivisibili di movimenti naturali e mo-vimenti di macchina. Come nella durata bergsoniana, la “forza” e l’“alterazione”53 sostituiscono le vedute statiche e i raccordi. Anche quando le scene di Rossellini appaiono scarne e rarefatte, esse contengono una densità inanalizzabile di “fatti”, prodotti dalla semplice interazione tra il tempo della messa in scena e il tempo e la posizione “giuste” della macchina da presa: bisogna abituarsi a
53 H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., p. 81.
Topologia del visibile 53
inventare tanti piccoli fatti dentro le cose […] C’è un tempo per ogni cosa, ogni aspetto dev’essere utilizzato al momento giusto […] Sento subito dov’è che va messa la macchina da presa […] Devo trovare il punto più giusto da dove cominciare, un punto per tutta la scena54. La predilezione di Rossellini per una drammaturgia fondata
su unità episodiche deriva dalle esigenze e dai limiti di questo metodo: un episodio non è nient’altro che un’amplificazione della scena centrale attorno a cui esso è costruito. L’unità se-quenziale della narrazione classica è sostituita dalla densità e indivisibilità dell’immagine-fatto centrale, intorno a cui si cri-stallizzano le altre scene. Si leggano a questo proposito le di-chiarazioni di Rossellini:
In effetti ogni film che realizzo mi interessa per una data scena, per il finale che, magari, ho già in mente […] Tutta la mia preoccupazione non è che di arrivare a tale fatto. Gli altri, gli episodi cronachistici, mi rendono come balbettante, come distratto, estraneo […] Io non mi sen-to sicuto che nell’episodio decisivo. E Germania anno zero, se debbo esser sincero, è nato proprio per l’episodio del bimbo che vaga solo tra le rovine. Tutta la parte precedente non mi interessava minimamente. Anche Il miracolo è nato per l’episodio dei ciottoli di latta. E dell’ultima parte di Paisà avevo in testa quei cadaveri che passavano sull’acqua, lentamente naviganti sul Po, con cartello che recava la scritta “Partigiano”55. Poiché l’immagine centrale racchiude una continuità indivi-
sibile di fatti spazio-temporali56, essa si cristallizza in forme ta-glienti, in lame di significato. Come in Bergson, il metodo dell’intuizione e la conseguente collocazione all’interno della durata fa sì che «tutto si riporti a un punto unico», a un «qual-cosa di semplice, di infinitamente semplice»57. Uno “sforzo” nel caso di Bergson, la ferita affettiva delle situazioni centrali di
54 R. Rossellini, Il mio metodo di lavoro, cit., pp. 414-415. 55 Id., Colloquio sul neorealismo, in Il mio metodo, cit., p. 89. 56 Bazin ha colto questa legge che presiede alla costruzione di immagini-durata:
«Quando ciò che è essenziale in un avvenimento dipende dalla presenza simultanea di due o più fattori dell’azione, il montaggio è proibito» (Montage interdit, in Qu’est-ce que le cinéma, cit., p. 59. Trad. it. mia).
57 H. Bergson, L’intuizione filosofica, in Pensiero e movimento, cit., p. 100.
Capitolo II 54
Rossellini, sentimenti “sottili” e “brucianti”58, i tagli provocati dai cristalli di tempo.
Limiti
Il bergsonismo kantiano di Deleuze, la sua ottica delle super-
fici lucide e germinali, non può riconoscere la lama cristallina delle immagini-tempo di Rossellini. Immagini che restano den-tro il territorio del movimento, estraendo da esso la sua pura na-tura temporale. Come afferma Bergson in Materia e memoria, «l’analisi ci riporta sempre al movimento stesso. Ma perché cercare altrove?»59. Per Bergson l’azione e i movimenti nello spazio non sono una realtà impura, non si svolgono in una re-gione ontologica derivata rispetto alla purezza delle sintesi tem-porali originarie. Al contrario, non vi è alcuna sintesi trascen-dentale, poiché il tempo è un fatto, e la sua immanenza è radica-ta nella mobilità stessa delle cose. Il pensiero metafisico è intui-tivo nella misura in cui accetta di collocarsi nel movimento, e soltanto a partire da esso estrae «la mobilità che ne è l’essenza»60. Si tratta dunque di una pedagogia, non di una lo-gica del movimento; per vedere, al di sotto delle apparenze in-gannevoli di una temporalità omogenea, la struttura della durata dell’uomo e la sua interazione con le molteplici durate della vita naturale, è sufficiente fissare «la mobilità, questo atto indiviso che la vostra coscienza coglie nei movimenti che voi stessi ese-guite»61. Come Bergson, Rossellini resta nei confini dell’immagine-movimento, ma per coglierne la struttura tempo-rale: «i suoi personaggi sono come ossessionati dal demonio della mobilità»62.
Rossellini indica nelle molteplici forme dell’attesa la sostan-za del tempo filmico:
58 R. Rossellini, Intervista con i «Cahiers du cinéma», cit., p. 174. 59 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 165. 60 Ibidem 61 Ivi, p. 175. 62 A. Bazin, Difesa di Rossellini, cit., p. 323.
Topologia del visibile 55
Intervistatore: Che cosa trova di essenziale nel racconto cinematogra-fico? Rossellini: A mio modo di vedere, l’attesa: ogni soluzione nasce dall’attesa. È l’attesa che fa vivere, l’attesa che scatena la realtà, l’attesa che – dopo la preparazione – dà la liberazione […] L’attesa è la forza di ogni avvenimento della nostra vita: e così anche per il ci-nema63. Che cosa significa questa frase? Bazin riconduce l’attesa
rosselliniana ad una logica della posteriorità: L’unità del racconto cinematografico in Paisà non è il “piano”, punto di vista astratto sulla realtà che viene analizzata, ma il “fatto”. Fram-mento di realtà bruta, in se stesso multiplo ed equivoco, il cui “senso” si mostra soltanto a posteriori grazie a degli altri “fatti” tra i quali lo spirito stabilisce dei rapporti64. Di questa osservazione merita conservare il riconoscimento
dei limiti che costituiscono un “fatto”, un’unità di racconto. Poiché l’attesa è sempre attesa di qualche cosa, ogni sequenza-attesa è un fatto delimitato da un altro fatto, un’intersezione di avvenimenti. È questa la logica dei finali-svolta tipici della drammaturgia incompleta ed episodica di Rossellini: i fatti non sono significativi in sé, ma in quanto possono venire trattati temporalmente, come unità di attesa e forze di interruzione. L’attesa è la forza di ogni avvenimento, perché essa non è tem-poralità sciolta ma durata orientata alla propria catastrofe. I per-sonaggi di Rossellini non attendono mai in modo indefinito, at-tendono la chiusura dell’attesa, che conferisce ad essa la sua na-tura. La forma ontologica dell’attesa rosselliniana è l’attesa del-la fine dell’attesa, sia questa un irreparabile o un godimento, la vita o la morte: «Prenda ad esempio l’episodio della tonnara, in Stromboli. È un episodio che nasce dall’attesa. Si viene crean-do, nello spettatore, una curiosità per ciò che dovrà succedere: poi è l’esplosione della mattanza dei tonni»65. La chiusura
63 R. Rossellini, Colloquio sul neorealismo, cit., pp. 91-92. 64 A. Bazin, Le réalisme cinématographique et l’école italienne del la libération, in
Qu’est-ce que le cinéma, cit., trad. it. mia, p. 281. 65 R. Rossellini, Colloquio sul neorealismo, cit., pp. 91-92.
Capitolo II 56
dell’attesa non significa, come suggerisce Bazin, che la realtà sia in se stessa informe e che il senso sia prodotto soltanto a po-steriori, dopo che l’attesa si è compiuta. L’attesa di una risolu-zione è altro dalla ricostruzione di un passato. La fine dell’attesa, il suo limite, è presente in ogni suo momento. Il li-mite di una temporalità vissuta come attesa non giunge mai dall’esterno. In tal caso non si tratterebbe di attesa ma di uno scorrere indefinito del tempo interrotto da un limite esterno a ciò che viene delimitato. Il limite è sempre presente nell’attesa, benché in modo soltanto virtuale: l’attualizzazione del limite non aggiunge nulla alla sua realtà, se non l’esistenza.
Bazin potrebbe legittimamente sostenere questa logica della “posteriorità” soltanto se il limite dell’attesa assumesse in Ros-sellini la forma di una rivelazione apocalittica. E proprio ser-vendosi di questo inadeguato lessico ebraico-cristiano – attesa della salvezza, ascesi e rivelazione – viene spesso mutilato il ci-nema di Rossellini. Così come l’attesa, anche i suoi limiti, che le sono strutturalmente interni, sono una forza e non uno scio-glimento, un’eternità. Come Bergson, Rossellini fa dipendere il movimento dalla mobilità, e quest’ultima da un unico presuppo-sto: che la mobilità sia cambiamento, che sia trasformazione qualitativa e non addizione quantitativa. Ma perché il cinema dell’immagine-movimento liberi l’immagine-tempo che esso racchiude segretamente al proprio interno, i limiti dell’atto de-vono essere colti come forze virtuali, la loro natura deve esclu-dere ogni istantaneità66. Un atto viene colto nella propria durata soltanto a questa condizione, che il suo limite sia un cambia-mento, una forza, e non una parte o un istante: «io sono sicuro della realtà del movimento quando lo produco dopo averlo vo-luto produrre […] Vale a dire che tocco la realtà del movimento quando mi appare, internamente a me, come un cambiamento di stato o di qualità»67.
66 «L’indivisibilità del movimento implica dunque l’impossibilità dell’istante» (H.
Bergson, Materia e memoria, cit., p. 160). 67 Ivi, p. 165.
Topologia del visibile 57
Mentre Deleuze pone la genesi dell’immagine-tempo nell’automatismo spirituale dell’intervallo irrazionale, Rosselli-ni attraverso il metodo dell’attesa amplifica gli intervalli tempo-rali racchiusi dai tagli-forza dei movimenti. Le lunghe riprese ad inseguire i movimenti dei personaggi – uno stile che si af-ferma compiutamente nei film con Ingrid Bergman68 – interrot-te bruscamente da soggettive che fanno a meno dei buoni rac-cordi classici69, convertono il movimento in attesa. Queste se-quenze, delimitate dagli stacchi delle soggettive, sono puri in-tervalli-attesa. I tempi morti diventano la sostanza dei film di Rossellini e rendono inutili i raccordi funzionali. Così in Viag-gio in Italia non accade nulla, «nulla tranne l’attesa; una lunga attesa dilatata per tutto il film», delimitata dalla scena conclusi-va della processione di Maiori70.
Dunque per Rossellini, una ripresa è sia continua che limita-ta, un blocco di tempo che si sottrae a ogni costruzione trascen-dentale, agli automatismi temporali: «Riprendo le cose sempre in movimento. E me ne infischio completamente di arrivare alla fine del movimento per raccordare il piano successivo. Quando ho fatto vedere l’essenziale, taglio: è quanto basta»71. Mentre Deleuze descrive una logica dell’intervallo, Rossellini pratica una pedagogia dell’attesa. L’attesa, a causa della sua irriducibile temporalità vissuta e della natura dei suoi limiti, non può con-vertirsi in un fondamento logico-trascendentale, nell’automatismo spirituale deleuziano che scompagina i vettori temporali e li ricompone secondo linee di fuga macchiniche. Il tempo dell’attesa, come nella durata bergsoniana, non è un flus-so indistinto ma una continuità indivisibile, sostenuta da un li-mite qualitativo, le soggettive il cui ritmo non umano intervalla le sequenze narrative. La durata si avvolge su se stessa – l’ossessiva figura del gorgo di Europa 51 – a partire dal “centro
68 E. Dagrada, Le varianti trasparenti, cit., p. 27. 69 Sul rapporto tra “buoni raccordi” e “falsi raccordi”, cfr. A. Bergala, Faux rac-
cords, in Roberto Rossellini, a cura di A. Bergala e J. Narboni, Cahiers du cinéma, Paris 1990, pp. 57-60.
70 Ivi, p. 311. 71 R. Rossellini, Intervista con i «Cahiers du cinéma», cit., p. 176.
Capitolo II 58
attivo”72 dell’atto di movimento; l’intervallo di tempo compreso nei confini dell’attesa coincide con l’autoaffezione delle imma-gini-tempo.
Rossellini produce una molteplicità di sequenze-durata a partire dai tagli delle soggettive. In Europa 51 le immagini della diga, le visioni della fabbrica e delle borgate, la tromba delle scale da cui precipita Michel e i corridoi della clinica in cui vie-ne rinchiusa Irene, sono altrettanti limiti-forza che racchiudono le forme dell’attesa e ne fanno delle sequenze-durata chiuse su se stesse come cristalli di tempo. Il cinema classico si è costrui-to sull’orizzonte psicologico della tensione e della risoluzione della tensione, suspense e scioglimento. In questo modo esso ha distrutto l’attesa e con essa l’elasticità di un intervallo tempora-le pieno, benché presente a se stesso soltanto nell’esperienza del ritardo. I tempi morti dell’immagine non sono tempi vuoti ma tempi pieni; la loro purezza non-narrativa mostra l’autoaffezione della temporalità, lo spessore e la densità della durata. Rossellini sostituisce i meccanismi dello spettacolo con una pedagogia della pazienza: saper aspettare significa, per lo spettatore cinematografico, lasciar crescere dentro di sé i ritmi della durata, abituarsi a riconoscere negli atti dei personaggi la continuità indivisibile delle forme dell’attesa73.
Nei film ad episodi di Rossellini, e in modo programmatico in Paisà, non sono le soggettive o gli inserti extra-diegetici a delimitare la continuità dei blocchi di durata, quanto degli av-venimenti posti ai limiti delle sequenze narrative: «A ben guardare, Paisà è tutto fatto di attese. Ogni episodio non è altro che la lunga attesa d’un evento che, seppure incombente, si manifesterà soltanto alla fine, in maniera brusca e definitiva»74. Così nell’episodio finale, ambientato nel delta del Po, la prima ripresa del cadavere del partigiano trascinato dalle acque segnala l’apertura di una durata di attesa che verrà chiusa
72 G. Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, cit., p. 295. 73 «Intervistatore: Il lirismo ha sempre, nel suo caso, qualcosa di folgorante. Si a-
spetta e poi si è fulminati, illuminati. Rossellini: Poco fa ha detto una parola molto giu-sta: la pazienza. La pazienza è anch’essa una virtù! Dopo c’è la scintilla» (R. Rossellini, Intervista con i «Cahiers du cinéma», cit., p. 368).
74 G. Rondolino, Roberto Rossellini, UTET, Torino 1990, p. 102.
Topologia del visibile 59
l’apertura di una durata di attesa che verrà chiusa dall’annegamento dei partigiani. Esordio e conclusione delimi-tano i confini di ciò che la molteplicità continua della sequenza può mostrare: morte e scorrere delle acque sono le facce del cri-stallo entro cui si ripartisce addensandosi la temporalità delle riprese. Che cosa vediamo dentro il cristallo? Lo scorrere del fiume, i movimenti impacciati delle barche e degli uomini nell’ambiente lagunare, il soffiare lento e teso del vento tra le canne, esplosioni isolate e scontri a fuoco repentini, l’immobile cielo stellato e i rumori degli aerei, i dialoghi dei combattenti e il pianto del bambino di cui è stata massacrata la famiglia. Que-ste prospettive non aggiungono niente all’immagine centrale del cadavere galleggiante del partigiano, e nemmeno ne ritardano il senso, che non è liberato a posteriori dalla morte dei partigiani, già anticipata nella scena iniziale. In se stessi, i limiti dell’episodio non possiedono alcun significato, essi sono prin-cipi di trasformazione della temporalità slegata in blocchi di du-rata indivisibile. Dentro questa durata i fatti diventano significa-tivi, assumono il ritmo dettato dalle forme dell’attesa. L’attesa assorbe virtualmente la fine nell’inizio, addensa il tempo, fa e-splodere l’impossibile presenza del presente in una molteplicità di piani di contrazione ed espansione, compresi tra i poli della contemplazione del cielo stellato e delle azioni degli uomini.
Il “dentro”
Questa concezione dell’immagine-attesa rilancia il bergsoni-
smo – una delle matrici profonde della cultura italiana del No-vecento, basti pensare al Futurismo, a Pirandello e Gadda – per-correndo una via alternativa rispetto alla lettura kantiano-spinozista dell’immagine-tempo deleuziana. Sullo sfondo, due visioni incompatibili del vitalismo. In Rossellini, la filosofia della natura incontra il vitalismo orientale: la temporalità del mondo e quella dei soggetti viventi si formano all’interno di un unico campo d’immanenza. È questa la prospettiva del filosofo giapponese Kitarō Nishida:
Capitolo II 60
Nel mio saggio La vita ho scritto che il mondo della vita, a differenza del mondo della materia, contiene al suo interno un’autoespressione […] In altre parole, è un mondo che esiste e si muove da se stesso […] In questo mondo, quando una cosa agisce […] tutto questo deve diri-gersi verso l’autoformazione del mondo stesso […] Il tempo deve ave-re il proprio contenuto75. Deleuze elabora invece un vitalismo spinozista del pensiero
puro, in cui il tempo è autoaffezione del concetto. Perciò, l’automa spirituale «segna l’esercizio spirituale del pensiero, la maniera in cui il pensiero pensa e pensa se stesso, nello sforzo fantastico di un’autonomia»76 e il “cervello vissuto” è il territo-rio del cinema moderno: «Il cervello diventa il nostro problema o la nostra malattia, la nostra passione»77. L’essenza del cinema «ha come obiettivo più elevato il pensiero, nient’altro che il pensiero e il suo funzionamento»78.
Le tracce che ci permettono di distinguere i due orientamenti si riassumono nelle caratteristiche attribuite rispettivamente da Deleuze e da Rossellini ai limiti-interruzione del tempo narrati-vo. Per Deleuze è paradigmatico il metodo “interstiziale” di Godard: la proliferazione di falsi raccordi e falsi movimenti79, l’esplosione della temporalità cronologica, l’intervallo irrazio-nale come metodo fondato sulla disgiunzione delle inquadrature e tra immagini e suoni80. In Rossellini, le interruzioni interseca-no la durata delle scene portanti come forze ritmiche e non-narrative, soggettive e sequenze-inquadrature extra-diegetiche, svincolate dalla logica dell’azione dei personaggi: immagini vulcaniche in Stromboli e Viaggio in Italia, paesaggi industriali in Europa 51. Questa collocazione delle interruzioni all’esterno delle sequenze continue spiega l’insofferenza di Rossellini per il vocabolario del montaggio e la sua repulsione per il “nesso
75 Kitarō Nishida, La logica del luogo e la visione religiosa del mondo, trad. it. di T.
Tosolini, L’Epos, Palermo 2005, pp. 98-99. 76 G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., p. 290. 77 Ivi, p. 234. 78 Ivi, p. 188. 79 «Il movimento è diventato aberrante per essenza» (ivi, p. 300). 80 Ivi, p. 278.
Topologia del visibile 61
logico” del soggetto: «Il nesso logico del soggetto è il mio ne-mico […] Io non mi trovo bene che là dove posso evitare il nes-so logico»81. Date queste premesse, è ovvio che i passaggi «utili per una narrazione continua» – correlazione delle scene tra loro attraverso i raccordi – risultino “estremamente fastidiosi”82 e che Rossellini prediliga narrazioni tese ed episodiche.
All’interno delle singole scene, Rossellini si preoccupa inve-ce di costruire una continuità stratificata, che corrisponde alla natura delle molteplicità di fusione descritte da Bergson. In questo caso, l’interazione tra i movimenti dei corpi, degli ogget-ti e della macchina da presa, libera una pura mobilità di cam-biamento, un ritmo di durata che varia per ogni scena. Come aveva intuito Bazin, l’unità del piano sequenza è il procedimen-to ideale per rendere l’indivisibilità di una durata al tempo stes-so continua e solcata da movimenti eterogenei. Così Rossellini preferisce «girare una scena per intero con una ripresa unica»83. Una ripresa in cui, per produrre la stratificazione interna della durata, si ha «bisogno di tutto: dei primi piani, delle reazioni degli altri […] di sapere da che angolazione riprendere la sce-na»84. Anche quando interviene il montaggio, il suo utilizzo non è che un prolungamento dei movimenti della macchina da pre-sa, una messa a fuoco o un pedinamento delle azioni che prose-gue l’interazione tra gli elementi interni alla continuità della scena. La proverbiale rapidità con cui Rossellini monta i propri film deriva da questa indivisibilità di ogni sequenza, che si sot-trae alla logica di retrospezione e al formalismo del montaggio.
Per dare avvio alla cristallizzazione dell’immagine-durata, Rossellini procede come in una reazione chimica. A seconda delle esigenze drammaturgiche, prende a prestito e rifunziona-lizza le tecniche cinematografiche tradizionali, utilizzando me-todi di sintesi differenti. Prendiamo il caso della “soggettiva li-bera indiretta” teorizzata da Pasolini. Rossellini se ne serve in modo limitato, ma quando ciò avviene le modalità sono quelle
81 R. Rossellini, Colloquio sul neorealismo, cit., p. 91. 82 Ibidem 83 R. Rossellini, Il mio metodo di lavoro, cit., p. 407. 84 Ibidem
Capitolo II 62
anti-formalistiche e non-estetiche di trucchi tesi ad estrarre la temporalità dei ritmi di durata dalla mobilità pura delle imma-gini, e quest’ultima dai movimenti dei corpi nello spazio. È ciò che avviene nella scena della cappella Brancacci affrescata da Masaccio nel film per la televisione L’età di Cosimo de’ Medi-ci. Il mercante inglese Wadding, precipitato nell’universo sco-nosciuto della civiltà fiorentina del XV secolo, si ritrova al co-spetto degli affreschi del Masaccio. Accompagnato da un frate, che durante tutto il piano sequenza pronuncia soltanto la frase “Sono gli affreschi del Masaccio!”, Wadding entra nello spazio della cappella. Qui due pittori sono intenti a lavorare all’affresco ancora in fase di realizzazione. Wadding, colto di sorpresa dalla realtà incomprensibile degli affreschi, interroga il frate e i pittori sul significato di quest’arte. Nel mentre, cammi-na avanti e indietro nello spazio della cappella, seguito dallo zoom della macchina da presa che nel mostrare il suo movimen-to coglie di volta in volta particolari differenti degli affreschi, che non sono mai mostrati in campo lungo. Poiché né il frate né i pittori rispondono alle domande di Wadding, e vengono mo-strati soltanto di schiena, la sequenza si trasforma in una sogget-tiva libera indiretta, nella quale pur osservando Wadding dalla prospettiva della macchina da presa, siamo catturati dal suo in-volontario monologo e vediamo, sovrapposti, ciò che egli vede e le immagini degli affreschi filtrate dal prisma dello stile di ri-presa di Rossellini. Questa soggettiva libera indiretta si sottrae sia al formalismo estetico di Antonioni che al vernacolare e-spressionista di Pasolini: Rossellini è interessato piuttosto ad in-tuire la compenetrazione tra la temporalità figurativa degli af-freschi e quella delle riflessioni di Wadding. Perciò lo strata-gemma della soggettiva libera indiretta contribuisce al metodo di costruzione delle molteplicità continue, alla pedagogia della durata.
La doppia articolazione dello stile di Rossellini, scene-durata continue e interruzioni-forza extra-diegetiche, elimina la dialet-tica tra campo e fuoricampo. L’introduzione nei film televisivi della carrellata ottica – e la conseguente piattezza dell’immagine, con successive apparizioni delle azioni
Topologia del visibile 63
all’interno di un campo visuale auto-sufficiente e indeterminato – segna la perfetta corrispondenza tra tecnica di ripresa e pre-supposti estetici. Ogni volto e azione, ogni movimento naturale e intenzionale, ogni gesto e immobilità sorge dentro la continui-tà di lunghi piani sequenza. Ma il movimento della macchina da presa non è significativo in sé. Come nel cinema classico, “non si sente la macchina”, ma in questo caso l’oggettività ricercata è quella dei ritmi della durata e non quella della trasparenza del racconto. In Rossellini il movimento della macchina da presa è invisibile poiché non è una fonte autonoma di visione, essendo posto al servizio dell’alternanza tra gli sfondi virtuali confusi – a causa della mancanza di profondità di campo – da cui proma-nano gli avvenimenti e le immagini piatte in atto dei movimenti e delle espressioni che sgorgano dentro i confini inalterabili del-la ripresa (che corrispondono all’indivisibilità dei singoli ritmi di durata)85.
Un esempio di questo procedimento sono i lunghi piani se-quenza che aprono L’età di Cosimo de’ Medici. La scena si svolge dentro l’ambiente notturno dei saloni di casa Medici. In questo spazio chiuso – non nel senso geometrico-cognitivo dell’immagine-azione, ma secondo i limiti di tensione di uno spazio della durata che, come un corpo elastico, si distende e contrae dentro i propri limiti – si svolgono molteplici azioni che si susseguono sovrapponendosi alle voci fuoricampo del vesco-vo e del coro, oltre che all’immagine centrale della salma di Giovanni di Bicci de’ Medici, mostrata all’inizio della sequenza e intersecata più volte dai movimenti e dalle parole dei perso-
85 Citiamo per esteso la descrizione fornita da Adriano Aprà delle caratteristiche
della mise-en-scène di Rossellini nei film per la televisione: «Two-dimensional ele-ments prevail over three-dimensional ones. Generally, one or two actors stand on the set as if they were facing an audience and the space behind them is like a backdrop […] Off-screen space is absent. The surface of the frame absorbs the camera’s and the spec-tator’s interest. Tricks of perspective and depth of field play a minimal part […] Camera movements are used to follow characters or, in some cases, to ensure continuity of the sequence-shot. They are “invisible”, though sometimes refined, movements […] the op-tical movement of the zoom maintains the tendential flatness of the images» (A. Aprà, Rossellini’s Historical Encyclopedia, in Roberto Rosellini. Magician of the Real, cit., p. 137).
Capitolo II 64
naggi. Pochi piani sequenza alternati da alcuni stacchi in piano medio e controcampo costruiscono la temporalità al contempo continua e molteplice dell’azione, che compenetra dimensioni temporali eterogenee: il tempo morto centrale del corpo-salma di Giovanni di Bicci, la durata cerimoniale della litania funebre del coro, il lento incedere rituale di amici e avversari del defun-to, il tempo mondano del commercio e della lotta politica nei pettegolezzi tra i gentiluomini convenuti in casa Medici. Questa molteplicità di piani temporali emerge grazie ai movimenti e al-la messa a fuoco compiuti sulle azioni in atto dalla macchina da presa, sullo sfondo continuo del piano virtuale della durata del piano sequenza: lo sfuocato delle azioni e dei luoghi, l’andirivieni elastico della visione.
Deleuze collega l’espansione incontrollata delle interruzioni proprie dell’immagine-tempo alla penetrazione del “fuori” nel tessuto delle immagini. Il “fuori”, nella sua forma più essenzia-le, è la “forza pura del tempo”, l’irrazionalità di un cambiamen-to che travolge il dentro delle immagini, delle narrazioni e dei personaggi. La logica dell’interruzione si sdoppia in un lin-guaggio tecnico-formale del montaggio irrazionale e in una ta-vola delle categorie del “fuori”, vera e propria enciclopedia del-le forze che annullano ogni movimento naturale: l’inevocabile di Welles, l’indecidibile di Resnais, l’inesplicabile di Robbe-Grillet, l’incommensurabile di Godard, l’irriconciliabile degli Straub, l’impossibile di Marguerite Duras, l’irrazionale di Syberberg86.
Come si noterà, a questo elenco mancano le interruzioni di Rossellini. Avendo forse presagito la loro refrattarietà alla poe-tica del “fuori”, Deleuze le ha tenute ai margini del sistema dell’immagine-tempo. In Rossellini, il rapporto tra sequenze continue e interruzioni-forza non rimanda infatti a uno scontro tra un “dentro” e un “fuori” del pensiero e dell’immagine, a un automatismo dello scambio ineguale tra il piano attuale delle immagini-movimento e quello virtuale delle immagini-tempo. Come in Bergson, in Rossellini i ritmi della durata delle se-
86 G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., p. 306.
Topologia del visibile 65
quenze portanti appartengono a centri corporei – siano essi u-mani o animali, come in India, matri bhumi – che incrociano ritmi eterogenei di durata, caratteristici dei movimenti e degli orizzonti temporali della natura (i film con Ingrid Bergman) o della storia (la guerra in Roma città aperta, Paisà e Germania anno zero, economia e tecnologia nei film televisi). Il Rossellini neorealista, quello spiritualista e quello pedagogico-enciclopedico incarnano aspetti diversi del Rossellini bergso-niano, maestro di una drammaturgia vitalistica che sorge all’interno del campo di tensione tra le pluralità delle durate: «Questo preteso tempo omogeneo […] è un idolo del linguag-gio […] In realtà non c’è un ritmo unico della durata, si possono ben immaginare dei ritmi differenti […] Questa rappresentazio-ne di durate dall’elasticità ineguale è forse difficile per il nostro spirito»87. Un cinema-miniera in cui si cristallizzano i movi-menti divergenti della durata; un “dentro” limpido e profondo di sequenze continue e interruzioni-forza, durate esistenziali e du-rate delle cose, tempi dei personaggi e tempi del mondo: «Una volta piazzata la macchina da presa guardo dentro, perché quel-lo che c’è fuori non deve esistere»88.
Il volo degli sciacalli
L’immagine-tempo di Rossellini custodisce sia i ritmi conti-
nui della durata che la pluralità delle durate. In entrambi i casi, è l’attesa la forma assunta dalla temporalità quando l’interruzione che delimita ogni blocco di durata, ogni cristallo di tempo, pe-netra all’interno del presente e ne fa esplodere l’istantaneità. Come in Bergson, anche in Rossellini non esistono presenti ine-stesi ma soltanto presenti distesi o contratti, intervalli di attesa e di memoria. Fissare le immagini-cristallo di Rossellini significa
87 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 174. 88 R. Rossellini, Il mio metodo di lavoro, cit., p. 415. «There’s no off-space in
Rossellini’s storyworld, writed Charles Tesson, except the set’s “fourth wall” (the cam-era), toward which Ingrid Bergman exposes herself and risks herself» (T. Gallagher, The Adventures of Roberto Rossellini, Da Capo Press, New York 1998, p. 365).
Capitolo II 66
osservare la struttura interna della durata, riconoscere le molte-plici forme dell’attesa.
Nel vitalismo naturalista di Rossellini e Bergson, i movi-menti-durata non sono manifestazioni di un intervallo trascen-dentale quanto forze immanenti. Ma anche gli intervalli che de-limitano le unità di durata non sono limiti inestesi quanto, a loro volta, come in un gioco di scatole cinesi, intervalli densi, inter-ruzioni complesse e misteriose, molteplicità qualitative “ultra-sottili”. Infra-mince («ultra-sottile») è un termine coniato da Marcel Duchamp per descrivere la complessità estesa delle in-terruzioni di durata e lo spessore bergsoniano dei limiti che se-parano fenomeni eterogenei:
=a ogni frazione della durata ( ?) si riproducono/tutte le frazioni future e ante-riori – Tutte queste frazioni future e anteriori/coesistono dunque in un presen-te che non è/già più ciò che si chiama comunemente/l’istante presente, ma una sorta di/presente dalle estensioni multiple89.
Le affinità strutturali tra il cinema di Rossellini e l’arte con-
cettuale di Duchamp sono sorprendenti, a partire dal fatto che anche per Rossellini non è rilevante l’immagine quanto l’idea: «Ciò che importa sono le idee, non le immagini […] Le imma-gini in sé non hanno niente, sono delle ombre e basta»90. Il ci-nema di Rossellini, come l’arte visuale di Duchamp, è concet-tuale e non astratta. In entrambi i casi la realtà esterna non vale in senso rappresentativo-documentaristico ma come rottura del soggettivismo estetico e strumento ottico di precisione per co-gliere la durata. Il realismo di Rossellini corrisponde all’epistemologia concettuale del readymade di Duchamp.
Poiché sono posti all’intersezione di una molteplicità di ritmi ineguali di durata, i corpi e, nel caso degli esseri umani, il volto, rappresentano le regioni di attesa più sottili e strutturate. Le combinazioni dei movimenti sprigionano effetti che si leggono
89 M. Duchamp, Marcel Duchamp, Notes, a cura di P. Matisse, G. K. Hall &
Company, Boston 1983, nota 135 (trad. it. mia). 90 R. Rossellini, Intervista con i «Cahiers du cinéma», cit., p. 176; R. Rossellini,
Film vecchi e nuovi orizzonti, cit., p. 350.
Topologia del visibile 67
sui volti. Il conflitto delle durate si mostra nei volti come su una mappa. Che il tempo sia la forma dell’attesa è evidente nei pri-mi piani che affollano le riprese di Rossellini. Eccitazione, di-sperazione, pietà e tutta la gamma delle emozioni non sono che affezioni corrispondenti alle modalità dell’attesa. Il cinema di Rossellini si svolge pertanto nel campo di ciò che Deleuze defi-nisce “immagine-affezione”: il corpo come centro di interruzio-ne e sospensione dell’azione, luogo di assorbimento e trasmis-sione ritardata dell’azione91. Per esigenze sistematico-architettoniche, Deleuze colloca l’immagine-affezione all’interno dell’immagine-movimento, ma in realtà essa possie-de tutte le caratteristiche dell’immagine-tempo.
Oltre che ad appartenere ai corpi e ai volti, l’attesa vive en-tro i confini dell’impossibilità e della ripetizione. Ciò che i cor-pi biologici attendono senza poterne assorbire il limite che li definisce e ne racchiude la continuità vitale è la morte, l’esperienza dell’annullamento di ogni attesa e memoria, la soppressione della densità temporale e lo sbriciolamento del cristallo di tempo. A questa fenomenologia dell’attesa corri-spondono forme di esteriorità radicale: in Stromboli i pescatori aspettano sotto il sole che si compia la mattanza dei tonni, in Europa 51 Irene assiste all’agonia e alla morte della prostituta Ines. All’estremo opposto troviamo la quasi-istantaneità dell’attesa, la ripetizione come abitudine, le costanti senso-motorie ed intellettuali, i clichè. In questo caso l’attesa dei per-sonaggi è una ripetizione, un’abitudine di reazione ad uno sti-molo previsto, e dunque l’azione dissolve lo spessore del tempo non perché ne renda impossibile l’occorrenza ma al contrario perché ne intensifica l’attualizzazione, riducendo la virtualità di realizzazione di cui è intessuta l’attesa a un movimento riflesso, a un automatismo senso-motorio.
È questo il territorio del comico, praticato da Rossellini in modo rigorosamente bergsoniano:
91 G. Deleuze, L’immagine-movimento, cit., p. 130. Qui Deleuze descrive i “primi
piani taglienti” di Dreyer.
Capitolo II 68
Trattare la vita come un meccanismo a ripetizione, come effetti rever-sibili e scene interscambievoli. La vita reale è un vaudeville nella mi-sura esatta in cui produce naturalmente effetti del medesimo genere, e per conseguenza nella misura esatta in cui dimentica se stessa, poiché se fosse continuamente attenta, sarebbe continuità variata, progresso irreversibile, unità indivisa92. Ritroviamo la polarità del cinema di Rossellini: da un lato
una visione attenta, i tempi lenti e continui dell’attesa, delimitati dal progresso irreversibile verso le interruzioni-catastrofe che fanno delle micro-sequenze e dei macro-episodi delle unità in-divise. Dall’altro scene comiche che segnalano il prevalere dell’abitudine e della ripetizione, e con esse la sconfitta della durata e della differenziazione, il trionfo dell’incomprensione e l’affermarsi della violenza.
L’episodio dell’assedio di Viterbo in Francesco giullare di Dio mostra, in puro stile slapstick, il legame tra meccanicizza-zione e commedia. Il tiranno Nicolaio (Aldo Fabrizi), le cui truppe stanno assediando la città di Viterbo, è imprigionato in una gigantesca armatura che ne limita e irrigidisce comicamente i movimenti. Violenza e potere, in quanto ripetizioni di compor-tamenti strumentali, automatismo dell’azione, si prestano sol-tanto al riso. Di contro, il goffo Fra Ginepro incarna la perfetta inefficacia delle convinzioni francescane e dunque il loro spes-sore di durata: Fra Ginepro non ritaglia il proprio comportamen-to – il messaggio pacifista – sulla natura della situazione, non prevede e dunque attende l’impossibile, lascia che la virtualità della soluzione riposi in se stessa.
Un altro esempio della dimensione comica del cinema di Rossellini è la gag di Viaggio in Italia, in cui assistiamo ai di-sperati tentativi di Alex Joyce di farsi riempire dai domestici napoletani una caraffa di vino. Alex ripete con insistenza di a-vere sete, compie ripetutamente gesti inappropriati, vaga da un locale della villa ad un altro per portare a termine il suo compi-to, tratta con arroganza i domestici a causa della loro incapacità
92 H. Bergson, Il riso. Saggio sul significato del comico, trad. it. di F. Stella, Rizzo-
li, Milano 2001, p. 95.
Topologia del visibile 69
di comprenderlo e infine, portato a termine il suo proposito, raggiunge Katherine che sta riposando in terrazza. Qui non trat-tiene il disprezzo per i tempi morti della cultura mediterranea, ironizzando sui servi che dormono come se fosse notte. Palese-mente, il contenuto di questa scena comica è il mancato incon-tro tra due ritmi di durata: i tempi della cultura napoletana, fede-li alla natura del luogo (durata del vino e della calura) e i tempi del protagonista anglosassone, preoccupato di vendere la pro-prietà dello zio e ritornare agli affari (durata del commercio e delle transazioni economiche). Poiché i due ritmi sono incompatibili – è questa una convinzione profonda di Rossellini, espressa attraverso la metafora della diversità di natura tra gli “uomini drappeggiati” del sud e quelli “cuciti” del nord – l’unico stile di narrazione possibile è il vaudeville, lo scontro tra l’implacabile coazione a ripetere dei luoghi comuni. E poiché i due flussi di durata non appartengono all’unità indivisibile di un’unica molteplicità ma all’esteriorità di durate spazializzate, la fusione dei tempi cede il passo all’estraneità geografica. Il secondo asse dell’attesa è compreso tra i limiti dell’attesa rimemorante e dell’attesa pianificante. La forma più pura di at-tesa rimemorante è rappresentata dal vuoto oggettuale. La me-moria pura, come in Bergson, è assoluta virtualità. Essa non può attendersi nulla dall’esistenza materiale. Non poter assegnare un contenuto all’attesa significa rovesciare l’attesa come una fode-ra, mostrando il rovescio della memoria. È questa la condizione affettiva di Irene in Europa 51. La morte del figlio inaugura l’impossibilità di attendere qualcosa di attuale. L’attesa stessa sembra perciò impossibile e con essa la costruzione della durata vissuta, la possibilità di vivere. In questa condizione limite Ire-ne scopre la follia e la santità, ossia un rapporto assoluto con l’attesa rimemorante, la virtualità del contenuto dell’attesa. Ire-ne ricorda ossessivamente il figlio e lo attende come vuoto di ogni possibilità di presenza nel mondo dell’attesa pianificante, delle abitudini motorie e delle convenzioni sociali. Le ripetizio-ni e i progetti diventano impossibili. Bisogna lasciarsi vivere, penetrare nel vuoto assoluto della memoria pura, nella sua pura virtualità. Qui Irene è travolta dalle durate degli altri: la povertà
Capitolo II 70
delle borgate, l’agonia di Ines, il lavoro meccanizzato (la fab-brica), la follia, ossia i tempi della scarsità, della sofferenza, del lavoro e della perdita di sé. L’ottusità della protagonista, la sua impenetrabile testardaggine, segnalano la formazione di cristalli di tempo dotati di un ampio potere di assorbimento.
L’attesa rimemorante, per la sua autonomia dalle costrizioni della vita attiva, esprime il dato originario della durata: l’autoaffezione del tempo. All’estremo opposto, l’attesa pianifi-cante si rivolge agli oggetti e ai corpi esistenti, è finalizzata alla manipolazione del reale: pura efficacia e attualità di contro all’inefficacia e ricettività dell’attesa rimemorante. In Europa 51 questa forma di attesa è incarnata dal marito di Irene, Geor-ge, e dal cugino André. Il primo, un borghese conservatore, analizza la situazione in vista della conservazione delle condi-zioni esistenti; il secondo, un comunista rivoluzionario, si con-fronta con la realtà per introdurvi dei mutamenti. In entrambi i casi, l’unità indivisibile dei blocchi di durata – il tempo com-preso tra il presente e la rivoluzione o tra il presente e l’egemonia della borghesia – è occupato dai ritmi dell’azione finalizzata: la crudele etichetta dell’etica borghese, l’aggressiva intelligenza dell’agire politico. Irene penetra in una dimensione virtuale, e da questa prospettiva scopre che l’impossibilità dell’attesa nasconde un’altra realtà, interna a questo mondo ma scandita da ritmi incommensurabili di durata.
L’episodio conclusivo di India, matri bhumi mostra lo sfon-do naturale dell’attesa, la sua radicale immanenza:
Non ho messo quell’episodio alla fine perché più drammatico, ma perché rappresenta la regola perfetta della natura. Gli avvoltoi atten-dono, ma non mangeranno l’uomo che non è morto. Bisogna attendere il decreto di morte. Bisogna che, in qualche modo, sia legalizzata la morte dell’uomo per far sì che gli avvoltoi, parte della natura, si muo-vano e vadano a compiere la loro funzione nella natura […] Allora, morto il suo padrone, la povera scimmia, che non è più né una scim-mia né un uomo, prova il bisogno di andare nello stesso tempo dalle scimmie e dagli uomini, di tornare indietro e di andare avanti93.
93 R. Rossellini, Intervista con i «Cahiers du cinéma», cit., p. 174.
Topologia del visibile 71
Un saltimbanco accompagnato da una scimmia vestita sta at-
traversando un’arida steppa per raggiungere un villaggio. Sor-preso dalla calura si addormenta e infine muore. Inizialmente la scimmia gli resta a fianco, cercando di svegliarlo e poi di scac-ciare gli avvoltoi che li sorvolano, ma quando si accorge che il suo padrone è morto lo abbandona e raggiunge il villaggio, do-ve non riesce più a trovare posto né tra gli uomini né tra le scimmie. L’episodio ricorda la conclusione di Stromboli e di Paisà. Invece di svolgersi orizzontalmente, le traiettorie dei personaggi si addensano sull’asse verticale: cielo e terreno vul-canico in Stromboli, notte stellata e laguna in Paisà, volo degli avvoltoi e deserto in India. In questa situazione le interazioni senso-motorie tra i personaggi s’inceppano, sostituiti da una sorta di campo-controcampo tra l’alto e il basso, i personaggi ed il cosmo. A causa di questa disfunzione della percezione attiva, l’immagine-cristallo si riduce alle sue componenti essenziali: l’attesa dell’interruzione e la pura mobilità dell’alternanza tra immagini slegate dai contesti senso-motori.
Il volo degli avvoltoi, la loro complessa danza, è un effetto dell’attesa della morte. Nell’attendere l’interruzione che ne de-finisce la funzione naturale, gli avvoltoi temporalizzano il cielo. La “regola perfetta della natura” è la convertibilità del movi-mento in mobilità pura e della mobilità nella temporalità dell’attesa. Il volo è danza, la danza è attesa del decreto di mor-te. Questa sequenza vale come una definizione della forma na-turale dell’attesa: il movimento. Così come il camminare osses-sivo di Ingrid Bergman in Europa 51, il volo degli avvoltoi è una cristallizzazione dell’attesa del limite, la descrizione della virtualità del limite prima del compimento dell’interruzione. Nella durata l’interruzione accompagna l’attesa come sua di-mensione virtuale. L’attualizzazione di ciò che era reale, pur vi-vendo soltanto di un compimento virtuale, non aggiunge nulla allo spessore della durata. La temporalità del cinema di Rossel-lini non è orientata teleologicamente alla parusia, è un fenome-no naturale, la “regola perfetta della natura”. Non è necessario il cristianesimo per vivere nell’attesa, è sufficiente osservare il
Capitolo II 72
volo degli avvoltoi con gli occhi degli indiani per comprendere che il movimento è impregnato della sua cessazione virtuale.
Ma se l’attualizzazione dell’interruzione – la morte del sal-timbanco e la conclusione del volo degli avvoltoi – non aggiun-ge nulla al volo-attesa degli avvoltoi e alle urla-attesa della scimmia – che sono unità dense di durata, cristalli virtuali di tempo delimitati da strutture genetiche di cristallizzazione dell’evento che li definisce – ciò non significa che i limiti non esistano e le interruzioni non siano efficaci. Attraverso il suo cinema “incompleto” Rossellini mostra come l’avvenire del li-mite, la sua attualizzazione, sprigioni la seconda dimensione della durata: il mutamento. Dopo la morte del suo padrone la scimmia cambia di natura. Quando il limite delle molteplicità qualitative è virtuale, la durata si presenta come continuità indi-visibile dell’attesa, i tempi morti del cinema di Rossellini; quando è attuale come discontinuità radicale del mutamento, gli eventi definitivi, lo scandalo di esperienze non assimilabili. I ritmi di durata, così come le vite degli uomini e i tempi del mondo, sono separati da soglie irriducibili alla coerenza di un destino o all’autonomia dello spirito. Dunque tra di essi non esi-ste commensurabilità e le unità di durata non sono raccordabili se non attraverso esperienze di non comunicabilità (santità e follia, natura estranea e distanza del passato, geologia ed uma-nesimo)94. L’insofferenza di Rossellini per il “nesso logico” tra le sequenze, il suo rifiuto di un cinema di sceneggiatura solida-mente costruito su una prassi narratologica dei buoni raccordi – o su una logica decostruzionista dei falsi raccordi – rispecchia il suo profondo bergsonismo della durata.
94 Viaggio in Italia rappresenta un caso estremo del protagonismo delle forze tellu-
riche, che impone nuove modalità di racconto. Cfr. Laura Mulvey, Vesuvian Topogra-phies: The Eruption of the Past in Journey to Italy, in Roberto Rosellini. Magician of the Real, a cura di D. Forgacs, S. Lutton, G. Nowell-Smith, BFI, London 2000, pp. 95-111.
Topologia del visibile 73
Il metodo dell’intuizione In Cinema 1, Deleuze espone una tesi che sembra rubata ai
cliché di Viaggio in Italia: Rossellini e il neorealismo italiano possiedono una conoscenza intuitiva dell’immagine-tempo, a differenza della nouvelle vague che ne sviluppa intellettualmen-te i presupposti95. L’ipotesi che ho sostenuto in questo interven-to è un’altra: la divergenza tra Rossellini e la nouvelle vague, così come la sua distanza da Deleuze, va ricercata nell’incompatibilità tra due sviluppi del bergsonismo. Nel caso di Rossellini, la tecnica cinematografica non è posta al servizio della costruzione formale dell’intervallo, non è un circuito per commutare il piano logico nell’esperienza, i concetti nei corpi. L’esattezza dell’intervallo, l’unica posizione “giusta” in cui mettere la macchina da presa e iniziare i movimenti, esprime l’intuizione della durata, la collocazione più precisa dentro i ritmi dell’attesa. Come in Bergson, l’intuizione rosselliniana – il suo rigetto del formalismo e dell’autorità della sceneggiatura – non rimanda a una poetica dell’ambiguità, della metaforicità e dell’allusione simbolica. L’intuizione è un metodo, il metodo di collocarsi con precisione dentro la durata: «Ciò che più è man-cato alla filosofia è la precisione»96.
Il termine intuizione, dichiara Bergson, è fuorviante. Esso può trarre in inganno, non a causa della sua vaghezza, ma nel suggerire un luogo sbagliato per l’intuizione. Ad esempio, «uno Schelling, uno Schopenhauer […] poiché credevano che l’intelligenza operasse nel tempo, ne hanno concluso che oltre-passare l’intelligenza consistesse nell’uscire dal tempo»97. L’errore di queste posizioni è topologico. La collocazione più difficile, che richiede maggiore sforzo, corrisponde
95 «Il cinema in Francia non potrà rompere con la propria tradizione che molto tardi, e attraverso una svolta riflessiva e intellettuale quale fu quella della nouvelle vague. Tutt’altra era la situazione in Italia […] Gli Italiani potevano dunque avere una cono-scenza intuitiva della nuova immagine che stava nascendo» (G. Deleuze, L’immagine-movimento, cit., p. 240).
96 H. Bergson, Sviluppo della verità. Movimento retrogrado del vero, in Pensiero e movimento, cit., p. 3.
97 Id., La posizione dei problemi, in Pensiero e movimento, cit., 23.
Capitolo II 74
all’intuizione della “mobilità originale”, la capacità di prendere posto nella “sostanzialità del mutamento”98. L’intuizione è una pedagogia del movimento e della sua temporalità. Intuire signi-fica per Bergson, come per Rossellini, assorbire dentro l’immagine la “fatica di attendere”:
Sappiamo bene, sin dai nostri anni di collegio, che la durata si misura attraverso la traiettoria di un mobile e che il tempo matematico è una linea […] La misura del tempo non riguarda mai la durata in quanto durata; viene contato soltanto un certo numero di estremità di interval-li o di momenti, vale a dire, in definitiva, di arresti virtuali del tempo […] Tra le estremità potrà accadere qualsiasi cosa: il tempo potrebbe accelerarsi enormemente e anche infinitamente, ma nulla cambierebbe per il matematico, per il fisico, per l’astronomo. La differenza sarebbe tuttavia profonda per ciò che riguarda la coscienza […] la fatica di at-tendere non avrebbe infatti lo stesso significato dall’oggi al domani, da un’ora all’ora seguente. Di questa attesa determinata e della sua causa esteriore la scienza non può tenere conto99.
Per Rossellini l’intervallo è un metodo e il metodo non rap-
presenta una struttura trascendentale. Pur senza essere “realisti-co” – cosa c’è di realistico nell’autoaffezione dello sforzo e dei tagli dell’intuizione della durata? – il suo cinema resta avvin-ghiato al mundus praesens, si sottrae al kantismo della durata. A queste condizioni il cinema di Rossellini è politico: intuire la durata significa infatti mostrare le conseguenze tecnologiche, sociali ed affettive della collocazione nell’universo dell’attesa. Alla falsa politicizzazione della cultura Rossellini risponde con una pedagogia dell’immagine. Ai falsi problemi artistici sosti-tuisce lo sforzo della visione. Perché la violenza è impazienza e all’Occidente “manca il tempo” per vivere e vedere100.
98 Id., La percezione del mutamento, in Pensiero e movimento, cit., 139. 99 Id., Sviluppo della verità. Movimento retrogrado del vero, cit., p. 5. 100 R. Rossellini, Intervista con i «Cahiers du cinéma», cit., p. 173.
Topologia del visibile 75
2. Lo spazio letterale
Chiunque avrà avuto modo di osserva-re quanto più facile sia cogliere un quadro, e più ancora una scultura o addirittura un’architettura, mediante la fotografia che non nella realtà. W. Benjamin, Piccola storia della fo-tografia
Sant’Ivo
Riprendendo un motivo filosofico condiviso con varietà di
accenti da autori come Malraux, Adorno e Blanchot, in un pa-ragrafo di Verità e metodo Gadamer indica nel museo la “sede esterna” della moderna coscienza estetica. Poiché espone in un’unità di luogo una produzione artistica decontestualizzata e destoricizzata, il museo provvede alla “concreta esistenza ester-na” della “differenziazione estetica”. Divenuto “sede della si-multaneità”, il moderno museo d’arte, “raccolta delle raccolte”, rompe i legami con la committenza e le collezioni delle antiche corti e si presenta come paradigma dell’autonomia della dimen-sione estetica. Nel museo, incarnazione del rapporto astratto tra contenuti di verità e fenomeni estetici, il visibile si offre con-temporaneamente allo sguardo del visitatore, «l’opera perde il suo posto e il mondo al quale appartiene»101. Il riordinamento storico delle opere nel museo sostiene così l’ideologia romanti-ca della libertà creativa dell’artista. All’apologia della purezza e specificità dell’esperienza estetica, Gadamer contrappone lo smascheramento dell’astrazione dell’“opera d’arte in sé”: l’occasione, l’esecuzione, il ruolo del fruitore entrano a far parte
101 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, trad. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 1983, p. 116.
Capitolo II 76
dell’essenza dell’arte, l’ontologia ermeneutica sacrifica la mito-logia dell’opera e il culto dell’artista.
Su questa linea, Vattimo rifiuta l’alternativa tra l’inautenticità della società dei consumi e il valore profetico della “grande arte”: l’ermeneutica deve confrontarsi con un’esteticità dissolta nella sfera economica e dell’informazione e riconoscere il perdurare del nesso di arte e religione, la dina-mica incompiuta di ogni secolarizzazione, la sopravvivenza di una mitologia estetica anche nella processione postmoderna dei simulacri102. Vattimo ci invita a riflettere sull’“esperienza di Sant’Ivo”, sulla peculiare sovrapposizione, in una chiesa come il Sant’Ivo alla Sapienza, della fruizione estetica dell’architettura del Borromini da parte degli abituali “turisti culturali” e dell’esperienza religiosa da parte dei fedeli raccolti in preghiera. A questo esempio Vattimo contrappone l’esperienza di un fedele in ginocchio davanti a una pala d’altare esposta in museo, tra lo stupore dei visitatori. Nel tenta-tivo di mantenere distinte la dimensione estetica e quella reli-giosa, a differenza dei musei d’arte che proibiscono la fruizione religiosa delle opere, le chiese praticano una difensiva “divisio-ne dei tempi” per i fedeli e i turisti, che induce a riflettere sull’attuale “superiorità” dell’atteggiamento estetico103.
In termini benjaminiani, il turista del Sant’Ivo è irretito dal valore espositivo dello spazio cultuale. Con il percepire esteti-camente anche l’architettura della chiesa, il turista si abbandona a un’esperienza che non necessita dell’apparato ideologico della museologia tradizionale, diviene egli stesso un centro di mu-seizzazione: come osserva incidentalmente Vattimo, il visitatore scambia per “figure da museo” i fedeli raccolti in preghiera: «anche i fedeli che pregano in Sant’Ivo alla Sapienza si vedono assegnato il loro posto come momenti o figure “da museo”, da rispettare accanto alle opere d’arte che continuano ad “utilizza-re” per un fine “non proprio”, non puramente estetico e dunque
102 G. Vattimo, Oltre l’interpretazione. Il significato dell’ermeneutica per la filoso-
fia, Laterza, Roma-Bari 1994. 103 Ivi, p. 75.
Topologia del visibile 77
estraneo alla dimensione a cui, invece, esse specificamente ap-partengono»104.
Il carattere estetico dello spazio postmoderno, di cui sono agenti inconsapevoli i visitatori delle chiese e dei musei, non coincide perciò con la coscienza estetica gadameriana. Tramon-tata è la legittimità di un’esteticità delle opere d’arte, di una sfe-ra artistica autonoma e protetta, che trova nel museo un argine alla mercificazione. Di contro, la musealità postmoderna rivela modalità di fruizione in balia dell’autonomizzazione del valore espositivo, il cui risvolto oggettivo è sancito dalla spettacolariz-zazione dell’architettura dei musei. E tuttavia, come interpretare la proliferazione di musei identitari, contenutistici e site-specific, il cui tratto postmoderno è rappresentato dal ripiega-mento sui nuovi “soggetti estetici collettivi”, dal ripudio di ogni mediazione formale e disciplinare, dall’esplosione di rivendica-zioni sociali e di fondazioni territoriali105? Come spiegare la convivenza di neo-etnicizzazione e derealizzazione visiva, il contemporaneo dominio dell’identità e dell’immagine, la molti-plicazioni di spazi espositivi simulacrali (gli imponenti musei d’arte contemporanea su cui converge il turismo culturale inter-nazionale) e di cellule museali localizzate e cariche di funzioni sociali, strumenti dello sviluppo partecipato, “zone di contatto” (J. Clifford) dei nuovi soggetti collettivi (ecomusei e musei a-perti in Europa, musei post-coloniali)? Che ne è del carattere e-stetico dell’arte quando la musealità diviene l’avamposto dei processi di identificazione e del turismo di massa, dell’esplorazione riflessiva dei presupposti ideologici del mer-cato dell’arte e del consumo visivo? 106
104 Ibidem 105 Cfr. G. Vattimo, Il museo postmoderno, «Rivista di Estetica», n. 37, 1991, pp. 3-
11. 106 L’intersezione di etnografia e estetizzazione segna l’emergere di una nuovo figu-
ra di artista critico. Sempre più l’«artista-etnografo» (Hal Foster) produce “opere-museo”, non “opere-mondo” avulse dai processi sociali di comunicazione. Nonostante il valore di mercato dell’arte critica continui ad aumentare e dilaghi l’aura dell’autenticità e della creatività individuale, quest’arte si attribuisce il compito di decostruire la propria artisticità, interrogando l’ideologia estetica dei contesti espositivi. Sulla scia di Marcel Duchamp, Marcel Broodthaers e Joseph Beuys, artisti come Hans Haacke, Daniel Bu-
Capitolo II 78
San Zaccaria A partire dal 1989, il fotografo tedesco Thomas Struth ha ri-
tratto in fotografie di grandi dimensioni – le Museum Photo-graphs – gruppi di turisti in visita presso chiese e musei europei e americani (fig. 1):
La fotografia scattata nella chiesa di San Zaccaria nel 1995 esemplifi-ca la ricerca di Struth. In un’unica composizione Struth incorpora una tipologia virtuale di modi di vedere. Molti visitatori, seduti sui banchi della chiesa da soli o a gruppi, sembrano guardare in direzione di un altare. Un giovane uomo in primo piano contempla davanti a sé con particolare concentrazione. Altri visitatori si guardano intorno o scru-tano all’insù verso la volta. C’è una coppia che osserva la grande Ma-donna col bambino di Bellini. L’autore di questa descrizione prosegue con un’osservazione
di risonanza ermeneutica: Probabilmente, come molte delle persone sedute, sono dei turisti, ma non è possibile essere sicuri. Alcuni dei visitatori della chiesa potreb-bero allo stesso modo essere venuti per pregare. Si prova la sensazione che le persone nella fotografia siano dei credenti, sebbene non sia dato di sapere in cosa essi credano: forse nel valore della cultura, o nel po-tere dell’immagine, o soltanto nella possibilità di credere in un’epoca secolarizzata107. La fotografia di San Zaccaria sancisce la sovrapposizione di
fruizione religiosa ed estetica, nonché la superiorità della di-mensione estetica rilevata dall’“esperienza di Sant’Ivo”. Una superiorità che, attraverso il mezzo della fotografia, stravolge la
ren, Lothar Baumgarten e Louise Lawler scorgono nel trionfo della museificazione una chance emancipativa, la possibilità di rivolgere il museo contro se stesso: «Questi svi-luppi [la genealogia minimalista dell’arte contemporanea e l’imporsi dei cultural stu-dies, N.d.A.] costituiscono una serie di spostamenti nella localizzazione dell’arte: dalla superficie del medium allo spazio del museo, dagli ambiti istituzionali alle relazioni di-scorsive» (H. Foster, The Artist as Ethnographer, in The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century, MIT Press, Cambridge, Mass. 1999, p. 184).
107 J. Lingwood, Composure [or On Being Still], in T. Struth, Still, The Monacelli Press, New York 2001, p. 120.
Topologia del visibile 79
distinzione tra gli elementi dell’immagine: in qualità di spetta-tori delle fotografie di Struth, contempliamo i fedeli, i turisti e i protagonisti del capolavoro del Bellini come se appartenessero ad un unico complesso estetico, ad un peculiare genere di rap-presentazione visiva. Come testimonia la corrispondenza tra la composizione dei dipinti e l’involontaria disposizione dei turisti nel museo, il contenuto delle Museum Photographs di Struth ri-siede nell’unità dell’esperienza museale postmoderna. Neutra-lizzando la specificità dei mezzi espressivi della pittura e dell’architettura, il medium fotografico coglie il nuovo soggetto estetico collettivo, il complesso museo-spettatori. Le Museum Photographs esibiscono la specifica condizione postmoderna dell’esperienza museale, che potremmo definire “museificazio-ne spontanea”: così come noi spettatori delle fotografie valu-tiamo esteticamente, a fianco dei dipinti, l’architettura e i fre-quentatori dei musei, lo sguardo del visitatore del Sant’Ivo tra-muta in figure da museo i fedeli raccolti in preghiera. La musei-ficazione spontanea segnala il travaso delle tematiche museolo-giche – e con esse il museo moderno, paradigma della coscienza estetica – in una più generale possibilità di allestimento spaziale dell’esperienza estetica. Benché ridotta a immagine (le Museum Photographs), a involucro (gli enormi musei postmoderni) o a simulazione (i musei aperti e virtuali), l’attuale costellazione espositiva ripropone «la seria e interminabile questione del Mu-seo»108.
In quanto zona di contatto tra i presupposti dell’arte e le ri-chieste della società, il museo è soggetto a una continua ridefi-nizione. Se le collezioni principesche del Rinascimento, i salon e i musei pubblici dell’Ottocento accolgono la dimensione mondana dell’arte, ponendosi da intermediari tra le opere e il pubblico, mediando tra la pura apparenza estetica dell’arte e le sue condizioni di esposizione, con l’ingresso nella tarda moder-nità gli “operatori culturali” scorgono nell’attraente gigantismo architettonico dei musei postmoderni potenzialità inespresse di controllo sociale. Baudrillard definisce “effetto Beaubourg” la
108 J. Derrida, Artaud le Moma, «Rivista di Estetica», n.s. 3, 1996.
Capitolo II 80
produzione estetica della socialità, una caratteristica della socie-tà postindustriale: il museo postmoderno, potente catalizzatore delle ambizioni culturali del pubblico, ribalta la serialità della produzione nell’estetica della concentrazione museale. Il “buco nero” del museo “produce le masse”, le trasforma nel contenuto stesso del museo:
Francamente, gli unici contenuti del Beaubourg sono le masse stesse, che l’edificio tratta come convertitori, scatole nere, o in termini di in-put/output, così come una raffineria tratta i prodotti petroliferi o un flusso di materiale grezzo […] Ben al di là delle istituzioni tradizionali del capitale, l’ipermercato, o il Beaubourg “ipermercato della cultura”, rappresenta già il modello di tutte le forme di “socializzazione” con-trollata109. L’“effetto Beaubourg” fa suo il presupposto soggettivo della
museificazione spontanea: se i fedeli di Sant’Ivo diventano del-le “figure da museo”, le sagome imponenti dei musei postmo-derni irretiscono i turisti culturali allettandoli come icone dell’esteticità. Il risultato è l’emergere di un contenuto che mai prima d’ora aveva assorbito la missione di questa istituzione, il museo stesso:
il design e il mostrare al servizio dell’esposizione e dei valori di scam-bio sono al centro dell’attenzione quanto mai prima d’ora: oggi ciò che il museo esibisce più di ogni altra cosa è il suo proprio spettacolo – questo è il motivo principale di attrazione e l’oggetto principale di riverenza110. Col rappresentare unitariamente il complesso museo-turisti,
le Museum Photographs ritraggono (in senso letterale, tornere-mo in seguito sull’essenza ritrattistica di queste fotografie) la confluenza tra l’estetizzazione della vita sociale e la socializza-zione delle qualità estetiche dell’arte. Accolte dalle principali i-stituzioni museali, le fotografie di Struth celebrano la trasfor-
109 J. Baudrillard, L’effetto Beaubourg, in Simulacri e impostura, bestie, Beaubourg,
apparenze e altri oggetti, Cappelli, Bologna 1980. 110 H. Foster, Archives of Modern Art, «October», n. 99, 2002, p. 95.
Topologia del visibile 81
mazione del museo in un soggetto per l’arte. Si tratta di un e-vento decisivo, favorito dall’autoriflessività dell’arte moderna. Prendiamo atto che la dialettica di soggettività e oggettività se-gnalata da Gehlen – più l’arte è autonoma più dipende dalle isti-tuzioni, più è soggettiva più dipende da condizioni oggettive a lei inaccessibili – ha perso di rilevanza. Le Museum Photo-graphs mostrano un nuovo soggetto dell’esperienza estetica, il “soggetto estetico collettivo” teorizzato da Vattimo: esso tutta-via non coincide né con il corpo sociale né con il linguaggio formale dell’arte, bensì con il convergere di arte e società nella loro paralisi museale. Il complesso visitatori-arte-museo raffi-gurato dalle Museum Photographs è il risultato di questo corto-circuito. All’insegna della museificazione spontanea, l’estetizzazione dei rapporti sociali si ribalta nell’esteriorizzazione dell’arte. Fattosi ora accessibile, benché attraverso modalità estranee a quelle della tradizione, il risvolto mondano dell’arte ridisegna le priorità e i contenuti dei feno-meni estetici.
Questa musealità debordante, che ingloba le opere d’arte, gli spazi espositivi e gli spettatori, sembra rispondere a due esigen-ze specifiche: da un lato sono i turisti in visita a Sant’Ivo e gli spettatori delle Museum Photographs a non poter fare a meno di percepire come "opera d’arte" il museo (o la chiesa); dall’altro, sono la chiesa stessa (tramite l’artificio della divisione dei tem-pi) e il museo (con la sua auto-rappresentazione in immagini esposte al suo interno) a presentarsi come oggetti di godimento estetico. È necessario perciò comprendere più a fondo l’intreccio di museificazione ed estetizzazione in gioco nella museificazione spontanea: mentre la “differenziazione estetica” stigmatizzata da Gadamer trovava ancora nel museo una corri-spondenza esterna, e per questo separata dalle facoltà cognitive del fruitore, la museificazione spontanea si dispiega a partire dalla costituzione dei soggetti.
Figure della museificazione spontanea
A ben vedere, quanto detto sinora è in accordo con le descri-
Capitolo II 82
zioni della spazialità postmoderna. Secondo Fredric Jameson, la “logica culturale” del postmodernismo è guidata dall’egemonia delle relazioni spaziali, che neutralizzano l’efficacia del pensie-ro utopico e la politica estetica delle avanguardie storiche111. L’“iperspazio” postmoderno è contraddistinto da una disgiun-zione tra il corpo umano e l’ambiente costruito, a cui si accom-pagna una dissociazione tra la percezione individuale e la spet-tacolarizzazione degli edifici112. Sopraffatti da questa “aliena-zione tecnologica”113, i turisti esperiscono una modalità po-stmoderna del sublime kantiano, il “sublime isterico”: nel men-tre vengono atterriti e confusi dalle immense architetture progettate dalla rete comunicativa decentrata del tardo capitalismo, i soggetti godono per l’“esilarante esperienza” della derealizzazione, per l’intensità della decostruzione dell’umanità degli spazi114.
Le pratiche espositive dell’arte contemporanea sono un e-sempio privilegiato della riconfigurazione postmoderna delle coordinate spaziali: gli allestimenti di Nam June Paik e di Ro-bert Gober annunciano la sublimità dell’alienazione tecnologi-ca, utilizzando come medium lo spazio della galleria e i corpi in movimento degli spettatori. È questa una esteriorizzazione radi-cale, che si lascia alle spalle anche la mortificazione rituale dell’esteticità praticata dalle avanguardie storiche in funzione emancipativa.
Rosalinde Krauss ha richiamato la matrice artistica di questa sensibilità spaziale. Il “sublime isterico” jamesoniano ripropone la formulazione minimalista del ruolo dello spettatore e della natura dell’opera d’arte. Per i teorici del minimalismo, il soggetto e l’oggetto dell’esperienza estetica non si fronteggiano come altrettante entità fisse e complete, ma risultano differen-zialmente nel corso del loro incontro, che avviene sotto il segno di una spazialità inclusiva, lo “spazio totale” di Robert Morris:
111 F. Jameson, Il Postmoderno: o la logica culturale del tardo capitalismo, trad. it.
di S. Velotti, Garzanti, Milano 1989. 112 Ivi, pp. 43-4. 113 Ivi, p. 45. 114 Ivi, p. 34.
Topologia del visibile 83
Come lo stesso Morris ha scritto nelle sue Note sulla scultura, l’ambizione del Minimalismo fu quella di abbandonare il dominio di ciò che egli chiamava “relazioni estetiche” per portare le relazioni al di fuori dell’opera per renderle funzionali allo spazio, alla luce, al campo visivo dell’osservatore115.
Il soggetto dell’esperienza estetica diviene perciò un prodot-
to contingente, esposto alle determinazioni ambientali, e pertan-to in equilibrio precario tra le richieste del «mondo decaduto della cultura di massa» e l’utopia del superamento delle modali-tà visive di ricezione della pittura116.
Robert Morris contrappone la vocazione “intimista” dell’arte moderna a quella pubblica della nuova arte: il formato monu-mentale delle sculture minimaliste obbliga il fruitore a prendere atto della loro esistenza in uno “spazio letterale”, a non privile-giare i dettagli dell’opera sulla sua collocazione in rapporto al corpo sovrastato dello spettatore117. All’attenzione visiva per la superficie, il colore e il materiale dell’opera intimista (pittura o scultura), per la quale è come se “lo spazio non esistesse”, si so-stituiscono le continue variazioni percettive di un oggetto espe-rito da uno spettatore in movimento nell’ambiente: «L’oggetto stesso non è divenuto meno importante. Soltanto è divenuto meno importante in se stesso»118. Ciò che conta ora è la sua col-locazione nello “spazio totale”. E poiché a sua volta lo “spazio totale” è generato dall’incontro tra l’oggetto e il soggetto dell’esperienza estetica, esso presuppone da parte dello spettato-re una consapevolezza senza precedenti «di esistere nello stesso spazio dell’opera»119.
Le pagine di Vattimo sull’“esperienza di Sant’Ivo” e le Mu-seum Photographs di Struth sanciscono il tramonto del museo
115 R. Krauss, The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum, «October», 1990,
n. 54, p. 12. 116 Ivi, p. 10. 117 R. Morris, Notes on Sculpture, in (a cura di) G. Battcock, Minimal Art. A Criti-
cal Anthology, Dutton, New York 1968, p. 231. 118 Ivi, p. 234. 119 Ivi, p. 232.
Capitolo II 84
come “sede esterna” della coscienza estetica. Ciò che avvince nelle fotografie di Struth è l’eguale rilevanza compositiva che assumono i capolavori dell’arte moderna e i turisti che “esistono nel loro stesso spazio”: le circostanze di fruizione dell’arte si ri-baltano nel contenuto artistico, l’esteriorizzazione del carattere di fait social delle opere è qui ritratto come una relazione ester-na alle opere, la relazione tra gli spettatori e i dipinti. Poiché la spazialità postmoderna ha colonizzato la forma dell’esperienza espositiva, queste relazioni formano una totalità, afferrata rifles-sivamente dalle Museum Photographs. La spazialità museale postmoderna non prescrive l’immersione nell’opera: come mo-strano le fotografie di Struth, la forma postmoderna delle rela-zioni insorge là dove lo spazio totale dell’esperienza museale presuppone la dissociazione tra l’arte e i suoi fruitori. Il com-plesso museo-spettatori, il nuovo “soggetto estetico collettivo” dell’esteticità postmoderna, è sì il contenuto rappresentativo delle Museum Photographs, ma a patto di interpretarlo come esperienza dell’incommensurabilità di arte (del passato) e frui-zione (attuale). Per questa ragione le Museum Photographs so-no occupate dai dettagli extra-artistici degli spazi museali: i vi-sitatori e le opere recedono di fronte alla vastità delle pareti, all’intralcio dei cordoni che proteggono i dipinti, alla ridondan-za delle cornici, agli apparati che sostengono i dipinti, ai motivi del pavimento e alla processione delle panche, alle mancate su-ture delle tappezzerie.
Poiché lo spazio museale postmoderno è uno spazio “lettera-le”, in cui gli attori dell’esperienza estetica e gli oggetti artistici fanno esperienza della loro incommensurabilità, i dettagli archi-tettonici hanno la meglio sulla relazione immediata tra i visita-tori e le opere. Il museo contiene i turisti e i dipinti nella mate-rialità del suo frapporsi tra gli sguardi reali e gli sguardi dipinti, tra i corpi reali e quelli rappresentati. Non appena ci soffermia-mo sugli interni dei musei rappresentati nelle Museum Photo-graphs ci accorgiamo che lo spazio museale rappresenta la sce-na di un mancato dialogo tra i turisti e le opere, il luogo della dissociazione della tradizione storico-artistica in una asintotica divergenza di mutismo dell’arte del passato e di ricezione turi-
Topologia del visibile 85
stica. Le Museum Photographs permettono di cogliere l’essenziale
estraneità dell’arte e dei turisti al museo, una condizione preclu-sa ai visitatori del Louvre, della chiesa di San Zaccaria o della Galleria dell’Accademia. Mentre noi vediamo sia i turisti che il museo, i turisti non si accorgono del dominio del museo. Un tema ricorrente delle fotografie di Struth è il silenzioso dispoti-smo dello spazio sull’arte e sui corpi. Anche le tele più impo-nenti, come quelle di David e di Veronese al Louvre, non risol-vono l’incombere delle pareti, dei supporti e degli arredi. Quan-to ai visitatori, essi si aggirano intimiditi in uno spazio inabita-bile. La varietà dei loro comportamenti, il loro raggrupparsi im-paurito intorno alle guide, gli sguardi rivolti all’esterno del campo visivo, le pause di distrazione, rimandano allo spaesa-mento provocato dall’architettura museale.
La museificazione spontanea intacca anche i santuari dell’esteticità modernista – il Louvre, la National Gallery, il Museum of Modern Art – nei quali Struth ritrova il gigantismo, l’inassimilabilità e l’impenetrabile materialità della spazialità postmoderna. Muovendosi in ambienti che è incapace di affer-rare, e che tuttavia condivide con le opere, il turista culturale produce la spazialità postmoderna, dà forma all’“allarmante di-sgiunzione” tra il corpo umano e l’architettura. Nell’epoca dell’estetizzazione postmoderna, l’ideologia museale colonizza anche lo spazio urbano: emancipandosi dalla sudditanza alle opere, il museo trionfa nel suo presentarsi come intralcio tra le capacità di comprensione del turista culturale e l’oggettualità dell’opera.
Spettatori del ritratto
La musealità postmoderna ripropone, in forma aggravata,
una difficoltà segnalata da Walter Benjamin: con l’avvento di un pubblico di massa dedito alla fruizione simultanea dell’arte attraverso il cinema e la fotografia, la ricezione della pittura su-bisce “una grave limitazione” che l’istituzione museale non è in grado né di occultare né di risolvere:
Capitolo II 86
Il fatto è appunto questo, che la pittura non è in grado di proporre l’oggetto alla ricezione collettiva simultanea […] Nelle chiese e nei chiostri del Medioevo e alle corti principesche fin verso la fine del se-colo XVIII, la ricezione collettiva di dipinti non avveniva simultane-amente, bensì mediatamente, secondo una complessa gradualità e se-condo una gerarchia. Se questa situazione si è trasformata, in tale mu-tamento si esprime il particolare conflitto in cui la pittura è stata coin-volta attraverso la riproducibilità tecnica del quadro. Ma benché si cercasse di portarla di fronte alle masse, mediante le gallerie e i salon, non esisteva una via lungo la quale le masse potessero organizzare e controllare se stesse in vista di una simile ricezione120. Benjamin colloca la fotografia là dove la difficile coabita-
zione del museo e della pittura raggiunge una soglia critica sot-to l’effetto del turismo culturale. Nel caso delle Museum Photo-graphs, «il particolare conflitto in cui la pittura è stata coinvolta attraverso la riproducibilità tecnica del quadro» costituisce il nucleo generativo della resa fotografia del complesso museale. E tuttavia, per quale ragione, Struth mette in scena dei visitatori che riflettono mimeticamente l’arrangiamento spaziale, le po-sture e i colori dei dipinti?
Lasciamoci guidare dalle dichiarazioni del fotografo. Struth afferma di aver ideato la serie delle Museum Photographs in occasione delle sue visite al Louvre, dove aveva l’abitudine di recarsi per esaminare dei ritratti rinascimentali: «Ho avuto le prime idee al Louvre nel periodo di Natale; era molto affollato e ho pensato che il mondo dei visitatori del Louvre, persone dall’età e provenienza etnica più diversa, fosse incredibilmente simile ai temi dei dipinti»121. Da tempo impegnato nella ritratti-stica fotografica, Struth osserva i dipinti “come fossero fotogra-fie”, alla ricerca di soluzioni per i dilemmi compositivi del ri-tratto122. Grazie a questa circostanza – che non è estranea alla concezione dell’equivalenza “intellettuale” tra le tecniche arti-stiche, sostenuta da Struth in polemica con gli appelli greenber-
120 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Ei-
naudi, Torino 1991, p. 39. 121 T. Struth, Interview between Benjamin Buchloh and Thomas Struth, in T. Struth,
Thomas Struth, 1990, Marian Goodman Gallery, New York 1990, p. 39. 122 Ivi, p. 38.
Topologia del visibile 87
ghiani alla “specificità del medium” – si affaccia il progetto di una nuova variante del ritratto di gruppo. Nel museo, i visitatori e i personaggi delle tele corrispondono a due tipologie di sog-getti del ritratto: da un lato ritratti di contemporanei in carne ed ossa, dall’altro riproduzioni di ritratti dipinti. Una volta scattata la fotografia, il nuovo medium genera un campo di equivalenza, ridefinendo la qualità dell’esperienza dei visitatori tramite una relazione differenziale con le proprietà dei dipinti. Per Struth la fotografia è «per lo più un processo intellettuale di conoscen-za», un “medium comunicativo e analitico”, in grado di riattiva-re il dialogo tra realtà separate, come accade nello “scrivere un libro”123.
E tuttavia, è possibile ritrarre le figure dipinte e i loro spetta-tori nell’unità di una relazione significativa? Come può la foto-grafia rappresentare i turisti in un museo e al contempo propor-re all’osservatore un modello credibile di fruizione estetica? In un celebre studio del 1902 sulla ritrattistica olandese, Alois Riegl attribuisce la peculiarità del ritratto di gruppo alla sua di-pendenza da un doppio criterio di coerenza:
Dobbiamo solo paragonare i dipinti di Geertgen con qualsiasi esempio di un dipinto italiano dello stesso periodo per mostrare l’enorme diffe-renza di concezione tra i due: nel secondo caso le figure sono sempre subordinate all’interno dei loro sottogruppi, e questi, a loro volta, sono collegati all’azione principale. Nell’esempio del Nord, non c’è una connessione diretta tra l’azione e i partecipanti, ma piuttosto il più alto grado di coordinazione124. Riegl definisce “coerenza interna” il primo tipo di relazione
tra le figure dipinte, un’unità formale del dipinto ottenuta trami-te la “subordinazione” dei personaggi all’azione e in particolare al protagonista, nel mentre riserva l’espressione “coerenza e-sterna” alla «connessione tra lo spettatore e le figure dipinte nel
123 Ivi, p. 32. 124 A. Riegl, The Group Portraiture of Holland, trad. ingl. di E.M. Kain e D. Brit,
Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, Los Angeles 1999, p.78.
Capitolo II 88
quadro»125. Le due modalità sarebbero caratteristiche, rispetti-vamente, della pittura italiana e di quella nordica126. Riegl in-troduce inoltre una periodizzazione della ritrattistica di gruppo, a partire dalle relazioni che intrattengono i due generi di coe-renza. In particolare, saremmo debitori a Rembrandt della per-fetta compenetrazione di subordinazione e coordinazione, un ri-sultato raggiunto con il dipinto dei Sindaci dei drappieri (Am-sterdam, Rijkmuseum), la cui «concezione pittorica rappresenta in un certo senso il punto finale di evoluzione in Olanda»127.
L’analogia tra la disposizione dei turisti nel museo e i perso-naggi dei quadri – sostenuta dalle posture, dai rapporti reciproci tra i visitatori, dalla scelta dei colori e, talvolta, dalla involonta-ria riproduzione da parte dei turisti della collocazione spaziale dei dipinti sulle pareti – conferisce alle Museum Photographs la necessaria coerenza estetica: un unico soggetto, un’unica azione contraddistinguono le figure dipinte e i loro spettatori. Struth at-tende con pazienza finché la coincidenza delle azioni trasforma il museo in una immagine autosufficiente. La percezione po-stmoderna del museo s’imprime sulla struttura dell’immagine
125 Ivi, p. 253. 126 Riegl associa la ricerca della coerenza interna del dipinto al ruolo svolto
dall’azione e dalla volontà nella concezione pittorica italiana: «Durante tutto il quattro-cento, gli artisti italiani furono interessati alla risoluzione del problema del rappresenta-re il corpo umano in maniera che tutte le sue parti si muovano in risposta a un singolo atto della volontà, così come al raffigurare delle figure in una scena narrativa in cui sembrino partecipare tutte a una singola azione» (A. Riegl, The Group Portraiture of Holland, cit. p. 77). Di contro a questa subordinazione alla volontà del protagonista da parte dei personaggi dell’azione, la pittura del Nord mira al singolo nel suo isolamento dal gruppo, al cui interno verrà coordinato a partire da una rinnovata complicità con lo spettatore. Degli uomini ritratti si sottolinea così la pura attenzione, la loro autonomia di individui e la capacità di mettersi in relazione con lo spettatore del dipinto senza la me-diazione di un principio narrativo interno. A queste due modalità di rappresentazione Riegl associa due tipologie spaziali: da un lato lo spazio “cubico” della prospettiva line-are, “proprietà dei corpi solidi”, il cui contrassegno è la tridimensionalità, dall’altro lo «spazio libero tra le figure», uno spazio al cui interno le figure «sembrano più libere e più varie» (ivi, p. 82). Emancipatisi dal nobile eroismo dei corpi ritratti dagli artisti ita-liani, gli uomini dipinti dagli artisti del Nord riscattano la goffaggine e arbitrarietà dei gesti, che sembrano “congelati a mezz’aria”, tramite «un profondo stato di attenzione»: «i loro occhi sono rivolti all’interno, e riflettono il mondo esterno come uno specchio» (ivi, p. 78).
127 Ivi, pp. 285-6.
Topologia del visibile 89
fotografica. Ciò nonostante, quanto detto sinora non rende conto di un
tratto essenziale delle Museum Photographs, l’appello allo spet-tatore a cui è affidato l’impatto visivo delle fotografie di Struth. Prendiamo il caso della riproduzione della sala del Louvre che contiene la Zattera della Medusa di Géricault (fig. 2). A risalta-re è qui, in primo luogo, l’allineamento diagonale dei corpi di-pinti, che duplica la disposizione degli spettatori nel museo. In questo modo si avvia con spontaneità una comparazione tra i due livelli, la cui somiglianza è confermata da dettagli composi-tivi quali il rosso della maglia di una turista, in asse con un mantello dipinto dello stesso colore, o la postura del braccio di un visitatore, che richiama quella scelta da Géricault: «mentre noi stessi guardiamo le fotografie, così come gli altri guardano i dipinti, un’analogia sorge tra i due media che qui, in linea di principio, condividono un’unica collocazione: il museo»128. Un’analogia che scuote le abitudini percettive dello spettatore delle Museum Photographs, esponendolo alla sensazione di os-servare e di venire osservato, a causa dell’identificazione con i turisti. E tuttavia, malgrado il predominio di questa “follia im-plosiva” fondata sull’artificio della duplicazione estetica della musealità, non assistiamo qui a «un reale che s’involve in se stesso fino all’estenuazione»129, bensì a una rinnovata visibilità dei dipinti, a conferma dell’intuizione benjaminiana secondo cui è più facile cogliere un quadro «mediante la fotografia che non nella realtà». Per una ragione che dobbiamo ancora chiari-re, la visione en abyme riattiva la «connessione tra lo spettatore e le figure dipinte nel quadro» (Riegl), esaltando la coerenza e-sterna richiesta dal ritratto di gruppo:
Ciò che volevo ottenere con questa serie […] è una presa di posizione sul processo originale di rappresentare delle persone, che conduce al mio atto di creare una nuova immagine, il che è in un certo modo un
128 H. Belting, Photography and Painting: Thomas Struth’s Museum Photographs,
in Thomas Struth, Portraits, Schirmer/Mosel, Munich 1998, p. 13. 129 J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, trad. it. di G. Mancuso, Feltri-
nelli, Milano 1992, pp. 86-87.
Capitolo II 90
meccanismo molto simile: lo spettatore delle opere viste nella fotogra-fia è un elemento che si trova collocato in uno spazio al quale anch’io appartengo quando sto di fronte alla fotografia. Le fotografie illumi-nano la connessione e dovrebbero distogliere gli spettatori dal consi-derare le opere come dei meri feticci, e iniziare la loro comprensione o intervento nelle relazioni storiche130. Soffermiamoci su questa complessa dichiarazione di Struth.
Le Museum Photographs si rivolgono direttamente allo spetta-tore (esterno), lo chiamano in causa ricordandogli di appartene-re al medesimo spazio dello «spettatore delle opere viste nella fotografia». La “connessione” tra i due spazi influenza la perce-zione del quadro fotografato: una volta assorbito dalla fotogra-fia e posto a fianco dei visitatori riprodotti, lo spettatore (ester-no) si confonde con gli spettatori (interni). L’essere-nel-museo di fronte alle fotografie di Struth significa essere-nel-museo come soggetto delle Museum Photographs, un cortocircuito che ricodifica, senza sospenderla, l’esperienza della museificazione spontanea e il rapporto feticistico con gli oggetti del museo. Il soggetto dell’esperienza estetica, duplicato tematicamente in uno spettatore esterno e in uno interno, sperimenta l’ambiguità del proprio ruolo e inizia la «comprensione o intervento nelle relazioni storiche».
Resta da comprendere la prima affermazione di Struth: per quale ragione la connessione tra i due spazi e i due tipi di spettatori, in cui consiste «il processo originale di rappresentare delle persone», dovrebbe condurre all’«atto di creare una nuova immagine»? Mentre nel primo caso si tratta di una relazione in-terna alla ricezione della fotografia, nel secondo è in gioco un rapporto che nasce dalla produzione dell’immagine, dalle tecni-che di ripresa fotografica.
La procedura ritrattistica seguita con scrupolosa metodicità da Struth si attiene al principio di sottoporre la produzione di una nuova immagine a un’esperienza condivisa dal fotografo e dall’individuo fotografato. Preoccupato di non sottrarre il mo-nopolio della rappresentazione al proprio modello, il fotografo
130 T. Struth, Interview between Benjamin Buchloh and Thomas Struth, cit., p. 39.
Topologia del visibile 91
elabora un complesso rituale: l’immagine non deve scaturire dal contatto mistico con il soggetto, ma sedimentarsi in una concre-zione visibile di azioni e riflessioni condivise. Di questo rituale fanno parte i lunghi colloqui con i modelli, la scelta di rappre-sentarli nei loro ambienti domestici e la successiva cooperazio-ne nella selezione degli scatti migliori131. A differenza del pitto-re, che ricrea la realtà a partire dalla propria soggettività, Struth si pone a fianco dell’apparecchiatura fotografica, affidando al soggetto ritratto il compito di specchiarsi nella macchina. An-che se il modello non vede se stesso, egli è consapevole che l’immagine coglierà il suo atteggiamento al cospetto dell’obiettivo132. Ogni ritratto di Struth equivale perciò a un au-toritratto133.
Inoltre, i lunghi tempi d’esposizione prediletti da Struth im-pongono ai soggetti una “immobilità volontaria”, che li espone allo scorrere del tempo e alla discontinuità introdotta dallo scat-to. Lo spettatore, il fotografo e l’individuo ritratto assistono con parità di diritto a questo avvenimento, che preclude il voyeuri-smo dell’istantanea e la sottrazione dell’immagine allo scorrere del tempo. Grazie a questi stratagemmi, la tecnica ritrattistica
131 Se dal ritratto si sottrae il processo tecnico di riproduzione, privilegiando un
«aumento d’essere» riferito al modo di apparire «dell’originale», il modello di cui si suppone l’aumento d’essere viene paradossalmente escluso dal rapporto con l’immagine di se stesso: «I giudici adeguati di un ritratto non sono mai le persone vicine al raffigu-rato o addirittura il raffigurato stesso» (H.G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p.184).
132 T. Struth, Interview between Benjamin Buchloh and Thomas Struth, cit. p. 30 133 «Il senso di disagio dell’interprete di fronte all’apparecchiatura, così come viene
descritto da Pirandello, è in se della stessa specie del senso di disagio dell’uomo di fron-te alla sua immagine nello specchio. Ora, l’immagine speculare può essere staccata da lui, è diventata trasportabile. Dove viene trasportata? Davanti al pubblico» (W. Benja-min, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., p. 34). All’incompletezza dello specchiarsi del soggetto nell’ideale della propria immagine, come avviene nella situazione del ritratto fotografico, dobbiamo la ricchezza del genere. È l’irrisolta tensione tra la riflessione del modello nell’obiettivo e l’invisibilità immedia-ta del risultato di questo atto a garantire l’autonomia formale del ritratto. Benché la per-sona ritratta sia rivolta all’obiettivo, e quindi interpelli direttamente lo spettatore, la coe-renza esterna non prende il sopravvento sulla significatività dell’immagine. Poiché nell’atto di ritrarsi il modello interroga la propria immagine nello specchio “trasparente” dell’apparecchiatura fotografica, senza tuttavia che gli sia concesso di vederlo, lo spetta-tore ha la corretta impressione che il soggetto ritratto non si rivolga allo spettatore bensì a se stesso, alla propria identità non rappresentata.
Capitolo II 92
dissolve l’illusione che la fotografia sia fondata sulla composi-zione, un atto di pertinenza del medium fotografico, rivendi-cando invece la correlazione del fotografo e del fotografato. Tramite un “meccanismo molto simile”, lo spettatore esterno e quello interno sono costretti ad interagire, dopo che la trama delle Museum Photographs li ha assegnati alla spazialità inglo-bante del museo.
Le Museum Photographs prolungano dunque l’estetica del ritratto elaborata da Struth, con una significativa distinzione: mentre nei ritratti domestici i soggetti si specchiano nell’obiettivo, che li sottopone al “test” della ripresa fotografica e alla valutazione dello spettatore, i visitatori delle Museum Photographs si riflettono nelle tele dei musei. L’assorbimento inconsapevole dei turisti nelle sagome dei dipinti sostiene la co-erenza interna della fotografia mentre la distrazione, lo scosta-mento dalla fruizione contemplativa, gli sguardi dei turisti verso l’esterno dell’immagine, in direzione della presenza non vista di altri quadri e, più in generale, di una porzione di spazio museale non riprodotto e abitato anche dallo spettatore delle Museum Photographs attiva – “inizia” secondo Struth – il meccanismo di «connessione tra lo spettatore e le figure dipinte nel quadro». Riabilitando le tecniche sperimentate dal ritratto di gruppo pit-torico nel corso della sua storia, Struth si rivolge allo spettatore esterno. Come i personaggi dei ritratti di gruppo olandesi intenti a fissare lo spettatore, col rischio di porre a repentaglio l’autosufficienza dell’immagine, il bambino del Louvre fotogra-fato da Struth insieme a una comitiva scolastica raccolta sotto l’imponente tela del Veronese, distoglie l’attenzione dal gesti-colare della guida e, voltandosi verso la macchina fotografica, stabilisce un contatto diretto con lo spettatore (fig. 3).
Più di frequente, i turisti delle Museum Photographs avver-tono confusamente lo spazio circostante, lo occupano con un di-sordine non armonizzabile, che isola le une dalle altre le varie figure: «I loro sguardi sono sparsi in tutte le direzioni e sono differenziati con tale arte che è impossibile determinare con e-
Topologia del visibile 93
sattezza a cosa siano intente le figure»134(fig. 4). Altre volte an-cora, i visitatori sono attirati da una “presenza non vista”135, da un personaggio non rappresentato che completa il contenuto narrativo della scena e giustifica il divergere degli sguardi ritrat-ti dal contenuto visibile della fotografia. Ad esempio, come se-gnala Belting, nella fotografia che ritrae una folla in visita alla Galleria dell’Accademia di Venezia di fronte alla Cena in casa di Levi del Veronese, i passanti in primo piano contemplano un Martirio di San Marco del Tintoretto lasciato fuori campo dall’inquadratura di Struth136.
Malgrado questo ricorso alle tecniche narrative della pittura, la coerenza esterna delle Museum Photographs non si adagia sul repertorio degli artifici stilistici: essa è la conseguenza dell’impossibilità di risolvere la coerenza interna nei confini delle leggi di composizione. Ciò che distingue la ritrattistica pit-torica da quella fotografica è l’incapacità da parte della fotogra-fia di contenere entro una totalità intenzionale la risonanza di uno scatto. Accade così che lo spettatore venga investito da una responsabilità pressante e che alle sue virtù interpretative sia af-fidata la decifrazione della fotografia:
A differenza del ritratto dipinto, che ha già operato la propria selezio-ne del campo visuale, eliminando le caratteristiche e i dettagli che non si accordano con le finalità dell’autore, la fotografia d’archivio esiste come un’entità predeterminata, preorganizzata, dalla quale l’interprete deve selezionare post facto le caratteristiche considerate rilevanti o si-gnificative137.
L’effetto ricercato da Struth, il divenire lo «spettatore delle
opere viste nella fotografia» un elemento «collocato in uno spa-zio al quale anch’io appartengo quando sto di fronte alla foto-grafia», poggia sopra un’articolata connessione tra gli spettatori interni ed esterni, che eccede la mera identificazione tematica
134 A. Riegl, The Group Portraiture of Holland, cit. p. 79. 135 Ivi, p. 285. 136 H. Belting, Photography and Painting, cit. p. 21. 137 N. Bryson, Thomas Struth's Nescient Portraiture, in Thomas Struth, Portraits,
cit.
Capitolo II 94
descritta in precedenza. Le varie forme della coerenza esterna, alle quali dobbiamo la correlazione tra i contenuti delle fotogra-fie e il museo, presuppongono, come avviene nella ritrattistica di Struth, l’inscrizione dell’«atto di creare una nuova immagi-ne» nell’esperienza museale. L’equilibrio tra le due modalità della coerenza, da cui deriva la complessità estetica delle Mu-seum Photographs, travalica le leggi stilistiche individuate dalla critica formalista e s’innesta sui presupposti tecnici della crea-zione di un ritratto fotografico.
La centralità della coerenza esterna, il tratto distintivo delle Museum Photographs, non innesca un meccanismo narrativo, ma traduce in contenuto estetico l’esperienza museale. La di-strazione dei visitatori del museo esclude un contenuto simboli-co e segnala il dato storico della
distanza incolmabile che separa la pittura dallo spettatore, il passato dal presente: una distanza che cresce quando si mettono in relazione le persone nei dipinti con quelle in piedi di fronte ad essi. Più si cerca di paragonarle, meno ci si riesce – non importa quanto esse siano in ar-monia con i dipinti138. Poiché la fotografia – almeno nella sua declinazione pre-
digitale – è un “medium dell’immediatezza”139, il suo realismo diverge dalla lontananza auratica della pittura. E quando nei ri-tratti fotografici è custodita la mediazione tecnologica dell’obiettivo, la fruizione conserva e prolunga l’eteronomia dell’immagine, il suo legame con l’occasionalità della situazio-ne di ripresa. Chiamati da Struth ad assumere il punto di vista del fotografo nel museo – lo stesso occupato dallo spettatore delle Museum Photographs – veniamo precipitati nel sito dell’inautenticità dell’immagine. La doppia eteronomia delle Museum Photographs – lo scatto del fotografo prende parte all’esperienza inautentica della museificazione; la ricezione da parte del pubblico è sfidata a riconoscere la reificazione musea-le – interrompe l’autonomizzazione della visione. Come testi-
138 H. Belting, Photography and Painting, cit., p.11. 139 Ivi, p. 11.
Topologia del visibile 95
monia la complessa e intellettualistica procedura ritrattistica di Struth, benché la fotografia sia in grado di cogliere un aspetto irripetibile dei personaggi – la loro reazione di fronte all’ideale della propria immagine – essa è il prodotto di una sequenza di pratiche artistiche e tecnologiche standardizzabili. Di qui la ri-gida serialità dei ritratti domestici di Struth e delle Museum Photographs: entrambi i generi rispondono alla logica dell’archivio, a un’intenzione sistematica e una raccolta spuria dell’informazione visiva:
Nell’immagine d’archivio, il “taglio” o “inquadratura” fatta dall’interprete è circondata e imbrigliata da una pletora di in-formazione isolata e casuale che cade al di là di un dato ambito di interesse. È questa immersione del tratto significante in un campo di generale non-significanza e “rumore” dell’informazione che costituisce esattamente lo status di veri-dicità della conoscenza d’archivio, la modernità del metodo e il suo oltrepassamento del ritratto dipinto a livello di affidabili-tà140.
La coerenza esterna delle Museum Photographs richiede allo spettatore di partecipare consapevolmente alla contingenza dell’opera, un presupposto condiviso dalla sensibilità minimali-sta per una spazialità unitaria e contingente, generata dall’incontro tra l’oggetto e il soggetto dell’esperienza estetica. E tuttavia, come ci ricorda l’artificiosità della composizione delle Museum Photographs, il rapporto tra l’opera e il fruitore non si ribalta su quest’ultimo, come accade perlopiù con gli og-getti minimalisti, che antepongono l’attività dello spettatore alla complessità dell’opera. Le Museum Photographs non prevedo-no uno spettatore naturale, che con i suoi meccanismi cognitivi dia forma all’oggetto. Esse rifiutano l’ipostatizzazione della soggettività, il mito di una verginità dell’esperienza estetica ot-tenuta al prezzo della riduzione dello spettatore a esecutore au-tomatico degli stimoli programmati dall’oggetto. La fotografia come tecnica critica nega la gestaltizzazione della ricezione e impone al soggetto della museificazione d’interrogarsi: «Dove
140 N. Bryson, Thomas Struth's Nescient Portraiture, cit.
Capitolo II 96
sono messi in mostra i meccanismi dello spettacolo del contem-poraneo business museale, le mie fotografie possono offrire una riflessione su questa situazione»141.
Nel caso delle Museum Photographs, che assumono come contesto di ripresa e di fruizione la musealità postmoderna, la tecnologia fotografica della presenza incontra la simultaneità espositiva142. Sulla sovrapponibilità di queste strutture si regge l’estetica delle Museum Photographs. Così come il museo mo-derno traduce la dispersa storicità dell’arte in una rivelazione della simultaneità – il “museo immaginario” di Malraux – la fo-tografia in quanto “medium della presenza” esplora la decaden-za dell’autosufficienza dell’immagine. Ritornando agli interro-gativi precedenti – per quale ragione Struth fotografa dei visita-tori che riflettono mimeticamente i contenuti artistici dei musei? come interpretare il parallelismo tra l’essere-nel-museo delle Museum Photographs e il «processo originale di rappresentare delle persone»? – l’affinità tra tecnologia fotografica e museali-tà postmoderna suggerisce ulteriori chiavi di lettura.
In primo luogo, l’analogia tra gli spazi dipinti e quelli vissuti dagli spettatori illustra tematicamente l’equivalenza strutturale tra musealità e fotografia, il loro paralizzante denominatore co-mune, ovvero la presentificazione della visione e il congelamento delle specificità artistiche e delle differenze storiche. Inoltre, se cogliamo la relazione tra la produzione e la fruizione delle Museum Photographs come un dialogo tra i mezzi fotografici e le forme contemporanee della musealità, constatiamo un ennesimo trionfo dell’immanenza: sia lo scatto registrato dalla pellicola sia l’esposizione promossa dal museo sono tecnologie del “verificare la presenza”143.
141 Ivi, p. 40. 142 R. Krauss, The Photographic Conditions of Surrealism, in The Originality of the
Avant-Garde and Other Modernist Myths, MIT Press, Cambridge, Mass. 1985, p. 107. 143 Come ricorda Pierre Bourdieu, il presupposto sociale dello sviluppo dell’arte
fotografica è il suo radicamento nella vita domestica e di conseguenza nella ritrattistica familiare, un’origine abbandonata a causa della seduzione modernista e “pittorica”, cfr. P. Bourdieu, La fotografia: usi e funzioni sociali di un'arte media, trad. it di M. Buo-nanno, Guaraldi, Rimini 1971. In questa prospettiva la ricerca di Struth costituisce una vera e propria genealogia della ritrattistica fotografica. Da un lato i ritratti domestici
Topologia del visibile 97
La fotografia è in Struth un’“arte dell’immediatezza” senza valere come una ricomposizione di soggetto e oggetto nell’ontologica dell’accadere: la forma delle Museum Photo-graphs è costruttiva e seriale, come nell’archivistica scientifica di Galton, Charcot e Bertillon e nel catalogo fisionomico di Au-gust Sander144. Poiché la “giusta” disposizione mimetica dei vi-sitatori nei musei non è una creazione soggettiva ma una regi-strazione occasionale di uno stato del mondo, l’apparecchio fo-tografico cristallizza gradienti temporali incomponibili: i dipin-ti, il pubblico del museo e il nostro sguardo attualizzante rac-chiudono dimensioni temporali eterogenee. L’accordo formale tra la composizione dei turisti e dei quadri s’incaglia nell’alterità dei dipinti, nella loro fantasmatica apparizione du-rante una gita al museo. Il fallimento della coerenza interna de-costruisce gli ambienti espositivi raffigurati dalle Museum Photographs, inaugurando un confronto enigmatico tra l’autoritratto del fotografo e la pittura di Rembrandt (fig. 5).
Subordinazione al museo
Il dipinto di Rembrandt assunto da Riegl come paradigma
della perfetta compenetrazione, nella ritrattistica di gruppo, di subordinazione e coordinazione, coerenza interna ed esterna è anche il soggetto di una fotografia di Struth scattata al Rijksmu-seum di Amsterdam (fig. 6). L’atteggiamento della donna sedu-ta di fronte al capolavoro di Rembrant, intenta a fissare una por-zione non rappresentata di spazio, ricalca quello dei sindaci. Come i personaggi di Rembrandt, la donna è vestita di nero e
(cfr. la serie Portraits) affrontano, incorporandole nell’immagine, le attuali condizioni di produzione della fotografia; dall’altro le Museum Photographs tematizzano il conte-sto sociale di ricezione del ritratto, la museificazione a cui viene sottoposto con l’inserimento nel museo.
144 L’estraniante convenzionalità delle fotografie di Struth si fonda sull’accettazione critica di questo presupposto. Struth, al quale non «interessa condurre una battaglia con il medium», procede in una direzione opposta alla tradizione fotografica del fotomon-taggio dadaista, della manipolazione surrealista dell’immagine e in generale della deco-struzione del medium fotografico, ritenuto un medium della presenza e come tale com-battuto per le sue potenzialità mimetiche.
Capitolo II 98
mostra il volto e le mani, lo sguardo assorto, sospeso tra intro-spezione e attenzione per una presenza esterna al campo della fotografia. In questo caso il ruolo strutturale della coerenza e-sterna è dichiarato apertamente da Struth e con esso l’inadeguatezza delle soluzioni ricevute, oltre che il fallimento dell’esibizione museale della pittura. La composizione dei Sin-daci dei drappieri non si risolve, come voleva Riegl, in una fruizione simpatetica da parte dello spettatore. La donna volge le spalle al dipinto, disdegna il richiamo degli sguardi pittorici e nel far ciò ricalca di fronte all’obiettivo la subordinazione all’esterno dei protagonisti del dipinto. L’equilibrio tra coerenza esterna e interna ricercato dal ritratto di Rembrandt perde il suo terzo polo, l’autosufficienza della visione del pubblico dell’arte.
L’attuale condizione di alienazione museale si riflette nella posizione della donna del Rijksmuseum: rispondendo alla su-bordinazione dei personaggi del dipinto di Rembrandt con una duplicazione dell’eteronomia della rappresentazione, la visita-trice distratta ci consegna intatto il dilemma della coerenza e-sterna, la mancata autosufficienza della fotografia e il mutismo del quadro da essa riprodotto. Prima che illustrazioni della mu-seificazione spontanea, le Museum Photographs sono perciò dei ritratti: ritratti nell’epoca dell’esposizione museale della foto-grafia a fianco dei dipinti che essa stessa contiene, esemplari di una fase successiva a quella descrittaci da Benjamin nell’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, un’età la no-stra in cui l’inattuale diatriba tra fotografia e pittura, tra autenti-cità e riproducibilità dell’immagine è ricomposta dalle tecnolo-gie dell’esposizione e dalla sociologia della ricezione.
In termini filosofici, quanto detto sinora nel gergo formalista di Riegl a proposito dell’interazione di coerenza interna ed e-sterna, si traduce in un’aporetica relazione tra arte autonoma e morte dell’arte. La radicalizzazione del principio della coerenza esterna, ciò che il critico Michel Fried ha definito la “teatralità” dell’opera d’arte, conduce nelle avanguardie e neo-avanguardie novecentesche alla non-arte, alla mera presenza di oggetti che sconfiggono le distinzioni tra opera e contesto. Quando l’oggetto d’arte si rivolge programmaticamente al suo pubblico,
Topologia del visibile 99
«chiede allo spettatore di venir preso in considerazione, di venir preso sul serio», esso finisce per ottenere una “presenza da pal-coscenico”; l’esistenza prende allora il sopravvento sulla signi-ficatività, che resta affidata al contesto comunicativo, al venir «percepito come parte di quella situazione»: «Tutto conta – non come parte dell’oggetto, ma come parte della situazione in cui l’oggettualità viene stabilita e da cui quella oggettualità dipende almeno in parte»145. Al termine di questo processo – che nei ca-si migliori ispira l’arte critica delle correnti minimaliste e site specific – incontriamo la museificazione della visualità, la scon-fessione della pretesa avanzata dalle immagini artistiche di ri-volgersi a un pubblico “esterno”, il sacrificio della residua in-transitività dell’opera in nome delle aspettative culturali dell’osservatore. In una parola, il trionfo della spettacolarizza-zione museale e il suo travaso nella sociologia della ricezione. Come suggeriscono le Museum Photographs, nel museo non si contrappongono ormai più opere d’arte e spettacolarizzazione, tramontata è l’alternativa tra “vivificazione e reificazione” dell’esperienza estetica146. La museificazione spontanea scon-figge la cristallizzazione dei compiti dell’artista e dell’interprete, confonde i diritti reciproci della creazione e del-la rivendicazione, imponendo di ripensare le prerogative dell’arte e della teoria.
145 M. Fried, Art and Objecthood, in Art and Objecthood. Essays and Reviews, Uni-
versity of Chicago Press, Chicago 1998, p. 155. 146 Cfr. H. Foster, Archives of Modern Art, cit.
Capitolo II 100
fig. 1 T. Struth, San Zaccaria, Venezia, 1995.
fig. 2 T. Struth, Museo del Louvre IV, Parigi, 1989.
Topologia del visibile 101
fig. 3 T. Struth, Museo del Louvre II, Parigi, 1989.
fig. 4 T. Struth, Museo del Louvre III, Parigi, 1989.
Capitolo II 102
fig. 5 T. Struth, Alte Pinakothek (Self-Portrait), Monaco, 2000.
fig. 6 T. Struth, Rjksmuseum I, Amsterdam, 1990.
Topologia del visibile 103
3. L’illusione nell’immagine
Da Platone, che nel Sofista condanna l’arte di produrre simu-lacri, ad Adorno, che coglie nella storia della civiltà il progres-sivo abbandono dell’incanto originario, l’avanzare di una disil-lusione, la tradizione filosofica attribuisce all’immagine le ca-ratteristiche dell’allucinazione e della seduzione, dell’inganno e dell’apparenza. Da un lato l’impostura e l’auraticità visiva, dall’altro il trasparente monologo della verità.
Domandiamoci innanzitutto: esiste una forma universale d’illusione visiva o il presente regime di seduzione sfugge alle categorie storiche dell’illusione? Nell’esaminare l’impatto delle tecnologie di riproduzione sulle pratiche artistiche e sull’esperienza estetica, Benjamin sottolineava il passaggio dal paradigma del pittore come mago a quello dell’operatore cine-matografico come chirurgo: «Il mago e il chirurgo si comporta-no rispettivamente come il pittore e l’operatore. Nel suo lavoro, il pittore osserva una distanza naturale da ciò che gli è dato, l’operatore invece penetra profondamente nel tessuto dei da-ti»147. A queste due metafore corrispondono secondo Benjamin due morfologie dell’immagine, accompagnate da pratiche illu-sionistiche specifiche: alle immagini totali della pittura figurati-va un’illusione generata dalla simulazione del punto di vista (prospettiva), all’immagine “multiformemente frammentata” delle sequenze cinematografiche un’illusione del procedimento tecnico (montaggio).
L’attuale cultura visiva è permeata da pratiche illusionistiche che sfuggono alla tipologia benjaminiana: i soggetti di un tem-po, maghi e operatori, sono stati sostituiti da una nuova élite della simulazione. I nuovi illusionisti non ingannano più sull’aldilà, ma sull’aldiquà, non presentano come realizzabili eventi inverosimili (i conigli che escono dai cappelli), ma con-feriscono un’aura d’irrealtà al reale: le merci, i desideri, le ri-
147 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., p.
38.
Capitolo II 104
produzioni visive di oggetti di consumo si tramutano in oggetti magici, in seducenti feticci.
Questo regime visivo rende obsoleti gli approcci convenzio-nali all’illusione, che ne inchiodano la natura al risvolto sogget-tivo o comunicativo delle immagini.
Dove risiede dunque il carattere illusionistico delle immagini della postmodernità, in una essenza o in un disturbo della rela-zione con il mondo e i soggetti? In gioco non è soltanto un sog-getto che “si illude”, una rappresentazione la cui consistenza è un’impostura (il trompe-l’oeil), o una realtà che “appare” senza essere (il mondo delle ombre di Platone, il mondo come feno-meno e rappresentazione di Kant e Schopenhauer), bensì una re-lazione distorta che si fa natura, una rete di condizionamenti cristallizzati in immagini.
Percezione, coscienza, immagine In Arte e illusione Gombrich rivendica l’utilità critica di ana-
lizzare i presupposti tecnologico-percettivi della pittura illusio-nistica, la quale mira a creare “l’illusione della realtà” e una «convincente sembianza del mondo sensibile». Essa conduce a una vera e propria “scoperta delle apparenze”, alla realizzazione di un «mondo sospeso tra la finzione e la realtà che i Greci fu-rono i primi ad esplorare»148:
Molto prima che la psicologia sperimentale ci avesse pensato, l’artista […] aveva scoperto che gli elementi dell’esperienza visiva potevano essere scomposti e ricomposti a creare l’illusione. Infine noi dobbiamo a questa invenzione se ora possiamo scoprire da noi stessi che il mon-do può essere contemplato come pura apparenza e oggetto di bellez-za149. L’arte illusionistica è sorretta dal mestiere, i suoi progressi
presuppongono un metodo di “sperimentazione ed errore” e
148 E.H. Gombrich, Arte e illusione. Studio sulla percezione della rappresentazione
pittorica, trad. it. di E. Romano, Leonardo Arte, Milano 2002, p. 190. 149 Ivi, p. 296.
Topologia del visibile 105
l’applicazione ai prodotti visivi di schemi interpretativi. Poiché una condizione fondamentale dell’illusione visiva è la presenza di un “contesto d’azione”150 in grado di produrre le aspettative necessarie a rafforzare l’illusione, l’arte illusionistica è esposta all’incalzare di nuove richieste, al mutare delle convenzioni e alla ridefinizione culturale del campo visivo e artistico. Ad essa si applicano perciò sia i metodi della psicologia della percezio-ne che il principio ermeneutico del “vedere uguale interpreta-re”151.
Non esiste un “occhio innocente” (Ruskin), una visione pu-ra, la percezione è un «processo così complesso e miracoloso di interazione e integrazione»152. La “scoperta delle apparenze” non consiste dunque in purificazione della percezione dagli e-lementi concettuali, ma nella progressiva «invenzione di con-fronti che reggano»153. L’“illusione della verosimiglianza”, fondata sulla costituzione psicologica della percezione, coin-volge la conoscenza e non soltanto l’esperienza. Per Gombrich l’illusione è dunque uno stato percettivo, la cui creazione e rice-zione richiede tuttavia abilità tecniche e conoscenze, orizzonti sociali d’attesa e procedure di verifica.
Il riferimento alla percezione e alla costruzione logico-sensoriale dell’esperienza visiva non esaurisce la fenomenolo-gia dell’illusionismo. In Quadri d’epoca Gehlen difende la no-zione di illusione dal discredito in cui è caduta in seguito all’affermarsi della pittura astratta e della crisi della figurazione, collocandola in una regione sovraordinata rispetto alla perce-zione, nella struttura stessa della coscienza. Secondo Gehlen, non bisogna sottrarre a questo termine il suo «ancor sempre possibile, elevato significato»154. Con Musil, Gehlen definisce illusione un «disturbo nell’equilibrio della coscienza di realtà», un’esperienza in cui la coscienza «balza all’improvviso su di un
150 Ivi, p. 190. 151 Ivi, p. XIII. 152 Ivi, p. 293. 153 Ivi, p. 273. 154 A. Gehlen, Quadri d’epoca. Sociologia e estetica della pittura moderna, trad. it.
di G. Carchia, Guida, Napoli 1989, p. 26.
Capitolo II 106
altro piano»155. Si dischiude in tal modo una “terza dimensio-ne”, un intero mondo dell’apparenza associato a un «“luogo chiaroveggente” in seno alla coscienza», il quale non va identi-ficato con l’inconscio, dal momento che possiede una “sostanza puramente intellettuale”156.
L’illusione realizza perciò nell’immediatezza ciò che “l’esperienza vissuta estetica” ottiene con i complessi mezzi dell’arte: «la distinzione tra parvenza e realtà diviene, allora, es-sa stessa parvenza»157. In Gehlen l’illusione coincide con il luo-go dell’apparenza, una facoltà che giustifica la rottura della re-altà e permette la “traduzione in immagini” delle forme e dei si-gnificati reali158. L’autonoma sfera cognitiva del mondo delle immagini è garantita dalla terza dimensione dell’illusione, lo sviluppo della “razionalità intraottica”, e dunque dell’arte mo-derna, richiede una coscienza che s’illude, non una coscienza disillusa.
Un orientamento divergente sostiene l’estetica negativa di Adorno. In questo caso il potere di corruzione posseduto dalle immagini illusionistiche è proiettato all’indietro, in un passato mitologico dell’umanità retto da un rapporto d’“incanto” tra il soggetto e il mondo. È questo il “comportamento mimetico”, l’originaria «affinità aconcettuale che ciò che è prodotto sogget-tivo ha con il suo altro»159. In seguito, con l’abbandono del mondo magico, l’arte diventa “il rifugio del comportamento mimetico”160, un serbatoio di istanze prerazionali e di immagini mitologiche. L’impulso mimetico, il tarlo illusionistico privile-giato dalle estetiche reazionarie di Klages e Jung, sta sempre in agguato nel nucleo ontologico delle immagini. La storia dell’arte si riduce pertanto all’incedere di un “processo di disil-lusione”161, il quale non è altro che una costante “proibizione di
155 Ivi, p. 26. 156 Ivi, p. 28. 157 Ivi, p. 26. 158 Ivi, p. 25. 159 T.W. Adorno, Teoria estetica, trad. it. di E. De Angelis, Einaudi, Torino 1975, p.
92. 160 Ivi, p. 91. 161 Ivi, p. 29.
Topologia del visibile 107
immagini” che accompagna il weberiano disincanto del mondo: «Le immagini estetiche soggiaciono alla proibizione di imma-gini»162. Come l’arte moderna, che da Baudelaire in poi è un’arte astratta, un “mondo senza immagini”163, l’estetica mo-derna nasce sotto il segno dell’astrazione, il suo medium è un “pensiero senza immagini”.
Il presupposto storico ed epistemologico di questa condizio-ne è riposto nella separazione di immagine e concetto prodotta dalla reificazione capitalistica:
Se dopo la scissione della conoscenza in immagine e segno il momen-to dell’immagine viene dal pensiero equiparato alla verità “sic et sim-pliciter”, la fallacia della scissione non viene affatto rettificata ma piuttosto sorpassata poiché l’immagine ne è colpita non meno del con-cetto. Quanto poco le immagini estetiche si prestano a farsi tradurre stringentemente in concetti, altrettanto poco esse sono “reali” […] le immagini non vanno ipostatizzate164. In Adorno l’illusione aderisce dunque come un parassita alla
natura delle immagini, che vanno fatte “esplodere”, liberate dai residui mitologici e ricondotte alla logica – assolutamente non visuale – della loro apparizione. È questo il compito delle opere d’arte, la cui «“apparition”, che le rende immagini, distrugge sempre al tempo stesso anche la loro natura di immagini»165.
Un’impalcatura concettuale adorniana percorre segretamente l’apologia dell’illusione di Baudrillard. In Illusione, disillusione estetiche il nucleo filosofico da cui si dipana la storia delle im-magini è la loro identificazione con un’essenza illusionistica, oltre che la loro irriducibilità al concetto e al mondo. Anche in questo caso è l’immagine il baricentro ontologico della filosofia dell’illusione.
Baudrillard ripercorre il processo attraverso il quale le im-magini estetiche della modernità – alle quali inerisce una tipo-logia estetica dell’illusione, generata dalla parsimonia della rap-
162 Ivi, p. 177. 163 Ivi, p. 32. 164 Ivi, p. 145. 165 Ivi, p. 144.
Capitolo II 108
presentazione, dal suo pudore, dal suo imperativo di riduzione del reale – vengono a loro volta estetizzate: è il regime dei si-mulacri, delle immagini che sfuggono alla rappresentazione e che infine si rovesciano in una superficie di oggetti puri, di puri “attrattori”. A questo nuovo realismo dell’immagine è preposta la forma contemporanea dell’illusione, l’illusione antropologi-ca. L’immagine divenuta realtà si rovescia in un oggetto puro, in un’illusione radicale, un rituale.
All’arte era assegnato nella modernità il compito della “ge-stione convenzionale dell’illusione” attraverso l’immagine. L’artista, mediante una presa di distanza dal reale, creava im-magini rappresentative, consapevole della loro apparenza. Lo specifico dell’illusione estetica – che Baudrillard definisce an-che “illusione rappresentativa”, o “creatrice”, o “vera illusione” – era il togliere, il sottrarsi per suggerire, l’operare da schermo allo strapotere del reale (è il paradigma schopenhaueriano, e poi nietzschiano e lacaniano dell’immagine come filtro, inganno necessario): «l’illusione è legata al segreto, al fatto che le cose siano assenti da se stesse, si ritraggano da se stesse per scivolare nella loro apparenza»166.
Come nella visione mcluhaniana del villaggio planetario, in cui la tecnologia elettronica si rovescia in oralità, la prolifera-zione di immagini tecnologiche riconduce l’umanità alla «scena primitiva dell’illusione in cui raggiungeremo i rituali e le fanta-smagorie non-umane delle culture antecendenti la nostra»167. Le immagini, «avendo ingoiato il proprio specchio, sono diventate trasparenti a se stesse, non hanno più segreti»168. L’immagine condannata al realismo diventa un’idea, un elemento del “ritua-lismo primario”, un feticcio o un gadget estetico169.
Fissato il requisito epistemologico della indipendenza di immagine e concetto, di rappresentazione e mondo, Baudrillard registra i sismi provocati dalla frizione tra i due blocchi di real-
166 J. Baudrillard, Illusione, disillusione estetiche, trad. it. di L. Guarino, Pagine
d’Arte, Milano 1999, p. 25. 167 Ivi, p. 43. 168 Ivi, p. 25. 169 Ivi, p. 37.
Topologia del visibile 109
tà: in alcuni periodi storici – che Baudrillard celebra esaltando l’illusione estetica (pittorica, rappresentativa) e l’illusione radi-cale (antropologica, tecnica) – prevale la separazione, in altri l’identità di concetto e immagine. È la polarità adorniana di mimesi e arte astratta, virata in nichilismo dopo il tramonto del pensiero utopico e dell’estetica modernista. Sullo sfondo, un principio condiviso sia da Adorno che da Baudrillard: l’illusione è intrecciata alla natura dell’immagine, come la de-cadenza allo sviluppo dell’organismo. Dal punto di vista di un’estetica dell’immagine, percezione e coscienza sono epife-nomeni, sovrastrutture di un illusionismo primario.
Falsi problemi
La chiave d’accesso all’illusionismo postmoderno va ricer-
cata in una radicale ermeneutica delle immagini, che muova dal superamento della contrapposizione tra immagine e concetto. Tale dualismo, un prodotto storico della modernità revocato dalla logica visuale del tardo capitalismo, non appartiene ai si-stemi filosofici pre-kantiani: le idee di Locke e le monadi leib-niziane lo escludevano. Un’epistemologia dell’immagine non dualistica riemerge sporadicamente in epoca moderna, ad esem-pio in Nietzsche e Bergson. Ad essa è necessario rifarsi per scongiurare l’inadeguatezza della filosofia al cospetto delle sfi-de avanzate dal nuovo illusionismo.
Se le immagini e i concetti sono realtà separate, l’alternativa concessa ai teorici e ai fruitori del visivo si restringe al rifiuto o alla seduzione, all’iconoclastia o all’iconofilia, dove a seconda della natura attribuita alle immagini ogni visualizzazione verrà concepita come un contatto con l’assoluto, come l’irruzione di un regime trascendente di coscienza, come l’utopia dell’emancipazione dal concetto, atteggiamenti che escludono l’interpretazione e la critica. Proviamo invece ad abbandonare il gergo modernista dell’autonomia del visibile e a pensare l’immagine come realtà e al contempo come forma, per quanto specifica, di razionalità. Potremo così riconoscere le illusioni visive senza dissolverle e addirittura scorgere negli inganni e
Capitolo II 110
nelle allucinazioni della ragione dei “falsi problemi” di matrice illusionistica170.
Il primo e insuperato riconoscimento di questa possibilità ri-sale a Platone, che nel Sofista associa gli inganni dei sofisti all’“arte produttiva d’immagini”. Come nota Carchia171, in que-sto dialogo l’obiettivo di Platone non è di tracciare il confine tra immagine e originale, tra copia e modello (l’idea), ma di distin-guere due tipi di immagini: le immagini vere e quelle inganne-voli:
La conclusione è che anche l’aletheia, anche il logos sono in qualche modo apparenza, immagine […] la distinzione platonica tra “mimesi icastica” e “mimesi fantastica” si regge tutta sulla negazione dell’idea di originalità […] Si dà pseudos e, dunque, la possibilità di un’immagine menzognera proprio perché è impossibile sfuggire alla struttura dell’apparenza172. In questo dialogo lo Straniero di Elea tenta di dimostrare
contro le tesi sofistiche l’esistenza del non essere. Se infatti, come sostengono i seguaci di Parmenide, il non essere non è, anche il falso non è, rendendo dunque impossibile confutare i discorsi e le immagini ingannevoli. Nel corso del dialogo lo Straniero definisce il sofista un illusionista, un “imitatore delle cose reali”. Una volta dimostrata la realtà dell’illusione («Stra-niero: Giacché questo parere e sembrare, ma non essere, e que-sto dire bensì qualcosa, ma non il vero; tutto ciò è pieno d’ambagi sempre, così in passato come ora», Sofista 237 e)173 – ovvero che il non essere esiste e che dunque il falso, pur essen-do non essere, esiste a sua volta – è di nuovo accessibile la divi-sione del vero dal falso, delle immagini-copia dalle immagini-simulacro: «Se il falso è, c’è anche l’inganno. […] E se c’è
170 Cfr. H. Bergson, Pensiero e movimento, cit. 171 Per un’interpretazione analoga del Sofista cfr. anche G. Deleuze, Logica del sen-
so, trad. it. di M. De Stefanis, Feltrinelli, Milano 1975. 172 G. Carchia, La teologia dell'immagine dell'immagine come idoloclastia, in Nicea
e la civiltà dell'immagine, a cura di L. Russo, Aesthetica Preprint, Palermo 1998, p. 12. 173 Le citazioni dal Sofista sono tratte da Platone, Sofista, in Tutte le opere, a cura di
G. P. Carratelli, Sansoni, Firenze 1988.
Topologia del visibile 111
l’inganno, necessariamente tutto sarà pieno di simulacri, di im-magini e di apparenza»174.
«Due sono queste opere di fattura divina: l’oggetto reale e l’immagine che gli si accompagna»175: immagine e logos, dire e sembrare, convivono nel regno delle apparenze, tra le quali si muovono sia il filosofo che il sofista. La posta in gioco è la se-parazione del discorso vero da quello menzognero, il ricono-scimento delle immagini fedeli al reale e delle imposture visive, ma a partire dal mondo delle apparenze e sulla base del criterio della differenza e della somiglianza. La via sempre percorribile dell’illusione e della falsità – dove falso per Platone è il pensie-ro: «giacché l’opinare o il dire ciò che non è, ecco, in sostanza, ciò che costituisce, credo, il falso così nel pensiero come nei di-scorsi»176 – porta a convergere la ragione e l’immagine. A parti-re da questa radiografia della “struttura dell’apparenza” diventa esercitabile una critica delle immagini intesa come autocritica della ragione.
Come mostra l’esempio platonico, per un pensiero-immagine incerto sulla propria autonomia epistemologica, la logica visiva dell’illusione si ribalta in un’incessante denuncia dei falsi problemi (nel Sofista, l’irrealtà del non essere). Ber-gson, filosofo della realtà-immagine come Kant fu il filosofo dell’immagine-schema, forma ibrida di intelletto, immaginazio-ne e sensibilità177, attribuisce al pensiero il compito di cogliere e di lottare contro l’illusione. Dal momento che le illusioni – della stabilità, dell’immutabilità, del disordine, del nulla, dello scorrere lineare del tempo – provengono dall’“uso naturale dell’intelletto”, esse vanno additate come “falsi problemi”178, autoinganni inestirpabili di una ragione la cui vita coincide con l’inviluppo delle immagini:
174 Platone, Sofista, 260 c. 175 Ivi, 267 c. 176 Ivi, 260 c. 177 Cfr. M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica, trad. it. di M. E. Reina,
Laterza, Roma-Bari 2000. 178 Cfr. H. Bergson, Pensiero e movimento, cit..
Capitolo II 112
Per Kant la ragione, nel suo punto più profondo, non genera errori ma illusioni inevitabili di cui si può solo scongiurare l’effetto. Pur deter-minando la natura dei falsi problemi in modo del tutto diverso, e pur considerando la stessa critica kantiana come un insieme di problemi mal posti, Bergson tratta l’illusione in un modo analogo a quello di Kant: l’illusione, infatti, si fonda nel punto più profondo dell’intelligenza. Non è dissipata né dissipabile, può solamente essere rimossa179. Una prima conseguenza della tematizzazione della struttura
ontologica dell’illusionismo è la ridefinizione della rilevanza teorica delle tendenze artistiche naturalistiche. Ogni illusione radicale, ad esempio l’illusione che scaturisce secondo Floren-skij dalla “sintesi psicofisica” del particolare nella totalità dell’opera d’arte, relega a un’area marginale i trucchi mimetici dei pittori studiati da Gombrich:
La deformazione degli elementi in un tutto organizzato, cioè, in altre parole, l’illusione, è l’essenza stessa dell’attività dell’artista. Ma no-tiamo, anche se è sottointeso, che l’illusione nell’opera d’arte non ha niente in comune con l’illusionismo di opere di specifiche scuole e tendenze. L’illusione nell’opera non crea un’opera illusionistica, come al contrario un’opera illusionistica può soffrire, e anzi soffre, di un’insufficienza di illusione nei suoi elementi180. La «premessa formale dell’illusione, da qualsiasi parte essa
sorga»181 è indicata da Florenskij in una regola generale, facil-mente afferrabile nel caso dei fenomeni visivi, ma valida anche per il pensiero, dal momento che è sostenuta da un principio generale di economia dell’energia psichica. L’illusione sorge dallo scontro tra due generi di impressioni che la mente incana-la in un rapporto di subordinazione tra un fenomeno dominante, il quale diventa in tal modo generale, e uno subordinato, il quale arretra al rango della particolarità. Ad esempio,
179 G. Deleuze, Il bergsonismo e altri saggi, cit., p. 10. 180 P. Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte, a cura di N. Misler, Adelphi, Mila-
no 1995, p. 207. 181 Ivi, p. 208.
Topologia del visibile 113
una limitata superficie arancione su un ampio sfondo verde sembra più rossa di quando la si percepisce da sola, senza lo sfondo. Il fenomeno generale è qui l’ampio sfondo verde, quello particolare la limitata su-perficie arancione, l’illusione, il mutamento di colore di quest’ultima in rapporto all’allontanamento dello sfondo verde nello spettro dei co-lori182. La ripetizione, una maggiore durata, intensità o estensione di
un’impressione tendono perciò a fare di essa uno schema, una categoria universalmente valida183. Incapaci di accettare, già a livello psicofisico, la “molteplicità dei fenomeni”, l’irriducibile complessità del reale, tendiamo a riunificarli in un solo schema, che contrapponiamo all’autonomia formale del dettaglio.
Se annidata nel pensiero è a una tenace “volontà d’illusione”, l’obiettivo di un pensiero critico sarà di evitare sia il rigetto che l’irretimento delle molteplici forme di illusione vi-sive. Nell’epoca della tecnologia dell’immagine, in cui la po-tenza del falso è posta stabilmente al servizio dell’ordine eco-nomico-culturale, è necessario afferrare teoricamente quell’«area intermedia di esperienza a cui contribuiscono la re-altà esterna e quella interna […] l’area intermedia compresa tra ciò che è soggettivo e ciò che è oggettivamente percepito»184. L’immagine e la razionalità sono immerse e trascinate nella cor-rente dell’illusionismo tecno-capitalistico. È questa una dimen-sione che, nella sfera psicologica degli oggetti transizionali teo-rizzata da Winnicott, non può venire posta in dubbio, dal mo-mento che «nessuno la rivendica se non per il fatto che esisterà come posto-di-riposo per l’individuo impegnato nel perpetuo compito umano di mantenere separate, e tuttavia correlate, la realtà esterna e quella interna»185.
Il virtuosismo illusionistico delle tecno-immagini ha poten-ziato le tendenze conservatrici della coscienza. La molteplicità feticistica delle merci è irriducibile al senso, sfugge al pensiero
182 Ivi, p. 209. 183 Ivi, p. 215. 184 D.W. Winnicott, Oggetti transizionali e fenomeni transizionali, in Gioco e real-
tà, trad. it. di G. Adamo e R. Gaddini, Armando Editore, Roma 1974, pp. 25-26. 185 Ibidem
Capitolo II 114
e si alimenta di pulsioni regressive e previsioni statistiche. Mar-keting e infantilismo di massa convivono in un’atmosfera non più unitaria, refrattaria alle vecchie categorie della “società” e della “cultura”. Alla produzione e regolamentazione di questi fenomeni – irrapresentabili mediante gli strumenti percettivi e intellettuali della sensibilità estetica e delle scienze umane – so-no preposte le scienze sociali quantitative e le psicologie positi-vistiche. Smarriti nella molteplicità dei fenomeni, abbiamo ab-bandonato l’utopia di una teoria – di per sé aporetica e deco-struttiva – del frammento e della molteplicità, dedicandoci in-vece all’elogio dell’identità, della totalità e delle gerarchie. Co-me suggerisce la diagnosi di Florenskij, le tendenze conserva-trici del pensiero, poste di fronte a fenomeni conflittuali di i-naudita intensità e pervasività, a un immane campo di impres-sioni e prestazioni incomponibili – consumo di massa e intro-spezione, visualizzazione ossessiva di ogni aspetto del reale e politiche di potenza fondate sulla segretezza – hanno obbedito alla forma più tenace di illusione, adeguandosi alla matrice illu-sionistica dell’intelletto: «Il pensiero è conservatore e si attacca con tutte le sue forze a ciò che ha già accettato: l’ostinazione nei propri errori è il motore fondamentale dello sviluppo delle con-cezioni scientifiche»186.
Nel contesto di una cultura visiva di massa ben consapevole del potenziale illusionistico riposto nelle immagini e nell’uso naturale dell’intelletto, siamo chiamati, a costo di sacrificare la consistenza del nostro senso di realtà e di individualità, a ripen-sare dall’interno la struttura ontologica dell’illusione, la sua predilezione per la totalità, l’unità e la subordinazione. Nel cor-so di questa operazione è possibile che vada perduta la correla-zione tra soggettività e oggettività, oltre a quella sfera rassicu-rante di oggetti e credenze che, come i succhiotti dei neonati, ci permettono di accettare l’esistenza di un mondo inumano.
186 P. Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte, op. cit., p. 215.
Strumenti meravigliosi 1. Jucunda spectacula: le macchine gesuitiche
Mirabile è sempre il paradosso. Longino, Del sublime, XXXV, 5. Ci-tato in Francesco Patrizi, Della poeti-ca
Come pensare l’attualità delle fantasmagorie tecnologiche ed editoriali di Athanasius Kircher, «il più contemporaneo dei no-stri antenati e il più inattuale dei nostri contemporanei»1? Per l’“ansia enciclopedica”, la “combinatoria fantasiosa” e i “dispo-sitivi allucinatori” escogitati, il gesuita tedesco è considerato da Umberto Eco un precursore del Surrealismo, che non a caso ha dato avvio alla sua riabilitazione novecentesca. Lo squilibrio tra l’attualità e l’inattualità delle macchinazioni kircheriane segnala però la necessità di ricercare una connotazione più specifica per la sua “epistemologia”, che Eco individua nella collocazione «a metà strada tra due epoche della storia dell’enciclopedia»: da un lato la tradizione greco-romana e medievale, per cui «l’enciclopedista raccoglie tutto quello di cui aveva sentito di-re», dall’altro la riforma illuministica, segnata dalla raccolta metodica, collettiva e cumulativa delle informazioni. Anche la
1 U. Eco, Perché Kircher? Presentazione di Umberto Eco, in Iconismi e mirabilia da Athanasius Kircher, a cura di E. Lo Sardo, Edizioni dell’Elefante, Roma 1999.
115
Capitolo III 116
storiografia erudita sembra appagata in genere dal riconosci-mento dell’inclassificabilità della produzione kircheriana, della sua posizione di confine tra due epoche del collezionismo, tra la fisica aristotelica e la fisica sperimentale, tra la filologia medie-vale e la filologia umanistica, tra l’Egitto ermetico e l’egittologia professionale, tra la polifonia sacra e la musica ba-rocca2.
E tuttavia, quale risvolto di intelligibilità della cultura baroc-ca si nasconde dietro l’attualità kircheriana? Quali costellazioni concettuali – che includono il nostro presente culturale e quello che fu il presente di Kircher – si mostrano attraverso questa at-tualità? Per gli storici della scienza seicentesca interessati alle implicazioni simboliche delle pratiche collezionistiche, al con-fine tra sperimentazione scientifica, cerimoniali espositivi e psi-cagogia controriformistica, Kircher appare come un eccezionale rappresentante di «un modo di pensare e di essere che si poneva in competizione, nel XVII secolo, con le altre epistemologie: quella aristotelica, platonica, ermetica, lulliana, baconiana, gali-leiana, cartesiana e via di seguito»3. Ma in che cosa consiste questo “modo di pensare”? Con il museum kircherianum e la quarantina di voluminose pubblicazioni stipate d’invenzioni meccaniche, Padre Athanasius dà vita a uno specifico enciclo-pedismo gesuitico, una vera e propria «macchina che rigurgita-va conoscenza e produceva libri»4. Una macchina in senso let-terale, dal momento che gli artificialia magnetici, idraulici e meccanici (orologi, arche, fontane, statue, organi) erano il sigil-lo della sua eccezionalità, destando meraviglia e ammirazione in tutte le corti europee:
Kircher era diventato il nuovo Aristotele, che prometteva tutto ai suoi discepoli, da una maggiore eloquenza e una memoria rafforzata a una
2 Cfr. i saggi raccolti in M. Casciato, M.G. Ianniello, M. Vitale (a cura di), Enciclo-
pedismo in Roma barocca. Athanasius Kircher e il Museo del Collegio Romano tra Wunderkammer e museo scientifico, Marsilio, Venezia 1986.
3 P. Findlen, The Last Men Who Knew Everything … or Did He?, in Athanasius Kircher. The Last Men Who Knew Everything, a cura di P. Findlen, Routledge, New York 2004, p. 43, trad. it. mia.
4 Ivi, p. 2.
Strumenti meravigliosi 117
sorta di onniscienza indotta con mezzi fisici, ottenibile attraverso la manipolazione di una delle famose “arche” kircheriane – cassette combinatorie di legno che contenevano numeri, parole, musica, in breve, tutto ciò che fosse producibile automaticamente da una mac-china che combinasse le cose sulla base di una logica preordinata, programmata dal suo inventore nella macchina5. Il ritratto è quello di un Kircher “barocco”, che sovrappone
trucchi teatrali e preoccupazioni scientifiche, cultura cortigiana e magia naturale, un collezionista-impresario, scenografo di ce-rimonialità museali utili per guadagnarsi i favori della corte a-sburgica oltre che per contrastare l’attività delle coeve accade-mie scientifiche: «Mentre Kircher forniva a giovani e anziani principi enigmi, rebus, emblemi e arcane conoscenze che a-vrebbero confermato la loro superiorità sociale, essi gli offriva-no il loro supporto finanziario e conferivano autorevolezza alle sue opere»6.
Enciclopedismo, tecnologia ingegnosa e meraviglia, messi in scena nel teatro delle curiosità del museo Collegio Romano e
5 Ivi, p. 5. 6 M. Gorman e N. Wilding, La cultura barocca delle macchine, in Athanasius Kir-
cher S.J. Il museo del mondo, Edizioni de Luca, Roma 2001, p. 231. I contributi eruditi alla conoscenza del Kircher collezionista oscillano tra la constatazione del primato della spettacolarità strategica nel barocco romano di quegli anni e una più articolata ricerca delle fonti. Entrambe le posizioni accettano tuttavia la collocazione di Kircher all’interno del paradigma neoplatonico rinascimentale: «Le macchine di Kircher posso-no essere così paragonate ad universi artificiali miniaturizzati, che trasmettono messaggi criptici provenienti da un giocoso creatore. Le macchine del moto perpetuo e gli em-blematici orologi esposti nel museo di Kircher mostravano in modo più evidente il ca-rattere microcosmico delle macchine kircheriane» (M. Gorman e N. Wilding, La cultura barocca delle macchine, cit., p. 235). Sfugge alla separazione analitica di spettacolarità e magia naturale il contributo di G. Barboncini, che attraverso una minuziosa analisi del materiale didattico gesuitico rintraccia la compenetrazione di procedimenti tecnici e processi naturali sin nel cuore del tradizionale cursus physicus gesuitico: «L’equivalenza, se non l’eguaglianza, tra produzione artificiale e produzione naturale pone un problema di contatto con quell’area di fenomeni che per una mentalità scolasti-ca stanno dentro il mondo fisico, ma non fanno parte dei processi naturali. Si tratta dei mirabilia e degli artificialia, che trasgredendo i modi usuali di produzione naturale ri-cadono nel magico» (G. Baroncini, L’insegnamento della filosofia naturale nei collegi italiani dei Gesuiti, 1610-1670: un esempio di nuovo aristotelismo, in G.P. Brizzi, La «Ratio studiorum». Modelli e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Sei-cento, Bulzoni, Roma 1981, pp. 188-189). È questo “problema di contatto” il baricentro della sperimentazione ludico-operativa di Kircher.
Capitolo III 118
negli iconismi delle sontuose pubblicazioni per l’editore Jan-sonn di Amsterdam, costituiscono la specifica epistemologia kircheriana, una cultura debitrice dell’“estetica della seduzione” piuttosto che della dottrina della verità, funzionale ad intenti pa-renetici piuttosto che dogmatici: «Il potenziale emblematico, performativo e magico dei congegni meccanici e degli strumenti matematici venne progressivamente privilegiato rispetto al loro ruolo di alternativa alla filosofia naturale aristotelica»7. Da semplice cubiculum per ospitare gli strumenti kircheriani i loca-li del musaeum mathematicum si trasformarono negli anni ‘50 del XVII secolo, anche in seguito all’acquisizione nel 1651 del-la collezione antiquaria del senatore romano Alfonso
Donnini, in un teatro di mirabilia, in una Wunderkammer che con i suoi artifici meccanici, magnetici, ottici e idraulici, descritti con puntigliosità nel catalogo dell’assistente Giorgio De Sepi, è in grado di intrattenere un pubblico raffinato di lette-rati e potenti8. La matematica rigorosa di Clavius venne così rimpiazzata da un’applicazione ludico-esortativa della combina-toria e della tecnologia, che verrà perseguita dai discepoli-inventori di Kircher: Gaspar Schott e Francesco Lana Terzi9.
Sotto il segno di queste macchinazioni e “prodigi di verità” (Gracián), spesso scambiati per epifenomeni di un’epistemologia ermetica di matrice analogica, avviene la ri-scoperta novecentesca di Kircher: negli anni Cinquanta con i ri-chiami di Baltrusaitis alle anamorfosi catottriche, più di recente con la grande mostra a Palazzo di Venezia, la ricostruzione dei
7 M.J. Gorman, The Scientific Counter-Revolution. Mathematics, Natural Philoso-
phy and Experimentalism in Jesuit Culture, 1580-c.1670, Ph.D. dissertation, European University Institute, Firenze 1998, p. 215, trad. it. mia. Su questo argomento cfr. anche M. Gorman e N. Wilding, La cultura barocca delle macchine, cit. I due autori ricondu-cono la tecnologia fantastica kircheriana alla tradizione della magia naturale. La strada seguita nel mio intervento è un’altra, all’intersezione tra le trasformazioni del meravi-glioso aristotelico e la ripresa gesuitica della meccanica greca. La stessa magia naturale, definita da Schott «una meraviglia che travalica il senso e la comprensione dell’uomo», appartiene all’ambito del thauma.
8 Cfr. G. de Sepi, Romanii Collegii Musaeum Celeberrimum …, Amsterdam, 1678. 9 Cfr. tra le loro molte pubblicazioni, K. Schott, Technica Curiosa …, Würzburg,
1664 e F. Lana Terzi, Prodromo overo saggio di alcuni inventioni nuove premesso al-l'arte Maestra, Rizzardi, Brescia 1670.
Strumenti meravigliosi 119
mirabilia kircheriani nel Museum of Jurassic Technology di David Wilson e la celebrazione dell’“arte analogica” kircheria-na10.
Mechane
Decisi a non lasciarsi sopravanzare dallo sviluppo tecnologi-
co e al contempo prudentemente attestati su un eclettico quanto tattico aristotelismo, i Gesuiti del Collegio Romano lasciarono ampio margine di manovra a Kircher, che nel suo museo ab-bracciò una delle possibili discendenze della meccanica classica e dell’aristotelismo, combinando tecnologia curiosa e meravi-glia ingegnosa: «La mechane dei Greci antichi è soprattutto la macchinazione, ed è solo quella. Nella meccanica “il più picco-lo domina il più grande”, dice Aristotele. Ecco qualcosa di ato-pon e di thaumasion: cioè senza luogo e sorprendente»11. Gli
10 Cfr. J. Baltrusaitis, Anamorfosi, o magia artificiale degli effetti meravigliosi, A-
delphi, Milano 1978; “Athanasius Kircher S.J. Il museo del mondo: macchine, essoteri-smo, arte”, Roma, Palazzo di Venezia, 28 febbraio – 22 aprile 2001, catalogo della mo-stra Athanasius Kircher S.J. Il museo del mondo, cit.; per il Museum of Jurassic Te-chnology di David Wilson cfr. il sito web: http://www.mjt.org/. In Visual Analogy: Consciousness as the Art of Connecting, MIT Press, Cambridge, Mass. 1999, Barbara Maria Stafford tenta di sciogliere il nodo dell’attualità di Kircher: a suo avviso, le tecni-che di analogia visuale sono in Kircher un’arte per “parlare attraverso le differenze” e ricomporre, in un’epoca di espansione politica ed economica, la frammentazione cultu-rale. Sostenuta dal principio di simpatia e antipatia, la visualità kircheriana dispiega il desiderio visivo ed “erotizza le corrispondenze”, ridistribuendo capricciosamente, come le scatole di Joseph Cornell e le valigie di Marcel Duchamp, i livelli della realtà. All’“esagerata consapevolezza delle differenze” del post-strutturalismo Stafford con-trappone così la combinatoria “metaforica” e “metamorfica” di Kircher, un’arte della somiglianza, una prodigiosa macchina comunicativa in grado di tessere ponti tra identità slegate.
11 J.-F. Lyotard, In cui si considerano certe pareti come gli elementi potenzialmente celibi di alcune machine semplici, in AAVV, Le macchine celibi/Bachelor Machines, a cura di H. Szeemann, Alfieri, Venezia 1975, pp. 21, 98. I tentativi di ricondurre l’epistemologia kircheriana a principi teologici o magico-ermetici, ad esempio la meta-fisica della luce, il magnetismo universale o la panspermia, si scontrano con le implica-zioni dell’imitazione della meccanica antica. In Kircher i riferimenti testuali e dottrinali, peraltro copiosi e contraddittori, a partire dalla fondamentale ambivalenza tra platoni-smo rinascimentale e neo-aristotelismo, sono a loro volta collezionati e moltiplicati combinatoriamente dagli espedienti narrativi di cui abbondano le sue pubblicazioni: viaggi sotterranei ed estatici, storia del diluvio, descrizioni esotiche, promesse di sa-pienza universale, false dimostrazioni scientifiche.
Capitolo III 120
oracoli delfici e la statua di Iside zampillante latte dalle molte mammelle, gli orologi solari e magnetici, le ricostruzioni delle colombe volanti di Archita, degli specchi ustori di Archimede e delle apparizioni artificiali di Erone d’Alessandria, le macchine divinatorie e gli oroscopi solari kircheriani producono uno stu-pore artificiale, che proietta la mechane all’interno dell’antropologia dell’immaginazione degli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. Le figure animate dei congegni fantastici, il diletto visivo e i meccanismi segreti, le proiezioni acustiche e visive,
una folla di genietti che danza, animata dal silenzioso volgere dell’acqua […] un globo grande di cristallo pieno d’acqua che rappre-senta la Resurrezione del Salvatore in mezzo alle acque […] Uno specchio ustorio assai grande, cavo-convesso, con un’infinita quantità di specchi di cui alcuni ripromettano immagini luminose nell’aria, altri propongono oggetti trasformati, altri oggetti moltiplicati, altri ricom-pongono in bella forma, da una serie confusa di oggetti, forme in nes-sun modo predefinite. Tra queste una ricompone l’immagine di Ales-sandro VII12
sono altrettante “fantasie coscienti”, scene tratte dall’“imperialismo radicale dell’immagine” che forma la mate-ria degli Esercizi ignaziani13.
Dal momento che soltanto una parte dei soggetti del museo kircheriano appartiene al catalogo di luoghi, vedute e allegorie edificanti di cui Ignazio predispone accuratamente la composi-zione – tempio, montagna, giardino, sepolcro, valle di lacrime – il punto d’incontro tra il museo e gli Esercizi è riposto nell’affinità strutturale piuttosto che in quella tematica. In en-trambi i casi la scena è apparecchiata come una raccolte di e-xempla, allestiti per stupire e indurre alla devozione e animati da ripetizioni ossessive (gli esercizi ciclici dell’allievo, i movi-menti ricorrenti dei meccanismi). In entrambi i casi il risultato è
12 Giorgio de Sepi, Romani Collegii Museum, cit., pp. 2-3; trad. it. in M. Gorman e
N. Wilding, La cultura barocca delle macchine, cit., p. 222-23. 13 R. Barthes, Loyola, in Sade, Fourier, Loyola, trad. it. di R. Guidieri, Einaudi, To-
rino 2001, p. 55.
Strumenti meravigliosi 121
una dissezione schizoide del reale, la moltiplicazione dei “lon-tani” e la costruzione di un piano di passività.
La meraviglia, analogon parenetico del miracolo cristiano, nella sua variante spettacolare kircheriana non è nient’altro che uno strumento di assoggettamento della volontà, di sospensione del giudizio e dunque di piacevole asservimento dei sensi all’autorità14. L’autorità si manifesta innanzitutto nella tempo-ranea interruzione del principio di realtà. Le rigorose istruzioni impartite da Sant’Ignazio all’esercitante, perché si isoli dalle di-strazioni e appartandosi acceda al regno dell’immaginazione – «il primo punto consisterà nel vedere, con la vista dell’immaginazione le grandi fiamme, e le anime come dentro corpi di fuoco»15 – si prolungano nella teatralità del museum kircherianum e nella sua iconografia, ad esempio nelle proie-zioni di immagini sovrannaturali ottenute con la lanterna magi-ca e nelle metamorfosi del Proteo catottrico16. L’apparente in-compatibilità tra le tecniche di meditazione ignaziane e i giocosi intrattenimenti di corte kircheriani non deve trarre in inganno: in un contesto mutato, ma pur sempre segnato da esigenze pe-dagogiche, Kircher offre ai suoi spettatori l’esteriorizzazione dell’immaginazione, ottenuta tramite congegni che rendono vi-sibile la dissezione dei “moti dell’animo”17.
14 Un buon esempio di admiranda con finalità devozionale è riportato da Kircher nell’Ars magnesia: «Si intaglino le statue di Cristo e di Pietro dal materiale più leggero possibile […] ponendo una potente calamita nel petto di Pietro, e con Cristo che tende le braccia o con una qualsiasi parte della sua veste protesa verso Pietro, realizzate con un buon acciaio, si disporrà del necessario, atto ad illustrare la storia. Con glia arti infe-riori ben sostenuti da sugheri, sì da mantenere una certa stabilità sull’acqua, si pongano le statue in un bacile ricolmo fino all’orlo di quello stesso liquido, e le mani in ferro del Cristo sentiranno la forza d’attrazione esercitata dalla calamita collocata nel petto di Pietro. L’effetto sarà sorprendente se, al centro, la statua del Cristo sarà snodata, poiché in questo modo si porgerà in avanti con grande stupore e devozione degli spettatori» (Cit. in M. Gorman e N. Wilding, La cultura barocca delle macchine, cit., pp. 234-235. Gorman e Wilding interpretano l’episodio alla luce della ripresa, con intenti pedagogici, della magia naturale).
15 Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, in Gli scritti, a cura di M. Gioia, UTET, Torino 1977, p. 113.
16 Cfr. Athanasius Kircher. Il museo del mondo, cit., pp. 250-53. 17 La devozione kircheriana per Sant’Ignazio è testimoniata dalla sua intenzione di
dedicare gli ultimi anni di vita alle pratiche contemplative descritte negli Esercizi igna-ziani, cfr. P. Findlen, The Last Men Who Knew Everything … or Did He?, cit., p. 2.
Capitolo III 122
La centralità della musica e del teatro nella pedagogia gesui-tica discende dallo stesso principio di espressione, riassunto dal-la teoria degli affetti esposta nel settimo libro della Musurgia universalis (1650): l’affectus è una passività dell’animo, a cui qualsiasi uomo può venire piegato mediante i giusti suoni. Il sonus miracolosus e il sonus prodigiosus sono l’equivalente musicale del mirabile visivo, fenomeni straordinari sfruttabili per ottenere il controllo del «comportamento morale delle mas-se»18.
Stupore e devozione, dunque la programmatica commistione gesuitica dell’utile e del dilettevole, allestiti con la dignità ceri-moniale che si addice al pubblico aristocratico del museum, co-stituiscono l’impalcatura performativa della pedagogia militante gesuitica. L’obiettivo è l’imposizione, o la simulazione nel caso di un spettatore dotto, dell’autorità, sullo stesso modello del mi-racolo cristiano:
Vediamo che a volte Dio nostro Signore concorreva con miracoli per confermare questo modo di obbedienza […] Volevo rilevare che que-sto modo di sottomettere il giudizio proprio, presupponendo che quan-to viene comandato sia santo e conforme alla divina volontà, senza ul-teriore investigazione, è in uso presso i santi e deve essere imitato da qui vuole obbedire perfettamente in tutte le cose dove non ci fosse peccato evidente19. Così come l’autorità limita le possibilità, il potenziale spet-
tacolare gesuitico confina i suoi intrattenimenti in uno spazio chiuso: interiorità dell’animo, luoghi appartati di meditazione, Wunderkammer, teatri di collegio: «Da lungo tempo esistono luoghi in cui tutto ciò che è dato a vedere si trova al di dentro: cellula, sacrestia, cripta, chiesa, teatro, studio di lettura o di
18 H. Pfeiffer, La radice spirituale dell’attività teatrale della Compagnia di Gesù
negli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio, in M. Chiamò e F. Doglio (a cura di), I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa, Viterbo, Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1995, p. 37.
19 Ignazio di Loyola, Epistolario, in Gli scritti, cit., p. 793.
Strumenti meravigliosi 123
stampa. Sono questi i luoghi che il Barocco privilegia, facendo-ne emergere tutta la potenza e la gloria»20.
Gli automata kircheriani sono oggetti materiali animati da un «prodigioso movimento ad un’immagine»21, come le statue di Dedalo, i tripodi e le ancelle di Efesto, ma «il termine greco automaton si riferisce anche al caso, dove la connessione tra i due significati consiste nel fatto che ciò che possiede una volon-tà propria può anche agire indifferentemente dai nostri interes-si»22. Oltre che imitazione dell’antico, gli spectacula meccanici, come il miracolo, effettivo o simulato che sia ad opera della magia naturale, sono figure dell’autorità divina, imitatio Dei; essi servono per esercitare i superiori all’imposizione sottile dell’autorità e per esortare i fedeli a riconoscere in essa l’unica traccia del divino: «Vorrei dunque che tutti vi esercitaste a rico-noscere in qualsiasi superiore Cristo nostro Signore e a riverire ed obbedire con ogni devozione, nella sua persona, alla sua di-vinità»23.
Musica, retorica sacra, teatro e Wunderkammer poggiano, nella prassi polemologico-morale della Compagnia di Gesù, sulla stessa filosofia pratica24. Nel Collegio Romano elementi
20 G. Deleuze, La piega. Leibniz e il Barocco, n. ed. a cura di D. Tarizzo, Einaudi,
Torino 2004, p. 46. 21 A. Kircher, Magnes (1653), Liber II, Pars 4, p. 238, cit. in M. Gorman e N. Wil-
ding, La cultura barocca delle macchine, cit., p. 234. 22 D. Summers, Real Spaces. World Art History and the Rise of Western Modern-
ism, Phaidon, New York 2003, p. 327. 23 Ignazio di Loyola, Epistolario, cit., p. 786. L’essenziale degli artificialia kirche-
riani è che essi “sembrino miracoli”, che siano animati e sorprendenti, vere e proprie macchine taumaturgikai. La magia naturale è l’ambito tassonomico entro cui collocare questi fenomeni che sfuggono all’orizzonte oggettuale della fisica aristotelica. Ampia fortuna ebbero nel Medioevo e nel Rinascimento gli automi descritti da Erone di Ales-sandria, fonte privilegiata anche di Kircher, il quale vi fa riferimento nell’Oedipus Ae-gyptiacus (1653), cfr. Athanasius Kircher. Il museo del mondo, cit., pp. 248-56. Fra i numerosi studi dedicati alla storia degli automata, cfr. E. Battisti, L’antirinascimento, con una appendice di manoscritti inediti, Feltrinelli, Milano 1962.
24 «Una volta fatte tutte queste composizioni di luogo come preludio ad una medita-zione, diventava abitudine, e dall’abitudine interiore si passava alla traduzione esterna. Il passaggio dalla composizione del luogo alla composizione delle quinte teatrali non ha bisogno del ricorso al libro degli Esercizi. È un passaggio organico e vitale […] Per muovere la volontà degli uomini verso il bene e verso la volontà di Dio si deve presen-tare dei modelli quanto più vivi […] Il teatro gesuitico ha visto questo scopo. Gli eserci-
Capitolo III 124
salienti degli Esercizi spirituali – le vedute immaginative, il “sentire la conoscenza”, lo sviluppo dell’obbedienza e della passività, la ripetizione e automatismo pedagogico, il primato del miracoloso e dell’exclamar admirando, l’intimità delle sce-ne – sono adattati a una cultura aristocratico-curiale. Il rialle-stimento del musaeum mathematicum originario in una quinta di oggetti prodigiosi e la trasformazione del Kircher-matematico in scenografo della sapienza e della scienza natura-le, storica e matematica corrispondono allo sviluppo del teatro del Collegio Romano, le cui opere edificanti venivano allestite a pochi passi dalle sale del museo.
«L’intreccio barocco si sviluppa, si potrebbe dire, come un cambio di scena a sipario alzato»25. Nel teatro di collegio, il tes-suto narrativo del dramma classico subisce una frammentazione spettacolarizzante, dal momento che i Prologhi e gli Intermezzi diventano occasioni per soluzioni sceniche prodigiose: discese dalle nuvole, caroselli, apparizioni miracolose e guadagnano au-tonomia a scapito dell’unità compositiva26. Ancora una volta, è la sospensione dell’ordinario, in nome del prestigio della visio-ne eclatante, a sorreggere il teatro di collegio e ad imporre le sanzioni della sovranità dispotica: «però che dalla meraviglia nasce il diletto, come da’ repentini cambiamenti delle scene»27.
zi presentano la vita di Gesù come modello fondamentale […] Il teatro gesuitico ha avu-to lo stesso scopo, ma non per un singolo uomo, ma per la grande massa, alla quale vengono presentati dei modelli da imitare o rifiutare […] Così l’attività teatrale è servita a un doppio scopo: la formazione degli alunni e l’influsso sul comportamento morale delle masse. Tutte e due hanno le loro radici nell’esperienza spirituale di Sant’Ignazio. Gli esercizi costituiscono la partecipazione a questa esperienza e nello stesso tempo so-no l’anima di tutta l’attività apostolica della Compagnia di Gesù», H. Pfeiffer s.j., La radice spirituale della Compagnia di Gesù negli “Esercizi spirituali” di Sant’Ignazio, in I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa, cit., pp. 32-7.
25 W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, trad. it. di E. Filippini, Einaudi, Tori-no 1971, p. 60.
26 Cfr. B. Filippi, Il teatro al Collegio Romano: dal testo drammatico al contesto scenico, in I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa, cit., pp. 165-76. Della stessa autrice cfr. anche Il teatro degli argomenti. Gli scenari seicenteschi del teatro ge-suitico romano, Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma 2001.
27 E. Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, a cura di E. Raimondi, Einaudi, Torino 1978, p. 68.
Strumenti meravigliosi 125
La scena teatrale gesuitica condivide le caratteristiche del museo kircheriano, tradendo la comune origine dalla pedagogia ignaziana: entrambi sono luoghi separati, loci mentali ancor prima che spazi fisici, che istruiscono l’allievo a modificare l’otium in ludus e il ludus in una macchina ideologico-esortativa in grado di imbrigliare gli affetti e la volontà28.
La metafisica dell’autorità contenuta nella riformulazione kircheriana del meraviglioso è enunciata programmaticamente nel Cannocchiale aristotelico di Emanuele Tesauro (1670):
Ancora il grande Iddio, godé talora di fare il poeta e l’arguto favellato-re, motteggiando agli uomini e agli angeli con varie imprese eroiche e simboli figurati gli altissimi suoi concetti. E a giuste ragioni. Primie-ramente, acciò che l’ingegno divino non ceda punto all’umano, né quella mente isterilisca, la qual feconda di concetti le altre menti […] Dipoi, acciò che lo stile della divina maestà non senta punto del trivia-le, ma da nobili figure si sollievi in guisa che la sublimità generi me-raviglia, e la maraviglia venerazione. Inoltre, acciò che la verità, per sé amara, col vario condimento di concettosi pensieri si raddolcisca. Finalmente, acciò che ll’ottusae temeraria turba non si presuma inter-prete de’ divini concetti, ma solo i più felici e acuti ingegni, consape-voli de’ celesti segreti, ci sappiano dalla buccia della lettera snoccola-re i misteri ascosi, e con subalternate influenze il nume impari da sé solo, il savio dal nume, l’idioto dal savio29. I paradossi dell’ingegno, le sue stupefacenti congiunzioni,
non sono che riflessi del dispotismo teologico della «divina ma-està». Dio desta meraviglia e “motteggia agli uomini”, celando-si ed ingannandoli, per 1) affermare la propria trascendenza («acciò che l’ingegno divino non ceda punto all’umano»); 2) trattenere i fedeli in una condizione di passiva contemplazione («ma da nobili figure si sollievi in guisa che la sublimità generi maraviglia»); 3) occultare la durezza del dominio con il piacere («acciò che la verità, per sé amara, col vario condimento di concettosi pensieri si raddolcisca»); 4) istituire una gerarchia
28 B. Filippi, Il teatro al Collegio Romano, cit. pp. 181. Per una discussione del rap-
porto tra scena classica e spazio derealizzato delle azioni sceniche, cfr. P. Lacou-Labarthe, J.-L. Nancy, Scena, «Aut Aut», n. 258, 1993, pp. 3-28.
29 E. Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, cit., p. 18.
Capitolo III 126
immutabile fondata sull’accesso alla sapienza («con subalterna-te influenze il nume impari da sé solo, il savio dal nume, l’idioto dal savio»). Gli aspetti ludici ed “estetici” del museum – rarità, varietà, complicazioni, illusionismo, esotismo – appar-tengono all’epistemologia della meraviglia e questa alla teolo-gia dell’autoritarismo.
Lontananze
Queste son le forme categoriche de’ mirabili. Ora io vo’ discoprirti quattro miniere che somministrano copiosa materia a queste forme: però che alcuni son mirabili per natura, altri per arte, altri per nostra opinione, altri per nostro finimento […] Vengo a quelle dell’arte, in-gegnosa machinatrice di strane e argutissime opre, come ti dissi. Tal è la nave, che guizza come pesce e non è pesce, vola come uccello e non è uccello, nata in terra, cammina come il mare, porta gli uomini sicuri, benché sol quattro dita lontani dalla morte. Tal è l’oriuolo a ruota, che sempre corre e non si muove, non è astrologo e mostra i tempi, benché menta sovente. Tai son le colombe di Archita: uccelli insensati che non sono vivi e pur volano, di nulla si pascono e pur non muoiono. Tai sono i libri, maraviglioso ritrovo dell’intelletto, che han parole e non han lingua, non han discorso e discorrono, non san leggere e ogni scienza ci ‘nsegnano30. Con la loro ambiguità, le astruserie tecniche e i rimandi po-
lemici cifrati, i jucunda spectacula kircheriani rappresentano un esempio privilegiato dell’arte «ingegnosa machinatrice di strane e argutissime opre». L’incomprensione degli obiettivi di Kir-cher non è soltanto affare moderno, se anche personalità come Cartesio, Huygens e Torricelli non furono in grado di accedervi:
L’opera stampata è un volume assai grosso sopra la calamita; volume arricchito con una gran suppellettile di bei rami. Sentirà astrolabi, oro-logi, anemoscopi con una mano poi di vocaboli stravangantissimi. Fra
30 Ivi, p. 86. Il titolo del trattato del Tesauro, “cannocchiale aristotelico”, è un para-
dosso ingegnoso che assume come sua materia uno strumento tecnico. Nella tavola illu-strativa che accompagna il volume del Tesauro (cfr. la ristampa anastatica Savigliano, Cuneo 2000) un Aristotele che sorregge un telescopio permette di scoprire le macchie solari; si tratta dunque della congiunzione delle due “lontananze” della scienza galileia-na e dell’aristotelismo.
Strumenti meravigliosi 127
l’altre cose poi vi sono moltissime caraffe e carraffoni, epigrammi, di-stici, epitaffi, inscrittioni, parte in latino parte in greco, parte in arabi-co, parte in ebraico et altre lingue […] Basta, il Signor Nardi, Mag-giotti et io habbiamo riso un pezzo»31.
Pur cogliendo la matrice enciclopedica del “kircherismo”,
Torricelli non cede allo stupore. In termini aristotelici è questa la corretta reazione di uno spettatore erudito, ma poiché Torri-celli non condivide i presupposti “concettosi” degli admiranda kircheriani, egli non partecipa al gioco dello svelamento e rea-gisce con dileggio.
Virtuoso scenografo dei “mirabili per arte” descritti dal Te-sauro, Kircher ne sperimenta tutte le forme: le navi – la piccola enciclopedia nautica che accompagna la narrazione del diluvio nell’Arca Noë (1675) –, gli innumerevoli “orioli” e le finte co-lombe volanti del museum, i libri dei segreti che “ogni scienza ci ‘nsegnano”. Il museo kircheriano, affine al museo Chigi di Roma e a quello milanese di Manfredo Settala, condivide di en-trambi la passione per i mirabilia tecnologici e la ripresa degli elementi sofistico-illusionistici della meccanica classica. Allie-vo del retore gesuita Emanuele Tesauro, il collezionista-inventore Manfredo Settala – l’“Archimede milanese” – incor-pora nel suo museo una “maraviglia” concettosa, innescata dal «ligare insieme le remote e separate nozioni»32. Il suo è un “tea-tro di invenzioni”, che include sia gli strumenti d’indagine natu-ralistica della tradizione galileiana, sia marchingegni emblema-tici, in particolare congegni che simulano il moto perpetuo. Le due dimensioni convivono senza difficoltà, “ligate” dalla loro lontananza, come dettato dalla retorica del Tesauro.
L’unione di cose lontane, il trovare «in cose dissimiglianti la simiglianza» in cui consiste il thauma, il “mirabile”, è
31 È questa la descrizione torricelliana del Magnes, in una lettera a Galileo, cit. in
M.G. Ianniello, Kircher e l’Ars magna lucis et umbrae, in Enciclopedismo in Roma ba-rocca, cit., p. 223. In una lettera a Marsenne, Cartesio definisce Kircher «un ciarlatano piuttosto che uno studioso» e Huygens mette in guardia Cartesio nei confronti delle sue mistificazioni.
32 E. Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, cit., p. 67.
Capitolo III 128
d’altronde una prerogativa dell’ingegno33. La somiglianza come figura del transito ingegnoso non va perciò ricondotta alla sinte-si o all’analogia. «Ma voglio io qua palesarti il più astruso e se-greto, ma il più miracoloso e fecondo parto dell’umano ingegno […] Questi è quegli che grecamente chiamar possiamo thauma, cioè “il mirabile”, il quale consiste in una rappresentazione di due concetti quasi incompatibili e perciò oltremirabili»34. La logica da cui scaturisce la meraviglia è quella del paradosso, la cui figura principale secondo Francessco Patrizi consiste nell’accostamento di “lontananze” e tra queste l’unione del cre-dibile e dell’incredibile, ottenuta grazie a «lo innalzamento del-le cose oltre al verisimile e al credibile»35. Il paradosso mantie-ne intatto, nella congiunzione, l’ordine delle lontananze: del di-vino e dell’umano, del necessario e del suo contrario, del possi-bile e dell’impossibile, dell’avvenuto e del non avvenuto, del vero e del falso, del verosimile e del falsosimile36. Allo stesso modo, il meraviglioso presuppone il “mescolamento” dell’umano e del divino, del credibile e dell’incredibile: «A-dunque il mescolamento di ambedue, credibile ed incredibile, farà la maraviglia, ed il mirabile sarà non altro che un cotale congiungimento, di che di incredibili divengano credibili, o di credibili divengano incredibili»37. Patrizi teorizza addirittura la possibilità di effettuare un “calcolo delle lontananze”, moltipli-candole «sino alla somma di settantacinque» sulla base di un complesso “congiungimento dei lontani” di stampo combinato-rio38. L’invenzione di collezioni di mirabilia paradossali e la celebrazione dell’“argutezza” da parte dei teorici barocchi – Gracián e Tesauro su tutti – si configura come una ricognizione delle forme della lontananza. Si tratta del dispiegamento di una logica macchinica, che non contempla la verità ma costruisce
33 Ibidem 34 Ivi, p. 84. 35 F. Patrizi da Cherso, Della poetica, ed. critica a cura di D. Aguzzi Barbagli, vol.
II, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, Firenze 1969, p. 303. 36 Ivi, p. 311. 37 Ivi, p. 310. 38 Ivi, p. 312.
Strumenti meravigliosi 129
relazioni tra i “remoti” e i “separati”. Le relazioni sono ingra-naggi retorici, commutatori disgiuntivi che non predicano il ve-ro ma funzionano, si offrono teatralmente a uno spettatore gene-rando stupore.
Una delle fonti principali del thauma greco sono i teatri di automi, “macchine taumaturgiche” la cui funzione è di ergersi sulla materialità affermando l’animazione di ciò che è in realtà inerte:
“Meccanica” significava originariamente l’arte d’inventare cose inge-gnose, la creazione di effetti che non potevano essere compresi […] La meccanica greca continuò ad essere accompagnata da un’apparenza di vita simile a quella di Dedalo, gli automata vennero inventati non soltanto per risolvere problemi pratici ma anche per ge-nerare stupore, così come marchingegni ancor più pratici come le pu-legge e gli argani usati sulle navi furono usate a teatro per il deus ex machina39. Fedele alla teologia controriformistica piuttosto che al poli-
teismo e al naturalismo greco, il movimento che produce la me-raviglia delle collezioni kircheriane non rimanda a un principio sostanziale di animazione ma celebra l’eteronomia della vita e l’autorità della morte, l’unica evidenza della realtà divina.
Gli artifici e le curiosità kircheriane sono false apparenze dell’autosufficienza del mondo, dimostrazioni ingegnose, e dunque celate agli occhi dei fisici, del collasso del naturalismo aristotelico e della sua pretesa di fondare in se stesso il movi-mento. Poiché non dissimula il vero ma finge l’impossibile, la mechane kircheriana è una simulazione, non una dissimulazio-ne: «si simula quello che non è, si dissimula quello che è»40. Di qui la preminenza emblematica attribuita nel museo kircheriano e in quello di Settala alle macchine per il moto perpetuo, “mac-chine taumaturgikai” che vivono nella negazione dell’esaurimento del movimento impresso da forze magnetiche e idrauliche e trasmesso da meccanismi celati. In questo modo,
39 D. Summers, Real Spaces, cit., p. 327. 40 T. Accetto, Della dissimulazione onesta, a cura di S.S. Nigro, Einaudi, Torino
1997, p. 27.
Capitolo III 130
fisica aristotelica e teologia cristiana non vengono sintetizzate ma accoppiate in modo “illegittimo” (Tesauro), tramite un’ingegnosa celebrazione della fisica aristotelica che in verità nasconde la sua obsolescenza41. Il meraviglioso “animato” del dux mechanicus Kircher afferma nel paradosso i diritti della materia. Le apparenze seducenti del museum sono inganni pro-dotti da un gioco incessante di tiri mancini, le macchinazioni, le inversioni, i paradossi escogitati per celare episodicamente, con la forza del paradosso, l’inerzia della materia: «il puro diverti-mento è il rovescio interno obbligato del lutto che ogni tanto viene in luce come l’imbottitura del vestito nell’orlo o nel ri-svolto»42. L’efficacia performativa del paradosso, la sua arte di fingere l’impossibile, è l’unica traccia della divinità, che la con-troriforma esalta nella sua potentia absoluta. Nell’inganno co-me imitazione della creatio ex nihilo si sposano i trucchi dell’arte e la diabolicità della materia.
Come una “macchina celibe” teorizzata da Michel Carrou-ges – un artificio concettuale che «impiega una straordinaria dovizia di mezzi complicati per produrre effetti di meraviglia raffinati e orribili» – le invenzioni kircheriane non sono «mac-chine di officina o di laboratorio, ma macchine di spettacolo»43. La loro logica concettosa è un’ostensione del fatto che esse so-no innanzitutto «macchine mentali, il cui funzionamento imma-ginario serve a produrre un movimento reale dello spirito»44. Occultando le intenzioni del loro autore, esse indicano la ca-pricciosità del loro creatore e questa l’arbitrio divino:
41 In Instruments and the Imagination (Princeton University press, Princeton 1999,
pp. 14-36) Thomas L. Hankins e Robert J. Silverman considerano l’orologio girasole, e in generale i congegni magnetici kircheriani, degli “esperimenti elaborati”, che mostra-no la realtà del magnetismo cosmico nel modo della testimonianza dei sensi (la demon-stratio ocularis) piuttosto che attraverso dimostrazioni fondate sulla prova. A mio avvi-so, questo livello interpretativo ne nasconde un altro, quello teologico della potenza di-vina simulata dagli inganni visivi.
42 W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, cit., p. 122. 43 M. Carrouges, Come inquadrare le macchine celibi, in AAVV, Le macchine ce-
libi/Bachelor Machines, cit., p. 44. 44 Ivi, p. 44.
Strumenti meravigliosi 131
La macchina celibe può dunque essere costituita da una sola macchina bizzarra e sconosciuta, o da un insieme apparentemente eteroclito di parti […] La macchina celibe non ha la sua ragion d’essere in se stes-sa, come macchina governata dalle leggi fisiche della meccanica o dalle leggi sociali dell’utilità. È un simulacro di macchina […] Guida-ta essenzialmente dalle leggi mentali della soggettività, la macchina celibe non fa che adottare certe figure meccaniche per simulare certi effetti meccanici. Soltanto quando si scoprono, a poco a poco, gli in-dizi di questa determinazione soggettiva, si vede dissiparsi la nebbia dell’assurdo e levarsi l’alba di una logica implacabile45. La specificità della metafora, la “figura ingegnosa” quintes-
senziale, non un’analogia ma un “trabocchetto” come la techne aristotelica, è realizzata secondo il Tesauro da ciò che «portan-do a volo la nostra mente da un genere all’altro, ci fa intravede-re in una sola parola più di un obietto»46. In quanto mirabili, posti in sospensione dalla comparazione ingegnosa, gli oggetti di Kircher e Settala non segnalano l’avvenuta riconciliazione della frantumazione culturale ma la sua intensificazione esposi-tiva: la metafora concettosa non è un’arte della somiglianza fondata sull’analogia entis, bensì una tecnica di fissazione dell’eterogeneità, un «intravedere in una sola parola più di un obietto». Il thauma sorge dal predicare un medesimo termine di più soggetti e l’analogia è una forma temperata dell’equivocità, una forzatura semantica prodotta da un corto-circuito: «L’essenza dell’ingegno dev’essere cercata nel transito […] L’ingegno è trasformare la natura in cultura, ma la perfezione della cultura è quella di sembrare naturale: il maggior artificio consiste nel nasconderlo»47.
45 M. Carrouges, Istruzioni per l’uso, in AAVV, Le macchine celibi/Bachelor Ma-
chines, cit., p. 21. La più articolata ripresa della teoria delle macchine celibi si trova in G. Deleuze, F. Guattari, L’anti-edipo: capitalismo e schizofrenia, trad. it. di A. Fontana, Einaudi, Torino 2002.
46 E. Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, cit., p. 8. 47 M. Perniola, Presentazione, in B. Grácian, L’acutezza e l’arte dell’ingegno, trad.
it. di G. Poggi, Aesthetica Edizioni, Palermo 1986, p. 14.
Capitolo III 132
Accoppiamenti celibi Un luogo comune tenace, suffragato dai testi platonici e ari-
stotelici e rimesso in circolazione dall’Umanesimo italiano, as-segna all’esperienza dello stupore, al “meravigliarsi” (thauma-zein), l’origine della filosofia: «Infatti gli uomini hanno inco-minciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meravi-glia»48. In quanto stupore artificiale sprigionato da un enigma, generato tecnologicamente e fondato sull’inganno dei sensi, la meraviglia kircheriana è al contempo un’imitazione e una deco-struzione del thauma filosofico. A ben vedere, poiché annidati negli schemi di produzione degli artifici kircheriani vi sono congegni nascosti e rebus semantici, essi rispettano la pedago-gia aristotelica del meravigliarsi, che prescrive la necessità del superamento dell’illusione una volta afferrate le cause dei fe-nomeni. Ad esempio, la Colomba volante di Archita descritta nel Magnes è uno spettacolo che «sembra tanto inconsueto e prodigioso a coloro che non ne conoscono la causa che quando l’ho presentato molti, stupiti, si sono così ostinati a credere che avvenisse per magia che quasi nessun ragionamento ha potuto persuaderli del contrario»49.
In ragione della loro dilettosità, gli oggetti fantastici kirche-riani sono exempla didatticamente utili a evocare e dar forma al-le passioni degli spettatori, loci visuali come quelli prescritti da Ignazio di Loyola50. Il ricorso al meraviglioso giustifica la ca-ratteristica più singolare, per noi contemporanei, delle collezio-ni barocche: la compresenza di naturalia ed artificialia, di cu-riosità naturali e ritrovati meccanici, la giustapposizione di fos-sili, animali imbalsamati, fontane, orologi, strumenti catottrici. Persino le collezioni d’impianto naturalistico, ad esempio il
48 Aristotele, Metafisica, I, 982 b 12. 49 Cit. in F. Camerota, Ricostruire il Seicento: macchine ed esperimenti, in Athana-
sius Kircher S.J. Il museo del mondo, cit., p. 243. 50 «La sua capacità di stupire attraverso mirabili esposizioni è ricordata da Gaspar
Schott che vede nel maestro l’attore, il regista e il poeta di un mondo enciclopedico in cui la conoscenza si trasmette attraverso un’esperienza ludica che ha per oggetto la per-suasione dei sensi» (F. Camerota, Ricostruire il Seicento, cit., p. 239).
Strumenti meravigliosi 133
grande “studio” di Ulisse Aldrovandi, subirono riordinamenti spettacolarizzanti, nel solco del mirabile barocco, un perturban-te acuto e strategico, la cui forza discende dalla complessità dell’allestimento delle lontananze51.
Il territorio della magia naturale e degli automata, per la sua difficile collocazione nell’enciclopedia del sapere controrifor-mistico, fornì uno spazio di espansione ideale alla poetica del movimento e alla retorica dello stupore: «L’apparato crea – co-me il carnevale – una zona di licenza, dove il capriccioso, l’assurdo, l’impossibile è lecito; e dove invenzioni, ritenute in-decorose nell’arte sacra o in sede monumentale, diventano legit-time e generalmente accolte»52. Kircher coglie il potenziale e-sortativo dei teatri di macchine, una tradizione antichissima, culminata nei fasti dei virtuosistici apparati scenici rinascimen-tali ripresi dalle coreografie celebrative barocche, in cui pertur-bante animazione ha la meglio sulle intenzioni simboliche. Più che il repertorio convenzionale di topoi meccanici – colombe volanti, statue parlanti, specchi ustori, orologi zodiacali, genietti danzanti, sfere armillari, fontane con serpenti, uccelli e perso-naggi mitologici, prospettive architettoniche, organi idraulici – le invenzioni kircheriane stupiscono per gli accoppiamenti in-gegnosi, ad esempio per la sovrapposizione di fisica aristotelica e immagini sacre («un globo grande di cristallo pieno d’acqua che rappresenta la Resurrezione del Salvatore in mezzo alle ac-que») e per i legami spericolati dell’inaccoppiabile: ad esempio, nelle macchine del moto perpetuo, il matrimonio artificiale di materialità e trascendenza, di inerzia e animazione, di morte e
51 Cfr. P. Findlen, Possessing Nature. Museum, Collecting, and Scientific Culture in
Early Modern Italy, University of California Press, Berkeley 1994, p. 27. 52 Cfr. E. Battisti, L’antirinascimento, cit., pp. 230. «L’età, a cavallo tra il cinque ed
il seicento, è come ossessionata dal movimento: prima negli intermezzi, poi nelle fonta-ne, quindi, nell’arte monumentale […]; il movimento distrugge […] ogni funzione sim-bolico-tematica tradizionale trasponendo la scena su un altro livello» (ivi, pp. 247, 252). Secondo Battisti, nella storia degli automi il filone magico, quello scientifico-sperimentale e quello ludico corrono paralleli almeno sino al Settecento (ivi. p. 455). In Kircher, la confluenza di militanza missionaria, intrattenimento cortigiano, erudizione umanistica e interessi scientifici rende non pertinente la separazione di tecnologia ludi-ca, magica e sperimentale.
Capitolo III 134
vita, realizza un’efficace simulazione dell’intervento della gra-zia. Il mirabile che vi corrisponde, al confine dell’impostura, è un legame di “lontananze”, l’arte di far fare ingranaggio ad es-seri remoti per metterli in movimento, la produzione di relazio-ni disgiuntive che lasciano intatti i termini di partenza pur pren-dendoli in trappola tramite una macchinazione. E appunto un dolon, una “trappola”, è tesa da Efesto ad Afrodite e Ares trami-te catene invisibili, così come dolos è il “trucco”, la techne al servizio dell’astuzia, la creazione di effetti imprevedibili tramite congegni nascosti53. Come nelle macchine del moto perpetuo, la suprema macchinazione consiste nell’accoppiamento della morte con il soffio divino, nell’accostamento della finitezza di ciò che è corruttibile all’assolutezza di ciò che tutto muove.
Da Erone a Kircher i principi restano pressoché invariati: per quanto complessi i congegni barocchi sono macchine statiche a cui resta estraneo il motore, la fonte del movimento:
Continuando il lavoro dei meccanici greci, l’età classica sviluppa la teoria delle macchine semplici […] La teoria è innanzitutto una stati-ca, e l’oggetto è una statua. Mobile o immobile, funziona mediante o verso il riposo, la stabilità, l’equilibrio: è uno statore […] Questo resta vero per gli ingranaggi e per gli orologi, come per gli edifici, i portici, i templi, gli automi e le macchine calcolatrici, gli strumenti musicali e gli uccelli parlanti. Essi trasmettono il movimento lo propagano, lo in-vertono, lo duplicano, lo espongono, lo trasformano, lo annullano. Quale che sia la complessità del progetto, essi sono un passaggio dal movimento al riposo54. E tuttavia, negli automata barocchi la meccanica statica è
posta al servizio di un fine opposto, lavora “contro natura” per simulare un movimento in sé. Producendo ciò che è raro e im-
53 G. Cambiano, Automaton, «Studi Storici», anno 35, n. 3, 1994, pp. 623-624. 54 M. Serres, È stato prima dell’esposizione (universale), in AAVV, Le macchine
celibi/Bachelor Machines, cit., p. 64. Anche il magnetismo è introdotto nelle invenzioni kircheriane per estendere astutamente la trasmissione del moto: ad esempio nell’orologio magnetico (fig. 2) la calamita svolge la funzione di un ingranaggio nasco-sto piuttosto che di una fonte di energia. Per questa ragione bisogna essere molto cauti, a mio avviso, nello scorgere nei mirabilia kircheriani una dimostrazione di postulati fi-sici o metafisici.
Strumenti meravigliosi 135
previsto tramite ciò che è disponibile tecnologicamente, fingen-do ciò che è animato per mezzo della materia inerte, nascon-dendo una causa in ciò che è manifestamente senza causa, gli automata kircheriani diventano «una sorta di doppio dell’evento automaton, casuale, raro e caratterizzato da una finalità inatte-sa»55. Sullo sfondo, una diversa interpretazione dell’automaton, dell’evento imprevisto trattato da Aristotele nella Fisica. Là do-ve in Aristotele l’automaton è una simulazione accidentale di un processo orientato verso un fine, e dunque appartiene alla tyche, in Kicher la potenza di agire contro natura, che anche se-condo Aristotele è la vera causa della meraviglia resta preroga-tiva divina. La simulazione macchinica è una simulazione di se-condo grado, copia di copia, imitazione della divina potestà; gli automata kircheriani sono a ragion veduta un doppio dell’evento automaton in senso cristiano.
L’essenziale delle macchine kircheriane non è dunque il movimento visibile bensì l’artificio che le dota di un motore in-visibile, un motore “concettuale”: grazie all’efficacia della contaminatio, del coniugium, dei “ligami”, come a dire dei tran-siti sospesi teorizzati da retori come il Tesauro e Gracián, la te-chne ludico-teurgica kircheriana sfugge al controllo della mec-canica e afferma un’interpretazione controriformistica dell’automaton aristotelico. Negli eventi inattesi, che non rien-trano nei regolari processi naturali, non opera il caso, ciò che è accidentale e desta meraviglia, bensì il miracoloso, la cui strut-tura esortativa è simulata dal museum del Collegio romano: «generando meraviglia, paura e divertimento le magiche mac-chine di Kircher indussero i suoi visitatori a confrontarsi con il miracoloso e il demoniaco»56.
55 G. Cambiano, Automaton, cit., p. 633. 56 M.J. Gorman e N. Wilding, La cultura barocca delle macchine, cit., p. 235. Poi-
ché la finalità del miracolo è “retorica”, la simulazione tecnica e gli artifici teatrali ne costituiscono il corretto adattamento devozionale, la più efficace traduzione per una ec-clesia militans. Ciò spiega l’assenza in Kircher di un’impalcatura teologica sistematica. Essa non è necessaria, poiché Dio va imitato nella sua operatività, non nella sua essen-zialità, al fine di accrescere la gloria di Dio.
Capitolo III 136
L’arguzia più sottile delle macchine kircheriane consiste nel-la doppia finalità degli effetti “taumaturgici”. La messa in scena dei trucchi della magia naturale non è funzionale soltanto allo smascheramento dei falsi miracoli, ma si presenta come una si-mulazione dei veri miracoli; le trappole macchiniche sono esi-bizioni dell’ingenium divino, imitazioni dell’arte dell’inganno, della sorpresa di ciò che non risponde alle leggi naturali. Più che “analogie della natura”, ad esempio del magnetismo cosmi-co, gli strumenti kircheriani sono analogie dell’assolutismo di-vino57. La commistione di retorica dell’ingegno e di meccanica ludica è funzionale all’esposizione della potenza dissimilante del divino e alla produzione della “stupidità” tramite lo stupore, dell’asservimento all’illusione, al mirabile e dunque all’autorità. Con le sue macchine-dolon, il museo kircheriano adatta al mondo cristiano le prerogative fondamentali degli Dei pagani: prendersi gioco degli uomini, trascinarli nei labirinti dell’apparenza, sedurli58. E poiché, a differenza delle litigiose e “incompatibili” divinità classiche, il Dio cristiano non è impe-gnato in una lotta con entità di pari grado, l’inganno si esaurisce nell’allestimento di uno spettacolo di cui l’autore possiede i se-greti e di cui lo spettatore subisce gli effetti. La meccanica ari-stotelica è posta al servizio dell’occultamento dell’arche, non dello svelamento delle cause: «gli artefici predispongono uno strumento nascondendone il principio, in modo che sia manife-sto solo l’aspetto meraviglioso del meccanismo, mentre la causa rimane oscura»59.
57 «Gli strumenti di Kircher sono analogie della natura. Essi imitano la natura piut-
tosto che testarla o indagarla», T. Hankins, R.J. Silverman, Instruments and the Imagi-nation, cit., p. 32, trad. it. mia.
58 Alle seduzioni kircheriane cedettero quasi tutti gli ingegni del secolo. Significati-va è la burla dell’orologio-girasole, che trasse in inganno personalità come Cartesio, Mersenne e Peiresc: «Durante la primavera e l’estate del 1633, in Francia e Olanda tutti gli importanti filosofi naturali discussero l’orologio solare di Kircher […] L’orologio, come il manoscritto, sembrava essere un oggetto intrappolato dentro un labirinto di illu-sioni. Dopo la sua dimostrazione pubblica da parte di Kircher nei collegi gesuitici del sud della Francia, Peiresc giunse alla conclusione, del resto corretta, che non si trattasse di un orologio bensì di un magnete» (P. Findlen, The Last Men Who Knew Everything … or Did He?, cit., p. 15. Trad. it. mia).
59 Meccanica 1, 848 a 34-38, cit. in G. Cambiano, Automaton, cit., p. 623.
Strumenti meravigliosi 137
In quanto macchinazione dissimilante, il meraviglioso kir-cheriano unisce i trucchi della techne aristotelica all’adombramento e all’«opacizzazione dell’idea o verità, propri della tradizione esoterica del neoplatonismo»60. Nei confronti del suo pubblico, il museum è un ricettacolo di tecniche di per-suasione visuale, una fucina di stratagemmi spettacolari (il me-raviglioso); rispetto al suo creatore è una collezione di rebus tecnologico-allegorici (l’ingegno). Il legame di meraviglia e in-gegno, di stupore visivo e sprezzatura emblematica, di miraco-losità simulata e codici espressivi a chiave non presuppone un sistema filosofico ma si esaurisce nell’apologia pratica della simulazione. Il sodalizio illegittimo di lontananze realizza la lo-gica del mirabile kircheriano: «Uno strumento per Kircher illu-stra per imitazione un effetto meraviglioso in natura la cui causa è occulta», ma occulta soltanto per gli spettatori61.
Avendo a che fare con un intreccio di nascondimento ed ef-fetti meravigliosi, di stupore e inganno, il costruttore antico di automata si collocava «al di sopra del livello basso dell’animatore di marionette e al di sotto della demiurgica divi-na e magica»62. Per il Kircher-thaumatopoios gli ingredienti so-no gli stessi: statue e fontane animate e motori nascosti, illusio-nismo visivo ed effetti sorprendenti, rimandi mitologici e ripre-sa dei prodigi egiziani descritti da Erodoto. Ma la secolarizza-zione dei trucchi del sacro praticata da Aristotele ed Erone la-scia il posto in Kircher a una ri-sacralizzazione dei thaumata e degli automata, un aspetto essenziale del progetto culturale kir-cheriano, teso alla riabilitazione della matrice sacerdotale-egiziana a scapito del razionalismo greco-romano. Il taumaturgo gesuitico non ha bisogno di distinguersi dal burattinaio e dal demiurgo, dal momento che Dio stesso si serve del thauma per mettere in scena nel teatro del mondo lo spettacolo della sua po-tentia absoluta.
60 T. Accetto, Della dissimulazione onesta, cit., nota 1, p. 9. 61 T. Hankins, R.J. Silverman, Instruments and the Imagination, cit., p. 32, trad. it.
mia. 62 G. Cambiano, Automaton, cit., p. 627.
Capitolo III 138
Poiché la meccanica classica, tramandata dai testi alessan-drini, arabi e rinascimentali, è una tecnica di accoppiamento ce-libe, un trucco per prendere in trappola le forze della natura e, nell’agire contro di esse, generare stupore, essa si colloca sullo stesso piano di ciò che deve accoppiare. Anche la combinatoria, in Kircher, non è lo strumento di una mathesis divina, la minia-turizzazione matematica della totalità del cosmo, quanto un sot-toinsieme della meraviglia ingegnosa, una produzione di thau-mata il cui presupposto è il matrimonio di «due concetti quasi incompatibili» (Tesauro): «nella mathesis la coincidenza del metodo con il suo stesso oggetto sarà motivo di stupore»63.
Come gli Esercizi ignaziani, caratterizzati dalla tirannia della ripetizione e della scomposizione immaginativa64, la combina-toria kircheriana è una disciplina della ricognizione automatica ed ossessiva, un’attività che non ha nulla da spartire con l’aspetto inventivo della topica privilegiato da Leibniz. L’ossessività deriva dalla dissezione e classificazione infinita di ogni recesso del mondo e della conoscenza, e va ad alimentare una contabilità meccanica, sia essa genealogica o tecnologica: invenzioni come l’Organum mathematicum (1661) – uno stru-mento in grado di automatizzare l’apprendimento e l’esecuzione di complesse operazioni aritmetiche e geometriche65 – o il con-gegno per la composizione meccanica di brani musicali descrit-to nell’ottavo libro della Musurgia, non sono soltanto stravaganti anticipazioni degli automi illuministici o dell’estetica macchinica di Roussel, Duchamp e Tinguely, quanto deiezioni enciclopediche, strumenti per la produzione artificiale della meraviglia66. Anche il mirabile, il commutatore umanistico dell’enciclopedismo lulliano in simulazione, è sottoposto alla legge dell’accoppiamento paradossale e
63 G. Deleuze, Mathesis, scienza e filosofia, «Millepiani», n. 8, 1996, p. 18. 64 «Dal momento in cui appare, un oggetto, intellettuale o immaginario, è rotto, di-
viso, computato» (R. Barthes, Loyola, cit., p. 58). 65 Cfr. Athanasius Kircher. Il museo del mondo, cit., pp. 214-16. 66 Gli automi di Jacquet-Droz (lo scrittore, il disegnatore, la musicista), i teatri di
macchine di Roussel (nelle Impressions d’Afrique), le sculture per la creazione automa-tica di arte di Tinguely (la serie Méta-Matic), le macchine concettuali di Duchamp (il Grande vetro) sono altrettante riformulazioni delle macchinazioni dissimilanti kirche-riane.
Strumenti meravigliosi 139
legge dell’accoppiamento paradossale e s’innesta nelle macchi-ne combinatorie.
L’accoppiamento celibe per eccellenza è quello del divino e dell’umano, dell’arte e della natura: “Artis et naturae coniu-gium” recita il motto apposto alla raffigurazione kircheriana dell’orologio-girasole (fig. 1). L’espansione incontrollata del principio di autorità, divenuto nella concezione controriformi-stica una metafisica della sovranità dispotica, necessita di effetti scenici e di proliferazioni combinatorie. Nella formulazione benjaminiana, «le forme più esaltate del bizantinismo barocco non dissimulano neppure la tensione tra mondo e trascenden-za»67. Ciò corrisponde all’abolizione dell’escatologia e all’esteriorizzazione del rapporto tra vita e morte, tra soteriolo-gia e mitologia pagana, tramite una spaventosa macchina enci-clopedica, un «meccanismo che raccoglie ed esalta tutto ciò che è nato sulla terra, prima di consegnarlo alla morte»68.
In Kircher, la preminenza assunta dal mirabile, prudente-mente celato sotto il velo dello stupore filosofico platonico-aristotelico, oltre che la completa traduzione dell’interiorità dei moti dell’anima nella ricorsività dei movimenti meccanici degli automi segnala l’abbandono delle finalità dialogiche degli Eser-cizi ignaziani. Reinventati da scenografi-inventori gesuitici co-me Settala, Kircher, Schott e Lana-Terzi, gli Esercizi coloniz-zano l’intero campo della teologia e delle formule cerimoniali e pedagogiche, accentuano la loro «legge di dominio totalitario» enciclopedico: «tutto è ricoperto, rivestito, esaurito», le artico-lazioni occupano «la totalità del territorio mentale»69. In questo modo la piena accettazione della molteplicità e varietà del reale, un’esigenza centrale per il proselitismo missionario gesuitico, si accompagna al rifiuto programmatico dell’alterità70.
67 W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, cit., p. 49. 68 Ibidem 69 R. Barthes, Loyola, cit., pp. 48, 43. 70 «L’invenzione di una lingua, questo è dunque l’oggetto degli Esercizi. Tale in-
venzione si prepara attraverso un certo numero di protocolli […] un incessante già se-gna il tempo del devoto e gli assicura una pienezza capace di respingere lontano da lui ogni lingua altra […] è la prescrizione in sé, non il suo contenuto, che isola» (ivi, p. 38).
Capitolo III 140
L’espansione del meraviglioso e il dominio dell’illusionismo tecnico, ovvero la complicazione scenotecnica degli stessi Eser-cizi, li rese funzionali al principio di sovranità seicentesco. Mentre gli Esercizi prescrivevano una morale dell’obbedienza come viatico all’elezione, e consistevano dunque in un’interrogazione della volontà divina tesa alla determinazione della scelta, il dispotismo del meraviglioso rigetta le esitazioni della mantica. In quanto spettacolo, e dunque simulazione della semiofania, la meraviglia tecnica toglie la parola alla divinità oltre che all’interrogante.
Gli Esercizi e il museo kircheriano sono macchine. Ma se le pratiche ascetiche ignaziane si raccolgono nella figura della bi-lancia – «devo trovarmi come l’ago di una bilancia per seguire quello che senta più essere a gloria e a lode di Dio nostro Signo-re e a salvezza della mia anima» – il teatro kircheriano delle cu-riosità sceglie a suo sigillo l’operatività truffaldina delle mac-chine del moto perpetuo71. Come ha notato Michel Carrouges, tutta l’iconografia dei meccanismi assurdi rimanda ai “padroni della macchina” e dunque al «potere sovrano di costruire la macchina e di deciderne l’impiego»72.
71 «Il Museum Kircherianum divenne presto uno spazio per la dimostrazione delle
macchine per il moto perpetuo» (M.J. Gorman, The Scientific Counter-Revolution, cit., p. 235). Su questo argomento cfr. S. Schaffer, The Show that Never Ends: Perpetual Motion in the Early Eighteenth Century, «British Journal of the History of Science», n. 28, 1995, pp. 157-189.
72 M. Carrouges, Come inquadrare le macchine celibi, cit., p. 40.
Strumenti meravigliosi 141
fig. 1 L’orologio-girasole kircheriano. A. Kircher, Magnes, sive De Arte Ma-gnetica, 1641.
fig. 2 L’orologio magnetico kircheriano. A. Kircher, Magnes, sive De Arte Magnetica, 1641.
Capitolo III 142
2. La costruzione dell’immanenza: il readymade
Nonostante l’enorme attenzione critica riservata all’opera di Duchamp, il dialogo con il bergsonismo è stato sinora rimanda-to, o tutt’al più confinato a comparazioni estemporanee o ad esi-tanti genealogie73. Paradossalmente, l’ostacolo maggiore a que-sto incontro è rappresentato dall’immensa popolarità di cui ha goduto la filosofia bergsoniana durante i primi due decenni del XX secolo. Un successo pagato al prezzo della proliferazione di schematizzazioni neutralizzanti, che hanno progressivamente soffocato la specificità teoretica della filosofia bergsoniana, im-pedendo in seguito di cogliere il radicalismo epistemologico e l’anti-tradizionalismo estetico del Bergson assimilato dalle a-vanguardie storiche.
Si consideri ad esempio l’importante monografia di Linda Dalrymple Henderson, in cui il fantasma di Bergson si affaccia costantemente alla discussione, a partire dall’origine bergsonia-na del termine “readymade”74. Nonostante Dalrymple Hender-
73 La maggior parte degli studi su Duchamp non tiene conto del rapporto con Ber-
gson e il bergsonismo: così avviene ad esempio in J. Clair, Marcel Duchamp: ou, Le grand fictif: essai de mythanalyse du Grand verre, Galilee, Paris 1975; C.E. Adcock, Marcel Duchamp’s Notes from the Large Glass: An N-Dimensional Analysis, UMI Re-search Press, Ann Arbor, Mich 1983 e J.-F. Lyotard, I transformatori Duchamp. Studi su Marcel Duchamp, a cura di E. Grazioli, Hestia, Cernusco 1992. Fra i rari contributi attenti alla matrice bergsoniana dell’arte di Duchamp: L. Beier, The Time Machine: a Bergsonian Approach to the Large Glass, «Gazette des Beaux-Arts», vol. 88, 1976, pp. 194-200; I. Davies, New Reflections on the Large Glass. The Most Logical Sources for Marcel Duchamp’s Irrational Work, «Art History», vol. 2, n. 1, 1979; L. Dalrymple Henderson, Duchamp in Context. Science and Technology in the Large Glass and Re-lated Works, Princeton University Press, Princeton 1998; M. Antliff, Inventing Bergson: Cultural politics and the Parisian Avant-garde, Princeton University Press, Princeton 1993. A differenza dei critici, i biografi di Duchamp non hanno mancato di rilevare l’influenza sostanziale di Bergson sullo sviluppo artistico di Duchamp: cfr. C. Tomkins, Duchamp. A Biography, Henry Holt, New York 1996, p. 68.
74 «According to Bergson, such intellectual ideas, “which we receive ready-made [tout fait],” must remain external to the inner self of artistic creation. Bergson’s use of the term tout fait in this context and in Le Rire to signify the very state of being external or mechanical that Duchamp was seeking suggests that the philosopher’s terminology lies behind Duchamp’s adoption of its English translation, “ready-made”, once he was in New York» (L. Dalrymple Henderson, Duchamp in Context, cit., p. 63).
Strumenti meravigliosi 143
son riconosca la presenza diffusa in Duchamp di vari motivi bergsoniani, poiché Bergson rappresenta per lei il filosofo anti-intellettualista e anti-scientista del “sé interiore” e della “pro-fonda auto-espressione”75, il lessico bergsoniano le sembra in-compatibile con la rivoluzione artistica concettuale introdotta da Duchamp. Una volta poste queste premesse, diventa necessaria un’operazione di esorcismo storiografico per risolvere lo scan-daloso connubio Bergson-Duchamp. Ed ecco la soluzione: poi-ché Duchamp rigetta i fondamenti teorici dell’estetica dei cubi-sti di Puteaux (Jean Metzinger, Albert Gleizes), egli rifiuta an-che in blocco il bergsonismo, che è la matrice filosofica delle loro posizioni76. I numerosi rimandi bergsoniani “indubbiamen-te” presenti nell’armamentario critico-artistico di Duchamp non sono che macerie accumulate nel corso della battaglia condotta contro Bergson e i suoi seguaci cubisti77.
Proviamo ora a districarci da questa linea interpretativa, ab-bandonando i luoghi comuni sull’“irrazionalismo” bergsoniano e accostandoci a Duchamp come a uno dei più radicali esponen-ti del bergsonismo. A partire dal Saggio sui dati immediati della coscienza, Bergson distingue tra due tipi di molteplicità. Da un lato una molteplicità di fusione ed eterogeneità, virtuale e con-tinua, dall’altro gli stati discontinui ed attuali, di simultaneità e
75 Cfr. L. Dalrymple Henderson, Duchamp in Context, cit., p. 120. 76 La posizione di Mark Antliff, a cui si deve lo studio di riferimento sul bergsoni-
smo dei cubisti di Puteaux è più attenta alla complessità interna della filosofia bergso-niana. Antliff comprende che non è possibile restringere la comprensione dell’estetica bergsoniana al dualismo di durata e spazialità, intuizione e movimento fisico. In Ber-gson esiste infatti una elaborata teoria qualitativa dello spazio, che ha una profonda in-fluenza sulla concezione artistica dei cubisti di Puteaux. Cfr. M. Antliff, Inventing Bergson, p. 344.
77 Citiamo altri passi in cui Dalrymple Henderson, sulla scia di Ivor Davies, ricono-sce il bergsonismo di Duchamp: «Indeed, Bergson’s theory of humor was undoubtedly one of the roots of Duchamp’s description of the Large Glass as a “hilarious picture” on a page on notes headed “General notes. For a hilarious picture” […] Such Bergsonian talk of immeasurability was undoubtedly one of the sources for the language Duchamp adopted in certain discussion of the Bride’s realm […] The subtlety of the Bride’s op-positional characteristics points up a further contrast between her and the Bachelors, with their “jerky” motions. Bergson had identified this distinction as a source of laugh-ter in Le Rire: “The rigid, the ready-made, the mechanical, in contrast with the supple, the ever-changing, and the living […] in a word, automatism in contrast with free activ-ity”» (L. Dalrymple Henderson, Duchamp in Context, cit., pp. 35, 84, 96, 97).
Capitolo III 144
giustapposizione78. Sulla base di questa concezione, il moltepli-ce continuo si confonde con l’indivisibile e la tradizionale diffe-renziazione tra spazio (discreto) e tempo (continuo) viene sosti-tuita da una logica del continuo e discontinuo che comprende sia molteplicità spazio-temporali di conpenetrazione che molte-plicità geometrico-analitiche di fusione.
Attenendosi a questi presupposti, Bergson descrive le pro-prietà di una dimensione infra-spaziale, al tempo stesso conti-nua ed eterogenea, l’“estensione”79. Com’è possibile per il pen-siero afferrare la realtà delle molteplicità continue se il “mecca-nismo cinematografico” a cui è sottomessa l’intelligenza umana induce a giustapporre nello spazio discontinuo entità esterne le une alle altre? Le molteplicità indivisibili sono soltanto un os-simoro, una vaga metafora musicale come quelle privilegiate da Bergson nel Saggio sui dati immediati della coscienza?
La risposta di Bergson fa leva sulla natura della “percezio-ne” che, a differenza dell’intelligenza concettuale e del pensiero simbolico è immersa in un’eterogeneità costitutiva, in un’estensione puramente qualitativa. È questo il regno assegna-to da Bergson all’arte e alla vita animale, ed è questo il territo-rio eletto da Duchamp e dalle avanguardie storiche come di-mensione propria per l’esercizio dell’arte.
Ritardo
«SPECULAZIONI. Si possono fare opere che non siano “ar-
te”?»80. La risposta di Duchamp è il readymade. Attraverso un
78 H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., p. 79 e ss. Come ha mostrato Deleuze, la distinzione tra i due tipi di molteplicità è debitrice delle teorie ma-tematiche di Riemann (G. Deleuze, Il bergsonismo e altri saggi, cit., p. 29), a sua volta tra le principali fonti dell’architettura concettuale del Large Glass duchampiano.
79 «Bisogna quindi distinguere tra la percezione dell’esteso e la concezione dello spazio […] Ciò significa che per l’animale lo spazio non è omogeneo come per noi […] In realtà nella natura le differenze qualitative sono ovunque» (H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., p. 64). Significativamente, anche Duchamp utilizza nelle sue note la distinzione tra “espace” ed “étendue”; cfr. M. Duchamp, Duchamp du signe. Écrits, a cura di M. Sanouillet, Flammarion, Paris 1975, pp. 134-135.
80 M. Duchamp, Mercante del segno, a cura di A. Bonito Oliva, trad. it. di R. D’angelo, Lerici, Cosenza 1978, p. 89.
Strumenti meravigliosi 145
differimento della presenza il readymade produce uno “scarto” nell’arte, fa implodere l’opposizione tra arte e non-arte, tra ope-ra e non-opera. Per la sua logica temporale, lo “scarto” è anche un “ritardo”, ma un ritardo prodotto da un’operazione; dunque “lo scarto è un’operazione”81.
Ad esempio: «progettando per un momento futuro […] il re-adymade potrà essere cercato in seguito (con ogni rinvio)»82. Le informazioni che integrano la dimensione visiva del readymade, le sue istruzioni, indicano “questa data, ora, minuto” in cui un oggetto qualsiasi, prelevato da un contesto qualsiasi ed anche posto in un contesto qualsiasi – una circostanza che le teorie i-stituzionali dell’arte contemporanea non riconoscono – accetta questa “specie di appuntamento” e diventa un’opera: «usare ri-tardo invece di quadro o pittura»83. Duchamp definisce “orolo-gismo” la simultaneità che presuppone la temporalità di uno scarto.
Anche per Heidegger «non esistono opere contemporanee che possano essere opere d’arte»84. L’avanguardismo di Du-champ e l’interrogazione dell’essere convergono nel togliere all’arte la stabilità di una provincia epistemologica. L’unica pre-tesa legittima dell’arte, per entrambi, è la riduzione alle condi-zioni di esistenza85. L’opera d’arte heideggeriana, come una macchina del tempo, dispiega una temporalità orientata verso l’anticipo epocale, non verso la passività quietista del readyma-
81 Ivi, p. 32 82 Ivi, p. 38. 83 Ivi, pp. 39, 32. 84 M. Heidegger, Dell’origine dell’opera d’arte, a cura di A. Ardovino, Aesthetica
Preprint, Palermo 2004, p. 45. 85 Mostrando le implicazioni epistemologiche del readymade e sottraendo le sue
“risonanze” alla mortificazione storicistica, T. De Duve definisce il readymade un’“opera artificiale di secondo grado” paradigmatica della riduzione dell’arte “alla sua funzione enunciativa”, Artefatto, in Marcel Duchamp, a cura di E. Grazioli, Marcos y Marcos, Milano 1993, p. 159. Le lenti filosofiche scelte da De Duve – la teoria dell’enunciazione di Foucault, il giudizio riflettente di Kant – non gli permettono tutta-via di mettere a fuoco la rivoluzione anti-estetica di Duchamp; cfr. Nominalisme pictu-ral. Marcel Duchamp, la peinture et la modernité, Minuit, Paris 1984; Au nom de l’art. Pour une archéologie de la modernité, Minuit, Paris 1989; Résonances du readymade, J. Chambon, Nîmes 1989; Kant after Duchamp, The MIT Press, Cambridge, Mass. 1998.
Capitolo III 146
de. Heidegger pensa l’opera come un centro inaugurale, l’inizio già sempre iniziato di un mondo. Allo scarto duchampiano, pra-ticato come un’operazione, subentra la differenza ontologica, l’apertura destinale dell’essere per un esserci interpretante. In tal modo l’implodente profanazione del readymade si rovescia nell’esplodente sacralità dell’arte auratica86.
L’inversione heideggeriana del ritardo in anticipo smentisce l’ontologia dell’appuntamento dell’opera con le condizioni del-la sua esperibilità. L’orologismo del readymade si rispecchia, ribaltato, nella “messa-in-opera” della verità: l’opera d’arte è un evento, un venire all’opera, un lasciar-scaturire in cui “inizia la storia” e «la custodia di ciò che è dato-in-eredità» è afferrata con una decisione87. Mentre il readymade toglie l’esteticità all’opera per decreare la storia nell’aleatorietà, ed è perciò indif-ferente a chiunque, l’opera d’arte destinale fonda un mondo “per un popolo” e importa a molti. Entrambe queste logiche dell’evento privano l’opera della sua coscienza estetica, sbef-feggiano l’immediatezza del suo porgersi e i diritti dell’interpretazione. Ma, in un caso, quel che sull’arte si può di-re sono “ironie d’affermazione”, nell’altro enigmi oracolari.
A distanza di pochi anni, due riduzioni di segno opposto dell’antropologia occidentale dell’arte. Duchamp concepisce il readymade come una “disumanizzazione dell’opera” ottenuta mediante “l’uso di tecniche meccaniche”; attraverso l’opera di-sumanizzata parla il caso88. Heidegger stabilisce un’equazione tra tecnica ed arte, tra l’arte come fondamento non tecnico della tecnica e la tecnica come destino mondano dell’arte89. Alla di-
86 Cfr. G. Agamben, Profanazioni, Nottetempo, Roma 2005. 87 M. Heidegger, Dell’origine dell’opera d’arte, cit., pp. 50-52. 88 M. Duchamp, Mercante del segno, cit., p. 156. Sulla convergenza di anti-
umanesimo post-strutturalista e ontologia heideggeriana, cfr. Sloterdijk, Non siamo an-cora stati salvati. Saggi dopo Heidegger, a cura di A. Calligaris e S. Crosara, Bompiani, Milano 2004.
89 «Poiché l’essenza della tecnica non è nulla di tecnico, bisogna che la meditazione essenziale sulla tecnica e il confronto decisivo con essa avvenga in un ambito che da un lato è affine all’essenza della tecnica e, dall’altro, ne è tuttavia fondamentalmente distin-to. Tale ambito è l’arte» (M. Heidegger, La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 1991, p. 27).
Strumenti meravigliosi 147
struzione dell’umanità dell’arte, che accompagna il rifiuto della pura artisticità dell’arte, consegue l’irruzione della non-umanità del divino: l’arte liberata dalla sua prigionia in un “settore della produzione culturale” fa «risplendere la presenza degli dei, il dialogo del destino divino e del destino umano»90.
A livello percettivo, l’opera-ritardo di Duchamp è accompa-gnata da un visuale raddoppiato, duplicato in serie divergenti di sensazioni e informazioni, otticità e istruzioni verbali. Né este-tico né artistico, il readymade – su tutti il totem del duchampi-smo, il Grande Vetro – è soggetto alla legge dell’impossibilità: «Impossibilità/di memoria visiva sufficiente»91. A partire da Duchamp, il rinvio (renvoi) delle immagini celebra l’indifferenza visiva. Se la memoria è la presenza a sé del passa-to – in un soggetto come ricordo, in un’opera come iconografia – il readymade prescrive l’amnesia. La temporalità innescata dai differimenti di Duchamp contrasta la “stupidità” dell’occhio privandolo della memoria visiva sufficiente e generando un vi-suale inottico: «Perdere la possibilità di riconoscere (di identifi-care)/ 2 cose simili. / 2 colori, 2 merletti / 2 cappelli, 2 forme qs. / arrivare all’Impossibilità/di memoria visiva sufficiente»92. In quanto “ritardo”, il readymade sventa il potere di assorbi-mento e di assimilazione dell’occhio. In quanto “anestesia com-
90 Ivi, p. 26. 91 J.-F. Lyotard, I transformatori Duchamp, cit., p. 54. «Il Grande Vetro […] è co-
stituito da due lastre di vetro verticali issate l’una sull’altra in una cornice di 1,76 m di larghezza per 2,72 m di altezza. Su questi vetri, senza offuscare l’essenziale della loro trasparenza, Marcel Duchamp ha disegnato, con del filo di piombo, secche figure mec-caniche malvagiamente bloccate, si direbbe imprigionate nei vetri. Le ha schizzate, pre-cisate, poste su dei piani, ne ha suggerito i possibili movimenti per mezzo di annotazio-ni, a penna, a matita, su pezzi di carta buttati giù a Parigi dal 1912 al 1915. Li ha cristal-lizzati pazientemente, ossessivamente, a New York tra il 1915 e il 1923, data in cui ha abbandonato il suo cantiere “definitivamente incompiuto”» (J. Suquet, Il Grande Vetro. Visita guidata, in Marcel Duchamp, cit., p. 193). In seguito all’accidentale rottura dell’opera, Duchamp ha affiancato al Grande Vetro, “come se fosse una guida”, un co-fanetto di velluto verde – la Scatola verde – che contiene il facsimile di 93 fogli volanti con le note relative al progetto. Nel Grande Vetro un’intricata iconografia concettuale svolge il tema allegorico-mitologico della “Sposa messa a nudo dai sui celibi”: «Non si tratta qui dell’interpretazione realistica di una sposa, ma della mia concezione di una sposa espressa attraverso la giustapposizione di elementi meccanici e di forme viscera-li» (M. Duchamp, A proposito di me stesso, in Mercante del segno, cit., p. 33).
92 M. Duchamp, Scritti, cit., p. 36.
Capitolo III 148
pleta”, si preclude l’accesso a modelli iconici significativi. In quanto “indifferenza” alla “bellezza animale”, si sottrae all’esperienza estetica. Il readymade è “un quadro malato”93.
Specchi
Mentre Bataille reinventa la visione privando l’occhio delle
sue capacità prospettiche e rendendolo un corpo, un “occhio pi-neale”94, Duchamp inserisce negli oggetti uno specchio: «La parete di uno specchio è una macchina alimentata dagli oggetti che gli si presentano e che produce altri oggetti, cioè le imma-gini che riflette»95. Non più epifania del senso, l’opera non arti-stica è scelta come laboratorio per la sperimentazione dei para-dossi dell’immediatezza, su tutti la dissociazione di “apparenza” e “apparizione”.
Costruendo degli elaborati apparati di riflessione, trasfor-mando la Sposa in un labirinto di funzioni specchianti, Du-champ sospende le forme della presenza dell’opera. Collocato in un gioco di specchi – innazitutto nel raddoppiamento del Grande Vetro in un Grande Vetro realizzato e in un Grande Ve-tro progettato, in un’opera esposta e nelle “Note” progettuali – il Grande Vetro diventa inottico, “un ritardo di vetro”. La sua condizione di possibilità, l’a priori della sua non artisticità, ri-siede nella non coincidenza tra la sua specularità concettuale e la sua apparenza, nell’impossibilità dell’evidenza visiva:
In fin dei conti il vetro non è fatto per essere guardato (con occhi “e-stetici”); doveva essere accompaganto da un testo di “letteratura”, il più amorfo possibile, che non prese mai forma; i due elementi, vetro per gli occhi e testo per l’orecchio e l’intelletto, dovevano completarsi e soprattutto impedirsi l’un l’altro di prendere una forma estetico-plastica o letteraria96.
93 M. Duchamp, Mercante del segno, cit., p. 39. 94 «Questo albero oculare non è che un grande pene rosa (ignobile)» (G. Bataille,
Dossier dell’occhio pineale, in L’ano solare, a cura di S. Finzi, SE, Milano 1998, p. 42). 95 J.-F. Lyotard, I transformatori Duchamp, cit., p. 40. 96 M. Duchamp, “Lettera J. Suquet”, 25 dicembre 1949, in M. Duchamp, Mercante
del segno, cit., p. 26. J. Clair interpreta il ritardo come una traccia dell’“idealismo” di
Strumenti meravigliosi 149
Duchamp localizza con precisione la possibilità dell’impossibilità: l’opera non artistica esiste là dove il possibi-le è sottratto alla sua opposizione all’impossibile e l’impossibile così liberato, divenuto mera “figurazione di un possibile”, ri-succhia tutte le possibilità dell’immagine, ne cancella la memo-ria: l’opera non artistica è un’idrovora della profondità storica delle immagini. L’impossibile è un ritardo sulla natura visiva, una differenza dentro l’oggetto stesso, come dimostra l’esposizione delle “Note” a fianco del Grande Vetro. Il rea-dymade non mira a svuotare l’immagine dei suoi contenuti, ad affrancarla dal suo inconscio, a raffinarne la gettatezza per rag-giungere la purezza. La “memoria visiva sufficiente” diventa visione inottica, visione impossibile e l’impossibile semplicità dell’oggetto è scelta come luogo proprio dell’arte. Lo “scarto” del renvoi miroirique è un “rinvio” nella doppia accezione di “posticipazione”, una ripetizione-espulsione dal presente di un atto mancato, e di “rimando” come rapporto tra segni e cose. L’opera-ritardo si riflette su se stessa e rinvia nel tempo la pro-pria immagine.
È ciò che Duchamp, con Bergson, definisce “virtualità”, o “quarta dimensione”. Il virtuale come “ciò che non agisce più”, l’impassibile e l’impotente; una dimensione aniconica ma non per questo trascendente, che non istituisce l’empirico ma lo so-stituisce e decostruisce affiancandosi ad esso. Impregnata di vir-tualità, l’opera non artistica di Duchamp presuppone la corrente densa delle immagini bergsoniane: «Per noi la materia è un in-sieme di immagini […] e per “immagine” intendiamo una certa esistenza […] un’esistenza situata a metà strada tra la “cosa” e la “rappresentazione”»97. L’elemento non-estetico duchampiano consiste in questo regno di immagini sospese. Né cose né rap-presentazioni, né simboli né forme psicologiche, le immagini di Duchamp sono un “misto” di virtuale e attuale. Il Grande Vetro
Duchamp, l’affermazione dell’inattingibilità del modello e dunque una strenua difesa del “classicismo”, J. Clair, Marcel Duchamp. Il grande illusionista, trad. it. di M.G. Camici, Abscondita, Milano 2003, p. 51.
97 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 5.
Capitolo III 150
è il prototipo di ogni readymade: uno specchio in cui il virtuale si riflette nell’attuale.
Che cosa significa, e se non significa, almeno come funzio-na, questa virtualità aniconica? Come concepire un’immagine senza memoria e un’opera senza immagini? Come spostare l’opera nel virtuale, dal momento che l’amnesia estetica di Du-champ, in questo fedele a Mallarmé, è orfana dell’accesso intui-tivo alla memoria pura e allo spirito come durata, orfana dello spiritualismo?
La “speculazione” precede la domanda sull’opera non arti-stica. “Speculazione” in Duchamp significa riflessione, ma ri-flessione “miroirique”, “renvoi miroirique”: «La riflessione / (immagini virtuali) / in uno specchio»98. Immagine, riflessione, il virtuale, lo specchio. Il Grande Vetro si affida alla specularità per mettere in moto – il moto statico delle forme meccaniche bloccate sulle lastre di vetro, il loro “riposo istantaneo” – un rinvio non speculativo nell’accezione hegeliana. Il neologismo miroirique distingue lo “specchiante” dal semplice riflettente e designa operazioni concettuali che non duplicano l’identità del-lo spazio riflesso ma che lo “dissimilano senza finalità”99.
Il meccanismo è bergsoniano: data un’immagine, in questo caso la Sposa, le riflessioni delle altre immagini su di essa ne fanno un’immagine centrale. Alle modalità specchianti corri-spondono azioni dei corpi sui corpi, ad ogni azione possibile una tipologia di assorbimento, ad ogni reazione un sensorio:
Tanti sono i tipi di azione possibile per il mio corpo, altrettanti saranno, per gli altri corpi, i differenti sistemi di riflessione, e ciascuno di questi sistemi corri-spoderà ad uno dei miei sensi. Il mio corpo si comporta, quindi, come un’immagine che ne rifletterebbe delle altre, analizzandole dal punto di vista delle diverse azioni da esercitare su di esse100. Nel Grande Vetro il corpo “esploso” della Sposa della parte
superiore dell’opera – l’Impiccato femmina e la Via lattea– è
98 M. Duchamp, Mercante del segno, cit., p. 119. 99 J.-F. Lyotard, I transformatori Duchamp, cit., p. 62. 100 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 38.
Strumenti meravigliosi 151
una proiezione di un irrapresentabile corpo temporalizzato (“ri-tardato” nella quarta dimensione); in Bergson, l’immagine cen-trale è invece il corpo fenomenologico, il “mio corpo”: «Ecco, in mezzo a tutte le immagini, una certa immagine che chiamo il mio corpo e la cui azione virtuale si esprime attraverso un’apparente riflessione delle immagini circostanti su esse stes-se»101.
Il Grande Vetro funziona come la percezione in Bergson, sulla base di un sistema di riflessione delle azioni in cui è pro-dotto il corpo. La Sposa non è una sostanza, ma l’effetto delle azioni sulla sua immagine, il risultato dell’intersezione di un’azione e di un assorbimento-riflessione: il corpo vivente è «una specie di centro da cui si riflette, sugli oggetti circostanti, l’azione che questi oggetti esercitano su di esso: in questa ri-flessione consiste la percezione esterna»102. Il Grande Vetro non è una rappresentazione di un corpo, per quanto assoluto e temporalizzato, ma un sistema di riflessioni che hanno luogo, la messa in scena dello sferragliare di un marchingegno speculati-vo, «un sistema di riflessione e di inquadramento che fa esitare il resto»103. Come in Bergson, la riflessione avviene nel Grande Vetro sotto forma di azione: l’automatismo meccanico e la bru-sca natura dei movimenti della parte inferiore – andirivieni del carrello, rotazione della macinatrice di cioccolato, caduta dell’acqua, crolli, spruzzo – e la leggerezza di quelli della Sposa – comandamenti, ordini, corrente d’aria, allungamento metereo-logico, fiamma, spari, fioritura – sostengono un’impalcatura di azioni che disseminano effetti di specchio e, letteralmente, in senso topologico, danno luogo alla Sposa, sprigionano la sua “timida potenza”: «la Sposa […] è questa timida potenza stes-sa”, che “serve allo sboccio di questa vergine […] Tutta l’importanza grafica va a questo sboccio cinematico»104.
101 Ibidem 102 Ivi, p. 45. 103 J. Derrida, La disseminazione, in La disseminazione, trad. it. di S. Petrosino e M.
Odorici, Jaca Book, Milano 1989, p. 328. 104 M. Duchamp, Mercante del segno, cit., p. 50.
Capitolo III 152
Nel terzo capitolo di Materia e memoria Bergson mostra in che senso il corpo consista in un “ritardo”, dunque non in un centro ma in una “specie di centro”: «il nostro corpo non è nient’altro che la parte invariabilmente rinascente della nostra rappresentazione, la parte sempre presente, o piuttosto quella che, in ogni momento, è appena passata»105. Il corpo umano è un «limite mobile tra passato e futuro», una contrazione della memoria in funzione dell’azione; il corpo della Sposa è genera-to dalla riflessione delle azioni macchinose dei Celibi sul suo desiderio. Il “caldo rifiuto” che la Sposa oppone al desiderio dei Celibi innesca un “corto-circuito” da cui promana una scintilla che infiamma il gas dei Celibi. La Sposa si spoglia, depone il suo vestito sulla Linea dell’orizzonte (la traversa superiore) ed esplode nelle figure liberate (Ala, Vespa, Impiccato femmina, Via lattea) con uno “sbocciare cinematico”.
Tocchiamo il nucleo generativo del duchampismo: pur non rappresentando nulla e non simboleggiando nulla, un’opera non-artistica è opera quando le sue regole di costruzione riflet-tono, con una duplicazione senza somiglianza, i contenuti: nel Grande Vetro, le azioni dei protagonisti, il paesaggio meccani-co dello sguardo celibe e la saga aerea della Vergine. Le azioni concepite o realizzate graficamente sul Grande Vetro rimbalza-no attraverso un sistema di rinvii che le traduce in principi rap-presentativi:
Lo spruzzo […] termina la serie di operazioni celibi e trasforma la combinazione del gas d’illuminazione e delle forbici in un unico so-stegno continuo […] Abbagliamento dello spruzzo attraverso le tavole d’oculista. Scultura di gocce (punti) che forma lo spruzzo dopo esser stato abbagliato attraverso le tavole oculistiche […] Rimando specula-re106.
Il contenuto è la forma, ma senza passaggio dialettico, per
mero raddoppiamento del movimento in figura, delle narrazioni delle “Note” in proiezioni sul vetro. Più si accumulano i riferi-
105 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 128. 106 M. Duchamp, Mercante del segno, cit., p. 76.
Strumenti meravigliosi 153
menti tematici, più si complica la macchinazione grafica. Il Grande Vetro non è l’illustrazione allegorica di un’Assunzione, di un poema d’amore, di un’esperienza alchemica o del Voyage au Pays de la Quatrième Dimension di Pawlowski107. È un’operazione che mette in opera, la trasformazione di un appa-rato di riflessione in oggetto (readymade) e di un oggetto in gioco di specchi (il miroirique). Un’opera che presuppone l’unità duplicata – come il dualismo di materia e memoria che divide il monismo di Bergson – di pura operatività (lo scarto) e di semplice datità (i temi trovati e accatastati nella Sposa, per la gioia di generazioni di commentatori!).
Virtuale
Le osservazioni contenute nella Boite blanche illustrano il
sistema delle immagini virtuali ottenibili con gli specchi della Sposa. L’apparato, esponenzialmente macchinoso, si basa sull’invenzione di specchi astratti, che funzionano come “tagli” per generare, in accordo con le teorie di Dedekind e Poincaré, geometrie n-dimensionali108. Quali sono «i tipi di azione possi-bili» per il corpo-immagine della Sposa?
Innanzitutto, nella parte superiore c’è una riflessione proiet-tiva della Sposa quadridimensionale:
la mia Sposa per esempio sarebbe la proiezione tridimensionale di una sposa quadridimensionale. Ma poiché è su vetro, è piana, e allora la mia Sposa è la rappresentazione bidimensionale di una sposa tridi-mensionale che è essa stessa la proiezione della sposa quadridimen-sionale nel mondo tridimensionale109.
107 Cfr. J. Clair, Marcel Duchamp. Il grande illusionista, cit., pp. 107-108. 108 La svolta artistica duchampiana è assimilabile al passaggio dai grandi telescopi
ottici ai sistemi di captazione delle onde eletromagnetiche che esplorano la porzione non visibile dello spettro, utilizzando meccanismi di assorbimento delle radiazioni (la dispo-sizione geometrica dei tralicci dei radiotelescopi) e apparati di traduzione delle onde magnetiche in immagini. Come le forme temporalizzate del Grande Vetro, queste im-magini finali non riflettono mimeticamente la sorgente di luce.
109 J.-F. Lyotard, I transformatori Duchamp, cit., p. 61.
Capitolo III 154
La virtualità delle immagini bidimensionali risiede in primo luogo nella realtà non attuale di un contenuto irrapresentabile sul piano, la costruzione prospettica legittima sulla superficie di un modello tridimensionale.
Il Grande Vetro è segnato da un’ulteriore specularità, non proiettiva ma duplicativa:
Il Vetro è esso stesso composto dall’assemblaggio di due parti, alto e basso, che sono come due specchi congiunti lungo una cerniera forma-ta dalle strisce di vetro mediane. Le immagini che vediamo in questi due specchi, Celibi in basso, Sposa in alto, non sono poste sullo stesso piano; bisogna immaginare che gli specchi formino un angolo ottuso l’uno con l’altro e che gli spazi virtuali che si aprono siano, diciamo, differenti110.
Duchamp non è interessato, come Derrida, ad attraversare lo
specchio e a renderne trasparente alla riflessione il fondo (tain). Il Grande Vetro è uno specchio doppio che scatena illusionismi concettuali a partire dagli angoli di riflessione. Non “specchio di specchio” ma specchio disgiunto, non specchio fenomenolo-gico ma specchio bergsoniano, nel Grande Vetro si riflettono due metà che non fanno un’unità ma il “corto circuito” dell’attuale (le azioni dei Celibi, soggette alla legge della causa-lità e rappresentati visivamente applicando rigorosamente le leggi della prospettiva lineare) e del virtuale (il “corpo senza organi” della Sposa, la donna come “motore a scoppio” e im-maginazione). Oltre che “modello” della Sposa e rappresenta-zione di un volume, la virtualità è l’effetto di una “riflessione in uno specchio”, il risultato dello specchiarsi delle azioni dei Ce-libi nell’immaginazione della Sposa. È un “analogo” delle due opzioni: «Virtualità come 4a dimensione: non la Realtà sotto l’apparenza sensoriale, ma la rappresentazione virtuale di un volume (analogo alla sua riflessione in uno specchio)»111.
«La riflessione / (immagini virtuali) / in uno specchio»112. La virtualità dischiusa dalla riflessione dei due specchi è “nello
110 Ibidem 111 M. Duchamp, Mercante del segno, cit., p. 121. 112 Ivi, p. 119.
Strumenti meravigliosi 155
specchio”, è la forma di esistenza di un apparato doppio costrui-to per moltiplicarsi come un caleidoscopio, non di uno specchio condannato a simulare effetti mimetici. Macchinazione unitaria, il Grande Vetro richiede una cerniera, relazioni che articolino la disgiunzione: «forse fare un quadro di cerniera […] Far valere il principio di cerniera negli spostamenti 1o nel piano; 2o nello spazio. Trovare una descrizione automatica della cerniera»113. Lyotard ha ricostruito con meticolosità la struttura e le implica-zioni teoriche delle cerniere del Grande Vetro. Dalla sua analisi riprendo i motivi fondamentali del “taglio” e dell’“incongruenza”.
Se le immagini che vediamo nei due specchi (Celibi e Spo-sa) non sono sovrapponibili è perché il Grande Vetro applica il principio kantiano dell’incongruenza – la simmetria unita a non sovrapponibilità nel piano – a una figura ruotata intorno a una cerniera e riflessa in uno specchio doppio:
Kant mostra che lo specchio piano, o più in generale la simmetria in rapporto a un piano nello spazio tridimensionale […] se garantisce la similitudine di due oggetti li carica di una proprietà curiosa che chia-ma la loro incongruenza: così la mano destra può ben essere simile e simmetrica alla sinistra in tutti i suoi punti, esse restano tuttavia non sovrapponibili l’una all’altra114. Per sovrapporre senza incongruenza la mano destra a quella
sinistra è necessario farle ruotare in uno spazio tridimensionale, non basta trasportarle su un piano. Radicalizzando questo prin-cipio, Duchamp concepisce le due facce dello specchio del Grande Vetro come regioni incongruenti, ottenute mediante la rotazione intorno alla cerniera centrale di due spazi tridimensio-nali virtuali. Così come, per ridurre un’incongruenza in uno spazio a due dimensioni, serve la rotazione intorno a una cernie-ra che apra i battenti di una dimensione superiore, l’«incongruenza tra volumi esigerebbe di disporre di una quarta dimensione, quella che potrebbe essere suggerita da uno spec-
113 Ivi, p. 33. 114 J.-F. Lyotard, I transformatori Duchamp, cit., p. 40.
Capitolo III 156
chio tridimensionale, ossia uno specchio a tre facce che si riflet-tono reciprocamente»115. L’essenziale non sono pertanto le due sezione speculari del Grande Vetro, quanto la loro connessione (disgiuntiva) mediante tre strisce di vetro, con la trasversale mediana che fa cerniera tra quella superiore (il “Vestito della Sposa”, deposto dopo la messa a nudo cinematica) e quella infe-riore (l’“Orizzonte dei celibi”, il punto di fuga della loro proie-zione geometrica). Agli specchi dei Celibi e della Sposa si ag-giunge una ceniera-specchio, uno specchio kantiano a tre facce che produce l’incogruenza tra le due regioni spaziali, innescan-do la virtualità propria dell’opera. A causa di questa sua pura funzione concettuale di cerniera, lo specchio-trasversale è to-talmente trasparente e privo di iscrizioni iconografiche.
Oltre al principio d’incongruenza, le tre strisce mediane ri-spondono alla funzione di angolo, raffreddatore e soprattutto “taglio” dei volumi virtuali dei due spazi del Grande Vetro. Ri-sultato di una proiezione, Duchamp pensa le trasversali come tracce di una potenza di taglio che nella geometria n-dimensionale di Dedekind appresa da Poincaré, genera esten-sioni di dimensioni sovraordinate. Se una superficie taglia uno spazio tridimensionale, un taglio tridimensionale – la trasversa-le superiore – taglia un’estensione a quattro dimensioni: lo spa-zio virtuale temporalizzato in cui riposa in modello invisibile della Sposa. Dunque, la cerniera del Grande Vetro – le tre stri-sce di vetro – è al contempo uno specchio a tre facce che riduce l’incongruenza e uno specchio-taglio formato da trasversali tra loro incongruenti, perché generate come potenza di taglio di spazi di dimensionalità eterogenea.
Semplice lastra di vetro, il Grande Vetro è collocato in una spazialità impossibile: le due facce del suo specchio doppio ap-partengono sia a dimensioni spaziali incongruenti – ottenute at-traverso una rotazione intorno a un angolo a 4 o 5 dimensioni – sia a spazi virtuali non omogenei, prodotti dal taglio di spazi proiettivi dissimili. Risultando da operazioni e descrizioni senza corrispettivo sensibile, la scena del Grande Vetro è virtuale, e
115 Ivi, p. 45.
Strumenti meravigliosi 157
dunque riflette soltanto concettualmente l’“immagine” della Sposa.
Circuito
La vertigine di una riflessività intensificata, che cerca le
condizioni di possibilità dell’empirico nello speculum di una struttura logico-ontologica, non appartiene al readymade. Il vir-tuale duchampiano non è uno spazio dislocato di possibilità bensì la produzione nell’oggetto della sua impossibilità. Il rea-dymade non espone l’Altro dell’oggettività ma l’impossibilità del medesimo. Non assimilando speculativamente l’oggetto ma abbandonandolo alle dissimulazioni dello specchio, l’opera si dissocia da se stessa. Ogni readymade incorpora uno specchio, un meccanismo che ritarda l’autocostituzione dell’oggetto senza riflettere alcuna realtà trascendente. L’arte di Duchamp non porta da nessuna parte, non schiude la “mondità del mondo” (Heidegger), non dissolve la presenzialità nell’impossibilità del-la costituzione ontologica (Derrida). Ritardando l’oggettualità degli oggetti, Duchamp li mette in opera, conserva ironicamente la loro impossibilità, lasciandoli riposare nella loro esitazione.
Nel secondo capitolo di Materia e memoria, Bergson descri-ve il “circuito elettrico” della percezione. Poiché si trova im-merso in un circuito le cui polarità sono l’attuale e il virtuale, ogni oggetto è doppio, appartiene contemporaneamente alla to-talità della memoria virtuale e all’attualità della percezione. Non esiste dunque una percezione presente degli oggetti, quanto una “percezione riflessa”, un rimbalzare della percezione sulla profondità della memoria e un suo ritorno nell’attualità:
Noi […] pretendiamo che la percezione riflessa sia un circuito in cui tutti gli elementi, compreso lo stesso oggetto percepito, si tengano in uno stato di muta tensione, come in un circuito elettrico, così che nes-suna vibrazione partita dall’oggetto possa arrestarsi lungo il percorso nelle profondità dello spirito; essa deve sempre fare ritorno all’oggetto stesso116.
116 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 87.
Capitolo III 158
Il renvoi miroirique realizza questo movimento della perce-zione, l’operazione che sdoppia ogni oggetto in un circuito di concettualità e presenza, di virtualità specchiante e inerzia rea-dymade. Il ritardo duchampiano non è altro che il rinvio intro-dotto dall’operazione della riflessione, la condizione di possibi-lità della duplicazione dell’oggetto che solo lo rende un oggetto. Il Grande Vetro è un oggetto doppio, una cosa “già fatta” e ri-flessa, un pezzo di realtà che ha ingoiato uno specchio.
Mantenendosi in prossimità di Bergson, Deleuze definisce il virtuale «una parte integrante dell’oggetto reale – come se l’oggetto avesse una sua parte nel virtuale e vi si immergesse come in una dimensione oggettiva»117. Ancor prima della sua messa in opera, l’oggetto percepito è doppio. Divenuto concet-tuale e dunque semplice lastra di vetro, raffreddatore o cerniera, il principio specchiante del Grande Vetro presiede alla sua du-plicazione implosiva. Gli specchi di Duchamp sono macchinari logico-empirici di dissezione, tagli che fanno del Grande Vetro un’opera divisa: alto e basso, Sposa e Celibi, regno del deside-rio e della necessità, temporalità liberata e spazialità geometri-ca, forme esplose e costruzioni prospettiche legittime. La pro-prietà fondamentale del rimando miroirique è lo sdoppiamento del reale; il Grande Vetro non rappresenta, se non al livello del-la specularità come proiezione, la Sposa virtuale, la mostruosa divinità del desiderio, la donna a quattro dimensioni. Il Grande Vetro non “intuisce” la Sposa ma la produce in un gioco di specchi, attraverso la moltiplicazione degli ordini spaziali e la loro incongruenza in un’unica dimensione percettiva.
Poiché del tempo non c’è intuizione, la proiezione nel mon-do tridimensionale di un oggetto immerso nella quarta dimen-sione (la Sposa) assomiglia al superamento della barriera del suono: prima e dopo questa soglia tutto è come prima, il pas-saggio è un’esplosione. La Sposa è il prodotto di un “corto-circuito”, dei «legami elettrici […] tra la macchina celibe e la Sposa»118. Radicato nella duplicità dell’oggetto, nel circuito che
117 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., p. 27. 118 M. Duchamp, Mercante del segno, cit., p. 47.
Strumenti meravigliosi 159
fa l’oggetto nel mentre lo sdoppia, il virtuale di Duchamp è ri-gorosamente bergsoniano. La virtualità della Sposa è un luogo inassegnabile, che «non esiste per la nostra intuizione»119. Il mi-roirique duchampiano non crea ma depotenzia, non si mostra attraverso tracce ma ha luogo in un gioco di specchi.
La produzione implosiva della Sposa, la sua ontologia spec-chiante, è un evento? La virtualità è la forma di esistenza pro-pria della temporalità degli eventi?120 Guardando la metafisica bergsoniana dentro uno specchio stoico, Deleuze pensa l’evento come una coesistenza paradossale di passato e futuro, Aiôn. Aiôn è «un istante senza spessore e senza estensione che suddi-vide ogni presente in passato e futuro»121. Un istante impossibi-le e atopico, che manca sempre al proprio posto, un «punto a-leatorio”, un “non senso di superficie»122. Come in Bergson, come nell’Aiôn deleuziano, in Duchamp l’istantaneo non esi-ste123. Le due facce del Grande Vetro non riflettono uno stesso contenuto e non sottostanno alla medesima forma; il virtuale e l’attuale non si specchiano l’uno nell’altro riconoscendosi. In Bergson, l’«indeterminazione [nelle immagini, N.d.A] […] si tradurrà per una riflessione su se stesse, o meglio, per una divi-sione delle immagini che circondano il nostro corpo»124. Il de-siderio della Sposa riflette la dissimmetria del virtuale, duplica la cosalità dell’oggetto qualsiasi per mezzo di un’ironia d’affermazione che lo proietta nel non omogeneo, nell’incongruente e nella multi-dimensionalità. Ma nel Grande Vetro il virtuale e l’attuale non fanno sistema come nella logica
119 J.-F. Lyotard, I transformatori Duchamp, cit., p. 74. 120 Sulla base della nozione di “corpo-evento” virtuale, Diodato fa interagire le ca-
ratteristiche empiriche della virtualità (la “realtà virtuale”, le “immagini interattive”) e la filosofia deleuziana dell’evento: «qui interessa trarre dalla nozione di virtuale elabo-rata da Deleuze spunti per la comprensione dell’oggetto virtuale come immagine digita-le interattiva […] Questa coesistenza plurima dei tempi nell’ora dice un oggetto che è evento, e Deleuze pensa bene il lato “evento” dell’oggetto-evento» (R. Diodato, Estetica del virtuale, Bruno Mondadori, Milano 2005, pp.159, 166).
121 G. Deleuze, Logica del senso, trad. it. di A. Verdiglione, Feltrinelli, Milano 1984, p. 147.
122 Ivi, p. 148. 123 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 56. 124 Ivi, p. 51.
Capitolo III 160
deleuziana degli eventi puri e nel circuito bergsoniano della percezione riflessa: il renvoi miroirique produce effetti di inde-terminazione125.
Il luogo dell’implosione dell’oggetto, della sua vivisezione in parti non sovrapponibili, è l’immagine. Bergsonianamente, l’immagine è sospesa tra “la cosa e la rappresentazione” e rad-doppiata dal misto attuale-virtuale. Il Grande Vetro è un corpo-immagine, un corpo impossibile, un mostro come nel «sistema Wilson-Lincoln […] cioè simile ai ritratti che guardati da sini-stra danno Wilson, guardati da destra danno Lincoln» 126. Anche il rimando speculare avviene nel medium dell’immagine: la cerniera del Grande Vetro duplica la figura in due metà incon-gruenti: «Rimando speculare. Ogni goccia passerà i 3 piani all’orizzonte tra il prospettico ed il geometrico delle 2 figure che saranno indicate a questi 3 piani dal sistema Wilson-Lincoln […] Le gocce speculari, non le gocce stesse, ma la loro immagine, passano tra questi due stadi della stessa figura» 127.
Impotenza
Il bergsonismo duchampiano è estraneo alla storia degli ef-
fetti scatenata dall’evento Bergson. Duchamp non interpreta Bergson, disinnesta la riflessione della memoria nell’azione. Gli ingredienti del Grande Vetro sono quelli di Materia e memoria: il corpo-specchio, la riflessione, il virtuale, l’azione, e il mac-chinario bergsoniano avrebbe già potuto produrre questi effetti se fosse stato azionato, e inceppato, come un readymade.
Poiché il presente della fisiologia è senso-motorio, in Ber-gson l’azione attinge al serbatoio delle immagini e dunque il corpo «è sempre situato nel punto preciso in cui il mio passato terminerà in un’azione»128. Ma il circuito della memoria è per-
125 «Dopo aver ricostruito l’oggetto percepito, come un tutto indipendente, rico-
struiamo con esso le condizioni sempre più lontane con le quali esso forma un sistema» (ivi, p. 88).
126 M. Duchamp, Mercante del segno, cit., p. 78. 127 Ibidem 128 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 64.
Strumenti meravigliosi 161
corribile nei due sensi dalle correnti della riflessione; l’azione indeterminata può condurre alla memoria, l’attualità dei movi-menti del corpo può disinnestare la virtualità: «la memoria è co-sì la ripercussione, nella sfera della conoscenza, dell’indeterminazione della nostra volontà»129. Nel Grande Ve-tro la virtualità della Sposa ha luogo come ripercussione, rifles-sione dell’arresto improvviso dei movimenti automatici del mondo meccanico-prospettico dei Celibi. La macchinazione bloccata dei Celibi sprigiona la scintilla che manda in frantumi l’attualità dell’oggetto, la Vergine denudata diventa un Impicca-to femmina, la Sposa è bruscamente spogliata dal desiderio dei Celibi.
Il movimento disfunzionale del Grande Vetro – retroversio-ne e blocco – ne fa una “macchina celibe”, secondo la nota for-mulazione di Carrouges:
Al contrario delle macchine reali o anche della maggior parte delle macchine immaginarie, ma razionali e utili come il Nautilus di Jules Verne o i razzi della fantascienza, la macchina celibe si presenta in-nanzitutto come una macchina impossibile, inutile, incomprensibile, delirante130.
Il moto retrogrado dell’azione dei Celibi sventa le conse-
guenze dello spiritualismo e dell’umanismo bergsoniano, proietta debolezza a partire dall’indeterminazione dell’azione. Immerso nell’“impotenza radicale” del virtuale, il Grande Vetro è come il ricordo puro, “impotente finché rimane inutile”131.
L’immersione del readymade nella virtualità giustifica la sua esibita assurdità: il readymade è inutile, il motore della Sposa è fermo. A scanso di equivoci, Duchamp suggerisce di pensare il risultato di tutti i movimenti dell Grande Vetro come una «mes-sa a nudo volontariamente immaginata dalla sposa desideran-te»132. L’immaginazione della Sposa riafferma parodisticamente
129 Ivi, p. 52. 130 M. Carrouges, Istruzioni per l’uso, in AAVV, Le macchine celibi/Bachelor Ma-
chines, cit., p. 21. 131 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 119. 132 M. Duchamp, Mercante del segno, cit., p. 50.
Capitolo III 162
l’atteggiamento contemplativo che nel sistema bergsoniano permette di accedere all’intuizione della durata. Di questa di-mensione onorica il Grande Vetro mantiene l’ineffettualità, così come preserva la paradossale istantaneità dell’intuizione ber-gsoniana: la messa a nudo ha bisogno di un’esplosione, di una scintilla, di un corto-circuito.
Motore
Il ritardo miroirique non esclude la simultaneità, la perce-
zione riflettente non esautora l’intuizione. Lo specchio ritarda l’immagine attraverso un renvoi che ripete l’assenza dell’immediatezza, l’istante duplicato non si svolge in una pre-senza vivente ma si distende su una superficie esplosa, esplo-sione ed implosione essendo l’ordine inverso dell’apertura tem-porale delle apparenze.
L’inattuale è ciò che toglie il proprio tempo al soggetto, un rinvio dell’appuntamento con il senso che svuota l’interiorità del tempo. Benché Heidegger e Duchamp condividano l’insofferenza per la presenzialità dell’attimo e l’esigenza di la-sciarsi alle spalle l’estetico in nome della sua origine, la tempo-ralità capricciosa del readymade e la sua specularità dissimilan-te si distinguono dalla specularità non appropriante e dalla “temporalità originaria” heideggeriana. Il readymade non di-schiude un mondo e un’epoca, cattura l’aura dell’inaugurale nel castello di specchi dell’impotenza virtuale.
Ponendosi accanto all’arte, usando “un Rembrandt come ta-volo da stiro”, il readymade lascia implodere ciò che nell’arte è storico. Un Rembrandt-tavolo da stiro è un’opera perché la sua divisione fa apparire due oggetti, come la Sposa e i Celibi; in questo caso un Rembrandt e un tavolo da stiro. Un’opera sorge nel rinvio specchiante di due oggetti; reciprocamente, l’opera è ciò che incorporando la specularità si divide in due. Dopo il re-adymade, la “storicità dell’arte” è rinviata e la “storia dell’arte” va in frantumi: la storia si riflette nell’arte e l’arte nella storia, rendendo impossibile la loro relazione essenziale, ossia la stori-cità dell’arte.
Strumenti meravigliosi 163
Immerso nell’epistemologia bergsoniana, Duchamp ne ripete l’impalcatura: la macchina metafisica del bergsonismo, con le sue invenzioni grafiche (il cono della memoria, il circuito degli oggetti percepiti) rimbalza nello specchio anamorfico del Gran-de Vetro. La struttura totalizzante della memoria-durata è azio-nata dalla macchina temporale della Sposa, con le sue proiezio-ni n-dimensionali: percezione (parte inferiore del Grande Vetro, i Celibi raffigurati in prospettiva lineare), ricordo-immagine (parte superiore, la Sposa proiettata in forme libere), ricordo pu-ro (la Sposa messa a nudo dai Celibi, l’azione del suo sbocciare cinematico). La prima funzione di ogni specchio è di restituire un’immagine ribaltata: lo specchio del Grande Vetro ribalta la macchina della durata di Materia e memoria.
Il paradossale presente bergsoniano – il “puro presente” co-me «inafferrabile progresso del passato che rode il futuro» – e il corpo desostanzializzato – «limite mobile tra il futuro e il passa-to» – sono lo specchio della Sposa133. L’“ultra-rapido” di Du-champ è un’altra occorrenza del ritardo miroirique. La “posa ul-tra-rapida” del Grande Vetro esibisce il “riposo istantaneo” del-la Sposa. L’istantaneità è un riposo perché «di fatto, per noi, non c’è mai l’istantaneo» e la presenza dell’immediato è già sempre ritardata, non mediata come nella tradizione speculativa hegeliana. Il “riposo istantaneo” della Sposa è la forma statica del ritardo simultaneo, uno scarto prodotto dalla dissomiglianza tra il virtuale e l’attuale.
La legge fondamentale dell’attualizzazione consiste nel principio secondo cui «l’attuale non assomiglia alla virtualità che realizza»134. Se vi assomigliasse, se non esistesse una diffe-renza di potenziale, il circuito dell’oggetto virtuale non potreb-be funzionare e il Grande Vetro non sarebbe un motore ma una macchina statica: «La sposa fondamentalmente è un motore. Ma prima di essere un motore che trasmette la sua timida potenza – essa è questa timida potenza stessa»135. La “timida potenza” è la
133 H. Bergson, Materia e memoria, cit., pp. 127, 64. 134 G. Deleuze, Il bergsonismo e altri saggi, cit., p. 87. 135 M. Duchamp, Mercante del segno, cit., p. 50.
Capitolo III 164
potenza dell’impotente: l’energia prodotta dalla differenza di in-tensità tra il “radicalmente impotente” bergsoniano (il virtuale) e l’azione come attualità di un movimento inutile e aleatorio. Figurativamente, i dislivelli dell’impotenza che fanno del mec-canismo un motore corrispondono allo “sboccio cinematico” della Sposa nella parte superiore e alla “messa a nudo elettrica” degli scapoli. Una vergine di sopra e la masturbazione degli scapoli sotto. La potenza timida scaturisce dalla riflessione-trasformazione delle due metà del Grande Vetro, la messa a nu-do della Sposa è innescata dallo specchio-trasformatore-raffreddatore centrale.
La Sposa è un motore concettuale: riflessione del virtuale nell’attuale. Un motore a due tempi: polarità dell’organico e del meccanico, energia “psico-chimica” e sintesi di “meccanica e mistica” per il Bergson delle Due fonti della morale e della re-ligione. Un motore a scoppio: la temporalità implosiva della Sposa, l’intuizione bergsoniana. Come ogni motore ha bisogno di ventilazione (il vento che scuote il corpo esploso della Sposa nella parte superiore del Grande Vetro) e di un raffreddatore, le tre strisce di vetro che separano le due metà dell’opera:
Questo motore-desiderio è l’ultima parte della macchina celibe. Lungi dall’essere in contatto diretto con la Sposa, il motore-desiderio è sepa-rato da un raffreddatore ad aria (o acqua). Questo raffreddatore (grafi-camente) per esprimere che la Sposa, invece di essere soltanto un pez-zo di ghiaccio asensuale, rifiuta caldamente (non castamente) la bru-sca offerta dei celibi. Questo raffreddatore sarà di vetro trasparente. Parecchie lastre di vetro le une sulle altre136. La cerniera è una cesura attorno alla quale si ordina
l’insieme del tempo, un’incrinatura che trasforma la temporalità vivente del presente in una distribuzione formale del diseguale, risolvendo il problema compositivo che intrattenne Duchamp sin dagli esordi cubo-futuristi: la rappresentazione statica del
136 Ivi, p. 47.
Strumenti meravigliosi 165
movimento137. Nel Grande Vetro, come in Bergson, lo spazio è temporalizzato (critica dell’illusione spaziale del movimento nel Saggio sui dati immediati della coscienza; “quarta dimensione” della Sposa) e la temporalità spazializzata (la durata come si-multaneità in Materia e memoria; il virtuale costruzionista del Grande Vetro, effetto di proiezioni geometriche). In Bergson, il corpo-riflessione ha luogo nell’evento – intemporale come la cesura – della selezione delle immagini, con un taglio che di-stribuisce il tutto e lo ordina in base al gioco dell’azione e dell’impotenza, dell’attuale e del virtuale. In Duchamp, la Spo-sa è l’evento del fiorire del desiderio, ma si produce soltanto come rispecchiamento del regno meccanico (i Celibi, l’attualità) in quello erotico (la Sposa, il virtuale), nella riflessione causata dalla duplicazione dello specchio ad opera della ceniera-cesura.
Nelle “Note” del Grande Vetro Duchamp ricorre a una for-mulazione che collega il raffreddamento del motore concettuale al circuito dell’“oggetto virtuale” di Bergson: «Malgrado questo raffreddatore, non c’è soluzione di continuità tra la macchina celibe e la Sposa. Ma i legami saranno elettrici ed esprimeranno così la messa a nudo: operazione alternativa. All’occorrenza corto-circuito»138. Macchinazione a motore e non semplice meccanismo statico, la produttività “estetica” della Sposa è a-zionata dal dislivello tra le due timidezze del virtuale e dell’attuale139. La Sposa come bergsoniano “centro di indeter-minazione” contesta la retorica della presenza: né cosa né istan-te, la Vergine nuda si riflette su se stessa mediante una divisio-ne dell’immagine. Il Grande Vetro non rappresenta una Sposa,
137 La decostruzione della presenzialità dell’istante travolge anche la mistica della fruizione contemplativa, o “assorbente”, dell’arte: non a caso, la Sposa è su vetro, più la si guarda meno essa si lascia vedere e si confonde con lo sfondo del museo.
138 Ibidem 139 Per Michel Serres, la meccanica classica non accede al motore e celebra il mec-
canismo (leve, pulegge, argani, corde, contrappesi e così via). Ad essa il movimento è estraneo, mentre centrale è l’equilibrio. Anche quando le macchine propagano, inverto-no, duplicano, trasformano il movimento, ciò a cui esse tendono è il ripristino del ripo-so, l’annullamento del movimento, l’equilibrio. Di contro, il motore scoperto dalla Ri-voluzione industriale non appartiene alla meccanica ma alla fisica, e sfrutta il principio di produttività insito nella differenza tra le forze; cfr M. Serres, È stato prima dell’esposizione (universale), in Le macchine celibi/Bachelor Machines, cit., pp. 64-74.
Capitolo III 166
ha luogo come presentazione impossibile di un evento indeter-minato, è una catena di effetti insensati avviati dall’aleatorietà di una cesura.
Altre riflessioni
Nello smarcarsi dall’ontologia hegeliana della speculazione
(Heidegger, Derrida, Deleuze, Lyotard) o nel ribadire l’epistemologia kantiana della riflessione (Apel, Habermas, Lu-hman) la filosofia del Novecento incrocia il miroirique du-champiano140. La scelta dei materiali riflettenti condiziona il ri-sultato. Le superfici eteromorfe non rinviano reciprocamente e ogni gioco di specchi si svolge secondo regole di costruzione specifiche.
Accorto commentatore di Duchamp, Lyotard proietta la spe-cularità miroirique nel “dissidio” linguistico, nel dualismo im-plosivo delle antilogie sofistiche: «Non c’è arte perché non ci sono oggetti. Ci sono solo trasformazioni, redistribuzioni di e-nergia»141. Si tratta di una ripresa della cartegoria duchampiana dello “scarto”, di un’interpretazione logicistica di Duchamp che universalizza i meccanismi di eterogeneità e incongruenza142. Vittima di questa interpretazione è lo statuto oggettuale del rea-dymade: la conservazione dell’oggetto presupposta alle cesure duchampiane è sacrificata per introdurre un principio di disfun-zionalità. Rigettando la duplicità interna al readymade, dimenti-cando lo specchio virtuale su cui è montato quello attuale, Lyo-tard scorge nel ricorso alla virtualità un pericoloso residuo me-tafisico e ne disconosce il ruolo: la Sposa è una “macchinazione spaziale” in cui «si va non tanto a cogliere il virtuale quanto a dissimilare il preteso reale»143. Lo specchio in Lyotard non è
140 Cfr. R. Gasché, The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflec-
tion, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1986. 141 J.-F. Lyotard, I transformatori Duchamp, cit., p. 29. 142 Elio Grazioli descrive i I trans-formatori Duchamp come una «prassi e logica
della “dissimilazione”», che traduce il miroirique duchampiano in un esercizio d’incongruenza; cfr. E. Grazioli, Introduzione, in J.-F. Lyotard, I transformatori Du-champ, cit., p. xii.
143 Ivi, p. 62.
Strumenti meravigliosi 167
una macchina impossibile, e dunque un readymade che nella ri-flessione dell’oggetto su se stesso blocca la sintesi del virtuale nell’attuale. Al contrario, la specularità lyotardiana nasconde sempre una funzionalità miroirique, il lavoro di una macchina “dissimilante” che “spiritualizza” l’oggetto non-artistico e lo annienta in pura operatività (ritardo, scarto, dissimilazione, in-congruenza).
Di specchio in specchio, i versi hölderiniani dettano a Hei-degger un’ontologia del “gioco di specchi” (Spiegel-Spiel) che riformula la dialettica di auto-riflessione del soggetto e disten-sione speculativa dell’essere:
Terra e cielo, i divini e i mortali sono reciprocamente connessi, di per se stessi uniti, a partire dalla semplicità dell’unica Quadratura. Ognu-no dei Quattro rispecchia a suo modo l’essenza degli altri. Così facen-do, ognuno si rispecchia a modo suo in ciò che gli è proprio entro la semplicità dei Quattro. Questo rispecchiare non è la presentazione di un’immagine. Portando alla luce ognuno dei Quattro, il rispecchiare fa avvenire in una reciproca appropriazione la loro propria essenza nella semplicità del traspropriare […] Il rispecchiare legante nella libertà è il gioco, che confida ognuno dei Quattro a ognuno degli altri, grazie al plesso della traspropriazione che li trattiene […] Questo espropriante traspropriare è il gioco di specchi della Quadratura. In virtù di esso i Quattro sono legati nella semplicità che li affida uno all’altro”144.
Duchampianamente, lo specchiarsi heideggeriano non gene-
ra un’immagine. La proceduralità della riflessione specchiante ha pertanto la meglio sull’ontologizzazione dell’immagine: la riflessione non riflette cose in simboli e simboli in concetti, essa è un “gioco”, un’articolazione ossimorica delle relazioni leganti e liberanti, un’appropriazione-traspropriazione dei punti cardi-nali dell’essere. L’immagine si decostruisce moltiplicandosi nel “gioco di specchi” della Quadratura. In questo gioco non iconi-co, concepito da Heidegger come un’esperienza del “portare al-la luce”, la partita non ha bisogno che della regola della sempli-
144 M. Heidegger, La cosa, in Saggi e discorsi, trad. it. di G. Vattimo, Mursia, Mila-no 1991, p. 119. Sulla specularità in Heidegger, cfr. R. Gasché, On Minimal Things. Studies on the Notion of Relation, Stanford University Press., Stanford 1999, pp. 195-220.
Capitolo III 168
cità, dell’irrevocabilità del risultato. La divinità, quando detta l’opera, giudica senza appello: il gioco di specchi non prevede esitazioni, ci sono soltanto vinti e vincitori. La grecità heidegge-riana dissimula la predestinazione nella “terra” e Cristo negli dei. Poiché l’ontologia heideggeriana è elaborata ma non mac-chinosa, il gioco dei suoi specchi avviene, “si dà” (sich zu-spielt). In un’attività ludica priva degli inganni delle partite a scacchi di Duchamp non ci sono tiri mancini: si vince e si per-de, si è salvati o dannati. Semplicità e gioco di specchi. I due requisiti della riflessione secondo Heidegger, fondati in un gio-care senza le iperboliche complicazioni (tecnologiche e catego-riali) dei meccanismi riflettenti del Grande Vetro. L’essere è un gioco di specchi, una relazione disgiuntiva, ma di questa sfida importa soltanto che qualcuno sia messo in gioco, che ci sia un destino nella manifestazione. Se si gioca in stato di grazia, allo-ra si vince.
In quanto evento, sentenza aniconica, semplicità e sincerità, la riflessione heideggeriana è giocata dai versi di Hölderlin. I suoi specchi non rendono irriconoscibile il modello: lo svelano, lo interpretano, rivelano l’enigma. Le matrici esoteriche del Grande Vetro sono invece complicazioni inutili, costruzioni che ritardano l’interpretazione. In Duchamp non c’é riflessione de-cisiva e dunque messa in gioco. L’orologismo dell’opera è un evento che ne rimanda l’apparizione e ne duplica l’apparenza, un caso in cui «negazione ed affermazione vengono ad arenar-si» (Mallarmé). Perché il fruitore abbandoni l’abito ermeneuti-co, perché si astenga dall’interpretare la presenza dell’opera e dal produrne, in stato di grazia, l’enigmaticità, perché nessuno si specchi nell’arte come le riflessioni di Heidegger sulla super-ficie luminosa dei versi di Hölderlin, Duchamp smonta il suo ultimo readymade.
Dati: 1o la caduta dell’acqua, 2 o il gas d’illuminazione è un’opera già costruita, disassemblata e consegnata ai posteri come sequenza di Istruzioni di montaggio (Approssimazione smontabile, eseguita tra il 1946 e il 1996 a New York). Dati … non ha bisogno perciò di interpreti che si riconoscano in essa, ma di esecutori (decoratori, elettricisti) che la rimontino atte-
Strumenti meravigliosi 169
nendosi alle istruzioni. Per sventare il rapimento estatico della ricezione, la violenza appropriante di uno spettatore che decida di vincere e farsi assorbire dall’evento dell’opera sfruttando la residua visibilità dell’opera per specchiarsi, Duchamp immobi-lizza il fruitore, istruisce anche la sua riflessione e gli assegna la posizione del voyeur: attraverso due fori si assiste alla scena, pornografica, di un delitto. La presenza è oscena, l’interpretazione un delitto.
Nel saggio La disseminazione Derrida ha portato a una so-glia di attenzione filosofica l’ontologia della specularità di Phi-lippe Sollers. Per la comune derivazione da Mallarmé, il miroi-rique di Duchamp condivide l’impalcatura dello specchio-schermo di Sollers-Derrida: cesura, ritardi, duplicazione, schermatura; l’essenziale è che questi specchi siano “insoliti”, “germinali”, “deformanti”, che producano “effetti di specchio”: «se la “presenza, o produzione, non è che un prodotto”, il “rea-le”, l’“originario”, il “vero”, il “presente” non sono costituiti che di rimando, a partire dalla duplicazione nella quale solo possono sorgere»145.
Derrida riconduce il “gioco di specchi” heideggeriano al pa-esaggio duchampiano dello scarto. Lunghe citazioni da La cosa e Costuire abitare pensare vengono introdotte per “mantenere lo scarto” e l’esitazione della specularità, per catturare la que-stione dell’essere in un’ontologia specchiante: «E tuttavia l’è […] rimane preso nello specchio. Letto nello scarto, non arriva mai»146. Derrida insiste sulla radice quaternaria della specularità heideggeriana (Geviert), associandola ai movimenti anti-dialettici della quadratura-inquadramento-quadrante, alle «quat-tro radici delle cose di Empedocle», «al tetragono – o sacro qua-ternario – di Pitagora, ai quattro punti cardinali della Cabbala,
145 J. Derrida, La disseminazione, cit., p. 334. Gli specchi di Sollers-Derrida si di-
stinguono radicalmente dalla “fase dello specchio” lacaniana. Anche in Lacan lo spec-chio attua una generazione “celibe” della rappresentazione e della soggettività, e tuttavia la matrice gestaltica ed hegeliana di questa specularità dà vita esclusivamente a processi identificativi e alienativi; cfr. Y.-A. Bois, R. Krauss, L’informe, a cura di E. Grazioli, Bruno Mondatori, Milano 2003.
146 J. Derrida, La disseminazione, cit., p. 359.
Capitolo III 170
al Grande Quaternario d’Eckartshausen» e, soprattutto, alla “quarta superficie” degli specchi-schermo del Libro di Mallar-mé e dei Numeri di Sollers.
La fedeltà a Mallarmé-Sollers – e dunque al lessico ducham-piano – è controbilanciata dalla matrice husserliana, che condu-ce Derrida a una teoria quasi-trascendentale dello speculativo. La traccia si cancella nel prodursi, lo specchio nasconde il pro-prio fondo per far rimbalzare la rappresentazione con inganne-vole neutralità. E tuttavia, sfruttando i buchi della superficie, la riflessione generalizzata e eccessiva della decostruzione penetra lo specchio e mostra la densa lastra di stagno che regge la sedu-cente unità del rispecchiamento: «Guardare attraverso lo spec-chio significa guardare il suo retro, la parete opaca che raddop-pia il gioco di specchi, in breve, la lastra di stagno»147. Così come il taglio della riduzione trascendentale spalanca a Husserl il dominio degli atti puri della coscienza, è una rottura dello specchio a sostenere la decostruzione del mimetismo rappresen-tativo: «Lo specchio ha luogo – cercate di pensare l’aver luogo di uno specchio – per essere infranto»148. L’“aver luogo” dello specchio è una fessura che ne fende la lucida superficie, lo spa-lancarsi dei buchi che raddoppiano la rappresentazione, espo-nendo il fondo della superficie. Decostruire la specularità signi-fica perciò descrivere fenomenologicamente la natura di questo infrangere, le condizioni di possibilità della cesura, l’aver luogo di uno specchio semi-riflettente e assorbente.
Frammentato, lo specchio riflettente diventa specchio-schermo, uno “specchio di specchio” che intensifica la rifles-sione e la torce su se stessa. Solo a una riflessività ipertrofica, che irrompe facendo breccia nello specchio, sono accessibili al contempo le leggi formali della riflessione e il fondo dello specchio (tain). «Il mondo comprende lo specchio che lo capta e reciprocamente»149. Lo specchio penetrato dalla luminosità che doveva restituire, lo specchio infranto, è il buco di una ca-
147 R. Gasché, The Tain of the Mirror, cit., p. 238. 148 J. Derrida, La disseminazione, cit., p. 326. 149 Ivi, p. 327.
Strumenti meravigliosi 171
mera oscura, uno schermo che assomiglia all’apertura di una pa-rete mancante, uno specchio «che si attraversa da se stesso»150. Poiché l’evento della rottura dello specchio, il suo “aver luogo”, precede l’intrusione narcisistica del soggetto – come un oriz-zonte, l’evento che inaugura la riflessione «producendosi sem-pre, non arriva mai» – Derrida si colloca nella logica della di-struzione della specularità specchiante e ne descrive le conse-guenze. Lo specchio-filtro – né puro specchio né puro schermo, una superficie a cui è tolta l’opacità assoluta di una perfetta la-stra di stagno e di un muro impenetrabile, la “quarta parte” di Sollers – confonde la delimitazione del rispecchiato e del ri-specchiante, «elude ogni sicurezza presa nell’opposizione del valore e del non-valore, del rispettabile e del non-rispettabile, del vero e del falso, dell’alto e del basso, del dentro e del fuori, del tutto e della parte»151.
Mentre il “dissidio” di Lyotard si colloca nello spazio d’incongruenza scoperto dalla logica duplicativa, escludendo la produttività del virtuale, in Logica del senso Deleuze rilancia la strategia duchampiana della virtualità specchiante. Ma i suoi specchi sono quelli di Lewis Carroll, non il miroirique della Sposa. Come Carroll in Attraverso lo specchio, Deleuze tra-sforma la superficie dello specchio in una scacchiera: «Alice in-tende lo specchio come superficie pura, continuità del fuori e del dentro, del sopra e del sotto, del dritto e del rovescio […] Alice stessa entra nel gioco: appartiene alla superficie della scacchiera che ha soppiantato lo specchio»152. A prima vista, la coppia di Aiôn e Kronos – la coesistenza paradossale di un pas-sato e futuro senza presente e il “presente vivente”, l’ operazio-ne specchiante e il taglio corporeo, la riflessione e l’assorbimento, il formalismo e la materialità – non fa altro che prolungare la polarità del virtuale e dell’attuale. E tuttavia, logi-cizzando le funzioni di Aiôn in una “logica del senso”, Deleuze abbandona l’unità impossibile dell’opera non artistica, la so-
150 Ivi, p. 359. 151 Ivi, p. 327. 152 G. Deleuze, Logica del senso, cit., p. 207.
Capitolo III 172
vrapposizione del readymade e del miroirique, e rivendica una dualità radicale tra ciò che assorbe e riceve l’azione (Kronos) e ciò che si sottrae a questa azione (Aiôn, l’evento puro, il puro divenire). Mentre il Grande Vetro, indipendentemente da qual-siasi “lettura”, è insieme readymade e specchio e appare nel gioco di cerniera tra il virtuale e l’attuale, Aiôn e Kronos sono in Deleuze «due letture del tempo»153; Aiôn non è il virtuale come «parte integrante dell’oggetto reale», ma l’“operazione pura” della divisione del tempo, il divenire folle della superfi-cie.
Aiôn-specchio, istanza paradossale, superficie a due facce che si riflettono disconoscendosi; Aiôn divide il presente impe-dendo l’incarnazione dell’istante: operazione pura dell’evento, «istante senza spessore e senza estensione che suddivide ogni presente in passato e futuro»154. A rigore, questo istante para-dossale, in grado sempre di schivare l’identità e la materialità del presente, è sia un ritardo che un anticipo, funzionando piut-tosto come un «puro momento di astrazione» che suddivide «o-gni presente nei due sensi contemporaneamente, in passato e fu-turo»155. Coincidendo con l’evento, Aiôn nomina la matrice del senso definito, duchampianamente, «quarta dimensione della proposizione»156. «Quali sono i caratteri di questa istanza para-dossale? […] È un’istanza a doppia faccia, ugualmente presente nella serie significante e nella serie significata. È lo spec-chio»157.
Con un linguaggio mallarmeiano che potrebbe trovare posto, readymade, tra le “Note” di Duchamp al Grande Vetro, Deleuze attribuisce ad Aiôn le caratteristiche di un giocatore ideale. Co-me il Manipolatore di gravità della Sposa, Aiôn «gioca almeno su due tavole, alla cerniera delle due tavole […] L’Aiôn si trova esattamente alla frontiera di entrambe, la linea retta che le sepa-ra, ma anche superficie piana che le articola, vetro o specchio
153 Ivi, p. 60. 154 Ivi, p. 147. 155 Ivi, p. 148. 156 Ivi, p. 25. 157 Ivi, p. 43.
Strumenti meravigliosi 173
impenetrabile»158. La logica del senso di Aiôn non ha bisogno dei movimenti dei Celibi, della pesantezza del mondo meccani-co: il virtuale come effetto di superficie – specchio che riflette gli eventi o scacchiera che li pianifica – è un’arte della legge-rezza, un “gioco ideale” senza regole, un movimento di scarto “rispetto a quell’elemento che non cessa di spostarsi in rapporto a sé nelle due serie” del significante e del significato159.
“Vetro o specchio”, Aiôn o Kronos, virtualità o attualità. De-leuze smonta il circuito dell’oggetto virtuale e reinventa il dua-lismo platonico delle copie e dei simulacri, là dove Duchamp prescrive un’opera che sia insieme copia e simulacro, vetro e specchio, dissimulazione e desiderio, virtualità e attualità. Sepa-rato da Aiôn, Kronos si sedimenta nel fondo dello specchio (tain), diviene la materialità assorbente in cui si incorporano e inscrivono le operazioni pure di Aiôn: «Vi è sempre un più va-sto presente che riassorbe il passato e il futuro […] Il presente in Kronos è in qualche modo corporeo. Il presente è il tempo delle mescolanze o delle incorporazioni, è il processo stesso dell’incorporazione»160.
Quel che rende la Sposa un vetro è il suo essere una superfi-cie semi-trasparente, uno specchio che duplica senza appro-priarsi del modello. Emancipandosi dall’opacità del fondodi stagno (schermo o Kronos), questa trasparenza scansa sia la lo-gica decostruzionistica della trascendentalizzazione della pre-senza sia l’ermeneutica della speculatività dialettica attribuita alla soggettività spettatoriale:
Ricollegandoci a un uso terminologico documentabile in Hegel, chia-miamo ciò che vi è di comune tra la dialettica metafisca e la dialettica ermeneutica speculatività. Speculativo indica qui il rapporto del ri-specchiare. Lo specchiarsi è uno scambio continuo […] L’immagine dello specchio è essenzialmente legata alla cosa che riflette per mezzo dell’osservatore. Non ha un essere per sé161.
158 Ivi, p. 63. 159 Ivi, p. 44. 160 Ivi, p. 145. 161 H.G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 532.
Capitolo III 174
Il miroirique duchampiano non ha bisogno né di un osserva-tore che suplisca alla “stupidità” sostanziale del rimando specu-lare né del legame “essenziale”, dialettico, d’incorporazione e somiglianza tra la cosa e l’immagine. La sua è l’esistenza pro-pria di un’opera concettuale, non di un’immagine rappresentati-va, allegorica o simbolica che sia. Il Grande Vetro è il manife-sto di un’esteticità senza arte e di un’ontologia dell’opera come operazione senza soggetto. Di qui la sua apparenza costruttiva e la sua innocenza: Duchamp non ha bisogno di discolparsi della tradizione idealistica ed estetica, non deve aggredirla con nega-zioni determinate (ermeneutica) o interminabili mise en abyme (decostruzione).
Renvoi miroirique: la riflessione nel Grande Vetro del tessu-to di Materia e memoria deforma l’opera e sfigura la tradizione bergsoniana. Come Alice nel paese di Deleuze, il Grande Vetro ha contratto l’influenza bergsoniana, l’opera di Duchamp è un quadro malato di bergsonismo e si sdoppia. Perciò i cinquanta oggetti definiti “readymade” da Duchamp sono entità bicefale; non semplici readymade ma readymade specchiati: “reciproci”, “precisati”, “aiutati”, “malati”.
Capitolo III 176
3. Macchina, occhio, corpo
Che genere artistico sarebbe quello che fosse estratto dal concetto di spettatore, quasi che la vera forma di tale genere do-vesse essere considerata lo “spettatore in sé”? F. Nietzsche, La nascita della tragedia
Esiste un luogo per l’arte? Che cosa accade all’opera quando
si affermano altri pretendenti, quando l’arte abbandona l’unità del quadro, la sua silenziosa immediatezza e ha luogo nell’esperienza, nel corpo, nel concetto o nello spettatore?162 Il disperato tentativo di difendere l’autonomia estetica ha finito con il ridurre il luogo dell’arte al mito della purezza della visio-ne e in seguito alla specificità del medium163. Per questa strada, percorsa con coerenza dalla critica d’arte greenberghiana, la compresenza del tattile e del visivo all’interno del paradigma ottico della Kunstwissenschaft si approfondisce in una scissione tra l’occhio e il corpo, tra l’osservatore e lo spettatore, tra un modernismo votato alla specificità della visione gestaltica e un’avanguardia che ne contesta la purezza164.
162 Cfr. R. Klein, L'eclissi dell'“opera d'arte”, in La forma e l'intelligibile. Scritti
sul Rinascimento e l'arte moderna, trad. it. di R. Federici, Einaudi, Torino 1975. 163 È il paradigma impressionista e fiedleriano della “pura visibilità”. Dipendenti da
questa tradizione sono alcune fondamentali interpretazioni filosofiche dell’arte moder-na, ad esempio la ricostruzione della storia della pittura di Arnold Gehlen (Quadri d’epoca, trad. it. di G. Carchia, Guida, Napoli 1989) e gli studi di Pavel Florenskij (Lo spazio e il tempo dell’arte, a cura di N. Misler, Adelphi, Milano 1995).
164 «In tutte le sue manifestazioni il dadaismo e la pittura modernista sono antiteti-che. Mentre il dadaismo aspira a cancellare tutte le distinzioni tra le opere d’arte e gli al-tri tipi di oggetti o di occorrenze nel mondo, la pittura modernista ha tentato di isolare, asserire e lavorare con ciò che è essenziale per l’arte della pittura in un determinato momento» (M. Fried, Three American Painters: Kenneth Noland, Jules Olitski, Frank
Strumenti meravigliosi 177
Nella ricostruzione di Brian O’Doherty, l’Occhio è il solo abitante di uno spazio espositivo sterilizzato […] L’arte a cui l’Occhio è portato quasi esclusivamente ad affidarsi è quella che preserva il piano pittorico – la corrente principale del mo-dernismo. L’Occhio afferma lo spazio liscio della galleria, le sue pare-ti sono coperte da superfici piane di tela. Tutto il resto – tutto ciò che è impuro, compreso il collage – favorisce lo Spettatore165. Dopo aver abbandonato l’illusionismo della rappresentazio-
ne, la pittura da cavalletto sopravvive rifugiandosi nella superfi-cie che a sua volta, con l’erosione dei limiti formali della corni-ce – il significante dell’autonomia del quadro – s’identifica con le pareti. La coabitazione dell’occhio e dello spettatore che i-naugura la modernità pittorica è rimpiazzata da un’estetica della superficie e da un’arte dell’impurità166.
L’occhio disincarnato trova il suo ultimo rifugio nell’astrattezza del white cube, nello spazio neutrale di una gal-leria dalle pareti bianche, di una camera estetica formalistica, un esito della letteralizzazione dello spazio pittorico. Alla sublima-zione visuale degli ambienti modernisti rispondono la “galleria come gesto” di Duchamp – i milleduecento sacchi di carbone appesi al soffitto dell’Esposizione internazionale del Surreali-smo (1938), il miglio di corda teso a ragnatela al 551 di Madi-
Stella, in Art and Objecthood. Essays and Reviews, University of Chicago Press, Chi-cago 1998, p. 259. Trad. it. mia). Per una ricostruzione storiografica che registra l’abbandono del primato dell’occhio teorizzato dalla Kunstwissenschaft e «la riabilita-zione della mano e dei suoi ritmi» in Merleau-Ponty, Dufrenne e Deleuze, cfr. A. Pinot-ti, Il corpo dello stile, Aesthetica Preprint, Centro internazionale studi di estetica, Pa-lermo 1998.
165 B. O’Doherty, Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, Uni-versity of California Press, Berkeley 1999, p. 42 (trad. it. mia).
166 Il superamento della concezione del quadro come finestra sul mondo e rappre-sentazione mimetica e l’elezione dei valori di superficie a luogo privilegiato dell’arte non scaturiscono necessariamente in una contrapposizione tra occhio e corpo, otticità e apticità. Nell’interpretazione della superficie pittorica proposta da G. Deleuze la teleo-logia della superficie rimanda a una tavola-informazione, allo sviluppo infinito delle pieghe, a un’estensione del “dentro” che fuoriesce dalle cornici sotto la spinta di una legge degli estremi, non al trionfo della visibilità e del supporto: «Al quadro-finestra si sostituisce così il tabulato, la tavola su cui si indicano le linee, i numeri, i caratteri inter-cambiabili (l’oggettile)» (G. Deleuze, La piega. Leibniz e il barocco, cit., p. 45).
Capitolo III 178
son Avenue nel 1942 – e gli happening di Yves Klein, che uti-lizzano l’intero spazio espositivo come materiale artistico, sve-lando i contenuti impliciti del mondo dell’arte167. Il white cube diventa un “medium alchemico”, al fruitore menomato e impri-gionato nell’occhio è restituito un corpo – libidinale e sociale – e con esso la possibilità di indignarsi, di toccare, di desiderare e demistificare gli oggetti.
Poiché ha proiettato al suo esterno, sullo spettatore, ogni va-lore etico, politico ed esperienziale, lo spazio espositivo moder-nista può rovesciarsi in un’estetizzazione del contesto. Il vuoto della galleria, le pareti bianche, il referente rimosso della super-ficie pittorica, si trasformano in una membrana, nel significante centrale dell’arte postmoderna. Le belle arti abbandonano la collocazione metafisica dell’opera, diventano site-specific, ef-fimere, e hanno luogo al di fuori del museo o in un museo deco-struito dalla logica parergonale di un’esteticità impura168.
La dissociazione dell’arte contemporanea in un modernismo pittorico intransigente e in un’avanguardia di ispirazione co-struttivista e dadaista comporta una duplicazione schizofrenica dei luoghi dell’arte: nel primo caso l’opera assorbe lo spettato-re, nel secondo lo incarica di supplire a se stessa, di ripeterla e sostituirla. A questa genealogia – tipicamente statunitense, in-centivata dagli orientamenti dei grandi musei e dall’istituzionalizzazione della critica modernista – corrisponde la divaricazione teorica tra i sostenitori formalisti della qualità
167 Sulla “galleria come gesto” e in particolare sulla riformulazione concettuale del-
lo spazio espositivo da parte del Vide di Yves Klein del 1958 e del Plein di Arman del 1960 (entrambi alla Galerie Iris Clert di Parigi) cfr. B. O’Doherty, Inside the White Cu-be, op. cit., pp. 87-107. Il contenuto implicito dello spazio espositivo è trasformato nella sua totalità in potenziale artistico dal gesto dell’artista: Klein materializza il suo sistema mistico mediante un complesso rituale che pone al centro della galleria una vetrina vuo-ta, Arman satura l’esposizione di spazzatura e rottami, confinando all’esterno lo spetta-tore (ivi, pp. 87-94).
168 Cfr. l’Invisible Sculpture di Andy Warhol, le Zones de sensibilité picturale im-matérielle di Yves Klein o le sculture autodistruttive di Jean Tinguely. Per un’efficace panoramica sulle pratiche espositive postmoderniste, cfr. N. de Oliveira, N. Oxley, M. Perry, Installation Art, Thames and Hudson, London 1994.
Strumenti meravigliosi 179
estetica e quelli decostruzionisti dell’interesse169. La condanna dell’arte minimalista da parte di Fried, un critico formalista di ispirazione greenberghiana, è condotta perciò in nome della per-fetta simultaneità e autosufficienza ontologica della visione: l’arte modernista non possiede durata, le opere si manifestano interamente in ogni momento, escludendo il protrarsi temporale dell’esperienza dello spettatore170. Sulla base di una concettuali-tà fenomenologica, affidandosi al paradigma dell’occhio come centro e nucleo vivente, Fried celebra la grazia, la presenza in-tuitiva dell’osservatore nell’opera171.
La relazione dell’arte figurativa con lo spettatore, la cui esi-stenza diventa problematica a partire dalla metà del XVIII seco-lo, è risolta da Diderot – una volta per tutte, all’origine della modernità – con la “finzione suprema” della non esistenza dell’osservatore, ovvero mediante la neutralizzazione e nega-zione della sua presenza empirica172. Al prezzo dell’accettazione di una nozione ristretta di visualità, che com-porta il sacrificio dello spettatore e dei motivi non-artistici in-trodotti dalle avanguardie, Fried preserva la centralità assiologi-ca dell’opera e le leggi compositive del quadro173. Di contro, quando la “teatralità” ha il sopravvento e il contatto intuitivo con l’opera è sacrificato a beneficio dell’interazione tra la situa-
169 H. Foster, The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century, MIT Press, Cambridge, Mass 1999, p. 199.
170 M. Fried, Art and Objecthood, in Minimal Art. A Critical Anthology, a cura di G. Battcock, University of California Press, Berkeley 1995, p. 145.
171 Jacques Derrida ha mostrato la differenza interna all’attualità del presente feno-menologico, la ripetizione che produce l’idealità: «se la puntualità dell’istante è un mi-to, una metafora spaziale o meccanica, un concetto metafisico ereditato o tutto questo nello stesso tempo, se il presente della presenza a sé non è semplice, se si costituisce in una sintesi originaria e irriducibile, allora tutta l’argomentazione di Husserl è minacciata nel suo principio» (J. Derrida, La voce e il fenomeno, trad. it. di G. Dalmasso, Jaca Book, Milano 1984, p. 98).
172 M. Fried, Absorption and Theatricality. Painting and the Beholder in the Age of Diderot, University of California Press, Berkeley 1980, p. 93.
173 Per isolare la logica formale dell’arte tardo-modernista di Noland, Olitski e Stel-la, Michael Fried introduce la distinzione tra strutture deduttive e induttive: «L’estrema dipendenza dal carattere letterale del supporto del quadro che costituisce la struttura de-duttiva rappresenta il punto di arrivo di una tendenza visibile nell’opera di Manet, se non prima» (M. Fried, Three American Painters: Kenneth Noland, Jules Olitski, Frank Stella, op. cit., p. 252. Trad. it. mia).
Capitolo III 180
zione e lo spettatore, prende avvio la deriva dell’arte minimali-sta: gli oggetti di grande dimensione e privi di relazioni interne tengono a distanza lo spettatore, impediscono al fruitore di ve-nire assorbito dall’opera, di partecipare alla parusia della sua verità174.
Al formalismo puritanico di Fried, alla celebrazione della to-talità e unità compositiva del dipinto (o della serie di dipinti), i sostenitori della teatralizzazione neoavanguardista contrappon-gono l’irruzione di una dimensione artistica inesplorata: la loca-lizzazione ideologica e percettiva di ogni atto spettatoriale:
In breve, con il minimalismo la scultura non è più isolata, su un piedi-stallo o come arte pura, ma è riposizionata tra gli oggetti e ridefinita in termini di luogo. In questa trasformazione lo spettatore, rifiutato lo spazio sicuro, sovrano dell’arte formalista, è rigettato nella contingen-za; e invece di scandagliare la superficie di un’opera per una mappatu-ra topografica delle proprietà del suo medium, lo spettatore è indotto a esplorare le conseguenze percettive di un intervento particolare in un sito determinato. È questo il riorientamento fondamentale inaugurato dal minimalismo175. Deleuze ha collegato esplicitamente questa cattura dello
“spettatore stesso nella performance” all’arte barocca, al «pro-digioso sviluppo di una continuità tra le diverse arti», che fa sì che la pittura fuoriesca dal quadro per realizzarsi nella scultura e quest’ultima nell’architettura, la quale a sua volta si rovescia in urbanistica176. Le arti informale e minimal ereditano consa-pevolmente il teatro delle arti barocco, il «piacere di situarsi “tra” due arti, tra pittura e scultura, tra scultura e architettura, per raggiungere un’unità delle diverse arti attraverso la perfor-
174 «Si è ragionato molto negli ultimi tempi di body art e si è discusso molto, anche
troppo, di arte concettuale, situazionale, microemotiva […] Ma forse non si è dato abba-stanza peso a un fatto: al divenire teatro di tutte le forme artistiche del periodo che stia-mo attraversando. Divenir teatro, nel senso di trasformarsi delle arti figurative, della musica, della plastica, in un’azione dell’uomo che si serve del proprio corpo (del Lieb come avrebbe detto Husserl) per imbastire un dialogo tra sé e il prossimo, tra artista (l’attore) e il pubblico» (G.Dorfles, Il divenire della critica, Einaudi, Torino 1976, p. 255). Con Mallarmé, anche la letteratura si sopprime nella teatralità del Libro.
175 H. Foster, The Return of the Real, op. cit., p. 38 (trad. it. mia). 176 G. Deleuze, La piega, cit., p. 202.
Strumenti meravigliosi 181
mance»177. Il coinvolgimento dello spettatore e la teatralizza-zione provengono da una nuova concezione del luogo dell’arte, dalla teorizzazione di un’unità estensiva «in cui la forma non limita più un volume, ma abbraccia uno spazio illimitato in ogni direzione»178.
L’incarnazione dell’arte nell’opera e nello spettatore non è l’unica soluzione ai dilemmi della “s-definizione dell’arte”, del-la sua destabilizzazione categoriale. Introducendo la nozione di “opera aperta”, Umberto Eco scorge nella comunicazione il luogo proprio dell’arte del XX secolo. Con l’ambizione di si-stematizzare e arginare la decostruzione dell’esperienza estetica favorita dall’irruzione dell’anti-arte179, il paradigma dell’opera aperta sdogana la nozione di “informazione estetica”, recupe-rando i presupposti di una condizione estetica di matrice kantia-na: l’artista – a cui si riconosce l’intenzionalità creativa – l’opera – colta nella sua apertura controllata – e il pubblico – un pubblico attivo e critico, concepito sull’esempio benjaminiano del pubblico di massa (che tuttavia, in Benjamin, è competente perché distratto). L’opera aperta è il luogo in cui convergono l’opera e l’esperienza della sua ricezione: «Così nella dialettica tra opera e apertura, la persistenza dell’opera è garanzia delle possibilità comunicative e insieme delle possibilità di fruizione estetica»180. Mediante un simultaneo appello alla partecipazione del pubblico e alla creatività irreggimentata dell’artista, la no-zione di opera aperta (e i suoi calchi segreti) ha influenzato la scena artistica a partire dagli anni Sessanta181 e risuona ancora oggi nella vulgata museologica, negli appelli alla democratizza-zione dei musei, al superamento della passività del pubblico contemplativo, descritto come un correlato dell’autoritarismo dell’arte figurativa e della sue pratiche espositive.
177 Ivi, p. 203. 178 Ibidem. 179 La categoria di “opera aperta” è la risposta di Eco «di fronte alla provocazione
del Caso, dell’Indeterminato, del Probabile, dell’Ambiguo, del Plurivalente» (U. Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Bompiani, Mi-lano 1980, p. 2).
180 U. Eco, Opera aperta, op. cit., p. 184. 181 C. Millet, L’art contemporain en France, Flammarion, Paris 1994, p. 47.
Capitolo III 182
Nell’elenco di sperimentazioni artistiche riconducibili alla poetica dell’“opera aperta”, Eco include anche le macchine di Jean Tinguely «(che deformate dallo spettatore e fatte ruotare disegnano configurazioni sempre nuove)»182. Avendo abbando-nato la chiusura formale in favore dell’instabilità della configu-razione visiva e della decisione motoria racchiusa nell’intervento attivo del fruitore, le sculture di Tinguely si tra-sformano in un campo di possibilità, radicalizzano le premesse dell’arte cinetica e rinnovano a favore dell’interprete la dialetti-ca tra opera e apertura della lettura. Lo spettatore diviene un soggetto attivo, consapevole della sua responsabilità di fruitore estetico, e può legittimamente aspirare all’«atto critico che rico-nosce quanto la piena apertura di varie possibilità fruitive sia tuttavia collegata intenzionalmente in un campo che orienta la lettura e dirige le scelte»183. Pena la riduzione della comunica-zione a “rumore” – il rumore assordante dei meccanismi di Tin-guely? – l’opera aperta è ancora opera, dispositivo comunicati-vo, e l’apertura è «garanzia di un tipo di fruizione particolar-mente ricca»184.
Prima di tornare alle macchine di Tinguely, che ci offriranno una chiave d’accesso all’attuale trasformazione dell’osservatore e degli spazi espositivi, è opportuno indicare una genealogia dell’arte post-estetica estranea al compromesso dell’opera aper-ta. «Si possono fare opere che non siano “arte”?»185 Nella pro-vocatoria formulazione di Marcel Duchamp, la categoria di ope-ra è mantenuta, ma a patto di sopprimere l’artisticità, il gusto, l’aspetto fisico della pittura e in generale tutto ciò che può veni-re ricondotto all’espressione animale e alla pittura “retinica”. Funzionale a questo programma, alla liberazione dell’idea dalla seduzione reificata dell’opera d’arte, è la poetica del readyma-de, nucleo generativo di tutta l’arte contemporanea, quanto di più vicino a un’opera spogliata dell’esteticità, pura testimonian-za di indifferenza visiva. Concepito come reazione alla disuma-
182 U. Eco, Opera aperta, op. cit., p. 157. 183 Ivi, pp. 177-178. 184 Ivi, p. 184. 185 M. Duchamp, Mercante del segno, cit., p. 89.
Strumenti meravigliosi 183
nizzazione dell’opera, il readymade – come gli oggetti riciclati che compongono le macchine di Tinguely – è separato dall’espressione pittorica; inoltre, in quanto oggetto già fatto, il readymade vive del giudizio del pubblico. Lo spettatore, inter-pellato aporeticamente dall’opera non artistica, “trasmuta” la materia inerte in opera.
Ma per quanto centrale sia la funzione spettatoriale nell’arte di Duchamp, il fruitore non è concepito come il decodificatore di un messaggio intenzionale, di un atto di comunicazione pre-sente a se stesso. Se l’artista non è solo a compiere l’atto della creazione, se l’opera vive del suo contesto e del suo pubblico, tanto che lo spettatore «aggiunge il proprio contributo al pro-cesso creativo»186, è perché nella catena di reazioni che accom-pagnano l’atto creativo manca un anello. È questa una “cesura” che deriva dall’impossibilità per l’artista di corrispondere, an-che inconsciamente, alla propria intenzione creativa – «la lotta verso la realizzazione è una serie di sforzi, di dolori, di soddi-sfazioni, di rifiuti, di decisioni che non possono né devono esse-re pienamente coscienti, almeno sul piano estetico»187 – una ce-sura che lascia l’opera nella condizione di “arte allo stato grez-zo”188. Compito dello spettatore – un soggetto che come l’artista non è padrone di se stesso e che Duchamp concepisce come “posterità”, istanza a cui si nega la soddisfazione gastro-nomica, perché «per lo spettatore più ancora che per l’artista, l’arte è una droga ad assuefazione» – è di “raffinare” l’“arte grezza”, di stabilire il contatto dell’opera con il mondo esterno mediante l’interpretazione189.
186 Ivi, p. 163. 187 Ivi, p. 162. 188 Le parole chiave della poetica di Duchamp, “ritardo”, “scarto”, “ultrasottile”,
“indecidibile”, “indefinito”, appartengono alla sematica della cesura; cfr. J.-F. Lyotard, I transformatori DUchamp, cit. e E. Grazioli, L’immagine ultrasottile, in G. Lingua (a cura di), Il segreto dell’immagine, Medusa, Milano 2004.
189 M. Duchamp, Mercante del segno, cit., p. 163. La “cesura”, un termine dalla ri-sonanza hölderliniana, è ripreso da Philippe Lacoue-Labarthe all’interno di una strategia di interruzione della figurazione e della rappresentazione, per bloccare il processo fin-zionale che sorregge l’“ontotipologia” occidentale, cioè l’«assegnazione figurale e fin-zionale della presentazione dell’essere e/o della verità». L’interpretazione della cesura – come taglio, distinzione, scarto, ritardo, sospensione, differenza o interruzione – è la po-
Capitolo III 184
Se, pur riconoscendole un privilegio senza precedenti, la ne-oavanguardia contemporanea diffida dell’autonomia ontologica dell’arte e si richiama a Duchamp, non risparmiando beffe e frustrazioni al suo pubblico, è perché la nuova configurazione dell’arte, la sua collocazione nella cesura, ha trasformato anche lo spettatore-interprete, il fruitore capace di giudicare nel mo-mento stesso in cui gode esteticamente dell’opera190. La natura dell’opera e il destino dello spettatore sono segnati dai ritorni dell’avanguardia storica e dalla differenziazione della cesura, come luogo dell’arte, in costellazioni “parergonali”, del “fuori” e del “dentro”191.
Con pratica “parergonale” intendiamo un’intepretazione de-costruzionista dell’arte moderna che interpreta la cesura come uno slittamento che prende «in contropiede il modernismo […] insultando l’opposizione di forma e contenuto – essa stessa formale, derivante com’è da una logica binaria – dichiarandola nulla, e non valida»192. È questo il movimento dell’“informe” di derivazione batailliana, riproposto da Yve-Alain Bois e Rosa-lind Krauss. Come il parergon derridiano – un “ornamento se-ducente” che sostituisce l’ergon (l’opera), un misto di dentro e
sta in gioco nella decostruzione della visibilità. In polemica con Lacoue-Labarthe, Nancy difende la figurazione in nome del «movimento di un taglio che, tagliando, trac-cia un altro luogo di enunciazione». P. Lacoue-Labarthe e J.-L. Nancy, Scena, «Aut aut», n. 258, 1993, p. 9. Nella filosofia dell’immagine di Nancy, la cesura risponde a un movimento di distinzione; la forza che permette all’immagine di presentarsi nella sua eterogeneità e sconnessione è sorretta dall’essenza energetica di un tratto che, nel suo ri-trarsi, marchia la differenza: «Ciò che va compreso è come la forza e l’immagine appar-tengano l’una all’altra nella stessa distinzione: come, cioè, l’immagine si dia attraverso un tratto di distinzione (ogni immagine si dichiara o si indica in qualche modo come immagine) e come ciò che essa dà sia in primo luogo una forza, un’intensità, che è in-nanzitutto la forza stessa della sua distinzione» (J.-L. Nancy, Tre saggi sull’immagine, trad. it. di A. Moscati, Cronopio, Napoli 2002, pp. 32-33). In Nancy il tratto distintivo, il movimento della cesura, costituisce la specificità dell’immagine, l’ultimo baluardo della sua autonomia.
190 U. Eco, Opera aperta, op. cit. p. 177. 191 Queste categorie non ambiscono a mappare tipologicamente alcune tendenze ar-
tistiche contemporanee, quanto a designarne, spesso trasversalmente, le costanti. Ad e-sempio, artisti come Picasso, Richter e Warhol attraversano nelle loro fasi di sviluppo i tre campi, o li combinano simultaneamente in un’unica opera.
192 Y.-A. Bois, R. Krauss, L’informe, trad. it. di E. Grazioli, Bruno Mondadori, Mi-lano 2003, p. 4.
Strumenti meravigliosi 185
di fuori, una forma che «non ha come determinazione tradizio-nale la funzione di staccarsi, ma quella di scomparire, di eclis-sarsi, di cancellarsi, di dissolversi proprio al momento in cui fa uso della maggior energia»193 – l’informe proviene dalla delu-sione di un’attesa, da una strategia di rovesciamento e declas-samento che contraddice l’ipostatizzazione modernista del vi-suale, l’otticità atemporale e l’istantaneità di un quadro vertica-le, l’ideale regolativo di opere sottoposte alla fruizione disinte-ressata di un osservatore-occhio.
La distribuzione dell’arte in opere e spettatori, e con essa una storia dell’esposizione eseguita come un valzer dialettico di occhi e corpi, non regge allo slittamento categoriale introdotto dalla critica parergonale, che decostruisce la ripartizione oppositiva del visibile e del carnale, dell’alto e del basso, dell’ideale e dell’empirico, del verticale e dell’orizzontale, riallacciandosi all’ampliamento duchampiano della funzione spettatoriale, alla sovrapposizione del vedere e del desiderare:
Imponendo allo spettatore la posizione di colui che guarda dal buco della serratura di una porta il corpo nudo di una donna presentato nella forma intensamente realista del diorama tridimensionale, Dati: 1° la caduta dell’acqua, 2° il gas d’illuminazione (1945-60), mette in scena la visualità come una sorta di voyeurismo e insiste così sulla dimen-sione corporea dell’atto di vedere – che si tratti del desiderio erotico che suscita lo sguardo, o dell’imbarazzo di essere colto mentre si guarda. Nell’un caso come nell’altro la critica duchampiana trasforma lo spazio di esposizione (in questo caso il museo) formalmente inteso come spazio pubblico in cui gli sguardi “disinteressati”, che rappre-sentano l’universalità del gusto estetico e ritenuti trasparenti gli uni agli altri, si aprono a una pluralità di opere che giudicano ma non de-siderano. Ideale della “purezza” visiva e spaziale che Dati … ostruisce con l’opacità del corpo desiderante194.
A un’arte impura, che abbandona i presupposti normativi
dell’orientamento verticale del campo visivo (i drip painting di Jackson Pollock, il flatbed di Robert Rauschenberg), della pu-
193 J. Derrida, La verità in pittura, trad. it. di G. e D. Pozzi, Newton Compton, Ro-
ma 1981, p. 62. 194 Y.-A. Bois, R. Krauss, L’informe, cit., p. 168.
Capitolo III 186
rezza dei materiali (gli assemblage dei nouveaux réalistes, le te-xturologie di Dubuffett), dell’unicità dell’atto creativo (le istru-zioni a distanza di Sol Le Witt, i multipli di Victor Vasarely), della separazione del visuale e del testuale (i disegni di Sigmar Polke, le scritte di Joseph Kosuth), della ricezione museale con-templativa (i pénétrable di Jesús Rafael Soto, gli earthwork di Robert Smithson) risponde una critica parergonale, che depo-tenzia e sposta le opposizioni categoriali, ricercando nel loro scarto un nuovo luogo per l’arte.
La ripresa dell’avanguardia dadaista-costruttivista da parte delle modalità del “fuori” approfondisce invece la separazione tra la residua specifità dell’arte e la sua essenza sociale, il suo risvolto istituzionale, intersoggettivo e referenziale195. L’artista come etnografo o sciamano, in entrambi i casi un manipolatore di segni invece che un produttore di oggetti, sostituiscono l’artista come creatore, dedicandosi al compito di desublimare la visione, di farne esplodere la mistificante dimensione esteti-ca196. Michael Asher, Christian Boltanski, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Christo, Hans Haacke, Louise Lawler, Allan McCollum, Claes Oldenburg e Fred Wilson, rappresentanti di un’arte sensibile ai contesti espositivi, decostruiscono gli stili di allestimento tradizionali per smascherare il falso idealismo este-tico del museo moderno, il suo corpo mistico, aggredito in quanto supplemento dell’opera, dispositivo di chiusura197. Oltre alle pratiche site-specific e di critica istituzionale, all’arte del “fuori” possiamo ascrivere anche le tendenze simulacrali e dell’abietto (Richard Prince, Cindy Sherman, Paul McCarthy e
195 Il “fuori” proprio di una logica della cesura si distingue sia dal “fuori” deleuzia-
no – un “campo di esteriorità” in cui si fronteggiano forze libere; cfr. G. Deleuze, Pen-siero nomade, in Nietzsche e la filosofia, a cura di F. Polidori, Einaudi, Torino 2002 – sia dal “fuori” foucaultiano: un pensiero senza soggetto, l’esteriorità del linguaggio; cfr. M. Foucault, Il pensiero del di fuori, in Scritti letterari, trad. it. di C. Milanese, Feltri-nelli, Milano 1971. Il “fuori” della cesura artistica è l’esteriorità dell’opera, ciò che nell’arte si sottrae allo sviluppo immanente del suo principio costruttivo e alla sua ra-zionalità specifica.
196 Cfr. H. Foster, The Artist as Ethnographer, in The Return of the Real, cit., pp. 171-204.
197 H. Foster, Subversive Signs, in Recodings. Art, Spectacle, Cultural Politics, New Press, New York 1999, p. 101.
Strumenti meravigliosi 187
Mike Kelly), che mediante il travestimento, la delocalizzazione dello sguardo e il perturbante, rinunciano ai procedimenti di a-strazione estetica per bucare la superficie delle immagini e riat-tivare il sostrato esperienziale della rappresentazione, la sua o-rigine non rappresentativa, la realtà del desiderio o del trau-ma198. In tutti questi casi si assiste a una politica dell’alterità, a un’alleanza tra l’analisi decostruttiva e la prassi identitaria, che orienta l’arte verso il suo “fuori”, innestandola sulla natura ses-suale e censoria di uno spettatore-testimone, di uno spettatore indistinguibile dal contesto sociale ed esperienziale199.
La terza direttrice dell’arte contemporanea, il terzo luogo di un’arte della cesura per cui lo “scarto è un’operazione” (Du-champ), dell’indifferenza genetica tra l’opera e lo spettatore, è incarnata dalla linea del “dentro”200. Gli artisti del “dentro” tra-sformano l’opera in non-arte e l’oggetto non-artistico in una presenza indecidibile, all’incrocio dei piani dell’effimero, della ripetizione, del disfunzionale e del residuale201. Indifferente alla misura dell’esperienza e alle proporzioni dello spazio umaniz-zato, l’arte del “dentro”, di cui la piega barocca descritta da De-leuze è un’occorrenza, risponde a un principio di proliferazione e inclusione per il quale “tutto ciò che è dato a vedere si trova al di dentro: cellula, sacrestia, cripta, chiesa, teatro, studio di lettu-
198 Le pratiche artistiche simulacrali assorbono lo spettatore secondo modalità diffe-
renti da quelle sperimentate dalla pittura anti-teatrale celebrata da Fried. Lo spettatore è incluso nel simulacro, che si trasforma e deforma con il variare del suo punto di vista, realizzando quella confusione del sé e dell’immagine, del dentro e del fuori, caratteristi-che delle fantasie consumistiche e delle immagini pubblicitarie, cfr. H. Foster, The Return of the Real, cit., p. 268.
199 H. Foster, The Return of the Real, cit., pp. 166-8. 200 Con questa espressione ci riferiamo a una declinazione decostruttiva dell’opera,
a un’arte della differenza che non rinuncia alla totalità dell’opera – abbandonata invece dalle pratiche parergonali e del “fuori” – ma che ne deforma e radicalizza le ambizioni.
201 Dal punto di vista storico-artistico, l’arte del “dentro” eredita, ribaltandone l’orientamento, la convergenza avanguardistica tra arte e vita: «Le avanguardie storiche hanno spesso voluto tessere legami tra l’arte e la vita […] Rauschenberg segue il cam-mino inverso: vuole introdurre la vita nell’arte, onde modificarne la fisionomia» (D. Riout, L’arte del ventesimo secolo. Protagonisti, temi, correnti, trad. it. di S. Arecco, Einaudi, Torino 2002, p. 168).
Capitolo III 188
ra o di stampa”202. È il trionfo «dell’autonomia dell’interno, un interno senza esterno»203.
Il Retable de l’abondance occidentale et du mercantilisme totalitaire, un’imponente scultura motorizzata dell’ultimo Tin-guely (fig. 1), campeggia come un totem nell’Espace Jean Tin-guely – Niki de Saint Phalle di Friburgo (Svizzera)204. Il motore del Retable, che avvia le rotazioni a velocità differenziate, i bat-titi e le vibrazioni della costruzione spaziale, è azionato dallo spettatore con un pulsante. Pur mantenendo la dimensione della performance automatica – ad ogni pressione del pulsante la macchina-scultura riprende il suo ciclo, il suo curioso e beffar-do spettacolo tautologico – il Retable ha abbandonato la ribel-lione anti-museale degli happening degli anni ‘60205, la poetica della macchina-suicida. La matrice dadaista di questo readyma-de cinetico è facilmente riconoscibile negli objects trouvés che ne costituiscono il corpo, nella titolatura ironica, nell’aspetto di perturbante giocattolone. E tuttavia l’invecchiamento dell’arte occidentale ci ha privato delle categorie utili a metabolizzare questa esperienza, il novum modernista e lo scandalo avanguar-dista non appartengono alla logica della “scultura” di Tin-guely206.
202 G. Deleuze, La piega, cit. , p. 46. 203 Ivi, p. 47. 204 Il Retable condivide le caratteristiche formali e iconografiche delle sculture della
serie Inferno, prodotte da Tinguely a partire dal 1984: il supporto è un palcoscenico rialzato, insegne luminose si accendono a intermittenza, dei vasi di fiori rotanti si ag-giungono agli elementi centrali, grande rilievo hanno i giocattoli e i teschi di animali, i movimenti sono estremamente vari.
205 Celebre è la performance realizzata nel 1960 presso il Museum of Modern Art di New York dalla scultura autodistruttiva Homage à New York, un’«opera effimera», «de-stinata a non essere recuperata dai musei» (J. Tinguely, Tinguely parla di Tinguely, in P. Hulten, Una magia più forte della morte: Jean Tinguely, Bompiani, Milano 1987, p. 350).
206 Dobbiamo a Clement Geenberg la denuncia del carattere irrimediabilmente “arty” delle macchine di Tinguely, estromesse dal campo della non-arte a causa dell’invecchiamento del capitalismo; cfr. C. Greenberg, Recentness of Sculpture, in Mi-nimal Art. A Critical Anthology, cit., p. 183.
Strumenti meravigliosi 189
Realizzazione parodica e perturbante di una Gesamtkun-stwerk207, il Retable di Tinguely risucchia lo spettatore e lo spa-zio espositivo nel suo meccanismo cigolante. Da un lato siamo sedotti dalla configurazione formale dell’opera, dall’interazione delle ruote e delle catene che trasmettono il movimento, dalla qualità del marchingegno. Dall’altro è l’interesse per la presen-za di un oggetto comicamente e provocatoriamente inutile a trattenerci. Un interesse che non fuoriesce definitivamente dall’opera: il Retable aggiunge al movimento meccanico un movimento idiomotorio, inducendoci ad allontanarci per co-glierne l’instabile struttura compositiva (una piramide, centrata sulla grande ruota centrale) e ad avvicinarci per decifrarne l’iconografia (il buffo assemblage degli oggetti riciclati) 208.
La discrezione dell’arte autonoma, la sua decorosa accetta-zione della camera estetica di fruizione predisposta dalle tecni-che museali di esposizione, dal white cube della galleria moder-nista - lo spazio neutro e deconstestualizzante del piacere esteti-co - sono contraddette dal frastuono e dall’ingombrante pienez-za del Retable, dall’esplicita connotazione politica di questa al-legoria dell’“assurdità totale”, dell’“aspetto folle, autodistrutti-vo, ripetitivo” del lavoro nell’economia capitalistica209. Lo spet-tatore è coinvolto e disturbato, distratto dal cigolio delle puleg-ge e confuso dal disordine della macchina. Fino all’arrivo del suo spettatore, che il Retable interpella a livello senso-motorio, inducendolo ad azionare la scultura per scongiurare la sua morta
207 L’influenza di Kurt Schwitters, le cui opere d’arte totali Tinguely conobbe sin dai primi anni ‘40, nel corso del suo apprendistato artistico a Basilea, è decisiva. Come il Merzbau, le “sculture” di Tinguely sono composte di materiali riciclati, indifferenti al confine tra opera e contesto; esse avvolgono lo spettatore e sono spesso destinate alla distruzione.
208 Jonathan Crary ha mostrato, in chiave foucaultiana, l’imbricazione di occhio e corpo che sorregge le attuali tecnologie di visualizzazione e il paradigma purovisibilista: «La preistoria dello spettacolo e la ‘pura percezione’ modernista sono collocate nel ter-ritorio appena scoperto di un osservatore interamente incarnato […] Il corpo, a lungo un elemento neutrale o invisibile della visione, diventò allora lo spessore da cui ricavare la conoscenza dell’osservatore» (J. Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, MIT Press, Cambridge, Mass. 1992, pp. 136 e 150. Trad. it. mia).
209 J. Tinguely, Parola d’artista, in P. Hulten, Una magia più forte della morte, op. cit., p. 350.
Capitolo III 190
apparenza allegorica, il Retable resta un bricolage di rifiuti e neon spenti, un funereo collage tridimensionale. È l’azione del pubblico, supplemento dell’artista, ad animare l’oggetto, a libe-rarlo nella sua vita meccanica di opera. Ma il gesto che inaugura l’allegoria della ricezione – vincolata in tutto, tranne che nella decisione motoria, al progetto meccanico dell’artista – e pone lo spettatore al centro della scena, lo depriva al contempo del con-trollo percettivo, impedisce il rovesciamento dell’esperienza dell’opera in una situazione che appartiene esclusivamente all’osservatore.
Il risultato di questo gesto, la vita non artistica dell’opera, il suo dispendioso e inutilizzabile lavorio meccanico, è il frastuo-no che decostruisce la capacità di raccoglimento contemplativo. Il Retable divora senza contropartita formale la neutralità dello spazio espositivo e la partecipazione del pubblico. L’animazione della forma, la sublimazione della ricezione in un’esperienza istantanea che permetta all’opera di manifestarsi pienamente in ogni momento, la realizzazione della “finzione suprema” dell’assenza dello spettatore, lasciano posto a una tea-tralità meccanica, a un frastuono totalizzante che contesta la sa-cralità museale, gli ordinati riti di fruizione individuale di opere silenziose. Abbandonata la “rivolta manifesta” nei confronti dei musei e il coinvolgimento esplicito dello spettatore – le “scultu-re di esperienza” progettate per venire attraversate dal pubblico, le “macchine disegnatrici” che permettono al fruitore di produr-re automaticamente dipinti astratti210 – il Retable guadagna alle forze del “dentro” l’abbattimento della distinzione tra opera, museo e spettatore. Poiché Tinguely rivendica la mancanza di distanza estetica delle sue macchine inutili nei confronti della contesto sociale e tecnologico – «io sento di fare validamente parte di questa società»211 – la sua arte guadagna uno scarto con
210 «Una macchina per disegnare doveva essere bella, comica, il bambino che con
essa giocava non doveva porsi il problema di toccare un’opera d’arte, e il risultato do-veva essere pertinente, concreto, utilizzabile» (J. Tinguely, Parola d’artista, in P. Hul-ten, Una magia più forte della morte, cit., p. 348).
211 Ivi, p. 350.
Strumenti meravigliosi 191
il presentarsi come un “commento sporco, satirico”212, introdu-cendo «un margine con spazio attorno» tra i titoli umoristici e ingannevoli delle macchine e le macchine stesse.
Le macchine assurde di Tinguely mancano di proporzione: possono avere dimensioni estremamente ridotte o crescere a di-smisura, fino ad occupare spazi industriali. Esse non rispondono alla logica estetica della scala, non sono né oggetti né monu-menti213, non si rapportano all’uomo e alle sue facoltà percetti-ve come all’unità di misura, ma obbediscono a un principio in-terno di proliferazione. L’identità dell’opera e del mondo, del quale conosciamo la varietà dimensionale, si ripercuote senza mediazione sulla loro grandezza. A differenza dei meccanismi utili, che per quanto giganteschi possiedono sempre una misura connessa alla loro intima relazione con uno scopo, a causa della loro mancanza di funzione le macchine di Tinguely proliferano a dismisura, come un tumore. Costruite sulla base di un princi-pio di non sviluppo e improduttività – uno scarto che appartiene all’essenza della tecnologia e che l’arte del “dentro” approfon-disce – le sculture cinetiche di Tinguely crescono e si rimpiccioliscono, nascono e muoiono organicamente, libere dai vincoli di un principio utilitaristico di realtà.
La regolata demarcazione del museo e dell’opera non pertie-ne alla proliferazione come legge di produzione artistica. L’arte del “dentro” disdegna le barriere estetiche ed istituzionali che separano le condizioni espositive dalle premesse produttive e dalle abitudini ricettive. Con Le Cyclop (noto anche come la Tê-te) – la scultura-museo alta 22,5 metri, a cui Tinguely ha lavora-to nella foresta dell’Ile-de-France, in collaborazione con Niki de Saint Phalle e Sepp Imhof, a partire dal 1969 (fig. 2) – l’assorbimento dello spazio (Le Cyclop ha inglobato anche una grande quercia) e dello spettatore operato dal Retable sfocia in un’impresa colossale, che ingoia la riconoscibilità della funzio-ne museale in una vorace opera totale. Le Cyclop è una gigante-
212 Ibidem. 213 Cfr. R. Morris, Notes on Sculpture, in Minimal Art. A Critical Anthology, op.
cit., p. 230 e ss.
Capitolo III 192
sca struttura labirintica che ricorda la testa di un Ciclope, per-corsa da uno sferragliante sistema di posta pneumatica a simula-re l’attività del pensiero, un’architettura grottesca che racchiude uno scivolo per bambini (la lingua del Ciclope), terrazze, balco-ni, scale, un appartamento domestico, un teatro e numerose aree espositive in cui sono installate opere di numerosi artisti, tra le quali un gigantesco biliardino di Luginbühl, la chambre-de-bonne di Daniel Spoerri, una piscina dedicata a Yves Klein e un ambiente progettato da Larry Rivers.
Torniamo al Retable. Quando la macchina si spegne, lo spet-tatore è restituito al desiderio di vedere e toccare, la realtà dell’opera ricade in un’esistenza materiale degradata: «tutto tornava all’immondezzaio»214. Ma poiché la rotazione della macchina è integrata da una ricezione digitale (l’acceso/spento in cui si riduce l’intervento del pubblico), la temporalità ciclica del Retable s’impregna dello stimolo-riposta dello spettatore215. Le due ripetizioni, il movimento ciclico degli ingranaggi e l’accensione prodotta dal desiderio del soggetto, interferiscono creando la peculiare temporalità delle opere di Tinguely. Il pro-trarsi dell’interesse sprofonda nella coazione a ripetere di uno spettatore catturato dal fascino di una residua artisticità dell’opera e dalla sfida a cogliere la costruzione allegorica e la composizione di una forma in movimento216.
214 J. Tinguely, Tinguely parla di Tinguely, cit., p. 350 215 Rosalind Krauss ha indagato sistematicamente le conseguenze del battito e della
pulsazione (dai Rotorilievi di Duchamp alle sculture di Giacometti alla videoarte di Ja-mes Coleman) sulla stabilità delle opposizioni categoriali su cui si fonda il modernismo pittorico: spazialità-temporalità, vista-corpo, forma-contesto. La pulsazione, in quanto nucleo segreto della visione, è un elemento inconscio, figurale, che decostruisce l’opposizione tra spazio e tempo e la separazione dei sensi (cfr. R. Krauss, The Im/pulse to See, in Vision and Visuality, a cura di H. Foster, New York, New Press, 1999, e R. Krauss, Pulsazione, in Y.-A. Bois, R. Krauss, L’informe, cit., pp. 163-170).
216 L’analisi del piacere connesso alla pulsazione condotta da Rosalind Krauss sulla base della teoria della figura di Lyotard, è una chiave di lettura preziosa per accostarsi all’arte cinetica di Tinguely. Nel Retable questo piacere si dissocia in due movimenti: le rotazioni-battiti multiple dell’opera – al centro della scultura, un peluche è martellato incessantemente da un contenitore di plastica – e la coazione a ripetere dello spettatore. A quest’ultimo è assegnato il compito di incarnare con la sua decisione motoria «l’opposizione ritmica tra contatto e rottura» (R. Krauss, The Im/pulse to See, cit., p. 67), dissolvendo in tal modo l’illusione formale di una ripetizione senza interruzione ed
Strumenti meravigliosi 193
Ma poiché il Retable è un gioco e un trucco piuttosto che un enigma, la sua apprensione formale è stimolata soltanto per es-sere disattesa: la visione frontale richiesta dalla collocazione dell’opera, il palcoscenico-piedistallo, la piramide visiva e la stratificazione iconografica, una volta innescati dal fruitore e sottomessi alle molteplici rivoluzioni differenziali – ogni unità compositiva è un’unità mobile soggetta a movimenti specifici: ellittici, circolari, lenti, rapidi, sussultori, percussivi, vibratori –, si dissolvono nel sublime industriale di un inquietante sferra-gliare, in un’immagine impura e instabile. La forma non è com-plessa quanto indeterminata, e il piacere negativo che associa-mo istintivamente al Retable è intensificato dalla frustrazione dell’assorbimento ottico, dal timore di venire stritolati dagli in-granaggi217.
Né oggetto pittorico né scultura, né forma unitaria né stimo-lo ambientale, il Retable organizza la cesura tra i due vettori privilegiati della modernità artistica, l’occhio e il corpo. Alle-stendosi teatralmente su un palcoscenico e al contempo ritiran-dosi in un’allegoria metafisica, interpellando lo spettatore e poi irretendolo in una barocca allegoria della vanitas, decostruendo con blasfema irrisione l’idealità del contesto espositivo e of-frendosi come opera totale, inscenando il vuoto di una mobilità insensata e il pieno di una retorica macabra, Tinguely dichiara non pertinente l’opposizione tra l’occhio e il corpo, sospende la rilevanza dell’alternativa tra la specificità modernista del me- esponendo la matrice inconscia di un piacere frammisto all’angoscia dell’interruzione. La forma temporale del Retable è una semi-pulsazione triadica, uno schema di accen-sioni-rotazioni-spegnimenti, di battiti e trasmissioni asimmetrici che trasportano il senso dell’opera nella cesura tra la temporalità libidinale dello spettatore e la temporalità mec-canica dell’opera.
217 La difficile coabitazione tra il piano formale (“estetico”) e quello meccanico (“costruttivo”) delle macchine rappresenta il nucleo generativo, il “conflitto”, lo specifi-co problema artistico di cui le opere di Tinguely sono una soluzione: «La struttura delle mie macchine deve avere aspetti materiali ben precisi per permetterne la costruzione ve-ra e propria. Ma quando questi aspetti sono soddisfatti sul piano costruttivo e su quello del movimento (vale a dire allorché il movimento ottenuto è accettabile), può accadere che il risvolto estetico, l’aspetto formale, non mi piaccia. E allora, eccomi alle prese con un problema, con un conflitto. E in questo caso disegno, soltanto allora, per scoprire un nesso tra la forma, il suo aspetto e il movimento da produrre» (J. Tinguely, Parola d’artista, in P. Hulten, Una magia più forte della morte, op. cit., p. 347).
Capitolo III 194
dium e la politicizzazione avanguardista della ricezione, tra l’autosufficienza estetica dell’opera e la contestualità sociale della ricezione.
Come dimostra l’inadeguatezza della sua riproduzione foto-grafica, che difetta innanzitutto della quarta dimensione dell’opera, il movimento, il Retable non si presta all’egemonica museificazione dispiegata dal “museo immaginario”, all’inserimento differenziale in un archivio universale della qua-lità estetica, dell’arte del mutamento temporale. In quanto opera totale e macchina – benché macchina inutile e opera non artisti-ca – il Retable declina le forze del “dentro” dispegate dalla ce-sura218.
L’indifferenza di occhio e corpo appartiene a un’immagine la cui natura è consustanziale al movimento, ricorrente e mec-canico, della scultura. Il Retable è un’opera-macchina in quanto opera-movimento. In che cosa consiste questo movimento? In che senso la sua insensatezza e ripetitività appartengono a un corpo, a una macchina e a una totalità? Il tutto è l’opera; nono-stante la degradazione ironica della sua artisticità (i contenuti sono trovati, il moto è tautologico), la poetica di Tinguely si mantiene nel quadrante del “dentro”. Quanto all’opera, essa consiste nella totalità del movimento delle sue parti, nell’insieme progettato della macchina, nel corpo di parti as-semblate, animato dai macro-movimenti della ricorrenza circo-lare della scultura e dell’attivazione-disattivazione da parte del-lo spettatore. La preminenza della totalità del corpo-macchina sul vocabolario elementare dei movimenti impedisce alla visua-lità richiesta dal Retable di ricadere nella dicotomia di gesto e forma.
Il movimento, o meglio la complessa rete di moti che altera-no la struttura, contorcendola inutilmente, è dunque una “sezio-
218 Poco opportuno è l’imprigionamento dell’arte cinetica in un genere specifico,
nella “totalità del vocabolario dei movimenti” costituito da intervalli e vibrazioni, rota-zioni e oscillazioni; un’interpretazione formalistica del rapporto tra movimento e imma-gine proposta ad esempio da G.W. Rickey (The Morphology of Movement: A Study of Kinetic Art, «Art Journal», vol. 22, n 4, 1963).
Strumenti meravigliosi 195
ne in movimento” della totalità della macchina219, la radiografia cinetica del corpo dell’opera. Il Retable è anti-arte e al contem-po Gesamtkunstwerk, un’anti-macchina come totalità che muta ad ogni rivoluzione, un’opera che si trasforma qualitativamente grazie al movimento, sul modello degli oggetti cinetici di Du-champ, generatori di illusioni percettive e cambi dimensionali: i Rotorilievi, dischi grammofonici ai quali il movimento conferi-sce un illusorio aspetto tridimensionale, e le Lastre di vetro ro-tanti, una sorta di elica alla quale un motore dona l’apparenza di una superficie piana.
L’immagine del Retable, la specifica visualità preclusa alla riproduzione fotografica, consiste nella totalità in trasformazio-ne di un movimento le cui sezioni mobili corrispondono alle due funzioni dinamiche del corpo-macchina: la pulsazione or-ganica del desiderio dello spettatore e la rotazione dell’opera. Il Retable non aggiunge la coordinata del tempo alle tre dimen-sioni della scultura, ma produce un’indifferenza spazio-temporale, dal momento che entrambe le forme a priori della sensibilità sono secondarie rispetto all’immagine-movimento, alla fisiologia della ricezione (la sua pulsazione organica) e all’ontologia dell’opera (la rotazione qualitativa)220.
219 L’arte di Duchamp e Tinguely presuppone l’innovazione estetico-tecnologica in-
trodotta dal cinema: il superamento della distinzione tra l’immagine e il movimento (cfr. G. Deleuze, L’immagine-movimento, cit., p. 74). Il movimento contiene due aspetti: da un lato esso è una “sezione immobile”, quanto accade tra oggetti e parti, dall’altro è una “sezione mobile”, il cambiamento qualitativo di un tutto (della durata per Bergson-Deleuze, dell’opera per Duchamp-Tinguely): «Possiamo considerare gli oggetti o le par-ti di un insieme come sezioni immobili; ma il movimento si stabilisce tra queste sezioni, riporta gli oggetti e le parti alla durata di un tutto che cambia, esprime dunque il cam-biamento del tutto dei confronti degli oggetti, è esso stesso una sezione mobile della du-rata» (G. Deleuze, L’immagine-movimento, cit., p. 24).
220 A proposito del cinema di Buster Keaton, Deleuze cita le macchine di Tinguely e di Picabia. Le “gag-macchina” caratteristiche del burlesque di Keaton rispondono se-condo Deleuze alla finalità segreta della riconciliazione tra la situazione e l’eroe, tra la smisuratezza della tecnologia e la piccolezza dell’uomo. Grazie a macchine a “funzione minorante” – che convertono imprevedibilmente al piccolo, alle competenze di un eroe solitario, le grandi macchine (case smontabili, treni, pirosocafi) – o macchine a “funzio-ne ricorrente” – che come le sculture di Tinguely rendono funzionali al movimento ele-menti in sé privi di significato – la gag-macchina risolve la separazione tra l’eroe e l’ambiente. Inversamente a quanto accade nel cinema di Keaton, che colma mediante le gag-macchina “il grande scarto” tra la situazione immensa e l’eroe minuscolo, le mac-
Capitolo III 196
L’arte di Jean Tinguely è basata sul principio della ruota, il cui movi-mento rotatorio è un’eterna ripetizione. Alla ruota corrisponde un e-terno rinnovamento non appena essa tocca un supporto: una ruota in movimento non ripete uno stesso percorso. Ripetizione e cambiamen-to sono quindi gli elementi fondamentali dell’arte di Tinguely221.
Ripetizione e cambiamento, e dunque il caos dotato di “una
certa armonia” ricercato da Tinguely, si servono del movimento come linguaggio per esprimere il mutamento del mondo-macchina. Il Retable non rappresenta ma produce un campo di differenze, attivando la cesura del “dentro” grazie all’impossibile integrazione del livello meccanico e di quello estetico, del movimento imposto e di quello discontinuo della pulsazione:
L’arte non imita perché anzitutto ripete … Persino la ripetizione più meccanica, più quotidiana, più abituale, più stereotipata, essendo sem-pre spostata in rapporto ad altre ripetizioni, trova posto nell’opera d’arte, a condizioni che si sappia ricavarne una differenza per queste altre ripetizioni222. L’allestimento teatrale, su un palco rialzato, delle ultime
macchine di Tinguely accentua riflessivamente la teatralizza-zione223, mette in scena la ripetizione come differenza e molti-plica la differenza in una pluralità incomponibile di sezioni di movimenti eterogenei che modificano la macchina e la distan-ziano dallo spettatore, a sua volta un oggetto trovato dell’opera. L’arte del “dentro” dispiega le differenze intensificando le ripe-
chine di Tinguely producono lo scarto, nel dentro dell’opera, tra la ricezione e il senso; cfr. G. Deleuze, L’immagine-movimento, cit., p. 203.
221 P. Hulten, Libertà sostitutiva, o sul movimento nell’arte e la méta-mécanique di Tinguely, in P. Hulten, Una magia più forte della morte, op. cit., p. 34.
222 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., p. 375. 223 L’arte di Tinguely è méta-mécanique, una ripetizione differenziante, per il trami-
te del movimento, di motivi trovati nel repertorio della storia dell’arte, come i rifiuti che costituiscono l’ossatura delle sue meta-meccaniche: «Sono partito da elementi costrutti-visti del vocabolario di Malevic, pittore suprematista russo, da Kandinskij, da Arp e da qualche altro artista: ho riutilizzato i loro elementi e li ho messi in movimento per giun-gere a una ri-creazione» (J. Tinguely, Parola d’artista, cit., p. 350).
Strumenti meravigliosi 197
tizioni: il suo inclusivo principio di proliferazione comprende anche la ripetizione ironica (intima concentrazione del “den-tro”) della coazione a ripetere del trauma. Il punctum del Reta-ble –la testa del peluche battuta da un contenitore di plastica in cui si ritrae la residua referenzialità della scultura, alludendo al-la possibilità di sfuggire alle operazioni del “dentro”, di signifi-care con trasparenza la violenza repressiva della civiltà occiden-tale – è ridotto a un’allegoria automatica dal commento moto-rizzato della macchina. Non esiste alcuna esperienza originaria: ad ogni rotazione delle pulegge e pressione del pulsante da parte dello spettatore, l’inconscio infantile delle macchine è percosso dalle sue leve, dagli scarti del suo consumo224.
224 Un altro esempio di arte (decostruttiva) del “dentro” è rappresentato dalla poeti-
ca della polvere di Claudio Parmiggiani. La polvere è il risvolto materiale della cesura, un luogo dell’arte irriducibile alla percezione spaziale esplorata dal minimalismo e all’immaginario sociale della pop art, una “materia della distanza” che disinnesca l’opposizione di tecnica e caso, di spazialità e temporalità, di presenza e assenza dell’opera. La polvere è il residuo che mostra, ciò che presenta senza rappresentare, un assorbimento spettrale della presenza, un’immagine come sopravvivenza in cui la pittu-ra implode, un «luogo paradossale: un luogo per mettere alla prova nello stesso tempo il contatto e la distanza» (G. Didi-Huberman, Génie du Non-Lieu. Air, Poussière, Em-preinte, Hantise, Les Éditions du Minuit, Paris 2001, p. 146).
Capitolo III 198
fig. 1 J. Tinguely, Retable de l’abondance occidentale et du mercantilisme to-talitaire, 1989-1990 (Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle, Friburgo).
fig. 2 J. Tinguely, Le Cyclop (la Tête), 1969-1994 (Milly-la-Forêt, Parigi).
Il posto delle parole 1. Fine della critica
Oggi, tutte le cose vogliono manife-starsi. J. Baudrillard, Illusione, disillusione estetiche
Mentre la legittimità accademica dei cultural studies non ne-cessita di particolari giustificazioni, dal momento che sotto que-sta etichetta hanno trovato asilo nel corso degli ultimi decenni orientamenti disciplinari sacrificati alla rigida separazione acca-demica dei saperi, la sensatezza della loro missione teorica di-pende da un presupposto lucidamente enunciato quasi vent’anni or sono da Fredric Jameson:
la dissoluzione della cultura va immaginata in termini di esplosione: un’espansione prodigiosa della cultura nell’intero ambito sociale, al punto che tutto nella nostra vita sociale – dal valore economico e dal potere statale alle pratiche sociali e alla stessa struttura della psiche – si può dire che sia diventato “culturale” in un senso originale e finora mai teorizzato1.
1 F. Jameson, Il Postmoderno, o la logica culturale del tardo capitalismo, trad. it. di
S. Velotti, Garzanti, Milano 1989, pp. 90-91.
199
Capitolo IV 200
È al “divenire culturale mai teorizzato” a cui si rivolgono i cultural studies, imbattendosi innanzitutto nella difficoltà di in-dagare un oggetto di cui non si possiede una definizione pre-ventiva, e la cui stessa esistenza pare mettere a repentaglio la distinzione tra l’atto interpretativo e la cultura a cui esso si ri-volge. Jameson associa correttamente i due fenomeni, il diveni-re culturale del piano economico e tecnologico e ciò che egli definisce «l’abolizione della distanza critica»2. Si potrebbe anzi affermare che la rilevanza delle sue posizioni, o meglio la sua consistenza filosofica all’interno del panorama spesso ingenuo dei cultural studies, discenda proprio dall’aver eletto questi pre-supposti a ciò che il teorico della cultura deve pensare. Ma cosa intende Jameson per “abolizione della distanza critica”, per cancellazione della “distanza estetica” ed “eteronomia della cri-tica”?
In un senso ristretto, questa espressione segnala la crisi della politica culturale, il senso di impotenza che accompagna il trionfo della “condizione postmoderna”: «Nessuna politica di politica culturale oggi presente nella sinistra è stata in grado di fare a meno della nozione di una sia pur minima distanza esteti-ca, della possibilità di porre l’atto culturale fuori dell’Essere massiccio del capitale»3.
Ma Jameson è interessato soprattutto, e veniamo al secondo ordine di fenomeni associati all’abolizione della distanza critica, alle ripercussioni teoriche e formali della ridefinizione della dominante culturale. A suo avviso il potenziale estetico dell’arte modernista e il potenziale critico della razionalità filosofica si reggevano su enclaves precapitalistiche sopravissute allo svi-luppo economico. Erano l’inconscio e la natura, la sensibilità storica e la proiezione utopica nelle opere d’arte di una sogget-tività non alienata, a sostenere il pathos conoscitivo e l’efficacia emancipativa della cultura borghese. Essa riponeva tanta enfasi sulla dimensione estetica – ad esempio discorrendo del valore ontologico dell’opera d’arte – perché conservava la fiducia di
2 Ivi, p. 86. 3 Ivi, p. 91.
Il posto delle parole 201
potersi ergere, grazie a un “punto archimedico” come dice Ja-meson sulla scorta di Adorno, al di sopra delle determinazioni sociali e tecnologiche.
Il panorama attuale, che Jameson definisce sul piano econo-mico “tardo capitalismo” e su quello artistico “postmoderni-smo”, è segnato invece da una redistribuzione delle forme di ra-zionalità:
Lo spazio medesimo della cultura si è ampliato, finendo con il coinci-dere a tal punto con la società di mercato che il culturale non resta ormai più confinato nelle sue forme precedenti, tradizionali o speri-mentali, ma viene consumato nel corso della stessa vita quotidiana […] Lo spazio chiuso dell’estetico è perciò a sua propria volta spalan-cato al suo contesto di qui in poi pienamente culturalizzato […] Per-ciò, da un punto di vista strettamente filosofico, questa fine della mo-dernità deve anche implicare la fine dell’estetico, o in generale dell’estetica: dato che dove quest’ultima imbeve ogni cosa, dove lo spazio della cultura si espande sino al punto in cui tutto diventa in un modo o nell’altro acculturato, la tradizionalità distinguibilità o “speci-ficità” dell’estetico (e anche della cultura in quanto tale) andrà neces-sariemente sfumata o del tutto persa4.
Il retroterra filosofico di questa tesi risiede palesemente nelle
tesi introduttive della Condition postmoderne di Lyotard, che Jameson assimila senza distinguo, pur accantonando l’intero ri-corso al tema della legittimazione, ai giochi linguistici e in ge-nerale allo statuto della conoscenza scientifica. Il “sapere” con-vogliato dai nuovi dispositivi della comunicazione è divenuto per Lyotard “la principale forza produttiva”5, con il risultato della sua «radicale esteriorizzazione rispetto al “sapiente”»: «questa trasformazione generale non lascia intatta la natura del sapere»6. A causa dell’incidenza del trattamento tecnologico dell’informazione e della moltiplicazione (“esplosione” scrive
4 F. Jameson, The Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern 1983-1998,
Verso, London 1998, p. 111. 5 J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna, trad. it. di C. Formenti, Feltrinelli, Mi-
lano 1985, p. 13. 6 Ivi, p. 11.
Capitolo IV 202
Lyotard) dei linguaggi scientifici settoriali7, il sapere speculati-vo smarrisce la capacità di autolegittimarsi e si avvita nella spi-rale del nichilismo: «La speculazione si nutre della sua soppres-sione»8. Basta sostituire la nozione di metanarrazione con quel-la di distanza critico-estetica, e la tesi jamesoniana sulla “aboli-zione della distanza critica” si mostra come una trasposizione letterale, sul piano della teoria della cultura, della diagnosi di Lyotard: «Semplificando al massimo, possiamo considerare “postmoderna” l’incredulità nei confronti delle metanarrazio-ni»9.
Jameson scorge nell’avvento di questo sapere esteriorizzato un mutamento epocale della nozione di cultura, che si lascia alle spalle l’antica distinzione tra cultura in senso estetico – come contenuto di verità anticipato dall’esperienza estetica, come “assoluto e astrattezza”, come idea e come ideale (R. Williams) – e cultura in senso antropologico – quale ambito specifico del-la vita sociale, «regno della protezione e dell’adattamento»10, sistema vissuto di significati e valori. Benché gli obiettivi po-lemici non siano più l’idealismo reazionario della critica della cultura e il marxismo volgare stigmatizzati da Raymond Wil-liams, Jameson rimette in scena l’atto fondativo dell’attuale teo-ria della cultura, opponendosi ai ritorni di forme mascherate di estetica filosofica e al determinismo sociologico di molte va-rianti identitarie o tecnologistiche dei cultural studies. In Jame-son – discepolo eclettico della teoria critica, dello strutturalismo greimasiano, del culturalismo anglosassone, dell’esistenzialismo sartriano e delle teorie ermeneutiche della narratività – il «pensare in avanti, oltre i migliori elementi ela-borati delle imprese strutturaliste e culturaliste»11 significa
7 «Attraverso l'egemonia dell'informatica, si impone una certa logica, cioè un in-
sieme di prescrizioni fondate su enunciati accettati come enunciati "del sapere"» (J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna, cit., p. 12).
8 Ivi: 70. 9 Ivi, p. 6. 10 F. Jameson, Tardo marxismo. Adorno, il postmoderno e la dialettica, trad. it. di
P. Russo, Manifestolibri, Roma 1994, p. 118. 11 S. Hall, Cultural studies: Two Paradigms, in J. Storey (a cura di), What is cul-
tural studies? A Reader, Arold, London 1998, p. 48.
Il posto delle parole 203
combattere le componenti idealistiche e riduzionistiche della critica della cultura.
L’ideale estetico di cultura, erede della religione romantica dell’arte e custode del valore assiologico dell’Opera, implica secondo Jameson il ricorso a un “punto archimedico” su cui far leva per incrinare la falsa totalità dell’esistente. Esso è rappre-sentato in genere dall’appello al non-contemporaneo, al poten-ziale emancipativo dell’arte modernista, all’autonomia (o “se-mi-autonomia”, per quanto precaria e colpevole) della sfera e-stetica dalle tecniche e categorie della cultura di massa. Di con-tro, l’antropologia si volge alla cultura come a uno degli ambiti della riproduzione sociale, i cui valori sono socializzati a priori in funzione della costruzione o del mantenimento di identità, o meglio nelle varianti meno deterministiche di processi di identi-ficazione. Entrambe le concezioni divengono però obsolete nel momento in cui, per usare la terminologia dell’antropologo Ja-mes Clifford, va in crisi il “sistema arte-cultura”, la complementarità di una sfera dell’estetico avulsa dalle costrizioni materiali e dedita «all’esercizio di una soggettività non alienata»12, e di una dimensione pratico-sociale preposta alla formazione delle identità collettive e al mantenimento della tra
dizione. Dalla «repugnanza di fronte al valore incarnato», dalla “reli-gione dell’opera” che indicava in ogni bellezza formale il segno di una “incarnazione riuscita”13 non si sfugge ormai più facendo appello alla “cultura come un tutto”14. La complicità denunciata da Adorno tra i due aspetti costitutivi della moderna cultura oc-cidentale, il divenire “cultura di se stessa” della cultura e la «degenerazione a mera ideologia di ciò che è approdato al con-sumo», s’infrange di fronte allo svuotamento della “pura cultu-ra” e alla trasformazione della manipolazione massmediatica della comunicazione in «perfezione tecnologica della cultura di
12 F. Jameson, Tardo marxismo. Adorno, il postmoderno e la dialettica, cit., p. 119. 13 R. Klein, L'eclissi dell'«opera d'arte», in La forma e l'intelligibile. Scritti sul Ri-
nascimento e l'arte moderna, trad. it. di R. Federici, Einaudi, Torino 1975, p. 445. 14 T.W. Adorno, Critica della cultura e società, in Prismi. Saggi sulla critica della
cultura, trad. it. di C. Mainoldi, Einaudi, Torino 1972, p. 15.
Capitolo IV 204
massa»15. L’affievolirsi della relazione oppositiva di arte e so-cietà, testimoniata dall’ormai completa integrazione dell’arte contemporanea nell’economia dei beni culturali e dall’estinzione di qualsiasi credibile forma di politicizzazione della dimensione estetica, incrina i modelli dialettici di spiega-zione.
Mentre la dialettica negativa adorniana conservava ancora l’illusione di potersi adeguare alla natura dell’arte moderna, al-meno sino alla sua fase tardo-modernista (Schonberg e Be-ckett), negli ultimi decenni nessuna teoria della cultura, per quanto raffinata, ha ritenuto profiquo far cozzare il presunto “valore di verità” delle opere e la (falsa) totalità sociale. I resi-dui contenuti utopici dell’arte moderna si scontrano infatti con l’implosione anti-estetica dell’oggetto artistico, con il suo tra-mutarsi in un’arte altamente ironica e demitizzata, quando non in forme teconologicamente avanzate di intrattenimento (ciò che Jameson chiama il “sublime isterico” dell’arte postmoder-na). Da quando l’acculturamento delle società occidentali ha in-crinato l’equilibrio tra gli ideali culturali e le pratiche sociali, l’industria culturale ha smesso di proporsi come industria e le sue merci si sono tramutate in “a whole way of life” (R. Wil-liams), in una nuovo sistema di consumo estetico condiviso da artisti, critici e pubblico.
Siamo di fronte a un processo che caratterizza tutte le arti occidentali, e le cui ripercussioni incrinano persino la legittimità epistemologica delle discipline critiche . Un esempio significa-tivo, come suggerisce Hans Belting, è rappresentato dall’attuale crisi d’identità della storia dell’arte, spiazzata dal declino dei paradigmi storicistici e della scomparsa dell’oeuvre, suo ogget-to privilegiato. Se non cediamo alla tentazione della lametazio-ne e della nostalgia per la scomparsa della “grande arte” del passato modernista, e invece constatiamo impassibilmente la trasformazione dell’arte d’avanguardia in una pletora di tecno-logie visive del passatempo (nel senso regressivo assegnatogli da Baudrillard), siamo in grado di riconoscere nella sovrapposi-
15 F. Jameson, Tardo marxismo. Adorno, il postmoderno e la dialettica, cit., p. 160.
Il posto delle parole 205
zione di arte e intrattenimento il profilo di una nuova arte pub-blica, segnata dall’esaurimento dell’originalità e della genialità individuale: «Le immagini circolano sotto forma di repliche e di citazioni. La loro provenienza è universale, il loro uso incontrollabile. L’inflazione ne rivela la perdita di efficacia, e il loro illimitato consumo insidia le stesse nozioni di realtà»16. Una nuova arte del grazioso e del decorativo, dell’anticulturale, del banale o del casuale, sorta dalla confluenza di avanguardia e cultura di massa e socializzata per la definitiva assimilazione al consumo. Ma soprattutto, e veniamo qui all’intreccio di accultu-ramento dell’economico e crisi della distanza estetica, la tra-sformazione dell’opera d’arte visiva in comunicazione di massa autoriflessiva sottrae al critico la posizione di esternalità, e con essa i vantaggi della distanza, la “frontalità” al cospetto della “chiara obiettività” dell’opera:
L’idea di una divisione di compiti tra arte, da un lato, e la critica come discorso sull’arte, dall’altro, entra in crisi allorquando l’arte recente si costituisce come una sorta di “testo”, un discorso sull’arte per proprio conto […] Così la stessa opera diventa equivalente a un atto di “inter-pretazione” o, al contrario, diventa testimonianza della perdita di un punto di vista unitario17. Si badi tuttavia a non confondere questa peculiare redistri-
buzione delle funzioni di arte e critica con la tradizionale filoso-fia dell’“ascolto” dell’opera. Al parassitismo del critico in rap-porto al suo oggetto non viene promessa alcuna epifania: l’autoriflessiva arte del presente non aspira ad uno statuto “on-tologico”, non ammicca alla preganza simbolica della cultura. Piuttosto, lo studioso è irretito dal suo oggetto, «divenuto un in-definibile, strano “attrattore” non è più un oggetto estetico»18. Il rovesciamento del rapporto tra soggetto e oggetto, in cui Bau-drillard scorge il riemergere di una “scena primitiva
16 H. Belting, La fine della storia dell'arte o la libertà dell'arte, trad. it. di F. Poma-
rici, Einaudi, Torino 1990, p. 46. 17 Ivi, p. 53. 18 J. Baudrillard, Illusione, disillusione estetiche, trad. it. di L. Guarino, Pagine
d'Arte, Milano 1999, p. 30.
Capitolo IV 206
dell’illusione”, di una nuova «immediatezza delle forme ante-cedenti o seguenti l’estetizzazione generale della nostra cultu-ra»19, avviene in realtà sotto il segno di immagini artificiali i-perculturalizzate, vale a dire funzionali e sovradeterminate nell’interesse sistemico della comunicazione20.
Comprendiamo perché la disillusione estetica della cultura tardo-borghese poco si presti alla conservazione nostalgica di un regno dei valori incarnati, all’interrogazione rabdomantica delle apparenze e delle forme pure. La capillare espansione del godimento estetico spodesta l’intellettuale critico, sconfessando al contempo il culto dell’autenticità e l’attesa pensierosa di cen-ni di autenticità. Facendo ricorso a questa seconda accezione dell’abolizione della distanza critica, dovremo allora inquadrare la confluenza di cultural studies ed estetica nel più ampio fe-nomeno della ridefinizione del culturale e dell’estetico, o me-glio dei due significati di cultura tenuti disperatamente distinti dalla terminologia filosofica.
Ma veniamo ora, lasciandoci alle spalle il riferimento alle te-si jamesoniane, al lutto estetico della nostra tarda modernità, al terzo decisivo livello interpretativo. Esso presuppone quanto detto sinora, e al contempo annuncia le ripercussioni filosofiche più dirompenti innescate dall’acculturamento manipolativo del-la vita sociale. Il critico culturale è chiamato infatti a tagliare il cordone ombelicale che lega la descrizione della cultura con-temporanea alla nostalgia per distinzioni epistemologiche sor-passate. All’odierna teoria della cultura si presenta oggi un di-lemma ben più profondo dell’articolazione tra modernismo e cultura popolare, tra determinismo sociologico e estetica filoso-fica. Il compito ricorda piuttosto le antinomie del criticismo kantiano e in generale della coscienza illuministica, l’impasse di una razionalità esposta all’acuta consapevolezza dei propri limi-ti cognitivi. L’abolizione della distanza critica non rappresenta
19 Ivi, p. 31. 20 «Non è più il soggetto che si rappresenta il mondo (I will be your mirror!), è l'og-
getto che rifrange il soggetto e sottilmente, attraverso tutte le nostre tecnologie, gli im-pone la sua presenza e la sua forma aleatoria)» (J. Baudrillard, Illusione, disillusione e-stetiche, cit., p. 30).
Il posto delle parole 207
forse che una delle possibili ricadute della difficoltà teorica di predere partito nei confronti delle due tesi: “tutto è cultura, niente è cultura”.
Poiché ogni fenomeno sociale è ricoperto dalla patina della “culturalità” – dall’economia alla comunicazione visiva, dai rapporti interpersonali agli ideali politici – il teorico della cultu-ra è costretto a fare i conti con la dispersione del suo oggetto. Come ogni scienza che abbia smarrito il riferimento normativo a una sfera privilegiata di indagine, l’estetica tramutata in cultu-ral studies scorge in questa prodigiosa porosità dei propri con-fini disciplinari un’opportunità unica, un nuovo imperativo a o-rientarsi verso le “cose stesse”. Dopo circa mezzo secolo di ana-lisi teoriche e ricerche empiriche, i cultural studies sembrano poter intepretare l’indeterminatezza del loro oggetto come una traccia della loro perduta ingenuità epistemologica:
Il concetto [di cultura] resta complesso – un sito di interessi conver-genti, piuttosto che un’idea logicamente o concettualmente chiara […] Può essere utile, perciò, riassumere brevemente i caratteristici accenti e le enfatizzazioni attraverso le quali il concetto ha raggiunto il pre-sente stato di (in)-determinazione21. La debordante positività del contenuto da pensare sui model-
li esplicativi ereditati dalle singole discipline in cui sino a poco tempo si differenziava il campo culturale (estetica filosofica, storia dell’arte, critica letteraria, sociologia dei mezzi di comu-nicazione), obbliga l’interprete a decidere per ogni snodo della propria analisi se le categorie più indicate a rendere conto del fenomeno derivino dalle sfera economica o da quella estetica, dalla teoria dei generi o dalla sofistica pubblicitaria. A decidere, si badi bene, non essendo guidati che dalla cosa stessa, divenuta nel frattempo un noumeno falsificato (ma non un “oggetto pu-ro” che partecipa al rovesciamento dialettico dell’arte postmo-derna in un “ritualismo primario”), la cui apparenza estetica in-clude una gamma sempre più ampia di connotazioni sociali ed economiche. In una parola, l’indecidibilità della matrice cultu-
21 S. Hall, Cultural studies: Two Paradigms, cit., p. 33.
Capitolo IV 208
rale implica innanzitutto una confusione tra la conoscenza della cultura e la natura della cultura stessa. L’acculturamento del mondo della vita tardo-capitalistico presuppone una dislocazio-ne dei giochi linguistici tradizionali, che mette a repentaglio i principi regolativi delle ermeneutiche regionali, tra le quali dobbiamo inserire anche le estetiche filosofiche sistematiche.
Per comprendere appieno questa condizione, che obbliga la razionalità critica a una rischiosa esibizione senza rete di prote-zione, è sufficiente prendere atto dell’odierna impraticabilità della conciliazione dialettica di critica immanente e critica tra-scendente, la chiave di volta dell’approccio adorniano alla cul-tura. Ci soffermeremo brevemente sulla posizione di Adorno, un filosofo paradigmatico dell’ultima grande stagione di critica estetica della cultura, al fine di dissipare quella diffusa tentazio-ne che consiste nello stigmatizzare l’attuale teoria della cultura (per lo più di matrice anglo-americana) rintracciandovi una ri-presa “ingenua” dei sofisticati modelli filosofici continentali. Ingenua non è infatti, nell’attuale costellazione culturale, quella critica che si senta gettata senza principi tra le cose stesse di un consumo ipertrofico di immagini, bensì la convinzione adornia-na di poter raccordare secondo una teoria più o meno sistemati-ca la dimensione gnoseologico-filosofica della critica con la so-stanza “materiale” della cultura. Come vedremo, anche le me-diazioni dialettiche introdotte da Adorno tra la società, la cultu-ra e la filosofia, fanno ricorso a una netta distinzione tra il pen-siero e lo “spirito oggettivo”, eleggendo a presupposto ciò che per l’odierna teoria della cultura rappresenta invece il telos dell’interpretazione.
Ma veniamo a Adorno. Poiché nei confronti della cultura e-gli ha programmaticamente rifiutato di tenere separati i metodi di analisi interni ed esterni, la sua conciliazione di formalismo e determinismo può sembrare la più coerente risposta filosofica all’attuale condizione di eteronomia della distanza critica (una diagnosi avvalorata dalla sua profetica concezione dell’«approdare al consumo della cultura europea»): «Alla fine, lo stesso contrasto tra conoscenza che penetra dall’esterno e co-noscenza che procede dall’interno diviene sospetto agli occhi
Il posto delle parole 209
del metodo dialettico»22. E tuttavia, la possibilità di appianare il contrasto tra i due modi di conoscenza prescrive ai fenomeni “spirituali” (nella terminologia hegeliana di Adorno) di presen-tarsi con il marchio della “contraddizione oggettiva” tra i due movimenti di autonomizzazione e determinazione sociale. Una dinamica innescata secondo Adorno dalla reificazione in cui in-cappa lo stesso «ritrarsi in se stessa della cultura borghese» (che sfocia nella mitologia della purezza della cultura), dalla risposta dell’arte autonoma alla radicalizzazione del processo secondo cui la cultura è ciò che «riproduce se stessa secondo econo-mia»23. Nell’epoca del capitalismo «la cultura europea nella sua estensione» può considerarsi «degenerata a mera ideologia di ciò che è approdato al consumo e oggi viene prescritto alle po-polazioni da managers e psicotecnici»24. E nonostante ciò, nelle opere d’arte più radicali è viva «l’immagine di un’esistenza che addita al di là dalla costrizione che sta dietro al lavoro»25. Per quanto l’espansione della razionalità economica abbia messo a repentaglio la nozione stessa di cultura, «nessuna autentica ope-ra d’arte e nessuna vera filosofia si è mai esaurita in se stessa secondo il suo senso, secondo il suo essere in sé»26.
La contraddizione oggettiva riconosciuta sul piano dei fe-nomeni si ripercuote direttamente, grazie alla flessibilità e per-vasività garantita dal concetto di reificazione, sui due momenti della critica della cultura. Alla conoscenza che promana dall’interno e quella che sopraggiunge dall’esterno non è con-cesso di cristallizzarsi in metodologie indipendenti, dato che la loro stessa falsa opposizione ripropone nell’ambito del pensiero la dinamica della reificazione (un effetto della razionalizzazione e della differenziazione estetica): «all’astratta subordinazione da una parte, al pensiero per così dire amministrante, corrisponde dall’altra il feticismo dell’oggetto reso cieco rispetto alla sua
22 T.W. Adorno, Critica della cultura e società, cit, p. 20. 23 Ivi, p. 11. 24 Ivi, p. 8. 25 Ivi, p. 13. 26 Ivi, p. 8.
Capitolo IV 210
genesi, la prerogativa dello specialista»27. Di contro, «dialettica significa intransigenza di fronte ad ogni reificazione»28.
In cosa consistono propriamente le due dimensioni della cri-tica che il procedimento dialettico tenta di mediare? La proce-dura immanente, che scaturisce dall’interno dei fenomeni cultu-rali, fa leva sull’«inconciliabilità dei momenti costituenti» del suo oggetto per scardinare la falsa conciliazione di società e va-lori estetici. Essa intravede nella contraddizione tra l’«idea o-biettiva» e la «pretesa di coincidenza con la realtà», riposta in ogni configurazione spirituale, il marchio dell’ideologia, l’ingannevole pretesa di “corrispondere alla realtà”29. La critica immanente è in grado di denunciare la negatività della cultura senza appoggiarsi a criteri esterni, soltanto mostrando la «con-traddizione oggettiva» irrisolta, propria di ogni prodotto cultu-rale. Di essa Adorno nota la lucidità e al contempo l’incapacità di andare al di là dell’evidenza per cui «tutto lo spirito è para-lizzato da un sortilegio»30. Essa, come dice Adorno con laconi-ca precisione, è trascinata «nell’abisso dal suo oggetto». Quanto all’approccio trascendente, questo confida di poter “aggredire la totalità” frontalmente: «Esso s’installa in un punto sottratto alla cultura e al contempo sociale dell’accecamento, in un punto ar-chimedico per così dire, dal quale la coscienza sia in grado di riportare il movimento nella totalità, pur grave che sia»31.
Come abbiamo mostrato in apertura, lo svuotamento simbo-lico dell’oeuvre e la contemporanea inclusione del culturale nell’economico danno scacco alla nozione di ideologia, e con essa alla distinzione tra critica immanente e trascendente. Il cri-tico della cultura non è più chiamato a mettere in salvo in un pensiero a cui si garantisce una colpevole autonomia, la manca-ta conciliazione di ciò che nella realtà è illusionisticamente uni-to. Le forme estetizzate della contemporaneità si spogliano dell’aporetica inconciliabilità dei momenti costituenti: essi sono
27 Ivi, p. 21. 28 Ivi, p. 18. 29 Ivi, p. 19. 30 Ivi, p. 20. 31 Ivi, p. 18.
Il posto delle parole 211
la realtà, se per realtà dobbiamo intendere il manifestarsi sedu-cente delle merci, quell’acculturamento della bella comunica-zione che si innesta senza soluzione di continuità sui duri rap-porti di produzione. Quanto alla teoria, essa non può installarsi in «un punto sottratto alla cultura»: le sue categorie scaturisco-no dalla cultura stessa, dalla complessità procedurale della sua intensificazione tecnologica e falsa naturalità sensibile. Ritor-nando allo slogan jamesoniano dell’abolizione della distanza critica, possiamo ora dissipare il sospetto che con questa espres-sione si intenda ammiccare postmodernisticamente a una hege-liana “morte dell’arte”. La difficile collocazione della distanza critica non va interpretata come l’ennesimo falso superamento escatologico della cultura, bensì alla stregua di un congedo dall’ingenuità della distanza critica. L’impossibilità di prendere partito tra le due (un tempo) inconciliabili interpretazioni della cultura (tutto è cultura, niente è cultura) rende tangibili i limiti della critica dell’ideologia e della scienza cultura. Dal momento che la distanza critica non è più un a priori garantito dall’autonomia dello spirito, essa va indagata come esito di un pensiero. Ma di quale pensiero?
Se la riflessione accetta di vivere con maturità nell’eteronomia, la teoria della cultura potrà accontentarsi, in via preliminare, della definizione del culturale come di un cam-po di «intersezione dove discorsi filosofici, scientifici ed estetici si sovrappongono a tecnologie meccaniche, requisiti istituziona-li, forze socioeconomiche»32. Accecata dall’ipostatizzazione dei propri strumenti d’indagine (la dialettica negativa, la storia de-gli effetti, la decostruzione del logocentrismo), o dall’isolamento metodico di un livello ontologico di sua esclu-siva competenza (il non-contemporaneo, la differenza, la tra-scendenza, l’alterità), l’estetica filosofica ha creduto in genere di poter sfuggire alla volgare cristallizzazione dei metodi interni ed esterni, dei formalismi e dei determinismi. Eppure, come ab-biamo mostrato con il caso di Adorno, se da pensare è la cultura nella sua attuale e compromettente configurazione, le concilia-
32 J. Crary, Techniques of the Observer, cit., p. 8.
Capitolo IV 212
zioni forzate risultano inadeguate almeno quanto i dualismi af-frettati.
Mentre gli sforzi meno ingenui di render conto della cultura non temono di far ricorso a una terminologia ibrida, corrispon-dente all’impurità post-romantica dei fenomeni culturali (Ra-ymond Williams, Jonathan Crary), le scorciatoie filosofiche so-no costrette a reintrodurre una qualche dimensione di ingenuità nel proprio armamentario concettuale, dedicandosi alla ricrea-zione artificiale di una distanza estetica perduta. Come mostre-remo prendendo in esame due tipologie opposte della nostalgia per la distanza critica, la seconda via può condurre alla tradu-zione dei cultural studies in una metafisica applicata (Gayatry Chakravorty Spivak), o addirittura alla destituzione filosofica della nozione di cultura, stigmatizzata a causa della sua ipertro-fica “knowingness”, come a dire per la sua deplorevole carica di neutralizzazione dell’ineffabile “valore ispirativo” (Richard Rorty).
A dispetto dell’apparente naiveté di ogni ricorso al potenzia-le esplicativo della cultura (sia esso di stampo foucaultiano, francofortese, gramsciano o quant’altro), definire la comunica-zione televisiva una “tecnologia culturale” (Williams), e gli arti-fici ottici della camera oscura e dello stereoscopio altrettanti “siti culturali” appartenenti «all’economia culturale del valore e dello scambio» (Crary), significa maneggiare una terminologia ibrida, resa semiconcettuale dall’accettazione della compromis-sione del soggetto conoscente con l’avvolgente neutralità delle cose. Di contro, come intendere la tesi di Spivak, secondo cui la cultura sfugge ad ogni definizione per essere sempre “on the run”, se non come una radicale rivendicazione dell’ineluttablità che “tutto sia divenuto cultura”? (da cui discende la visione stravagante di un acculturalmento dei rapporti sociali che impo-ne ai soggetti colonizzati la deriva ontologica della rappresenta-zione). E come giustificare l’apologia rortyana «del romanze-sco, del genio, del carisma, delle pennellate individuali, dei pro-
Il posto delle parole 213
feti e dei demiurghi»33, se non leggendovi una difesa della tesi per cui “nulla è cultura”, dal momento che cultura significa per Rorty un regno dei valori sottratto alla teoria, secondo il princi-pio irrazionalistico secondo cui: «Non è possibile essere con-temporaneamente ispirati da un’opera e conoscerla»34?
Nelle pagine seguenti misureremo le risonanze della nuova configurazione della distanza critica mostrando gli esiti para-dossali di un mancato riconoscimento dell’innesto delle forme della conoscenza sulle forme della cultura tardo-moderna. Sia Rorty che Spivak – da opposti versanti ideologici: etnocentri-smo liberale e postcolonialismo marxista – tentano infatti di re-cuperare un punto di vista privilegiato sulla cultura. In un caso mediante una strenua difesa della distinzione tra due accezioni di cultura (Rorty), nell’altro mediante una localizzazione del culturale in soggetti sociali posti al centro dei processi di rinno-vamento storico (Spivak). Si tratta per entrambi di una regres-sione metafisica a uno stato di natura “mitologico” della teoria, che ponga rimedio all’odierna confusione dell’economico e del-lo “spirituale”.
Al disorientamento procurato dall’iscrizione tardo-moderna della conoscenza negli ingranaggi della riproduzione sociale e della gestione economia della sfera culturale, Rorty contrappone la visione “profetica” di legami comunitari insondabili, che con la loro stessa positiva esistenza legittimano la sopravvivenza “dell’entusiasmo romantico”35, di una pratica soltanto ironica-mente culturale. Mentre la “sinistra accademica foucaultiana” – capeggiata secondo Rorty proprio da Fredric Jameson, l’intellettuale meno foucaultiano dell’intero panorama accade-mico statunitense – è in grado di «ridicolizzare qualsiasi cosa senza riporre speranza in niente, di spiegare tutto senza idolatra-re niente»36, l’intellettuale ispirato alla Whitman o alla Dewey è chiamato a riscoprire l’immaginazione, il valore utopico del
33 R. Rorty, Achieving our Country, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
1999, p. 131. 34 Ivi, p. 133. 35 R. Rorty, Achieving our Country, cit., p. 126. 36 Ivi, p. 127.
Capitolo IV 214
pensiero non alienato, «costruendo immagini ispirative della nazione»37. Nulla è cultura insomma, perchè la vera cultura non giace come un cadavere sottoposto all’autopsia dei cultural stu-dies.
Queste tesi sono enunciate da Rorty – un filosofo che ha so-stituito la postmetafisicità dell’impianto filosofico con una re-gressione preteorica al “mondo della vita” del capitalismo fi-nanziario e dell’eccezionalismo americano – in un volumetto provocatoriamente ingenuo e visceralmente anti-intellettuale, impegnato nell’appassionata requisitoria delle “allucinazioni te-oretiche” della New Left americana38. Punto d’avvio è la so-vrapposizione tra il movimento dei cultural studies e una poco patriottica Sinistra Culturale di matrice foucoultiana, alla quale un vecchio liberale come Rorty non perdona di aver accantona-to, come reazione alla Guerra del Vietnam, la «religione civica di Dewey e Whitman»39. La nuova Sinistra Culturale è conta-giata dal corrotto elitarismo e snobismo europeo, dalle tendenze apocalittiche dei Derrida, dei Foucault e dei Baudrillard: «Quando i giovani intellettuali guardano i film di guerra di John Wayne dopo aver letto Heidegger, Foucault, Stephenson o Sil-ko, si convincono spesso di vivere in un paese violento, inuma-no e corrotto»40. Per questa ragione i cultural studies disdegna-no in nome della “teoria” i temi economici e il rapporto con i militanti politici e gli operatori sociali e sindacali. Invece di de-dicarsi alla storia del sindacalismo, i nuovi studenti di sinistra perdono il loro tempo sulla jamesoniana “dominante culturale postmodernista”.
I cultural studies si «specializzano in quel che essi defini-scono la “politica della differenza” o “dell’identità” o “del rico-noscimento”», credendo di dover «insegnare agli americani a
37 Ivi, p. 98. 38 Un libro che porta per titolo Realizzare la nostra nazione e che si apre con l'af-
fermazione: «L'orgoglio nazionale sta alle nazioni come il rispetto per se stessi agli in-dividui: per entrambi una condizione necessaria per migliorarsi» (R. Rorty, Achieving our Country, cit., p. 3).
39 Ivi, p. 95. 40 Ivi, p. 7.
Il posto delle parole 215
riconoscere l’alterità», il che secondo Rorty può curare soltanto gli epifenomeni psicologici, lenire il “sadismo socialmente ac-cettato”, senza giungere a fornire un’immagine utopica della cultura nazionale. Non basta infatti che gli Stati Uniti siano “forti e coraggiosi”; la loro eccezionalità è oggi giustificata sol-tanto dalle creazioni intellettuali della vecchia sinistra, che ha mostrato quanto la nazione sia anche “good”: «Dewey e Whit-man volevano che gli americani continuassero a pensare a se stessi come a una eccezione»41. Poiché gli americani «vogliono ancora sentirsi patriottici», bisogna riscoprire l’appartenenza al-la cultura ufficiale americana, quella della borghesia bianca, e lasciare da parte la cultura delle “vittime”, cioè delle donne, dei neri, dei gay, degli ispano-americani e dei migranti. Anzi, sa-rebbe necessario porre “una moratoria alla teoria”, cercare di tenere in vita ciò che rimane «dell’orgoglio di essere america-ni»42.
Sulla base di queste premesse nel capitolo finale, un’invettiva contro Fredric Jameson, ritenuto responsabile della crociata antiromantica dei cultural studies, Rorty avanza una fosca previsione sul destino dei cultural studies: «Non ho nes-sun dubbio che tra trent’anni i cultural studies saranno invec-chiati quanto è invecchiato trent’anni dopo il suo trionfo il posi-tivismo logico»43. A suo avviso Jameson e i cultural studies stanno a Harold Bloom e al canone immaginativo della lettera-tura angloamericana, come Ayer e il positivismo logico stavano allo spiritualismo di Whitehead. In entrambi i casi una pratica scientifica «analitica, antimetafisica, non romantica e altamente professionalizzata» si propone di rimpiazzare la “religione lette-raria”, quella “immaginazione secolarizzata” chiamata a «sosti-tuire la Sacra Scrittura quale sorgente principale di ispirazione e speranza per ogni nuova religione»44.
Se per un attimo accantoniamo il disagio causato all’intellettuale progressista dal ricorso al vocabolario della
41 Ivi, p. 15. 42 Ivi, p. 92. 43 Ivi, p. 132. 44 Ivi, p. 136.
Capitolo IV 216
“cultura nazionale”, ed isoliamo i motivi meno populisti elabo-rati in questo risentito pamphlet, ci accorgiamo che Rorty impu-ta alla confusione del piano politico con quello teorico la genesi del tema squisitamente compensativo della cultura. I cultural studies riguardano la cultura perché hanno perso di vista la sfera economica. O meglio, come vedremo in seguito, Rorty lascia intendere che il vero problema consista nell’allodossia dei cul-tural studies, nel loro ricorso al linguaggio della cultura per af-frontare la sfera economica. L’argomentazione di Rorty è rias-sumibile in quattro punti: A) I cultural studies rappresentano una forma degenerata di politica e non una forma sofisticata di teoria B) La politica non ha nulla a che vedere con la teoria e con la cultura. Essa riguarda esclusivamente la redistribuzione della ricchezza C) La teoria si può praticare a patto di non reci-dere il legame con “l’entusiasmo romantico” e la “creazione di idoli” e utopie D) La cultura non è un tema adatto alla teoria, perché la cultura oggettivata dalla teoria non è più cultura ma degenera a “knowingness”, ad arida furbizia: «Non è possibile essere contemporaneamente ispirati da un’opera e conoscer-la»45.
La «riformulazione delle speranze della società liberale in un modo non razionalista e non universalista»46 implica dunque una condanna degli approcci neutralizzanti alla cultura. Nulla è culturale, poiché la cultura non è un “oggetto” compromesso con la dimensione economica e politica dell’agire umano. Rorty, la cui intera filosofia può venire intesa come una risposta al riconoscimento della fine della distanza critica, la ricrea at-traverso la netta separazione tra le due accezioni di cultura. La distanza critica che Rorty dà per perduta è infatti esclusivamen-te quella del soggetto della conoscenza scientifico-filosofica dalla realtà “oggettiva” del mondo “là fuori”. Essa consiste nell’impiego di un metalinguaggio unitario, posto al di sopra della contingenza dei linguaggi particolari:
45 Ivi, p. 133. 46 R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge University Press, Cam-
bridge, Mass. 1989, p. 44.
Il posto delle parole 217
Chiamo “contingenza del linguaggio” il fatto che non ci sia modo di uscire dai vari vocabolari che abbiamo impiegato per trovare un meta-vocabolario che in qualche modo prende atto di tutti i possibili voca-bolari, di tutti i possibili modi di giudicare e sentire47. Abbandonare il criterio della verità come rappresentazione
non significa rinunciare tout court alla fondazione metafisica del sapere sociale in una superiore cultura “poeticizzata”. Per Rorty i “cambiamenti culturali” dipendono infatti dal «talento di parlare in maniera differente», dalla consacrazione di un re-gno dell’immaginazione utopica, fondato dalla mera constata-zione della sua matrice linguistica e della contingenza storicisti-ca e nominalistica dei suoi risultati. Come si vede, una consta-tazione soltanto parziale della crisi della distanza critica, parzia-le perché relegata alla revisione della razionalità obiettivistica, può facilmente comportare la presa di partito per l’ineffabilità della cultura. Tramite la rifondazione della perduta ingenuità della distanza critica nell’ingenuità artificiale di vincoli comuni-tari poeticizzati, Rorty tenta di eludere il divenire culturale dell’economico, un fatto di portata storica che preclude la mi-tizzazione dell’immaginazione linguistica. Di qui all’elaborazione di una filosofia kitsch da mondo della vita, at-testata sull’apologia di un senso comune nazionalista, il passo è breve.
Dopo questo esempio di delegittimazione della dominante culturale tardo-moderna, alla quale Rorty contrappone una iro-nia liberale inscritta nella comunità profetica statunitense, ve-niamo ad una modalità speculare di repressione della disillusio-ne estetica. Nel caso di Gayatry Chakravorty Spivak, portaban-diera di un postcolonialismo marxista di matrice derridiana, la cultura si dice soltanto tra virgolette, per non cristallizzare il di-rompente dinamismo dei suoi slittamenti semantici:
“La nostra cultura”. È perciò salutare ricordare, di nuovo, che la “cul-tura” è un regolatore del come si conosce. La famosa coppia della ca-pacità-di-conoscere foucaultiana: il pouvoir/savoir come abilità di co-
47 Ivi, p. xvi.
Capitolo IV 218
noscere è “cultura” a livello base […] Da questo punto di vista, le tas-sonomie della cultura sono possibili e utili. Ma ogni “cultura” al lavo-ro è un gioco di differenze […] da queste tassonomie […] La cultura è sempre in movimento, sempre mutevole48.
Declinata in versione decostruttiva, la cultura suona come il
grido di battaglia – sempre localizzato e storicizzabile – della “politica culturale”. Ad esempio, nella battaglia multiculturali-sta, il ricorso alla cultura segnala una “complessa situazione strategica”: «“La nostra cultura”, con la sua pretesa di valere come un modello di comportamento al di là della sola ragione, viene opposta all’appello della cultura dell’Illuminismo europeo alla Ragione»49. Per Spivak la cultura non si riduce quindi né alla manipolazione ideologica né all’utopia estetica. Essa si in-sinua piuttosto tra le condizioni di possibilità della conoscenza; a patto di intendere per conoscenza la continua dislocazione delle opposizioni categoriali tramandate: «La peculiarità della pratica decostruttiva deve essere qui ribadita. Dislocando le op-posizioni che essa apparentemente metteva in questione all’inizio, essa è sempre differente da se stessa, sempre differi-sce se stessa»50. La “pratica decostruttiva” duplica, o meglio ri-pete, la deriva ontologica (e rappresentativa) in cui sono coin-volti gli attori sociali. La perdita della distanza critica genera un’apologia eraclitea della differenziazione, e il «riconoscimen-to produttivo della complicità» del teorico con la rete del potere in cui è collocata la sua “subject-position” diviene il nucleo ge-nerativo del progetto postcoloniale.
Confrontandosi con le tesi di Jameson sulla dominante cultu-rale postmodernista – «Per il pubblico generico dell’accademia letteraria statunitense, il più brillante esempio di sovrapposizio-ne tra postmodernismo e poststrutturalismo è stato offerto forse da Jameson con Il Postmoderno, o la logica culturale del tardo
48 G.C. Spivak, A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanish-
ing Present, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1999, pp. 356-357. 49 Ivi, p. 353. 50 G.C. Spivak, Explanation and Culture, in The Spivak Reader, D. Landry, a cura
di G. MacLean, Routledge, London-New York 1996, p. 30.
Il posto delle parole 219
capitalismo»51 –, Spivak non può allora che accettare, con una “differenza”, il primato della dimensione culturale: «Tutto è sta-to trasformato in cultura. Spero che il lettore noterà la differen-za e la convergenza tra questa affermazione e quella di Jame-son»52. Come si è detto, la convergenza risiede nella condivi-sione della necessità di fare teoria dopo l’estenuazione della di-stanza critica. La differenza è riposta invece con chiarezza nella limitata fedeltà di Jameson ai principi costitutivi della decostru-zione. La dominante culturale, in quanto dominante, rischia di collaborare alla «repressione dell’emergente eterogeneità […] col rifiutarle l’accesso allo status di idioma della descrizione culturale»: «se ci concentriamo solo sulla dominante, dimenti-chiamo che la differenza tra le varietà dell’emergente e del resi-duale potrebbe essere la differenza tra la resistenza radicale e conservatrice al dominante»53. Coerentemente con il principio che fa della cultura un «regolatore del come si conosce», in no-me della politica culturale Spivak riafferma la centralità dell’eterogeneo, della pratica decostruttiva.
Osserviamo la mutazione subita dalla distanza critica una volta posta nel cerchio magico della tesi del tutto è cultura. La crisi del logocentrismo, come a dire della soggettività gnoseo-logica borghese e del modello socio-politico occidentale, con-duce al differimento di se stessa della razionalità e al primato dell’eterogeneo, in una parola, alla scomparsa della distanza cri-tica. Ciò nonostante, accordandosi con il processo storico di de-ragliamento dell’identità e di impura produttività della teoria, il pouvoir/savoir del critico postcoloniale recupera un punto di vi-sta privilegiato sulla società e sulla conoscenza. Il processo di dissoluzione della riflessività e di compromissione sociale del concetto è invertito dall’ontologizzazione del processo di dislo-cazione della rappresentazione. Una visione a cui non manca il referente sociale, incarnato dalle soggettività decentrate a cui si volgono i cultural studies transnazionali54.
51 G.C. Spivak, A Critique of Postcolonial Reason, cit., p. 313. 52 Ivi, p. 411. 53 Ivi, p. 314. 54 Per Spivak, le «più povere donne del Sud» (ivi, p. 6).
Capitolo IV 220
nenza.
Mentre per il critico di ispirazione marxista la fine dell’ingenuità della distanza critica impone quantomeno di tener ferme, foucaultianamente, le «condizioni di realtà degli enun-ciati» sulla cultura55, il pragmatista radicale e il decostruzionista intravedono nell’evanescenza della distanza critica una straor-dinaria opportunità per eludere, in nome della purezza e assolu-tezza di una testualità culturale non-oggettivabile, l’esistenza di una cultura positiva. In un caso l’oggettivazione è smascherata quale “asciutta, sardonica erudizione”56 che mortifica l’entusiasmo romantico della secolarizzata religione letteraria, nell’altro le si imputa la sopraffazione dell’emergente, la nega-zione dell’«(im)possibilità di (un’altra) narrazione»57.
Quanto detto sinora non ha toccato un’accezione fondamen-tale della distanza critica, che sembra condizionare con la sua consequenzialità ogni interrogazione filosofica della contempo-raneità. Se la cultura è per noi un tutto, come sostengono in genere i fautori della svolta culturale, l’affievolirsi della distanza critica dall’attualità della “nostra” cultura può apparire come un mero effetto dell’inscrizione della teoria nei modi di apparizione del suo oggetto. Nel caso di una cultura “vivente”, l’unico a priori concesso alla riflessione è la presa d’atto che la nozione di cultura assorbe anche i discorsi su di essa e i soggetti interroganti, divora ogni pretesa di neutralità, di trascendenza del pensiero nei confronti delle cose. Alla traiettoria nichilistica della speculazione filosofica, finita nella crisi di legittimità di un sapere dei fondamenti che si nutre invece della propria soppressione, i cultural studies oppongono specularmente una positività impenetrabile, un regno della pura imma
È il problema affrontato da Foucault tramite l’orientamento archeologico della sua indagine che di proposito, per mettersi al
55 «A priori storico. Giustapposte, queste due parole producono un effetto un po'
stridente; con esse intendo designare un a priori che sia non condizione di validità per dei giudizi, ma condizione di realtà per degli enunciati» (M. Foucault, L'archeologia del sapere, trad. it. di G. Bogliolo, Rizzoli, Milano 1971, p. 170).
56 R. Rorty, Achieving our Country, cit., 135. 57 G.C. Spivak, A Critique of Postcolonial Reason, cit., p. 6.
Il posto delle parole 221
riparo da questo esito, si volge ai «discorsi che hanno appena cessato di essere nostri»:
È evidente che non si può descrivere esaurientemente l’archivio di una società, di una cultura o di una società […] D’altra parte non è possi-bile descrivere il nostro archivio, perché parliamo proprio all’interno delle sue regole, perché è lui che conferisce a ciò che possiamo dire – e a se stesso, oggetto del nostro discorso – i suoi modi di apparizione, le sue forme di esistenza e di coesistenza, il suo sistema di cumulo, di storicità e di sparizione […] L’analisi dell’archivio comporta dunque una regione privilegiata, che è al tempo stesso vicina a noi, ma diffe-rente dalla nostra attualità […] La descrizione dell’archivio sviluppa le sue possibilità (e la padronanza delle sue possibilità) a partire dai discorsi che hanno appena cessato di essere nostri; la sua soglia di esi-stenza è instaurata dalla frattura che ci separa da ciò che non possiamo più dire, e da ciò che cade fuori della nostra pratica discorsiva58.
Per sfuggire a queste conseguenze, tipiche degli approcci
dialettici e post-dialettici alla cultura (da Adorno a Foucault, da Said a Crary), i teorici della cultura si sono rivolti perlopiù alla delimitazione metodologica, temporale, geografica, sociale o metafisica, di una regione privilegiata della cultura, che pur es-sendo interna ad essa non risulti del tutto assimilabile alle sue condizioni di esistenza e di conoscenza. La soluzione più ovvia, che ripete la strategia di Foucault, sfrutta il “presupposto segre-to” offerto dalla discontinuità dei processi storici. Il critico di-stoglie il proprio sguardo dall’avvolgente immanenza del pre-sente e interroga un passato che, studiato a partire dalla nozione di frattura, si può considerare almeno in parte trascorso.
Chi invece tenta di mettere a fuoco la cultura vivente, si sen-te chiamato a giustificare a priori, tramite una qualche conce-zione filosofica, lo scarto ontologico che inaugura e sostiene il discorso sulla cultura, in contrapposizione alla mera critica pra-tica condotta nella cultura. In questo senso, la non-contemporaneità del desiderio utopico (Jameson), la confluenza di nuovi sistemi di comunicazione e migrazioni di massa (Ap-
58 M. Foucault, L'archeologia del sapere, cit., pp. 174-175. In Foucault l’“archivio” è l’a priori storico, il trascendentale differenziale, il sistema di tutte le formazioni di-scorsive studiate dall’“archeologia”.
Capitolo IV 222
padurai), la persistenza di sistemi rappresentativi specifici di minoranze e gruppi marginali (Hall), la continua produzione di differenze nell’ambito del sistema totale della rappresentazione (Spivak, Zizek) dischiudono alla descrizione della cultura una soglia di estraneità che sostiene l’analisi critica del presente.
Dobbiamo domandarci però se la cosiddetta svolta cul-turale possa restare aggrappata a un concetto totalizzante di cultura, e dunque affidarsi all’illusione di poter ricreare artificialmente la distanza critica mediante l’evocazione della storicità, della contraddizione, dell’egemonia o della differenza. Siamo certi che l’efficacia e la penetrazione della cultura tardo-moderna, nonché la sua definitiva sop-pressione dell’antiquata dialettica di cultura estetica e an-tropologica, implichi un domino totale del mondo e della conoscenza? Il divenire non teorizzato della cultura apre piuttosto lo spiraglio a una concezione post-romantica e post-ideologica della positività del sapere socializzato e dell’esteriorità della dimensione estetica. Accantonati l’escatologismo da morte dell’arte e la nostalgia per l’ingenuità della distanza estetica, si profila infatti l’esigenza di render conto del regno imperfetto della nuo-va economia culturale nei termini impuri di un pensiero disilluso.
Il posto delle parole 223
2. La rivoluzione indifferente
La più complessa delle rivoluzioni era iniziata. Bruno Corra, Sam Dunn è morto
Nel “romanzo sintetico” futurista di Bruno Corra, Sam Dunn è morto59, passività e rivoluzione, indifferenza e trasformazione del mondo confluiscono in una costellazione magico-ironico-messianica, non eminentemente letteraria, che rappresenta uno dei contributi più originali dell’avanguardia futurista alla cultu-ra europea del Novecento. La mia tesi è che questi motivi rie-mergeranno, e troveranno ampio sviluppo, soltanto nella rifles-sione filosofica più recente, ad esempio nell’estetica di Gianni Vattimo e nell’ontologia politica di Giorgio Agamben. Per met-tere in luce queste connessioni, più che di un’ennessima riscrit-tura della storia letteraria italiana abbiamo dunque bisogno di una topologia culturale all’altezza delle utopie e dei problemi formulati all’inizio del Novecento.
Come afferma Bruno Corra nella prefazione alla seconda e-dizione, Sam Dunn è morto è «il primo romanzo sintetico […] vale a dire il primo romanzo senza capitoli di preparazione, senza squarci riempitivi, senza particolari oziosi»60. Sam Dunn è un romanzo breve ambientato a Parigi e Bogliano (Liguria) tra il 1943 e il 1952. Il narratore-testimone-discepolo, parodiando
59 L’edizione a cui faccio riferimento è la sesta ed ultima, apparsa per Einaudi nel 1970 a cura di Mario Verdone: B. Corra, Sam Dunn è morto. Racconto insolito, Einau-di, Torino 1970. Per la cronologia delle edizioni rimando alla postfazione di Verdone, pp. 73-80. Il volumetto di Corra, scritto nel 1914, venne pubblicato inizialmente a Mila-no nel 1915 per le Edizioni di Poesia dirette da F. T. Marinetti. Corra scrisse due prefa-zioni diverse, una per l’edizione del 1917, una per quella del 1928. Entrambe sono ri-stampate nel testo einaudiano.
60 Ivi, p. 74. Il manifesto in cui Marinetti teorizza i principi del romanzo sintetico non apparirà che nel 1939.
Capitolo IV 224
la narrazione dei Vangeli, narra per episodi e brani interrotti, che includono diari e testimonianze, la parabola di Sam Dunn, un nuovo messia apatico, grottesco e fallimentare. Mentre le storie letterarie collocano il romanzo, per i temi occultistici e la prosa surreale, agli albori del novecentismo, lo stile ironico e descrittivo, ben lontano dalla retorica simbolista di Marinetti, ricorda invece la scrittura di Calvino e più in generale del ro-manzo sperimentale razionalista.
La trama del romanzo è scarna: Sam Dunn è un ricco aristo-cratico di Parigi, scettico e inetto. Senza compiere alcuna azio-ne, forte soltanto della propria inerzia e passività, Sam Dunn in-canala le energie occulte nascoste sotto la crosta della vita quo-tidiana e scatena a Parigi, il 5 giugno 1952, un’irrefrenabile “ri-voluzione lirica”. Un “incantesimo” avvolge la città, preparan-dola a un rinnovamento apocalittico, alla «più profonda di tutte le rivoluzioni»: «tutta Parigi cominciava a fermentare di fanta-sia», un esito messianico che ricorda la nuova mitologia estetica del romanticismo jenese. Lo “scardinío immaginoso” della real-tà indotto da Sam Dunn produce la «più idiota frenesia che si potesse immaginare»; a Parigi accadono fatti illogici e sensa-zionali: sparizioni di edifici, azioni simultanee, avvenimenti in-sensati – ad esempio, «due mostruosi asparagi, più alti di un uomo, nacquero in cinque secondi sotto l’Arco dell’Etoile»61 – che confluiscono in una processione spontanea di «quattro mi-lioni di essere umani» i quali, «al culmine della frenetica verti-gine dalla quale erano stati trascinati»62, lanciano verso il cielo un grido fantastico: «Sam Dunn! Sam Dunn! Sam Dunn! Sam Dunn! Sam Dunn!»63.
E tuttavia, a causa della «più sterile delle deviazioni», le for-ze occulte scatenate a Parigi dall’apatia di Sam Dunn interseca-no l’altro “polo d’irrealtà” del romanzo, l’Hôtel Portorosa di Bogliano, costruito dal Cav. Santerni e dominato dalla «magica atmosfera di carnosa allegria» che promana dal corpo possente
61 Ivi, p. 30. 62 Ivi, p. 33. 63 Ibidem
Il posto delle parole 225
della consorte, la signora Peppona. Divenuto a propria volta un serbatoio di energie vitali, l’Hôtel Portorosa interviene nella “rivoluzione dunniana”:
Il nucleo medianico di Portorosa Hôtel aveva imbevuto di sé tutta Pa-rigi. La rivoluzione di Dunn era irrimediabilmente deviata nella più i-diota frenesia che si potesse immaginare. Una impreveduta corrente di energie capricciose, aveva soffocato lo slancio lirico di una realtà che stava per elevarsi a un superiore piano di vita64.
L’Hôtel è inghiottito dalle rocce e, nel corso degli avveni-
menti convulsi causati dalla “frenesia pepponica”, Sam Dunn viene legato dalla cameriera Rosa André alla poltrona «su cui se ne stava coricato sonnecchiando» e ucciso con una sederata65. Come contraccolpo dell’abortita rivoluzione estetica parigina, sorge in Norvegia una montagna d’acqua, il Monte Dunn, che «ogni anno […] erutta con violenza indescrivibile milioni di piccoli sassi di forma ellittica […] portanti incisi le iniziali S.D.»66. Nell’ultimo capitolo del romanzo, l’azione buffa sfocia nel mito e la narrazione diventa leggenda.
Come il Molloy di Samuel Beckett67, Sam Dunn è immerso in un “abituale letargo”: «del resto la sua personalità era quasi sempre ottenebrata, immersa in una stanchezza corrosiva, semi annichilita […] Ciò che prima vi colpiva in lui era appunto l’immobilità, una immobilità totale, che evidentemente gli pe-netrava anche lo spirito»68. L’indole implosiva di Sam Dunn, la sua inattività al cospetto del “soffocamento” della “rivoluzione fantastica”, la sua completa indifferenza di fronte alla “catastro-fe” che devia – complice Peppona, il principio femminil-passatista – l’energia poetica, condanna la trasformazione salvi-fica: Sam Dunn «non volle far niente per impedire lo sfacelo dell’opera che tanto gli era costata»69.
64 Ivi, p. 60. 65 Ivi, p. 61. 66 Ivi, p. 66. 67 Ivi, pp. 37-39. 68 Ivi, p. 12. 69 Ivi, p. 58.
Capitolo IV 226
Sul piano strutturale, l’esito imprevisto è innescato dal cor-tocircuito tra potenziali energetici inversi: Peppona, sensuale e decadente, gioviale ed erotica; Sam Dunn, anti-eroe futurista, messia grottesco dello scardinio immaginoso del principio di realtà, transistor della nuova distribuzione lirica dei fenomeni. Rifuggendo l’azione, Sam Dunn ride della “sterile deviazione” della sua rivoluzione: «Il suo organismo era dotato di una ecce-zionale refrattarietà ad ogni genere di eccitanti»70. Come lo Za-rathustra di Nietzsche, Sam Dunn è un messia-umorista71; os-servando la frenesia parigina, Sam Dunn è preda di una “con-vulsione di riso”: «il grottesco dell’avvenimento lo divertì»72.
Fedele alla parabola cristologica, l’azione romanzesca cul-mina nel sacrificio di Sam Dunn: «Sapeva già il fallimento ir-rimediabile ed imminente dell’opera religiosa che era stato lo scopo di tutta la sua vita, sapeva già di essere egli stesso irrime-diabilmente votato al sacrificio ma […] non trascurava di con-servare […] una linea di indifferenza veramente divina»73. La vita di Sam Dunn è troncata dalla cameriera Rosa André: «Col-tolo di sorpresa, essa lo legò solidamente su cui se ne stava co-ricato sonnecchiando e lo uccise barbaramente colpendolo ripe-tute volte con la parte posteriore del corpo». Con la morte vio-lenta di Sam Dunn e il fallimento della “rivoluzione fantastica”, lo scanzonato romanzo di Corra si dissolve in tragedia umoristi-ca.
Per quale ragione, in questo testo di Corra, trasformazione rivoluzionaria del mondo e passività dell’eroe entrano in riso-nanza con il fallimento tragico? Perché la rivoluzione lirica si accompagna al cinismo di Sam Dunn, il quale sa che «la vita è un pasticcio […] in cui ci si può ficcare di tutto ciò che si vuole senza peggiorarlo e senza migliorarlo»? Che strana avanguardia è quella futurista, per contemplare simultaneamente – un termi-ne tecnico del lessico futurista-bergsoniano – sovversione este-
70 Ivi, p. 38. 71 Ivi, p. 58. 72 Ibidem 73 Ivi, p. 39.
Il posto delle parole 227
tico-politica e fatalismo, rivoluzione e atarassia, utopismo e quietismo?
La mia ipotesi è che il nucleo generativo del romanzo di Corra sia vittimario: il sacrificio è il punto di contatto della vio-lenza sugli altri e su di sé, dell’impulso alla trasformazione e della passività, dell’azione e della rinuncia. Eppure, a differenza dell’eroe cristiano, Sam Dunn non si sacrifica per salvare il mondo bensì per lasciarlo così com’è. Che senso ha tutto ciò?
I lettori di Palazzeschi avranno colto l’aria di famiglia che permette di ricondurre l’anti-eroe sacrificale Sam Dunn al mes-sia impotente, all’“uomo di fumo” del Codice di Perelà (1910). Entrambi i romanzi si sfaldano per l’eccessivo protagonismo di personaggi espiatori, anti-eroi condannati a un destino umoristi-co, e quindi non tragico nel senso greco74. Come nel caso di Pa-lazzeschi, la prosa di Corra è paradigmatica della sensibilità meno marinettiana, più “debole” del Futurismo, la stessa sotto-lineata da Giovanni Papini nel Crepuscolo dei filosofi (1905), dove l’accento cade sull’“azione nell’inazione” e sulla “debo-lezza” di Nietzsche.
Proprio “debolezza” e “irreparabilità” sono concetti chiave utilizzati da Gianni Vattimo e Giorgio Agamben. Sullo sfondo, il dilemma posto da René Girard: come demistificare la logica della violenza sacrificale e rompere la connessione tra violenza e sacro?75 In Vattimo, la preoccupazione è quella di portare alle estreme conseguenze lo «svelamento del meccanismo vittima-rio»76, radicalizzando la logica anti-sacrificale del Cristianesi-mo sino all’autoconsumazione della trascendenza nella radicale accettazione della debolezza dei principi e dei limiti. In Agam-ben, l’obiettivo è afferrare la potenzialità dell’“irreparabile”, immaginare una condizione liberatoria simile al sacrificio ma
74 Cfr. su questo punto il celebre saggio di L. Pirandello, L’umorismo, Garzanti, Mi-lano 2004.
75 R. Girard, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 2000. Per Girard sacra non è la violenza che conduce al sacrificio. Questo esito è il frutto dell’esigenza umana di trovar un capro espiatorio per unificare la società intorno alla vittima. Per il dialogo tra Vatti-mo e Girard, cfr. R. Girard, G. Vattimo, Verità o fede debole. Dialogo su cristianesimo e relativismo, a cura di P. Antonello, Transeuropa, Massa 2006.
76 È questa un’espressione di Gianni Vattimo, in R. Girard, G. Vattimo, cit., p. 15.
Capitolo IV 228
priva della violenza sociale nei confronti del capro espiatorio. Una redenzione dell’umanità che lasci al tempo stesso che le cose siano come sono, una trasformazione politico-teologica che parta dall’esistenza, dall’“essere qualunque”, dai soggetti nella loro finitezza e passività, nella loro naturalità, nel loro es-sere creaturale: «L’Irreparabile è che le cose siano così come sono […] Rivelazione non significa rivelazione della sacralità del mondo, ma soltanto rivelazione del suo carattere irrepara-bilmente profano»77.
Vattimo e Agamben, come Sam Dunn, esplorano il punto di convergenza di passività e trasformazione, di esaurimento delle possibilità e messianismo. In questo modo la logica del sacrifi-cio si libera dal circolo vizioso che imprigiona i soggetti e le collettività. La realtà stessa mostra una natura vittimaria quan-do, come accade a Sam Dunn, essa arriva al fondo della propria passività. Solo dopo che «tutto si è definitivamente compiuto» si annuncia un “altrimenti”78. Come sostengono i logici indiani, «tra il nirvana e il mondo non c’è la più piccola differenza». Per Agamben questa condizione regola anche lo svolgimento della scrittura letteraria, la quale deve aspirare a una perfetta passivi-tà: «L’atto perfetto di scrittura non proviene da una potenza di scrivere, ma da un’impotenza che si rivolge a se stessa»79.
La “marea rinnovatrice” scatenata da Sam Dunn è descritta da Corra come uno «smarrimento di chi si sente assalito alle spalle da una forza gigantesca». Sam Dunn è «concentrato in una sua totale, disperata tensione verso un caos di possibilità meravigliose»80. Il suo comportamento è retto da «stravaganze, illogicità di azione, pazzie»:
C’erano sopra una sedia otto lunghe sciarpe di lana diversamente colo-rate: se le ravvolse l’una dopo l’altra sulla fronte, serrandole poi tutte strettamente con un acinghia a fibbia. Corse, così bendato, all’angolo opposto della stanza, dove rovesciò, con un gesto violento e febbrici-
77 G. Agamben, La comunità che viene, Einaudi, Torino 1990, p. 63. 78 Ivi, p. 37. 79 Ivi, p. 27. 80 B. Corra, op. cit., p. 16.
Il posto delle parole 229
tante, un tavolo a thè, carico di grosse bocce di profumi le quali si frantumarono sul pavimento81. Lo scopo di Sam Dunn è la produzione del caos, la devia-
zione delle energie sotterranee del mondo apparente per liberare la “viva elasticità multiforme” della pura possibilità del mondo reale: «La più complessa delle rivoluzioni era iniziata […] Nel mondo degli uomini si aprivano crateri di imprevedibilità, e-mergevano foreste di capricci, irrompevano torrenti di nuove leggi e di nuove logiche»82.
Secondo Agamben, ciò che la teologia medievale definiva atto confusivo, actus confusionis, è il raggiungimento di un caos in cui consiste la redenzione del mondo “così com’è”. Un caos che, come in Sam Dunn, non si ottiene con la violenza ma at-traverso la passività e il sacrificio:
L’essere che è giunto alla sua fine, che ha consumato tutte le sue pos-sibilità, riceve così in dote una possibilità supplementare […] Questo impercettibile tremito del finito, che ne indetermina i limiti e lo rende capace di confondersi, è il piccolo spostamento che ogni cosa dovrà compiere nel mondo messianico83.
Attraverso il personaggio di Sam Dunn, Corra immagina un
piccolo spostamento estetico84, una riconfigurazione politico-letteraria della violenza cristiana e del sacrificio rituale fondata sull’apparentemente paradossale coincidenza di passività e rivo-luzione, di scetticismo e attivismo magico-politico. Sam Dunn rivela al mondo che «ogni oggetto, ogni fatto conengono in sé una possibilità di infinite rivelazioni»85. Celata tra i motivi ori-ginari del Futurismo c’è dunque la celebrazione estetico-politica dell’indifferenza, una sensibilità new age, riscoperta dalla filo-sofia italiana del dopoguerra, che ha poco da spartire con
81 Ivi, p. 38. 82 Ivi, p. 37. 83 Ivi, p. 38. 84 Per la radice romantico-illuministica di questo motivo, cfr. Il più antico pro-
gramma sistematico dell’idealismo tedesco, in F. Hölderlin, Scritti di estetica, SE, Mi-lano 1987.
85 B. Corra, op. cit., p.21.
Capitolo IV 230
l’attivismo fascista, con l’ordine umanista borghese, o con la critica della cultura d’ispirazione marxista.
Il posto delle parole 231
3. Il taglio nell’immagine
Il difficile problema dell’immagine in Bergson. Jean Hyppolite, Aspetti diversi della memoria in Bergson
Percorrendo un sentiero solitario, Deleuze ha reinventato il bergsonismo, sottraendolo allo spiritualismo cattolico e alla mortificazione esegetica86. Dispiegando la provocatoria affer-matività di un pensiero dadaista, gioiosamente anti-borghese e non-cristiano, Deleuze ha smontato e rimontato il macchinario metafisico bergsoniano, moltiplicandone gli effetti e il raggio d’azione. E tuttavia, in parallelo al programmatico bergsonismo deleuziano, la rete concettuale tesa da Bergson ha minacciato di catturare gran parte del pensiero francese del Novecento. Così in Bataille, Blanchot e Derrida assistiamo a una lacerazione del bergsonismo: la loro è un’estetica dei tagli, una filosofia come “esperienza interiore”, “esperienza limite”, esperienza dello strappo della tunica bergsoniana.
Pur essendo stata prima confutata (Sartre, Merleau-Ponty) e poi rimossa (Lévinas, Foucault), l’ontologia bergsoniana ha su-bito una prodigiosa disseminazione che ne ha esteso e al tempo stesso occultato i confini: ai margini di questo orizzonte, Deleu-ze ha riformulato il naturalismo immanentistico bergsoniano, attualizzandolo come pensiero dell’«essere del problematico, del problema e della domanda»87, mentre Bataille e Blanchot hanno distolto lo sguardo dalla “questione dell’essere” tramite
86 A. Badiou, Deleuze. «Il clamore dell’essere», trad. it. di D. Tarizzo, Einaudi, To-
rino 2004, p. 111. 87 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., p. 89.
Capitolo IV 232
un esercizio obliquo di scrittura88. In Deleuze il bergsonismo diventa così un’ontologia dei paradossi dell’esteriorità89, in Ba-taille e Blachot una filosofia della differenza come interiorità. Esteriorità dei simulacri – il pensiero del “fuori” celebrato da Foucault90 – e interiorità “sanguinante”; assorbimento o allon-tanamento dall’essere. Si tratta in entrambi i casi di ripetizioni stranianti del bergsonismo, di distorsioni del “grande edificio speculativo” che, in Francia, ha ospitato anche la concettualità hegeliana, husserliana e heideggeriana91. La notte
Bataille definisce il primo romanzo di Blanchot, Thomas l’oscuro92, un testo in cui sono «pressanti, quand’anche vi ri-mangano nascoste, le questioni della nuova teologia»93. La “nuova teologia” a cui aderiscono i pensatori dell’avanguardia parigina – di cui Thomas l’oscuro costituisce una sorta di mani-festo – non è nient’altro che una resa dei conti con l’ontologia di Bergson: «Mai la filosofia era parsa tanto fragile, più prezio-sa e più appassionante come nel momento in cui uno sbadiglio faceva svanire nella bocca di Bergson l’esistenza di Dio»94. Nella citazione di Bataille, uno sbadiglio – suprema indifferen-
88 M. Blanchot, L’infinito intrattenimento. Scritti sull’«insensato gioco di scrivere»,
trad. it. di R. Ferrara, Einaudi, Torino 1977, p. 32. 89 Cfr. G. Deleuze, Logica del senso, cit. 90 Cfr. M. Foucault, Il pensiero del di fuori, in Scritti letterari, trad. it. di C. Milane-
se, Milano, Feltrinelli, 1971. 91 A. Badiou, Deleuze, op. cit., p. 111. 92 La prima redazione di Thomas l’obscur (Gallimard, Paris) risale al 1941. Del ro-
manzo Blanchot ha fornito nel 1950 una seconda versione: Thomas l’obscur, nouvelle version, Parigi, Gallimard. Di questi testi non esistono traduzioni italiane, se si escludo-no le citazioni da Thomas l’oscuro riportate da Derrida e Bataille, a cui faremo spesso riferimento.
93 G. Bataille, L’esperienza interiore, trad. it. di C. Morena, Dedalo, Bari 1978, p. 154. Sul commento di Bataille a Thomas l’oscuro cfr. J.- P. Sartre, Un nouveau mysti-que, in Situations I, Gallimard, Paris 1947, pp. 183 e ss. e R. Ronchi, Bataille, Lévinas, Blanchot, Spirali, Milano 1985, pp. 19-23. Per un confronto tra le posizioni di Sartre e quelle di Blanchot, cfr. G.H. Hartman, The Fulness and Nothingness of Literature, «Ya-le French Studies», n. 16, 1955, pp. 74-78.
94 M. Blanchot, Thomas l’oscuro, cit. in G. Bataille, L’esperienza interiore, cit., p. 154.
Il posto delle parole 233
za e passività – realizza il compito nietzschiano della nuova teo-logia, la ripetizione della morte di Dio. La filosofia rinasce, co-me sbadiglio, “nella bocca di Bergson”.
La rilevanza filosofica della bocca deriva in Bataille dalla sua predisposizione al grido e al riso: Thomas l’oscuro è il «gri-do di un’esistenza», «Lévinas dice di alcune pagine di Thomas l’oscuro che sono la descrizione dell’il y a. Il che non è total-mente esatto: Lévinas descrive e Maurice Blanchot grida in una certa misura l’il y a»95.
Anche Didi-Huberman riporta alla metaforica della bocca il nucleo della nuova teologia. La bocca è ciò che ingoia il visibi-le, il rammendo del corpo e dell’immagine, i campi magnetici dell’ontologia bergsoniana:
La bocca è in grado di realizzare ciò che il più delle volte l’occhio non può far altro che desiderare: l’oggetto visto, l’oggetto frontale, la boc-ca sa incorporarlo. Concretamente. Incorporare il visibile […] questa precisamente sarebbe stata l’esigenza messa in opera da Georges Ba-taille96.
Lo spalancarsi della bocca nell’immagine del sacrificio, la
convergenza dell’immagine e del corpo nel dolore di un grido di orrore o paura, gli ossessivi topoi letterari batailliani – «Quando vi dico che vedo è un grido di paura che vede» – inci-dono la tela visuale dell’ontologia bergsoniana.
Sulla scia di Leibniz, in Materia e memoria Bergson fissa il baricentro dell’interrogazione filosofica nel rapporto tra il corpo e l’immagine. Spazio e tempo, materia e memoria, azione e contemplazione sorgono nel medium ontologico di un “insieme di immagini”, nel non-luogo dell’“esistenza”, cammino “a metà strada” tra il mondo e il soggetto, tra la realtà empirica e la rela-zione cognitiva: «Per noi la materia è un insieme di “immagi-ni”. E per “immagine” intendiamo una certa esistenza che è più
95 G. Bataille, Dall’esistenzialismo al primato dell’economia, in L’aldilà del serio e
altri saggi, a cura di F. Papparo, Guida, Napoli 1998, p. 98. 96 G. Didi-Huberman, L’immagine aperta, in Georges Bataille: il politico e il sacro,
a cura di J. Risset, Liguori, Napoli 1987, p. 175.
Capitolo IV 234
azione» .
di ciò che l’idealista chiama una rappresentazione, ma meno di ciò che il realista chiama una cosa, - un’esistenza situata a metà strada tra la “cosa” e la “rappresentazione”»97. Né rappresentra-zione né cosa, bensì presenza in movimento, il mondo sospeso delle immagini bergsoniane sopporta esclusivamente la tra-sformazione del corpo, l’unica immagine opaca e assorbente, un’immagine che occupa “una posizione privilegiata”:
Tutte queste immagini agiscono e reagiscono le une sulle altre in tutte le loro parti elementari […] Tuttavia ce n’è una che risalta su tutte le altre per il fatto che non la conosco soltanto dall’esterno, attraverso delle percezioni, ma anche dall’interno, attraverso delle affezioni: è il mio corpo. […] Ecco le immagini esterne, poi il mio corpo, poi, infi-ne, le modificazioni apportate dal mio corpo alle immagini circostan-ti98.
Ingoiate o spalancate da una bocca – lo sbadiglio bergsonia-
no in cui “svanisce” il mondo cristiano – le immagini di Bataille non intrattengono alcun rapporto con una posizione rappresentativa o con una soggettività fenomenologica. Come in Bergson, le immagini sono l’unico sostrato di un’ontologia anti- idealistica; nemmeno il corpo «saprebbe far nascere una rappresent 99
In Thomas l’oscuro, l’ontologia dell’immagine bergsoniana è drammatizzata nel corso di una scena notturna, su cui si ad-densano le annotazioni di Lévinas e Bataille: «Scese in una spe-cie di grotta dove l’oscurità era totale […] Immagini che face-vano la sua oscurità lo inondavano, e il corpo trasformato in uno spirito demoniaco cercava di rappresentarsele»100. La pre-minenza di questa regione crepuscolare che eccede ogni rela-
97 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 5. 98 Ivi, pp. 13, 15. 99 Ivi, p. 15. 100 M. Blanchot, Thomas l’oscuro, cit. in G. Bataille, Dall’esistenzialismo al prima-
to dell’economia, in L’aldilà del serio, cit., p. 98 e parzialmente in G. Bataille, L’esperienza interiore, cit., p. 153. Lévinas paragona l’il y a, il “fuori” della sua ontolo-gia esistenzialista, all’esperienza notturna di Thomas l’oscuro: «Thomas l’oscuro, di Maurice Blanchot, si apre sulla descrizione dell’il y a», E. Lévinas, Dall’esistenza all’esistente, trad. it. di F. Sossi, Marietti, Casale Monferrato 1986, p. 56.
Il posto delle parole 235
zione conoscitiva, in cui l’immanente datità delle immagini bergsoniane – mantenuta nelle filosofie della visibilità (l’Aperto) di Deleuze e Foucault101 – è sostituita dall’“estasi della notte”102, svela la strategia di interiorizzazione del bergso-nismo praticata dalle scritture di Blanchot, Bataille e Derrida. «L’esistenza spettatrice si condensa negli occhi. Questo caratte-re non viene meno se scende la notte»103. Per quale ragione la visione richiede un “luogo paradossale”, un organo in grado di “vedere la notte”?104 Cosa vede un occhio ridotto all’“apparato” di un corpo e al gesticolare di un grido, quando la visione perde il mondo e s’immerge nell’oscurità? «Ciò che si trova allora nell’oscurità profonda è un desiderio implacabile di vedere quando, dinanzi a tale desiderio, tutto si sottrae»105. Il dehors foucaultiano e deleuziano, l’esteriorità di un essere che non ammette altro rapporto che il non-rapporto di una “piega” o di una «sintesi disgiuntiva”, diventa in Blanchot e Bataille la “pro-fondità vuota” di una “lacerazione” prodotta dal movimento di un desiderio senza oggetto106: «desiderio di quell’infinita man-canza che è il desiderio, desiderio dell’impossibilità del deside-rio»107.
Se in Deleuze le immagini bergsoniane, dispiegate dalle con-trazioni-distensioni della durata, sono colte nella loro luminosa
101 «Il sapere è irriducibilmente doppio, parlare e vedere, linguaggio e luce, e questa
è la ragione per cui non c’è intenzionalità» (G. Deleuze, Foucault, trad. it. di P.A. Ro-vatti e F. Sossi, Cronopio, Napoli 2002, p. 110).
102 G. Bataille, L’esperienza interiore, cit., p. 182. 103 Ibidem. Sulla moltiplicazione labirintica del linguaggio dell’oscurità in Thomas
l’oscuro cfr. T. Schestag, Mantis, Relics, «Yale French Studies», n. 93, 1998, pp. 221-251. Sul disorientamento percettivo indotto dall’ambientazione notturna del romanzo, cfr. S. Ungar, Night Moves: Spatial Perception and the Place of Blanchot’s Early Fiction, «Yale French Studies», n. 57, 1979, pp. 129-133.
104 G. Didi-Huberman, L’immagine aperta, cit., p. 172. 105 G. Bataille, L’esperienza interiore, cit., p. 182. 106 Ivi, p. 183. 107 M. Blanchot, L’esperienza limite, in L’infinito intrattenimento, cit., p. 283. In
Blanchot il desiderio non è un fondamento ontologico ma un nome per l’irruzione della differenza, per la “domanda dell’Altro” non compresa nella problematica dell’essere (cfr. La parola plurale, in L’infinito intrattenimento, cit., p. 33). Sull’interpretazione te-stuale del pensiero di Bataille da parte di Blanchot, cfr. M. Perniola, Georges Bataille e il negativo, Feltrinelli, Milano 1977, pp. 73-84.
Capitolo IV 236
esteriorità, il “non-sapere” di Bataille e il “neutro” di Blanchot mirano all’interiorità dell’“altra notte”, che «eternamente si agi-ta e si ripiega nella sua indifferenza»108. È questa “l’estasi della notte”, l’esperienza-limite in cui la soggettività si dissolve in una “ferita del pensiero” e “l’assenza di visione”, la “massa not-turna” che acceca Thomas, si ribalta nell’accrescimento dell’occhio:
Il suo occhio, inutile per vedere, assumeva proporzioni straordinarie, si sviluppava in modo smisurato e, estendendosi all’orizzonte, lasciava penetrare la notte nel suo centro per crearsi un’iride. Attraverso questo vuoto erano dunque lo sguardo e l’oggetto dello sguardo a mescolarsi. Non solo quest’occhio che non vedeva nulla apprendeva qualcosa, ma apprendeva la causa della propria visione. Vedeva come un oggetto, il che equivaleva al fatto che non vedeva nulla109.
La posizione privilegiata del corpo bergsoniano all’interno
«dell’insieme delle immagini date sin dall’inizio»110, la sua fun-zione di selezione delle immagini in vista dell’azione, è svuota-ta e sottratta dall’esperienza notturna di Thomas, dalla prolife-razione tumorale di un’“esistenza spettatrice” che “si condensa negli occhi”111.
Oltre ad aver sottolineato la consonanza teorica tra l’il y a e la notte di Thomas l’oscuro, Lévinas ha colto la matrice bergso-niana “di questa oscurità”, il suo radicamento nella presenza so-spesa delle immagini, nella “luminosità dell’essere”, nella «ne-cessità di un ente, di un “qualcosa” che esiste»112. L’estasi della notte, l’esperienza limite di Thomas, non consiste nel “privile-gio notturno” di una comunione con l’essere113, nella compiu-tezza di un’esperienza ontologica – la visione cieca del tutto nel
108 M. Blanchot, L’esperienza limite, cit. p. 283. 109 Id., Thomas l’oscuro, cit. in G. Bataille, Dall’esistenzialismo al primato
dell’economia, cit. p. 98. 110 H. Bergson, Materia e memoria, cit., p. 37. 111 G. Bataille, L’esperienza interiore, cit., p. 182. 112 E. Lévinas, Dall’esistenza all’esistente, cit., p. 56. 113 M. Blanchot, L’esperienza limite, cit. p. 283.
Il posto delle parole 237
buio di un occhio-mondo – bensì nella «chance di un rapporto “immediatamente” senza misura» con il tutto114.
Il corpo di Thomas, il suo occhio immenso e inutile, ingoia le immagini nel buio di uno scarto in grado di eccedere la totali-tà delle immagini date. Il “potere assorbente” e l’“intervallo” del corpo all’interno del sistema delle immagini descritti da Bergson nel primo capitolo di Materia e memoria, sopravvivo-no come una pura affermazione dell’esperienza interiore. Si tratta in Bataille di un’interiorità senza soggetto, dell’interiorità del sacrificio dell’io: «L’esperienza interiore afferma, è affer-mazione pura, si limita ad affermare […] È la presenza senza nulla di presente»115; in Lévinas, del campo impersonale di-schiuso, in prospettiva fenomenologica, dal potere di negazione della coscienza: «È invece necessario chiedersi se il nulla im-pensabile come limite o negazione dell’essere, non sia possibile in quanto intervallo e interruzione, se la coscienza, con il suo potere di sonno, di sospensione, d’epoché, non sia il luogo di questo nulla-intervallo»116.
Svincolati dalla servitù dell’essere e dalla funzione vitale della selezione delle immagini, l’assorbimento e l’intervallo bergsoniani consumano voracemente le immagini e innescano un differimento infinito del senso. La notte decostruisce la real-tà descritta di Materia e memoria: «Ora, in questa notte, io a-vanzo portando il tutto verso ciò che eccede infinitamente tutto. Io progredisco al di là della totalità che tuttavia abbraccio stret-tamente»117. Sottoposto al movimento di contrazione dell’interiorità – da intendersi, letteralmente, come il completo assorbimento del mondo nell’esperienza – il “corpo-immagine” bergsoniano è solcato dagli inizi ossessivi dei testi narrativi di Blanchot: le immagini che sgorgano dal sacrificio del corpo non formano una tela ma si sparpagliano come brandelli: «tra le immagini che si susseguono resta una sorta di vuoto, fatto
114 Ivi, p. 285. 115 Ivi, p. 282. 116 E. Lévinas, Dall’esistenza all’esistente, cit., p. 57. 117 M. Blanchot, Thomas l’oscuro, cit. in J. Derrida, Non/Passo, in Paraggi. Studi
su Maurice Blanchot, trad. it. di S. Facioni, Jaca Book, Milano 2000, p. 110.
Capitolo IV 238
dell’assenza della narrazione del tessuto che lega strettamente gli uni agli altri gli eventi»118. La “ferita del pensiero” è una rot-tura nel caleidoscopio bergsoniano, la fuga dalla prigionia del mondo della durata ottenuta per mezzo di un’affermazione asso-luta: «l’affermazione liberatasi da tutte le negazioni […] si tiene al di sopra, al di fuori dell’essere e non dipende né dall’ontologia né dalla dialettica»119.
Analizzando la filosofia dell’immagine di Bataille, Didi-Huberman indica nell’«arresto sull’immagine aperta e negativa del figlio sacrificato»120 una ripresa della tradizione dell’imago pietatis. In ciò consiste la genealogia cristiana della lacerazione del tessuto concettuale bergsoniano: l’immagine aperta e carna-le dell’“iper-cristianesimo” di Bataille frantuma la totalità aper-ta della metafisica bergsoniana, precipita «la nozione di imma-gine per aprirla»121. Ma dobbiamo a Starobinski il miglior commento – una scrittura intenzionalmente parassitaria, non un’interpretazione – alla scrittura di Blanchot: «l’immagine ap-pare qui come il minimo di “corpi” necessari perché il pensiero si percepisca come pensiero»122. Pur senza riconoscere aperta-mente i motivi bergsoniani, Starobinski descrive accuratamente la “fisicità” e l’estraneità della scrittura di Blanchot al linguag-gio fenomenologico: Thomas non è una “coscienza spettatrice”, ma un’eventualità interna al corpo-immagine del racconto. La narrazione, dominata dall’invadente positività di un “fuori” ma-rino e notturno, dalle metamorfosi e dagli annegamenti di un io
118 G. Bataille, Silenzio e letteratura, in L’aldilà del serio, cit., p. 286. De Man ha
richiamato l’attenzione sulla «riasserzione del fallimento nell’originare» una narrazione, caratteristica della prosa di Blanchot (P. De Man, Impersonality in the Criticism of Maurice Blanchot, in Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, Routledge, London 1983, p. 66).
119 M. Blanchot, L’esperienza limite, cit. p. 282. 120 G. Didi-Huberman, L’immagine aperta, art. cit., p. 182. 121 Ivi, p. 171. Nancy denuncia i residui dialettici segretamente attivi nel culto ba-
tailliano del sacrificio: «Bataille […] ha voluto mettere sulla bilancia il corpo orrenda-mente lacerato e lo sguardo – stravolto o estatico? – di un giovane cinese suppliziato. Ma così facendo, Bataille adempiva alla logica del superamento dialettico del sacrificio, che vuole sottrarlo al suo carattere ripetitivo e mimetico» (J.-L. Nancy, Un pensiero fi-nito, trad. it. di L. Bonesio, Marco y Marcos, Milano 1992, p. 237).
122 J. Starobinski, Thomas l’obscur, chapitre premier, «Critique», n. 229, 1966, pp. 502-503.
Il posto delle parole 239
neutro, dispiega un “Altro materiale”, un “fuori fisico”123. Tho-mas «è divenuto lui stesso una parte» della «retina dell’occhio assoluto»124. Lo spettatore narrativo diventa un occhio assoluto – il sistema bergsoniano delle immagini – e l’occhio assoluto sprofonda nella fisicità – il principio dell’oscurità in Blanchot – di un’immagine-retina, di un corpo-luce. Lo scarto del corpo – in Bergson un “centro di indeterminazione” e un’immagine car-dine – assorbe ogni altra evidenza nella sua oscurità. In Blan-chot tutto è “arresto” perché il tutto è un intervallo che impedi-sce l’apertura dell’essere. L’essere
In Blanchot l’oscurità delle immagini nelle quali, come nell’intuizione bergsoniana, si è immediatamente collocati sen-za la mediazione della coscienza, spezza con il suo “eccesso di affermazione” il ritmo della durata. Né il ricordo né la memoria sopravvivono alla frantumazione dell’essere: l’esperienza «non si dà mai come compiuta, perché nessun ricordo può confermar-la, trascende la memoria ed è misurata solo dall’oblio, l’immenso oblio contenuto nella parola»125. Al movimento di allontanamento dalle immagini bergsoniane, al distacco dall’essere come luce, si affianca l’affermazione della “disper-sione”, un “divenire oscuro” che rifiuta la questione dell’essere come durata126. Mentre la filosofia di Deleuze si presenta come una mappatura della molteplicità luminosa della durata, una “memoria assoluta detemporalizzata”127, la scrittura di Blanchot mette in scena «l’immenso oblio contenuto nella parola», grida l’impossibilità di porre la “problematica dell’essere”, contrasta il privilegio dell’ontologia:
123 Ivi, p. 503. 124 Ivi, p. 512. 125 M. Blanchot, L’esperienza limite, cit. p. 284. 126 Id., La parola plurale, cit., p. 62. 127 A. Badiou, Deleuze, op. cit., p. 113.
Capitolo IV 240
La questione dell’essere che decade come questione, è questione che decade nell’intelligenza dell’Uno […] la “domanda più profonda” è quella che sfugge al riferimento all’Uno. È l’altra questione, la do-manda dell’Altro e anche la questione che è sempre altra, diversa128.
Il bergsonismo di Deleuze rivendica l’affinità con la diffe-
renza ontologica di Heidegger129. L’univocità dell’essere vale come garanzia contro la distribuzione gerarchica dei generi (il platonismo), come difesa della molteplicità equivoca dei simu-lacri: «l’essenziale dell’univocità non è che l’Essere si dica in un solo e stesso senso, ma che si dica, in un solo e stesso senso, di tutte le sue differenze individuanti o modalità intrinseche»130. La differenza, che per Deleuze sgorga dall’univocità dell’essere e si realizza come attualizzazione della durata secondo linee di-vergenti – «Bergson non trova alcuna difficoltà nel conciliare i due caratteri fondamentali della durata: il continuo e l’eterogeneo»131 – richiede invece in Bataille e Blanchot il dé-soeuvrement, la «soffocante inutilità del presente», l’arresto del-la scrittura in una sospensione di «questo mondo della dura-ta»132: «Io, infatti, duro: tutto sfugge se non ho potuto annien-tarmi»133; «è in questo stato di abbandono che si lasciò trascina-re dal sentimento della durata»134. Poiché le scritture di Blan-chot e Bataille si svolgono nell’elemento della durata, non è in gioco un allontamento da una temporalità totalizzante. Si tratta piuttosto, come mostrano Derrida e Starobinski nel loro corpo a corpo con Thomas l’oscuro, di un movimento di scrittura che altera istantaneamente ogni totalità, di un passo “multiplo di se
128 M. Blanchot, La parola plurale, cit., p. 34. 129 «Heidegger invece sta dalla parte di Duns Scoto e infonde un nuovo splendore
all’univocità dell’essere» (G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., p. 91). 130 Ivi, p. 53. 131 G. Deleuze, Il bergsonismo e altri saggi, cit., p. 27. 132 G. Bataille, Silenzio e letteratura, cit., p. 288. 133 Id., L’esperienza interiore, cit., p. 169. 134 M. Blanchot, Thomas l’oscuro, cit. in J. Derrida, Non/Passo, in Paraggi. Studi
su Maurice Blanchot, trad. it. di S. Facioni, Jaca Book, Milano 2000, p. 103.
Il posto delle parole 241
stesso” che “si porta come labirinto” e come incessante ripeti-zione di una esperienza “che non dura”135.
«Né attivo né passivo, l’essere univoco è neutro»136. In veste di filosofi bergsoniani dell’immagine, Deleuze e Blanchot spe-rimentano un pensiero non-dialettico e non-fenomenologico137. Anche i vettori delle loro divergenze, la posizione del tutto co-me differenza o ripetizione, dell’essere come luce o oscurità, si lasciano marcare da una topologia delle attualizzazioni dell’ontologia bergsoniana. Sbarazzandosi dei concetti di rela-zione e trascendenza, di alterità ed esperienza, Deleuze ha pro-seguito la rivoluzione nietzschiana, ha depurato dalle incrosta-zioni cristiane l’edificio speculativo eretto da Bergson, espel-lendo dalla terminologia filosofica ogni traccia di soggettività e di assiologia. Come testimonia la difesa del «potere trascenden-te di negazione» accordato alla parola e all’esperienza, il “mes-sianismo parigino” di Blanchot e Bataille ha mantenuto tuttavia una sofferta fascinazione – e dunque il privilegio di una relazio-ne – con la tradizione cristiana, di cui conserva dialetticamente il calco della promessa di alterità138.
135 J. Starobinski, Thomas l’obscur, chapitre premier, cit., p. 511 e J. Derrida,
Non/Passo, cit., p. 100. 136 G. Deleuze, Logica del senso, cit., 160. 137 Deleuze ha dichiarato a più riprese il suo debito nei confronti di Blanchot; cfr.
Pensiero nomade, in Nietzsche e la filosofia e altri testi, cit., p. 314 e Differenza e ripe-tizione, cit., p. 147.
138 Girard sottolinea “l’ascesi romanzesca” a cui mirano i romanzi metafisici di Blanchot (R. Girard, Ou va le roman, «The French Review», vol. 30, n. 3, 1957, p. 205). Anche secondo Poulet Thomas l’oscuro realizza una «ascesi quanto più completa possibile» (G. Poulet, Maurice Blanchot as Novelist, «Yale French Studies», n. 8, 1951, p. 80).
AREE SCIENTIFICO–DISCIPLINARI
Area 01 – Scienze matematiche e informatiche
Area 02 – Scienze fisiche
Area 03 – Scienze chimiche
Area 04 – Scienze della terra
Area 05 – Scienze biologiche
Area 06 – Scienze mediche
Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie
Area 08 – Ingegneria civile e Architettura
Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione
Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico–letterarie e storico–artistiche
Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Area 12 – Scienze giuridiche
Area 13 – Scienze economiche e statistiche
Area 14 – Scienze politiche e sociali
Le pubblicazioni di Aracne editrice sono su
www.aracneeditrice.it
Finito di stampare nel mese di agosto del 2008dalla tipografia « Braille Gamma S.r.l. » di Santa Rufina di Cittaducale (Ri)
per conto della « Aracne editrice S.r.l. » di Roma
CARTE: Copertina: Patinata opaca Bravomatt 300 g/m2 plastificata opaca; Interno: Usomano bianco Selena 80 g/m2.ALLESTIMENTO: Legatura a filo di refe / brossura
Stampa realizzata in collaborazione con la Finsol S.r.l. su tecnologia Canon Image Press