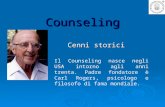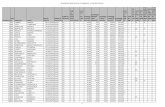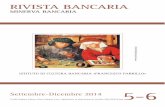La sintesi realista per valorizzare le evidenze e gli esi_ delle ...
Le nazioni per le strade
Transcript of Le nazioni per le strade
1
La nazione per le strade. Odonomastica e segni urbani per la costruzione
della nazione e per l’affermazione della monarchia nelle città dell’Italia
postunitaria.
(Maila Pentucci)
«Maceratesi! Quel fausto giorno vagheggiato ne’ nostri pensieri, affrettato dal
desiderio di tutti i buoni, spunterà alla fine anco su di noi. Il bel sole d’Italia, che da
secoli non illuminava, che dolori e miserie, brillerà di tutta la sua luce abbagliante
sulle gioje nostre, sulla era novella, che si apre a noi dinanzi. Quel Re, cui
l’Onnipotente Iddio concedeva un cuore capace di comprendere le sofferenze di
milioni d’italiani, ed una volontà salda nello imporre ad esse un termine, l’eroe di
Palestro, di S. Martino, il glorioso Vittorio Emanuele II domani ci onorerà di sua
Augusta presenza.»1
Così il conte Tommaso Lauri, presidente della commissione municipale provvisoria per
la città di Macerata, il 9 ottobre 1860, dalle colonne del foglio quotidiano marchigiano
«L’Annessione Picena», incitava i propri concittadini a salutare il passaggio in città di
Vittorio Emanuele.
Il re attraversava le terre italiane da poco liberate, diretto verso l’Aspromonte, in una
sorta di viaggio elettorale che doveva rafforzare il sentimento di appartenenza alla
nazione ed il riconoscimento del potere di casa Savoia nelle popolazioni che si
apprestavano a votare per i plebisciti.
Di fatto, nonostante che i maceratesi e tutti i marchigiani sarebbero stati chiamati alle
urne solo il 4 e 5 novembre successivo, già fin dall’esito positivo della battaglia di
Castelfidardo2 avevano iniziato a sentirsi italiani. Infatti tra il 19 ed il 20 settembre
1860, appena giunse in città la notizia della vittoria sabauda sui papalini, i liberali
maceratesi organizzarono una manifestazione a grande partecipazione popolare
durante la quale fu abbattuto lo stemma pontificio dai palazzi e dalle porte cittadine e
sostituito con il tricolore, segno tangibile del passaggio dal governo del papa a quello
1 «L’Annessione Picena», n. 8, 9 ottobre 1860, p. 1. 2 La battaglia di Castelfidardo, combattuta tra un corpo d’armata dell’esercito piemontese guidato dal generale Enrico Cialdini e le truppe papali – in prevalenza francesi – al comando del generale Christophe De Lamoricière, definì l’annessione delle Marche e dell’Umbria al Regno d’Italia e aprì la strada per la presa di Ancona. Ebbe luogo nelle piane adiacenti al fiume Musone, tra i comuni di Castelfidardo e Loreto, in provincia di Ancona, il 18 settembre 1860. Per approfondimenti si vedano UFFICIO STORICO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE, La battaglia di Castelfidardo (18 settembre 1860), Roma, Tipo-litografia del Genio Civile, 1903, SEVERINI, Marco (cur.), Le Marche e l’Unità d’Italia, Milano, Codex, 2010.
2
del re. Così pochi giorni dopo Vittorio Emanuele attraversò la città imbandierata a festa
da porta Romana a piazza Maggiore, tra due ali di folla acclamante giunta da tutti i
municipi vicini, le cui manifestazioni di consenso, richieste da pubblici proclami, erano
comunque anche spontanee3.
Fa riflettere il fatto che il re ripercorre la stessa strada, da porta Romana fino alla piazza
centrale, ancora denominata piazza Maggiore, che circa 20 anni prima il papa Gregorio
XVI aveva attraversato in solenne corteo, durante una visita ufficiale al capoluogo della
delegazione pontificia maceratese ed in occasione della quale furono poste ben 13
epigrafi celebrative e memoriali sui muri della città4.
Il passaggio del re invece, che pure è documentato in maniera minuziosa negli atti e nei
verbali5 del primo governo nazionale dopo la cessazione del dominio pontificio e sulla
stampa locale6, non lascia tracce di pietra in città. Rintracciamo tuttavia esempi di
odonomastica spontanea che si è poi codificata prima nell’uso e successivamente negli
atti ufficiali del passaggio del corteo reale: a Montecassiano, paese attraversato dal re
nel suo percorso verso il capoluogo, sopravvive una fontana pubblica denominata dei
cavalli in quanto vi sostò il corteo sabaudo e vi si abbeverarono i cavalli di Vittorio
Emanuele7.
La mancanza di una subitanea comparsa della cosiddetta patria di pietra, ovvero del
corredo di lapidi, intitolazioni, statue, spazi pubblici dedicati, a fare da memento agli
entusiasmi postunitari dei maceratesi, ci dà una lettura abbastanza chiara della
transizione da un potere all’altro.
Infatti la città, che pure ebbe un ruolo di primo piano e fu teatro di eventi importanti
durante il processo risorgimentale8, assorbì il passaggio al nuovo stato in maniera tutto
sommato indolore. L’adesione al regno d’Italia e la scelta di Vittorio Emanuele II come
re, come dimostrano i numeri del plebiscito9 fu senza dubbio piena ed indiscussa,
probabilmente grazie anche al fatto che la classe dirigente non subì grandi mutamenti.
3 Archivio di Stato di Macerata (d’ora in poi ASMC), Archivio antico del Comune di Macerata, busta n. 586. 4 ASMC, Archivio antico del Comune di Macerata, Volumi e Registri, n. 1027. 5 ASMC, Archivio antico del Comune di Macerata, Volumi e Registri, n. 1047. 6 «L’Annessione Picena», n. 8, 9 ottobre 1860, n.9, 10 ottobre 1860. 7 SVAMPA, Gabriele, Montecassiano. Dalle origini, Macerata, Tip. Alvise Slavi, 1934. 8 Macerata vide la nascita precoce di un movimento indipendentista di stampo carbonaro, che culminò in un tentativo di moto fallito nel 1817, ma soprattutto ebbe un ruolo importante nella breve esperienza della Repubblica Romana, in quanto in città si acquartierò Giuseppe Garibaldi con la Legione in marcia verso Roma e nel periodo del suo soggiorno maceratese (gennaio 1849), fu eletto deputato alla Costituente della Repubblica Romana proprio nel collegio di Macerata. La città (considerare se metterlo nel corpo del testo) 9 Sui 4.127 votanti si erano registrati in città 4104 sì, 17 no e 6 schede nulle. In ASMC, Commissario Provinciale, busta n. 8.
3
Il notabilato maceratese postunitario era composto da elementi dal retroterra politico
rassicurante e mette insieme borghesi di orientamento liberali, cavouriani più che
garibaldini, insieme ad esponenti della vecchia classe politica al potere durante i
trascorsi papalini10. Il commissario straordinario per la Marca, Lorenzo Valerio viene
accusato sulle colonne de «L’Annessione Picena» di preferire come collaboratori per la
gestione della transizione politica verso la monarchia sabauda, personaggi
compromessi con il vecchio governo piuttosto che i sostenitori della causa patriottica11.
Del resto la vecchia classe dirigente, coinvolta nel governo postunitario, si sente garante
della continuità e dà prova di trasformismo ante litteram aderendo alla richieste del
nuovo potere costituito, per il quale comunque aver avuto meriti nel vecchio governo è
comunque titolo preferenziale. Tra l’altro tra il ceto alto borghese e liberale, che aveva
sostenuto le istanze risorgimentali a livello locale, e la vecchia nobiltà papalina il
rapporto è improntato alla collaborazione ed al reciproco riconoscimento.
Lo stesso Tommaso Lauri, primo sindaco di Macerata e nominato nel 1863 senatore del
regno, nobile di antico lignaggio, era stato, nel 1848, ministro delle finanze del governo
di Pio IX.
Il trasformismo politico impedisce un vero rinnovamento della classe dirigente nelle
piccole patrie locali, ma segni evidenti dell’affermazione della nuova patria italiana e
del regno unificatore dei Savoia si trovano nelle mutazioni e nei segni che il potere
iniziò a lasciare sul tessuto urbano, sull’apparato viario, sugli spazi pubblici dell’ex
capitale della marca pontificia, declassato nel passaggio alla monarchia sabauda a
semplice capoluogo di provincia. Come tutte le città italiane, anche a Macerata la storia
fu iscritta sui muri.
Fare gli italiani
Dunque la trasformazione politica così significativa per la storia d’Italia lascia il segno,
più che sulla conformazione delle classi dirigenti e sulle strutture dei rapporti
economici e sociali, sulle mutazioni che si possono osservare nei tessuti urbani delle
città, che diventano casse di risonanza a cielo aperto per la narrazione di una nuova
10 Si vedano MAGNARELLI, Paola, Appunti sulla classe dirigente maceratese tra antico regime e restaurazione, in TORRESI, Enzo, TORRESI, Franco, Macerata. Dal primo Ottocento all’Unità, Macerata, Agenzia libraria Einaudi, 1984, pp. 9 – 19 e SEVERINI, Marco (cur.), Macerata e l’Unità d’Italia, Milano, Codex, 2010. 11 I continui attacchi che l’élite liberale maceratese lanciava al commissario Valerio dalle colonne del giornale, nato nel 1860 per accompagnare con un lavoro di commento e di esortazione il processo di italianizzazione dei cittadini maceratesi, ne provocò la chiusura il 23 febbraio del 1861. In GIANANGELI, Vittorio (cur.), Bibliografia della stampa operaia e democratica nelle Marche 1860 - 1926. Periodici e numeri unici della provincia di Macerata, Ancona, Il lavoro editoriale, 1998, pp. 11 - 16.
4
storia, che abbia un forte carattere nazionale e sia identificabile nei simboli delle lotte
risorgimentali: il re, l’esercito, i patrioti e gli eroi.
In effetti, L’uso pubblico della toponomastica e dell’odonomastica con funzione politica
e la ridefinizione dell’aspetto della città come luogo di condivisione di memorie e di
aggregazione in momenti precisi del calendario celebrativo nazionale, assumono un
aspetto rilevante nel complesso progetto di costruzione dell’identità nazionale e dello
spirito di popolo portato avanti dalle classi dirigenti dell’Italia postunitaria; tale
fenomeno si esplicita a partire dal 1848, anno di rivoluzioni diffuse in tutta la penisola,
si consolida nell’età delle annessioni e prosegue dopo il 1861, con la Destra Storica al
potere, ma diventa discorso politico e pedagogico dominante a partire dalla presa di
Roma e dall’avvento dei governi della Sinistra Storica, fino all’età Crispina12.
All’indomani della realizzazione dell’unità d’Italia, il problema più impellente percepito
dalle classi al potere fu quello di costruire, praticamente dal nulla, un sentimento di
identità nazionale che trasformasse delle plebi, per secoli divise, dominate, non
soggette a diritti di cittadinanza, in un unico popolo.
Furono molti e variegati i mezzi utilizzati in questo progetto politico e civile, che prese
le mosse già nel corso del Risorgimento e proseguì attraverso percorsi differenti e con
fini mutevoli durante tutto lo svolgimento della nostra storia nazionale. Questa
operazione di costruzione dell’italianità fu strutturata partendo da una visione
paternalistica dello stato, secondo la quale esso si deve assumere il compito di educare
le masse e guidarle, senza destabilizzare comunque l’assetto della società: lasciando,
cioè, al notabilato quel ruolo di potere, sia centrale che locale, in gran parte
sopravvissuto alle annessioni e successivamente trasposto da un sistema politico
all’altro.
La scuola, l’esercito, la famiglia ebbero un ruolo centrale e assimilabile per metodi e
organizzazione nella costruzione dell’identità italiana; questa aveva bisogno di essere
fondata su di un retroterra storico comune, che non esisteva di fatto, ma andava
fabbricato e diffuso; a ciò doveva prestarsi dunque la storia del recente Risorgimento,
che fu inteso come evento mitopoietico e privo di frizioni e contraddizioni, condiviso e
unitario, sul quale avviare il processo di nazionalizzazione dell’Italia e dei suoi cittadini.
La storia risorgimentale, così variegata e parcellizzata nello spazio e nel tempo,
diventava così una sorta di leggenda nazionale comune, che metteva insieme nord e sud
del paese e si apprestava a creare un retroterra di simboli, eroi, fatti nei quali
12 Si veda in proposito Sergio Raffaelli, I nomi delle vie, in Mario Isnenghi (a cura di), I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, Roma – Bari, Laterza, 2010, pp. 261 – 288.
5
riconoscersi e dai quali prendere esempio. Infatti, come afferma lo storico inglese
Christopher Duggan, la celebre espressione «fare gli Italiani»13significava anche
correggere, tramite un’attenta proposta paidetica, la corruzione e le meschinità del
carattere italico, frutto di secoli di dispotismo, di strapotere politico e culturale della
chiesa, di subordinazione e abbrutimento morale e materiale14.
Tali aspetti connotavano la percezione dell’italianità e purtroppo emergevano
vividamente dalle cronache e dai diari dei tanti scrittori giunti in Italia per il gran tour
e attenti reporter del contrasto tra il pittoresco dei luoghi, il fascino dell’arte e della
storia e le miserrime condizioni delle genti visitate.
Il programma pedagogico doveva essere dunque unitario, ma capillarizzato, invasivo
dei vissuti quotidiani, tanto da instillare nelle menti e nelle coscienze un modo di
pensare.
La città fu uno dei luoghi deputati nei quali narrare il nuovo discorso nazionale,
utilizzando le strade, le piazze, i muri come superfici per raccontare la versione ufficiale
della storia e fare in modo che penetrasse nell’immaginario degli abitanti. Da questo
momento in poi il potere pubblico lascia intenzionalmente tracce e iscrizioni – in senso
reale o figurato – tantoché la città diventa un testo dove si stratificano e si
interconnettono le storie individuali e le storie collettive.
I nomi delle strade sono uno degli strumenti utilizzati, non più frutto di scelte casuali,
ma specchio di una precisa volontà politica rintracciabile sia nell’oggetto
dell’intitolazione che nella localizzazione nel tessuto urbano (centro o periferia non
danno la stessa visibilità e dunque si creano gerarchie); tale volontà è esplicitata nella
delibera di intitolazione, atto pubblico nel quale leggere ed interpretare le motivazioni
delle scelte odonomastiche attuate.
La città postunitaria e di età liberale
La città (piccola patria municipale) entra dunque a far parte del programma politico
risorgimentale e postrisorgimentale come luogo di esplicitazione del mutamento in atto
sia nella vita pubblica, sia nei ruoli e nei costumi sociali, sia nei valori di riferimento. Le
amministrazioni centrali e locali al potere elaborano piani urbanistici ispirati a un
modello unico: la Torino sabauda dalle vie larghe e diritte, con i palazzi dalle facciate
13«… il primo bisogno d’Italia è che si formino Italiani dotati d’alti e forti caratteri. E pur troppo si va ogni giorno verso il polo opposto. Pur troppo s’è fatta l’Italia ma non si fanno gli Italiani». M. D’Azeglio, I miei ricordi, A. M. Ghisalberti (a cura di), Einaudi, Torino 1971, p. 4. 14 C. Duggan, La forza del destino. Storia d’Italia dal 1796 ad oggi, Mondolibri, Milano 2009.
6
severe e porticati a livello di strada,atti a creare un diaframma tra esterno e interno che
incoraggi la socialità e la fruizione del luogo pubblico15.
L’odonomastica entra in questo progetto in maniera massiccia e con grande successo. I
nomi delle strade sono un mezzo per la pedagogizzazione del popolo molto efficace ed
economico: intitolare una strada costa meno che costruire un monumento o restaurare
un palazzo e ha un’incidenza diretta nella vita di tutti. Vedere e sentire ogni giorno eroi,
date, simboli scritti alle cantonate delle strade percorse continuamente, ripeterli per
necessità della loro funzione d’uso materiale, fa sì che essi diventino parte della
quotidianità individuale e collettiva dei cittadini italiani, con le stesse modalità e
caratteristiche da Torino a Palermo.
Gli spazi comuni, inoltre, rivestono un nuovo significato e assumono centralità in
questa opera di maquillage istituzionale; diventano infatti teatro e luogo deputato per
quelle ricorrenze e manifestazioni ufficiali, che coniugano la festa popolare e la
cerimonia, necessarie e funzionali alla creazione programmatica di un calendario civile
risorgimentale portatore di una doppia funzione: da una parte esso deve fornire al
popolo un promemoria potentemente sottolineato degli eventi considerati fondanti per
la nuova nazione, dall’altra deve soppiantare il calendario delle festività religiose
riproponendone però lo spirito, la funzione aggregativa e autocelebrativa e deve offrire
un apparato di nuovi simboli da riconoscere e nei quali sia facile riconoscersi.
Per l’Italia il Risorgimento, a partire dal biennio delle annessioni (1859 – 1861), segna
un importante passaggio nella modalità di intitolazione delle strade, prendendo le
mosse dall’uso francese introdotto dalla Rivoluzione, dopo la quale si osserva il
passaggio da una odonomastica spontanea, di derivazione medievale, a una celebrativa,
atta a dare una visibilità urbana al discorso nazionale e identitario. Prima della nascita
della nazione italiana non tutte le strade delle città e dei paesi avevano un nome e quelli
che esistevano erano endogeni, generati dal basso, dalla necessità pratica di avere o
dare punti di riferimento. Le strade prendevano il nome dalle caratteristiche
geografiche, architettoniche, naturali, dai tratti peculiari che presentavano, da elementi
che le rendevano riconoscibili e indicabili. Tuttavia, questi nomi attribuiti non erano
codificati. Anche le tracce da essi lasciati nei documenti ufficiali, e addirittura nelle
mappe catastali preunitarie, danno l’idea dello spontaneismo e dell’aleatorietà e
provvisorietà dei nomi16.
15C. Sorba, Il 1848 e la melodrammatizzazione della politica, in A. M. Banti, P. Ginsborg, a cura di, Storia d’Italia. Annali 22. Il Risorgimento, Einaudi, Torino 2007, pp. 481 – 539. 16 Ricorrendo a esempi locali, la strada che collega Macerata al borgo di Villa Potenza, oggi chiamata via de’ Velini, è indicata nei verbali dei consigli comunali come “strada detta corta del
7
Il nuovo stato si rende conto della potenzialità dell’odonomastica e inizia ad attribuire
alle strade nomi risorgimentali, che narrino ai passanti la storia recente della nazione,
resa uguale in tutte le città da nord a sud. Rispetto all’uso francese di scegliere simboli
astratti e concetti ideali (libertà, fraternità, giustizia, ecc.), l’Italia opta per la scelta di
nomi propri, eroi eponimi che diventano così padri della patria, ma anche di date,
luoghi e battaglie significative: una vera e propria narrazione storica che racconta, però,
la storia dei vincitori ricostruita e pacificata, dalla quale sono espunte tutte le anime
diverse e discordanti di un Risorgimento in realtà per nulla unitario né univoco.
La creazione di un palinsesto di stradari – medaglieri finalizzati all’appiattimento della
memoria sul modello proposto dalla borghesia dirigente e alla creazione di una
enciclopedia a uso e consumo delle masse17 – rappresenta il primo esempio, nella
nostra nazione, di uso pubblico della storia. Infatti,l’odonomastica diventa in questo
periodo atto intenzionale che emana dal potere costituito. Le municipalità assumono il
compito, tramite delibera del consiglio comunale, della decisione di intitolare o
reintitolare le strade, utilizzando tale provvedimento di solito come corollario e traccia
perpetua per qualche evento pubblico degno di nota (il passaggio del re o la visita di
qualche alta personalità dello stato, ma anche la celebrazione di un anniversario),
oppure incamerandolo in un piano più ampio di lavori pubblici.
Del resto la prima legge unitaria che si occupa sia pur marginalmente delle strade
comunali italiane è una legge sui lavori pubblici del 1865, che ha la finalità di stilare un
esatto inventario delle strade esistenti e di fissare norme di manutenzione,
attribuendone gerarchicamente la responsabilità a stato, provincia e comune18.
L’odonomastica diventa così una questione pubblica, afferente l’amministrazione e la
politica sia locali che nazionali19. Nel 1871 una legge del regno prescrive che tutte le
molino o corta di Villa Potenza”, ma nelle mappe del catasto gregoriano non porta nessuna denominazione. Si veda, per la prima notazione, Archivio di Stato MC, Fondo dell’Archivio antico del Comune di Macerata, Volumi e Registri, Registri, dei verbali del Consiglio Comunale. Per le mappe: Archivio di Stato MC, Catasto Gregoriano, Mappe Macerata, sez. città, cart. 1. 17«Si sostituiscono i nomi medaglia. Lo stradario diventa un medagliere. Tutta la paccottiglia della bassa erudizione si riversa nelle vie. I nomi sono suoni inerti, che non suscitano alcuna immagine di vita, che piombano nel fondo della coscienza materiale, morta, che non legano al passato, che strappano, con un atto violentemente illogico, i legami tradizionali tra l'uomo e la via. Lo stradario diventa un museo, un cimitero di illustri ignoti, povero ossame ammuffito e sbianchito dalla dimenticanza opportuna, perché meglio pone in rilievo chi veramente ha operato nella storia. La borghesia bottegaia non sa sostituire nulla di originale alla intensa vita spirituale del passato. La sua vita è la medaglia, la decorazione; stimolo, l'enciclopedia; metodo, il conguagliamento, l'appiattimento dei valori», in A. Gramsci, Sotto la Mole (1916 – 1920), Einaudi, Torino 1972, p. 318. 18 Legge n. 2248 del 20 marzo 1865, allegato F. 19 C. Marcato, Nomi di persona, nomi di luogo. Introduzione all’onomastica italiana, Il Mulino, Bologna 2009.
8
strade abbiano un nome e tutte le case una numerazione, stabilendo delle regole di
massima che escludono la possibilità di avere due vie con lo stesso eponimo nella
medesima città20. Tale legge risponde essenzialmente a esigenze di controllo e di ordine
pubblico, così come è attestato dalle successive circolari emanate dal ministero degli
Interni in epoca crispina: si nota la tendenza ad avere una sempre maggiore
rintracciabilità dei cittadini attraverso l’accertamento della loro residenza, possibile
solo se le strade hanno nomi codificati e non ripetuti. Con una legge organica del
governo Crispi21, emanata nel 1888, si procede a una vera e propria anagrafe delle
strade italiane e si attribuisce ufficialmente ai comuni la competenza dell’intitolazione e
della numerazione. La nazionalizzazione dell’odonomastica in età liberale fa un
ulteriore progresso con la catalogazione dei nomi comuni ammessi per la prima parte
dell’odonimo, mutuati da una pratica importata in Italia da Napoleone e tendenti
all’omologazione linguistica. Vengono, infatti, aboliti quasi tutti i nomi di derivazione
dialettale o locale a favore dei generici via, piazza, piazzale, corso, con alcune note
eccezioni, talmente radicate nei rispettivi tessuti urbani da non poter essere abolite per
legge: calle, campo, campiello ed altri a Venezia;lungarno a Firenze (che passa però da
nome proprio a nome comune, assumendo un’ulteriore aggiunta intitolatoria); rua ad
Ascoli Piceno22.
La pratica corrispondente a tale idea di una odonomastica fissata per atto
amministrativo e con mansione sempre altra rispetto alla semplice funzione d’uso, è
quella di un vero e proprio furore intitolatorio, volto alla riscrittura del Risorgimento in
chiave piemontesistica e filomonarchica23. Le giunte comunali di molte città d’Italia
procedono a operazioni di «sventramento odonomastico»24che a volte modificano il
nome storico e universalmente condiviso di una via con odonimi di richiamo patrio o
risorgimentale, che devono dichiarare l’adesione della città alla neonata nazione ed
educarne gli abitanti ai nuovi valori di riferimento. È il caso di via Toledo a Napoli, che
per breve e infelice periodo diventa via Vittorio Emanuele per poi tornare alle
origini,praticamente a furor di popolo, o della proposta di intitolare allo statuto la
storica piazza Castello a Torino, proposta rientrata per diverbi interni alla stessa
20 Legge n. 297 del 20 giugno 1871. 21 Legge sulla sicurezza pubblica n. 5888 del 23 dicembre 1888. 22 Per una panoramica completa delle pratiche legislative relative all’odonomastica italianasi veda G. Melis, La legislazione sulla toponomastica, in «Bollettino della deputazione di Storia Patria per l’Umbria», n. CI, fasc. II, pp. 89 – 103. 23 M. Isnenghi, L’Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri, Il Mulino, Bologna 2004. 24S. Raffaelli, I nomi delle vie, in M. Isnenghi, a cura di, I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, Laterza, Roma – Bari 2010, pp. 261 – 288.
9
amministrazione e sostituita con l’apposizione di una lapide commemorativa. Tale
sovrapposizione tra nome d’uso e nome ufficiale ha portato nel tempo vere e proprie
duplicazioni odonimiche, come quella tuttora presente nello stradario di Ancona: la
centrale piazza Plebiscito, così intitolata nel 1870 in occasione delle celebrazioni per il
decennale dell’annessione delle Marche allo stato sabaudo, aveva già subito successive
revisioni legate ai mutamenti del potere fin dal 1500: da piazza Nuova, a piazza
Grande, a piazza Napoleone dopo la conquista dei francesi, a piazza San Domenico in
seguito alla restaurazione, essa è nota e indicata fin dal Settecento come piazza del
papa in virtù di una statua di Clemente XII che vi ha sede. Questa intitolazione prevale
ancora oggi nell’uso corrente, ed è segnalata anche in molti stradari, guide turistiche e
in alcuni database di navigatori satellitari, nonostante il nome ufficiale sia quello
risorgimentale25.
Le scelte prevalenti nelle reintitolazioni dall’età postunitaria a quella liberale vanno
nella direzione della tradizione ufficiale e coniugano la storia nazionale e quella locale.
In ogni città si creano dei veri e propri percorsi nel Risorgimento e le vie e le piazze
centrali, spesso sedi di palazzi pubblici, assumono i nomi dei cosiddetti medaglioni del
Risorgimento, ovvero le quattro figure esemplari, lontanissime tra loro per idee e
comportamenti nella realtà fattuale, ma accostate nell’epica unitaristica a
rappresentare ciascuna un aspetto dello spirito risorgimentale: il guerriero Garibaldi, lo
statista Cavour, il re galantuomo Vittorio Emanuele, il filosofo Mazzini. Questo
processo si intensifica a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento, quando i primi
interessi della sinistra storica per le imprese coloniali spingono sulla questione della
nazionalizzazione delle masse e sul consolidamento dell’epica guerriera e patriottica
propria della riscrittura della storia risorgimentale. Accanto all’intitolazione di strade,
le città vengono costellate di lapidi che mettono insieme le quattro glorie nazionali, di
volta in volta denominati «i sommi che restituirono l’Italia agli Italiani»26, «forti tra
forti … che per diversa via signoreggiando uomini e tempi votati al patrio riscatto
vindici di eterno diritto conquistaste degno seggio nell’areopago europeo»27, esaltati
rispettivamente per «il pensiero divinatore e l’eterna parola, l’audacia guerriera
25 Per notizie sulla topografia di Ancona si veda S. Sebastiani, Ancona, forma e urbanistica, L'Erma di Bretschneider, Roma 1996. 26Recanati (MC), lapide apposta il 25 agosto 1907 sulla facciata interna al porticato del palazzo comunale. 27 Montecassiano (MC), lapide apposta nel 1899 sulla facciata del palazzo comunale.
10
magnanima, il genio politico, la lealtà cavalleresca»28, appiattendo su un generico
eroismo patriottico posizioni storiche diverse e contrastanti.
Le intitolazioni non si limitano a fatti e personaggi contingenti della storia recente, ma
tendono a un discorso pedagogico più ampio rispetto al semplice memento: si scelgono,
nel vasto repertorio di biografie delle antichità italiane, diverse personalità che a vari
livelli spesero la propria vita per la libertà o in difesa della patria, e si celebrano come
antesignani dell’idea risorgimentale. È il caso di Francesco Ferrucci, di Arnaldo da
Brescia, ma soprattutto di Giordano Bruno, assunto nel doppio ruolo di difensore
estremo della libertà di pensiero e martire dell’oscurantismo religioso, eroe soprattutto
per la massoneria anticlericale, che ha notevolmente contribuito all’unificazione ed è
ben inserita nella classe dirigente dell’Italia liberale. In corrispondenza con le note e
sofferte questioni legate all’erezione – avvenuta dopo lunghe traversie e discussioni
politiche nel 1889 – della statua a Giordano Bruno di Ettore Ferrari a Campo de’ Fiori,
in moltissime città furono intitolate vie e dedicate lapidi al filosofo nolano29.
Contestualmente, il mito della grande Italia viene esaltato ricordando al popolo i padri
della patria, per cui si procede ad intitolare vie ai pittori, ai letterati, ai musicisti che
fanno grande la storia della nazione: Dante è uno degli eponimi più diffusi, anch’egli
investito di una duplice funzione, quella di precursore sul piano politico del discorso
unitario30e quella di codificatore di una lingua nazionale necessaria al superamento dei
dialetti e degli usi linguistici locali.
L’analisi delle procedure di intitolazione ci permette inoltre di avere una panoramica
sia cronologica che geografica dei processi politici in atto per il consolidamento
dell’unità: a partire dal 1870, ad esempio, la data del 20 settembre diventa
imprescindibile negli stradari di quasi tutte le città italiane, così come dopo la
sfortunata battaglia di Dogali entrano nell’odonomastica le denominazioni via o piazza
dei cinquecento o dei cinquecento martiri, a memoria dei soldati caduti. È possibile
ipotizzare che tale scelta intitolatoria andasse in un senso antididascalico, in quanto
solo evocativa di un’impresa infausta che non venne quasi mai esplicitata attraverso il
28San Severino Marche (MC), lapide apposta in occasione del cinquantesimo anniversario dell’unità (1911) sulla facciata del palazzo comunale. 29 A Macerata, nel 1888, fu affissa alla facciata del palazzo comunale una lapide che recitava: «La cieca immobilità del papato contro cui ragionando insorgesti o frate Giordano Bruno te ancora paventa dopo tre secoli che ti bruciò sul rogo ma l’Italia da te antico riscossa alla nova libertà di pensiero centuplica per le sue terre il degno monumento che indarno conteso ti starà a Campo de’ Fiori». Nella stessa occasione fu intitolata a Giordano Bruno la centrale via del commercio. Si veda la deliberazione del Consiglio comunale di Macerata del 21 giugno 1888, in Archivio di Stato MC, Fondo Archivio antico del Comune di Macerata, Busta 590. 30 Ciò avviene a partire dalla rilettura in chiave nazionalistica del libro VI dell’Inferno.
11
nome della battaglia perché controproducente nella costruzione di un’idea di nazione
conquistatrice31.
È altrettanto importante notare come le differenti correnti politiche interne alle
amministrazioni locali abbiano determinato le scelte intitolatorie: è il caso di Giuseppe
Mazzini, assunto nel pantheon dei medaglioni risorgimentali solo alla fine del secolo e
spesso relegato, per il suo repubblicanesimo, in posizione defilata e non centrale nelle
mappe cittadine.
La prima guerra mondiale e il fascismo
Il Novecento segna una svolta nelle procedure odonomastiche: da un intento
prettamente pedagogico e memorialistico si passa a una ideologizzazione32 nelle
intitolazioni, che assumono una decisa connotazione politica via via che si intensificano
le istanze irredentistiche e la diatriba tra interventisti e non interventismi precedente
alla Grande Guerra.
Entrano nel tessuto stradale Trento e Trieste, Guglielmo Oberdan e Cesare Battisti e,
soprattutto, il susseguirsi degli eventi bellici è scandito da intitolazioni,che avvengono
quasi in tempo reale, che segnano le tappe vittoriose dell’esercito italiano e i loro
protagonisti: i nomi dei fiumi Piave e Isonzo che compaiono negli stradari di buona
parte delle città italiane esulano dalla connotazione geografica e ricordano, invece, gli
spostamenti del fronte, così come il Carso o Gorizia, Zara e la Dalmazia.
Ma la caratteristica che il primo conflitto mondiale introduce nell’odonomastica è la
collettivizzazione del culto dei morti. Collettivizzazione intesa sia dal punto di vista dei
celebranti che dei celebrati: infatti, la dimensione di massa del conflitto e il numero
maggiore di morti rispetto alle guerre risorgimentali aveva fatto sì che praticamente
ogni famiglia italiana vivesse il lutto per un congiunto caduto al fronte. L’elaborazione
di tale dolore aveva bisogno di riti collettivi e cittadini, i quali rendessero tutti partecipi
del sacrificio e accomunassero le vittime, impossibili da rievocare per nome sia a causa
del numero sia a causa della tecnologizzazione della guerra, che spesso rendeva
irriconoscibili o irrintracciabili i singoli cadaveri33.
Ciò si esplicita nelle intitolazioni ai ragazzi del ’99 o ai caduti del Piave, che
sostituiscono il nome del singolo eroe, locale o nazionale, tipico del periodo
31 Anticipiamo rispetto alla disamina storica che il fascismo, nel periodo delle conquiste coloniali, eliminò moltissime vie dedicate ai caduti di Dogali, proprio con l’intento di cancellare il ricordo della sconfitta. 32 Si veda a tal proposito S. Raffaelli, I nomi delle vie, cit. 33 M. Isnenghi, Il mito della Grande guerra, Il Mulino, Bologna 1989.
12
risorgimentale o postunitario. Inizia a porsi anche il problema dell’ideologizzazione del
lessico della morte, che prosegue fino ai nostri giorni: l’uso del neutro ‘morti’ è, di fatto,
sempre sostituito da sostantivi connotati. Molto utilizzato è il termine ‘martiri’, che
unisce l’elemento della volontarietà del sacrificio – necessario da sottolineare in una
chiamata alle armi in realtà imposta e subita dalle classi subalterne, che pagarono il più
alto tributo ad una guerra non voluta o almeno non compresa e lontana – a una
dimensione quasi religiosa. La parola ‘caduti’ invece, propria della semantica bellica,
allontana attraverso l’uso dell’eufemismo la crudità della morte e la riconduce in una
sorta di orizzonte di dovere del soldato nei confronti della patria. Meno ricorrente è
invece ‘vittime’, che pone l’accento sull’innocenza e sull’estraneità della morte, che avrà,
invece, grande fortuna nelle intitolazioni afferenti la seconda guerra mondiale, i
totalitarismi e i relativi eccidi34.
Tutto l’apparato memoriale allestito nel corso e subito dopo la grande guerra fu ripreso
dal fascismo, che trovò nella città uno dei più potenti mezzi di propaganda e di
consolidamento del proprio consenso. Come tutte le dittature, l’appropriazione degli
spazi pubblici attraverso marcature ideologiche che ne riscrivessero la storia in
funzione celebrativa del regime, fu programmatica nella politica di fascistizzazione
delle masse messa in atto da Mussolini fin dai primi anni di potere.
Le città, infatti, diventano veri e propri teatri entro i quali celebrare i fasti presenti del
fascismo, ma anche fondali di una storia nazionale volta all’esaltazione della Nazione
attraverso i suoi eroi. Il Duce avvia opere pubbliche imponenti con l’intenzione di
cambiare il volto alle città e al territorio: dagli sventramenti di interi quartieri alle città
di fondazione, l’urbanistica deve concorrere all’autocelebrazione, alla spinta verso il
rinnovamento, controbilanciata, però, da scelte architettoniche con forti richiami
all’antico; spesso i lavori coincidono con le visite ufficiali dello stesso Mussolini, per il
quale si apprestano vere e proprie quinte sceniche ristrutturando i centri urbani
interessati. È il caso, a livello locale, della città di Corridonia, così battezzata in
occasione della visita del Duce del 24 ottobre 1936: per l’occasione il centro medievale
fu completamente cancellato e venne costruita la piazza in stile metafisico –
razionalista studiata per fare da contesto alla statua all’eroe locale Filippo Corridoni,
sindacalista amico dello stesso Mussolini, morto sul Carso e assunto nel pantheon dei
martiri fascisti, in onore del quale fu anche modificato il nome dello stesso paese che gli
aveva dato i natali, da Pausula in Corridonia.
34 Sull’argomento si vedano Oliver Janz e Lutz Klinkhammer (a cura di) La morte per la patria. La celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica, Donzelli, Roma 2008.
13
L’odonomastica non è ovviamente esclusa da questo programma politico e ideologico:
dare il nome alle cose è, infatti, un modo di ribadire l’autorità su di esse, di ricrearle
sottraendole al passato e rinconducendole entro il proprio universo valoriale.
È proprio del periodo fascista la prima legge organica dedicata all’odonomastica: essa
viene regolata prima con il decreto legge n. 1158 del 1923, che per iniziativa del
ministero della Pubblica istruzione «dettava norme per i mutamenti del nome delle
vecchie strade e piazze comunali»35, successivamente convertito nella legge n. 1188 del
1927, che ancora oggi disciplina le intitolazioni delle strade.
Con la legge 1188sono introdotte la necessità dell’autorizzazione prefettizia, a
limitazione dell’iniziativa dei comuni, e la norma che vieta l’intitolazione a personaggi
morti da meno di dieci anni, con alcune deroghe per i membri della famiglia reale e per
individui benemeriti per la causa nazionale o caduti per la patria.
Inoltre, il filosofo e ministro dell’Istruzione Giovanni Gentile vuole che per ogni nuova
intitolazione sia sentito il parere delle locali deputazioni di storia patria o società
storiche, per evitare anacronismi e attribuzioni di nomi assolutamente slegati rispetto
al contesto e conferire dignità storica alla scelta odonomastica36.
Nel contempo vengono emanate, a volte direttamente da Benito Mussolini, ulteriori
circolari e disposizioni relative all’odonomastica: per fermare lo zelo intitolativo di
molte amministrazioni che intendono dedicare vie al Duce, il quale, non gradendo tale
omaggio (pare, per motivi scaramantici), indica di sostituirle con la data della marcia su
Roma;per ripristinare o cancellare nomi graditi o meno alla chiesa dopo i patti
Lateranensi (il primo a farne le spese è proprio il già ricordato Giordano Bruno, che
perde quasi tutte le intitolazioni);per orientare alcune scelte, come quella che dal 1932
impone a ogni comune italiano di avere una strada intitolata alla capitale, o quelle degli
anni Quaranta per espellere gli ebrei dalla toponomastica o italianizzare alcuni odonimi
delle regioni di confine e non solo: non si salva alla xenofobia linguistica neppure
Sidney Sonnino, che a causa del nome anglofono (forse, unitamente al fatto che fosse di
origine ebrea) perde le vie a lui dedicate.
Resistenza, RSI e Repubblica
L’armistizio dell’otto settembre, oltre a dividere l’Italia in due sul piano bellico e
politico, lo fa anche a livello odonomastico. Infatti, mentre nel Regno del sud si procede
alla semplice cancellazione dei nomi più direttamente riferiti all’appena caduto regime
35 S. Raffaelli, I nomi delle vie, cit. 36 S. Raffaelli, Il primo dopoguerra e il ventennio fascista, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l’Umbria», vol. CI, fasc. II, pp. 155 – 173.
14
e alla loro sostituzione con nomi della casa reale, i territori del centro-nord subiscono
modifiche successive, indicative del complicato e movimentato momento storico. Già
nei pochi giorni che intercorrono tra la caduta del fascismo del 25 luglio e l’occupazione
tedesca iniziano le revisioni da parte delle amministrazioni comunali che si affrettarono
ad espellere dagli stradari i nomi di stampo fascista. L’avvento della Repubblica di Salò,
però, frena le reintitolazioni di matrice antifascista o libertaria. La damnatio memoriae
colpisce innanzitutto i membri di casa Savoia, in particolare l’attuale re, colpevoli di
tradimento, e i gerarchi fascisti, rei di aver determinato la caduta del Duce, coi loro
familiari, come succede, ad esempio, al padre di Galeazzo Ciano, Costanzo. Nella
rappresentazione della nuova Repubblica Sociale devono inoltre entrare i recenti eroi
della seconda guerra mondiale, ma anche i capisaldi della prima rivoluzione fascista, a
richiamo degli ideali dimenticati.
La liberazione porta con sé una circolare del primo ministro della Pubblica istruzione, il
giurista Arangio Ruiz, che, conscio dell’accelerazione e delle sovrapposizioni che si
erano succedute nei passaggi storici precorsi, invita a ripristinare i nomi delle vie
precedenti al 1922, a sospendere la cancellazione dei nomi di casa Savoia fino a che non
sia definito il nuovo assetto istituzionale e a dare sempre comunicazione al ministero
stesso dei mutamenti in atto. In effetti,le giunte del Comitato di Liberazione Nazionale
stanno procedendo con grande celerità all’unica epurazione che è stata effettivamente
attuata in Italia, quella odonomastica, a favore di personaggi esemplari
dell’antifascismo e della Resistenza, Gramsci e Matteotti primi tra tutti37.
Le amministrazioni comunali della nuova Repubblica italiana, dopo il 2 giugno 1946, si
adeguano invece anche nell’odonomastica al clima di pacificazione oramai prevalenti
nel Paese: i riferimenti alla Resistenza, infatti,diminuiscono a favore di intitolazioni, sul
modello francese, a concetti astratti,ad essa non così esplicitamente riconducibili. Si
preferisce libertà o Italia libera a liberazione, e si ritorna al vasto patrimonio del
Risorgimento, a cui la Resistenza idealmente si riallaccia, per celebrare la riconquista
dell’indipendenza e della sovranità.
Dopo le elezioni del 1948, ma soprattutto negli anni Cinquanta, con il definirsi della
contrapposizione tra i due blocchi a livello internazionale e il conseguente
schieramento della maggioranza e dell’opposizione italiane, l’odonomastica diviene
terreno di scontro ideologico e il colore delle giunte al potere ne influenza
pesantemente le scelte fino a tutti gli anni Settanta.
37 R. Ridolfi, La transizione democratica e la nascita della repubblica, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l’Umbria», n. CI, fascicolo II, pp. 175 – 201.
15
Tendenze odonomastiche attuali
Ben più interessante dell’ovvio repertorio delle vie rosse o bianche – che riportano in
auge da un lato la memoria della Resistenza, dall’altro l’uso di intitolazioni di stampo
ecclesiastico – è osservare come la contemporaneità, sul piano odonomastico, viaggi tra
i due estremi del disimpegno e dell’uso pubblico strumentalizzato.
Terminata negli anni Ottanta l’epoca delle forti contrapposizioni politiche interne,
anche le scelte odonomastiche risentono del riflusso: infatti, i sindaci, per evitare
lunghe diatribe in seno ai consigli comunali, ripiegano su scelte neutre, appiattite su
stereotipi politici o culturali ‘ecumenici’, che non possano essere contestati né fatti
propri da nessuna fazione politica, pescando spesso nel catalogo straniero (Kennedy,
Martin Luther King) oppure ricorrendo alle cosiddette vie seriali38.
L’uso della serialità nelle intitolazioni prende piede contestualmente al boom edilizio
degli anni Settanta-Ottanta, quando sorgono interi quartieri, di solito periferici o in
zone precedentemente rurali, e di conseguenza si presenta l’esigenza di dare il nome a
molte nuove vie. Scegliere la serialità ha due vantaggi: da una parte offre un repertorio
che può essere aumentato per accumulo in qualsiasi momento, nel caso in cui l’abitato
si estenda, dall’altra non ha connotazioni politiche e ideologiche e si presta alla
neutralizzazione dell’atto pubblico dell’intitolazione. In genere si scelgono nomi di fiori,
di colori, oppure l’infinita gamma di nomi geografici o naturalistici, che provocano
situazioni di assoluta estraneità tra il luogo e il nome giungendo a esiti ai limiti
dell’assurdo.
È il caso di molte cittadine costiere, dove si è iniziato a intitolare con i nomi dei mari
italiani e si è proseguito, man mano che nuove strade nascevano, con mari lontanissimi
e assolutamente alieni alla realtà di riferimento. Si producono anche piccole
aberrazioni, come nel caso della cittadina laziale di Torvajanica, dove i nomi dei pesci
del Mediterraneo non sono stati sufficienti per colmare la recente esplosione edilizia e
si è arrivati ad avere un lungomare delle meduse, di certo non invitante per un sito a
vocazione balneare. La frazione Sant’Egidio di Perugia, non lontana dall’aeroporto, ma
in un’amena posizione sulle verdi colline umbre, ha una serie di vie denominate via
elica, via aliante, via astronauta, via mongolfiera, via radar, via aerostato, fino
all’escatologica via Dedalo. A Novasiri, in provincia di Matera, una serie di traverse del
lungomare sono intitolate a film di Federico Fellini (cosa che sarebbe alquanto
giustificata a Rimini, meno vicina alle spiagge della Magna Grecia):vi troviamo via la
strada (che sembra una tautologia), via luci del varietà, via amarcord, piazzetta la
38 C. A. Maestrelli, Aspetti storico – linguistici della odonomastica, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l’Umbria», n. CI, fasc. II, pp. 61 – 73.
16
dolce vita, via la voce della luna,via Giulietta degli spiriti, via tre passi nel delirio, che
forse è la sintesi perfetta dell’operazione odonomastica messa in atto.
Accanto alla scelta del disimpegno, la contemporaneità ci restituisce tuttavia anche
modelli di rinnovata strumentalizzazione dell’odonomastica, con fini di vero e proprio
abuso pubblico della storia39.
La cosiddetta “seconda repubblica” esordisce con un esempio eloquente: una delle
prime interrogazioni parlamentari prodotte dalla allora Lega lombarda, a nome di
Umberto Bossi e Roberto Castelli, propone di abolire il necessario placet delle
prefetture e il parere delle deputazioni di storia patria nella legislazione odonomastica
in vigore40 al fine di permettere l’uso, nei comuni controllati dallo stesso partito, di una
toponomastica dialettale41. Lo scontro prosegue negli anni su un piano di bassa
ideologia, con tentativi di improbabile par condicio odonomastica che controbilancia
una intitolazione a Pasolini con una a Ezra Pound. Un esempio di cerchiobottismo
politico ci viene dal comune di Codogno, in provincia di Lodi, dove nel 2000 la nuova
amministrazione di centrodestra propone di intitolare una strada a Sergio Ramelli, un
giovane militante neofascista milanese ucciso nel 1975 da due esponenti di Avanguardia
operaia. La prefettura, sentita la società storica lombarda, si oppone alla decisione per
motivi di inopportunità, ma il sindaco, anziché ritirare la proposta, rilancia
programmando di intitolare un’altra strada a Claudio Varalli, diciassettenne studente di
sinistra ucciso dai fascisti sempre nel 1975. Nonostante la reiterazione del parere
sfavorevole del prefetto, che consiglia di evitare il caso politico, la doppia intitolazione
viene effettuata grazie a una sentenza del TAR che si appella all’autonomia
amministrativa prevista dalla legge Bassanini, in nome di una sorta di pareggio dei
morti tra le opposte fazioni42.
L’appropriazione della storia da parte di amministrazioni ideologizzate e la sua messa
in discorso nelle vie cittadine è un fenomeno che attraversa tutto il Paese nel ventennio
berlusconiano, in cui si risveglia una contrapposizione ideologica spesso banalizzata e
fondata su false mitologie e su una distorsione e semplificazione delle categorie
storiche. È esemplare il caso delle molte intitolazioni ai morti nelle foibe istriano-
dalmate, seguite all’istituzione del Giorno del ricordo, anch’esso risarcimento e
39 A. Giannuli, L’abuso pubblico della storia. Come e perché il potere politico falsifica il passato,Parma 2009 40 La già citata legge fascista n. 1188 del 1927. 41 A. Bonomi, P.P. Poggio, a cura di, Ethnos e Demos. Dal leghismo al neopopulismo, Mimesis, Milano 1995. 42 Si veda a tal proposito il riassunto della vicenda sul «Corriere della Sera» del 6 febbraio 2001 a firma di Diego Scotti.
17
bilanciamento verso destra della Giornata della memoria43. Ricompare, nelle
lunghissime discussioni delle delibere per l’intitolazione, la diatriba sulla scelta del
sostantivo:‘martiri’ o ‘vittime’ a seconda della connotazione strumentale che si intende
dare.
Altri esempi riguardano lo sdoganamento di molti nomi fascisti utilizzati per
intitolazioni, da Bottai a Italo Balbo, ad Almirante, ai caduti della Repubblica Sociale
titolari di una strada a Rovato, in provincia di Brescia, dal 2006. Ancora più segnata da
ideologismo è la scelta inversa, quella della cancellazione e della sostituzione degli
odonimi, che comporta anche dei costi per le amministrazioni e delle problematiche di
tipo logistico: la Lega nel 2009 toglie l’intitolazione della biblioteca a Peppino
Impastato perché ritenuto avulso dalla realtà locale, mentre il sindaco del PdL di
Pecorara, in provincia di Piacenza, suscita nel 2010 una sollevazione nazionale
proponendo di eliminare piazza XXV aprile.
Anche il revisionismo storico coinvolge l’odonomastica: nel corso dell’anno delle
celebrazioni risorgimentali abbiamo avuto una via di Sciacca intitolata a Maria Sofia di
Borbone e a Castelvetrano una piazza e una via intitolate a Francesco II e alla regina
consorte.
Risemantizzazioni
A conclusione di questa panoramica sulla storia e sull’uso pubblico e politico
dell’odonomastica è opportuno introdurre il discorso della risignificazione che molti
odonimi oggi hanno subito nella nostra percezione e nel sentire comune.
Fin dall’introduzione di una vera e propria politica odonomastica, che come abbiamo
visto risale alla Rivoluzione francese e in Italia al Risorgimento, il nome della via è stato
investito di una vera e propria modificazione della sua funzione d’uso originaria, quella
dell’indicazione spaziale, per assumere significati simbolici e finalità pedagogiche,
memorialistiche, propagandistiche, ideologico-politiche, comunque strumentali al
potere costituito.
Ma la risemantizzazione può avvenire anche per processi spontanei, legati
all’immaginario collettivo e alla forte connotazione che i luoghi assumono quando sono
associati a fatti storici o politici fondanti la nostra identità di nazione e di popolo, tanto
da diventare delle vere metonimie che trasferiscono il significato sul segno, ovvero
sull’odonimo. È il caso per esempio di piazzale Loreto, il cui nome perde
completamente la sua connotazione geografica e diventa evocativo di un sentimento di
43 G. De Luna, La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Feltrinelli, Milano 2011.
18
rivalsa (o vendetta, a seconda delle letture ideologiche) legato a un preciso evento
storico44.
Stesso processo di risignificazione lo hanno subito i teatri di alcuni eventi luttuosi nella
storia della nostra Repubblica: piazza Fontana o piazza della Loggia sono simboli delle
cosiddette stragi di stato, via delle Botteghe Oscure evoca un momento e una storia
politica oggi tramontati.
Infine, occorre mettere in evidenza il processo di intitolazione dal basso, che avviene
quando il popolo si vuole appropriare di un luogo per non perdere la memoria
dell’evento in esso successo. A Milano abbiamo la reintitolazione “abusiva” di via
Mancinelli in via Fausto e Iaio, con tanto di lapide apposta e imbullonata con ganci di
acciaio, a memoria dei due giovani autonomi del Leoncavallo Fausto Tinelli e Lorenzo
Iannucci, uccisi dai fascisti nel 1978, così come a Genova l’odonimo piazzaAlimonda è
stato cancellato e riscritto in piazza Carlo Giuliani, a memoria del giovane ucciso dai
Carabinieri durante le manifestazioni contro il G8 del 2001. Si tratta di fenomeni di
ritorno a un’odonomastica dal basso, spontaneamente attribuita come quella di età
preunitaria, ma portatrice della stessa funzione ideologica, politica e memoriale di cui
oramai i procedimenti di intitolazione sono inevitabili portatori, siano essi espressione
del potere costituito o della libera iniziativa popolare.
Il Risorgimento è solo l’inizio della risignificazione e della riscrittura degli spazi
pubblici con finalità propagandistiche, memoriali, politiche. Infatti la messa in discorso
della storia per le strade delle città avrà esiti interessanti sul piano della affermazione
del potere in età fascista e come testimonianza di rinnovamento e cambiamento a
partire dalla Liberazione e con l’avvento della Repubblica. Fino ai giorni nostri la
questione del conferire un nome e di conseguenza un significato altro, rispetto alla
semplice funzione d’uso di indicarne la posizione sulla mappa, allo spazio urbano si
44 Piazzale Loreto fu teatro il 10 agosto 1944, prima dell’esposizione del corpo del Duce in seguito all’esecuzione di Dongo, di un eccidio di partigiani impiccati e lasciati esposti per giorni da parte della legione Ettore Muti. Dopo la rimozione dei cadaveri, una mano ignota affisse la dicitura ‘piazza quindici martiri’ a memoria della strage. Per ritorsione e sfregio la piazza fu reintitolata dalla Repubblica sociale piazza Ettore Muti. Dopo la liberazione, per un giorno, essa fu ufficialmente piazzale dei quindici martiri, ma tornò subito all’antica denominazione, forse primo esempio di rimozione di una memoria scomoda in nome della pacificazione. Parte della storia è narrata in S. Raffaelli, I nomi delle vie, cit., la ricostruzione intera è invece affidata a fonti orali indirette.