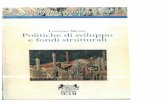Una Matrice per le Politiche Pubbliche
Transcript of Una Matrice per le Politiche Pubbliche
Danilo Taglietti
1
UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
a Pubblica Amministrazione italiana versa in condizioni sempre più critiche, mentre il dibattito sulla riforma dello Stato si basa spesso sulla riproposizione di formule già
utilizzate altrove, senza considerare che, seppure meglio attrezzati, anche gli altri Paesi vivono problematiche radicali. L’intenzione è quella di proporre un punto di osservazione globale differente, fondato non sul piano della politics ma su quello della policy. Andando in profondità nella crisi della forma organizzativa dello Stato Amministrativo, se ne rintracceranno le cause nella costituzione della società e nelle sue dinamiche interne di mutamento. Il tentativo sarà quello di costruire uno strumento interpretativo utile e flessibile: una matrice per le politiche pubbliche. Si vedranno poi alcune sue possibili applicazioni in relazione all’attuale dibattito tra formule alternative di governance, entrando nel merito delle teorie su Experimentalist e Democratic Governance.
he conditions of the Italian Public Administration are becoming everyday more critical. The current debate on the reform of the State is often based on solutions that have
already been implemented in other countries, not considering that these countries, even if more prepared, are facing similar problems. The main intention is to propose a different global point of view, based on policy rather than politics. If we analyse deeply the crisis that concerns the Administrative State, it is possible to spot the reasons in the constitution of society and in its continuous internal changes. We will try to figure out an useful and flexible interpretation tool: a matrix for policies. We will discuss several potential applications related to the current debate about alternative forms of governance and, finally, we will point our attention to Experimentalist and Democratic Governance. Keywords: Structuration Theory; Neoinstitutionalism; Experimentalist Governance; Democratic Governance; Matrix for Policies.
LA RIFORMA IMPOSSIBILE
<<Ci sono pazzi che credono di essere Napoleone e pazzi che credono di poter risanare le Ferrovie dello Stato>>: la pungente ironia di Giulio Andreotti sintetizza verità bibliche. Considerata la profusione di commissioni di saggi recentemente istituite per la riforma dello Stato, oggi, la massima del Divo può ragionevolmente riferirsi a tutta la macchina pubblica italiana. L’insoddisfazione verso il funzionamento della Pubblica Amministrazione data fin dal 1916 [Sepe 2007] ed è antico quanto il sarcasmo nel commentare i fallimenti dei vari tentativi di riforma [Cagli 1918]. Oggi, pur dopo un trentennio di <<riformismo permanente>> [Capano 2006, p. 36], la qualità della governance amministrativa italiana risulta la più scadente tra i paesi OECD [D’Autilia et al. 2009]: liberalizzazioni orientate al compromesso politico [Di Porto e Silva 2005] e che hanno favorito la nascita di oligopoli privati [Bertoli 2007], un sistema universitario soffocato [Turri 2011], un sistema sanitario <<in mezzo al guado>> [Toth 2006, p. 228]: il buongoverno non risiede in Italia. Vi è chi ha individuato una relazione tra buongoverno e politiche pubbliche [Cassese 2013] e chi ha evidenziato come l’assenza di una prospettiva di policy nelle istituzioni e nel dibattito culturale sia la causa prima dell’incapacità amministrativa del Belpaese [Regonini 2012a; 2012b].
L
T
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
2
Seppur l’Italia rappresenti un <<benchmark negativo>> [Regonini 2012b, p. 76] assoluto, guardare altrove non aiuta moltissimo. Pre-legislative advice e legislative oversight sono pratiche che, ove istituzionalizzate, incidono significativamente nel rendere l’azione pubblica più efficace ed efficiente. Eppure, la trentennale <<pandemia di riforme del management pubblico in gran parte dei Paesi dell’OECD>> [Pollitt e Bouckaert 2000, p. XVII] <<con l’obiettivo di fare in modo che funzionino meglio>> [ibidem, p. 4] autorizza a pensare che i malfunzionamenti degli apparati amministrativi siano cosa diffusa. Anche dopo le riforme, poi, i risultati finali sono spesso difficili da identificare con sicurezza. Procedendo in analisi comparate, non è possibile affermare che le riforme producano inequivocabilmente risparmi, né aumenti di produttività o di outcome per i clienti, né che i servizi forniti da privati siano migliori di quelli pubblici o che vi siano stati incrementi della fiducia nel sistema [ibidem]. La percezione dei cambiamenti dipende sempre più da chi dà le risposte, risente di fattori politici e psicologici e rende la soddisfazione un obiettivo mobile. Forse il problema non è nell’organizzazione dello Stato, ma nell’organizzazione-Stato: una formula organizzativa emersa, a partire dal Medioevo, quale contenitore di potere [Giddens 1984] ed il cui sviluppo, in seno a quelle che erano le zone più potenti del globo, ha condizionato la creazione, affatto naturale, di un sistema mondiale stato-centrico [Tilly 1975; March e Olsen 1995]. Se, da un lato, lo Stato nacque come <<un’organizzazione di controllo dei principali mezzi di coercizione all’interno di un certo territorio>> [Tilly 1975, p. 469] è d’altro canto vero che, in esso, dopo le prime forze centrifughe, di tipo coercitivo ed unificativo, si sono sviluppate anche forze centripete, redistributive e partecipative [Rokkan 1975]. Se, per tutto il periodo in cui hanno dominato le spinte centro-periferia, lo Stato si imponeva ai propri cittadini come unica organizzazione sovra-ordinata possibile, già con il comparire delle prime spinte opposte il potere centrale si è trovato nella necessità di utilizzare nuovi strumenti di adesione: <<l’esaltazione dell’identità politica nazionale fu lo strumento con cui si affermò lo stato nazionale […] La coscienza nazionale fu costruita socialmente.>> [March e Olsen 1995, p. 71] Se è quasi certamente prematuro parlare della fine dello Stato nazionale [Mann 1993], <<è indubbio che l’ordine politico contemporaneo basato su tale unità politica stia attraversando un momento di crisi>> [March e Olsen 1995, p. 87]: con il prevalere delle spinte periferia-centro, il meccanismo che era al cuore di quello strumento si svincola dal suo utilizzo, rendendo l’adesione nazionalistica una vera e propria scelta e la solidarietà verso lo Stato una possibilità, in competizione con altre solidarietà più inclusive [Habermas 1992]. I confini mobili della soddisfazione, quindi, potrebbero configurarsi come il segno di una realtà in cui tutti i punti di vista paiono parimenti legittimi, dando luogo a strategie di comportamento di exit and voice [Hirschman 1970] che caratterizzano le opzioni di risposta del cittadino dinanzi a ciò che gli viene proposto dall’organizzazione statale cui temporaneamente appartiene.
UN PUNTO D’OSSERVAZIONE
Dopo la fine delle grandi narrazioni del Novecento [Habermas 1996], la de-ideologizzazione della società rende potenzialmente secondario il piano della politics rispetto a quello della policy, almeno nell’analisi delle questioni inerenti il governo della società stessa [Easton 1953]. Tutto ciò che concerne l’azione della e nella società può essere osservato, descritto, esplicato e sintetizzato in modo generalizzato in una prospettiva di politiche pubbliche: intrinsecamente imparziale, non-partigiana [Lasswell 1951; Regonini 2012a], strumentale e pragmatica. Sostenere che la prospettiva
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
3
della politica non sia poi così rilevante non è certo un punto di vista nuovo [Hirschman 1991; March 1988; March e Olsen 1995] ed è anzi piuttosto comune, laddove ci si concentri sulla nyāya invece che sulla nīti [Sen 2009], interessandosi meno delle hard-institutions e più dei comportamenti effettivi delle persone. In tal senso, <<la politica pubblica è […] un’astrazione […] Sono gli schemi di comportamento a costituire una politica pubblica.>> [Salisbury 1968, p. 23] In quest’ottica, non è possibile fare alcun ragionamento sulle politiche pubbliche senza aver prima messo a fuoco il funzionamento della società stessa. Abbandonando le visioni funzionalistiche di Parsons e sfruttando appieno le novità introdotte dalla rivoluzione cognitivista degli anni ’70, ci avvaliamo della Teoria della Strutturazione [Giddens 1984] per la costruzione di un vocabolario di base dell’azione umana: le attività sociali possono essere considerate come un flusso di pratiche ricorsive routinizzate, finalizzate alla minimizzazione dell’ansia e riproducenti continuamente le stesse condizioni che le hanno generate. Ciò presuppone l’esistenza di un continuo monitoraggio del flusso stesso da parte dell’essere umano: la capacità riflessiva. In ogni interazione sociale, gli attori vengono coinvolti nel processo di strutturazione, ovvero nella ri-produzione dei princìpi strutturali che sono a fondamento delle pratiche: regole e risorse che fungono da modello paradigmatico. Poiché regole e risorse sono anche i mezzi attraverso i quali i medesimi princìpi si riproducono, la struttura è duale: risulta sempre abilitante e vincolante. Analiticamente, i processi di strutturazione avvengono in tre ambiti: Significazione, Dominio e Legittimazione. Quando le persone si incontrano, lo fanno in momenti (temporali) localizzati (geograficamente), creando le situazioni di compresenza in cui si attua il processo di strutturazione ed avviene l’integrazione sociale. In questa visione, le istituzioni, lungi dall’essere burocrazie sostantive, sono viste come delle pratiche standardizzate: un insieme di princìpi strutturali particolarmente diffusi, che sopravvivono grazie a procedure riproduttive routinarie, almeno finché eventuali contraddizioni con altre istituzioni non distruggano il processo. Anche altri hanno condiviso questa visione, giungendo a definire le società come dei sistemi inter-istituzionali potenzialmente contraddittori [Friedland e Alford 1991]. Focalizzando l’attenzione sul concetto di azione umana, sia Giddens che Friedland e Alford qualificano e sostanziano l’azione nel fare la differenza. Per il sociologo inglese azione è tutto ciò di cui l’attore è anche autore, nel senso che l’azione è ciò che collega l’attore con le conseguenze volute dei propri comportamenti: il fine di questa specificazione è il voler porre in essere una relazione diretta e stabile tra azione e potere, inteso come capacità di fare la differenza e facendolo così divenire connaturato ad ogni azione. Friedland e Alford, invece, inglobano il senso di fare la differenza direttamente nell’essenza di azione: se agire è ciò che fa la differenza, allora si compie un’azione solo quando si decide di non conformarsi ad una pratica routinaria posta a fondamento della riproduzione istituzionale. Le due concezioni paiono l’una la specificazione dell’altra: se agire è fare la differenza, allora si agisce solo quando si decide di non seguire una routine e, quindi, ogni azione si conferma dotata di potere. Nel processo di strutturazione, cattura immediatamente l’attenzione la nolontà di Giddens di indagare le relazioni tra le tre dimensioni della struttura: Significazione, Legittimazione e Dominio vengono presentate come solo analiticamente separabili e devono essere sempre concepite in una sorta di sincronicità. Nelle proprie formulazioni, il sociologo inglese appare preoccupato soprattutto dal confutare quelle concezioni, di stampo neo-marxista, che ipotizzano la possibilità di trascendere il Dominio in una più o meno lontana società ideale. Così facendo, però, a nostro avviso, si giunge ad esagerare l’importanza conferita al Dominio stesso, contemporaneamente marginalizzando il potere rispetto alle intenzioni precedentemente manifestate. Se, da un lato, per l’esperienza stessa che noi abbiamo della realtà, il Dominio è ad essa intimamente connaturato; d’altro canto, ciò non significa che esso debba anche essere considerato de facto come la condizione dell’esistenza stessa dell’intera strutturazione. Senza speculare sulle loro relazioni, Significazione,
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
4
Legittimazione e Dominio vengono concepiti come tre princìpi paritetici e la strutturazione si presenta come una seriazione lineare in cui le variazioni possono essere dettate solamente dalla prevalenza quantitativa di un princìpio sugli altri. Seppur anche solo dal punto di vista analitico, poniamo di voler indagare le relazioni tra le tre dimensioni della struttura. Per farlo, partiamo dalla definizione di azione, come sopra ricavata. Se azione è la decisione di non seguire una routine (e, quindi, azione contiene potere), significa che: in presenza di una seriazione della strutturazione D – S – L (istituzione politica A); (1) un attore agisce solo se opta per una seriazione D’ – S’ – L’ (istituzione politica B); (2)
oppure, ad esempio, per una seriazione S’’ – D’’ – L’’ (ordine simbolico). (3)
Se i principi strutturali e gli ordini istituzionali operano in collaborazione e contraddizione tra loro [Friedland e Alford 1991], tra due seriazioni della strutturazione deve esservi una sorta di equilibrio dinamico, mutevole e variabile. Guardando nel dettaglio alle relazioni intraseriazione, facendo riferimento allo schema delle dimensioni della dualità della struttura [Giddens 1984, p. 31]:
L è formalizzabile come una relazione tra il coefficiente di legittimazione l e la Sanzione di
L SAL:
L = l SAL , con 0 < l ≤ 1 (4)
D, invece, è formalizzabile come una relazione tra il coefficiente di dominio d e il Potere di
D PD:
D = d PD , con 0 < d ≤ 1 (5)
allo stesso modo, S è riscrivibile come una relazione tra il coefficiente di significazione s e
la Comunicazione di S CS:
S = s CS , con 0 < s ≤ 1 (6)
Ma, sia intuitivamente che empiricamente, è possibile dire che qualsiasi Sanzione dipende sempre da un certo ordine di potere (e, quindi, dal Dominio), con il quale è in rapporto di proporzionalità diretta piuttosto rigido, del tipo:
SAL = l D , con 0 < l ≤ 1 (7)
La (4), pertanto, è riscrivibile come:
L = l2 D , con 0 < l ≤ 1 (8)
le stesse relazioni, poi, valgono anche per L’, D’ ed S’:
L’ = l2 D’ , con 0 < l ≤ 1 (9)
D’ = d PD’ , con 0 < d ≤ 1 (10)
S’ = s CS’ , con 0 < s ≤ 1 (11)
A seguito di queste riscritture, la (1) può essere formalizzata come:
D + S + L = D + S + l2 D = (1+ l2) D + S (12)
e la (2) come:
D’ + S’ + L’ = D’ + S’ + l2 D’ = (1+ l2) D’ + S’ (13)
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
5
Per comodità di scrittura, inoltre, possiamo porre:
1+ l2 = n , con 1 < n ≤ 2 (14)
in cui n assolve alla funzione di coefficiente moltiplicatore del Dominio legittimato. Quindi, la (12)
diventa:
n D + S (15)
e la (13):
n D’ + S’ (16)
Passando ad analizzare i rapporti interseriazione, la (1) è riscrivibile come:
n D + S = a , con 0 < a < +∞ (17)
ove a è il parametro che rappresenta l’istituzione A; e la (2) come:
n D’ + S’ = b , con 0 < b < +∞ (18)
ove b è il parametro che rappresenta l’istituzione B; allora, nel momento in cui dobbiamo riproporre la situazione di scelta tra due istituzioni differenti, avremo anche che: a + b = k , con 0 < k < +∞ (19) ove k è il parametro di equilibrio dinamico tra le due seriazioni. Possiamo riscrivere la (19) come:
n D + S + n D’ + S’ = k (20)
e, riordinando:
n (D + D’) + (S + S’) = k (21)
L’espressione D + D’, in virtù della (5) e della (10), può essere riscritta così:
D + D’ = d PD + d PD’ (22)
il cui risultato non può che essere:
D + D’ = d PD + d PD’ = d PTOT , con 0 < PTOT < +∞ (23)
ove PTOT, nell’ambiente limitato di un sistema a 2 seriazioni, rappresenta il valore parametrico costante del Potere Totale. Seguendo il medesimo procedimento, anche l’espressione S + S’, in virtù della (6) e della (11), può essere riscritta come:
S + S’ = s CS + s CS’ (24)
il cui risultato non può che essere:
S + S’ = s CS + s CS’ = s CTOT , con 0 < CTOT < +∞ (25)
ove CTOT, nell’ambiente limitato di un sistema a 2 seriazioni, rappresenta il valore parametrico costante della Comunicazione Totale. Ne consegue che, la (21) può essere riscritta come:
n d PTOT + s CTOT = k (26)
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
6
L’espressione (26) esemplifica in modo chiaro che l’equilibrio dinamico dipende sia dal Potere che dalla Comunicazione: evidenziato con la (8) che la Legittimazione può essere espressa in funzione del Dominio, è possibile dire che esistono due elementi di dinamicità interseriazione: la Significazione e il Dominio. Ci ritroviamo così con due possibili cause dell’azione. Guardando la (23) e, similarmente, la (25), invece, possiamo notare che ogni variazione di D ed S deve essere compensate da variazioni uguali e contrarie di D’ e S’:
Δ D = - Δ D’ e Δ S = - Δ S’ (25) Considerando D come il motore della variazione di S ed implementando la definizione iniziale di azione, ovvero che azione è la decisione di seguire un’altra istituzione sulla base delle sue caratteristiche di Dominio, potremmo dire che azione è Dominio. Ciò si rivelerebbe corretto in quanto: azione è caratterizzata da potere e, per la proprietà transitiva, potremmo dire anche che Dominio è ciò che contiene potere. Tale assunzione è vera e pienamente rispondente alle dimensioni della dualità della struttura. Considerando S come il motore della variazione di D e sviluppando questa proposizione allo stesso modo della precedente, si può giungere a dire che azione è Significazione e che, quindi, Significazione contiene potere. Questa affermazione è errata in rapporto alle dimensioni della dualità della struttura, ma coerente con l’assunto giddensiano della onnipresenza del potere: si rivela necessario apportare una integrazione allo schema del processo di strutturazione. Restando nei termini proposti da Giddens, ciò è così traducibile: rispetto a Dominio e Legittimazione, princìpi quantitativi, la Significazione è dotata sia di aspetti quantitativi che di aspetti qualitativi. Essendo il potere pervasivo rispetto ad ogni ambito della realtà, la Significazione si caratterizza, rispetto a Dominio e Legittimazione, per essere collegata a due tipi di interazione: il potere e la comunicazione. In vece della seriazione lineare, quindi, si propone una notazione di questo tipo:
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
7
Le conseguenze di questa variazione, che chiameremo strutturazione triangolare, sono considerevoli e non esclusivamente di tipo logico-formale. Come alcuni esperimenti sociali hanno messo in luce [Zucker 1979], gli attori, pur non avendone una comprensione esaustiva (ma aspettandosi di poterla avere all’occorrenza, senza peraltro poi dare luogo a tale evenienza), danno per scontate le istituzioni ed i significati da queste veicolati, accettandone di buon grado le indicazioni interpretative, anche quando queste contravvengono esplicitamente all’esperienza soggettiva diretta, giungendo perfino a tramandare queste spiegazioni alle generazioni successive. Ciò sarebbe in evidente contraddizione con una delle tesi fondanti della teoria della strutturazione: la struttura si rivelerebbe solo vincolante e lo farebbe proprio in relazione all’ambito della Significazione. La strutturazione triangolare, invece, permette di arricchire la relazione tra struttura ed attore: la struttura risulta sempre vincolante ed abilitante ma: mentre il vincolo entra direttamente in contatto simbiotico con la pratica routinaria
degli attori, venendone così automaticamente riprodotto; la sua caratterizzazione abilitante è mediata dalla Significazione e, per essere utilizzata
(ovvero: per originare una azione) presuppone una comprensione piena, da parte degli attori, dei significati coinvolti in quel particolare processo di strutturazione.
UNO SGUARDO AL PRESENTE
I mezzi di comunicazione globali e l’avvento di internet, la diffusione delle comunicazioni digitali mobili e la possibilità di interconnessione praticamente permanente operata dagli smartphones e dai social media, la realtà aumentata promessa dai GoogleGlass, sono il pratico riscontro di quella che, teoricamente, è definibile come una compresenza permanente. Assistiamo alla significativa estensione territoriale del processo di integrazione sociale, in grado ormai di bypassare i confini delle comunità locali di riferimento e delle nazionalità statali: il contatto potenzialmente continuo ed immediato con chiunque contribuisce a rafforzare le relazioni sociali inter-statali e le solidarietà locali ed ultra-nazionali, al di là del potere dello Stato di definire confini. Sembra aver avuto ragione chi ha identificato la vera rivoluzione della modernità nella rottura della relazione tra mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione, operata dal segnale elettronico [Giddens 1984]. Eppure, la strutturazione lineare non riesce a tenere in debita considerazione nuovi fattori emergenti, quali: la diffusione progressiva di una coscienza e conoscenza globale; il radicale intaccamento dell’autonomia di qualsiasi Stato nel definire le regole; l’estensione di forme di disobbedienza a specifici vincoli normativi; la delocalizzazione delle imprese e le migrazioni delle nuove generazioni, ben oltre la fuga dei cervelli; le possibilità di ricorso a tribunali internazionali; la legittimazione progressiva di pretese soggettive derivanti dall’applicazione di schemi interpretativi alternativi proposti dal moltiplicarsi di organizzazioni in grado di essere percepite quali istituzioni. La strutturazione triangolare, invece, permette una operazionabilità più ampia e flessibile della Significazione, rendendo il modello capace di incorporare evidenze empiriche contemporanee. L’espansione delle possibilità fornite dai mezzi di comunicazione digitali globali, difatti, si concretizza in un incremento esponenziale delle comunicazioni, ovvero delle primarie interazioni collegate alla Significazione. La conseguenza prima di questo fenomeno è la disponibilità di una grande molteplicità di schemi interpretativi, ciascuno dotato di un potere sempre più relativo. Ciò interagisce (come causa e come effetto) con il progressivo indebolimento di quella che è l’istituzione principe del Dominio, lo Stato Nazionale nel sistema di Stati Nazionali. Dal punto di
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
8
vista grafico, è possibile rappresentare tutto questo come una espansione dell’area della Significazione in tutti i processi di strutturazione.
Il potere è in pezzi. Il mondo che ne risulta è uno spazio ove pochi centri di potere – che erano in grado di assumere ed attuare decisioni aventi incidenze reali ed ampie conseguenze su un cospicuo numero di persone sostanzialmente passive – stanno progressivamente lasciando spazio ad una moltitudine di centri di influenza, autori ciascuno di propri schemi interpretativi, in grado di influenzare le identità ed i comportamenti dei singoli attori che, sempre più capaci di attingere alle risorse della Significazione e, quindi, alle proprietà abilitanti della struttura, entrano con nuova autorità nel processo di strutturazione. Potremmo aver trovato un fondamento epistemico ad una delle osservazioni iniziali: sempre più cittadini valutano i servizi dello Stato sulla base di criteri e diritti variegati, derivanti anche da esperienze di altri Paesi, decidendo se optare per strategie di exit o di voice.
L’ISOMORFISMO DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Come può rispondere la socialità organizzata alla problematica complessità odierna? L’oggetto della nostra analisi diventano le politiche pubbliche. La scuola Neoistituzionalista ha riscontrato, nelle sue ricerche, un interessante fenomeno: l’isomorfismo organizzativo, ovvero un processo di progressiva somiglianza tra le persone [Bonazzi 2006], le organizzazioni e l’ambiente istituzionale che li circonda: quando tecniche e criteri per l’efficienza nascono in ambienti istituzionali, in realtà, essi sono miti razionalizzati, cui è necessario conformarsi per accrescere la propria legittimità sociale [Meyer e Rowan 1977]. Le pre-condizioni che permettono al processo di prendere avvio sono due: l’esistenza di un contesto che abbia maturato alcune fasi di sviluppo [Powell e Di Maggio 1983] e la condivisione di miti razionalizzati [Meyer e Rowan 1977].
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
9
Se, inizialmente, si parlava di isomorfismo solo in relazione a singole organizzazioni, vi è chi ne ha verificato la presenza anche in relazione a contesti più ampi, dai campi inter-organizzativi [Powell e Di Maggio 1983], fino ai settori societari [Scott e Meyer 1983], comprendenti ogni organizzazione facente parte di un comparto industriale, con tutte le sue unità organizzative, i rapporti ed i flussi pubblici e privati significativi. In tal senso, <<la definizione di settore societario è simile, per molti versi, a quella di settore di politica pubblica [si vedano, per esempio, Dye 19811; Wildavsky 19792].>> [ibidem, p. 165] Si rivela pertanto possibile parlare di isomorfismo all’interno di settori societari trans-statali, laddove le organizzazioni dei medesimi settori societari di diversi Paesi abbiano potuto seguire un percorso che, a partire dall’incremento dell’interazione inter-organizzativa, li abbia portati allo sviluppo di una reciproca consapevolezza di essere coinvolte in una impresa comune [Powell e Di Maggio 1983]. Per quanto attiene ai miti razionalizzati trans-statali, invece, possiamo dire che essi non sono cosa nuova, nel campo delle politiche pubbliche. Chi ha provato ad astrarre un modello generale di riforma del management pubblico nei vari Paesi, ad esempio, non ha potuto sottrarsi dall’attribuire un ruolo di rilievo alle nuove idee di management, riconducibili all’influenza di business school e di guru [Pollitt e Bouckaert 2000]. In questi studi, si sostiene che le riforme sono una moda nata <<dalle riunioni di amministratori pubblici, di accademici e dai cosiddetti imprenditori della politica.>> [Wright 1997, p. 35] La diffusione, in diversi Paesi, per successive ondate, di riforme improntate alla programmazione, alle privatizzazioni, alla sussidiarietà, al decentramento, alla qualità ed all’orientamento al cliente sembra pienamente accordarsi con l’idea che tutti questi siano, in realtà, miti razionalizzati. Ciò ancor più si avvalora se si pensa che la sostituzione di tali soluzioni <<non avviene perché sono riscontrati irreparabili errori nell’impostazione precedente>> [Regonini 2001, p. 233], ma perché <<il cambiamento spesso è guidato non dalla domanda, ma dall’offerta, cioè dall’esistenza di un’alternativa che attira attenzione e sostegno.>> [March e Olsen 1995, p.119] Senza un reale riscontro sui risultati e senza la verifica della soddisfazione di criteri di razionalità intrinseca, sembra possibile dire che gli obiettivi posti alla base di ciascuna politica pubblica, almeno in epoca recente, attengano direttamente alla sfera dei miti razionalizzati.
UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
La socialità che stiamo indagando, pur nella sua complessità, presenta analiticamente due dimensioni fondamentali, assi cartesiani che la sintetizzano, la descrivono e la riproducono. Si tratta delle due principali aree cui è possibile ricondurre tutti i processi di strutturazione: quella della Significazione e degli ordini simbolici / modi del discorso ad essa collegati e quella del Dominio-Legittimazione e delle Istituzioni politiche, economiche e legali ad essa collegate. Queste due dimensioni sono percorse tra loro da un equilibrio dinamico di cooperazione e di contraddizione: a livello interdimensionale, gli ordini simbolici producono interpretazioni delle istituzioni
politico-economico-legali e le istituzioni politico-economico-legali producono schemi 1 Il riferimento è a Dye T. R. [1981], Understanding public policy, Englewood Cliffs, Prentice-Hall. 2 Il riferimento è a Wildavsky A. [1979], Speaking truth to power: the art and craft of policy analysis, Boston, Little.
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
10
interpretativi: domina la contraddizione strutturale di una sfera pubblica che vuole definire quella sociale e viceversa [Giddens 1984];
a livello intradimensionale, ciascuna dimensione è percorsa dalla contraddizione secondaria [ibidem]: integrazione vs. frammentazione / globalizzazione vs. localizzazione.
Ogni dimensione è contesa tra due polarità, le cui combinazioni danno luogo ad un classico schema a matrice. Essendo schemi di comportamento [Salisbury 1968], con confini mobili e caratterizzate alla primazia delle qualità relazionali [Rorty 1995], possiamo dire che le politiche pubbliche sono simbiotiche alla società e si identificano con suoi interi frammenti, i settori societari. Le loro dimensioni rilevanti sono due: i soggetti coinvolti nella e/o legittimati alla loro elaborazione ed implementazione; gli obiettivi che si propongono di realizzare. Emerge chiaramente la sovrapponibilità di questa impostazione con la matrice già prefigurata: la dimensione dei soggetti adottanti è la medesima che attiene al Dominio-Legittimazione, mentre la dimensione degli obiettivi rientra in quella della Significazione. Inoltre, essendo possibile trattare le politiche pubbliche come un fenomeno isomorfico a livello inter-statuale, almeno per i Paesi che condividono una crescente integrazione sociale, come quelli dell’area OECD, possiamo considerarle come una unità di analisi uniforme per popolare la nostra matrice. Da ultimo, se il tempo è alla base della regionalizzazione ed il tempo mondiale è un concetto necessario per esaminare le congiunture storiche alla luce di una storia monitorizzata riflessivamente [Giddens 1984], occorre inserire una clausula di sequenzializzazione temporale tra le 4 caselle della matrice, ricreando così un percorso tale per cui ciò che viene considerato in una determinata configurazione delle due dimensioni non sia avulso dalle precedenti, ma ne conservi la memoria. Così progettata, la matrice può essere utilizzata per letture sia in chiave diacronica che in chiave sincronica: le configurazioni dimensionali sono successive ma, una volta scoperte, possono convivere, anche in relazione al differente punto di vista adottato ed in virtù della relatività che caratterizza l’attributo istituzionale [Jepperson 1991]. Le formule di politiche pubbliche proposte non sono classificazioni rigide, ma rispondono ad una opzione di first best per ciascuna configurazione dimensionale ed hanno una valenza sia descrittiva sia prescrittiva.
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
11
Il quadrante 1 rappresenta una realtà caratterizzata da pochi centri di potere ed ordini simbolici frammentati. I soggetti decisori sono pochi, dotati di autorità (relativamente) assoluta e con competenze ben definite, con un buon grado di autonomia tra loro; mentre i cittadini si caratterizzano per una sostanziale passività nell’aderire alle indicazioni ricevute. I loro schemi di comportamento e le loro identità sono in relazione diretta con l’autorità dei soggetti decisori, mentre le loro aspirazioni ed i loro riferimenti derivano prevalentemente dalla compresenza e dalle routine. Le politiche pubbliche, in questo caso, sono quelle legate al paradigma della ARP3, con le sue valutazioni costi-benefici e la centralità accordata al processo decisione-attuazione-verifica dei risultati. Le pressioni isomorfiche sono modeste, data la scarsità di miti razionalizzati trans-nazionali, e di natura prevalentemente coercitiva [Powell e Di Maggio 1983], stante la grande differenziazione tra istituzioni ed organizzazioni; investono il processo piuttosto che il risultato. Il quadrante 2 rappresenta una realtà caratterizzata da pochi centri di potere ed ordini simbolici integrati. I soggetti decisori restano pochi, ma sono in aumento e dotati di una autorità che va riducendosi, seppur con competenze che restano definite. Il grado di autonomia tra loro si riduce, aumentandosi significativamente l’integrazione sociale e la circolazione delle idee. I cittadini si caratterizzano per una crescente consapevolezza, seppur ancora concentrata. I loro schemi di comportamento e le loro identità iniziano ad essere contese e le loro aspirazioni e riferimenti derivano da più fonti. Le politiche pubbliche che si affermano in questo caso sono quelle legate al Policy Transfer: la diffusione di miti razionalizzati all’interno delle élite e la crescente incertezza derivante dal mondo sociale portano all’affermarsi di pressioni di isomorfismo mimetico [ibidem], per cui si preferisce adottare soluzioni già sperimentate altrove, in modo da poter giustificare la propria decisione con l’esistenza del precedente. Si tratta di un isomorfismo di risultato. Il quadrante 3 rappresenta una realtà caratterizzata da molti centri di influenza ed ordini simbolici integrati. I soggetti coinvolti sono molti ed interrelati in fitte trame di reciproca interdipendenza, dotati di autorità relative e con competenze ormai sfumate. I cittadini si caratterizzano per una accresciuta consapevolezza e le loro strategie si avvalgono di una moltitudine di schemi interpretativi tra cui poter scegliere. Le aspirazioni ed i riferimenti sono intelaiati in una trama di sistemi sociali che si intersecano, generalizzati nella società globale. Le politiche pubbliche più
3 Analisi Razionale delle Politiche.
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
12
idonee a questa configurazione del reale sembrano essere quelle legate alla Experimentalist Governance [Sabel e Zeitlin 2012a], con la loro capacità di integrare poliarchia ed incertezza. Le pressioni isomorfiche sono intense ed interessano il processo: sono di tipo normativo [Powell e Di Maggio 1983], in quanto provenienti dalle sempre maggiore professionalizzazione della sfera pubblica e dalla riduzione ormai sistemica della differenziazione tra organizzazioni ed istituzioni. Il quadrante 4, infine, rappresenta una realtà caratterizzata da molti centri di influenza e da ordini simbolici frammentati. I soggetti decisori restano molti, con autorità relative ed una ritrovata parziale autonomia, frutto anche della Experimentalist Governance del quadrante precedente. I cittadini si caratterizzano per una consapevolezza consolidata e riferimenti sia generalizzati nella società globale che radicalizzati nella comunità locale. Le politiche pubbliche idonee, in questo caso, potrebbero essere quelle della Democratic Governance [March e Olsen 1995]: sia per l’orientamento volto all’accrescimento di consapevolezze, capacità e risorse, che per l’indirizzo alla creazione di identità autonome. Le pressioni isomorfiche sono del tipo superamento [Scott 1991], grazie all’interiorizzazione dell’ambiente istituzionale.
APPLICAZIONI
Adottando le politiche pubbliche come una prospettiva integrata di lettura e di azione sulla società nel suo complesso, esse vanno a dipendere dalle dimensioni rilevanti che caratterizzano la società stessa in un dato momento. Oggi, nessuna formazione statale risulta adeguata a soddisfare le esigenze dei propri cittadini poiché nessuna riesce ad essere pienamente allineata all’evoluzione che le due dimensioni rilevanti stanno vivendo e che ci stanno conducendo dal quadrante 2 al quadrante 3 della matrice. Le ondate riformistiche che hanno percorso gli anni ’80, ’90 e 2000 erano uniformate al carattere prevalente del Policy Transfer ed orientate al raggiungimento di risultati specifici come la privatizzazione, l’esternalizzazione, la riduzione dei bilanci pubblici: veri e propri miti razionalizzati, diffusisi sotto il vessillo del New Public Management. La prima attività in cui la matrice si rivela utile, quindi, è proprio l’orientarsi nel dibattito contemporaneo tra le numerose proposte alternative al NPM. Tra quelle che godono di maggiore fortuna, anche in virtù di una serie di studi che dimostrano la sua efficacia, vi è la Digital Era Governance [Dunleavy 2005], che vede nelle novità di potenzialità ed utilizzo dei sistemi IT la cifra distintiva di un rinnovato possibile sviluppo degli apparati pubblici. In virtù di tali nuovi mezzi, si sostiene, è possibile procedere ad una ri-centralizzazione amministrativa più efficiente ed efficace, laddove la disaggregazione e la competizione sono stati le cause di fallimento principali del NPM. Tale punto di vista, però, non risulta coerente con la prospettiva sociologica adottata, rivelandosi improntato, nella sua radice, ad un certo determinismo tra struttura ed attore, fondandosi su relazioni unidirezionali tra strumenti di governance e modificazioni dei comportamenti4. Se i sistemi IT sono strumenti formidabili al servizio della società e di qualsiasi metodo di governo, più critica resta la loro elevazione a fondamento di un paradigma complessivo. Un differente percorso viene seguito dai sostenitori del Public Value Management [Stoker 2006], che condivide con il nostro approccio i medesimi princìpi fondativi. Il punto focale cui giunge questa teoria è che il compito principale delle Amministrazioni Pubbliche si sostanzia nel fornire servizi, la cui caratteristica rilevante non è il modo efficiente o efficace di erogazione, bensì l’esser
4 Cfr., in particolare, figure 1 in [Dunleavy 2005]
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
13
finalizzati all’incremento del valore sociale. Per raggiungere tale obiettivo, si sostiene, gli autori delle politiche pubbliche, manager e politici insieme, devono trovare forme di relazione e coinvolgimento continuativo con la cittadinanza, affinché sia possibile raccogliere le sue valutazioni in merito a questo aspetto. Dal nostro punto di vista, questa formula, seppur coerente, potrebbe difficilmente essere paradigmatica di un quadrante della matrice, in quanto resta intrappolata nella logica Principale-Agente, ancora vigente nel quadrante 2 ma ormai rotta nel successivo5. In virtù di ciò, essa si presenta come una formula ibrida, assai probabilmente adatta ai momenti di transizione tra i quadranti 2 e 3. Se una corretta comprensione del presente è necessaria per una migliore interpretazione del (possibile) futuro, una delle potenziali soluzioni alle inadeguatezze, ormai critiche, delle Amministrazioni contemporanee è nell’adozione di paradigmi nuovi e differenti, laddove permanere nelle logiche istituzionali dominanti significherebbe rielaborare concetti in verità contingenti [Hirschman 1986], riproducendoli e contribuendo così alla loro non certo naturale egemonia, <<creando una scienza sociale dei mezzi, priva di significato.>> [Friedland e Alford 1991, p. 341] Nel terzo quadrante, le condizioni caratterizzanti sono un’ampia diffusione di ordini simbolici integrati ed un consolidato passaggio da pochi centri di potere ad un insieme di centri di influenza. Ne deriva la possibilità di svincolarsi degli schemi interpretativi dalla localizzazione territoriale dell’organizzazione statale, fornendo a ciascun singolo attore dei paradigmi generalizzati e comuni cui attingere per la costruzione della propria esperienza soggettiva di vita. Tramite l’incremento degli interscambi comunicativi, si giunge ad una fusione di ordini simbolici trans-societari, con il conseguente indebolimento delle istituzioni fondate sul Dominio e sulla Legittimazione. Ciascuna di queste è in grado di fornire ulteriori schemi interpretativi con i quali, però, gli attori riescono ora ad interagire in maniera crescente, dato l’espandersi dell’area della Significazione e la capacità di utilizzare a proprio vantaggio le proprietà abilitanti della struttura. Il mondo che ne deriva è incerto e poliarchico: nessuno ha una visione esatta di cosa andrebbe fatto per risolvere un problema, né le strutture pubbliche né gli attori privati; mentre numerosi soggetti, pubblici e privati, condividono una in qualche misura rilevante porzione di potere relativo nell’adottare decisioni ed implementare soluzioni. Questa situazione porta, di fatto, alla crisi di tutte le relazioni fondate sulla logica Principale-Agente: sia quelle pristine, come i paradigmi di Politica Razionale, sia le soluzioni classiche a questa crisi adottate negli ultimi decenni, come il New Public Management. La crisi può essere sintetizzata come l’incapacità di governare la complessità sociale attraverso leggi, norme amministrative rigide e giudizi (sempre più opinabili) delle Supreme Corti [Sabel 2004; Prandini 2013]. È la realtà in cui potremmo stare entrando e che vedrebbe le pre-condizioni fondamentali alle quali viene fatto risalire l’affermarsi, in Europa e negli Stati Uniti, di modelli di policy making denominati Experimentalist Governance [Sabel e Zeitlin 2012a; 2012b]. Basato sulla relatività di ogni decisione e sulla sperimentazione, il sistema di EG mutua gli approcci di simultaneous engineering e di learning by monitoring e si fonda sulla logica della peer review [Sabel e Cohen 2003]. La EG si presenta come un processo ricorsivo di programmazione di obiettivi-quadro e loro revisione, basato sull’apprendimento attraverso la comparazione tra approcci alternativi proposti in contesti differenti. [Sabel e Zeitlin 2012a] Già al centro della rivoluzione toyotista degli anni ’90, questa tipologia di policy è stata rilevata come emergente in molti ambiti di competenza sia dell’Unione Europea che degli Stati Uniti: dal sistema scolastico di quest’ultimo, alla WFD6 della prima, passando per il sistema di HACCP7, le politiche di regolazione dei mercati energetici, finanziari e dei servizi dell’Unione [Sabel 2005, Sabel e Zeitlin 2012a]. 5 Vedi infra. 6 Water Framework Directive
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
14
Grazie alla nostra matrice, possiamo puntare l’attenzione su due aspetti controversi della EG. Anzitutto: se essa risulta il miglior approccio alle politiche pubbliche per le condizioni date dal sistema sociale, appare di primaria importanza chiedersi come sia possibile facilitarne la diffusione. Laddove incertezza e poliarchia sono pienamente evidenti, la EG sorge spontaneamente [Sabel e Zeitlin 2012b]. Dato che l’incertezza del mondo contemporaneo è una condizione dettata dall’espansione della Significazione e, pertanto, può essere considerata una variabile indipendente, è necessario focalizzarci sulle situazioni in cui non si sia realizzata una poliarchia. Una distribuzione poliarchica del potere può essere contrastata in quei contesti in cui una autorità è ancora in grado di assumere ed imporre decisioni. Alternativamente, ci si può trovare in situazioni di blocco conservativo, ovvero ambienti in cui la presenza di oligarchie interessate nella conservazione delle proprie rendite di posizione scoraggi la sperimentazione di formule cooperative potenzialmente erosive dei privilegi acquisiti. Per entrambe queste situazioni, Sabel e Zeitlin [ibidem] riprendono il concetto di ombra della gerarchia [Borzel e Risse 2010], sostenendo che si renderebbe necessaria l’introduzione – ad opera di autorità sovra-ordinate, oppure in relazione di interdipendenza ma da posizione di forza, quali ad esempio partner commerciali rilevanti – di meccanismi di penalty-default, ovvero l’imposizione in terrorem di conseguenze grandemente peggiorative per coloro che si rifiutassero di tenere un atteggiamento cooperativo. Dal nostro punto di vista, situazioni laddove ancora sussiste un centro potere in grado di prendere decisioni non rientrano nel caso in cui l’applicazione della EG sarebbe raccomandabile. Il caso delle oligarchie, invece, è una situazione differente e ci riguarda da vicino, essendo tipica anche della nostra realtà italiana. Riprendendo Power and Prosperity di Mancur Olson8, è facile parafrasare la descrizioni della Russia comunista, adattandola alla situazione italiana odierna: un sistema pubblico estremamente pervasivo nel prelievo ed altamente inefficiente nell’erogazione dei propri output conduce allo sviluppo di una ragnatela di micro negoziazioni con obiettivi miopi e prossimali, quali la difesa dei piccoli privilegi del management e della burocrazia. Prosperando grazie alla capacità di contrattare su tutto, ma in modo sotterraneo ed in un contesto chiuso, questi gruppi sociali guardano con allarme qualsiasi forma di cambiamento. Il sistema dei penalty-default, su cui la stessa Unione Europea si basa, peraltro, non pare aver avuto grande successo nel modificare l’approccio al policy making italiano. La motivazione di questo insuccesso, probabilmente, risiede nel fatto che quello ben descritto da Olson è l’instaurarsi di un vero e proprio sistema di relazioni sociali che vanno oltre i calcoli costi-benefici e gli assunti dell’uomo razionale su cui intendono incidere i meccanismi di penalty-default: le motivazioni a questo agire si sono radicate in profondità, andando a costruire significati, schemi interpretativi ed identità che non possono esser fatte mutare in modo meccanicistico. Importare in Italia una prospettiva di policy non può tradursi nella identificazione di una ipotetica Autorità o nella formalizzazione normativa di una determinata procedura da adottarsi per l’assunzione delle decisioni. Se una policy ha a che fare con gli schemi di comportamento delle persone, difficilmente un meccanismo di penalty-default può riuscire ad estendere una determinata tipologia di politica pubblica.
7 Hazard Analysis and Critical Control Points 8 Il riferimento è a Olson M. [2000], Power and prosperity, New York, Basic Books.
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
15
La matrice, però, ci consente di immaginare una soluzione alternativa. Se il campo da gioco delle policy sono i settori societari, ancor più ed ancor meglio nell’Unione Europea, che definisce la propria attività in termini di policy making nei diversi settori societari trans-nazionali [Mazey e Richardson 1993; Sabel e Cohen 2003], si potrebbe sfruttare il fenomeno dell’isomorfismo. In particolare, per la sua natura processuale, consensuale ed altamente professionalizzata, la EG è soggetta ad isomorfismo di tipo normativo: piuttosto che tramite meccanismi di policy-default, la EG potrebbe essere diffusa creando le pre-condizioni che portano al nascere dei fenomeni di isomorfismo delle politiche pubbliche, ovvero: la maturazione dei diversi settori societari trans-nazionali, attraverso le loro 4 fasi di
sviluppo [Powell e Di Maggio 1983]; la diffusione di potenti miti razionalizzati, ovvero anche accrescendo l’importanza, nel
reclutamento del personale delle strutture pubbliche, di credenziali di tipo accademico internazionale;
la partecipazione dei dirigenti pubblici in associazioni professionali e di categoria internazionali.
In questa chiave, probabilmente, potrebbe parlarsi della diffusione di una policy come reale mutamento non solo delle istituzioni formali, ma anche e soprattutto degli ordini simbolici e dei riferimenti generali cui le persone attingono per riprodurre la propria realtà. L’importanza della estensione della EG a tutte i sistemi che rientrano in un dato quadrante della nostra matrice è ancor di più evidente se rapportata al suo carattere ciclico, iterativo ed includente. Infatti, <<la Experimentalist Governance, nella sua forma più sviluppata, implica un’architettura multi-livello>> [Sabel e Zeitlin 2012a, p. 197]: se anche solo una delle unità locali non opera in modo sperimentalista, il risultato dell’intera politica ne può risentire in modo grave. È a questo punto che si pongono le basi per un’organizzazione della vita pubblica potenzialmente fondata su una polity non statale [Sabel e Coehn 2003]. La EG, pertanto, si configura come una policy volta a strutturare – e strutturata su – un sistema organizzativo con giurisdizioni aventi finalità specifiche [Ostrom e Ostrom 1999] ed affiliazioni plurime [Casella e Weingast 1995], a geometria variabile; una realtà fatta di giurisdizioni ottimali [McGuire 1974, p. 74]. Se l’isomorfismo delle politiche pubbliche si presenta come un potente strumento intenzionale, al servizio di chi lo voglia utilizzare, per modificare sia lo Stato Amministrativo che i comportamenti, le relazioni e le identità dei suoi cittadini; e se la EG potrebbe condurre alla frantumazione dello Stato Nazionale in favore di una governance multilivello articolata in comunità funzionali; ecco affacciarsi il secondo punto controverso in cui la nostra matrice può aiutarci: dove conduce la EG? Siamo lentamente scivolati nel quadrante 4 della matrice: nessun centro di potere, ma una miriade di centri di influenza; ordini simbolici globalizzati, ma anche localizzati. La realtà vive di una frammentarietà totale, in cui il soggettivismo dell’esperienza è massimamente legittimato: dal punto di vista degli ordini simbolici, alla globalizzazione segue una radicale localizzazione, con la piena capacità di attingere a schemi interpretativi differenziati e personalizzati. I centri di influenza sono molteplici ed incapaci di proporre visioni forti. La memoria della configurazione precedente permette la persistenza di alcuni miti globali, individuabili come principi di fondo dell’esperienza sociale. Si potrebbe assistere alla convivenza tra una sorta di umanesimo universale nel campo dei princìpi astratti ed a sue molteplici declinazioni pratico-pragmatiche in ciascun contesto locale. La riflessività umana sarebbe massimizzata, conducendo ad nuova consapevolezza e ad un più ampio cambiamento di frame, in cui il nuovo orizzonte è quello dei beni comuni [Prandini 2013].
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
16
Stiamo chiaramente entrando nell’ambito delle proprietà previsive del modello: pur riconoscendo come l’affidabilità crolli vertiginosamente, le tendenze individuate potrebbero portare anche qui. Con la matrice individuiamo nelle teorie della Democratic Governance [March e Olsen 1995] la formula di policy adeguata a questa situazione. Addentrarsi nei testi che illustrano le virtù e le potenzialità della DG è come entrare nel regno delle favole; ma sognare può essere salutare anche per l’analisi perché, nei tempi difficili, immaginare il mondo quale potrebbe essere aiuta a capire il mondo quale è. Se le preferenze non sono date, bensì socialmente e discorsivamente costruite [Corrao 2002], fondate sulle identità piuttosto che sul calcolo costi-benefici e rispondenti a regole di appropriatezza piuttosto che di massimizzazione [March e Olsen 1995] e la razionalità non è uno stato acquisito aprioristicamente, ma un processo che opera retrospettivamente, per fornire giustificazioni a posteriori a scelte fatte tra alternative limitate; allora le istituzioni sono combinazioni di princìpi strutturali che offrono agli individui un vocabolario di motivazioni ed un senso di sé. Quel che muta è l’oggetto dell’attenzione: perde senso parlare di efficienza di una Pubblica Amministrazione e perfino preoccuparsi dell’intento razionalizzante che essa ha sull’intera società, perché il fallimento di questo obiettivo non solo è possibile, ma dato per certo, in quanto spiegato. Il nuovo retroterra è costituito da altri punti cardine: la fiducia nel logos [Harbermas 1991] e nella costruzione narrativa del senso esperienziale [Atkinson 1998], la riflessività, l’orientamento inclusivo, il rafforzamento dello spirito civico [Sabel 2001]. Le radici della DG affondano nel Garbage Can Model [Cohen, March e Olsen 1972], che tenta di descrivere in modo iper-realistico il funzionamento dei processi decisionali: le preferenze degli attori non sono endogene [March e Olsen 1989], l’apprendimento non è la soluzione ai limiti della razionalità [March e Olsen 1995], la responsabilità e le costruzioni sociali sono vaghi [ibidem], il rapporto causa-effetto non esiste [March 1994], mentre è l’ecologia dell’attenzione a guidare le scelte [March e Olsen 1995]. Così, la DG si preoccupa di fornire un programma di policy finalizzato ad incrementare le possibilità dei cittadini di governare se stessi in modo civile, tramite azioni in tre ambiti: la formazione delle identità, la crescita delle capacità e la creazione di discorsi [ibidem]. Sebbene ciascuna di queste indicazioni potrebbe essere intesa come una guida morale o una collezione di buoni princìpi, in realtà esse sono concepite come una analitica elencazione dei processi che influenzano tutti gli aspetti chiave della vita sociale umana, individuando così nuove arene di policy, in una visione alternativa delle azioni in un settore societario, meno indirizzate alla soluzione dei problemi concreti e più al miglioramento dei problemi reali, laddove è esplosa in mille frammentati punti di vista la percezione del mondo esterno e ciò che rimane è la possibilità di agire esclusivamente sui modi in cui questi punti di vista si formano: per ricondurli ad un unico comun denominatore, individuato nell’ethos democratico. Il dubbio che si pone è lecito: siamo davvero desiderosi di incamminarci lungo un sentiero in cui <<la governabilità [sarà] garantita dal ruolo pervasivo delle istituzioni [che] sembra talvolta sconfinare nell’aperta manipolazione>> [Regonini 2001, p. 277], poiché <<le identità e le preferenze perdono autenticità quando le loro basi sono corrotte da informazioni, frames, emozioni e conclusioni che sono false: in altre parole, da una falsa coscienza>> [March e Olsen 1995, p. 87]? Davvero l’unica via è <<l’ingegneria dell’intelligenza […], chiamata […] alla trasformazione delle preferenze e delle identità>> [March 1994, p. 276]? March e Olsen motivano la loro visione con la speranza. La matrice permette un approccio ulteriore: nel quarto quadrante, l’area della Significazione è estesa al massimo grado in tutti i
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
17
processi di strutturazione, il sistema di riferimenti simbolici glocale e lo sfinimento delle relazioni di autorità sono le coordinate iniziali di massima che incorniciano l’utilità di un tale modo di intendere il policy making, nonché le coordinate finali ove potrebbe condurre un sistema di Experimentalist Governance. La EG, nel suo pieno dispiegamento, come detto, si articolerebbe in un sistema multi-livello la cui unità fondamentale sarebbe individuabile in micro-comunità a geometria variabile, finalizzate alla produzione e fruizione di beni comuni. Questo tipo di organizzazione sociale godrebbe di alcune proprietà: grazie all’attivarsi del sistema di incentivi e sanzioni sociali che automaticamente si genera nelle comunità di ridotte dimensioni, tutti i cittadini sarebbero spronati a collaborare ed a compartecipare alle scelte pubbliche ed alla produzione dei beni, abbattendo la disaffezione per le sorti comuni, incrementando le capacità di controllo del sistema sui comportamenti opportunistici, stimolando naturalmente il dialogo e l’incontro [Mancur Olson 1982]. Potrebbero forse essere queste le premesse in cui la DG perderebbe ogni ambivalenza, permettendo lo scaturire di quella che è la chiave di volta dell’intero processo, ovvero una concezione per cui la democrazia si fa luogo di auto-riflessione e di ridefinizione continua degli individui, delle istituzioni e della comunità stessa, stimolando la critica costruttiva e la riflessione sociale ed individuale sulla natura di ogni nuova identità che va a costituire [March e Olsen 1995]. È la riflessività al quadrato [Regonini 2001, p. 276].
CONCLUSIONI
La matrice per le politiche pubbliche rappresenta la risposta ad una domanda raramente approfondita: <<dopo il 1980, per ragioni che non conosciamo e che forse non comprenderemo mai, il mondo è diventato troppo mutevole per le gerarchie.>> [Sabel 2004, p. 61] Strumento interpretativo improntato all’utilità, la matrice può essere utilizzata per letture sia sincroniche che diacroniche, proponendo una relazione di tipo contingentista tra struttura della società e modalità di adozione delle politiche pubbliche, dando sostanziale dignità e correttezza a tutti gli approcci, razionali e sperimentali, a patto che siano utilizzati nel giusto ambiente. Pragmaticamente [Dewey 1910], management e governance possono essere intese come modalità generali della policy, idonee ad affrontare ciascuna un contesto differente: non esiste uno stile migliore, ma solo quello più adatto. In questo senso, la matrice rivela un’impostazione concorde con gli ups and downs rilevati da Olsen [2008] nel moto pendolare tra de-burocratizzazione e ri-burocratizzazione nelle riforme delle Pubbliche Amministrazioni occidentali. L’inesistenza di ricette buone per tutte le stagioni viene però conciliata con l’individuazione di poche variabili e di pochi profili paradigmatici, creando una griglia facilmente utilizzabile per interpretare il mondo socio-politico. I passaggi da un quadrante all’altro sono assicurati, in una dinamica ecologica ed interattiva, dal fatto che le stesse policy si diffondono nel settore societario tramite l’isomorfismo e giungono a modificarlo, conducendo ad un quadrante differente. Se ad una lettura diacronica la governance sembra emergere come la soluzione finale migliore, la realtà è ben diversa. La componente sincronica si rivela ineliminabile, dato il carattere relativo delle istituzioni [Jepperson 1991] e, pertanto, risulta indispensabile adottare un approccio generalmente affine a quello delle teorie sulla meta-governance [Jessop 2003, Sorensen 2006]. In queste visioni, le formule di governance, lungi dall’essere considerate soluzioni definitive, vengono viste come soggette a potenziali fallimenti, come tutte le attività umane. È pertanto importante assumere un
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
18
atteggiamento ironico, fondato sulla ricerca di soluzioni creative, restando coscienti dei loro stessi limiti ed adottando un approccio orientato alla soddisfacenza [Jessop 2003]. Sinteticamente e sommariamente, potremmo riassumere il percorso della nostra matrice come un cammino della percezione umana della società da condizioni di datità ad una emergenza di ambiguità, tramite un progressivo passaggio nella complessità e, poi, nell’incertezza. Il Policy Transfer è un modello basato sull’imitazione e ben si addice ad un comportamento che cerca di minimizzare e schematizzare la complessità, incrementando la sicurezza. Lo Sperimentalismo comporta, invece, un significativo mutare di atteggiamento. La sua risposta alla sfida posta dall’incertezza è renderla un’opportunità: il non sapere quale sia la strada migliore da intraprendere viene istituzionalizzato in un percorso che incoraggia a prendere strade differenti, percorrerle per un pezzo almeno e, confrontandosi di volta in volta, mantenere aperta la possibilità di mutamenti di rotta. La Governance Democratica nel suo faccia a faccia con l’ambiguità, ancor più, estremizza l’approccio sperimentalista: il problema non viene reso un’opportunità ma statuito quale condizione naturale del reale e, quindi, elidendone la problematicità, è trasformato in un vero e proprio bene [March 1971]. Ciò che emerge è che, dopo la rottura dello schema Principale-Agente, l’espressione Pubblica Amministrazione segnala la sua totale inadeguatezza per entrambi i significati di cui è portatrice: il concetto di Pubblico non può più essere relegato ad una forma organizzativa che si occupi
di tutto ciò che non è proprietà privata, ma dovrebbe essere coinvolto nella definizione stessa degli obiettivi e degli oggetti che saranno interessati dall’azione;
il concetto di Amministrazione non può più essere inteso come esecuzione di piani, norme e procedure finalizzati alla realizzazione di uno stato di cose desiderato.
Nelle società complesse e multilivello, con appartenenze plurime e generalmente deboli di oggi, il termine più idoneo potrebbe essere quello di Governo della Società: laddove per Governo si intenda una pratica orientata non più alla esecuzione ma alla
temporale sincronizzazione degli obiettivi ed attivazione delle forze sinergiche per il raggiungimento e la modifica degli stessi;
laddove per della Società si intenda l’incentivazione e la valorizzazione di una pratica partecipativa diffusa e, al contempo, il carattere di ciclico indirizzo riflessivo delle azioni.
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
19
BIBLIOGRAFIA
Atkinson R. [1998], The life story interview, London, Sage, trad. it. L’intervista narrativa, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2002. Bertoli G. [2007], Il settore dell’energia elettrica: dal monopolio verticalmente integrato alla concorrenza, in M. Martellini (a cura di), Dal monopolio alla concorrenza. La liberalizzazione incompiuta di alcuni settori, Milano, Franco Angeli Editore. Bonazzi G. [2006], Come studiare le organizzazioni, Bologna, Il Mulino. Borzel T. e Risse T. [2010], Governance without a state: can it work?, in “Regulation&Governance” n. 4, pp. 113-134, in C. Sabel e J. Zeitlin [2012b]. Cagli C. [1918], Il rinnovamento burocratico, l’ordinamento e la riforma della pubblica amministrazione, Roma, Società cartiere centrali, in Sepe [2007]. Capano G. [2006], L’evoluzione storica della pubblica amministrazione, in G. Capano e E. Gualmini (a cura di), La pubblica amministrazione in Italia, Bologna, Il Mulino. Casella A. e Weingast B. R. [1995], Elements of a theory of jurisdictional change, in A. Palumbo e S. Vaccaro [2006] Cassese S. [2013], La qualità delle politiche pubbliche, ovvero del metodo di governare, Camera dei Deputati, 11 Febbraio. Cohen M. D., March J. e Olsen J. [1972], A garbage can model of organizational choice, in “Admnistrative Science Quarterly”, 17, pp. 1-25, in J. March [1988]. Corrao S. [2002], Il focus group, Milano, Franco Angeli Editore. D’Autilia M. L., Ruffini R. e Zamaro N. [2009], Il lavoro pubblico, Milano, Bruno Mondadori Editore, in R. Ruffini, Fondamenti di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, Milano, Franco Angeli Editore. Dewey J. [1910], How we think: a restatement of the relation of reflective thinking to educative process, Boston, Heath, in G. Regonini [2001]. Di Porto F. e Silva F. [2005], Riformare le utilities è difficile: il caso elettrico italiano, in “Mercato concorrenza regole”, n. 1, pp. 11-50. Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J. [2005], New Public Management is Dead – Long Live Digital-Era Governance, in “Journal of Public Administration Research and Theory”, pp. 467-494. Easton D. [1953], The political system: an inquiry into the state of political science, New York, Knopf (II ed. ampliata 1971), in G. Regonini [2001].
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
20
Friedland R. e Alford. R. R. [1991], Tornare alla società: simboli, pratiche e contraddizioni istituzionali, in W. Powell e P. Di Maggio [1991]. Giddens A. [1984], The Constitution of Society, Cambridge, Polity Press; trad. it. La Costituzione della Società, Milano, Edizioni di Comunità, 1990. Habermas J. [1991], The theory of communicative action, Oxford, Polity Press, in G. Regonini [2005]. Habermas J. [1992], Citizenship and national identity: some reflections on the future of Europe, in “Praxis International”, 12, n. 1, pp. 1-19, in J. March e J. Olsen [1995] Habermas J. [1996], Die einbeziehung des anderen. Studien zur politischen theorie, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, trad. it., L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Milano, Feltrinelli Editore, 1998 (II ed. ampliata 2008). Hirschman A. O. [1970], Exit, Voice and Loyalty, Cambridge, Harvard University Press, in J. March e J. Olsen [1995]. Hirschman A. O. [1986], The concept of interest: from euphemism to tautology, in “Rival Views of Market Society”, New York, Viking, pp. 35-55, in W. Powell e P. Di Maggio [1991]. Hirschman A. O. [1991], The rhetoric of reaction, Cambridge, Harvard University Press, in in J. March e J. Olsen [1995]. Jepperson R. L. [1991], Istituzioni, effetti istituzionali e istituzionalismo, in W. Powell e P. Di Maggio [1991]. Jessop B. [2003], Governance and Metagovernance: On Reflexivity, Requisite Variety, and Requisite Irony, in A. Palumbo e S. Vaccaro [2006]. Lasswell H. D. [1951], The policy orientation, in Lerner D. e Lasswell H. D. (a cura di), The policy sciences: recent developments in scope and method, Stanford, Stanford University Press, in G. Regonini [2001]. Mancur Olson [1982], The rise and decline of Nations, New Haven, Yale University Press, in L. Bordogna (a cura di), Individuo e organizzazione, Bologna, Il Mulino, 2005. Mann M. [1993], Nation-states in Europe and other continents: diversifying, developing, not dying, in “Daedalus”, 122, n. 3, pp. 115-140, in J. March e J. Olsen [1995]. March J. [1971], The technology of foolishness, in “Civilokonomen, Copenhagen, 18 (4), pp. 4-12, in J. March [1988]. March J. [1988], Decisions and organizations, Oxford, Basil Blackwell, trad. it. Decisioni e organizzazioni, Bologna, Il Mulino, 1993. March J. [1994], A primer on decision making: how decisions happen, New York, The Free Press, in in G. Regonini [2001].
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
21
March J. e Olsen J. [1989], Rediscovering Institutions. The organizational basis of politics, New York, The Free Press, in G. Regonini [2001]. March J. e Olsen J. [1995], Democratic Governance, New York, Free Press, trad. it. Governare la democrazia, Bologna, Il Mulino, 1997. Mazey S. P. e Richardson J. J. [1993] (a cura di), Lobbyng in the European Community, Oxford, Oxford University Press, in G. Regonini [2001]. McGuire M. [1974], Group segregation and optimal jurisdictions, in “Journal of Political Economy”, n. 82, pp. 112-132. Meyer J. W. e Rowan B. [1977], Le organizzazioni istituzionalizzate. La struttura formale come mito e cerimonia, in W. Powell e P. Di Maggio [1991]. Olsen J. [2008], The Ups and Downs of Bureaucratic Organization, in “Annual Review of Political Science”, n. 11, pp. 13-37. Ostrom V. e Ostrom E. [1999], Public goods and public choices, in M. McGinnis (a cura di), Policentricity and local public economies, Ann Arbor, University of Michigan Press, in A. Palumbo e S. Vaccaro [2006]. Palumbo A. e Vaccaro S. [2006] (a cura di), Governance. Teorie, principi, modelli, pratiche nell’era globale, Milano, Mimesis Edizioni. Pollitt C. e Bouckaert G. [2000], Public Management Reform, Oxford, Oxford University Press, trad. it. La riforma del management pubblico, Milano, Università Bocconi Editore, 2002. Powell W. e Di Maggio P. [1983], La gabbia di ferro rivisitata. Isomorfismo istituzionale e razionalità collettiva nei campi organizzativi, in W. Powell e P. Di Maggio [1991]. Powell W. e Di Maggio P. [1991] (a cura di), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, The University of Chicago Press, trad. it. Il neoistituzionalismo nell’analisi organizzativa, Torino, Edizioni di Comunità, 2000. Prandini R. [2013], Esperimenti di (nuova) democrazia: come salvare l’esperienza democratica nell’epoca della sua crisi, in R. Prandini (a cura di), Esperimenti di nuova democrazia, Roma, Armando editore. Regonini G. [2001], Capire le politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino. Regonini G. [2012a], Scienze del pubblico e istituzioni, in “Rivista italiana di politiche pubbliche”, n. 1, pp. 5-31. Regonini G. [2012b], Parlamenti analitici, in “Rivista italiana di politiche pubbliche”, n. 1, pp. 33-87. Rokkan S. [1975], Formazione degli Stati e differenze in Europa, in C. Tilly [1975]. Rorty R. [1995], Il progresso del pragmatista, in U. Eco (a cura di), Interpretazione e sovrainterpretazione, Milano, Bompiani, in G. Regonini [2001].
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
22
Sabel C. [2001], A quiet revolution of democratic governance: towards democratic experimentalism, OECD, in G. Regonini [2005]. Sabel C. [2004], Beyond Principal-Agent Governance: experimentalist organizations, learning and accountability, in E. Engelen e M. Sie Dhian Ho (a cura di), De Staat van de Democratie. Democratie voorbij de Staat, Amsterdam, Amsterdam University Press, trad it. Oltre la governance dei principali-agenti: organizzazioni sperimentali, apprendimento e responsabilità, in R. Prandini [2013]. Sabel C. [2005], Globalisation, new public services, local democracy: what’s the connection?, presentato alla Local Governance and Production Conference in Trento, June 2005, trad it. Globalizzazione, nuovi servizi pubblici, democrazia locale: quale connessione?, in R. Prandini [2013]. Sabel C. e Cohen J. [2003], Sovereignty and Solidarity in the EU, in J. Zeitlin e D. Trubek (a cura di), Governing work and welfare in a new economy: European and American Experiments, Oxford, Oxford University Press, trad it. Sovranità e solidarietà: l’Unione Europea e gli Stati Uniti, in R. Prandini [2013]. Sabel C. e Zeitlin J. [2012a], Experimentalist Governance, in D. Levi-Faur (a cura di), The Oxford Handbook of Governance, Oxford, Oxford University Press. Sabel C. e Zeitlin J. [2012b], Experimentalism in the EU: Common ground and persistent differences, in “Regulation & Governance”, n. 6, pp. 410-426. Salisbury R. H. [1968], The analysis of public policy: a search for theories and roles, in Ranney (a cura di), Political science and public policy, Chicago, Markham, in G. Regonini [2001]. Scott W. R. e Meyer J. W. [1983], L’organizzazione dei settori societari. Ipotesi e prime verifiche, in W. Powell e P. Di Maggio [1991]. Sen A. [2009], The idea of justice, London, Penguins Books, trad. it. L’Idea di Giustizia, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2010. Sepe S., Mazzone L., Portelli I. e Vetritto G. [2007], Lineamenti di storia dell’amministrazione italiana (1861-2006), Roma, Carocci Editore. Sorensen E. [2006], Metagovernance: the changing role of politicians in processes of democratic governance, in “The American Review of Public Administration”, v. 36, n. 1, pp. 98-114. Stoker G. [2006], Public Value Management: a New Narrative for Networked Governance?, in “The American Review of Public Administration”, v. 36, n. 1, pp. 41-57. Tilly C. [1975] (a cura di), The formation of National States in Western Europe, Princeton, Princeton University Press, trad. it. La formazione degli stati nazionali nell’Europa occidentale, Bologna, Il Mulino, 1984. Toth F. [2006], Il Servizio sanitario nazionale, in G. Capano e E. Gualmini (a cura di), La pubblica amministrazione in Italia, Bologna, Il Mulino.
Danilo Taglietti UNA MATRICE PER LE POLITICHE PUBBLICHE
23
Turri M. [2011], L’università in transizione, Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati. Wright V. [1997], The paradoxes of administrative reform, in W. Kickert (a cura di), Public management and administrative reform in Western Europe, Cherltenham, Edward Elgar, in Pollitt C. e Bouckaert G. [2000]. Zucker L. G. [1979], Il ruolo dell’istituzionalizzazione ai fini della persistenza culturale, in W. Powell e P. Di Maggio [1991].