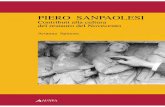Acque pubbliche ed acque private tra Otto e Novecento
Transcript of Acque pubbliche ed acque private tra Otto e Novecento
253
253
Acque Pubbliche ed acque private tra Otto eNovecentoFederico Caporale (Università di Roma “La Sapienza”)
Introduzione
Il dibattito attorno al criterio distintivo tra acque pubbliche ed acque pri-vate, da sempre molto vivace, assunse particolare rilievo nel XIX secolo, quan-do si vennero definendo i principi applicati per tutto il secolo successivo eche ancora dominano il nostro sistema concettuale.
Sin dai primi decenni dell’Ottocento, grazie ai fondamentali contributi diGiandomenico Romagnosi1 e Giacomo Giovanetti2, si assistette ad una pro-gressiva limitazione dei diritti individuali sulle acque ed alla definizione dinuovi interessi pubblici e collettivi legati alla loro utilizzazione.
Con l’industrializzazione, agli interessi pubblici sino ad allora diffusi – lanavigazione, l’utilizzo nella produzione manifatturiera e in agricoltura – si ag-giunse l’impiego massiccio delle risorse idriche nella produzione di energia3.
In primo luogo, é opportuno chiarire i concreti effetti derivanti dalla qua-lificazione giuridica delle acque come pubbliche ovvero private. Le seconde,infatti, erano oggetto della titolarità dei privati, che esercitavano su di esse unpotere amplissimo: avevano la facoltà di utilizzarle e disporne in maniera as-soluta, salvo i limiti, pur peculiari, disposti dal Codice Civile del 1865.
Avevano luogo, dunque, effetti sostanzialmente antieconomici, giacché,nonostante una generale abbondanza di acqua, alcuni agricoltori potevanoesser esclusi dall’accesso alle risorse idriche necessarie per l’irrigazione, con ungrave danno alle loro coltivazioni ed agli interessi economici collettivi4.
Inoltre, erano frequenti lunghe controversie processuali tra privati, costo-se sia in termini economici che produttivi, per l’uso di uno stesso corso d’ac-qua, a causa della non chiara definizione dei diritti sulle acque5.
Invece, affidare la titolarità delle acque allo Stato consentiva una gestionerazionale, orientata ad una equilibrata ponderazione tra gli interessi degli agri-coltori, degli industriali e dei privati cittadini.
254
254
LA C
ITTÀ
LIQU
IDA
- LA C
ITTÀ
ASSETA
TA: storia di un
rapporto di lunga durata
I diritti individuali sulle acque vennero così limitati attraverso il perfezio-namento di un ampio regime di servitù e l’estensione della categoria delle ac-que pubbliche.
Il Codice Civile 1865 e la Legge sui Lavori Pubblici (n. 2248/1865,allegato F)
Nella seconda metà del XIX secolo si determinarono sostanziali innova-zioni giuridiche e culturali, che diedero soddisfazione all’esigenza di amplia-re l’intervento dei poteri pubblici nella tutela e nella gestione delle risorse idri-che.
Il regime delle acque ebbe i suoi principali riferimenti normativi nel Co-dice Civile del 18656 e nella Legge n. 2246/1865, allegato F, cosiddetta “Leg-ge sui Lavori Pubblici”7.
I due testi differivano in molti aspetti: a) il primo faceva riferimento alleacque demaniali; il secondo alle acque pubbliche; b) il primo qualificava comedemaniali solo i corsi d’acqua maggiori (i fiumi e i torrenti); il secondo anno-verava tra le acque pubbliche anche i corsi d’acqua minori (fossati, rivi e cola-tori pubblici); c) il primo consentiva ai privati la libera utilizzazione dei corsid’acqua minori; il secondo ammetteva l’uso privato di acque pubbliche soloin virtù di concessione della pubblica amministrazione.
In ragione di tali difformità, gli operatori del diritto dovettero affrontaredue questioni fondamentali: se le nozioni di acque pubbliche e di acque de-maniali fossero coincidenti (e qualora non lo fossero, quale differenza sussi-stesse tra di esse) e quale fosse la natura giuridica – pubblica o privata – deicorsi d’acqua minori.
L’approfondimento di tali problemi ermeneutici consente di illustrare l’e-voluzione del criterio discretivo tra acque pubbliche ed acque private, sino al-la sua moderna definizione: si dimostrerà come si sia progressivamente supe-rato un criterio fisico/nominalistico (sono demaniali i corsi di acqua maggio-ri, cioè fiumi e torrenti; sono privati i corsi minori) in favore di unoteleologico/funzionale (sono demaniali le acque idonee a soddisfare interessipubblici; sono private le acque non in grado di assolvere tali scopi pubblici).
Giova rammentare che il primo criterio ha un carattere statico e formale,mentre il secondo è elastico e dinamico. Il primo, cioè, una volta disciplina-to nei testi legislativi, si cristallizza, a meno che non si verifichino modifica-
255
255
Parte
seco
nd
a.A
cque Pubbliche ed acque private tra O
tto e Novecento
zioni fisiche dei corsi di acqua (una cospicua riduzione della portata d’acqua,ad esempio); invece, il secondo si evolve con il mutare delle tradizioni socia-li, culturali ed economiche, e si modula diversamente in relazione ai differen-ti contesti geografici8.
In primo luogo, mette conto precisare ulteriormente i parametri legislati-vi richiamati.
Il Codice Civile del 1865, seguendo la tradizione piemontese9, stabilivache tra le acque demaniali dovessero ricomprendersi solo i fiumi e i torren-ti10. Tale richiamo veniva generalmente interpretato in senso tassativo, giac-ché nel novero dei beni demaniali non compariva più il richiamo estensivo eresiduale a tutte le parti del territorio non suscettibili di proprietà privata, con-tenuto, invece, nei principali antecedenti normativi a tale testo, il CodiceFrancese e il Codice Albertino11.
I corsi minori, invece, erano oggetto di un regime di libero uso da partedei rivieraschi, purché fossero soddisfatte due condizioni: le acque prelevatedovevano esser destinate ad usi agricoli o industriali e gli avanzi di esse resti-tuiti al corso ordinario12.
La Legge sui Lavori Pubblici annoverava tali corsi minori – rivi, fossati ecolature – tra le acque pubbliche13, utilizzabili dal privato solo in forza di unaconcessione o quando questi vantasse un legittimo titolo14.
Dunque, al regime di libero uso del Codice Civile si opponeva, almenoapparentemente, quello concessorio della legislazione speciale.
Concretamente, secondo la disciplina delle concessioni, la pubblica am-ministrazione doveva svolgere un giudizio prognostico sulla compatibilità del-l’uso esclusivo delle acque con gli interessi collettivi ad esse correlati: la con-cessione era possibile solo a condizione che l’uso privato non pregiudicassegli interessi pubblici.
Generalmente tali derivazioni delle acque erano sottoposte a limiti e con-dizioni, nonché al versamento di un canone, preventivamente determinatidalla medesima amministrazione15.
Invece, il Codice Civile consentiva al privato di usare immediatamente leacque, senza necessità di alcun preliminare provvedimento: questi potevaesclusivamente esser convenuto in giudizio dagli altri rivieraschi. In questocaso, il giudizio, successivo rispetto all’uso delle acque, aveva come unici ri-ferimenti valutativi i limiti anzidetti: la destinazione delle acque captate adusi agricoli od industriali e la restituzione degli avanzi al corso ordinario.
Dunque, emergono tra i due regimi alcune significative differenze: a) quel-lo civilistico disponeva esclusivamente un controllo ex post degli atti di utiliz-
256
256
LA C
ITTÀ
LIQU
IDA
- LA C
ITTÀ
ASSETA
TA: storia di un
rapporto di lunga durata
zazione dei privati sulle acque; la legislazione speciale ne prevedeva anche unoamministrativo, ex ante rispetto agli usi privati; b) la disciplina civilistica sta-tuiva la gratuità dell’uso; la legislazione speciale, generalmente, condiziona-va l’utilizzo delle acque alla corresponsione di un canone.
Il criterio discretivo tra acque pubbliche ed acque private
Apparente antinomia, questa tra Codice Civile e Legge sui Lavori Pubbli-ci, che la dottrina tardo ottocentesca tentò di risolvere offrendo una interpre-tazione conciliatoria dei due testi normativi.
Va preliminarmente osservato che, nonostante la notevole divergenza, le-gislazione speciale e Codice Civile sembravano chiaramente adottare un prin-cipio nominalistico: nella qualificazione del regime di titolarità pubblica oprivata delle acque è determinante il loro aspetto esteriore, l’essere fiumi, tor-renti ovvero rivi, fossati o colature16.
Ciò nonostante, tale criterio era spesso insufficiente a definire con certez-za quando un corso d’acqua dovesse ritenersi un fiume o un torrente (e dun-que pubblico) ovvero un rivo, un fossato o una colatura (e dunque privato).In merito, si possono liminalmente considerare le difficoltà percepite in dot-trina, in giurisprudenza e nella prassi applicativa17.
Quanto al primo ambito, è sufficiente richiamare l’intensità con cui Se-bastiano Gianzana approfondì l’argomento, dedicandovi le pagine introdut-tive di una delle sue opere principali, riproducendo pedissequamente i risul-tati raggiunti negli studi di idraulica di Domenico Turazza18. Altri autori, alcontrario, insistettero nell’osservare la assoluta impossibilità di distinguere icorsi d’acqua in minori e maggiori, facendo esclusivo riferimento alle loro ca-ratteristiche fisiche19.
Con riferimento alla giurisprudenza, basti ricordare la sentenza del 13 apri-le 1883 della Corte di Appello di Catania. I periti nominati dalla Corte ri-tennero il Cassibile «un corso intermedio fra i corsi primari, che sono i fiu-mi, ed i corsi piccoli, vale a dire i rivi»20, non riuscendo, dunque, a risolverela questione giuridica della sua demanialità facendo esclusivo riferimento alcriterio nominalistico21.
In relazione alla prassi amministrativa, mette conto fare un breve cennoalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 6 febbraio 1888. Essa ri-levò che «la sola denominazione data ad un corso d’acqua non potrebbe es-sere una guida certa ed inoppugnabile per distinguere le acque pubbliche dal-
257
257
Parte
seco
nd
a.A
cque Pubbliche ed acque private tra O
tto e Novecento
le private. Infatti tali denominazioni sono diversamente usate nelle diverse re-gioni, e corsi d’acqua di ugual natura sono diversamente denominati nelleprovince settentrionali, nelle medie e nelle meridionali d’Italia»22.
Va tuttavia ricordato che, al fine della determinazione della demanialità/pub-blicità23, né nel testo del Codice Civile né nella legislazione speciale veniva-no tenuti in considerazione gli interessi pubblici che le acque sono in gradodi assolvere.
Invece, qualche vago riferimento al criterio finalistico, gli interessi pub-blici cui l’acqua era in grado di assolvere, era già stato delineato nella dottri-na italiana, seppure ancora in maniera parziale e non pienamente definita.
In primo luogo, occorre citare l’essenziale contributo di GiandomenicoRomagnosi. In due lavori fondamentali, La condotta delle acque (1824) e Del-la ragione civile delle acque nella rurale economia (1829-1830), l’autore distin-se i beni oggetto di titolarità pubblica fondando il proprio ragionamento sul-la nozione di interesse pubblico. Lo Stato era proprietario di due classi di be-ni: quelli pubblici, destinati ad un uso pubblico, e quelli oggetto di pura «ap-partenenza fiscale o demaniale, ma non di uso pubblico» di cui lo Stato go-deva come fosse un privato proprietario24: dunque, la proprietà pubblica nonera di per sé garanzia di utilizzo collettivo.
Le acque appartenevano alla prima classe di beni solamente qualora fos-sero in grado di soddisfare un uso pubblico25 e tale destinazione doveva esse-re effettiva ed attuale (e non solo meramente potenziale) e doveva intender-si come «elemento obiettivo di fatto, soggetto a possibili mutamenti nel tem-po»26.
Romagnosi elaborò la propria sistematica quando era vigente in Franciail Code Napoléon (che qualificava come demaniali solamente i corsi d’acquanavigabili o atti al trasporto27), all’incirca un decennio prima della redazionedel Codice Albertino e quasi mezzo secolo prima del Codice Civile del 1865.Il criterio discretivo da lui adottato fu chiaramente funzionale, elastico, de-stinato a rinnovarsi nel tempo: possedeva i caratteri determinanti che si af-fermeranno nei primi tre decenni del XX secolo28.
Quindi, gli usi pubblici quale criterio caratterizzante per l’individuazionedelle acque pubbliche, più che le caratteristiche fisiche di esse, acquisironouna centralità evidente già nella sistematica di Romagnosi.
In secondo luogo, si deve far cenno ai lavori di Giacomo Giovanetti. L’apporto di Giovanetti, avvocato novarese, è ritenuto essenziale nella pro-
gressiva definizione del regime giuridico delle acque in Italia ed in Europa29. Allievo ed amico di Romagnosi30, egli fu incaricato dal Ministro di Gra-
258
258
LA C
ITTÀ
LIQU
IDA
- LA C
ITTÀ
ASSETA
TA: storia di un
rapporto di lunga durata
zia e Giustizia Carlo Barbaroux di redigere una Memoria destinata a costitui-re un contributo angolare nella redazione definitiva del Codice Civile del183731.
Il prestigio e la qualità della sua opera fu tale che egli divenne consulentedei governi russo32, francese33, tedesco34, portoghese35.
Giovanetti ritenne che tutti i corsi d’acqua, a prescindere dalla loro por-tata, dovessero essere oggetto di potestà pubblica e che il loro utilizzo doves-se esser regolato tramite lo strumento concessorio.
Il rilievo attribuito agli interessi pubblici fu significativo: egli giunse a so-stenere il superamento di qualsiasi distinzione tra acque pubbliche e priva-te36, lasciando quale unico, residuale, spazio per i diritti individuali la disci-plina delle concessioni, attraverso cui la pubblica amministrazione poteva as-sicurarsi che le utilizzazioni private non pregiudicassero gli interessi pubblicie collettivi.
La redditività delle acque, le esigenze dell’agricoltura e dell’industria di-vennero, nei contributi teorici e pratici di questi insigni studiosi, ragioni net-tamente preponderanti rispetto ai bisogni individuali37.
Gli usi pubblici acquisirono, così, una assoluta centralità nella limitazio-ne dei diritti individuali: non furono criterio di discernimento tra titolaritàpubblica e privata sulle acque, ma limite e presupposto della concessione.
Il dibattito successivo alla legislazione dell’Italia Unita
Alla fine dell’Ottocento, quando il legislatore non aveva ancora tradottoin norma giuridica il pensiero di Romagnosi e Giovanetti, la scienza giuridi-ca italiana – i professori di materie privatistiche e pubblicistiche, le ammini-strazioni statali, le magistrature inferiori e superiori – poteva essere suddivi-sa in tre principali correnti, a seconda dell’interpretazione offerta alla richia-mata contrapposizione tra disciplina civilistica e legislazione speciale38: a) i“privatisti” propesero per l’applicazione ai corsi d’acqua minori dell’articolo543 del Codice Civile; b) i “demanialisti” si schierarono in favore della pre-valenza della Legge sui Lavori Pubblici; c) il cosiddetto “sistema distinguen-te” optò per una posizione intermedia, ritenendo che i corsi d’acqua minoripotessero essere tanto pubblici, quanto privati, in ragione della loro capacitàdi soddisfare interessi pubblici.
Giova ripercorrere sinteticamente le argomentazioni delle tre sistematicheper comprendere meglio la conclusione proposta dalla giurisprudenza.
259
259
Parte
seco
nd
a.A
cque Pubbliche ed acque private tra O
tto e Novecento
Come anticipato, i “privatisti” annoveravano tra le acque demaniali soloi fiumi e torrenti e sottoponevano i corsi d’acqua minori al regime di liberouso dell’articolo 543 del Codice Civile.
Il criterio discretivo tra acque pubbliche ed acque private era di caratterestrettamente nominalistico: la titolarità demaniale o privata delle acque eradeterminata dalla natura di fiumi e di torrenti piuttosto che di corsi minori39.
In realtà, pur nella rigida applicazione di questo criterio, è opportuno se-gnalare la presenza di significative eccezioni: a tal proposito, si può richiama-re ancora la sentenza della Corte di Appello di Catania del 13 aprile 1883.
Nella difficoltà di fondare il proprio giudizio solo su criteri ingegneristicie scientifici (la quantità d’acqua portata dal fiume ed il volume di esso nel pe-riodo estivo ed in quello invernale), la Corte, pur ribadendo l’applicazionedel criterio meramente fisico/nominalistico, ritenne di dover argomentare lapropria statuizione riferendosi alla existimatione circumcolentium, principiodi tradizione romanistica, secondo il quale doveva procedersi, ai fini della ri-cognizione di ciò che fosse corso d’acqua maggiore o minore, alla valutazio-ne delle opinioni degli studiosi di storia e geografia, nonché degli abitanti deiluoghi ove il fiume scorreva40.
Una analisi rigidamente formale, tipica del criterio nominalistico (alme-no come affermatosi nella tradizione giuridica dei primi settanta anni delXIX Secolo) venne resa parzialmente elastica, attraverso il ricorso ad unaspetto di carattere storico, sociale e culturale, che tendeva a privilegiare l’u-tilità della risorsa nel contesto geografico più che gli elementi fisici del cor-so d’acqua.
Peraltro, la peculiarità di tale prima corrente fu l’aver individuato una dif-ferenza ontologica tra demanialità e pubblicità delle acque: acque demanialied acque private erano caratterizzazioni che attenevano alla titolarità sogget-tiva del bene; la pubblicità, invece, era un carattere funzionale, che poteva ac-compagnarsi ad entrambi i regimi proprietari41.
Infatti, la pubblicità non atteneva all’aspetto proprietario, ma alla naturaintrinseca del bene: era correlata alla rilevanza sociale delle acque, intese co-me forze naturali in grado di arrecare, al contempo, grande ricchezza e tre-mende devastazioni.
Il ruolo dello Stato, relativamente alle acque pubbliche, era di sorveglian-za, controllo e tutela: rispondeva ad un interesse sociale evidente – evitare idanni cagionati dalla negligenza dei privati sulle acque di loro proprietà – esi connotava per il suo carattere residuale e sostitutivo.
Dunque, i corsi d’acqua minori restavano pienamente privati, per quan-
260
260
LA C
ITTÀ
LIQU
IDA
- LA C
ITTÀ
ASSETA
TA: storia di un
rapporto di lunga durata
to riguarda il regime proprietario, ma venivano considerati pubblici per la lo-ro rilevanza sociale.
L’immagine che se ne desume è quella di una impostazione fortemente li-berale, nel quale allo Stato vengono assegnati poteri di vigilanza e controlloal fine di proteggere la comunità, ma non compiti di intervento diretto nel-la gestione – economica e razionale – delle acque al fine di orientare lo svi-luppo e la crescita della collettività.
Il secondo orientamento dottrinale, definito “demanialista”, estendeva il re-gime della legislazione speciale a quasi tutti i corsi di acqua, ritenendo applica-bile l’articolo 543 del Codice Civile a pochi, sparuti ed eccezionali casi42. Iniziòad emergere uno specifico riferimento di carattere teleologico/funzionale, desu-mibile in via generale dall’articolo 429 del Codice Civile43.
Tuttavia l’applicazione che di esso veniva proposta non era ancora elastica,né dinamica, ma tendeva a fondersi, al contrario, con il criterio fisico/nomina-listico: erano infatti ritenute pubbliche pressoché tutte le acque, cui veniva rico-nosciuta implicitamente la capacità di servire interessi pubblici.
Quindi, non vi era ancora una valutazione caso per caso, una analisi speci-fica delle peculiarità di ciascun corso d’acqua, dalla quale si faceva discenderela sua capacità a servire interessi pubblici: tale capacità era, infatti, presupposta.
La dottrina “demanialista”, muovendo dalla identità tra demanialità e pub-blicità, estendeva semplicemente l’elencazione offerta dall’articolo 427 del Co-dice Civile a tutte le acque, ritenendo una mera, involontaria omissione la man-cata inclusione dei corsi d’acqua minori nell’elenco proposto in questo articolo,ed interpretando la disposizione normativa in combinato disposto con l’artico-lo 429 del Codice Civile – che richiamava la funzione generale cui dovevano ser-vire i beni demaniali – e con la legislazione speciale, che chiaramente includevai corsi minori tra le acque pubbliche.
Dunque, il richiamo alla capacità di soddisfare interessi pubblici era solo unodegli spunti argomentativi, e neppure il principale, su cui veniva fondato il cri-terio discretivo tra acque pubbliche ed acque private.
Piuttosto, esso sembra essere stato usato in via integrativa, per dimostrare lanon tassatività dell’articolo 427 del Codice Civile, che rimaneva parametro nor-mativo fondamentale.
Pertanto l’idoneità a soddisfare interessi pubblici divenne strumento er-meneutico, piuttosto che riferimento risolutivo in via diretta: esso fu utiliz-zato per ampliare l’applicazione del criterio fisico/nominalistico dell’articolo427 del Codice Civile oltre il mero riferimento ai fiumi e torrenti, al fine diincludervi implicitamente anche i corsi d’acqua minori.
261
261
Parte
seco
nd
a.A
cque Pubbliche ed acque private tra O
tto e Novecento
Non a caso tale seconda sistematica confermava la titolarità privata sullerisorse idriche quando la lettera del Codice Civile non sembrava consentireagili “vie di fuga” interpretative, come nel caso delle sorgenti44.
Dunque, sono state esposte due chiare evidenze della rilevanza acquisitadagli usi pubblici nella tassonomia delle acque: la sentenza della Corte di Ap-pello di Catania e la dottrina “demanialista” offrono esempi del crescente ruo-lo assunto dalla capacità a soddisfare interessi pubblici, pur in una sistemati-ca generale ancora fortemente orientata verso la prevalenza del criterio distin-tivo fisico/nominalistico.
Una prima dichiarazione di preferenza per il criterio teleologico/funzio-nale si ha, in dottrina, con il “sistema distinguente”45.
Secondo i giuristi aderenti a tale corrente il regime proprietario delle ac-que dipendeva dalla idoneità a servire pubblici interessi: la natura fisica delcorso d’acqua diventava solo un elemento secondario nella determinazionedella qualificazione giuridica di esso.
In ragione della differente area geografica su cui insistevano e del conse-guente diverso contesto economico, culturale e sociale, un grande fiume po-teva non essere giudicato idoneo a servire pubblici interessi, mentre potevaesserlo un piccolo corso d’acqua.
Dunque, la idoneità a servire pubblici interessi si sostanziava in una plu-ralità di elementi: delle consuetudini e dei fatti, nonché dello stato vero deiluoghi ove le acque si trovano, delle circostanze di positura, di grandezza,del volume, della natura e del corso di esse, dell’utilità economica dei lorousi46.
Tale criterio è evidentemente elastico e dinamico: l’utilità economica simodifica con lo sviluppo tecnologico e culturale, le consuetudini sono entitàdiacroniche, l’opinione sociale può evolversi nel corso del tempo.
La prevalenza del criterio teleologico/funzionale trovò piena affermazio-ne giurisprudenziale nel dicembre 1910, quando una rilevante decisione del-la Corte di Cassazione di Roma ritenne «più razionale», ai fini della determi-nazione della pubblicità/demanialità delle risorse idriche, applicare il princi-pio della destinazione dell’acqua all’uso pubblico, consistente «oltre che nel-la navigabilità e nella fluitazione, nella derivazione (art. 3 L. 10 agosto 1884)»47.Il riconoscimento della pubblicità/demanialità di un corso d’acqua fu ritenu-to una «questione di fatto»48, che doveva esser risolta caso per caso, al termi-ne di una valutazione individuale che tenesse conto dei peculiari aspetti geo-grafici, storici, sociali, economici49.
A riprova di tale cambiamento interpretativo, vi è la diffusione dell’utiliz-
262
262
LA C
ITTÀ
LIQU
IDA
- LA C
ITTÀ
ASSETA
TA: storia di un
rapporto di lunga durata
zo della nozione di bacino idrografico. Essa venne progressivamente adope-rata in luogo dei vocaboli fiumi e torrenti nelle principali decisioni giurispru-denziali50, nei contributi di dottrina51 e nei testi legislativi52.
Infatti, il concetto di bacino idrografico aveva una ampiezza maggiore deivocaboli fiumi e torrenti: questi ultimi facevano riferimento, principalmente,al principio nominalistico e, dunque, alle caratteristiche fisiche e geografichedel corso d’acqua (quali, ad esempio, portata, volume e pressione delle ac-que); il primo, al contrario, teneva in considerazione anche gli elementi dicarattere sociale, economico e culturale peculiari del luogo ove le acque scor-revano e, conseguentemente, degli interessi pubblici e collettivi che esse era-no in grado di soddisfare.
Conclusioni
Il criterio teleologico/funzionale così definito è stato posto a riferimentodella successiva legislazione53.
Tale evoluzione dimostra che le acque, in quanto beni essenziali da unpunto di vista sociale ed economico, sono state e sono oggetto di un partico-lare regime giuridico54.
La loro vicenda storica denota una impostazione legislativa fortemente im-perniata sugli usi, sulle utilizzazioni concrete cui le acque sono destinate, dacui la disciplina della loro proprietà - pubblica o privata - è stata sempre for-temente condizionata.
Gli usi pubblici (bisogni domestici, irrigazione, navigazione, utilizzazioniindustriali, solo per citarne alcuni) hanno determinato, dapprima, il riconosci-mento di diritti individuali sulle acque e, successivamente, la progressiva limi-tazione di essi e l’affermazione di un regime di tutela privatistica (servitù) e pub-blicistica (ampliamento delle acque demaniali e legislazione speciale)55.
Può concludersi che gli usi delle acque abbiano fortemente indirizzato la di-sciplina puntuale: l’appartenenza pubblica delle risorse idriche è stata ritenuta,in passato, la modalità più efficace di garanzia e protezione degli usi colletti-vi e pubblici che l’acqua soddisfa.
L’impressione è che in materia di acque, già nel corso dell’Ottocento, sisia determinata l’inversione concettuale del classico percorso di definizionedella tassonomia dei beni: si è proceduti “dai beni ai regimi” invertendo ilpercorso classico, che va “dai regimi ai beni”56.
Tale impostazione, adottata da recenti sentenze della Corte Costituziona-
263
263
Parte
seco
nd
a.A
cque Pubbliche ed acque private tra O
tto e Novecento
le57, è oggi ancor più attuale alla luce della proposta di attribuire alle risorseidriche lo statuto giuridico di beni comuni, il cui regime ed i cui contenuti so-no tutt’ora in discussione58.
Note
1 Si tratta dei due studi monografici Della condotta delle acque (1824) e Della ragion civile delle ac-que nella rurale economia (1829-1830). Per un giudizio sull’apporto di Romagnosi nel dibattitogiuridico relativo alle acque, cfr. ASTUTI G., Il regime giuridico delle acque nel pensiero di GianDomenico Romagnosi (1961), in DIURNI G. (a cura di), Tradizione romanistica e cultura giuridi-ca europea, Napoli 1984, pp. 1251-1302; ID., La concezione romagnosiana della ragion civile del-le acque (1963), in ivi, pp. 1305-1331; ID., Problemi attuali di legislazione ed amministrazionedelle acque, in «Cultura e scuola», XII (1969), pp. 166-173.
2 Giacomo Giovanetti è autore di numerosi scritti di particolare rilevanza in materia di acque,fra i quali si vedano: GIOVANETTI G., Del regime delle acque (1844), Venezia 1873, ristampaanastatica, Novara 1989 e ID., Entwurf eines Gesetzes über die Benutzung des Wassers, in «Kriti-sche Zeitschrift für Rechtwissenchaft und Gestetzgebung des Auslandes», XVI (1844), pp. 467-481, nonché la Memoria e gli altri lavori per il Codice civile albertino; Sul governo delle acqueed i contributi inediti conservati all’Archivio Storico di Novara (su cui cfr. MOSCATI L., In ma-teria di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina, Roma 1993, pp. 111-141; 294).
3 La migliore testimonianza del nuovo modo di utilizzare le acque è offerta da NITTI F.S., La con-quista della forza. L’elettricità a buon mercato. La nazionalizzazione delle forze idrauliche, Torino-Roma 1905. In proposito può leggersi l’approfondimento di MANETTI D., La legislazione sulleacque pubbliche e sull’industria elettrica, in MORI G. (a cura di), Storia dell’industria elettrica inItalia. Le origini. 1882-1914, vol. I, Roma 1992, pp. 111 e ss.
4 Cfr. GIOVANETTI G., Del regime delle acque (1844)... cit, pp. 41-43 e DE MAUNY DE MORNAY
J., Relazione sulla pratica e sulla legislazione delle irrigazioni nell’Italia superiore e in alcuni statid’Alemagna, in GIOVANETTI G., Del regime delle acque (1844)... cit, p. 130.
5 Questa imprecisa definizione dei diritti individuali possiede i caratteri della tragedia degli anti-commons, su cui cfr. HELLER M., The tragedy of the Anticommons: property in transition from Marxto Markets, in «Harvard Law Review», CXI (1998), pp. 621-688; ID., The gridlock economy. Howtoo much ownership wrecks markets, stops innovation, and costs lives, New York 2008.
6 Codice Civile del Regno d’Italia (1865), Titolo III Delle modificazioni della proprietà, Capo IIDelle servitù prediali (in particolare artt. 536-545).
7 Legge n. 2246/1865, allegato F (“Legge sui Lavori Pubblici”), Titolo III Delle acque soggette apubblica amministrazione, artt. 91 e ss.
8 RANELLETTI O., Concetto, natura e limiti del demanio pubblico, vol. II, Torino 1898, pp. 57-58.9 Su cui cfr. SCLOPIS F., Storia della legislazione italiana, vol. I, parte III, Torino 1864, ristampa ana-
statica Milano 1972, p. 283; GIANZANA S., Le acque nel diritto civile italiano, vol. I, Torino 1879,p. VIII. Per una ampia e completa ricostruzione del regime giuridico delle acque anteriormentealla promulgazione del Codice civile del 1865 cfr. MOSCATI L., In materia di acque... cit, pp. 15e ss. Mette conto precisare che quello piemontese viene universalmente riconosciuto come il re-gime più evoluto dell’epoca. In questo senso, cfr. SCLOPIS F., Storia della legislazione italiana... cit,p. 283 e CONSEIL D’ETAT, L’eau et son droit. Rapport public, Paris 2010, p. 299.
10 Codice Civile del Regno d’Italia (1865), art. 427: Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, iseni, le spiagge, i fiumi e i torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e del-le fortezze fanno parte del demanio pubblico.
264
264
LA C
ITTÀ
LIQU
IDA
- LA C
ITTÀ
ASSETA
TA: storia di un
rapporto di lunga durata
11 Codice Civile Francese (1804), art. 538: Tutte le strade che sono a carico dello Stato, i fiumi e le rivie-re navigabili o adatte ai trasporti, le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare, i porti, i seni,le spiagge e generalmente tutte le parti del territorio francese non suscettive di proprietà privata, sono con-siderati come pertinenze del demanio pubblico. Codice Civile Albertino (1837), art. 420: Le stradepubbliche, fuorchè le comunali, i fiumi e torrenti, il lido del mare, i siti occupati od abbandonati dal me-desimo, i porti, seni e le spiagge, e generalmente tutti i punti del territorio dello Stato non suscettibili diprivata proprietà, sono pertinenze del regio demanio. Mette conto rilevare che, tra gli altri testi norma-tivi precedenti al Codice Civile del 1865, anche il Codice civile parmense (art. 397), quello estense(art. 430) e le Leggi civili napoletane (art. 463) mantenevano il riferimento alle parti di territorionon suscettibili di proprietà privata. Ne era sprovvisto, invece, il Codice austriaco (art. 287).
12 Codice Civile del Regno d’Italia (1865), art. 543: Quello il cui fondo costeggia un’acqua che corre na-turalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall’art. 427, o sulla quale al-tri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne uso per la irrigazione dei suoi fondi o per l’esercizio dellesue industrie, a condizione però di restituirne le colature e gli avanzi al corso ordinario. Quello il cui fon-do è attraversato da quest’acqua, può anche usarne nell’intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll’obbligodi restituirla al corso ordinario mentre esce da’ suoi terreni. Articolo, questo, che è stato oggetto di unamplissimo dibattito dottrinale, tanto in relazione al diritto assegnato al privato (di proprietà esclu-siva, di comproprietà, di uso, di semiproprietà, solo per citare alcune delle ricostruzioni proposte),quanto ai poteri effettivamente esercitabili ed ai limiti ad essi.
13 Legge n. 2246/1865, all. F, art. 102: I minori corsi naturali di acque pubbliche, distinti dai fiumi edai torrenti colla denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, sono mantenuti dai proprietari deibeni che li fronteggiano o di quelli cui servono di scolo, e dai possessori od utenti delle loro acque. Per ta-le manutenzione e per regolare l’ordinamento dell’alveo dei suddetti corsi d’acqua si stabiliscono consor-zi in conformità del disposto del capo II di questo titolo, quando concorra l’assenso degli interessati, a se-conda dell’art. 108.
14 Legge n. 2246/1865, all. F, art. 132: Nessuno può derivare acque pubbliche né stabilire su queste mo-lini od altri opifizi se non ne abbia un legittimo titolo, o non ne ottenga la concessione dal Governo.
15 Cfr. MOSCATI L., Le concessioni di acque tra Diritto comune e codificazione unitaria, in I rapporti con-trattuali della pubblica amministrazione nell’esperienza storico-giuridica. Congresso internazionale del-la Società italiana di Storia del diritto (Torino, 17-19 ottobre 1994), Napoli 1997, pp. 318-349. Sivedano anche: NONNIS A., I canoni di uso delle acque pubbliche, Milano 1934; SCIALOJA A., Le de-rivazioni di acque pubbliche e l’esperimento della nuova legge, Roma 1918; STOLFI N., Le derivazionieventuali e future di acque pubbliche, Torino 1915; TONINI V., Sulle derivazioni di acque pubbliche,in Giornale del genio civile, LIII (1915), pp. 3-21; FIORENZA G., Le acque pubbliche e la legge del 10agosto 1884, Milano 1904. Per un’ampia rassegna ed un commento alla giurisprudenza di tardo Ot-tocento e primo Novecento in materia di concessioni di acque pubbliche, cfr. D’ALBERTI M., Leconcessioni amministrative. Aspetti della contrattualità delle pubbliche amministrazioni, Napoli 1981,con particolare riferimento alle pp. 29-39; 39-145; 156-162.
16 Questo riferimento di carattere nominalistico è una delle ragioni di grande originalità della espe-rienza giuridica piemontese rispetto a quelle coeve. Introdotto con le Regie Costituzioni del 1729,esso si discosta fortemente dal criterio della navigabilità (sono demaniali le acque dei fiumi e dei tor-renti, purché navigabili o atte al trasporto) tipico della tradizione giuridica romana e seguito anchedal legislatore francese (Codice civile 1804). Cfr. BENEDETTO M.A., Acque (Diritto Intermedio), in«Novissimo digesto italiano», Torino 1960, p. 206. Sul non pieno superamento del criterio della na-vigabilità nel Codice Albertino si vedano le osservazioni di SOLIMANO S., Il letto di procuste. Dirit-to e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861), Milano 2003,p. 322. Nella penisola italiana, la prima disposizione che incamera le acque nel demanio pubblicoè il decreto del Senato Veneto del 6 febbraio 1556, su cui cfr. CASTELLI-AVOLIO G., Commento al-le leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, Roma 1935, p. 54 e MARRACINO A. - CONTE E., Com-mentario delle nuove disposizioni legislative sulle acque pubbliche, Roma 1917, pp. 35 e ss.
265
265
Parte
seco
nd
a.A
cque Pubbliche ed acque private tra O
tto e Novecento
17 Cfr. PANZARASA R., Le acque oggetto di pubblica amministrazione, in «Rivista di diritto pubblico», VI(1914), II, pp. 492-495.
18 GIANZANA S., Le acque nel diritto civile italiano, vol. I, Torino 1879.19 Cfr., ad esempio, DIONISOTTI C., Delle servitù delle acque, Torino 1872, p. 33: «In cospetto alla le-
gislazione italiana che si debba intendere per fiume e per torrente è molto incerto, mancando gli ele-menti positivi per distinguerli. Imperciocchè, fatta astrattazione per quei fiumi principali che sonotali da secoli, nei quali oltre ad essere l’acqua continua, scorre sempre in gran massa, tutte le corren-ti minori difficilmente possono esser talmente determinate da non lasciare alcun dubbio, se rivesta-no la natura di fiumi, piuttosto che quella di torrenti»; POSSENTI C., Sulla distinzione delle acquepubbliche dalle private, in «Giornale del genio civile», VII (1869), parte non ufficiale, pp. 282-297e GIORGI G., La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali, vol. III, Firenze 1892, pp. 322-325.
20 Corte di Appello di Catania, 13 aprile 1883, in «Foro Italiano», IX (1884), I, pp. 411 e ss.21 In senso analogo, cfr. Corte di Appello di Napoli, 18 marzo 1907, in «Giurisprudenza Italiana», LIX
(1907), I, 2, pp. 814 e ss., la quale considera elementi qualificanti dei fiumi e dei torrenti anche l’im-portanza e gli usi delle loro acque; Corte di Cassazione di Torino, 9 settembre 1909, in «La giuri-sprudenza: collezioni di sentenze della corte d’appello di Torino e di altre corti e tribunali», XLVII(1910), pp. 337 e ss.
22 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 6 febbraio 1888, n. 2116-159, su cui cfr. MAZZA A.,Dei diritti sulle acque, Roma 1913, pp. 93-96.
23 Si utilizzano ambedue i termini per superare le incertezze circa la omologia delle nozioni di acquedemaniali e pubbliche, oggetto di ampie discussioni in dottrina ed in giurisprudenza.
24 ROMAGNOSI G.D., Della condotta delle acque (1824), in DE GIORGI A. (a cura di), Della condottadelle acque e della ragione civile delle acque. Trattati di Gian Domenico Romagnosi riordinati da Ales-sandro De Giorgi, Milano 1843, pp. 36-41 e ID., Della ragione civile delle acque nella rurale econo-mia (1829-1830), in ivi, pp. 1286-1291. Va precisato che Gian Domenico Romagnosi utilizza ilvocabolo demaniale nel senso oggi assegnato al concetto di patrimoniale.
25 ROMAGNOSI G.D., Della ragione civile delle acque nella rurale economia (1829-1830)... cit, p. 1287.26 ASTUTI G., Il regime giuridico delle acque nel pensiero di Giandomenico Romagnosi... cit, p. 1277.27 Cfr. supra nt. 11. L’ordonnance n. 2006-460 del 21 aprile 2006 ha abrogato l’articolo 538 del Code
Civil, inserendo la disciplina del demanio pubblico fluviale francese nella seconda parte del Codegénéral de la propriété des personnes publiques, al libro I, titolo I, Capitolo I, sezione III Domain pu-blic fluvial (art. L2111-7 a L2111-13).
28 Mette conto ricordare che Romagnosi concludeva, in ragione della vigenza del Code Napoléon, chel’unico interesse pubblico sino a quel momento codificato fosse la navigazione. Ciò non esclude,tuttavia, il carattere elastico e dinamico delle sue considerazioni teoriche. Sostanzialmente, egli rite-neva che il legislatore avesse individuato, in maniera vincolante, l’unico uso pubblico delle acque,ma che, in futuro, avrebbero potuto esserne riconosciuti e codificati di nuovi.
29 Cfr. MOSCATI L., In materia di acque... cit, pp. 253 e ss. 30 GIOVANETTI G., Del regime delle acque (1844)... cit, p. 13.31 Giovanetti stesso precisa che il suo pensiero venne, pressoché interamente, accolto dal legislatore ita-
liano. Cfr. GIOVANETTI G., Del regime delle acque (1844)... cit, pp. 8-9.32 In proposito, cfr. MOSCATI L., In materia di acque... cit, pp. 257-266. 33 Giovanetti scrive Del regime delle acque su incarico dell’ispettore generale dell’agricoltura in Francia,
Joseph de Mauny de Mornay, al fine di contribuire ai progetti di riforma della legislazione francesein materia di acque.
34 Cfr. MOSCATI L., Giovanetti e Mittermaier: sul regime giuridico delle acque, in Giacomo Giovanet-ti tra politica e diritto: Atti del convegno di studi (Orta San Giulio, 20-21 aprile 1990), Torino1992, pp. 1-18 e GIOVANETTI G., Entwurf eines Gesetzes über die Benutzung des Wassers... cit, pp.467-481.
35 Cfr. MOSCATI L., In materia di acque... cit, pp. 296-298.
36 È opportuno precisare che nella Memoria realizzata per la redazione del Codice Albertino, Gia-como Giovanetti ritenne, invece, sussistente una distinzione tra acque pubbliche e private fon-data sulla loro destinazione ed utilizzazione pubblica. Questa prima concezione era, comunque,maggiormente estensiva rispetto alla tradizione francese ed austriaca, giacché attribuiva la pub-blicità anche a corsi d’acqua minori, purché utili all’agricoltura o all’industria, destinati all’usopubblico ovvero che contribuivano a rendere navigabili quelli maggiori. Cfr. MOSCATI L., Inmateria di acque... cit, p. 131.
37 Giova richiamare la acuta distinzione tra vantaggio patrimoniale ed economico, proposta daDE CUPIS A., Del concetto di proprietà sulle acque fluenti, Roma 1909, p. 35, secondo il qua-le il vantaggio patrimoniale attiene alla sfera individuale, mentre quello economico, correla-to al benessere della collettività, trascende la dimensione privata, acquisendo carattere pub-blico e generale.
38 Si usa la suddivisione adottata quasi unanimemente dalla dottrina coeva e moderna. Cfr., adesempio, PACELLI F., Le acque pubbliche, Torino 1913, pp. 64-65; CASTELLI-AVOLIO G., Com-mento alle leggi sulle acque... cit, pp. 64 e 115 e ss.; ZANOBINI G., Corso di diritto amministrati-vo, vol. IV, Milano 1958, pp. 66 e ss., LUGARESI N., Le acque pubbliche: profili dominicali, di tu-tela e di gestione, Milano 1995 pp. 26 e ss. Mette conto precisare che tale suddivisione deve ri-tenersi puramente orientativa: sussistono, talora, differenze profonde tra autori afferenti alle me-desime correnti e molteplici punti di contatto tra le ricostruzioni di esponenti di differenti teo-riche. Si segnalano, inoltre, le diverse suddivisioni adottate da CODOVILLA E., Del diritto delleacque, Torino 1905, pp. 49 e ss. e MARRACINO A. - CONTE E., Commentario delle nuove dispo-sizioni legislative... cit, pp. 47 e ss.
39 Cfr. GIANZANA S., Le acque nel diritto civile italiano... cit; DIONISOTTI C., Delle servitù delle ac-que... cit; RATTO L., Il nuovo regime legale delle acque e delle foreste, Roma 1909, pp. 43-81; ID.,Carattere ed enumerazione delle acque demaniali, in «La legge: monitore giudiziario ed ammini-strativo», XXXIII (1893), I, pp. 26-35 e 67-72; ID., Le acque pubbliche non demaniali, in «Lalegge: monitore giudiziario ed amministrativo», XXXIII (1893), I, pp. 499-504 e 536-540; RA-NELLETTI O., Concetto, natura e limiti del demanio pubblico... cit, pp. 25-98; GADDA E., Degliarticoli 427 e 543 del Codice Civile combinati coll’art. 1° della legge 20 marzo 1865 all. F, in «Ar-chivio Giuridico», XIX (1877), pp. 189-194.
40 «In vero, i periti giudicarono che il Cassibile, idrologicamente parlando non costituisca un fiu-me; sì bene un corso intermedio fra i corsi primari, che sono i fiumi, ed i corsi piccoli, vale a ri-dire i rivi; che sia insomma un fiumicello, un grosso rivo, un corso che partecipa della riviera edel torrente; dacché, mentre è perenne (caratteristica, che la riviera ha di comune col fiume) s’in-grossa e riceve subitaneo e notevole incremento dalle piogge (ciò che distingue i torrenti daglialtri corsi); epperò vennero a definirlo riviera torrenziale. E dalla sua natura, non essendo navi-gabile, e dal volume, comparativamente scarso, delle sue acque, specialmente nelle massime ma-gre, inferirono che sia un corso capace di privata proprietà. Ma siffatta conclusione, guardandoai principii dell’antico e del moderno diritto è destituita d’ogni fondamento. E per fermo, è benovvia, dapprima la massima della romana sapienza che, flumen a rivo ex magnitudine discernen-dum est aut existimatio circumcolentium (leg. 1, § 1. Dig. De fluminibus)». Corte di Appello diCatania, 13 aprile 1883, in «Foro Italiano», IX (1884), I, p. 416. Non si tratta, peraltro, di unagiurisprudenza isolata, ma di una tendenza rinvenibile in una pluralità di sentenze. Cfr., ad esem-pio, Tribunale di Torino, 22 febbraio 1862 e Corte di Appello di Genova, 19 ottobre 1882, sucui POSSENTI C., Sulla distinzione delle acque pubbliche dalle private... cit, pp. 433 e ss.; nonchéCorte di Cassazione di Torino, 8 febbraio 1882, in «La legge: monitore giudiziario ed ammini-strativo», XXII (1882), I, pp. 556 e ss. e Corte di Cassazione di Roma, 13 marzo 1882, in «Lalegge: monitore giudiziario ed amministrativo», XXIII (1883), pp. 442 e ss.
41 Ai fini del presente studio mette conto accennare che tale distinzione è stata ripresa recentemen-
266
266
LA C
ITTÀ
LIQU
IDA
- LA C
ITTÀ
ASSETA
TA: storia di un
rapporto di lunga durata
te, a seguito della dichiarazione generalizzata di pubblicità delle acque operata dalla Legge n.36/1994, c.d. Legge Galli. In proposito cfr. DI MAJO A., Le risorse idriche nel vigente ordinamen-to, in «Rassegna giuridica dell’energia elettrica», XII (1996), pp. 1-11.
42 TIEPOLO G., Le acque pubbliche nella legislazione italiana con riguardo ai diritti possessorii ed al-le concessioni, Torino 1889; MAZZA A., Delle acque nei rapporti con la pubblica amministrazione,Torino 1893; ID., La teorica delle acque pubbliche Torino 1900; ID., Dei diritti sulle acque, cit.,Roma 1913. Anche CODOVILLA E., Del diritto delle acque... cit, pp. 76-98 conclude in favoredella demanialità di tutte le acque, seppure con argomentazioni originali e profondamente di-verse dai due precedenti autori.
43 Codice Civile del Regno d’Italia (1865), art. 429: I terreni delle fortificazioni o dei bastioni dellepiazze da guerra che più non abbiano tale destinazione, e tutti gli altri beni che cessino di essere de-stinati all’uso pubblico ed alla difesa nazionale, passano dal demanio pubblico al patrimonio delloStato. Veniva ritenuto implicito, dunque, che la destinazione ad uso pubblico costituisse il crite-rio fondamentale al fine di determinare l’appartenenza di un bene al demanio dello Stato.
44 Attorno alla titolarità delle sorgenti ebbe luogo una lunga disputa, in dottrina ed in giurispru-denza. L’art. 540 del Codice, infatti, consentiva ai privati di usarne le acque a piacimento, sal-vo i diritti acquistati dai proprietari inferiori, l’obbligo di non creare danno ad altri fondi, non-ché il divieto di deviarle qualora esse fossero necessarie per gli abitanti di un comune. L’assegna-zione di tali, ampi, poteri in capo ai privati poteva finire per inficiare persino le acque demania-li: infatti il proprietario della sorgente caput fluminis non conosceva limiti ulteriori rispetto aquelli già menzionati e, dunque, poteva ridurre, anche sensibilmente, il volume delle acque delfiume, ostruendone, utilizzandone ovvero deviandone la sorgente. La potestà pubblica su talisorgenti verrà, definitivamente, affermata con una nota sentenza della Corte di Cassazione diRoma del 1910. La questione era avvertita anche negli altri Paesi europei, come dimostrano levicende francesi relative alla modificazione degli artt. 641 e 643 (che presentavano questionianaloghe ai riferimenti legislativi italiani) dalla legge 8 aprile 1898 sur le régime des eaux. In pro-posito può leggersi CAPORALE F., L’attività giuridica in materia di acque e il codice civile del 1865:tra inadeguatezza funzionale della legislazione e interpretazione “progressiva” della norma giuridi-ca, in MOSCATI L., Dialettica tra legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici dell’Italia Uni-ta, Napoli 2013, pp. 33-74.
45 DE CRESCENZIO N., Accessione, in Enciclopedia Giuridica Italiana, vol. I, Milano 1881, pp. 271-272; ID., Dei corsi d’acqua in generale, Dei corsi d’acqua in generale, in LAURENT F., Principii didiritto civile, traduzione italiana a cura di Giuseppe Trono, vol. VI, Roma-Napoli 1881, pp. 33-44 (in particolare, pp. 33-35); PACELLI F., Le acque pubbliche... cit, pp. 83-104; MARRACINO A.- CONTE E., Commentario delle nuove disposizioni legislative sulle acque pubbliche... cit, pp. 59-80; MEUCCI L., Instituzioni di diritto amministrativo, Torino 1892, pp. 344-350.
46 Cfr. Corte di Cassazione di Roma, 13-21 dicembre 1910, in «Foro Italiano», XXXVI (1911), I,p. 360.
47 Cfr. Ibidem, pp. 355 e ss. e in «Giurisprudenza Italiana», LXIII (1911), I, 1, pp. 11 e ss. Si trat-ta, ancora, della destinazione diretta, immediata ed attuale all’uso pubblico. Attraverso la deri-vazione acquisiscono, ormai incontrovertibilmente, carattere pubblico gli interessi industriali edagricoli. Mette conto segnalare che la sentenza viene pubblicata con data 13 dicembre 1910 in«Giurisprudenza Italiana» e 21 dicembre 1910 in «Foro Italiano». Cfr. anche Corte di Appellodi Napoli, 18 marzo 1907, in «Giurisprudenza Italiana», LIX (1907), I, 2, pp. 814 e ss.; Cortedi Cassazione di Torino, 2 luglio 1910, in «La giurisprudenza: collezioni di sentenze della cor-te d’appello di Torino e di altre corti e tribunali», XLVII (1910), pp. 1261 e ss.; Corte di Appel-lo di Aquila, 4 marzo 1908, in «Foro Italiano», XXXIV (1909), I, pp. 1158 e ss.; Corte di Cas-sazione di Roma, 16 agosto 1911, in «Foro Italiano», XXXVI (1911), I, pp. 1438 e ss.; Corte diCassazione di Roma, 21 giugno 1916, «Foro Italiano», XLI (1916), I, pp. 897 e ss.; Corte diCassazione di Roma, 19 dicembre 1916, in «Foro Italiano», XLII (1917), I, pp. 139 e ss.; Cor-
267
267
Parte
seco
nd
a.A
cque Pubbliche ed acque private tra O
tto e Novecento
te di Cassazione di Roma, 5 maggio 1917, in «Foro Italiano», XLII (1917), I, pp. 893 e ss.48 Cfr. Corte di Cassazione di Roma, 13-21 dicembre 1910, in «Foro Italiano», XXXVI (1911), I,
p. 356. Cfr., altresì, Corte di Cassazione di Torino, 9 settembre 1909, in «La giurisprudenza:collezioni di sentenze della corte d’appello di Torino e di altre corti e tribunali», XLVII (1910),pp. 337 e ss.
49 Cfr. Corte di Cassazione di Roma, 13 marzo 1882, in «La legge: monitore giudiziario ed am-ministrativo», XXIII (1883), pp. 442 e ss.; per la dottrina, cfr. ad esempio TEDESCO F.-PAULUC-CI A.-D’INTINO F., Le acque demaniali secondo la legislazione italiana, in «Giornale del genio ci-vile», XXV (1887), parte non ufficiale, pp. 428-429.
50 Cfr. Corte di Appello di Brescia, 21 aprile 1908, in «Foro Italiano», XXXIII (1908), I, pp. 1264e ss.; Corte di Cassazione di Torino, 2 luglio 1910, in «La giurisprudenza: collezioni di senten-ze della corte d’appello di Torino e di altre corti e tribunali», XLVII (1910), pp. 1261 e ss.; Con-siglio di Stato, 3 febbraio 1911, in «Giurisprudenza Italiana», LXIII (1911), III, pp. 191 e ss.
51 Cfr. RUFFOLO F., Sui bacini dell’Italia centrale e meridionale e la legge del 1884 sulla derivazionedelle acque pubbliche, Milano 1906, pp. 1-8; ID., Sulla nuova proposta di legge relativa alle pub-bliche acque, Napoli 1907, pp. 17 e ss.; BALDI C., Acque pubbliche: manuale pratico alfabetico,Torino 1911, pp. 64-67; VALENTI G., Le ragioni economiche di un nuovo regime delle acque, inGRUPPO NAZIONALE DI AZIONE ECONOMICA (a cura di), Il problema idraulico e la legislazionesulle acque, Roma 1916, pp. 39-54 e SCIALOJA V., La legislazione sulle acque, in ivi, pp. 57-69.
52 Cfr. D. Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664; Reg. 24 gennaio 1917, n. 85; R. D. 19 ottobre 1919,n. 2161; R. D. 14 agosto 1920, n. 1285; R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
53 Sui progetti di riforma in materia di proprietà pubblica dopo la prima guerra mondiale, cfr. RA-NELLETTI O., Su le disposizioni del progetto del libro II del Codice Civile concernenti le “cose pub-bliche”, in «Foro Italiano», LXIII (1938), pp. 105 e ss. Per la disciplina delle risorse idriche cfr.art. 3 del D.L. 20 novembre 1919, n. 1664 e art. 1 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, chepongono, quale criterio per determinare la natura pubblica o privata di un corso d’acqua l’atti-tudine (attuale o potenziale) ad usi di pubblico generale interesse, sulle quali può leggersi VASSAL-LI F., Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, in ID., Studi giuridici, Vol.II, Milano 1960, pp. 348 e ss. Sul criterio discretivo tra acque pubbliche e private nel Novecen-to, cfr. POTOTSCHNIG U., Vecchi e nuovi strumenti nella disciplina pubblica delle acque, in «Rivi-sta trimestrale di diritto pubblico», XIX (1969), pp. 1009-1037. Sulla disciplina del secondoNovecento possono leggersi: MICCOLI E., Le acque pubbliche, Torino 1958; DE BELLIS C., Il re-gime giuridico delle acque pubbliche e degli enti territoriali minori, Bari 1971; CERULLI-IRELLI V.,Acque Pubbliche, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», (1988), 2, pp. 1 e ss.; LUGARESI N., Leacque pubbliche... cit.
54 Successivamente anche la questione ambientale, correlata alla scarsità delle acque, inciderà sul-la disciplina delle risorse idriche. In proposito può leggersi BOSCOLO E., Le politiche idriche nel-la stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazione e concessioni,Milano 2012, pp. 276 e ss.
55 Mette conto precisare, tuttavia, l’ampiezza degli usi annoverati nei due ambiti legislativi: le di-sposizioni relative alle servitù sembrano caratterizzate da un’impostazione restrittiva rispetto alcriterio teologico/funzionale di distinzione tra acque pubbliche ed acque private: la disciplinacivilistica tiene in considerazione, infatti, solo interessi espressamente codificati: quelli agrico-li ed industriali (artt. 543 e 544) e, limitatamente alle sorgenti, i bisogni umani (art. 542); ilprincipio teleologico/funzionale fa riferimento, genericamente, agli interessi pubblici. Ciò èvero, invece, solamente in una prospettiva dinamica, ma non in una statica. Da un punto divista statico, considerando, cioè, gli interessi qualificati come pubblici negli ultimi decenni del-l’Ottocento e nel primo decennio del Novecento, osserviamo una sostanziale consonanza traimpostazione civilistica e pubblicistica. Solo la navigazione, gli interessi economici, agricoli,industriali (le derivazioni) e, seppur con limiti stringenti, domestici paiono essere annoverati
268
268
LA C
ITTÀ
LIQU
IDA
- LA C
ITTÀ
ASSETA
TA: storia di un
rapporto di lunga durata
come pubblici. Dunque, le fattispecie civilistiche e pubblicistiche di limitazione ai diritti indi-viduali sulle acque tendono a coincidere. Al contrario, in una ottica dinamica, guardando, cioè,all’evoluzione del regime giuridico delle acque nel corso del XX secolo, si osserva un sostanzia-le ampliamento degli interessi pubblici rispetto a quelli espressamente individuati nelle dispo-sizioni codicistiche – sia in tal senso sufficiente richiamare la pesca. Cfr., ad esempio, l’analisidegli interessi pubblici emersi tra gli Anni Venti e Cinquanta del XX secolo offerta da CANNA-DA-BARTOLI E., Interesse alla pesca e demanialità delle acque, in «Foro amministrativo», XXXII(1956), II, 1, pp. 75-79.
56 Per alcune interessanti notazioni rispetto alla rilevanza attribuita agli usi dell’acqua nelle modi-fiche del regime proprietario delle risorse idriche in Francia, cfr. CONSEIL D’ETAT, L’eau et sondroit... cit, pp. 287 e ss.
57 Cfr. Corte Costituzionale, n. 259/96: «I criteri discretivi delle acque pubbliche e private hannosubito, sotto il profilo storico, dallo scorso secolo (e non solo in Italia), una evoluzione progres-siva con caratterizzazione in crescendo dell’interesse pubblico, correlata all’aumento dei fabbiso-gni, alla limitatezza delle disponibilità e ai rischi concreti di penuria per i diversi usi (residenzia-li, industriali, agricoli), la cui preminenza è venuta nel tempo ad assumere connotati diversi» e n.419/96: «Ed appunto la “pubblicità delle acque” ha riguardo al regime dell’uso di un bene dive-nuto limitato, di modo che la dichiarazione di pubblicità di un’acqua, intesa come risorsa suscet-tibile di uso previsto o consentito, si basa su un interesse generale ritenuto in linea di principioesistente in relazione alla limitatezza delle disponibilità e alle esigenze prioritarie di uso dell’ac-qua. Quanto alla mancanza di una generalizzata ed indiscriminata forma di pubblicità (e regimeconcessorio di uso) di tutte le acque, si tratta di una circostanza che trova fondamento nella scel-ta, tutt’altro che irragionevole, del legislatore, di privilegiare talune utilizzazioni tradizionali ca-ratterizzate da esclusione di interesse generale o da una razionale ponderazione di interessi».
58 Cfr. la relazione conclusiva della Commissione Rodotà, istituita con D.M. 21 giugno 2007, alfine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in ma-teria di beni pubblici. La proposta di legge presentata dalla Commissione, nella quale si offrivauna prima esposizione della disciplina giuridica dei beni comuni, non è tuttavia mai giunta allaapprovazione parlamentare. Cfr., anche FROSINI T.E., Dare un diritto agli assetati, in «Analisigiuridica dell’economia», IX (2010), pp. 29-38; CARAPEZZA FIGLIA G., Oggettivazione e godi-mento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni, Napoli 2008; nonché alcunidei contributi contenuti nei volumi collettanei MATTEI U. - REVIGLIO E. - RODOTÀ S. (a curadi), I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del codice civile, Roma2010; POLICE A. (a cura di), I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, Roma 2008 e MAT-TEI U. - REVIGLIO E. - RODOTÀ S. (a cura di), Invertire la rotta: idee per una riforma della pro-prietà pubblica, Bologna 2007.
Bibliografia
ASTUTI G., Il regime giuridico delle acque nel pensiero di Gian Domenico Romagnosi (1961),in DIURNI G. (a cura di), Tradizione romanistica e cultura giuridica europea, Napoli1984, pp. 1251-1302.
ASTUTI G., La concezione romagnosiana della ragion civile delle acque (1963), in DIURNI
G. (a cura di), Tradizione romanistica e cultura giuridica europea, Napoli 1984, pp.1305-1331.
ASTUTI G., Problemi attuali di legislazione ed amministrazione delle acque, in «Cultura escuola», XII (1969), pp. 166-173.
269
269
Parte
seco
nd
a.A
cque Pubbliche ed acque private tra O
tto e Novecento
BALDI C., Acque pubbliche: manuale pratico alfabetico, Torino 1911.BENEDETTO M.A., Acque (Diritto Intermedio), in «Novissimo digesto italiano», Torino
1960.BONFADINI G., Le acque pubbliche e l’agricoltura, Chiavenna 1917.BORSARI L., Commentario del Codice Civile italiano, II, Napoli-Roma 1872.BOSCOLO E., Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra dema-
nialità custodiale, pianificazione e concessioni, Milano 2012.CANNADA-BARTOLI E., Interesse alla pesca e demanialità delle acque, in «Foro amministra-
tivo», XXXII (1956), II, 1, pp. 75-79.CARAPEZZA FIGLIA G., Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una
teoria dei beni comuni, Napoli 2008.CAPORALE F., L’attività giuridica in materia di acque e il codice civile del 1865: tra inade-
guatezza funzionale della legislazione e interpretazione “progressiva” della norma giuridi-ca, in MOSCATI L., Dialettica tra legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici del-l’Italia Unita, Napoli 2013, pp. 33-74.
CASTELLI-AVOLIO G., Commento alle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, Napoli 1935.CERULLI-IRELLI V., Acque Pubbliche, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», 1988, I, 2.CODOVILLA E., Del diritto delle acque, Torino 1905.CONSEIL D’ETAT, L’eau et son droit. Rapport public, Paris 2010.D’ALBERTI M., Le concessioni amministrative. Aspetti della contrattualità delle pubbliche am-
ministrazioni, Napoli 1981.DE BELLIS C., Il regime giuridico delle acque pubbliche e degli enti territoriali minori, Bari
1971.DE CRESCENZIO N., Accessione, in Enciclopedia Giuridica Italiana, vol. I, Milano 1881.DE CRESCENZIO N., Dei corsi d’acqua in generale, Dei corsi d’acqua in generale, in LAU-
RENT F., Principii di diritto civile, traduzione italiana a cura di Giuseppe Trono, vol.VI, Roma-Napoli 1881, pp. 33-44.
DE CUPIS A., Del concetto di proprietà sulle acque fluenti, Roma 1909.DIMAJO A., Le risorse idriche nel vigente ordinamento, in «Rassegna giuridica dell’energia
elettrica», XII (1996), pp. 1-11.DIONISOTTI C., Delle servitù delle acque, Torino 1872.FILIPPI L., L’utilizzazione delle acque pubbliche, Roma 1928.FILOMUSI-GUELFI F., Lezioni di diritto civile. Diritti Reali, Roma 1898.FIORENZA G., Le acque pubbliche e la legge del 10 agosto 1884, Milano 1904.FOSCHINI G., La teorica delle acque di ragion privata, Torino 1871.FROSINI T.E., Dare un diritto agli assetati, in «Analisi giuridica dell’economia», IX (2010),
pp. 29-38.GADDA E., Degli articoli 427 e 543 del Codice Civile combinati coll’art. 1° della legge 20
marzo 1865 all. F, in «Archivio Giuridico», XIX (1877), pp. 189-194.GIANZANA S., Le acque nel diritto civile italiano, Torino 1879.GILARDONI A., Acque pubbliche e impianti elettrici, Roma 1936.GIORGI G., La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali, vol. III, Firenze 1892.
270
270
LA C
ITTÀ
LIQU
IDA
- LA C
ITTÀ
ASSETA
TA: storia di un
rapporto di lunga durata
GIOVANETTI G., Del regime giuridico delle acque (1843), ristampa anastatica Novara 1989.GIOVANETTI G., Entwurf eines Gesetzes über die Benutzung des Wassers, in «Kritische Zeitsch-
rift für Rechtwissenchaft und Gestetzgebung des Auslandes», XVI (1844), pp. 467-481.HELLER M., The tragedy of the Anticommons: property in transition from Marx to Markets,
in «Harvard Law Review», CXI (1998), pp. 621-688. HELLER M., The gridlock economy. How too much ownership wrecks markets, stops innova-
tion, and costs lives, New York 2008.LUGARESI N., Le acque pubbliche: profili dominicali, di tutela e di gestione, Milano 1995.MANETTI D., La legislazione sulle acque pubbliche e sull’industria elettrica, in MORI G. (a
cura di), Storia dell’industria elettrica in Italia. Le origini. 1882-1914, vol. I, Roma1992, pp. 111-154.
MARRACINO A. - CONTE E., Commentario delle nuove disposizioni legislative sulle acquepubbliche, Roma 1917.
MATTEI U. - REVIGLIO E. - RODOTÀ S. (a cura di), Invertire la rotta: idee per una riformadella proprietà pubblica,
Bologna 2007.MATTEI U. - REVIGLIO E. - RODOTÀ S. (a cura di), I beni pubblici. Dal governo democra-
tico dell’economia alla riforma del codice civile, Roma 2010.MAZZA A., Delle acque nei rapporti con la pubblica amministrazione, Milano 1893.MAZZA A., La teoria delle acque pubbliche, Torino 1900.MAZZA A., Dei diritti sulle acque, Roma 1913.MEUCCI L., Instituzioni di diritto amministrativo, Torino 1892.MICCOLI E., Le acque pubbliche, Torino 1958.MOSCATI L., Giovanetti e Mittermaier: sul regime giuridico delle acque, in Giacomo Giova-
netti tra politica e diritto: Atti del convegno di studi, (Orta San Giulio, 20-21 aprile 1990),Torino 1992, pp. 1-18.
MOSCATI L., In materia di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina, Roma1993.
MOSCATI L., Le concessioni di acque tra Diritto comune e codificazione unitaria, in I rap-porti contrattuali della pubblica amministrazione nell’esperienza storico-giuridica. Con-gresso internazionale della Società italiana di Storia del diritto (Torino, 17-19 ottobre1994), Napoli 1997, pp. 318-348.
NITTI F.S., La conquista della forza. L’elettricità a buon mercato. La nazionalizzazione del-le forze idrauliche, Torino-Roma 1905.
NONNIS A., I canoni di uso delle acque pubbliche, Milano 1934.PACELLI F., Le acque pubbliche, Torino 1913.PACIFICI-MAZZONI E., Istituzioni di diritto civile italiano, Firenze 1873.PANZARASA R., Le acque oggetto di pubblica amministrazione, in «Rivista di diritto pubbli-
co», VI (1914), II, pp. 492-495.POLICE A. (a cura di), I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, Roma 2008.POSSENTI C., Sulla distinzione delle acque pubbliche dalle private, in «Giornale del genio
civile», VII (1869), parte non ufficiale, pp. 282-297.
271
271
Parte
seco
nd
a.A
cque Pubbliche ed acque private tra O
tto e Novecento
POTOTSCHNIG U., Vecchi e nuovi strumenti nella disciplina pubblica delle acque, in «Rivi-sta trimestrale di diritto pubblico», XIX (1969), pp. 1009-1037.
RANELLETTI O., Concetto, natura e limiti del demanio pubblico, Torino 1898.RANELLETTI O., La demanialità delle acque, in «Rivista delle società commerciali», VII
(1917), pp. 202-207.RANELLETTI O., Su le disposizioni del progetto del libro II del Codice Civile concernenti le
“cose pubbliche”, in «Foro Italiano», LXIII (1938).RATTO L., Carattere ed enumerazione delle acque demaniali, in «La Legge: monitore giudi-
ziario ed amministrativo», XXXIII (1893), I, pp. 26-72.RATTO L., Le acque pubbliche non demaniali, in «La Legge: monitore giudiziario ed am-
ministrativo», XXXIII (1893), I, pp. 499-540.RATTO L., Il nuovo regime delle acque e delle foreste, Roma 1909.ROMAGNOSI G.D., Della condotta delle acque (1824), in DE GIORGI A. (a cura di), Della
condotta delle acque e della ragione civile delle acque. Trattati di Gian Domenico Roma-gnosi riordinati da Alessandro De Giorgi, Milano 1843, pp. 9-1164.
ROMAGNOSI G.D., Della ragione civile delle acque nella rurale economia (1829-1830), inDE GIORGI A. (a cura di), Della condotta delle acque e della ragione civile delle acque.Trattati di Gian Domenico Romagnosi… cit, pp. 1167-1551.
RUFFOLO F., Sui bacini dell’Italia centrale e meridionale e la legge del 1884 sulla derivazio-ne delle acque pubbliche, Milano 1906.
RUFFOLO F., Sulla nuova proposta di legge relativa alle pubbliche acque, Napoli 1907.SCIALOJA V., La legislazione sulle acque, in GRUPPO NAZIONALE DI AZIONE ECONOMICA
(a cura di), Il problema idraulico e la legislazione sulle acque, Roma 1916, pp. 57-69.SCIALOJA A., Le derivazioni di acque pubbliche e l’esperimento della nuova legge, Roma 1918.SCLOPIS F., Storia della legislazione italiana, vol. I, parte III, Torino 1864, ristampa ana-
statica Milano 1972.SOLIMANO S., Il letto di procuste. Diritto e politica nella formazione del codice civile unita-
rio. I progetti Cassinis (1860-1861), Milano 2003.STOLFI N., Le derivazioni eventuali e future di acque pubbliche, Torino 1915.TEDESCO F. - PAULUCCI A. - D’INTINO F., Le acque demaniali secondo la legislazione ita-
liana, in «Giornale del genio civile», XXV (1887), parte non ufficiale, pp. 428-429.TIEPOLO G., Le acque pubbliche nella legislazione italiana, Torino 1889.TONINI V., Sulle derivazioni di acque pubbliche, in Giornale del genio civile, LIII (1915),
pp. 3-21.VALENTI G., Le ragioni economiche di un nuovo regime delle acque, in GRUPPO NAZIONA-
LE DI AZIONE ECONOMICA (a cura di), Il problema idraulico e la legislazione sulle ac-que, Roma 1916, pp. 39-54.
VASSALLI F., Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, in ID., Studigiuridici, Vol. II, Milano 1960, pp. 337-363.
ZANOBINI G., Corso di diritto amministrativo, vol. IV, Milano 1958.
272
272
LA C
ITTÀ
LIQU
IDA
- LA C
ITTÀ
ASSETA
TA: storia di un
rapporto di lunga durata