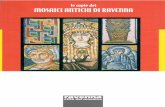Ravenna, architettura, città, acque 1200-1700
Transcript of Ravenna, architettura, città, acque 1200-1700
Storia di Ravenna IV Dalla dominazione veneziana alla conquista francese. a cura di L. Gambi. Comune di Ravenna e Marsilio editori. Venezia 1994, pp. 179-215. !
VINCENZO FONTANA !L’ARCHITETTURA NELLA CITTÀ E NEL TERRITORIO DAL QUATTROCENTO AL SEICENTO. !!
Una città di chiese può definirsi la Ravenna del basso Medioevo: erano infatti oltre cento, di cui molte, piccole o piccolissime, sono oggi scomparse1. Dentro le mura teodericiane la città conservava in parte il segno del suo remoto formarsi policentrico, per successivi agglomerati: l’oppidum quadrato romano, segnato a sud-ovest dalle torri, dette poi «da Lezze» o «di Lazzo» e «Presbiteriorum» o «Zancana», con al centro Porta Aurea, assurta ad emblema nel sigillo medievale della città, si estendeva ad ovest fino a Porta Adriana. Qui iniziava la regione racchiusa dalle mura di Onorio e Valentiniano m, estesa fino alla Porta San Vittore a nord e San Lorenzo a sud. A est, oltre il Padenna, era la regione gota, percorsa dalla «Platea Maior» (attuale via di Roma), con il palazzo di Teoderico, ancora non lontano dal mare, probabilmente visibile dalle mura a est.
In decadenza erano Classe e Cesarea, dopo la perdita della funzione di base navale, le conquiste longobarde e carolinge e le incursioni saracene. Le rovine erano servite come cave di costruzione dei grandiosi campanili dell'epoca ottoniana. Isolate fra valli e pinete le abbazie di Classe e di Porto, in decadenza San Lorenzo in Cesarea e San Severo, sono gli ultimi segni dell'antica struttura policentrica dettata dai corsi dei fiumi che hanno interrato il porto e la «fossa Augusta». Se ancora a nord e ad est le mura guardano un paesaggio marino e vallivo comunicante con il Po di Primaro, a sud e a ovest si sta perdendo l'antico isolamento strategico per la sede imperiale. Lungo il corso del Montone e del Ronco i terreni coltivati hanno sostituito le valli e le foreste, sono sorte le pievi a popolare e organizzare civilmente e spazialmente le campagne. L'orizzonte della città è diventato più limitato: da un lato le valli da pesca e le pinete; dall'altro i campi e gli Appennini all'orizzonte, ai cui piedi si stanno ripopolando i centri romagnoli della via Emilia.
All'interno delle mura, l'antica genesi «per successivi agglomerati che seguivano la dislocazione autoritaria di dati gruppi di monumenti, destinati, più che alla collettività, ad una elettissima classe dominante»2, seguita a pesare nell'assetto unitario di Ravenna, che pure tende a configurare un suo centro nel punto di convergenza dei tre settori antichi: dapprima il Capitolium, nel luogo dove sorgerà San Domenico, e poi, una volta trasformati in strade i corsi dei fiumicelli interni, la piazza Maggiore alla quale i Veneziani daranno un definitivo assetto urbanistico. Nella sua genesi di città anfibia va ricercato il perché, dell'andamento leggermente sinuoso di molte antiche" strade ravennati: per esempio via Cavour, via G. Rossi, via Mazzini, via Baccarini ecc. Ai portici chiusi dei quadriportici delle basiliche e della reggia teodericiana, vanno ad aggiungersi quelli dei chiostri abbaziali e delle domus delle più potenti famiglie, ma anche portici aperti e continui lungo le strade che poi spariranno nei secoli xvi e xvii per ragioni di decoro e sicurezza. Tale doveva essere il portico che da Santa Giustina «in capite porticus» correva lungo via Romolo Gessi, forse fino all'attuale via Mariani dove era San Giorgio «dei portici» nel luogo dove sorge ora la Cassa di Risparmio: un documento del 1301 ricorda una casa con portico presso San Teodoro che il Ricci volle identificare con quella all'angolo fra via Paolo Costa e la piazzetta dello Spirito Santo dove resta l'avanzo di un arco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1A. Tarlazzi (Le sacre memorie di Ravenna, Ravenna 1852, p. 31) ne contò 227 in tutti i tempi, ma contemporaneamente non ne dovevano esserci state più di un centinaio; nella sua opera ne descrive 82 di cui 37, ai suoi tempi profanate. T. Tomai (Historia di Ravenna, Pesare 1574, p. 31) ne aveva contate 369.2 Ch. M. Calvesi, Bisanzio in Italia, in Ravenna una capitale, Bologna 1965, pp. 31-41, ed. E. Chiarini, ad vocem Ravenna, ED, voi. iv, Roma 1975, pp. 860-861.
Vincenzo Maria Coronelli, Ravenna ricercata, Venezia 1709, immagine fantastica di città policentrica su isole come accenna Vitruvio I
2
LE PREMESSE. I SECOLI XIII E XIV FRA I TRAVERSARI E I DA POLENTA Con la nascita dei comuni Ravenna perde autorità nei confronti dell'ex Esarcato e della ex Pentapoli. Anche Ravenna è comune, in lotta contro Faenza, Bologna e Cesena, con Forlì unica alleata, e per di più indebolito all'interno per i contrasti fra Pietro Traversari e libertino Dusdei. Proprio come difesa del suo territorio dai Faentini viene fortificato il castello di Rafanara sul Lamone intorno al 1221. Pure in quell'anno è la prima visita dell'imperatore Federico n, poi la peste del 1225, che certo ridusse la popolazione dentro le mura e nelle pievi, la morte di Pietro Traversari sepolto in San Giovanni Battista, e infine le inondazioni del gennaio 1229. Dal Natale del 1231 al giugno dell'anno successivo Federico II è a Ravenna, forse nelle residenze imperiali ottoniane a Cesarea o nel palazzo di Teoderico, saccheggiato e spogliato da Carlo Magno, ma ancora in gran parte in piedi. Nel 1234 un freddo eccezionale gelò i pini delle pinete che la Chiesa arcivescovile aveva concesso alle abbazie dipendenti. L'assedio di Federico n nel 1240 fu breve, ma dopo la conquista ci furono cambiamenti decisivi nella compagine urbana. Le case dei Traversari furono distrutte, e, se mai quella che la tradizione attribuisce ad essi in via San Vitale fu davvero loro, essa appare successiva e decentrata rispetto alla domus duecentesca. Difficile è il giudizio dopo i restauri iniziati nel 1916: il muro del pian terreno appare più antico e genuino, mentre le sei bifore al piano superiore sono ampiamente restaurate «alla maniera» del Duecento. Sempre attorno al 1240 fu rialzata la torre civica che reca bifore alla sommità, ma contemporaneamente l'imperatore spogliò Porta Aurea, colpendo così il simbolo cittadino.Nei pressi dell'attuale corso del Lamone, nel territorio di Bagnacavallo, sorgono ancora i resti del castello di Traversara, roccaforte della famiglia, ma essi appaiono decisamente posteriori al loro bando da Ravenna. Scomparso del tutto è, invece, l'omonimo e assai più antico castello, abbinato alla pieve di San Paolo, che si trovava non lungi dal fiume Acquedotto (l'attuale Ronco) fra il territorio municipale di Ravenna e la diocesi di Forlì, presumibilmente luogo d'origine dei Traversari. Altri castelli appartenevano all'arcivescovo, come quello di Oriolo situato sulle prime propaggini collinari nel Faentino, verso Forlì, presto conteso dalle nascenti signorie prima degli Ordelaffi di Forlì, poi dei Manfredi di Faenza, nel corso del Trecento; o la torre di struttura romanico-esarcale inglobata nel rustico accanto alla villa Spreti-Tomasi di Casemurate, feudo arcivescovile. Altri controllavano la valle del Savio, asse di penetrazione verso Roma, e furono restituiti dagli Onesti all'arcivescovo alla fine del Duecento.La prima sede comunale era stata temporaneamente nel palazzo arcivescovile dove il consiglio teneva le sue riunioni, come nell'atto del 20 settembre 1184, e solo intorno al 1193 si ha testimonianza di una sede autonoma presso l'Arcivescovado. È però difficile stabilirne con certezza l'ubicazione. Assai più tardi un documento del 17 aprile 1280 dice che il comune «ebbe la casa e il palazzo» presso la strada pubblica («platea communis») e la chiesa maggiore e San Giovanni in fonte (Battistero Neoniano), ma proprio con quell'atto cedeva il terreno e gli edifici all'arcivescovo dal momento che la sede era già trasferita altrove. Ciò non contrasta, dunque, con l'ipotesi che il palazzo comunale si trovasse nel 1214 nella regione Ercolana e precisamente nel luogo dove ora sorge la sede della Banca Popolare; qui sarebbe stata la prima torre civica, che pure la tradizione vorrebbe restaurata da Federico n con i materiali di una casa Traversari non lontana.________________________________3 Fantuzzi, vi, p. 280.4 Fantuzzi, n, p. 318.5 Fantuzzi, in, pp. 128-129. Cfr. P. Uccellini, Dizionario storico di Ravenna e di altri luoghi di Romagna, Ravenna 1855, p. 342; S. Bernicoli, Le torri della città e del territoriodi Ravenna, Ravenna 1923, pp. 15-18; G. Savini, Per i monumenti e per la storia di Ravenna, Ravenna 1914, p. 23.
Nel x e nel xi secolo erano sorti i campanili tondi, unici e inequivocabilmente ravennati, idonei per la loro pianta a resistere ai terremoti e ai cedimenti di un terreno infido, e anche quadrati, costruiti secondo i modi e con materiali romani. Anche i privati li imitarono nelle loro torri quadrate di cui pochissime sono le superstiti: quella divenuta comunale fra via xiii Giugno e via Ponte Marino era probabilmente una delle maggiori e prima di passare al comune intorno al 1317 si ritiene appartenesse ai Guiccioli. La sua struttura poderosa è alta 39,47 metri e nel basamento sono inclusi mattoni romani e frammenti di sculture che la tradizione popolare ha collegato al modo di dire «cercar Maria o Mariola per Ravenna». È fortemente inclinata verso ovest. Pure di antica origine, almeno fino a una certa altezza, è la torre oggi inclusa nel palazzo Spreti, che fu prima dei Ruggini (in via G. Rossi). Ma altre torri esistevano intorno: la «Bacalarla», dove oggi sorge la Casa Matha; quella del cosiddetto palazzo di Teoderico, isolata verso le mura a est, forse medievale e restaurata da Federico n, caduta nel 1295; la torre dei conti di Cunio nella zona sud fra le porte Sisi e San Marna. Qui sorgeva anche il bastione costruito da Federico il dopo l'assedio e la presa della città, riducendo a calcina i marmi di Porta Aurea, per riallacciarsi alle mura teodericiane, più volte restaurate. Anche la casa Bellenghi (edificio d'angolo fra via C. Ricci e via Guido Novello da Polenta), stando al Ricci, aveva una torre medievale i cui resti scomparvero nei restauri del 1858: ma più probabilmente essa apparteneva alla costruzione cinquecentesca dei Rasponi.Il Padenna, affiancato da strade lungo le rive, era una specie di «Canai Grande» su cui si affacciavano le case più cospicue con le loro torri, soprattutto in corrispondenza dei ponti principali: il ponte coperto di Sant'Apollinare (fra via C. Ricci e via R. Gessi) e quello di San Michele in Africisco (fra via iv Novembre e la piazza del mercato coperto). Né sappiamo bene quale effetto distruttivo abbia avuto il comando di Pietro Guerra, rettore papale di Romagna, di mozzare le torri e i fortilizi privati nel 1295; eccetto forse che per la torre vecchia del comune, per quella di Teoderico o per quelle dei da Polenta e dei Cunio, presso Porta Ursicina, dal momento che nel Trecento il codice Polentano ci rappresenta una città nuovamente turrita. Intorno al 1280 il rettore provinciale diede facoltà di erigere un nuovo palazzo pubblico e uno come propria residenza, dando così inizio al nuovo «centro di comando» intorno alla piazza Maggiore.La domus dei Traversar! era nella zona fra via Girolamo Rossi e via Ponte Marino, sulla riva del Padenna, in un complesso di edifici probabilmente distribuiti intorno a una corte, secondo uno schema derivato dalla casa romana. Un avanzo di torre fu trovato durante i lavori per la fondazione del mercato coperto e riferito dal Bernicoli a tale complesso. Vicino scorrevano le acque sempre più stagnanti del Padenna, il fiumicello urbano diretto da sud a nord, che, scorrendo di fronte al quadriportico di San Giovanni Battista, ha disegnato le attuali vie Girolamo Rossi e Mazzini, lasciando tracce di archi nelle mura presso la Porta San Marna e la Porta San Vittore, rispettivamente entrata e uscita dalla cerchia. Nel 1269 la «chiavica del Pontastro» (parallela all'attuale via Cavour e confluente nel Padenna al ponte di San Michele) servì a delimitare i terreni concessi dal comune ai domenicani per erigere il loro convento, ma la Lamisa (che correva nella parte nord dell’oppidum romano per innestarsi nel Padenna al ponte Cipitello, nel luogo dell'attuale piazza dei Caduti) scompare dai documenti. Nel Duecento gli abitanti di Cervia avevano l'obbligo di ripulire dai fanghi questi canali interni e i fossati della città.________________________________7«Domus in qua D. Paulus [Traversari] habitat erat in Guaita Sanctae Mariae Majoris super flumen Padenne juxta Ecclesiam Sancii Johannis Chrisostomi, ubi recenserunt etiam aliae domus eiusdem. Item casamentum cum curte et horto [...] in regione Sanctae Mariae in Ceresio». Fantuzzi, III, p. 294. 8 Pasolini, Lustri, p. Il, 1. 8°, pp. 168-169.
Ormai le acque chiare del ramo più meridionale del Po hanno abbandonato da tempo il territorio intorno la città. Le paludi che ancora la cingono a nord e a sud-ovest si stanno interrando e colmando per l'apporto dei fiumi appenninici sempre più limacciosi per l'avanzato disboscamento delle valli, dove affiorano argille e calanchi. Il Lamone scorrendo a nord non riesce a colmare le valli settentrionali per la loro vastità, ma il Montone e il Ronco stanno cancellando le più esigue a sud-ovest. Per questo Federico n era riuscito a prendere la città nell'agosto 1240, dopo un tentativo di allagare le valli intorno, reso vano dai fiumi in secca.Il mare non è ancora lontano dal palazzo di Teoderico e dalle mura orientali nel 1208 e forse ancora esistono diversi porti nei canali con cui le piallasse comunicano con il mare; mentre a nord è ancora possibile per le valli raggiungere Comacchio e Ferrara, una volta imboccato il Po di Primaro. La «Schola piscatorum» qui estende il suo potere economico e civile al quale aderiscono anche i nobili cittadini, però ben più forte è quello dell'arcivescovo e delle abbazie. Ma ormai il dominio di queste valli che ancora legavano Ravenna ai traffici padani è conteso da Bolognesi e Veneziani; i primi nel 1258 costruiscono il castello di Sant'Alberto, all'incirca un fortino di legno, e i Veneziani la torre di Marcabò (o Marcamò) a sbarrare il Po di Primaro; inoltre dal 1261 Venezia tiene un «vicedomino» a Ravenna. Infine nel 1270 scoppia la guerra fra Bolognesi e Veneziani per il porto fluviale di Primaro. Né più in altre direzioni Ravenna riesce a ingrandire il suo raggio d'azione, che semmai si restringe, lasciando l'iniziativa ai Forlivesi di fondare Cotignola nel 1276 in funzione anti faentina, mentre l'arcivescovo deve rivendicare con fortune alterne il possesso di Argenta dai Ferraresi e dalla casa d'Este.L'ultimo decennio del Duecento porta dentro la città grandi cambiamenti. Nella zona a sud, contro le mura fra Porta San Marna e Porta Ursicina, lontano dal centro, sorgono le domus dei conti di Cunio e dei da Polenta, entrambe con torri che vengono demolite insieme ad altre case turrite nel 1295, ma che lasciano ampi lotti con giardini e orti fino ai giorni nostri. Il palazzo Brandolini con il giardino retrostante potrebbe all'inarca coincidere con la domus di Guido Minore da Polenta, padre di Francesca, e in via Zagarelli alle Mura sorge ancora una casa di origine duecentesca che può essere l'avanzo di questo complesso. La facciata presenta piccole finestre antiche su due piani e una muratura a mattone scoperto che presentava tracce di un intonaco a scacchiera bianco, rosso e giallo. Questo induce a pensare che in epoca gotica i muri fossero intonacati e colorati secondo disegni geometrici, anche graffiti, che fingevano i colori del marmo o quelli araldici della famiglia, contraddicendo quanto si è sempre pensato dello «stile ravennate», che nei restauri novecenteschi ha improntato interni ed esterni alla estetica tardo romantica del mattone a vista. Con tutti i beni polentani questa casa passò alla Repubblica di Venezia, che alla fine del secolo xv la diede alla Canonica di Porto di cui reca lo stemma. Nei primi decenni del Novecento i Brandolini la restaurarono ampiamente aprendo nuove finestre sul giardino retrostante.Intorno al 1270 era stato scavato nuovamente il canale Naviglio che da Porta Adriana seguiva la via Faentina (che nella sua ampia sezione attuale reca la traccia di un porto fluviale) per volgere a nord, lungo l'attuale via Canalazzo, verso la valle, dove a Sant'Alberto si apriva una foce del Po. Senonché questa si rinchiuse nel 1350, cosicché da allora le barche piatte - i «sandoni» tipici della navigazione interna padana - venivano tirate con argani dentro al Po di Primaro per risalire fino a Ferrara e immettersi nell'asta principale. Probabilmente si trattò solo del riattamento di un corso fluviale preesistente, il cavo «Coda rundini», ma resta il fatto che lo scavo mantenne per alcuni secoli Ravenna partecipe del vasto territorio commerciale padano di cui era l'unico terminale romagnolo. La navigazione probabilmente non fu né agevole né continua anche per le ostilità fra Venezia e Bologna, Ferrara e la Santa Sede, che portarono nel 1309 alla distruzione del castello di Marcamò e l'anno successivo di quello di Sant'Alberto. Inoltre si andava restringendo il retroterra dello scalo marino ravennate con l'inizio dello scavo del porto di Cesenatico nel 1314._________________________________Per il canale Naviglio e le sistemazioni idrauliche di Ronco e Montone cfr. P. Fabbri, Terra e acque dall'alto al basso Medioevo, in Storia di Ravenna, m, Dal Mille alla fine della signoria polentana, a cura di A. Vasina, Venezia 1993, pp. 33 ss.
Fra il 1280 e il 1288 il comune si insedia, come si è detto, sulla piazza Maggiore, seguito poi nel 1295 dal rappresentante del papa. Si abbandonò quindi la sede antica e si iniziò l'insediamento del potere pubblico sul lato sud di quello che con ogni probabilità era già il centro commerciale della città. Con la designazione di Lamberto da Polenta a podestà perpetuo (1301) e la cacciata dei Traversari nel 1303 inizia la signoria polentana con un fervore di nuove opere idrauliche nel territorio. Lo scavo della Lama a sud serve a bonificare i terreni fra il Montone e il Ronco che forse un secolo prima erano stati condotti intorno alle mura per difenderle dopo la dolorosa esperienza della presa imperiale. Essi forniranno acqua alla città, alimenteranno i canali e i fiumicelli interni superstiti, forniranno energia ai mulini (e in particolare a quello di Lamberto e Bernardino da Polenta a San Marna), ma con la loro incostanza appenninica, incrementata dai disboscamenti a monte, diventeranno un nuovo incubo per la città, quando dal Cinquecento in poi il loro letto si sarà tanto innalzato da sovrastarla e le mura diventeranno un argine precario contro le piene. Nonostante le pesti del 1318 e del 1348, il gotico lasciò a Ravenna il suo segno nelle fabbriche ecclesiastiche e negli affreschi della scuola riminese.
Situazione idrografica di Ravenna dal 1300 al 1700 e portale gotico della abbazia di s. Giovani Evangelista
Porto si impone come nuovo faro di spiritualità nei confronti di Classe. Qui la chiesa originaria di Pietro Peccatore, eretta fra l'xi e il xu secolo, fu ingrandita ed elevata. La parte ovest dalla facciata fino alla quarta campata è forse quella originale a tre navate rette da pilastri e con il tetto a capriate. Alla fine del secolo xiii o all'inizio del seguente la navata fu prolungata con colonne di rosso di Verona e fu rialzata. Fu pure costruita l'abside con un grande arco ogivale, il presbiterio con volta a vele e il corpo poligonale con nervature e costoloni; le cappelle laterali ripetevano in piccolo lo stesso modello. Nel 1246 un notaio, Graziadeo, aveva fatto un lascito perché la chiesa fosse decorata con pitture, ma esse, collocate probabilmente nell'abside, furono distrutte per la ricostruzione, appena descritta, in forme gotiche. Qui i pittori giotteschi della scuola riminese dipinsero il più grande e importante ciclo pittorico eseguito a Ravenna in epoca gotica, oggi irreparabilmente perduto eccetto qualche frammento. Tipicamente gotico era il soffitto trilobato a carena di nave (ricostruito su tracce antiche nei restauri novecenteschi), diffuso nelle coste adriatiche da Aquileia ad Ancona. Sul fianco destro della chiesa si innesta l'ala del capitolo con arcate gotiche, unico avanzo della canonica portuense. Dopo aver rinunciato a San Mercuriale, presso all'ospedale di Santo Spirito e al monastero del Corpus Domini, nel 1261 i conventuali francescani avevano ottenuto dall'arcivescovo Filippo la basilica di San Pietro Maggiore, d'allora San Francesco, ricostruita nel secolo x, con le case contigue e gli orti. Parimenti era stata assegnata ai domenicani nel 1269 una sede vicina a Santa Maria in Callopes (cioè Formosa) con la torre e il palazzo di Bacauda per costruirvi la chiesa loro, il convento e il cimitero. Questi furono eretti e consacrati nel 1374, ma poi la chiesa fu completamente ricostruita fra il 1699 e il 1703, e solo nella facciata sono ancora visibili gli archi ogivali delle sepolture, analoghe ad altre basiliche domenicane di Venezia, Bologna, Firenze ecc. Contemporaneamente i francescani costruirono il loro convento; e forse il chiostro più prossimo alla basilica ne era il primo nucleo, poi ricostruito nel secolo xv; ma ancora oggi sul lato est si vedono due archi più antichi che forse gli appartennero. Sul lato esterno di questa ala si innestava un portico che andava alla chiesetta di Braccioforte, estremo nord del nartece di San Pietro Maggiore che con una trentina di archi correva di fronte alla facciata della basilica e racchiudeva sarcofagi paleocristiani, poi reimpiegati per nuove sepolture. Esso con il fianco della basilica, il convento, il piccolo portico e la chiesetta racchiudeva il sepolcreto di Braccioforte. Sotto il portico, contro il muro esterno del convento francescano, fu il primo sepolcro di Dante consistente in un sarcofago sormontato da un'immagine della Madonna scolpita e da alcuni affreschi. Oltre a Porto, un gruppo numeroso di affreschi trecenteschi di scuola giottesca romagnola venne a rinnovare l'interno di San Francesco, prediletto dai da Polenta, che vi costruirono la loro cappella alla metà del Trecento. Un grande arco acuto si apre sulla navata sinistra creando un vano rettangolare della profondità di pochi metri che sporge all'esterno. Il muro di fondo è diritto, affrescato all'interno con la Crocifissione di Pietro da Rimini, purtroppo mal conservata; vi si aprono due finestre a ogiva, e all'esterno è sorretto da due archi ciechi retti da colonnette sotto i quali stavano le tombe. Oggi questo è ancora visibile sotto il lato nord del primo chiostro francescano che vi si addossò alla fine del Quattrocento. I pochi resti di affreschi all'interno della basilica non permettono di immaginare un ciclo pittorico completo come a Porto. Il tetto ligneo a carena di nave e dipinto fu ricostruito nel 1921 interpretando i segni lasciati nei muri accecati dal controsoffitto stuccato nel 1793, in analogia a quanto contemporaneamente si faceva a Porto. Viceversa si riaprirono le finestre esarcali a sesto tondo che erano state chiuse e ridotte a finestrelle archiacute.
La chiesa del monastero di Porto Fuori con gli affreschi attribuiti a Pietro e Giovanni da Rimini prima del bombardamento nel 1944
Fra il 1255 e il 1270 Chiara da Polenta aveva costruito il monastero e la chiesa di Santa Chiara presso la distrutta chiesa di Santo Stefano «in fondamento». La chiesa è forse il primo edificio gotico ravennate, a una sola navata, manomessa dopo la soppressione del convento nel 1805 e la trasformazione in teatro dei Filodrammatici nel 1891, poi Rasi, rinnovato nel 1978. All'esterno dagli orti del Ricovero «Garibaldi-Zarabini» si vede ancora il fianco di mattoni a vista con lesene e avanzi di archi ciechi ornati di terrecotte secondo l'uso padano, ma l'unica parte conservata è l'abside, oggi restaurata, ma che attende la ricollocazione degli affreschi trecenteschi di Pietro da Rimini, che restano oggi i più importanti a Ravenna dopo la distruzione di Porto Fuori. Essi infatti si fondono con l'architettura nella volta dell'abside a crociera con nervature che delimitano le vele. Una finestra gotica illumina l'abside con la Crocifissione e altre scene della vita di Cristo. Un altro edificio gotico, che, dopo i restauri in corso, potrà rievocare la tipologia a una sola navata, è San Nicolo, costruito dagli agostiniani, che qui già erano insediati con il loro convento, fra il 1356 e il 1359. I muri esterni di semplice mattone sono rinforzati da piedritti, secondo la tradizione esarcale, poi romanica, che trapassa anche nell'architettura gotica. Quest'ultima è più evidente nell'abside poligonale con volta a costoloni di forme raffinate che conclude l'unica navata. La facciata a capanna presenta due piedritti che la dividono in tre parti con un occhio centrale ornato da una ghiera in cotto secondo la tradizione padana. Tracce degli affreschi trecenteschi sono sopravvissute nell'interno alle decorazioni barocche del padre Cesare Pronti. La tipologia di San Nicolò si avvicina a quella di Santa Chiara e di quanto resta di trecentesco nella facciata di San Domenico; probabilmente un soffitto a carena ricopriva le capriate del tetto. Il 18 giugno 1316 Lamberto da Polenta nel testamento fece un lascito cospicuo ai benedettini dell'abbazia di San Giovanni Evangelista. Probabilmente esso permise la costruzione di fronte al quadriportico, oggi scomparso, con il portale gotico che resta la più importante opera architettonica e scultorea a Ravenna. In esso furono impiegati materiali più antichi (gli stipiti ai lati della porta, i leoni di rosso di Verona sui pilastri laterali, forse da un protiro precedente, il frammento dei soldati al seguito di Valentiniano III e Galla Placidia nell'angolo destro del timpano). La sua struttura è di ispirazione classica, quasi federiciana, nel timpano scolpito a basso-rilievo, mentre le grandi foglie di acanto, che lo arricchiscono come acroteri, hanno un modellato ancora bizantineggiante e ricordano il coronamento delle lunette della facciata di San Marco a Venezia. Le edicole sulle doppie colonne ai lati rientrano in schemi più ampiamente padani. Cappella in s. Giovanni Evangelista Pastori e angeli frammento s. Chiara, S. Nicolò interno,
All'interno della basilica fu rifatto il soffitto ligneo -oggi scomparso - con le capriate a vista, finite di dipingere nel 1334 da un maestro Boverio e dai suoi figli. Nonostante la parziale distruzione durante l'ultimo conflitto, si è invece salvata la cappella trecentesca che si apre nel fianco sinistro con una ogiva gotica. Ai lati dell'altare due finestre ad arco acuto illuminano il vano quadrangolare coperto da una crociera nervata, le cui vele sono affrescate con I quattro Evangelisti e i quattro Dottori della Chiesa. Nonostante i ripetuti restauri questa si può considerare più elegante della consimile cappella polentana di San Francesco, anche se non si può concordare con la antica tradizione locale che attribuisce gli affreschi a Giotto, che sarebbe stato presente a Ravenna intorno al 1319, contemporaneamente a Dante. Nel 1384 un documento relativo alla vedova di Guido da Polenta cita una «palazzetta» nel mezzo della domus del signore di Ravenna posta nella regione di San Michele in Africisco. Da ciò si può arguire che i Polentani lasciarono la loro dimora originaria presso alla Porta Ursicina (poi Sisi) per insediarsi più vicino alla piazza Maggiore. Sul lato ovest della piazza era la casa di Bernardino da Polenta, che già nel 1361 era adibita saltuariamente a ufficio comunale. Non sappiamo però se questa o la precedente possa identificarsi anche con la residenza dell'ultimo Ostasio in una casa a corte, dal momento che Giacomo Raisi fu ucciso in un agguato mentre rincasava dal cortile del signore attraversando piazza Maggiore nel 1439. Una residenza suburbana era fuori delle mura a nord, nei pressi di porta Anastasia: forse era la proprietà descritta con casa, corte e colombara, vigne e frutteti «nel borgo delle porte Adriana e Anastazia e posterule, nel loco detto taurexe e archa Sancti Martini». Il codice Polentano registra a metà del Trecento ben 90 case di proprietà polentana. Dalla casa «grande» originaria presso Porta Sisi, la grande proprietà edilizia si era attestata lungo il Padenna nella guaita di San Pietro Maggiore con case turrite all'epoca di Guido Novello e poi nella guaita di San Teodoro (oggi Spirito Santo). Qui, Bernardino possiede nel 1353 una casa a due piani con una parte a un solo piano, granaio e balcone, cortile con pozzo e orto. La casa sulla piazza serviva di alloggio per le guardie a cavallo ed era presso la chiesa di San Tommaso da Canterbury; le case di San Michele in Africisco erano allora in costruzione, ma poi saranno descritte «di mattoni e coppi, a un solare, con corte e balcone». Una masseria era presso la pescheria e un fondaco dietro a San Domenico; qui era pure una casa «balconata e solarata presso il prato» di quella chiesa. Inoltre la proprietà si estendeva anche a «casette presso il bordello», vicino cioè a San Domenico, ad altre nella zona della Cura, presso il «castello» della torre «Polentesia» e sulla «Platea Maior» all'altezza di via Cerchio, nonché a casupole di «lignamine e cannella» acquistate da Guidone nel borgo di Porta Adriana. A ciò si aggiunge una vasta proprietà agricola, che dai borghi di Porta Ursicina, dove è una casa con terreni e fornace, e di Porta Adriana, si estendeva in ogni luogo del forese. Nel 1327 Ostasio da Polenta emana gli statuti municipali. In essi si ribadisce il divieto di demolizione, soprattutto in mancanza di progetto di ricostruzione; l'obbligo di sostituire i tetti di canna palustre con nuovi con il manto di coppi contro il pericolo degli incendi (questo doveva esser fatto entro la festa di Sant'Apollinare); l'obbligo ai più facoltosi del contado di costruire una residenza dentro le mura. Tutte queste sono prove dell'impoverimento edilizio e demografico della città, comprovato anche dal censimento del cardinale Anglic de Grimoard che registra a Ravenna 1743 fuochi, numero inferiore a quelli delle altre città romagnole. _________________________________________
Del 1332 è il patto commerciale con Venezia con cui la capitale dell'Adriatico si assicura privilegi sul sale ravennate a scapito di Bologna; con la penetrazione economica inizia il secolare declino polentano che si conclude con la «dedizione» a Venezia nel 1441. Declino politico, ed economico. Infatti Obizzo impiantò saline a Classe, alimentate dall'acqua del Candiano, ma già nel 1433 esse erano «molto devastate», tanto che il figlio Ostasio dovette cederle come terre «sterili». Poi nel 1437 doveva cedere le sue terre di San Pietro in Trento agli ebrei Musetto e Zenatano da Imola per un prestito concesso dal loro banco a Ravenna. Frattanto si era consolidata la potenza economica della canonica di Porto cui l'arcivescovo concede nel 1439 le terre della cosiddetta Padusa per darle in affitto ai privati e bonificarle, ma l'impresa che inizia a Savarna sarà ostacolata dalle piene del Lamone che qui sfociava. Nascono poi continue liti fra Porto e gli affittuari che denunciano redditi precari e comunque scarsi. Nel 1406 i carmelitani ottengono dal papa l'abbazia di San Giovanni Battista. La navata maggiore della basilica Ursiana fu restaurata nel 1314, e durante il Trecento ci furono alcuni lavori alla sede arcivescovile, come fanno supporre le finestre ogivali nel corpo antico, ad archeggiature e lesene esarcali, che insiste sulla cappella di Sant'Andrea. E ancora gotiche sono le bifore del campanile di San Michele in Africisco che il Ricci fa risalire alla prima metà del Quattrocento insieme ad una cappella a lato dell'abside. Una attività artigianale di spicco era la ceramica invetriata di cui sono rimasti esempi con decorazioni verdi date dagli ossidi di ferro, nelle raccolte private ravennati e nel Museo nazionale. Il ritrovamento di un gruppo cospicuo di esse nella costruzione della sede della Banca Commerciale in piazza dell'Aquila fa supporre che qui fosse una fornace. Ma esistono documenti anche della manifattura «Badai» nella guaita di Sant'Agata Maggiore, della fabbrica «Piantavigna» in quella di Sant'Agnese, degli Albertucci a Santi Giovanni e Paolo, nell'arco del Trecento e poi nel secolo successivo a Porta Sisi e nella guaita del Gazzo, condotte da artigiani tedeschi. Inoltre nel 1372 esisteva una vetreria nella guaita di Sant'Agnese. IL QUATTROCENTO. RAVENNA VENEZIANAQuando i Veneziani entrarono a Ravenna e i Polentani uscirono dalla Porta Anastasia, appena riaperta, dopo che essi l'avevano chiusa, da cui l'appellativo di «Serrata» rimasto alla nuova porta, costruita più a est, per l'esilio a Venezia - trovarono una città in decadenza. Innanzitutto decadenza demografica dentro alle mura e nelle campagne dopo la peste nera trecentesca, e quindi decadenza economica, dopo il sanguinario malgoverno degli ultimi Polentani, con la simonia degli abati camaldolesi di Classe e la quasi estinzione numerica e finanziaria dei benedettini di San Vitale. Iniziò allora una nuova epoca, celebrata dal filo-veneziano Desiderio Spreti con la prima storia di Ravenna a stampa: De amplitudine, de vastatione et de instauratione Urbis Ravennae, con cui narrava la grandezza antica, la decadenza medievale, soprattutto sotto il dominio degli ultimi da Polenta, e la rinascita attuale. In realtà il dominio veneziano fu capillare e inflessibile, ma i loro interessi coincisero con quelli della città che poté riprendere il ruolo di capitale economica e politica della Romagna veneziana, aprendosi contemporaneamente a un hinterland più vasto. _____________________________________ASCR, Cancelleria, 7, f. 20, n. 589 e ASR, Classe, voi. 378, n. 3.
Venezia museo archeologico rilievo con trono di Nettuno da Ravenna, portale dell’arsenale fusti ss. Giovanni e Paolo fusti di colonne di marmo greco reimpiegati nel portale principale da Bartolomeo Bon, colonne forse da s. Severo a Classe. Sigismondo Malatesta ottenne da Venezia di utilizzare marmi dal coro dei cantori di s. Apollinare in Classe. Agostino di Duccio Rimini Tempio Malatestiano
Come a Roma il Rinascimento ebbe una doppia faccia: da un lato studio e ammirazione per l'antico, dall'altro la sua distruzione per ricavare materiali per le nuove costruzioni. Sigismondo Malatesta, generale della Serenissima, compera da Filippo, cardinale di Bologna e commendatario di Classe, i marmi di Sant'Apollinare (forse quelli che rivestivano le navate laterali, o i plutei e le colonnette di porfido e serpentino della «Schola cantorum», posta al centro della basilica) per ornare la prima architettura rinascimentale a nord dell'Appennino del debuttante architetto Leon Battista Alberti, e li paga cento ducati d'oro nel 1449. Dopo l'ambasciata dei ravennati Giovanni Francesco Bracci e Antonio Calvi al doge, questi ordina al podestà Stefano Trevisàn che impedisca ulteriori spoliazioni. Per impedire altre vendite Benedetto Venier assegna nuove entrate a Classe nel 1452 e poi l'abbazia di San Severo con i suoi beni nel 1456. Ma la basilica del vi secolo, vicina a Classe, era ormai in abbandono tanto da essere giudicata pericolante; così il consiglio comunale ne decise la demolizione con l'intenzione di reimpiegare i marmi e le colonne nella costruzione di una chiesa che doveva sorgere accanto all'antica. I Veneziani intervennero e con il pretesto che i monaci di Classe avrebbero potuto vendere anche questi materiali li trasferirono, in maniera cautelativa, a Venezia. Dopo che una buona quantità di colonne aveva preso la via del mare, il senato ravennate intervenne, mentre i capitelli e altri frammenti marmorei stavano per essere caricati. Si chiese al governo veneziano la fine del commercio dei beni ecclesiastici e la restituzione dei materiali trafugati, o in caso contrario un risarcimento in danaro. ______________________________________________ P.D. Pasolini, Delle antiche relazioni fra Ravenna e Venezia, Firenze 1874, p. 228.
Palazzetto veneziano con stemma Lando forse su loggia di epoca polentana sede comunale dopo lo spostamento del comune dal sito dell’attuale sede della banca popolare. Le colonne di granito con il monogramma di Teoderico sono forse spolio della chiesa di s.Agata dei Goti che sorgeva presso l’attuale rocca.
La vicenda si svolse nel novembre del 1465, ma non ci fu mai una restituzione; la basilica di San Severo fu ricostruita nei due anni successivi, ma senza marmi e colonne, mentre invece i portali veneziani dell'Arsenale (1457-1460) e dei Santi Giovanni e Paolo (1459-1463), mostrano quattro e sei colonne di marmo greco, fra cui le prime corredate di capitelli bizantini del vi secolo. Infine nelle collezioni del Museo archeologico di Venezia vi è un frammento del rilievo romano con putti e troni di divinità pagane, già murato in un sottoportico delle procuratie in piazza San Marco nella prima metà del Quattrocento, proveniente da Ravenna, dove restano i frammenti di San Vitale e del Museo arcivescovile, mentre altri sono a Milano e a Parigi. Ancora nel 1467 il podestà veneto emanò nuove norme per impedire la spoliazione delle chiese e due anni più tardi esse furono ribadite dal doge. Probabilmente queste non ebbero un grande effetto, poiché nel 1474 i canonici del Duomo ottennero dal papa il permesso di vendere una grande tavola d'argento, probabilmente quella donata da Carlo Magno che rappresentava Roma, per acquistare beni immobili. Il primo segno della rinascita è civile. Nel 1444 è terminato il «palazzetto veneziano» su piazza Maggiore, dopo una sua parziale rovina. Come abbiamo visto da più di un secolo questo luogo era andato connotandosi come centro del potere e del governo: nel 1288, sempre sullo stesso lato sud, si era eretto il palazzo del podestà, poi nel 1294 vi si era affiancato il palazzo del legato, mentre durante il Trecento Bernardino da Polenta aveva governato la città dalla sua abitazione posta nel lato ovest della piazza e nel 1377 è ricordata la residenza dei Savi nella guaita di San Michele presso Santo Stefano del Mercato, poi detta «palazzo vecchio» per distinguerla dal «nuovo», già esistente nel 1404 sulla piazza. Esso presenta un grande loggiato a pian terreno con archi a tutto sesto sorretti da colonne di granito antiche con capitelli del vi secolo che recano il monogramma di Teoderico. Molto si è discusso sulla loro provenienza: forse daSant'Andrea dei Goti, che però fu abbattuta più tardi per costruire la rocca, oppure dalla basilica di Èrcole, costruita da Teoderico secondo Cassiodoro, da cui prendeva nome la regione sud-ovest del castrum. Addirittura il Savini, che propose la seconda ipotesi, pensa che il portico appartenga alla residenza dei Savi, e quindi sia trecentesco. Fatto sta che probabilmente gli archi -confrontabili con quelli del portico dei Servi a Bologna (1395-1515) - e il piano superiore furono ricostruiti in epoca veneziana. Dietro erano edifici disposti intorno a cortili. Come in altre piazze medievali padane, la «loggia nuova» ha un'ampiezza considerevole, fatta per ospitare le operazioni commerciali private fino al giorno d'oggi. ____________________________C. Ricci, Monumenti veneziani nella piazza di Ravenna, in «Rivista d'arte», in (1905), pp. 27-28, sostiene la tesi che provengano dalla chiesa teodericiana di Sant'Andrea dei Goti, distrutta solo alla fine degli anni cinquanta, mentre il portico risale ai primi anni quaranta, come ha notato G. Savini, Per i monumenti e per la storia di Ravenna, Ravenna 1914, p. 23. Successivamente esso fu distrutto da un incendio e probabilmente rifabbricato dalle colonne in su dai Veneziani. Va notato che già A. Tarlazzi (Le sacre memorie di Ravenna, cit., p. 406) attribuì le colonne alla basilica di Ercole. C. Ricci, Guida di Ravenna, Bologna 1923, p. 14.
Probabilmente essa proseguiva nei portici degli antichi palazzi podestarile e legatizio e forse anche di quello polentano in modo da ricostituire l'immagine di una piazza porticata su almeno due lati, nella tradizione del foro latino. Al piano superiore erano le sale comunali in corrispondenza delle bifore della facciata; esse sono frutto del restauro del 1921, che in maniera alquanto libera ha interpretato le tracce murate per aprire anonime finestre rettangolari. Il balconcino aveva funzione di arengario e presenta mensole e balaustra di pietra d'Istria con lo stemma di Vitale Lando, podestà dal 1461 al 1462. La parete esterna era affrescata, probabilmente con disegni geometrici e una policromia basata sul giallo e sul rosso, sostituiti nel 1921 con il fregio di Adolfo De Carolis, a sua volta scomparso. La presenza di una colonna teodericiana inglobata nel palazzo legatizio dimostra che la loggia continuava verso est con almeno una campata, poi cancellata nelle successive ricostruzioni del palazzo legatizio: in questo modo il «palazzetto veneziano» aveva un prospetto simmetrico. Il 25 maggio 1457 il podestà Pietro Zorzi pone la prima pietra della Rocca Brancaleone, costruita per oltre dieci anni sotto la direzione di Vitale Lando, di Giacomo Corner e del maestro Giovanni Francesco da Massa. Quest'ultimo è forse l'ingegnere della signoria autore del modello in legno approvato nella sua forma quadrata, compresa fra la torre di Porta Nuova ed il gomito delle mura detto «gamba torta», fin dal 17 gennaio 1455 o 1456 (more Veneto). In quell'occasione si decise di murare i mattoni con calcina di Padova, dotata di proprietà idrauliche simili al cemento, di reggere verso l'interno la cortina con speroni collegati da volte per sostenere i camminamenti degli spalti e di demolire l'«anticaglia» di Sant'Andrea dei Goti per ragioni strategiche. Già intorno al 1460 Desiderio Spreti la descrive «ottimamente costrutta ed inespugnabile, dai fondamenti attorniata di vaste mura di pietre cotte e di un'altezza meravigliosa». Essa viene a capovolgere il sistema difensivo medievale del bastione federiciano e del castrum di San Mama nel tratto delle mura sud e si colloca con il castello quadrato e i quattro torrioni rotondi all'angolo nord-est delle mura teodericiane, verso l'antico porto Coriandro e la strada che dal convento di Santa Maria della Rotonda, cioè dal Mausoleo di Teoderico seguiva a nord il rilievo di vecchie dune marine che dividevano le valli dal mare, attraverso la pineta di San Vitale fino al Passo di Primaro. Così per terra e per mare essa poteva essere soccorsa da Venezia e controllare la città e la Romagna. La sua posizione viene a corrispondere ai precetti che Leon Battista Alberti detta intorno al 1450 (De re aedificatoria, Libro v, cap. iv): la rocca non sia né all'interno, né all'esterno della città, bensì collegata alle mura e del tutto autosufficiente, tanto da essere una piccola città nella città. La sua funzione è piuttosto di controllo e deterrente verso l'interno che di difesa verso l'esterno; per questo le bombarde più numerose sono nei torrioni rivolti verso la città. Nei lati sud e nord al centro della cortina si elevano due torri quadrate che reggevano i ponti levatoi; qui si apre la porta verso la cittadella e quella di soccorso rivolta in direzione di Venezia e fortificata da un avamposto. Torri e torrioni sono oggi in gran parte demoliti alla sommità che aveva caditoie e beccatelli, rimasti solo sulla cortina. A sud si estende il vasto ridotto, detto «barbacan» con la polveriera, il forno, le stalle e gli alloggi della guarnigione che forma la cittadella veneziana cinta da mura con due torrioni a sud sui quali si innesta il tratto est delle mura. Per costruirla i Veneziani distrussero, come si è detto, la chiesa di Sant'Andrea dei Goti e trassero mattoni da Cesarea, da Classe e dalla torre polentana detta «Beldeduit» in francese antico, cioè «bel diporto», probabilmente situata nella zona di Cenceda, fuori dalle mura e quindi pericolosa per la difesa della rocca. Il Montone alimentava il fossato che cingeva il castello, mentre un altro circondava la cittadella, collegandosi alla rete dei fiumicelli interni secondo una linea parallela a via Rocca i Fossi, dal Padenna presso San Giovanni Battista al lato sud della cittadella. Probabilmente questo nuovo corso trasversale venne a sostituire quello longitudinale del Padenna, permettendo la sistemazione del centro della città e l'ampliamento della piazza Maggiore. Le mura e le torri cilindriche del maschio si ergevano su scarpate, raccordate da un toro in mattoni alle pareti verticali, oggi demolite di svariati metri alla sommità, dove erano beccatelli, caditoie e merli. Infatti dal Seicento esse furono cave di mattoni per la costruzione del monastero di Classe, del ponte Nuovo, del Teatro vecchio e della chiusa sul Montone a San Marco. La porta della torre della Madonna si apre verso il ridotto con le profonde asole laterali donde sporgevano le catene del ponte levatoio. Sopra la porta è il bassorilievo in pietra d'Istria di una Madonna con Bambino, coeva alla costruzione, un frammento dello stemma Foscari e il Leone andante di Marino di Marco Cedrini del 1458, danneggiato dopo l'abbattimento nel 1509 e scolpito al rovescio nel 1559 dal milanese Filippo Mariani con lo stemma papale di Giulio III, ma che conserva l'efficacia espressiva originale nel suo muso feroce e minaccioso. ______________________________________La lettera di Francesco Foscari a Lorenzo Soranzo, podestà e capitano di Ravenna, che descrive il progetto della rocca è in Fantuzzi, iv, pp. 493-494, e vedi la ricostruzione disegnata in G.P. Bolzani e N. Pirazzoli (a cura di), Una fortezza veneziana a Ravenna, la rocca Tìrancaleone, mostra tenuta a palazzo Corradini, a Ravenna nel novembre 1983, del lavoro di tesi di laurea di studenti dell'Istituto universitario di Architettura di Venezia.
Dalla rocca partì il rifacimento delle mura, che con intervalli e interruzioni si protrasse per tutti i settant'anni della dominazione con la chiusura di porte e posterule che avevano perso di importanza e il mantenimento delle principali. Restano quindi aperte le Porte Adriana, Gaza (di pertinenza dell'arcivescovo), San Marna e Sisi; la prima e l'ultima di accesso ai principali borghi e alle vie di collegamento più frequentate con la campagna e gli altri centri romagnoli, mentre stranamente si chiuse la porta di San Lorenzo verso la strada di Roma e il porto Candiano. La richiesta del papa che Ravenna gli fosse restituita nel 1483 portò a un vasto programma di rinforzo della cinta muraria alla cui spesa le abbazie furono obbligate a contribuire. In particolare, grande cura si diede nel 1494 a rinforzare la cerchia verso sud-ovest con le torri «Leggia» e «Zancana». La prima prende il nome dal podestà Andrea da Lezze, la seconda dal podestà Andrea Zancàn, che la costruì nel 1496. Questa è detta «il torrione» per le sue maggiori dimensioni; la sua posizione a cerniera fra la cortina ovest e quella sud la doveva rendere strategica al fine di respingere un probabile attacco pontificio; inoltre essa viene a situarsi in diametrale opposizione alla rocca. Nonostante la sua funzione e la distruzione della parte superiore, soprattutto durante l'assedio successivo alla battaglia di Ravenna, essa mostra ancora una ricchezza di materiali insolita nell'architettura militare contemporanea: il cordulo fra la scarpata e il muro cilindrico è costituito da conci di pietra d'Istria e non da mattoni arrotondati come nella rocca; così le mensole che reggono le caditoie sono nella medesima pietra scolpite con volute terminali e ornamenti in bassorilievo, e non in laterizio, come nella cortina della rocca. La piazza di fuoco era probabilmente coperta da un tetto, come si vede nella più antica pianta di Ravenna, databile alla fine del secolo, che la mostra più alta e dominante non solo le altre torri murarie, ma la stessa rocca. La sua magnificenza architettonica voleva forse emulare la vicina Porta Aurea, ormai spogliata in parte, privata delle torri laterali, murata e parzialmente interrata, nel segno della rinascenza cittadina per opera dei Veneziani, ma anche a spese dei Ravennati, a cominciare dalle abbazie. I torrioni rotondi sono propri dell'architettura militare quattrocentesca di transizione: sono innovativi rispetto alle alte torri medievali a pianta quadrata del brunelleschiano castel Sismondo di Rimini, ma arcaici rispetto alla rocca di Cesena di Francesco di Giorgio o a quelle sforzesche di Imola e di Lugo. nei periodi di magra da una diga sul Montone nel 1470. La celebre lapide del 1493 reca il nome del podestà Girolamo Donà, promotore della costruzione del mulino. __________________________________________G. Caravita, L'acqua di Ravenna, Ravenna 1988, pp. 155-159.
Pianta di Ravenna con i fiumi Ronco e Montone, seconda metà 1400. Arch. Stor. Com. Rav.61 orientata est in alto ovest in basso. Si nota la rocca veneziana in alto, le torri Zancana e Lezze in basso e il canale dei mulini, i borghi di S. Mama e di San Biagio con il canalazzo comunicante con le valli a nord. !!!!II Montone e il Ronco venivano a completare il sistema difensivo scorrendo sotto le mura, e probabilmente furono scavati per migliorarne la difesa e lo scorrimento verso il mare, ma il fenomeno di interramento e innalzamento dell'alveo cominciava già a renderli pericolosi assedianti della città. La loro acqua non era potabile nemmeno per gli animali e veniva sostituita da pozzi, scavati per raggiungere falde sotterranee, spesso invase dall'acqua salata, o da cisterne nei cortili delle case, dove come a Venezia, si raccoglieva l'acqua piovana. Alcune vere da pozzo di epoca veneziana si sono conservate nei chiostri francescani, a Classe, a San Nicolò, a San Vitale, come in corti private: palazzo Rasponi dalle teste, Guaccimanni, Minzoni, anche se in alcuni casi si tratta di materiale erratico. Nel borgo San Biagio la via dei Pozzi conferma il documento del 1360 dove si parla di un«loco dicto i pozzi, non multum longe a civitate Ravenne». Qui l'acqua filtrava dall'argine destro del Montone attraverso strati di sabbia che dovevano renderla potabile. Quella dei fiumi, invece, poteva tuttalpiù servire per periodi saltuari a muovere le pale del mulino - già polentano - costruito fuori Porta San Marna con un canale di derivazione dal Montone al Ronco per sfruttare una piccola caduta, sensibilmente maggiore però di quella quasi nulla del Montone nel suo vizioso giro a nord e nuovamente a sud. E questa caduta fu aumentata, e regolata
20
Testo
La caduta di Costantinopoli, e ancor di più le perdite successive di Negroponte (Eubea) e di altre isole dell'Egeo, furono una delle occasioni che i Veneziani sfruttarono per ripopolare la città. I profughi più ricchi comprarono case in città e poderi in campagna (fra questi Serafino Pasolini cita i Bolcichi, chiamati «Bancherii», e i Pellegrini, detti «Cavallari»). I più poveri furono alloggiati nella cittadella. Alcuni provenivano da Candia e da altri possedimenti veneziani del Mediterraneo orientale; insieme ad Albanesi, Dalmati e Istriani, componevano in gran parte la guarnigione veneta. Gli ebrei di origine italiana erano già importanti nella tarda signoria polentana, ma continuarono a vivere sparsi nella città e avevano la loro sinagoga vicino al duomo. Intorno al 1460 Desiderio Spreti scrive il De amplitudine, de vastatione et de instauratione Urbis Ravennae che sarà stampato a Venezia, per iniziativa del figlio Gian Battista, nel 1489 con i tipi del parmense Matteo Capcasa. Questo incunabolo traccia un arco storico che collega la grandezza imperiale ed esarcale all'«augustum venetorum imperium», scavalcando polemicamente i secoli di abbandono remoti e recenti, compresi quelli dei «crudelissimi tiranni» da Polenta. E’ chiaramente una storia filoveneziana, testimonianza di un partito che si era formato con successo soprattutto fra le famiglie più importanti che avevano patito la tirannia degli ultimi signori, ma può servire a leggere gli interventi architettonici e urbanistici promossi dalla Dominante nei settant'anni scarsi di «Ravenna veneziana». Il concetto di instauratio è quello che si ritrova nella Roma di Nicolo v e nei progetti di restauro di Leon Battista Alberti, o nella celebrazione umanistica di Biondo Flavio, come nella Venezia che il riminese Filippo Morandi celebra come «altera Roma», e di cui Sabellico, nella sua storia pubblicata a Venezia nello stesso anno di quella ravennate, sostiene la superiorità sulla prima. A Venezia la porta dell'arsenale (1457-1460) è la prima architettura rinascimentale nel suo esplicito richiamo all'arco dei Sergi a Pola, ma le colonne binate ai lati sono reperti bizantini reimpiegati con i loro capitelli traforati, probabilmente del vi secolo. L'impiego di materiale di spoglio è usuale nell'epoca, e abbiamo visto come i Veneziani ne fossero maestri. Ma in questo riuso va forse visto un valore simbolico di appropriazione e memoria di un mondo di cui ci si considera eredi e che l'arsenale deve difendere dai Turchi e riconquistare. John Ruskin definì le opere dei Codussi, Lombardo, Rizzo, Buora, Spavento come «rinascimento bizantino», considerando «naturale che la mente veneziana si rivolgesse indietro con affetto a quei modelli bizantini nei quali l'arco rotondo e la colonna isolata [...] si presentavano sotto una forma consacrata dall'uso degli antenati». In tempi recenti John McAndrew e James Ackerman hanno analizzato questo fenomeno prendendo in esame una serie di architetture che vanno dal 1464 al 1509 circa - proprio gli anni di Ravenna veneziana - riconoscendovi un programma deliberato di «rinascita bizantina [...] con ogni probabilità, conservatore, ecclesiastico, in alcuni casi populista; perfino in alcuni settori antirinascimentale». Lionello Puppi ha visto nella connessione fra i committenti di Mauro Codussi e l'ambiente camaldolese un «partito della pace» intenzionato a un rinnovamento religioso ed etico di Venezia da tradurre anche in forma architettonica e urbanistica a partire da San Michele in Isola (1468). Non a caso il tagliapietre bergamasco appare già legato ai camaldolesi e l'Angelini ha ipotizzato un suo tirocinio romagnolo fra Classe e Cesena, con trasferte a Rimini e a Firenze per trarre ispirazione a concepire il suo primo capolavoro: la chiesa veneziana della congregazione camaldolese che viene riunita alla ravennate nel 1475. Certamente è presente a Classe nel 1477-1478 per restauri alla basilica e al monastero su incarico dell'abate veneziano Pietro Donà, suo estimatore per la costruzione di San Michele, che pure è trasferito nell'abbazia ravennate. Forse a lui si devono le bifore rade che sostituirono le finestre originali. E per le sue prestazioni a San Michele e a Classe chiede a Pietro Dolfin di intercedere presso il Donà per la concessione in enfiteusi di un fondo classense nell'agro di Cesenatico. Ma oltre alle «novità antiche» del disegno albertiano, _______________________________________Pasolini, Lustri, p. in (1680), 1. 10", pp. 116-117. J. Ruskin, Le pietre di Venezia (1851), trad. it. di A. Tornei, Firenze 1974, pp. 146-147. 26 J.S. Ackerman, L'architettura religiosa veneta in rapporto a quella toscana del rinascimento, in «Bollettino del CISA», xix (1977), pp. 135-164, e inoltre). McAndrew, L'architettura veneziana del primo Rinascimento, trad. it. Venezia 1983, pp. 32-38. M. Mazzotti, S. Apollinare in Classe, Ravenna 1953, pp. 91-93; G. Cortesi, La zona e la basilica di San Severo nel territorio di Classe, Ravenna 1964, p. 67; A. Angelini, Le opere in Venezia di Mauro Codussi, Milano 1945, p. 33; L. Olivato, L. Puppi, Mauro Codussi, Milano 1977, pp. 22-23 e 257. Per l'iconografia delle bifore cfr. V. Coronelli, Ravenna ricercata [1707 ca.] e un acquerello ottocentesco di R. Liverani in M. Mazzotti, G. Ravaldini, Ravenna nel passato: monumenti e vedute, Ravenna 1980, p. 93.
l'interno di San Michele mostra una originale interpretazione dello spazio basilicale, unica a Venezia, che solo Classe poteva suggerirgli. Inoltre il modello del Tempio malatestiano poteva essere integrato da quello della ben più modesta basilica nuova di San Severo, demolita nel 1820, che stando ai patti conclusi fra l'abate Pietro da Monte e il muratore Giovanni di Meio da Ferrara il primo novembre 1468, era di tipo basilicale a tre navate con volta, probabilmente sopra il presbiterio, sostenuta da un tamburo ottagonale («cuba sive tribuna») raccordato con pennacchi; all'interno correva una cornice, disegnata «secundum morem antiquum», ispirata a quella di San Lorenzo in Cesarea, mentre la chiesa era bianca e smaltata «secundum morem venetorum». Tanto che si può pensare che viceversa l'abate classense avesse in mente il modello codussiano per San Michele, già approvato e in costruzione, dato che appare una stretta somiglianzà fra i due edifici dove la tradizione ravennate si unisce alla veneziana con l'innesto della cupola all'impianto basilicale. Però proprio nella cupola sta la differenza: quella di Codussi è circolare su pennacchi e diviene modello per il Rinascimento veneziano, mentre quella nuova di San Severo è descritta nel contratto «cum octo cantonis sive angulis», cioè secondo una tipologia ancora medievale. Anche se Venezia fonderà le sue origini nella «respublica» voluta da Dio tramite San Marco e la Vergine, libera fin dalla nascita, cancellando la dominazione esarcale, la storia non si cancella; la sua civiltà artistica l'accomuna all'«antica madre» in decadenza e i legami si vengono ora a rinsaldare anche nel segno di San Romualdo e di Ambrogio Traversar!, facendo coincidere la rinascita di Costantinopoli nelle lagune con quella di Ravenna veneziana. Il Bessarione ne poteva essere l'ispiratore, investito da Eugenio iv dell'amministrazione di San Giovanni Evangelista e di Santa Maria in Cosmedin, che riuniva nel 1459 al monastero bolognese di San Salvatore, mentre inaugurava una politica permissiva verso gli ebrei. A Ravenna infine egli muore nel 1472. Il tombamento del Padenna e il disegno urbano II 15 maggio 1449 il doge Francesco Foscari scriveva al podestà Pietro Trevisan di esaudire le richieste degli ambasciatori ravennati con l'escavazione periodica dei «fiumicelli della città»; ciò è ribadito il 1° novembre 1461 con la concessione di costruirvi dei mulini, ma resta il fatto che essi scompaiono dai documenti e che edifici quattrocenteschi sorgono nell'alveo del Padenna che attraversa il centro. Sempre nella stessa data si dava facoltà di trasferire la casa di tolleranza dal sito centrale di San Domenico, sulla strada pubblica, in un luogo più appartato. Forse durante la podestaria di Nicolò Giustinian (1467-1469) - costruttore di case e chiese, di strade lastricate e scavatore dei fiumi urbani in nuovi alvei rettilinei - ci fu la scomparsa della residua percorrenza acquea interna e il definitivo assetto urbanistico moderno, segnato dall'ordine del doge Moro al podestà Zaccaria Barbaro di abbattere tutti i portici delle case (da intendersi come superfetazioni e sporti ad uso privato che rendevano irregolari e pericolose le strade) e dalla selciatura delle strade e delle piazze fino allora sterrate, probabilmente con mattoni di taglio o cocciopesto. Tanto che il 3 novembre 1495 si stabilivano pene per i danni che i «plaustri» ferrati arrecavano alla pavimentazione e si concedeva di fare «ogni ano uno pozo ad minus ad modo de Venetia in luochi publici». _______A. Tarlazzi, Le sacre memorie..., cit., p. 405. Fantuzzi, iv, p. 478. Rossi, p. 642 in data 1484.
Altrettanto importante, soprattutto nel futuro, era il problema del drenaggio delle acque all'interno delle mura. Almeno per la zona nord si cercò di risolverlo con lo «scolo di città», che partendo dal fianco sud di San Giovanni Battista percorreva l'attuale via Ugo Bassi e attraversava le mura a nord della stazione ferroviaria con un sifone di legno (da cui anche il nome di «ponte-canale»), per poi attraversare la zona di Cencèda. Probabilmente ciò permise il tombamento del Padenna, ormai naturalmente interrato, che non è solo un fatto idraulico, bensì un evento che segna il futuro urbanistico di tutto il centro urbano. Esso aveva disegnato nei millenni gli allineamenti delle case e dei quadriportici delle basiliche e lungo le sue rive leggermente sinuose si erano formati i principali assi viarì nord-sud. Ora si vengono a creare nuovi lotti edificabili e soprattutto è reso possibile il disegno della piazza Maggiore, che abbiamo visto già definita architettonicamente nei lati sud e ovest. Con le sue dimensioni, di due quadrati all'incirca, essa corrisponde alle prescrizioni albertiane (De re aedificatoria, libro vili, cap. vi) a proposito del foro latino. Questa immagine è ulteriormente ribadita dai portici su cui si innestano le strade laterali, come via Palserrato (l'attuale Cairoli), anche se la grande campata diagonale che collega il palazzetto veneziano al comunale fu costruita nel Cinquecento. Nei restauri del 1913 furono scoperti e ripristinati i merli trilobati, tipicamente veneziani; sotto il portico poi fu messa in luce la colonna che reca segni di anelli su cui si innestava la catena, o il palo per la chiusura notturna della via «Palserrato». Probabilmente esisteva già allora un ampio passaggio sotto il palazzo senatorio per collegare la piazza alla piazzetta dell'Aquila (allora della legna), di proporzioni all'incirca quadrate; Girolamo Rossi, nella sua Historia} dà grande risalto al restauro dei palazzi podestarili, nonché all'allargamento e alla pavimentazione della piazza Maggiore, dove fino ad allora cresceva l'erba e si incrociavano due sentieri sterrati, e all'erezione delle colonne. E’ con queste opere che il cuore della città assume l'aspetto di foro. In definitiva il sistema delle piazze, che connota il cuore della città, trova in questo momento la sua definizione permanente anche attraverso le rifabbriche successive del palazzo senatorio e di quello legatizio. Né va dimenticato che nel 1475, nella vicina Faenza, Carlo II Manfredi iniziava la costruzione della piazza con il duplice porticato, che solo a lavori ultimati alla fine del Settecento assumerà un ben più esplicito aspetto di foro romano secondo la trattatistica vitruviana e albertiana. Se il restauro della «loggia nuova» resta un frammento di un disegno urbanistico incompiuto dai Veneziani, le podestarie di Bernardo Bembo e di Baldassarre Trevisan vengono a compiere l'immagine veneziana della piazza Maggiore secondo un modello diffuso nelle città dello stato da Terra. Bernardo Bembo, da colto umanista, in contatto con la corte di Lorenzo il Magnifico, forse già nel suo breve periodo ravennate possedeva il codice del De re aedificatoria albertiano, ora a Eton College (ms. 128, e); in ogni caso questo conferma i suoi interessi urbanistici e architettonici che ne fanno uno dei maggiori promotori della «rinascenza» ravennate. Qui chiama Pietro Lombardo, allora lo scultore architetto di maggior fama a Venezia, a erigere le colonne di Apollinare e Marco, a disegnare e scolpire la tomba di Dante e forse a progettare il lato est della piazza Maggiore con le chiese gemelle di San Sebastiano (sostituito nell'intitolazione al martire bolognese Ruffillo), e di San Marco, già esistenti, ma ricostruite e ricomposte in una facciata unitaria, sormontata dall'orologio civico. E’ chiaro il significato simbolico di questo programma che unisce la città dominata alla dominante in un rapporto paritetico, ma basato comunque sull'innesto nella prima dei modelli urbanistici collaudati nella seconda e viceversa, senza dimenticare il poeta con un atto di pietas verso la sepoltura polentana, ormai labente soprattutto nelle parti affrescate. Infatti se nelle due colonne è ovvio il riferimento alla Piazzetta marciana, la torre dell'orologio, se la consideriamo iniziata nel 1483, precede quella veneziana, attribuita a Mauro Codussi (1496-1499), resa poi più simile, anche se più ricca, alla ravennate dall'aggiunta delle ali laterali (1500-1506), attribuite a Pietro Lombardo. Probabile modello fu la torre di piazza dei Signori a Padova con il grandioso orologio (1427-1437), dal momento che, stando ai disegni del Morigia, essa era sormontata da una torretta con una bifora per la cella campanaria e un cupolino, probabilmente costruito in legno e ricoperto di piombo. Esso è tipico dell'edilizia veneziana quattrocentesca (Arsenale, Santa Maria dei Miracoli ecc.), ma quello disegnato dal Morigia è più tardo, dal momento che fu ricostruito nel secolo xvii. Il Fiandrini considera la torre compiuta nel 1505, ma solo il 7 marzo 1510 il consiglio decise di fare un nuovo orologio, accogliendo l'offerta di Anastasio Cellini, che poi nel 1516 si associò ad Antonio Burchiella da Imola. ________________ Rossi, p. 642 in data 1484. " Secondo Girolamo Rossi e Camillo Morigia il congegno meccanico fu costruito dal ravennate Anastasio Cellini fra il 1483 e il 1484. BCR, Fondo Morigia, cassa grande, 82.6.a, cartella iv, 9/2. " S. Bernicoli, Le torri..., cit.,p. 40, dove informa che già prima del 1483 esisteva un orologio meccanico nella piazza. W. Barbiani (La dominazione veneta a Ravenna, Ravenna 1927, p. 120) ha identificato il Cellini nel notaio che propose la costruzione dell'orologio al consiglio comunale del 7 marzo 1510.
Ravenna veneziana, Sede del Monte di Pietà 1492, casa Loredan, casa Maioli, Ghigi, Diedo, albergo Cappello
Si può avanzare l'ipotesi che gli scultori Matteo da Ragusa e Giovanni Antonio da Milano non siano stati solo gli autori del portale di San Marco e del bassorilievo marmoreo (oggi in Duomo), ma anche della facciata e della torre dell'orologio, ma non conosciamo loro opere architettoniche a cui confrontare il disegno del Morigia. D'altro canto, facciata e torre si possono ricondurre allo stile di Pietro Lombardo e alla sua bottega ed è possibile trovare un richiamo del fianco della chiesa dei Miracoli e della scuola di San Marco a Venezia. Nel disegno del Morigia un doppio ordine di pilastri sorregge le due trabeazioni, impaginando al piano terra i portali di dimensioni diverse (quello di San Sebastiano del 1467 sotto la podestaria di Nicolo Giustinian e quello di San Marco del 1493 sotto Marco Bragadin); al centro del secondo ordine era il quadrante in pietra d'Istria dell'orologio, ora nel giardino del palazzo della Provincia. Straordinaria è poi la tipologia delle due chiese, dove quella di San Marco viene ricostruita e ampliata a fianco di San Sebastiano per creare uno spazio intercomunicante con colonne ed archi che creano due navate. Le colonne, poste contro il palazzo vecchio inquadrano l'orologio, come quelle veneziane. I fusti di granito orientale sono di provenienza antica, ma ignota; nei basamenti a ripiani, Pietro e i suoi collaboratori riecheggiarono il modello marciano, aggiornandone simbologia e stile secondo il repertorio antico. I rilievi raffinati si avvicinano a quelli contemporanei dell'interno dei Miracoli a Venezia, dove forse il Lombardo toccò il culmine di scultore e decoratore; l’effetto era reso ancor piùprezioso da lumeggiature in oro, tipiche del primo rinascimento veneziano. I capitelli corinzi, sormontati da dadi, sono insoliti per la bottega lombardesca e mancano nei modelli marciani; essi esprimono una attenzione per la grammatica classica dell'architettura di stampo umanistico, forse dettata dal colto podestà Bembo. Solo la statua di Sant'Apollinare si è conservata, mentre il Leone marciano fu portato dalle truppe papaline a Bologna. La tomba di Dante fu ricostruita nello stesso luogo e con lo stesso orientamento. Come quella polentana era appoggiata al lato esterno del più antico chiostro francescano, aperta a ovest sul portico che la congiungeva alla chiesetta di Braccioforte. Probabilmente si rifece la copertura a volte a crociera e l'arco d'ingresso in conci di pietra d'Istria, ma soprattutto Pietro Lombardo inserì la nuova urna rinascimentale e il bassorilievo prospettico con il ritratto di Dante intento a scrivere le sue opere in una architettura semplice, incorniciata da paraste e sormontata da una lunetta, che ben si inseriva nelle forme semplici del sacello, ottenuto dalla occlusione di una campata del portico. Il suo disegno ha resistito alla ricostruzione seicentesca, che ha portato al nuovo orientamento, in seguito alla demolizione del portico, e a quella settecentesca, dove il tempietto del Morigia ha rispettato la cornice architettonica dell'urna. _______________________E. Mattaliano, La scultura a Ravenna nei luoghi e negli edifici pubblici fra Quattro e Cinquecento, in Ravenna in età veneziana, a cura di D. Bolognesi, Ravenna 1986, p. 334.
Loggia molto restaurata di edificio con torre ora dietro a palazzo Spreti che ha inglobato la torre presso l’antico corso del Padenna .
L'architettura civile Nell'architettura civile, caratteristiche padane, come l'uso diffuso di cornici e ornamenti in cotto, si uniscono a modi veneti, nel disegno dei portali e nei balconi con balaustra in pietra d'Istria, nell'inserimento già descritto di vere da pozzo con cisterne al centro dei cortili. Certo qui l'influsso veneziano fu meno forte che nei monumenti ufficiali. Del tutto padana è l'architettura del Monte di Pietà del 1492, che si allunga sulla via «Giustiniana», oggi Diaz, per collegarla con la «Platea Maior», oggi via di Roma. La predicazione di Bernardino da Feltre, presente nel 1487 nel convento di San Mama, dove venivano allora introdotti i padri minori osservanti, ne aveva promosso l'istituzione nella casa concessa da Valerio Mainardi e poi ampliata. Scomparsi gli affreschi che ornavano la facciata, probabilmente dipinti da Nicolo Rondinelli con motivi decorativi rinascimentali, improntati alla plastica dei Lombardo e alla pittura dei Bellini, oggi solo piccole finestre con archi a tutto sesto, il portale con architrave in pietra d'Istria e soprattutto il cornicione in cotto sono gli elementi che articolano questa architettura. Essa pare partecipe più dei modi padani, e in particolare ferraresi, non solo nell'uso del cotto, plasmato in forme ornamentali, come in tutti gli edifici civili ravennati di quell'epoca, bensì nell'impianto allungato lungo la strada. Sul lato opposto di via Diaz è il palazzo forse Zorzi (1492-1498?), poi Guaccimanni, Caserta, dove il portale a lunetta ornata in cotto e il balcone su mensole di pietra d'Istria (ancora di forme tardogotiche, tipiche dell'area veneta) sono gli unici elementi originali nella facciata. Piuttosto nel cortile interno con loggiato e quadrifora al primo piano, vera da pozzo e scala esterna, è possibile ritrovare la tipologia della casa a corte, già diffusa a Ravenna nelle epoche precedenti, aggiornata da influssi veneti. Ancora il cotto e gli influssi ferraresi dominano nella casa Minzoni in via Cairoli (allora «Palserrato») nel cornicione e nel monogramma bernardiniano, così diffuso nell'edilizia di questa epoca in vai Padana, mentre le mensole del balconcino riportano a modi veneziani. Questi sono più espliciti nel cortile interno che presenta un loggiato su due archi al pian terreno; sopra corre su due lati una loggetta: ancora la tipologia della casa a corte con doppio loggiato con l'interessante variante del terzo piano, segnato da piccole finestre ad arco. La presenza di uno stemma, riferito da Umberto Foschi a Vitale Lando, porterebbe a ritenerla la sua abitazione, a iniziare forse dal 1456, quando fu soprintendente ai lavori della rocca, per poi divenire podestà. In ogni caso non la si può identificare con la casa venduta da Antonio alla famiglia Abbiosi, come rilevava il Bernicoli in contrasto con il Ricci; essa invece è la Fabri, oggi ricostruita nella parte prospiciente via Guido da Polenta, ma che conserva pure una corte con loggiato, seppure molto restaurata. Un androne conduceva a via Marsala (delle Melarance); quindi bisogna pensare che al tempo della costruzione il Padenna in quel punto fosse già tombato. Sempre in via Cairoli, al n. 1, è una casa dal cornicione in cotto di stile ferrarese, una targa reca la data «1501, xxiii Zugno». Motivi veneziani e ferraresi si intrecciano nell'ex albergo Cappello, già temporanea dimora di Biondo Flavio. I primi consistono nel portale a lunetta di pietra d'Istria, raccordato all'architrave con volute lombardesche, e nel balcone marmoreo di forme pure lombardesche: tipicamente ferrarese è invece il pilastro d'angolo in pietra d'Istria che sembra richiamare i più grandiosi esempi dell'addizione erculea rossettiana; un esempio più tardo lo si vede nel palazzo Settecastelli in via Mazzini, di fronte alla basilica di Sant'Agata. Più vicine a modi rinascimentali centro-italiani sono le cornici marmoree delle finestre del primo piano, mentre il balcone presenta mensole a volute molto più rinascimentali rispetto a quelle di palazzo Zorzi e così è per i balaustri di pietra d'Istria che reggono il parapetto ornato agli angoli da due pigne. __________________________________S. Bernicoli, Una casa storica, FR, xxx (1925), pp. 23-42. U. Foschi, Case e famiglie della vecchia Ravenna, Ravenna 1970, pp. 121-124; C. Ricci, Guida di Ravenna, cit., p. 32; S. Bernicoli, Le case polentane..., in Ricordi di Ravenna medievale, Ravenna 1921, pp. 132-133.
Accanto alla torre comunale, casa Melandri presenta un portico su pilastri con i tre archi ornati da ghiere in laterizio dei primi del Cinquecento. Essi fanno pensare a una parziale rifabbrica in epoca veneziana di parte di un edificio più antico, forse la domus dei Guiccioli di cui faceva parte la torre. La parte superiore è invece una rifabbrica in stile del 1905. Accanto il ponte Marino varcava il Padenna: i suoi resti affiorarono durante gli scavi del 1915 per le fondazioni del mercato coperto e rivelarono materiali del secolo xv o xvi. Ciò induce a pensare che il Padenna in questo tratto fosse ancora vivo e scoperto. Una tipologia di balcone di derivazione veneziana è il balcone d'angolo. Di essa sopravvive un esempio in casa Succi in via Romolo Gessi con mensole di pietra d'Istria di forma ancora tardogotica; più tardo pare invece il balcone di casa Oraziani, distrutto dai bombardamenti del 1944, che presentava mensole analoghe, mentre balaustra e parapetto erano decisamente più tardi (Cinquecento inoltrato). Il gotico fu lento a sparire. Ancora intorno al 1490 la cosiddetta «casa di Guidarello», demolita nel 1934 per creare l'attuale piazza dei Caduti, presentava in facciata un arco in cotto a sesto acuto ornato da motivi decorativi simili alle case manfrediane di Faenza. Tre archi murati di finestre nella casa Antonellini in via Girolamo Rossi, di fronte a San Giovanni Battista, presentano la forma ad ogiva ornata da una ghiera in cotto a forma di conchiglie, tipica dell'ambiente altoadriatico quattrocentesco. La tipologia del cortile interno con logge al massimo a due piani era invece preesistente e addirittura tardoromana, ma come abbiamo visto, tuttora vivissima nel Quattrocento, come dimostra il grande loggiato nel cortile di palazzo Spreti, anche se molto restaurato, di dimensioni paragonabili ai chiostri conventuali. Le bifore pure sono una forma di finestre preesistente (per esempio casa Traversari) che nell'epoca veneziana ebbero grande diffusione, a cominciare dal palazzetto comunale, nel campanile gotico di San Michele in Africisco, fino a quelle più belle e mature della casa Maioli, ora Brocchi, in via Paolo Costa. Esse si diffusero anche a Venezia, soprattutto per opera di Mauro Codussi (palazzi Lando e Loredan), ma gli esempi ravennati appaiono indipendenti e partecipi della tradizione padana nell'uso ampio del laterizio per i motivi decorativi. Nonostante la presenza di una sala passante in casa Brocchi, simile di concezione al «portego» veneziano, il camino ottagonale, che sorge su un semicono di piccoli mattoni messi d'angolo per dare l'effetto di piccoli diamanti (una tecnica tardoesarcale che a Venezia è detta «osso di pesca») è piuttosto padano e ferrarese in particolare. Anche i finestroni della cupola di San Vitale presentavano, fino ai restauri dell'inizio del Novecento, bifore di fine Quattrocento o tuttalpiù anteriori al 1520 circa (dal momento che furono registrate dal Falconetto negli affreschi dei Mesi di palazzo d'Arco a Mantova e anche da Antonio da Sangallo il Giovane). Esse avevano funzione statica come rinforzo dell'arco principale, ma soprattutto estetica, seguendo l'esempio dei restauri di Santo Stefano Rotondo a Roma di Leon Battista Alberti intorno al 1450. Ai primi decenni del Cinquecento appartiene la casa Diedi in via Romolo Gessi che presenta finestre rettangolari con cornice in pietra d'Istria simili a quelle dell'ex albergo Cappello e un balconcino con balaustra in pietra d'Istria. In corrispondenza di esso la casa si apre con una bifora a tutta altezza con una colonna centrale e cornici in cotto. Gli edifici civili dell'epoca si collocano quindi nelle vie che si diramano dalla piazza. Maggiore e in quelle che ad esse afferiscono, testimonianze di un rinnovamento edilizio che i secoli non hanno cancellato.
Le fabbriche religiose Piccole fabbriche ecclesiastiche mantengono caratteri arcaici locali con murature a facciavista appena articolate da lesene e arcatelle, come nella facciata di Santa Giustina «in capite porticus» e nel fianco di San Giacomo in via Ponte Marino, dove la ghiera del portale in cotto è l'unico elemento rinascimentale. Santa Maria delle Croci e Santa Barbara discendono da San Nicolò. Esemplare di questa minima tipologia è il santuario della Madonna del Pino, costruito nella pineta di Cervia fra il 1484 e il 1504; però qui alle lesene si aggiungono elementi tardogotici nel disegno della fascia laterizia di gronda, nei cippi, che a guisa di pinnacoli, segnano gli angoli dell'edificio e della cappella absidale, fortemente sporgente sul retro. Una lesena del fianco sarà poi demolita per la costruzione del portale marmoreo, che ancora nel 1577 ripropone colonne, capitelli e lunetta lombardeschi. Importante per la costruzione della città è l'attività edilizia monastica. Il convento di San Francesco probabilmente completò con i lati est e nord le ali già esistenti a sud e ad ovest, uniformando anche queste al disegno tardo quattrocentesco. Nel secolo seguente si aggiunse il secondo chiostro usando colonne e materiale antico. La loro architettura è povera e arcaica, soprattutto nelle loggette al primo piano del lato sud del chiostro più vicino alla basilica e del lato nord dell'altro chiostro. Vi si può trovare una analogia con quella civile del cortile Spreti. Lavori di rinnovamento furono compiuti a San Giovanni Evangelista con la partecipazione dell'unico architetto dell'epoca definito «ravennate», Bernardino Guiriti, nel 1485. Ragioni militari, ma anche civili, nel segno della rinascita di Ravenna all'interno delle mura, portarono alla costruzione della nuova canonica di Porto in un vasto terreno vuoto prospiciente la «Platea Maior» nel quadrante sud-est della cinta. Nonostante le molte vicissitudini e i ripetuti restauri, il chiostro restante e il fronte del giardino con la loggia restano per grandezza e qualità la migliore architettura veneziana a Ravenna, anche a confronto con analoghi esempi lagunari. Agli antichi legami con Venezia nella figura del doge Pietro Ziani, presente a Porto intorno al 1215, si erano aggiunti nuovi privilegi e concessioni da parte della repubblica con l'insediamento di abati Veneti e il collegamento con il monastero della Carità a Venezia, pure dei canonici lateranensi. Il 29 luglio 1494 il priore Silvano Morosini pose la prima pietra. Il complesso si disponeva in due chiostri, uno trilatero del 1522, prospiciente l'attuale via di Roma, non esiste più ed è stato smontato e rimontato nel piccolo chiostro della Classense adiacente alla chiesa di San Romualdo e nel portico di casa Oriani; quest'ultimo presenta una serie di colonne con capitelli corinzi, tipicamente lombardeschi. L'unico rimasto in situ era il principale, organizzato in due ordini di loggiati di uguale luce, con pilastri modanati al piano terra e colonne al primo piano, quattro eleganti balconi in corrispondenza delle due arcate centrali a richiamare il motivo della bifora, con piccole finestre aperte nella muratura piena del secondo piano: un modello probabile per la casa Diedi. Se si presta fede alla data 1502, che vi si legge, esso fu costruito subito prima della facciata verso il giardino, compartita secondo la tradizione veneziana della casa fondaco con portico centrale e torricelle laterali (si pensi a Ca' Pesaro, poi fondaco dei Turchi), ma anche della villa veneta quattrocentesca (villa Colleoni, a Thiene). I timpani dei corpi laterali recano ciascuno una data scolpita nelle torricelle, simbolo dell'abbazia, 1503 e 1518. I documenti di Porto, pubblicati dal Bernicoli, fanno il nome di Giovanni Buora con la fornitura di «pietre vive lavorate». Il tagliapietra campionese era attivo a Venezia fin dal 1480 come fornitore dei capitelli nelle fabbriche codussiane di San Michele e di San Zaccaria e anche nel cantiere lombardesco della Scuola di San Marco, prima di intraprendere come architetto in proprio il dormitorio e il chiostro degli Allori a San Giorgio Maggiore, costruito dal figlio Andrea. Capitelli, colonne, cornici possono essere stati lavorati a Venezia e poi trasportati via mare, secondo un sistema di prefabbricazione usuale; ma resta il dubbio circa il progetto. Il motivo d'angolo del primo ordine del chiostro con le arcate chiuse da conci di pietra d'Istria fa pensare a un'opera di rinforzo analoga a quella eseguita quasi un secolo dopo da Antonio da Ponte nel portico del Palazzo Ducale, mentre gli oculi che si aprono negli archi sono aperture di alleggerimento che si riscontrano nella facciata del dormitorio di San Giorgio. Anche il motivo delle bifore con balconi al centro del secondo ordine può essere confrontato con il chiostro di San Zaccaria a Venezia, iniziato nel 1510, mentre i balconi dei corpi laterali nel prospetto del giardino richiamano il chiostro degli Allori. Invece la duplice loggia del giardino fa pensare a una cultura architettonica raffinata da influssi urbinati nelle proporzioni complessive, racchiuse da lesene corinzie sovrapposte e dal fregio, come in quelle di archi e colonne, dove la luce dei primi è uguale all'altezza delle seconde. Se poi si rapporta la base con l'altezza del rettangolo, che la loggetta marmorea disegna sulla facciata di mattoni a vista, si ottiene il numero aureo; il che induce a pensare all'intervento di un architetto colto, o almeno guidato da un dotto al corrente delle raffinate ricerche di Luca Pacioli. _____________________ C. Grigioni, Bernardino Guiritì da Ravenna architetto del rinascimento, RAS, vili, sett.-dic. 1988, pp. 67-82. Id., Documenti su Porto, FR, xi (1913), pp. 440-445.
Gaetano Savini lesse su un capitello del secondo piano del fronte a sud del chiostro le iniziali «A.L.S.» che interpretò come Antonio Lombardo Solari. Antonio, figlio di Pietro, lasciò la bottega paterna alla fine del Quattrocento per lavorare a Ferrara e forse a Ravenna, e morì intorno al 1515. Non è quindi da escludere che sia lui che il Buora abbiano preso parte alla costruzione di Porto, continuando la tradizione di collaborazione iniziata a Venezia. Ma i documenti di Porto non registrano Antonio fra i molti tagliapietra lombardi, e invece Giovanni Buora dal 21 novembre 1505 spicca con i pagamenti di gran lunga maggiori rispetto ai colleghi, probabilmente per i pilastri del primo ordine del chiostro grande. Poi il 28 luglio 1508 arrivano dal mare le otto colonne «per la loza del giardino». Le balaustre della loggia superiore furono rifatte nel 1904 dando spunto alla polemica del Savini contro il Ricci. Il secondo aveva scelto le «fuseruole», ma il primo aveva raccolto testimonianze orali che vi erano colonnette e la scoperta di un frammento di esse a lavori compiuti sarebbe la dimostrazione della sua tesi; anche se le colonnette appartengono all'architettura gotica veneziana, continuarono ad essere usate anche dal Codussi (per esempio a palazzo, Loredan Vendramin Calergi) in alternativa ai balaustri a «fuseruola» di gusto più moderno (per esempio palazzo Lando, Corner, Spinelli, pure del Codussi). C'è quindi da pensare che il Savini avesse ragione. Solo nel 1520 sono approntate le colonne del secondo ordine del chiostro nuovo. Un importante edificio, scomparso alla fine dell'Ottocento, quando avvenne la trasformazione in caserma, era la torre dell'orologio. Un acquarello di Romolo Liverani ce la rappresenta di base quadrata con lesene e cornici in pietra d'Istria che disegnano ordini sovrapposti; era quasi una ricostruzione della Torre dei Venti ateniese secondo la descrizione di Vitruvio che viene a comprovare la declinazione colta, vitruviana e albertiana del cantiere portuense. Verso l'orto, di seguito alla loggetta era invece una piccola torre, forse avanzo di quella di Pietro Duca del xii secolo. Nei Diarii di Marin Sanudo si legge la notizia della morte di Giorgio Spavento, «protho» di San Marco, a Ravenna il 17 aprile 1509. L'autore del fondaco dei Tedeschi e di San Salvador (legata all'abbazia di San Giovanni che era obbligata a contribuire alla sua costruzione), stava compiendo a Rialto il sogno umanistico di Venezia «nuova Costantinopoli», ma purtroppo non sappiamo per quale ragione qui si trovasse alla vigilia della perdita della città. Si potrebbe pensare ad opere di difesa, ma lo Spavento ci è noto solamente per le sue «architetture di pace», né vi è notizia di rinforzi alla rocca e alle mura all'avanzare dell'offensiva papale.Documentata è invece l'attività a Porto di un «Tomaso lombardo» nel 1494 identificabile con Tommaso Fiamberti - campionese, ma proveniente da Venezia e dimorante a Ravenna dal 1498 -, forse autore del protiro di San Nicolò (1502-1508) e del sepolcro di Luffo Numai (1509) a San Francesco. Il protiro, che dal 1918 si trova nella facciata di Sant'Agata, è comunque di qualità ben diversa dalla loggetta, nell'esile rapporto fra colonne ed arco, nell'approssimativo disegno della ghiera, che accenna una baccellatura e che si raccorda con una chiave a mensola alla cornice sommitale, pure sorretta da due volute sulle lesene laterali di pietra d'Istria. La campagna La rinascita economica e civile che documenti e case testimoniano si basava sulla bonifica dei terreni incolti e paludosi «avarissimi e squallidi [...] e ingombrati da bronchi e spine», come li descrive lo Spreti, oppure nel disboscamento e nella trasformazione «in fertili campi» di quelli che erano diventati «nidi di fiere». La penetrazione della proprietà veneziana in tutto il territorio ravennate si concentra soprattutto nei terreni incolti o da migliorare della bassa: verso le valli di Savarna (Vinciguerra Zorzi, Morosini e Querini), a ovest intorno a Santerno e a Piangipane, a sud nel territorio di Pisignano, e lungo il Dismano (dove Leonardo Grimani nel 1464 acquista 90 tornature) fino a lambire il bosco Standiano, e permane anche oltre la fine della dominazione veneta. Ciò si accompagna all'introduzione di colture: come la canapa, le cui regole di coltivazione e trattamento per il rifornimento alle corderie dell'arsenale di Venezia sono fissate l'8 novembre 1468 a cura di Pietro Piemontese, e il guado, necessario alle tintorie veneziane, i cui capitoli per la coltivazione sono fissati nel 1473. Addirittura la repubblica deve frenare l'impresa bonificatoria del ferrarese Girolamo Roverella, revocandogli la concessione delle terre di San Pietro in Armentario perché restino paludi a difesa della rocca. _________________________________________G. Savini, Per i monumenti..., cit., pp. 27-28. M. Mazzotti, G. Ravaldini, Ravenna del passato..., cit., p. 46. Sorge però il dubbio che il Liverani abbia «abbellito» la torre e il convento di Porto per farne un fondale scenografico. C. Grigioni, Nota su l'arte e gli artisti in Ravenna, FR, xn (1913), pp. 502-503. D. Spreti, De amplitudine, eversione, et instauratione urbis Ravennae (1489), trad. it. di C. Spreti, voi. i, Ravenna 1793, p. 168. Fantuzzi, iv, p. 474, n. CLXIX, 23 ottobre 1495; M. Berengo, II governo veneziano a Ravenna, in Ravenna in età veneziana, cit., pp. 61-67.
Una mappa quattrocentesca, dai toponimi chiaramente veneziani disegna il territorio fra Ravenna, Cervia e il mare. Una nave indica ambiguamente il porto Candiano nel braccio che si dirige verso una porta: quella di San Lorenzo (probabilmente), che però sappiamo chiusa. La chiesa è chiaramente disegnata fuori della porta, ma non è indicato nessun percorso dalla città a un grande ponte di pietra «Candianus», perché costruito sull'asta principale del porto canale che scorre oltre Classe; della via Romana non vi è traccia, anche se il ponte le appartiene e ne segna il percorso dietro a San Lorenzo e a Sant'Apollinare. Si tratta forse del «Ponte Nuovo», citato nel contratto di affitto delle saline polentane dove si parla di un «canalis magnus Candiani», che divide le acque dolci dalle salate, di un canale verso Ravenna e un «canale vetus». Dal ponte inizia lo «stradello» che lascia la pineta sulla sinistra per piegare a monte e congiungersi all'altezza del Savio con la «carraia Ravignana», che uscendo da Porta Sisi, oltrepassa il fiume con un ponte di legno per poi rivolgersi decisamente a sud-ovest, verso Castiglione e Cesena. Stranamente, oltre il Savio lo stradello riprende più a valle per dirigersi verso Cervia, fra la pineta e le valli. Nonostante i dubbi che questo documento propone, si può ipotizzare che lo stradello rappresenti la Romea alla quale, intorno al 1450 Leon Battista Alberti probabilmente alluse, scrivendo che «Una strada, che attraversa la pineta di Ravenna, e che un tempo era molto rovinata, ora che è stata allargata col taglio di alberi e resa soleggiata, è divenuta comodissima» (De re aedificatoria, x, 10). Né è da stupirsi che l'umanista l'avesse percorsa in un sopralluogo fra il 1449 e il 1450 per la spogliazione dei marmi classensi, trasportati di notte su questa via, su oltre cento carri. La città d'arte Instauratio è anche riscoperta e riuso di antichi monumenti, come la statua di Ercole Orario, trasportata da Girolamo Donà (1493-1494) nel mezzo di piazza Maggiore. Il «conchincollo», come lo chiamava il popolo ravennate, reggeva una meridiana solare che di notte poteva diventare lunare; ad esso si attribuivano poteri magici, tanto che Pietro Lombardo lo raffigura nel basamento delle colonne della piazza come segno zodiacale dell'Acquario. Così nel foro veneziano l'orologio solare antico si confrontava con il nuovo orologio meccanico. L'Ercole fu descritto e rappresentato da Gabriele Simeoni, prima che cadesse nel terremoto del 1591. Ravenna antica è per il Rinascimento veneto città d'arte e fonte di ispirazione, seconda sola a Roma, con Verona e Pola. Fra Giocondo nella stesura definitiva della sua silloge epigrafica (1506 circa) raccoglie e riproduce iscrizioni pagane e cristiane, viste probabilmente di persona, Giuliano da Sangallo studia il Mausoleo di Teoderico, Giovanni Bellini descrive i campanili nella Trasfigurazione di Napoli (1490 circa). Dopo la fine della dominazione della repubblica, Alvise Cornaro e Giovanni Maria Falconetto vi sostano in viaggio per Roma. Per il pittore-architetto veronese Ravenna è già una città d'arte e negli affreschi dei Mesi in palazzo D'Arco a Mantova (1520-1521) dipinge la Rotonda di Teoderico, e per due volte San Vitale, dall'esterno, come tempio di Nettuno, e in spaccato, come tempio di Marte, infine Porta Aurea, che poi usa a modello di Porta Savonarola a Padova (1530). Il Cornaro poi nel primo Trattato di architettura, scritto fra il 1540 e il 1550, prende ad esempio la cupola fittile di San Vitale (che crede il tempio romano di Nettuno) per indicare ai suoi contemporanei un sistema di volta economico fatto di «vasetti voti». E forse i legami fra Alvise e Ravenna non furono solo culturali, bensì connessi alla sua passione di imprenditore agricolo e bonificatore, se è lui quel «nobil huomo Alvise Corner» contro cui la comunità di Cervia muoveva lagnanze per aver costruito una casa in una piccola pineta di sua proprietà usando le pietre della rocca cervese nel 1507. Cosa che i continui riferimenti e rimpianti della Romagna perduta nei suoi scritti di idraulica potrebbero comprovare. ___________________________________ASR, Classe, voi. 378, n. 3, 11 dicembre 1433. G. Simeoni, Illustrazione de gli epitaffi et medaglie antiche, Lione 1558, p. 80. G. Fiocco, A. Cornaro, il suo tempo e le sue opere, Vicenza 1965, pp. 61 e 155. U. Foschi, La dominazione veneta su Cervia, BER, nn. 3-4 (1981), p. 9.
Tuttlio Lombardo Monumento funebre a Guidarello Guidarelli 1520 c.a, colonna dei francesi eretta nel 1545, interno di s. Apollinare
Di Porta Aurea, oltre agli studi quotati di Giovan Battista da Sangallo, detto il Gobbo, dei primi decenni del Cinquecento, resta il bellissimo prospetto, già attribuito al Falconetto e oggi a Palladio e due schizzi parziali, quotati di Andrea Palladio. Anche lui aveva forse sostato a Ravenna, nei due viaggi a Roma del 1541 e del 1544 con Giangiorgio Trissino, autore dell'Italia liberata dai Goti e quindi «turista» d'obbligo della loro capitale. A queste visite forse risale il rilievo quotato in pianta e in alzato del mausoleo teodericiano. Probabilmente Francesco da Vicenza, priore di Porto, non si lasciò sfuggire l'occasione di chiedere all'architetto e al letterato concittadini un consiglio sull'intenzione di demolire la porta e rimontarla sulla «Platea Maior» come facciata della nuova basilica di cui stavano per riprendere i lavori52. Sta di fatto che le facciate delle chiese palladiane sono composte come porte o archi trionfali, a San Giorgio Maggiore soprattutto le edicole laterali richiamano la porta ravennate. A questa data però l'architettura ravennate si rivolge a esempi diversi da quelli veneziani. Nulla sappiamo del progetto della basilica portuense mostrato a Giulio II nel 1511 che Serafino Pasolini attribuisce al ravennate Bernardino Tavella, del quale non si ricorda nessun'altra opera. Probabilmente si trattava di una pianta schematica che può esser stata di base al progetto esecutivo di metà del Cinquecento dove forse si fissava la tipologia della croce latina con cupola, propria del secondo progetto di Bramante per San Pietro, ma anche di San Salvador a Venezia e di Santa Giustina a Padova e di San Sepolcro a Piacenza che da essa derivano. La morte dell'architetto della chiesa veneziana a Ravenna potrebbe essere un indizio, purtroppo privo di prove confortanti. La costruzione di San Salvador fu continuata e quasi compiuta da Tullio Lombardo, autore forse della chiesa abbaziale di Praglia, e pagato nel 1515 per far fare «la capella già dal argento del domo» a Ravenna. La commessa del ciborio metropolitano in sostituzione di quello d'argento, donato dall'arcivescovo Vittore e predato nel sacco del 1512, fu trovata dal Bernicoli, ma stranamente il nuovo ciborio non è descritto dalla letteratura ravennate, tanto da far dubitare che esso sia mai stato eseguito. Ciò comprova comunque la continuità del legame fra Ravenna e i Lombardo che culminerà nel Guidarello del 1525. A meno che il documento non intenda il tabernacolo di marmo greco che oggi si trova in San Carlino, dove fu trasferito nel 1751 dall'altare della Madonna del Sudore. Come scrive il Rossi, l'arcivescovo Filiasio Roverella nel 1516 ornò «...aram corporis Christi secto artificiosoque inaurato marmore eleganter...». La committenza ferrarese e la tecnica del marmo parzialmente «lumeggiato» di foglia d'oro portano a pensare che il tabernacolo sia un'opera ravennate della bottega di Tullio, precedente il Guidarello. ________________________________________Vicenza, Museo Civico, n. 31. Londra, RIBA, vol. xii, f. 12r e v. Ivi, voi. x, fol. 19. Inoltre cfr. H. Kaehler, Die Porta Aurea in Ravenna (1935), trad. it. di L. Cavalcoli, Ravenna 1959, pp. 12 ss. e 40 ss., e G. Tosi, La porta Aurea di Ravenna e un disegno di Andrea Palladio, in «Remisene Mitteilungen», 93 (1986), pp. 225-470, taw. 145-146. S. Bernicoli, Arte e artisti in Ravenna, FR, xni (1914), p. 557. 54 Rossi, pp. 684-685.
Francesco Maria Falconetto, prospetto di Porta Aurea Vicenza
Civici Musei, avanzi al museo archeologico nazionale. Pietro Lombardo base delle colonne
Il Cinquecento. La battaglia del 1512 e il sacco, che ne seguì, paiono precorrere il destino di Roma nel 1527 e durante il secolo XVI le nuove fabbriche e le sistemazioni urbane sembrano voler risarcire questo trauma. Si riparano le mura veneziane, danneggiate soprattutto nel lato sud, e il bastione di San Mama, mediante l'imposizione di un tributo straordinario alla popolazione residente.La rocca Brancaleone era in rovina non tanto per i danni della battaglia, che si era svolta dal lato opposto della città, ma per aver resistito un solo giorno, durante il sacco alle artiglierie francesi. I restauri, se ve ne furono, furono minimi e poveri. Giovan Battista e Antonio il Giovane da Sangallo e Michele Sanmicheli nel loro rapporto sulle rocche di Romagna, redatto nel 1526 per volere di Clemente VII, la descrivono in completo abbandono. Innanzitutto il terreno intorno era diventato un canneto paludoso, per cui occorreva innanzitutto scavare un canale di scolo che uscisse dalle mura per raggiungere Cenceda, poi con terra e canne fare terrapieni e innalzare il cortile interno del ridotto "di almeno l'altezza di un uomo con terra buona e asciutta". I torrioni terminavano con un tavolato di legno che andava sostituito con un solaio sorretto da volte in muratura per creare un piano sufficientemente robusto per sostenere i cannoni. Anche la merlatura, che nella cortina era fatta di gabbioni di terra, andava ricostruita in mattoni e in forma moderna "per tirare con l'artiglieria grossa". Poi bisognava ricoprire torrioni e cortina con un tetto e forse costruire un bastione di forma moderna nel muro di cinta verso est. Dopo appena tre quarti di secolo, il primo e più prestigioso edificio veneziano, simbolo del possesso della Dominante, era quindi ridotto in buona parte a rudere, tanto da essere inservibile, e gli annessi della cittadella neppure più ricordati. I lavori raccomandati dai Sangallo e dal Sanmicheli e corredati da un preventivo dettagliato dei materiali occorrenti, non furono mai eseguiti, per il precipitare degli eventi. Solo piccole riparazione furono operate forse fra il 1527 e il 1529, durante la nuova breve parentesi veneziana.I primi interventi del potere romano furono piuttosto demolitori che ricostruttivi, a cominciare dalla chiesa e dal convento di San Mama, usato da avamposto dalle truppe francesi. Si passò poi a colpire edifici veneziani da poco costruiti o restaurati, a cominciare dal leone marciano sulla colonna della piazza, fino alle abitazioni dei veneti residenti in città, coinvolti nelle attività di cospirazione filo-veneziana degli anni seguenti. Ma oltre all'impegno di cancellare quei segni della dominazione precedente che avevano innalzato qualitativamente il volto urbano e architettonico di Ravenna, i cantieri delle abbazie tardarono ad abbandonare lo stile lombardesco del secolo precedente, almeno fino alla metà del Cinquecento; in diversi casi restarono profondi contatti artistici se non con Venezia con il Veneto. ________________________________________A. da Sangallo il Giovane, M. Sanmicheli, Relazione sullo stato delle rocche di Ramaglia stesa nel 1526 per ordine di Clemente VII, a cura di L. Beltrami, Milano 1902, pp. 36-38, e cfr. F. Montevecchi, Repertorio dei castelli, rocche e torri, in Rocche e castelli di Romagna, Bologna 1970, pp. 296-307. Al Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi, il voi. VII, Architettura, contiene disegni di Antonio da Sangallo per il fosso di scolo della rocca e per i nuovi merli. A e. 43, n. 96 sono composti quattro fogli: tre con schizzi per Ravenna e uno per Ferrara. Nel primo si legge: «Paduli di Ravenna»; e poi: «Bisogniando fare sborratoro novo, si può pigliare alla rotta di Santa Caterina, overo aqua rotta de'fabri, e andare con un diritto fino al chantone della possessione di messer Pietro Pagolo da Fuligni; e lì fare un pocho di volta, e andare a canto alii salci grossi di ditta possessione; va diritta fino al ponte del fosso del veschovo, quale è in sulla strada di Santo Benedetto». Qui e là si trova scritto: «Selva della Caldana - Via San Michele - Via del Bertone -Bottaccio asciutto - Bottaccio con aqua - Canale da farsi - Via del Vescovo -Chiuse del Cardinale - Rotta di Montone - Fiume di Montone - Ravenna». Nello stesso volume a e. 34v, nn. 66 e 67, sono due fogli con schizzi di penna per le archibusiere della «rocha di Ravenna», con molti avvertimenti per la loro costruzione. In uno si legge: «Fate pigliare copia di questo, e rimandatelo per che possa fare lo modello, per che non me n'ò serbato copia». Cfr. M. Berengo, // governo veneziano a Ravenna, cit., pp. 61-67.
Falconetto porta Savonarola Padova 1530 circa con clipei ed edicole, omaggio a porta aurea. Palladio e Giangiorgio Trissino di passaggio da Ravenna verso Roma proposero di smontare la porta ormai murata e inutile per riutilizzarla nella facciata di s. Maria in Porto, ma l’acquisto da parte de canonici di Porto non avvenne e il Comune ne disperse i pezzi alla fine del cinquecento. Andrea Palladio se ne ricordò nelle sue facciate veneziane: s. Giorgio Maggiore con le edicole laterali.
Edilizia religiosa, restauri e costruzioni nuove. A Ravenna non si trattava solo di costruire, come nel caso di Classe o della chiesa di Porto, ma di restaurare le antiche basiliche che, come la rocca e come la città si erano nei secoli abbassate per subsidenza e sempre più erano invase dalle acque. Il primo caso di intervento si ebbe a Sant'Agata Maggiore già in epoca veneziana quando fra il 1476 e il 1494 il rialzamento significò una quasi riedificazione, rimaneggiando colonne e capitelli nuovi o antichi di varia provenienza Nel 1513 il convento medievale di San Mama, ridotto a rudere dagli assedianti, viene abbandonato definitivamente concedendo ai frati minori osservanti Sant'Apollinare Nuovo. Qui essi iniziano a edificare il loro convento radendo al suolo la parrocchiale di San Salvatore di cui viene rispettato solo il nartece. La parrocchia viene trasferita nella chiesa di Santa Barbara, dalla semplice architettura di cotto a una sola navata con facciata a capanna e occhio centrale contornato da una cornice in laterizio secondo una tipologia medievale, che da San Nicolò discende a Santa Maria delle Croci, prima del rifacimento barocco. Essa sorge sulla "plathea major", accanto al quadriportico di Sant'Apollinare, che venne aperto verso la strada in modo da creare un profondo sagrato. Il chiostro che si affianca alla basilica verso sud resta - anche se dimezzato - la fabbrica più importante della ricostruzione cinquecentesca che cancellò ogni resto del monastero benedettino precedente, riutilizzando invece dieci colonne antiche di marmo greco, una di granito, una di bigio, una di travertino e una di pietra d'Istria. I capitelli ionici sono rozzi e un pò ingenui nelle loro piccole volute che si presentano spesso variate. Fra il 1514 e il 1520 i frati eseguirono il restauro interno della basilica innalzando il pavimento e di conseguenza gli archi e le colonne, mantenendo fisse le pareti soprastanti decorate di mosaici. Si impose quindi il problema di ridecorare peducci ed intradossi degli archi con rosoni di terracotta e con tondi a fresco con figure di santi e di sante (ridipinti poi nel sec.XVII); ne consegue un effetto ricco e classico che ben si accorda ai mosaici. Contemporaneamente fu costruito il presbiterio con volta a crociera e la nuova abside con nervature a ombrello, mentre tutta una serie di cappelle venne aperta sul lato nord, fra cui quella delle reliquie (1540), dove si eseguì un raffinato assemblaggio di colonne e marmi preziosi raccolti nelle rovine adiacenti del palazzo di Teoderico. All'esterno la facciata assunse l'aspetto odierno con la loggia scompartita da paraste e triplici archi al centro. I capitelli ionici e i piccoli clipei marmorei fanno riferimento alla vicina loggia del giardino portuense, semplificando al minimo la sintassi e la grammatica rinascimentali, mentre la volta ad arcatelle dell'estrema campata sinistra riprende il motivo dell'abside. Nel 1515 i monaci di Classe abbandonano la loro sede originale, danneggiata dai recenti eventi bellici, e decidono la nuova fondazione intra moenia, sul luogo del monastero dedicato a San Bartolomeo "in turricula" (già in loro possesso per concessione dei Da Polenta) e dell'ospedale della Misericordia nonché della chiesa di San Lazzaro. I lavori iniziano nel 1517 con la costruzione della chiesa di San Romualdo, che inglobò quella di San Lazzaro, del campanile terminante con una guglia, demolita nel 1890, del chiostro attiguo, poi rimpicciolito dalle nuove costruzioni della manica lunga e della sacrestia. Nel 1530 già si provvedeva alla decorazione in marmo probabilmente dei
pilastri della chiesa (attribuiti da Corrado Ricci al milanese Filippo Mariani e datati al 1535 circa), ma che (secondo Gaetano Savini) apparterrebbero alla demolita chiesa di San Bartolomeo "in turricola", che si trovava però nel fronte seicentesco verso l'orto, che ingloba appunto una piccola torre. Nella ricostruzione seicentesca essi furono reimpiegati nel muro esterno su via Rondinelli; gli eleganti capitelli corinzi e i fusti scanalati, le modanature dello stilobate e dell'architrave denotano una conoscenza dell'antico non comune e probabilmente diffusa nell'ambiente lombardo dal Bramante. Il portale esterno sulla attuale via Baccarini reca la data del 1523 e ripete nei pilastri specchiati, nell'architrave sormontato da lunetta, il consueto modello lombardesco, mentre più tipicamente milanese è il disegno dei due portali che si aprivano sul chiostro - oggi al Museo Nazionale - dai raffinati intagli e dalla cimasa ornata di stemma con volute e sfere, paragonabile al gusto bramantesco di Cesare Cesariano. Essi sono stati attribuiti dal Ricci a Giovanni d'Antonio Bossi campionese, ma ora insieme a quello gemino, pure di stessa provenienza, sono dati alla bottega di Jacopo Bianchi. Essi possono risalire alla fase dei lavori iniziati nel 1536 con la costruzione del nuovo chiostro a nord della manica lunga, retto da colonne ioniche, con la cisterna al centro, su cui si affacciano il refettorio "e altri luoghi". Nel 1564 esso doveva essere funzionante quando viene visitato dal cardinale Carlo Borromeo. Già esisteva una libreria, che viene inventariata nel 1568, ma nel 1574 si fonda la Biblioteca Classense. Frattanto procedono i lavori del chiostro nuovo, dove nel 1579 viene costruito il pozzo, e completate le logge si procede ai solai del primo piano. Nell'anno successivo si completa la fabbrica del dormitorio, che corre da nord a sud, dal chiostro nuovo all'abside di San Romualdo, e il nuovo refettorio grande, disposto ortogonalmente sul lato ovest del chiostro nuovo con la parete di fondo affrescata da Luca e Francesco Longhi. La celebrazione del Concilio diocesano nel 1581 coincide con l'inaugurazione della nuova Classe. Nel 1475 l'abbazia benedettina di San Vitale fu congiunta a Santa Giustina di Padova dopo un periodo di decadenza economica e demografica. I monaci iniziarono quindi la costruzione del chiostro rinascimentale ampliando le fabbriche di origine ottoniana delle quali qualche traccia rimane nel lato sud. Alle forme pacate e semplici del chiostro della cisterna (1495) con i capitelli corinzi interpretati nei motivi lombardeschi di "thaenie" e "fusarole", si contrappongono le arcaiche colonne del portichetto di ingresso su basamento ottagonale con una fascia intermedia che segna i giunti dei fusti; quella d'angolo con i fusti lavorati a spirali e a spina di pesce rivela motivi tardomedievali contrastanti con il disegno dei capitelli compositi e con il puro disegno lombardesco del portale d'ingresso. Nei libri dell'abazia risultano pagamenti ad Agostino da Milano, a Pietro Lombardo e a Filippo Mariani, ma è difficile identificarne le opere. ____________________________________ Cfr. C. Ricci, Guida di Ravenna, cit., p. 142. Gaetano Savini (BCR, Piante panoramiche, voi. Ili, 1903, pp. 56-66) sostiene invece che lesene e capitelli appartengono alla chiesa di San Bartolomeo, ma ciò non ci pare possibile dato lo stile rinascimentale maturo. Cfr. anche P. Novara, Due capitelli presso la «manica lunga» della Biblioteca Classense di Ravenna, RAS, x, 29, maggio-agosto 1990, p. 5. Cfr. Ravenna la biblioteca Classense, a cura di M. Dezzi Bardeschi, voi. i, Bologna 1982, p. 48.
Chiostri francescani, complesso classense, refettorio con le nozze di Cana di Luca Longhi, e cantine con colonne e capitelli da basiliche di Classe
Il secondo chiostro su colonne binate, costruito da Andrea da Valle a cominciare dal 1562, si può considerare la prima architettura manierista a Ravenna, nella sua ispirazione a Serlio, a Giulio Romano, a Giovan Battista Bertani, e ad Andrea Palladio. Dal Prato di Palazzo a Mantova il motivo bramantesco e poi serliano di trabeazione-arco-trabeazione passa alla basilica di Vicenza, e nel chiostro degli allori a San Giorgio Maggiore a Venezia, pure legato a Santa Giustina. Andrea da Valle (1500 circa-1580), che ne è il proto, giunge a Padova dall'Istria e succede a Falconetto nel completamento delle fabbriche di Alvise Cornaro, consulente architettonico dei Benedettini. Dal mantovano Bertani probabilmente riprende il motivo della serliana continua da lui usata nel Prato di Palazzo dei Gonzaga intorno al 1549 e per la prima volta impiegata in un edificio monastico. Da Valle appare legato al Palladio da un reciproco scambio di motivi e invenzioni, che in tono minore qualitativamente determinano il volto cinquecentesco di Padova. Nel 1565 Palladio figura pagato dai monaci di San Vitale per un disegno che non sappiamo se sia relativo al chiostro. Ma in questo caso Andrea da Valle a Ravenna precede Palladio a Venezia di vent'anni, anche se i particolari denunciano una esecuzione approssimativa di maestranze lombarde e locali su disegni e saltuarie visite del proto istriano-padovano. I capitelli compositi lombardeschi ne sono testimoni, sebbene la soluzione d'angolo denunci una logica propria di un architetto esperto. Le finestre soprastanti si collocano all'interno della semplice orditura di tre fasce continue di pietra d' Istria, abbinandosi in corrispondenza delle colonne in maniera da creare un pieno sopra il vuoto dell'arco. Questa insolita alternanza basta a rendere il progetto di Andrea, del chiostro nuovo, del dormitorio e del monastero, una delle architetture più significative a Ravenna. I lavori procedettero anche dopo la morte del Da Valle nel 1580 con il chiostro dell'orto, intenzionalmente aperto su un lato, fino al 1589. Tanto che Antonio Soratini nel 1745 si limiterà solo a modifiche nella costruzione del dormitorio nuovo verso il mausoleo di Galla Placidia. Lavori di restauro e di abbellimento interessarono pure la basilica. Innanzitutto il portale lombardesco a semiluna dell'ingresso sud, il rifacimento degli affreschi medievali della cupola ad opera dei faentini Giacomo Bertucci e Giulio Tonduzzi (1541-43) e forse le bifore delle finestre, già presenti intorno al 1520 secondo le testimonianze di Antonio da Sangallo il giovane e Antonio Maria Falconetto, e rimosse nel restauro di Corrado Ricci ai primi di questo secolo. Infine alla base dell'intradosso dell'arcone del presbiterio furono sistemati i rilievi romani del trono di Nettuno inquadrati dalle colonne dell'antico ciborio e retti da rozzi putti, pallide imitazioni di quelli di Agostino di Duccio nel Tempio Malatestiano, mentre elegantissimi sono i clipei che replicano quelli di Porta Aurea. ___________________________________________________S. Serlio, Regole generali di architettura..., Venezia 1537, c. xiiiv. e c. xxiir. C. Ricci, Andrea da Valle a Ravenna, Padova 1909. Inoltre A. Venturi, Storia dell'arte italiana, voi. xi, Milano 1940, pp. 88 ss. e M. Zorzi, I chiostri del monastero di San Vitale a Ravenna, RAS, x, 30, settembre-dicembre 1990, pp. 39-52.
Il cantiere della canonica di Porto si compie, per quanto riguarda il monastero, nel 1525 con il chiostro trilatero, demolito nel 1885, all'esterno del quale stava il portale, oggi murato all'esterno della sacrestia verso i giardini pubblici. Il disegno classico delle colonne corinzie che reggono la trabeazione, sormontata dal simbolo di Porto fra volute, inducono a considerarlo appartenente al compimento dei lavori. Solo nel 1545, dopo la visita di Paolo III alla canonica nel 1541, si ha notizia che il priore Vitale Mercati raccoglieva mattoni e marmi per la costruzione della basilica, ma non si sa se ancora si pensasse di costruirla secondo il progetto mostrato a Giulio II nel 1511. Certo la posizione e l'orientamento erano fissati e coincidenti con quelli della realizzazione, se i canonici aprirono e lastricarono lo stesso anno la via Cerchio acquistando case e terreni da un certo Andrea Cluzzo, di modo che la futura facciata, arretrata e quindi invisibile dalla "platea major", avesse nel fronte un conveniente, anche se esiguo, canocchiale prospettico. Il 13 settembre 1553 viene posta la prima pietra e Giulio III rinnova la concessione di Giulio II ai canonici di utilizzare i mattoni e i marmi della chiesa e della canonica di San Lorenzo in Cesarea. Essa fu completamente demolita, ma solo i mattoni e due colonne trovarono impiego nella nuova costruzione, perché il legato Gerolamo Capo di Ferro si appropriò dei marmi e di, pare, trenta colonne, che inviò a Roma . Giustamente il Ricci ritiene inammissibile che lo spazio interno "di grandiosità palladiana" possa risalire al progetto del primo decennio del Cinquecento di un certo Bernardino Tavella ravennate. Un maestro Antonio Maria "architecto", risulta invece largamente pagato "a buon conto della fabbrica" nel 1554, e nel dicembre del 1557, dopo la sua morte, il figlio Francesco riceve una cospicua somma "per la chiesa già fatta" . Non è da escludere qualche suggerimento diretto di Andrea Palladio per il passaggio dell'architetto da o per Roma insieme con Giangiorgio Trissino nell'estate del 1541 e nel settembre del 1545 e poi con Daniele Barbaro, fra il 1553 e il 1554. La prima venuta coincide con il progetto del priore Francesco da Vicenza di far smontare porta Aurea completamente dalle fondazioni << a tutte sue spese, con peritissimi ed ingegnosissimi marmorarii, e con ogni diligentissima diligenza, e arte>> per ricostruirla <<gloriosamente>> <<ivi nanti quel vacuo dov'ha da essere col tempo, e in breve edificata una magnifica chiesa (...) nel proprio, e medesimo modo, e ordine, che al presente si è trovato, e anche se possibil (...), con qualche gionta migliore>>. La richiesta al Consiglio cittadino del 25 novembre 1540 fu accolta in quanto coincideva in parte con un precedente progetto dello stesso Consiglio del 28 settembre 1522 , ma a condizione dell'assenso di Roma o del Legato, e a patto <<che se per caso nel detto luogo , e cavamenti che si faranno, vi si trovassero statue, lamine e altre cose degne d'argento, oro e altri metalli, o marmi, tutte, e ciascuna di quelle siano della Comunità>>. Ma avversari di questo progetto ricorsero subito a Roma riferendo che la parte era stata presa dal Consiglio dei Trentotto, istituito l'anno precedente per decidere su cose minori, e non da quello dei Cento nobili competente per le maggiori, cosa che poi risultò falsa, e descrivendo la porta come ancora funzionale alla vita della città. Perciò il 18 dicembre Roma ingiunse al vicario dell'arcivescovo di proibire il trasporto. Poi, chiaritesi le cose, il decano della Camera Apostolica il 2 aprile 1541 invitò il vicario a dare una <<diligente informazione>> nella sede romana <<per potere più maturamente procedere in questo affare>>. La vicenda si concluse con un nulla di fatto, ma si possono fare alcune considerazioni: il progetto della Comunità del 1522 segue di poco la visita a Ravenna di Giovan Maria Falconetto e di Alvise Cornaro, di cui abbiamo già scritto nel capitolo precedente, e che il primo passaggio palladiano nella estate del 1541 cade in coincidenza con il dibattito sulle intenzioni del priore Francesco da Vicenza, conterraneo del Trissino. ___________________________ Pasolini, Lustri, p. iv, 1. 12°, p. 68. P. Uccellini, Dizionario storico, cit., ad vocem Capodiferro, e C. Giovannini, G. Ricci, Ravenna, Roma-Bari 1985, p. 114. C. Ricci, Guida..., cit., p. 131. S. Bernicoli, Arte e artisti in Ravenna, FR, xi (1913), p. 446. ASCR, Parti, B, xxix, e. 270r. ASCR, Parti, A, xxvin, e. 244v. A. Zirardini, Degli antichi edifici profani di Ravenna..., Faenza 1762, pp. 235-237; C. Ricci, Raccolte artistiche di Ravenna, Bergamo 1905, p. 32; G. Savini, Per i monumenti..., cit., p. 54; H. Kaehler, La fon'Aurea di Ravenna, trad. it. di L. Cavalcoli, Ravenna 1959, pp. 6-7; C. Giovannini, G. Ricci, Ravenna, cit., pp. 113 e 132; G. Tosi, Laporta aurea di Ravenna e un disegno di Andrea Palladio, in «Roemische Mitteilungen», 93 (1986), pp. 425-470, taw. 145-146.
Sarebbe lecito supporre un parere sulla nuova basilica, sulla sua collocazione urbanistica di cui doveva essere fulcro la ricostruzione di porta Aurea, aperta, ma quasi inutile in quella posizione, e semi interrata, nella futura facciata della nuova chiesa o meglio come "glorioso" ingresso al sagrato. Ciò rivelerebbe la volontà di intendere la porta come emblema pubblico di tutto il complesso portuense e fulcro urbano della "plathea major" segnato dalla nuova strada perpendicolare di raccordo con via Cerchio. Per quanto riguarda la tipologia d'impianto della basilica c'è da osservare che o il progetto originale fu completamente dimenticato o modificato per giungere all'attuato schema di croce latina con cupola e cappelle laterali. Però il corpo delle tre navate con cappelle si innesta con un raccordo decisamente brutto e sgrammaticato sul transetto, quasi che gli altari siano stati introdotti in un secondo tempo. Poco comune nell'architettura cinquecentesca è il ritmo alternato di pilastri con semicolonne e colonne, i primi reggenti le volte a vela della navata principale con capitelli corinzi, le seconde di ordine minore, con capitelli toscani reggono il fregio sopra gli archi; ma la loro entasi appare eccessiva rispetto alle regole classiche. In realtà piuttosto che al Palladio questo schema interno sembra rifarsi al duomo di Faenza, eretto a iniziare dal 1474 su disegno di Giuliano da Maiano, di cui Santa Maria in Porto sarebbe una discendenza piuttosto rara. Il corpo del transetto e del presbiterio con le tre absidi e al centro la cupola potrebbe venire da un'idea precedente, basata sull'imitazione del concetto bramantesco per San Pietro, poi modificata e congiunta malamente al corpo longitudinale. Piuttosto rara è la cupola ottagonale in forma esterna di doppio tiburio sovrapposto con cornice in laterizio che separa due ordini di finestre: le inferiori aperte, le superiori accecate per coprire la cupola interna. Sappiamo che la calotta bruciò nel 1685 e che essa era rivestita in piombo. Ciò però non basta per concludere che tutta la parte muraria sia stata rifatta dopo l'incendio e per ovvie ragioni non si poteva prescindere dall'impostazione originaria. Si potrebbe pensare quindi che l'involucro esterno "a torre" sia tardo cinquecentesco, almeno per quanto riguarda il primo ordine, vicino a modi centroitaliani, ripresi poi da Ascanio Vittozzi nella cupola dei Capuccini a Torino (post 1583). Probabilmente il secondo ordine fu sovrapposto per coprire la calotta interna in maniera economica con un tetto di tegole e una lanterna. Le specchiature delle murature su tutte le facce rimandano a soluzioni costruttive del manierismo. La rappresentazione della cupola in uno stucco del Martinetti nella chiesa del Suffragio risale ai primi decenni del Settecento e rappresenta i due ordini e una calotta a spicchi diversa dalla soluzione con tegole. Forse un progetto non realizzato per ragioni economiche, oppure la situazione precedente all'incendio. I lavori di costruzione avanzarono celermente fino alla copertura del tetto nel 1561, poi rallentarono; il 19 giugno 1570 i canonici stipularono una convenzione con il maestro Pier Antonio di Giovanni Ceroneta da Canobbio, abitante a Faenza, per completare l'opera muraria, il che avvenne nel 1593; solo nel 1587 fu consacrato l'altare maggiore e nel 1606 la chiesa. Marino francese intaglia gli stalli del coro fra il 1576 e il 1593 seguendo il modello del normanno Riccardo II Taurigny a Santa Giustina a Padova (1558-1566) . Non è improbabile una parentela di Marino con i Taurigny di Rouen; cognati di Riccardo furono Battista, Paolo e Francesco Marchesi, carpentieri di fiducia di Andrea Palladio nel ponte di Bassano e nella cupola del duomo di Vicenza. ______________________________Pasolini, Lustri, p. vi, 1. 16", p. 171. S. Bernicoli, Arte e artisti..., cit., ivi. S. Muratori, // martirio di San Vitale del Barocci: notizie, documenti, aneddoti, FR, vi (1912), p. 245; C. Grigioni, Un secolo di opere d'arte nella chiesa di Santa Maria del Monte presso Cesena, in «Rassegna Bibliografica dell'Arte Italiana», 17 (1914), p.56.
Dopo i restauri del 1470, nella basilica di San Giovanni Evangelista dei canonici agostiniani di San Salvatore, una delle poche opere certe dell'architetto ravennate Bernardino Guiritti, il Cinquecento portò a un drastico restauro. Dapprima si costuì l'unica cappella della navata destra - distrutta dai bombardamenti del 1944 - : essa si presentava con due colonne di marmo greco che reggevano la trabeazione e il timpano per inquadrare il portale disegnato nel 1524. Poi nel 1568 si procedette all'innalzamento delle colonne e degli archi con il taglio del muro soprastante, alla distruzione dell'abside con i mosaici e della cripta. Poco si sa delle decorazioni cinquecentesche perchè esse furono poi coperte da nuovi stucchi nel 1747. A sud l'agostiniano Giovanni Heredi costruì il chiostro con archi su colonne, iniziato nel 1580 e terminato nel 1614. Al centro il tagliapietra veneziano Alessandro Corsi (di cui abbiamo notizie fra il 1577 e il 1600, nei cantieri di San Vitale e di Classe) costruì il pozzale utilizzando quattro colonne antiche in una composizione ricca ed elegante culminante in due obelischi secondo lo stile del Vittoria. Nel 1543 anche la basilica dello Spirito Santo era stata sottoposta ad un analogo innalzamento del pavimento, delle colonne e degli archi per iniziativa dell'abate Corrado Grassi. All'esterno fu ricostruito il semplice loggiato su colonne tuscaniche. Pure la basilica di San Francesco ebbe il pavimento rialzato in questo secolo, ma probabilmente le colonne e gli archi furono innalzati durante i pesanti lavori di restauro del 1793. Le due cappelle che si aprono nella navata destra sono fra i più importanti esempi dell'architettura lombardesca del Cinquecento in città. Il portale della prima fra due colonne di marmo greco che poggiano su stilobati di pietra d'Istria è attribuito alla bottega di Tullio Lombardo e datato intorno al 1525 perchè all'interno conteneva il sepolcro di Guidarello. Semicolonne ornano pure l'intradosso dell'arco e gli angoli del vano interno dove sorreggono una trabeazione. Nella terza cappella è stata ricostruita l'architettura con cupola su pennacchi della cappella Dal Corno, durante i restauri del 1921, con il portale coronato da frontone, eseguito nel 1532 da Bernardino Saluteri da Como su disegno del milanese Filippo Mariani. Mura, porte e strade. L'innalzamento dei pavimenti delle chiese, che poi si è continuato a fare fino ad oggi, indica l'abbassamento dei monumenti più antichi, ma anche di tutta la città in generale. Abbassamento reso tanto più pericoloso dal laccio dei fiumi e dalle loro ricorrenti piene. Le riparazioni delle mura sono accompagnate dall'arginatura dei fiumi, ma ciò non basta. E fin dal 1518 ha inizio la lite sui mulini fra la comunità e l'arcivescovo, proprietario del mulino del Montone, nel quale fu vista la causa delle calamità più temute e frequenti. Nel 1522 fu riaperta la porta Aurea, parzialmente interrata e il comune pensò di recuperare tutto il settore della vecchia regione Ercolana promuovendovi nuove costruzioni. Progetto che rimase senza seguito, come quello dei canonici di Porto, di cui già abbiamo scritto, di smontarla e di trasferirla nella facciata della loro basilica, tanto che nel 1582 la porta fu demolita per ordine del legato Guido Ferreri e i materiali in parte impiegati per la costruzione di porta Aurea nuova (Adriana). Perciò fino al secolo scorso questa zona è stata occupata dagli orti del monastero di Sant'Andrea e ha conservato un carattere suburbano. ________________________________ C. Grigioni, Bernadino Guiritti da Ravenna..., cit., pp. 62-87. C. Ricci, Guida..., cit., p. 162. Pasolini, Lustri, p. iv, 1. 12°, p. 21.
Ripetutamente durante il Cinquecento si pose il problema dell'aggiornamento delle mura secondo i nuovi principi dell'ingegneria militare. Nel 1563 il perugino Ascanio della Cornia - (1516-1572) ingegnere militare allievo e amico di Galeazzo Alessi e incaricato con lui di rivedere le fortificaziomi di Roma per conto di Pio IV nel 1560 - presentò un progetto di fortificazioni a baluardo che non fu realizzato, se non in coincidenza di porta San Mama, nei pressi del bastione medievale di Federico II, e forse in maniera molto rudimentale dietro via Zagarelli alle mura. Dopo la costruzione delle nuove porte Adriana e Giulia il legato Canani ordinò nel 1585 l'atterramento di case e capanne <<dei poveri>> nel sobborgo della Sabbionara forse con l'intenzione di creare un guasto per fortificare il tratto di mura nord, che in effetti in corrisponenza della Madonna delle Mura presenta un un rudimentale scarto ad angolo molto ottuso della cinta e un altro nei pressi dell'antica porta Anastasia. Questi, ben visibili nelle piante del Coronelli, e poi nel Francia e nel Savini, si possono considerare gli unici baluardi di tipo moderno a Ravenna. Nei fatti, la questione dei mulini e il progetto del 1561, cui si era dato inizio per divertire il Montone e immetterlo in un nuovo alveo che con il Ronco andasse più speditamente al mare, era probabilmente legata anche a progetti di ammodernamento delle mura e di creazione di un nuovo ed efficiente porto nel vecchio corso fluviale; ma nulla fu fatto per gli interessi dei privati e dell'arcivescovo, proprietari dei mulini. Né il governo romano diede ascolto al vicelegato e presidente di Romagna Giovan Pietro Ghislieri che scriveva a Gregorio XIII intorno al 1580: "Sarebbe forse cosa utilissima il continuovare la fortificazione di Ravenna, la quale è quasi frontiera e antemurale alli stati della Santità vostra et per essere città posta in piano, in sito acquoso et abundantissimo, si farebbe fortezza inespugnabile". In realtà per Roma Ravenna non aveva un valore strategico, come per i Veneziani, e anche una sua ipotetica funzione di confine dello stato pontificio doveva venire a cadere due decenni più tardi con la devoluzione di Ferrara. Dal punto di vista urbanistico le porte diventano i fatti monumentali salienti del Cinquecento. Nel 1568 fu costruita porta Sisi con il portale inquadrato da due colonne di granito grigio con capitelli toscani che sorreggono un potente fregio coronato da un timpano. Una semplice ed elegante edicola, priva di complicazioni manieriste, vicina al classicismo compassato del Vignola. Nel 1578 il presidente Ghislieri decise di costruire la porta Nuova con il nome di Gregoriana in occasione della sistemazione della strada Romana verso il Savio. Essa venne a sostituire l'antica porta di San Lorenzo per allinearsi scenograficamente con la plathea major e in quella occasione si costruì un ponte di legno sul Ronco. La porta dovette essere decorata con pietre e marmi, ma il rifacimento seicentesco pone dubbi sull'aspetto originale, anche se probabilmente le colonne corinzie e la trabeazione appartengono a questo ultimo. Essa si inserisce nel più importante evento urbanistico di questo secolo: la costruzione della basilica di Porto dà nuovo carattere monumentale a tutto il Corso, da cui si irradia il nuovo asse prospettico di via Cerchio, di cui abbiamo già scritto, mentre fra il 1582 e il 1584 essa viene prolungata dall'innesto della veneziana via Giustinian (oggi Diaz) fino alla nuova porta Serrata. La costruzione del rettifilo da nord a sud di via di Roma, comportò l'abbattimento di numerosi edifici che si trovavano sul suo tracciato, fra cui il convento delle monache intitolato a San Giovanni Evangelista, detto San Giovannino, che da soli tre anni si erano lì trasferite, e che si dovettero stabilire in una nuova sede allineata sul lato della strada. Ciò nonostante il nuovo tratto dovette tenere una larghezza inferiore a quello sud, un andamento meno rettilineo, e anche oggi riveste un carattere meno monumentale e più dimesso. __________________________________ Pasolini, Lustri, p. iv, I. 13°, p. 12 e Rossi, p. 737. Pasolini, Lustri, p. iv, 1. 13°, p. 87. Cit. in L. Dal Pane, La Romagna nei secoli XVI e XVII in alcune descrizioni del tempo, Bagnacavallo 1932, p. 48.
Complementare a questo intervento è la costruzione della porta Giulia nel 1584, nei pressi della antica porta Serrata, reimpiegando parzialmente i materiali della demolita porta Aurea. Lo spostamento avvenne per allinearla sulll'asse della plathea major. Anche in questo caso è difficile ricostruire l'aspetto originale, dal momento che fu poi parzialmente ricostruita e adornata nel Seicento. Il portale rustico di massi di pietra d'Istria, cui si affiancano le colonne pure rustiche, potrebbe essere originale e ispirato ai trattati del Serlio nonché alle porte veronesi del Sanmicheli. All'interno era un edificio di tipo complesso, con una sala sovrapposta al fornice di ingresso che crollò durante un banchetto nel 1621. Nel 1583 fu pure costruita porta Adriana ripetendo lo schema delle colonne toscane su piedistalli reggenti la trabeazione; ma per la sua funzione di porta di Lombardia, le sue dimensioni sono maggiori di quella Sisi e soprattutto i clipei e gli ornamenti tolti a porta Aurea la rendevano particolarmente monumentale, con l'intenzione di risarcire la città della distruzione della porta romana, considerata inutile per la posizione e per lo sprofondamento. I torrioni circolari con beccatelli la inquadravano quasi a suggerire il ricordo delle torri della porta romana. Forse a seguito della visita di Paolo III nel 1541 si avviò una serie di opere urbanistiche di una certa importanza. Si costruirono ponti, probabilmente di legno, sul Ronco di fronte a porta Sisi e sul Montone di fronte a porta Adriana e si procedette a una lastricatura di strade e piazze, sostituendo probabilmente quella veneziana di mattoni pesti. Ma nel 1568 il bradisismo negativo della città rese necessario sopraelevare e lastricare con pietre romane le strade di porta Sisi (via Mazzini) e di porta Adriana (via Cavour). Incerti e mal definiti sono gli interventi di restauro nel palazzo vecchio del Comune, dopo i gravi danni recati dal sacco francese. Mentre il palazzo nuovo con il suo loggiato andò contraendosi per lasciar posto al palazzo legatizio. Esso utilizzò dapprima gli edifici della podestaria veneziana che sul retro si aprivano sul cortile della cisterna e sul giardino con una loggia. Fu restaurato nel 1544, poi ampliato nel 1557 dal legato Cesi a scapito forse della chiesa di Sant'Agata in Mercato, di alcune case veneziane, e del palazzo nuovo, fu poi restaurato ancora da Dionisio Ratta nel 1577. Forse a metà del Cinquecento risale l'arco Parrelli che congiunge la piazza Maggiore (oggi del Popolo) con quella degli svizzeri (oggi Garibaldi) organizzando spazialmente un vero e proprio "centro del comando" nel cuore cittadino. Il Coronelli ci dà un immagine postuma dell'assetto seicentesco del lato sud della piazza con i palazzi del vicelegato e del legato prima della ricostruzione inglobante le ultime arcate del palazzo nuovo. Intorno al 1534 i due palazzi comunali furono uniti dal voltone che scavalca la via Cairoli, ripetendo nell'arco ribassato le ghiere decorate in cotto del palazzo nuovo. Nel palazzo vecchio dalla parte retrostante, prospiciente la piazzetta XX Settembre, si ricavò nel 1543 la sede del magistrato dei Savi, che fu però completamente agibile solo nel 1555. Ancora nel 1578 si allestì la nuova sala consigliare, che però risultava del tutto insufficiente e mal ridotta nel 1601. Sia nel caso del palazzo vecchio, completamente demolito e ricostruito nel 1681, che del palazzo legatizio, quasi completamente rifatto e ingrandito nella sua forma definitiva nel 1696, è difficile stabilire il loro aspetto cinquecentesco. La distribuzione del commercio intorno alla piazza ha origini medievali che ebbero un assetto definitivo in epoca veneziana, consolidato poi durante il secolo XVI nelle vie che da essa si dipartono. Via Palserrato (oggi Cairoli) era specializzata nelle drapperie; via delle Melarance (oggi Mentana) o dei Bergamaschi è un toponimo che fa rimanda al commercio della frutta e ad attività artigianali (battirame e tessitori di saia e lana) esercitate da immigrati, come ad esempio Rubino da Bergamo stipendiato nel 1555 per introdurre quelle arti. Su piazza della Legna, del Vino o delle Granelle (poi dell'Aquila) confluiva la via delle Calzolarie (oggi Matteotti), mentre la via delle Beccherie (oggi IV Novembre) collegava piazza Maggiore con la pescheria della Casa Matha. Nel 1550 il Consiglio decide di riunire i poveri in una contrada, detta poi delle Stuore (oggi Pasolini), dove questi si guadagnavano la vita fabbricandole con la canna delle valli. _____________________________________Pasolini, Lustri, p. iv, 1. 12", p. 77 e p. 92.
Non si sa bene in che siano consistiti gli abbellimenti che il cardinale Pier Donato Cesi attuò nel 1558 nella piazza Maggiore in occasione dei lavori del palazzo legatizio. E' invece interessante l'uso del pilastro quadrato sormontato da un massiccio capitello ionico nel cippo marmoreo che il Cesi fece innalzare sul luogo dove per tradizione si credeva morto Gastone de Foix. La colonna dei Francesi appare un'opera scultorea lombarda, datata al 1557, dove gli eleganti arabeschi a candelabro di tradizione ancora quattrocentesca si trasformano in grottesche classicheggianti, mentre il motivo del pilastro ionico, del tutto eccezionale in architettura, appare come una licenza manierista, di gusto nordico. Il terremoto del 1591 fece crollare la statua di Ercole orario, posta di fronte alla chiesa di San Sebastiano da Girolamo Donà, i cui pezzi furono smembrati e dispersi, mentre il basamento di marmo di Verona fu utilizzato poi per erigere il monumento al presidente di Romagna Bonifacio Gaetani nel 1609. Con la costruzione della chiesa di San Girolamo dei Gesuati e poi dei Gesuiti, terminata nel 1564 e distrutta nel secolo presente per la costruzione del seminario, la tipologia della chiesa controriformista, a una sola navata con altari laterali, fa il suo ingresso a Ravenna. Alla fine del secolo si decise la sistemazione urbanistica della piazza del Duomo con l'erezione al centro della colonna romana di granito bigio che avrebbe dovuto sorreggere la statua di Clemente VIII. Ma essa fu innalzata nel 1605, e solo nel 1659 vi fu collocata la statua della Vergine, opera di Clemente Molli. Nel 1583 il monastero di San Paolo in via Mariani fu trasformato in seminario. Il piccolo chiostro interno appare cinquecentesco nella semplicità delle colonne di ordine toscano e di ordine corinzio che reggono gli archi. Edilizia privata. Nella edilizia privata il Cinquecento sembra interrompere lo stile aperto e pacifico diffuso dalla dominazione veneziana. I balconi di centro e d'angolo in pietra d'Istria, le bifore lombardesche e le decorazioni laterizie padane scompaiono senza dar luogo a facciate architettoniche di ordini sovrapposti, come in altre città italiane. Alla eleganza disarmata della palazzina Diedi si contrappongono le arcigne case-fortezza dei Rasponi in città e in campagna. Nel 1541 Giovanna Rasponi ricostruisce la propria dimora fra via Corrado Ricci e via Guido da Polenta sul sito di una "domus" medievale con il balcone d'angolo sorretto da beccatelli e una torre, forse di origine medievale. Nessun ornamento ricopre i muri di mattone grigio che sorgono a scarpa dal terreno, l'architettura è assente dall'esterno e presente solo all'interno nelle sale del pianterreno dalle volte a ombrello che ripetono in ritardo modelli quattrocenteschi _______________________________________. U. Foschi, Case e famiglie della vecchia Ravenna, Ravenna 1970, pp. 11-12.
Poco resta di antico nel palazzo Balbi, poi Fantuzzi, Rasponi Murat, di origine quattrocentesca. Il corpo principale su via Guerrini appare più antico nella muratura a scarpa che è coronata da beccatelli; all'interno le volte della sala terrena presentano la struttura a ombrello del primo Cinquecento. Problematica è la datazione della casa Pignata in via Mazzini (oggi sede del Consorzio Agrario), già esistente nel 1485, ma che deve l'aspetto attuale a un'ampio rifacimento cinquecentesco, presumibilmente anteriore all'ospitalità data a Torquato Tasso nel 1560. Il semplice esterno in mattone grigio con scarpa, appena ingentilito dal portale di pietra d'Istria, rientra nella tipologia già descritta. Una piccola torre sorgeva sull'omonimo vicolo laterale. Eccezionale è la decorazione di un palazzo Rasponi distrutto nel 1581 dove un fregio in cotto rappresentante grifi correva sotto il cornicione secondo i modi padani e soprattutto ferraresi diffusi nell'edilizia civile ravennate fra quattrocento e cinquecento; trasferito in una casa Monghini in via Guaccimanni, sta ora all'esterno della Soprintendenza ai monumenti. Solo nei portali, si può dire, ci fu una piccola deroga all'architettura spoglia degli esterni. La casa Zaccaria in via Guaccimanni ne presenta uno in pietra d'Istria che si può datare all'incirca alla metà del secolo, dato lo stile di transizione dai modi lombardi a una diversa ornamentazione liberamente ispirata ai modelli classici. Ma solo con la costruzione delle nuove porte i tagliapietra attivi a Ravenna ed i loro committenti ebbero sotto mano modelli aggiornati cui ispirarsi. L'ordine rustico del portale di casa Grossi-Vignuzzi-Marini in via Mariani dimostra lo scarto avvenuto nella seconda metà del secolo con l'abbandono definitivo della tradizione lombardesca. Il timpano spezzato e il cartiglio fanno pensare a motivi decorativi manieristi a cavallo fra Cinque e Seicento. Palazzo Pompili - Ferruzzi presenta un portale con obelischi e volute di ascendenza tardo cinquecentesca, forse di derivazione ferrarese; il suo disegno raffinato nella scansione di piani appena accennati, è infatti unico nella città, come è colto il disegno di dadi con guttae che reggono i davanzali del piano terreno. La qualità dei pochi elementi architettonici che risaltano sul muro di laterizio a vista corrisponde alle proporzioni generali della facciata, che lo distinguono dalle architetture ravennati contemporanee. Oltre che alle porte civiche la cimasa fra obelischi fa pensare al pozzale di San Giovanni Evangelista che Girolamo Fabri celebrava come michelangiolesco. Il portale del palazzo Grossi che gli stava quasi di fronte ripeteva in maniera rozza il disegno di quello di San Vitale, ma anche di quello del palazzo Pompili. Ancora nella prima metà del Cinquecento si continuò il tipo della casa borghese quattrocentesca con il tetto a due falde raccordato da una più piccola al colmo in modo da creare un prospetto a capanna: un ricordo probabilmente delle coperture di paglia, conservatosi con analogie nei capanni rustici. Di questo tipo è la casa Chigi, già sede degli uffici comunali dell'Anagrafe, e lo erano la casa Graziani in via Ponte Marino, oggi distrutta, e la casa Rizzetti, ricostruita in stile Novecento, nonostante la volontà di Corrado Ricci. Più comunemente le case borghesi si collegarono in schiere lungo le strade con disposizione longitudinale - con il colmo parallelo alla strada - occupando porzioni ristrette sul fronte che poi si allungava sul retro con il cortile dove si affacciavano edifici minori sussidiari "bassocomodi". All'estensione in larghezza del lotto corrisponde quasi sempre una maggiore importanza dell'abitazione, spesso sottolineata anche dalla posizione d'angolo. Ma quasi mai nel Cinquecento si superarono i due piani, se non con un terzo di sottotetto e le cantine. Solo le case più importanti si estendevano da una parte all'altra dell'isolato, affacciandosi sulla via opposta con edifici di servizio.
Ville e castelli. Nella campagna il possedimento neo-feudale trova espressione architettonica nelle ville-castello come le distrutte torri dei Rasponi a Savarna e a Mezzano, quest'ultima (1534) in stretto rapporto con l'esempio delle delizie estensi coeve e in particolare con la torre-colombara di Girolamo da Carpi a Vergiesi di Gambulaga (1536).Notevole per mole e qualità è il palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna, iniziato da Pietro Grossi, capitano al servizio di Venezia, seguendo un proprio disegno, e terminato da mastro Giovanni di Jacopo da Canobbio intorno al 1560. Esso è il modello della villa-castello serrata da quattro grandi torri angolari; le basi murarie a scarpa trovano un corrispettivo nel coronamento aggettante con beccatelli, ma non mancano accenni còlti e civili nell'accenno a triglifi sotto i beccatelli, o nella soffitta con occhi ovali sostituita a una merlatura, o ancora nelle cornici e modanature di mattone. L'interno presenta un androne passante che distribuisce alle sale coperte di volte.Fra il 1560 e il 1570 i Raisi costruiscono il palazzo di San Michele a Godo, dove si ritrova il basamento a scarpa cordonato in pietra d'Istria alla base del muro, mentre i beccatelli negli angoli e al centro alludono al modello castellano. Asimmetrica è la disposizione delle torri nella villa Da Porto-Cavalli a Godo, con accenni a un coronamento a beccatelli.
Villa Corradini a Campiano, Palazzo Pompili via XIII giugno, Grossi a Castiglione di Ravenna, villa Lovatelli Negrotto Cambiaso con la colombara.
Il Seicento. Il fasto romano nell'architettura religiosa. La devoluzione di Ferrara, toglie a Ravenna ogni perogativa strategica all'interno dello Stato Pontificio, mentre i progetti della grande Bonificazione Maggiore inaugurano una nuova stagione di opere pubbliche volte soprattutto allo sviluppo agricolo del territorio a nord ovest della città. Nella tranquilla vita della città legatizia, che dalla fine del cinquecento vede accrescersi la popolazione, si intensificano i cantieri civili e religiosi per iniziativa dei cardinali romani: il legato Bonifacio Gaetani e l'arcivescovo Pietro Aldobrandini.Per ingraziasi il primo i Ravennati gli eressero la colonna "dell'aquila" su disegno di Francesco Longhi nella piazza Maggiore, usando il basamento dell'Ercole orario e una colonna antica di granito grigio, spostata poi nella piazza XX Settembre, detta perciò dell'aquila, nel 1673. A lui si deve una nuova escavazione del Candiano e il soffitto a lacunari dorato, di Sant'Apollinare Nuovo (1611), che fa somigliare il suo interno a quello di una basilica romana anche per il suo elegantissimo disegno. Irrealizzato, per ovvie ragioni tecniche, rimase il suo progetto di costruire sulla piazza Maggiore una fontana, come contemporaneamente avveniva in altre città romagnole (Cesena e Faenza).Il secondo divenne arcivescovo di Ravenna il 13 settembre 1604. Vi si recò in visita diverse volte, specialmente in inverno, ma solo dopo l'elezione di Paolo V Borghese, le sue fortune volsero al peggio e decise volontariamente di esiliarsi nella sua arcidiocesi dal 21 maggio 1606 per non ritornare a Roma che nel febbraio del 1610. Già nel 1606 pare decidesse di costruire una nuova cappella del Sacramento nella Metropolitana, ma solo nell'ottobre del 1612 Carlo Maderno è pagato per la "Cappella che di nuovo si fabrica nel Duomo di Ravenna...per spendere per andare in detta città per il suddetto affare". Il fatto che la firma del Maderno manchi dai libri dei conti di San Pietro dall'ottobre al 9 novembre induce a pensare che in quel mese l'architetto lombardo fu a Ravenna. ___________________________________________________ H. Hibbard, Carlo Maderno, London 1971, p. 1
Carlo Maderno cappella del Sacramento, affreschi di Guido Reni e bottega, Barbiani cappella della Madonna del sudore, Duomo
I lavori iniziarono celermente atterrando la casa parrocchiale di San Giovanni in fonte per far posto al nuovo edificio. La prima pietra fu posta il 28 novembre 1612 e nell'estate del 1614 la costruzione era ultimata. Il 9 agosto Guido Reni fu incaricato di dipingerla, e la cupola e i pennacchi furono dipinti dai suoi aiuti fra l'autunno e l'inverno del 1615-16. A quella data presumibilmente anche la pala e quindi l'altare erano sul posto, cosicché si può presumere che il lavoro architettonico fosse finito a metà del 1615, se non prima. La decorazione si protrasse più a lungo; i pennacchi dovettero essere ridipinti per una infiltrazione di umidità dalla copertura pochi anni più tardi. Le figure sui pilastri di Gian Giacomo Sementi sembrano essere state dipinte non prima del settembre 1620. Forse le eleganti decorazioni in stucco con lo stemma Aldobrandini non furono finite prima di quella data. Nel 1618 Pietro Aldobrandini fa pagamenti a Bartolo Bassi scalpellino per i reliquarii, a Giovanni Battista Milanese (Montano?) intagliatore per il tabernacolo e a Biagio Giusti "spadaro" per la croce dorata, che vengono spediti a Pesaro e poi a Ravenna nel novembre 1620 .La cappella è di pianta all'incirca quadrata con angoli smussati che accennano a una croce greca, due lunette fra i pennacchi la illuminano, la terza, sull'altare maggiore fu chiusa e dipinta nel 1615. La cupola è a forma di calotta ribassata. Essa resta un esempio eloquente del fasto romano, con importanti conseguenze nel panorama architettonico ravennate. Nel 1612 il toscano Giulio Morelli è incaricato del progetto del chiostro grande di Classe la cui costruzione si protrasse fin oltre il 1620. Al primo ordine di archi sostenuti da colonne toscane si sovrappone una orditura di paraste su mensole che mal corrisponde alla logica statica. Il prospetto verso il giardino ripete lo schema di Porto nelle due testate a capanna che delimitano il retro di un lato del chiostro. Nel 1629 il ravennate Luca Danese (1598-1672) inizia la costruzione di San Romualdo per i monaci di Classe e nel 1632 la fabbrica è quasi compiuta al rustico e consacrata nel 1637. I capimastri ravennati, Egidio Romano, Pier Francesco e Bartolomeo Ghirardini lavorarono sotto la sua direzione. L'architetto dovette sottostare a vincoli: da una parte il monastero con il chiostro piccolo, dall'altra il muro ornato da paraste di pietra d'Istria della chiesa cinquecentesca e le sue fondazioni. La pianta si trova inscritta in un rettangolo, comprendente l'aula con altari laterali e un breve transetto, mentre l'altare maggiore si addossava a un setto (oggi scomparso) che divideva il presbiterio dal coro. Una cupola ribassata si leva su pennacchi all'innesto dell'aula con il transetto, un chiaro riferimento alla cappella del Sacramento in duomo. All'impianto chiaramente controriformista corrisponde un'architettura manierista che negli snodi d'angolo raggruma gli aggetti dei pilastri in un crescendo enfatico quasi proto-barocco (fig. 19). Lo stesso sarebbe avvenuto nella facciata (non realizzata) ma visibile in una pianta forse autografa (fig. 20), dove si vede il muro mosso da un aggetto e inclinato in corrispondenza dell'ingresso che potrebbe indurre a pensare a una soluzione proto-barocca. Vincenzo Coronelli nella Ravenna ricercata... intorno al 1708 presenta un progetto di facciata per San Romualdo senza darne l'autore. Esso presenta un tipo di facciata manierista romana, abbastanza coincidente con l'architettura di Danese, ma non si può dire che sia il progetto originale dal momento che non coincide affatto con la pianta citata. Inoltre le volute appaiono tipicamente settecentesche e del tutto diverse da quelle originali sul fianco dove Danese con l'uso della pietra d'Istria pare volersi accordare con le paraste lombarde. Tanto che potrebbe riferirsi a uno dei tanti progetti settecenteschi di Giuseppe Soratini. Dopo la consacrazione, per tutto il secolo continua il completamento della fabbrica. Nel 1647 un Giovanni Danese viene pagato per il disegno del pavimento che viene eseguito fino al 1653. Poi inizia la costruzione dell'ospizio nuovo, della cantina e della sacrestia (1632-1664), mentre fervono le decorazioni all'interno della chiesa e in particolare nella cappella di San Benedetto. Dalla cantina sono tolte le colonne di marmo greco e sostituite con pilastri di mattoni a reggere i capitelli teodosiani. La cappella del Sudore in Duomo viene iniziata nel 1630 guardando a quella del Sacramento di cui costituisce il "pendant". Se si pensa alla collocazione delle due cappelle all'interno della basilica ursiana si doveva avere in mente il modello romano di Santa Maria Maggiore con la Sistina e la Paolina a interrompere il ritmo basilicale accennando a un motivo di transetto. La cappella, consacrata nel 1659, accenna a un impianto cruciforme assente nel modello ravennate e presente invece nell'esempio romano: nei bracci laterali vengono collocati gli splendidi sarcofagi paleocristiani e la tavola riminese della Madonna del Sudore viene collocata sopra l'altare maggiore, incorniciata nel lombardesco tabernacolo del Santissimo a trompe-l'oeil di cui scrivemmo sopra. _______________________________________Roma, Archivio Doria Pamphili, Archivio Aldobrandini, b. 19, reg. 59a, Mandati di pagamento dal 1618 al 1628, addì 3 di gennaio 1618, addì 16 febbraio 1618, addì 17 marzo 1618, addì 3 di novembre 1620. V. Fontana, Luca Danesi (1598-1672), un galileiano a Ravenna, SR, xxxi (1980), pp. 105-119; T. Scalesse, Sull'attività di Luca Danese nella regolamentazione delle acque della legazione ferrarese (1635-1640), «OPUS», 1 (1988), pp. 7-46.
Classense chiostro grande edificato tra il 1611 e il 1620 su progetto di Giulio Morelli, interno di San Romualdo edificata a metà 1600 su progetto di Luca Danese, affreschi di Giovan Battista Barbiani e Cesare Pronti
58
L'inondazione del 1636 e il rifacimento di ponti e porte. Dopo l'inondazione del 27 maggio 1636 Luca Danese in brevissimo tempo libera la città delle acque, ripara le falle negli argini e nelle mura, ma afferma che 102 erano le case completamente distrutte, 36 "meze cadute", 114 le "servitù" dietro le case - cioè cucine, cantine e stalle - del tutto distrutte "perché fabricate invece di calce con terra, la quale ammolita dall'acqua et premuta dal peso cascano, e ne cascheranno delle altre" (83). La proposta di diversione totale e drastica dei due fiumi non fu mai eseguita, si ripiegò invece sul restauro delle mura e degli argini, nonché sul rialzo e allargamento degli archi dei ponti. Quello sul Ronco fuori porta Sisi fu fatto nel 1647 su suo disegno e vi si leggeva l'iscrizione "Lucas Danesius Inventor", mentre quello sul Montone fuori Porta Adriana fu eretto nel 1663 in pietra a due archi su disegno di Pietro Del Sale. Frattanto si procedeva al rinnovo o al restauro delle porte. Nel 1612-13 si riedificò la porta San Mama chiamandola Borghese in onore di Paolo V, ridisegnado in maniera più efficace e moderna il bastione di origine medievale, che rimase l'unico della cinta cittadina. Nella architettura della porta si seguì il modello della vicina porta Sisi, che venne restaurata nel 1649 per i danni probabilmente sofferti nell'inondazione. Poi nel 1650 il legato Cybo restaurò porta Serrata dopo che la volta interna era crollata nel 1621. E' difficile stabilire l'entità dell'intervento, anche se il rustico pesante dell'arco pare seicentesco e trova un precedente ravennate nell'arco di ingresso di San Vitale del 1622, ma soprattutto le volute del coronamento mostrano i caratteri dell'epoca. Nonostante la mancanza di documenti Danese potrebbe non essere estraneo all'intervento dal momento che egli fu particolarmente legato al Cybo di cui era protonotario, Nel 1653 fu il rinnovo di porta Nuova, battezzata Pamphilia in onore del papa. Probabilmente ci si limitò alla parte superiore con il disegno berniniano (così la tradizione) dello stemma papale retto da cornucopie, sfere e colombe ai lati, simboli di pace e di prosperità verso le banchine del nuovo porto canale Pamphilio scavato dal legato Donghi. Intorno al 1650 fu abbattuto il portichetto che univa la tomba di Dante alla chiesetta di Braccioforte sostituendolo con un muro; anche la tomba venne ricostruita in forma di edicola con tetto a due falde con un grande arco chiuso da una cancellata e rivolto a nord, come è oggi. Sulla facciata vi era l'effige di San Francesco e stemmi papali. Nel 1692 essa fu restaurata e intorno all'arco furono posti gli stemmi del comune, del legato e del vicelegato. L'immagine che ce ne dà il Coronelli presenta un arco molto simile a quello di porta Serrata rivolto verso la città e a quello dei coevi palazzi Rota e Grossi. I palazzi nobiliari. A differenza del Cinquecento il Seicento non portò profonde innovazioni urbanistiche all'interno della città, ma vi fu una discreta attività edilizia nella costruzione di palazzi nobiliari incombenti con le loro moli sulla povertà delle abitazioni comuni di cortina lungo le strade, pronte a essere sciolte dall'acqua dell'inondazione. La grande mole a blocco isolato del palazzo Ginanni Maroncelli non si distacca molto da quella del vicino palazzo Balbi, poi Rasponi Murat. Pochissimi i motivi architettonici: la grande scarpa con i conci d'angolo e il toro di pietra d'Istria, il portale rustico del primo piano nobile, aperto in origine, come ora nel vuoto o raccordato con una scala a due rampe di
ll palazzo Rota potrebbe essere per varie ragioni un'architettura civile attribuibile a Luca Danese, nonostante l'assenza di documenti certi. Se fu costruito da Pietro (1595-1652), la cronologia e i rapporti con Alderano Cybo potrebbero convalidare l'ipotesi, come pure l'aspetto massiccio e disadorno della sua architettura, simile alle fabbriche certe di Luca, ma non privo di eleganze che lo distinguono dai precedenti esempi. Il toro della scarpa basamentale coincide con la quota di imposta dell'arco del portale, incavato nel paramento murario, il disegno elegante e ricco del cornicione su turgide volute e dadi conclude la facciata organizzata sulle sottili linee orizzontali di imposta delle finestre. Quasi certamente Pietro Francesco Grossi fu l'architetto del palazzo omonimo su via di Roma: l'attribuzione è data dal disegno semplice del portale massiccio, identico al finestrone della facciata di San Giovanni Battista. Il palazzo nell'insieme segue la lezione di palazzo Rota, eliminando la scarpa basamentale, ma riprendendo l'orditura orizzontale dei davanzali delle finestre e semplificando il disegno del cornicione. Ancora alle architetture ecclesiastiche del cavalier Grossi fa pensare il tempietto del giardino con la serliana coronata dal motivo borrominiano del fregio arcuato. L'atrio ripropone il motivo della serliana con lesene e archi in corrispondenza delle sei porte (vere o finte) che si aprono sulle pareti. Tipica invenzione barocca è lo scalone immaginato come una forma continua e fluente legata dal robusto parapetto disegnato in obliquo su volte a vela che sostengono le rampe. Nel primo pianerottolo l'architetto collocò una magnifica colonna antica, forse proveniente dal suo restauro di Sant'Andrea. Ancora a Pietro o a qualche altro famigliare, i Grossi - che fin dal Cinquecento, come scrivemmo, si dilettavano di architettura - si deve l'altro palazzo su via Paolo Costa e il portale, oggi scomparso su via XIII Giugno. Il palazzo Fantuzzi, poi Farini, in piazza del Duomo conserva un impronta seicentesca nel portale rustico a conci e nell'allineamento su una cornice orizzontale delle finestre del primo piano. I palazzo Lovatelli di via Mazzini, sorto sulla magna domus polentana, ripropone la tipologia seicentesca, priva di scarpa, con il portale a bugnato liscio e la linea continua dei davanzali del primo piano solo interrotta da mensole in corrispondenza dei davanzali. Le finestre quadrate del mezzanino sotto il tetto, impaginate dalle linee orizzontali di davanzali e architravi, eil disegno del cornicione lo accomunano al palazzo Grossi La grande mole orizzontale del palazzo Lovatelli dal Corno ripete la continuità di linee orizzontali, solo interrotta dal portale dal bugnato piatto. Alla stessa tipologia appartiene il palazzo Cavalli, già da Mula poi Dal Corno, dove i rammodernamenti ottocentechi nella facciata e nell'interno hanno quasi cancellato le connotazioni cinque-seicentesche che restano solo nell'impianto. I palazzi di campagna. Nel Seicento si venne abbandonando la costruzione di ville-castello neofeudali per aprirsi a più pacifici modelli padani. Modello di questo nuovo tipo di palazzo rurale è quello che il conte Simone Lovatelli costruì intorno al 1630 a Castiglione di Ravenna . Qui è presente un compiuto disegno architettonico con il doppio loggiato centrale, che in pianta corrisponde ai saloni principali, mentre accanto la torre polentana del 1288 viene trasformata in colombara. Il motivo del loggiato poi si estende ancora su due ordini e con colonne ioniche nella "Palazza" Spreti a Piangipane, inglobando una torretta più antica. Sono motivi"pacifici" che senza contrapporsi, spesso si confondono con le torri e i beccatelli araldici. Ancora i beccatelli appaiono con questa connotazione nella villa Ginanni Corradini a Campiano del sec. XVII, ma le mensole assumono quasi la curva di volute. ______________________________________Cit. in T. Scalesse, Sull'attività di Luca Danese..., cit., p. 22. 84 U. Foschi, Case e famiglie..., cit., pp. 361-367. G. Adani, M. Foschi, S. Venturi, Ville dell'Emilia Romagna,II, Milano 1982, pp. 174-175.
Fra il 1664 e i primi anni del 1700 Guidopaolo e Cesare Rasponi fanno della residenza di San Giacomo presso Russi, la loro "Versailles", anticipando però cronologicamente il modello francese. Eccezionali sono le dimensioni: una facciata lunga quasi ottantacinque metri, alta quindici e conclusa da torri di venticinque metri. In realtà le due torri agli estremi fanno pensare al modello dell'Escorial, limitato però a un solo prospetto, celebrato in pubblicazioni seicentesche.Scomparso è l'edificio che si protendeva in profondità verso il fiume Lamone e che forse aveva inglobato una precedente costruzione dei canonici di Porto, precedenti proprietari della tenuta. In esso si apriva lo scalone monumentale a pianta quadrata, mentre l'atrio si concludeva in un portico aperto su una grande corte a prato disegnata ad anfiteatro. Nel piano superiore erano i saloni di rappresentanza, mentre l'esterno era ritmato da paraste reggenti un grande cornicione. La copertura aveva la forma di un grande padiglione. Vi si potevano riscontrare i modi vignoleschi di alcune ville bolognesi del Cinquecento e in particolare del Palazzo della Morte a Funo di Argelato. Ai lati si ritrovavano due cortili con grandi stalle, rimesse e cantine. Il lungo prospetto, data la sua ridotta profondità aveva un impianto interno abbastanza semplice di sale in sequenza, servite da una scala di servizio. L'imponente cimasa sulla fronte è stata pure demolita ai primi del Novecento, privando questa architettura della più importante connotazione barocca. In essa era l'orologio e la campana retta da eleganti ferri per scandire le ore del lavoro e dell'ozio del palazzo e della grande tenuta. La facciata non differisce molto dallo schema delle architetture coeve ravennati: il grande basamento a scarpa con toro e le linee orizzontali dei davanzali dei due piani superiori e del cornicione ne sono gli unici elementi organizzatori. La forza delle linee orizzontali prevale sulle verticali, tanto che il cornicione continua appiattito anche sulle torri, per poi ripetersi alla loro sommità con l'identico disegno a mensole. Il portale rustico è collocato fra grosse paraste che reggono il balcone. Vi si apre un elegante serliana con colonne ioniche, slanciata dal motivo di ghirlande che discendono dallo scudo araldico. L'uso di materiali di reimpiego potrebbero collegare questo cantiere a quelli ravennati dei palazzi del vice-legato e del legato, come la chiave rinascimentale del portale e le mensole che reggono il balcone (simili a quelle del palazzo Zorzi in via Diaz), o le colonnine ioniche della facciata posteriore che fanno pensare alla precedente residenza estiva dei canonici di Porto. Verrebbe in mente il nome di Pietro Francesco Grossi, allora l'architetto più attivo a Ravenna, da un confronto con i palazzi Rota e Grossi, ma certo ci fu una precisa volontà del committente a fondere motivi berniniani divulgati nella bottega di Carlo Fontana in una immagine insolita, ricordo dei viaggi e delle missioni diplomatiche del cardinale Cesare. Il restauro delle chiese e l'opera di Pietro Grossi. Nel 1645 l'arcivescovo Torreggiani ampliò il palazzo arcivescovile con un edificio allungato anteposto al coacervo di costruzioni antiche fra l'abside dell'Ursiana, la torre Salustra e la cappella di Sant'Andrea. Il prospetto, doveva essere molto semplice, prima del suo scompartimento con paraste ottocentesche, mentre tutta l'enfasi era data all'ingresso, eccentrico, con la serliana retta da colonne di porfido antiche che prosegue nell'atrio contiguo alla basilica metropolitana e aperto verso il giardino. Da essa parte lo scalone monumentale trasformato nell'Ottocento e ornato di colonne che conduce al piano nobile dove è la sala Gialla, ornata da pitture di Girolamo Curti. Nel 1658 un incendio distrusse la cella campanaria del Duomo che fu ricostruita con trifore inserite in grandi archi ribassati, dove l'arco centrale è notevolmente più ampio di quelli laterali. Forse si seguì il disegno antico alterando solo le trifore e le bifore sottostanti che furono in parte chiuse per rinforzare la struttura, e solo nel cornicione a dadi si usò un motivo moderno, ricorrente nell'architettura seicentesca ravennate; resta il fatto che la cella riprende il disegno del secondo ordine del battistero neoniano reinterpretandolo in modo moderno e usandolo a mo' di serliana. Quando invece cadde il campanile di San Vitale per il terremoto del 1688, danneggiando in parte il chiostro lombardesco della cisterna, si mantenne solo l'impianto circolare ravennate con rari oculi aperti nella muratura cilindrica in modo da concentrare l'attenzione sulla cella campanaria. Essa venne sopraelevata e ornata da un ordine di paraste corinzie fra le quali si aprono arcate aperte alternate ad altre cieche, mentre la copertura ha la forma di cupola ottagonale ricoperta da squame di piombo. ______________________________________U. Foschi, II palazzo di San Giacomo presso Russi, Forlì 1983, pp. 25-40; A.M. lannucci, Un racconto sul territorio, in Russi un racconto sul territorio, Ravenna 1989, pp. 227-236.
Pietro Grossi, appartenente a una famiglia dove le tradizioni militari si univano alla passione per l'architettura, come già scrivemmo, si impone dopo Luca Danese, come il più importante architetto a Ravenna, al servizio di arcivescovado e del comune. Subì evidentemente la influenza di Danese insieme con quella dell'architettura bolognese e del nord d'Italia, per i suoi legami col ducato di Mantova. L'arcivescovo Paluzzo Altieri, dopo aver costruito la sacrestia del Duomo nel 1670 accanto alla cappella del Sacramento, e probabilmente l'atrio del palazzo arcivescovile con la bella serliana, gli affidò una vasta opera di rinnovamento delle chiese paleocristiane ben più libera e creativa dei restauri cinquecenteschi, di vera e propria reinterpretazione sull'esempio di Borromini a San Giovanni in Laterano, celebrato non a caso dal cardinale Cesare Rasponi nel suo grande volume dedicato alla basilica (Roma, 1656). Spesso nelle sue opere egli si trovò affiancato al pittore Cesare Pronti, autore di decorazioni nel palazzo arcivescovile e nella villa Rasponi di San Giacomo. A Santa Maria Maggiore nel 1671, per incarico comunale, il ritmo basilicale fu ridotto a una serie di serliane impiegando alcune colonne antiche come motivo ornamentale accanto a pilastri; fu pure costruito un piccolo transetto e probabilmente innalzata la navata centrale con nuove finestre e un semplice cornicione a dadi. La sostituzione dei pilastri alle colonne era dettata dal bisogno di rendere piu solidi i fianchi della navata, ma soprattutto di sostituire la "sintassi" barocca alla "paratassi" paleocristiana. Grossi però aveva probabimente in precedenza preparato un altro progetto che mutava completamente l'impianto basilicale in uno centrale dove ingressi, presbiterio e cappella laterale si innestano su di un vano quadrato coperto con una volta a ombrello illuminata al centro da una lanterna. E' molto strana questa soluzione costruttiva quattrocentesca - sopravvissuta però per tutto il Cinquecento a Ravenna (palazzi Rasponi-Bellenghi-Ca' de' ven, Balbi-Fantuzzi-Rasponi Murat, Grossi a Castiglione) - nella seconda metà del Seicento ed è spiegabile solo con un omaggio alla tradizione costruttiva locale che continuava ad apprezzare questo sistema antico - romano di volta leggera in laterizio. Dodici colonne antiche della basilica venivano poi disposte negli angoli della parete inferiore e a inquadrare gli arconi dei bracci, intervallate da nicchie. Nel 1673 per incarico dell'arcivescovo Altieri, Grossi ricostruì Sant'Andrea Maggiore riducendo le tre navate in un'unica aula con transetto, mentre l'abside antica con la cripta fu separata con l'altare maggiore per diventare il coro delle monache. La chiesa assunse quindi un aspetto simile al modello controriformista di San Romualdo, dove le colonne antiche - celebrate da Agnello per la loro preziosità - furono addossate a paraste come oggetto ornamentale. Queste venivano a reggere una finta volta costruita al di sotto delle capriate del tetto, mentre il transetto presentava due arconi con finestre termali; gli altari minori, di disegno borrominiano si disponevano ai lati dell'aula, separati dalle paraste. Simile fu la trasformazione di Sant'Agnese nel 1682 demolendo le navate laterali, conservando la centrale dove si innestavano a mò di croce due cappelle, mentre la parte finale veniva trasformata in presbiterio e coro. ________________________________________87 Cfr. B. Bandini, N. Pirazzoli, Antonio Farini (1710-1794). Il mestiere del perito-architetto, Ravenna 1983, figg. 9-10. Cfr. B. Bandini, N. Pirazzoli, M. Scarano, Ravenna nell'Ottocento, Ravenna 1982, dove sono riprodotte la pianta e due sezioni di Sant'Andrea fatte da Giuseppe Cuppini prima della demolizione. La sezione longitudinale è nel voi. m, p. 451, di questa Storia di Ravenna.
Nel 1683 Pietro Grossi terminò l'ammodernamento di San Giovanni Battista. Nel 1634 era stato demolito il quadriportico per creare il piazzale antistante, poi per lascito di Anton Maria Rossi medico, figlio dello storico Girolamo, iniziò la ricostruzione a tre navate con transetto e cupola a catino, mentre solo l'abside dell'antica chiesa era conservata. La facciata presenta un disegno di ascendenza borrominiana nel movimento convesso della fronte, che avanza in una edicola coronata da un timpano ad arco ribassato che mal si combina con il timpano acuto retrostante, come succede nelle porte laterali fra le volute arcuate intorno all'arco e il timpano. Migliore è il disegno del portale principale di stile borrominiano nel disegno leggermente concavo coronato da un fastigio tipicamente romano. Questi motivi romani si mescolano al motivo palladiano delle finestre termali del transetto, tanto che si potrebbe pensare a un influsso diretto di Luca Danese su Grossi che lo avrebbe educato ai modelli veneziani e romani conosciuti direttamente nei suoi viaggi, e perfino un'ispirazione del transetto ravennate a quello del duomo di Ferrara, costruito da Danese nel 1636. Resta il fatto che la facciata segue il modello romano di Sant'Andrea della Valle, interpretato a Venezia da Giuseppe Sardi negli Scalzi (carmelitani, come a San Giovanni) la cui facciata era compiuta nel 1680. Analogie stilistiche portano ad attribuire a Grossi il portale, oggi distrutto, del palazzo omonimo su via XIII Giugno nel disegno del portone e del timpano con guglie e il busto al centro del condottiero Cesare Grossi. Nel 1691 Pietro Grossi ricostruì per Francesco Negri curato di Santa Maria in "Coelos eo", la piccola chiesetta oggi scomparsa che sorgeva su via Salara con un piccolo sagrato, a pianta rettangolare con due cappelle laterali. Questo rinnovamento toccò anche architetture minime o ridottissime, come i Santi Nicandro e Marciano che il parroco nel 1684 ridusse da tre navate a una sola. E c'è da supporre che allora si cominciasse a pensare al rinnovamento della basilica ursiana, dal momento che ai primi del Settecento si aprirono finestroni nella facciata. Il Coronelli nella Ravenna ricercata intorno al 1708 rappresenta un'immagine dell'interno con il colonnato antico intercalato da pilastri di rinforzo ogni due archi, che proseguono nella costolatura di una volta a botte ribassata sotto le capriate del tetto. Il ritmo di pilastri e colonne, pare una ripresa dell'interno di Porto. Nella volta si aprivano finestre incassate, e si accenna a un transetto con cupola, mentre la tribuna originale era conservata. Un'altra tavola mostra un progetto per la cupola del duomo a imitazione di quella di Santa Maria in Porto, appena ricostruita dopo l'incendio, con strane merlature sopra la lanterna. Forse anche questa è un'imprecisa rappresentazione di un progetto di Soratini. Nel 1696 si costruirono i portali della facciata di Porto impiegando colonne antiche a reggere timpani interrotti secondo i canoni del manierismo romano: ma ormai a Ravenna arrivavano direttamente da Roma gli ultimi bagliori del Barocco. Nel 1698 Giovan Battista Contini, allievo di Carlo Fontana, ricostruisce in brevissimo tempo San Domenico alzando una grande aula contraffortata. All'interno lesene giganti reggono la volta a botte disegnando ai lati una travata ritmica che inquadra i tre altari minori (numero canonico nella tipologia delle chiese della controriforma) su ogni lato .
I lavori del legato Francesco Barberini Contemporaneamente si assiste a una completa ricostruzione di piazza Maggiore e delle sedi del potere secolare. Nel 1644 la statua di San Vitale di Clemente Molli viene sostituita a quella lombardesca di Sant'Apollinare e questa messa al posto lasciato vuoto da quasi un secolo e mezzo del Leone marciano. Nel 1681 si riedificò il palazzo Comunale , forse per opera di Pietro Grossi che utilizzò materiali provenienti da Santa Maria Maggiore. Contemporaneamente il vicelegato aveva iniziato il rinnovo del proprio palazzo, promuovendo un'analogo intervento del legato Raggi, mentre nel 1658 nel cortile retrostante era stata edificata la tesoreria di Romagna. Il terremoto del 1688, oltre a provocare il crollo del campanile di San Vitale, di cui si è detto, lesionò gravemente il palazzo legatizio, tanto che il cardinale Francesco Barberini decise di ricostruirlo. I lavori procedettero spediti e nel 1696 esso era già abitato. La pianta allungata e l'architettura semplice, dove solo il portale con colonne reggenti timpani interrotti arcuati, interrompe il basamento a scarpa, le semplici inquadrature delle finestre nei due piani superiori, l'attico cieco con specchiature, e infine lo scalone doppio aperto verso il cortile fanno pensare a un progetto venuto da Roma. Un progetto quasi neo-michelangiolesco nelle citazioni di Porta Pia e della finestra del balcone di palazzo Farnese. Si potrebbe fare anche l'ipotesi dell'atelier di Carlo Fontana per la somiglianza con la fabbrica del San Michele a Roma. Lo sviluppo sulla piazza poteva anzi essere più esteso se si fosse eseguito un ulteriore progetto di prosecuzione sopra la loggia del palazzo nuovo, conservato nell'archivio Corsini a Roma. Dai disegni delle piante si può ricostruire l'assetto originale del palazzo che aveva inglobato la chiesa di San Giovanni Decollato - appartenente alla comunità ricostruita nel 1572 per la confraternita che assisteva i condannati a morte che conservava un suo ingresso indipendente sulla piazza e sporgeva con l'abside nel cortile dove si affacciavano le carceri pure ricostruite. L'ingresso sulla piazza è pure chiaramente visibile nella veduta di Coronelli. Un impianto simile è pure nel palazzo priorale di Cervia di Francesco Fontana (1701) parzialmente eseguito secondo il progetto originale. E verrà poi ripreso dallo stesso architetto nel palazzo Spreti, terminato nel 1711, e anche dal palazzo Rasponi dalle Teste costruito da Giuseppe Rasponi con interventi di Giuseppe Antonio Soratini. Sempre al legato Barberini si deve la costruzione a Ravenna del Collegio dei Nobili (1697-99) oggi caserma, in via Nino Bixio, che ripete i caratteri dell'edilizia ravennate dell'epoca: paramento in mattone a vista, scarpa di basamento, toro e cordoli orizzontali, unici elementi organizzativi della facciata insieme al grande portone. Il Seicento si chiude a Ravenna con un disegno simmetrico, barocco quindi: si era aperto con il manierismo di Carlo Maderno e ora si chiude con il post-barocco degli allievi di Carlo Fontana, in mezzo stanno gli architetti ravennati Danese e Grossi, che però mai aderirono alle novità romane, pur conoscendole di prima mano (nel caso del Danese). Sparirono quasi del tutto gli apporti veneti, mentre rimase forte il confronto con Ferrara e si accrebbe quello con Bologna, ormai città dominante anche culturalmente. Giuseppe Antonio Soratini sarà la novità del nuovo secolo: lombardo e attento alle ricerche del rococò europeo, saprà connotare in maniera singolare il volto di Ravenna distinguendolo da quello delle città vicine. Soprattutto rinnoverà l'edilizia civile, basata da secoli su un ascetismo fuori dal tempo, introducendo le "grazie" settecentesche. L'internazionalismo della biblioteca Classense diffonderà un gusto che attraverso gli stucchi dei Martinelli e le decorazioni dei Barbiani impronta architetture civili e religiose culminando nella decorazione della cappella del Sudore: sinfonia delle cosiddette "arti minori". Un gusto e una scuola locale che dovevano scontrarsi polemicamente con il Buonamici e la sua ricostruzione dell'Ursiana, imposta da arcivescovi stranieri. Non a caso periti come Antonio Farini preferiranno ritornare alla scarna architettura post-barocca della scuola romana, linguaggio ufficiale dei "grand traveaux" infrastrutturali di Massei e Alberoni. Poi Camillo Morigia si rivolgerà a Palladio e, ancor meglio, alla impaginazione ritmica degli archi onorari e delle porte romane - che Alberti e Bramante avevano reinventato - per la facciata di Santa Maria in Porto, dove l'erudizione non pregiudica l'originalità. _______________________________Biblioteca Corsini, Roma, MS. 34 K 14, ff. 54-57, I disegni acquerellati mostrano lo stato di fatto e i piani di progetto in «piedi di Faenza». Angelo Turchini, Cervia nuova. Materiali per la storia di una città di stato, SR, xxxvn (1986), pp. 27-59.
Palazzo del Legato oggi prefettura 1700, Bracci
monumento Clemente XII, Collegio dei Nobili (1697-99)
Francesco Fontana chiesa del Suffragio 1705-12, palazzo Rasponi 1770 e Camillo Morigia torre dell’orologio