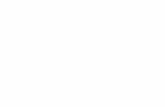Le acque termali nella Tabula Peutingeriana
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Le acque termali nella Tabula Peutingeriana
ANTENOR QUADERNI
Direzione
Irene Favaretto, Francesca Ghedini
Comitato sCientifiCo Maria Stella Busana, Jacopo Bonetto, Paolo Carafa, Marie Brigitte Carre, Heimo Dolenz, Christof Flügel, Andrea Raffaele Ghiotto, Giovanni Gorini, Stefania Mattioli Pesavento, Mauro Menichetti, Athanasios Rizakis, Monica Salvadori, Daniela Scagliarini, Alain Schnapp, Gemma Sena Chiesa, Desiderio Vaquerizo Gil, Paola Zanovello, Norbert Zimmermann
CoorDinamento sCientifiCo Isabella Colpo
segreteria reDazionale
Matteo Annibaletto, Maddalena Bassani
Layout del testo: Matteo Annibaletto
Volume realizzato e finanziato nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2008) “Il termalismo in età romana fra conoscenza e valorizzazione ar cheo logica”.
Università degli Studi di PadovaDipartimento dei Beni Culturali: Ar cheo logia, Storia dell’Arte del Cinema e della MusicaPiazza Capitaniato, 7 – 35139 [email protected]
ISBN 978-88-97385-64-6© Padova 2013, Padova University PressUniversità degli Studi di Padovavia 8 febbraio 1848, 2 - 35122 Padovatel. 049 8273748, fax 049 8273095e-mail: [email protected] www.padovauniversitypress.itTutti i diritti sono riservati. È vietata in tutto o in parte la riproduzione dei testi e delle illustrazioni.
In copertina: Bagni di Viterbo, bacino delle Terme Carletti (foto M. Annibaletto).
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVADIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
ANTENOR QUADERNI 29
AQUAE SALUTIFERAEil termalismo tra antiCo e Contemporaneo
ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE(MONTEGROTTO TERME, 6-8 SETTEMBRE 2012)
a cura di Maddalena Bassani, Marianna Bressan, Francesca Ghedini
PADOVA UNIVERSITY PRESS
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
SOMMARIO
franCesCa gheDini, Apertura dei lavori ......................................................................................7
PER UNA DEFINIZIONE DI TERMALISMO
paolo fabbri, marCo pola, Dario zampieri, Il termalismo da un punto di vista geologico ....11
giorgio zanChin, Le Terme Euganee. Cenni storici .................................................................19
angelo bassani, Le ambiguità idrologiche irrisolte dalla chimica fisica ..................................29
paola zanovello, Per una definizione di termalismo ..............................................................43
matteo annibaletto, maDDalena bassani, Morfologie del termalismo antico. Proposte metodologiche per un loro riconoscimento ..............................................................................49
IL TERMALISMO NEL MONDO ANTICO.OBIETTIVI, STRUMENTI, FONTI ARCHEOLOGICHE
franCesCa gheDini, paola zanovello, Il termalismo in età romana tra conoscenza e valorizzazione (PRIN 2008) ....................................................................................................65
matteo annibaletto, Servirsi delle acque minerali e termali: criticità e spunti di riflessione ... 77
maDDalena bassani, Spazi sacri e materiali cultuali nei contesti termominerali ....................91
vinCenzo tiné, louis torelli, Il complesso speleo-termale del Monte Kronio di Sciacca (AG) tra mitologia, speleologia e ar cheo logia .......................................................................109
maura meDri, In baiano sinu: il vapor, le aquae e le piccole terme di Baia ...........................119
raimonDo zuCCa, Il progetto di ricerca sulle Aquae calidae della Sardinia ...........................145
IL TERMALISMO NEL MONDO ANTICO: LE FONTI SCRITTE
maria feDeriCa petraCCia, maria tramunto, Il termalismo curativo nei testi epigrafici: il caso delle Ninfe / Linfe ........................................................................................................175
paola tomasi, Mea medicina lenietur. Le prescrizioni di un numen fontis in due tabellae medicinales ticinenses (CIL V, 6414-6415) ...........................................................................193
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
6 sommario
santiago montero, La dea Salus e i culti termali: il caso della Hispania .............................209
anDrea rizzi, Canaque sulphureis albula fumat aquis. Il termalismo romano in Italia e le fonti letterarie: un quadro d’insieme .................................................................................219
CeCilia zanetti, I siti termali d’Italia tra fonti letterarie e dati ar cheo logici ........................231
patrizia basso, Termalismo perché, termalismo per chi. I frequentatori delle aquae salutiferae .................................................................................................................................247
alfreDo buonopane, Curisti in divisa? Soldati e acque terapeutiche in età romana ...........263
franCesCa moranDini, Le acque termali nella Tabula Peutingeriana ...................................273
luCa trevisan, Rappresentare il termalismo. Tracce di un percorso iconografico .................289
enriCo maria Dal pozzolo, Per il benessere del corpo e dello spirito. Terme e arte nel Grand Tour in Italia tra ‘500 e ‘700. Qualche appunto e il caso Arundel ..........................307
maurizio rippa bonati, Iconografia termale euganea. Una lettura storico-medica .............323
IL CASO DI MONTEGROTTO TERME: DALLO STUDIO DEI MATERIALI AL PROGETTO DEL MUSEO DEL TERMALISMO
elena pettenò, silvia Cipriano, Chiara Destro, patrizia toson, franCesCa falesChini, alessanDra DiDonè, Il complesso termale e il teatro di viale Stazione / via degli Scavi. Nuove prospettive di studio .........................................................................335
marianna bressan, matteo marCato, Carla onnis, Chiara Destro, tiziana privitera, alessanDra DiDonè, stefania mazzoCChin, elisa brener, La villa romana di via Neroniana a Montegrotto Terme. Ipotesi ricostruttiva degli interni ..........361
ivana Cerato, stefania mazzoCChin, elisabetta fasson, Il paesaggio storico tra cartografia e ricognizione ar cheo logica. Alcuni dati dei lavori condotti nel territorio di Montegrotto Terme .................................................................................................................393
paola zanovello, Riflessioni a margine del progetto per un Museo del Termalismo a Montegrotto Terme .................................................................................................................409
samanta greggio, tommaso leti messina, paolo salonia, Rilievi e ricostruzioni tridimensionali per l’indagine ar cheo logica: i pavimenti musivi della villa di via Neroniana a Montegrotto Terme ...........................................................................................415
bruno fanini, emanuel DemetresCu, Daniele ferDani, sofia pesCarin, Aquae patavinae VR, dall’acquisizione 3d al progetto di realtà virtuale: una proposta per il Museo del Termalismo ............................................................................................................431
TAVOLE .......................................................................................................................................451
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
le aCque termali nella tabula peutIngerIana*
Francesca Morandini
Per chi si trovava a percorrere le strade dell’impero romano, suggestiva e oltremodo affasci-nante doveva essere la vista delle sorgenti di acque calde che poteva incontrare lungo il cammi-no. Quelle sulfuree erano riconoscibili anche da lontano per le caratteristiche esalazioni1, altre attiravano per le particolari incrostazioni che formavano2, altre ancora per la singolarità degli elementi che vi galleggiavano, comprese isole fluttuanti3; questi mirabilia aquarum ricorrono in numerosi passi di fonti latine di natura enciclopedica quali, ad esempio, l’VIII libro del De ar-chitectura di Vitruvio, il XXXI libro della Naturalis Historia di Plinio ed il III libro delle Na-turales Quaestiones di Seneca4.
Indubbiamente le acque termali, oltre a presentare questi fenomeni di grande suggestione, a poter curare un ampio spettro di patologie e a poter garantire generico e immediato benes-sere fisico, svolsero un ruolo pratico di notevole importanza per chi si trovava a programma-re spostamenti di ampio raggio lungo gli itinerari dell’impero, dal momento che presso di esse era possibile trovare acqua corrente e in alcuni casi anche strutture attrezzate per l’accoglienza, quali, ad esempio, in aggiunta alle consuete locande con alloggi e poste dove poter sostituire i cavalli, anche vasche per bagni con acqua calda naturale. Chi era quindi affaticato dal viaggio vi poteva trovare benessere per il corpo e, talvolta, vi poteva anche curare disturbi fisici.
La monumentalizzazione di acque termali presso la rete viaria dell’impero è nota attraver-so diversi tipi di fonti; i dati ar cheo logici, ove presenti, documentano direttamente questo feno-meno5; altri contesti sono noti solo per via epigrafica6, mentre in testi storici o letterari ne sono citati altri ancora.
Ad esempio da una lettera di Cassiodoro databile tra il 507 ed il 511, veniamo incidentalmente a conoscenza dello stato in cui versavano gli impianti dell’area eugano-veneta all’inizio del VI se-colo d.C.; con la missiva infatti il segretario del re goto Teodorico commissionava al noto architet-
* Questo contributo costituisce la sintesi della mia tesi di laurea, che s’inseriva nell’ambito di una serie di studi effettuati all’interno del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova relativi alle acque termali, agli edifici ad esse connessi e al loro rapporto con gli itinerari stradali (marChiori 1979-80; pettenò 1992-93). Il lavoro era stato seguito dal prof. Guido Rosada in qualità di relatore e dal prof. Luciano Bosio; ad entrambi va la mia riconoscenza per gli stimoli ed i preziosi consigli che nel corso dello studio mi hanno saputo dare. Ringrazio inoltre Stefania Pesavento Mattioli per la consueta generosa consulenza.
1 strabo 5, 4, 6; sen. nat. 3, 24, 4.2 sen. nat. 3, 20, 4.3 sen. nat. 3, 25, 8.4 Cfr. a questo proposito zanetti, rizzi, mantovanelli 2012.5 In molti casi la continuità d’uso delle sorgenti idrotermali ha reso impossibile la conservazione delle strutture
di età romana anche perché, a causa della particolare aggressività di alcuni tipi di acque, gli impianti hanno necessitato nel corso degli anni di innumerevoli interventi di manutenzione che hanno compromesso irrimediabilmente le opere antiche. È il caso ad esempio delle africane Aquae Persianae e Aquae Tacapitanae, le cui strutture di età romana non sono oggi più leggibili (pettenò 1998, p. 138, note 51 e 52).
6 Per quanto riguarda l’Africa, cfr. ad esempio i casi delle Aquae Flavianae, Aquae Traianae (ILA fr. 440; CIL VIII, 14457) o delle Aquae Palmenses (CIL VIII, 14465) (pettenò 1992-1993, pp. 70-78, 131-133).
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
274 franCesCa moranDini
to patavino Aloisio il restauro degli antichi bagni, descrivendone il grave abbandono da lui verificato durante un viaggio7.
Altre fonti nelle quali è registrata ca-pillarmente, e spesso con estrema precisio-ne, la presenza di acque sono i cosiddet-ti itineraria, documenti di uso pratico nei quali erano raccolte in modo schemati-co tutte le informazioni che potevano es-sere utili per chi si trovava in viaggio sul-le principali strade. Città, mercati, porti, mutationes dove poter cambiare i caval-li, mansiones dove poter anche alloggiare, ponti, guadi, venivano puntualmente indi-cati lungo il tracciato viario con la distanza
in milia, o in unità di misura di uso locale, dal centro principale più vicino. È evidente quindi il valore straordinario di queste fonti per la ricostruzione precisa dell’antropizzazione del pae-saggio antico e, per quanto riguarda le acque termali, per l’identificazione più precisa possibile della loro presenza e della loro posizione in prossimità di arterie viarie.
Tra gli itineraria scripta vel adnotata, secondo la distinzione enunciata da Vegezio8, all’in-terno della raccolta conosciuta con il nome di Itinerarium Antonini9, redatta probabilmente all’inizio del III secolo d.C. e aggiornata in occasione della copiatura all’inizio del IV10, vi sono alcuni tratti viari che interessano anche la penisola.
Anche nell’Itinerarium Burdigalense vel Hierosolymitanum sono presenti riferimenti a percorsi viari relativi all’Italia; in questo itinerario redatto nel 333 d.C. in occasione di un pelle-grinaggio da Bordeaux a Gerusalemme sono infatti riportati anche i percorsi da Susa ad Aqui-leia e, al ritorno, da Otranto a Laus Pompeia (Lodi)11; da ultime interessano la penisola anche altre fonti itinerarie di cronologia più tarda e di matrice prevalentemente geografica, la Cosmo-graphia dell’Anonimo Ravennate12 ed i Geographica di Guidone13.
Oltre a questi riveste un posto di grande importanza il più significativo itinerarium pictum a noi noto, la Tabula Peutingeriana o Codex Vindobonensis 324, una «descrizione pittorica del mondo antico», come la definisce il Bosio nello studio dedicatole, a noi nota attraverso una co-pia medievale il cui originale sembra risalire alla seconda metà del IV secolo d.C.14. Nella Ta-bula sono riportate figurativamente con simboli, che tuttavia richiamano idealmente l’elemen-to che indicano, tutte quelle informazioni legate alla viabilità e altre ancora che negli itineraria scripta vengono semplicemente elencate e affiancate dal numero delle distanze; vi si trovano ele-menti geomorfologici (monti, deserti, fiumi, laghi, mari e paludi) e della vegetazione (boschi e foreste), spesso accompagnati da annotazioni scritte che ne illustrano le peculiarità. Per quanto riguarda i dati antropici, numerosi sono i disegni con i quali vengono diversificate le tipologie degli insediamenti o semplicemente dei possibili luoghi di tappa lungo le arterie viarie, affian-cati dal toponimo. Sono segnalati prevalentemente siti che si trovano lungo le principali stra-
7 CassioDor. var. 2, 39; lazzaro 1981, pp. 65-73; reDDiti 1997, p. 17; marano 2011.8 veg. Epit. rei mil., III, 6.9 Cuntz 1929. 10 Da ultimo, cfr. Calzolari 1996 e per i problemi relativi alla datazione anche arnauD 1993, pp. 33-47.11 Cuntz 1929.12 sChnetz 1940; rigoni 1982.13 sChnetz 1940.14 Per un’analisi accurata del documento e per gli studi precedenti cfr. a bosio 1983.
Fig. 1 -Vignetta ad Aquas (Tab. Peut. III, 5).
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
le aCque termali nella tabula peutIngerIana 275
de, rese con segmen-ti di colore rosso che piegano ad angolo ret-to in corrispondenza di mansiones e muta-tiones; i nomi di que-ste sono registrati con precisione, affianca-ti dalla distanza dalla tappa precedente ge-neralmente in milia, in leugae nelle Gallie e in parasanghe per le re-gioni persiane.
Il tipo di vignetta utilizzato per i centri termali è prevalente-mente quello cosiddet-to “ad aquae”15, co-stituito da un edificio quadrangolare visto “a volo d’uccello”, con tre corpi di fabbrica ricchi di aperture, forse por-ticati, disposti a P, terminanti in facciata con due basse torri timpanate raccordate da un altro corpo di fabbrica nel quale si trova un’apertura. Lo spazio interno racchiuso da questo edificio è molto spesso di colore verde acqua. Questo schema di fondo viene riprodotto con numerose varianti che consentono comunque di riconoscere un tipo comune per indicare un gruppo di siti dalle medesime caratteristiche (fig. 1 e 1a).
utilizzo Della vignetta nella tabula peutIngerIana (cfr. tabella 1)
In ragione di alcune eccezioni nell’uso, l’interpretazione di questo disegno non è tuttavia univoca; alcuni studiosi16 sono propensi nell’individuare in questa vignetta l’indicazione di ville rustiche presso le quali era possibile trovare alloggio, anche se la presenza nella maggior parte dei casi della scritta aquae o di termini riferibili a fonti e sorgenti rende più probabile l’ipotesi che tale segno venga invece utilizzato prevalentemente per indicare la presenza di acque termali17.
Nella Tabula, dalle Gallie, all’Africa, alle province orientali, la presenza di acque viene in effetti segnalata con diverse modalità che possono talvolta ingenerare dubbi e che sembrano essere svincolate da motivazioni specifiche dei vari territori; nella maggior parte dei casi vie-ne utilizzata la vignetta ad aquae, anche se con leggere varianti che comunque consentono di identificare senza equivoco il tipo. Il toponimo può essere costituito o solamente dall’esplici-to riferimento all’elemento naturale, solitamente al plurale (Ad aquas III, 5; V, 1, 3; VI, 3, 5), talvolta con un epiteto che ne mette in evidenza alcune caratteristiche, al singolare o al plurale (Aqua viva IV, 4/5; Aquis calidis I, 4; VII, 4; IX, 2); con nomi legati al centro urbano presso il quale sgorgano le sorgenti e dal quale forse dipendevano amministrativamente (Aquas Volater-nas III, 2, Aque Populanie III, 2/3), o nomi legati alla divinità cui erano attribuite le acque e i
15 La definizione è data dai Levi (levi, levi 1967, pp. 65, 85-90, con bibliografia precedente) e ripresa poi da Bosio (bosio 1983, pp. 97-101). Da ultimi perex agorreta, roDríguez morales 2001.
16 levi, levi 1967, pp. 88-90.17 bosio 1983, pp. 98-99.
Fig. 1a -Vignette nel territorio dell’attuale Francia (Tab. Peut. I).
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
276 franCesCa moranDini
181920
18 19 20
Vignette ad aquae con toponimo indicante
la presenza di acqua
Toponimo indicante la presenza di acqua
Altra vignetta con toponimo indicante la presenza di acqua
Vignette ad aquae prive di altra specifica
Vignette ad aquae con toponimi che non
indicano la presenza di acqua
Italia e Sicilia
Aquas Volaternas III, 2 Piscinas III, 1 Aquis tatelis* II, 4/5 V, 2(Appii Foro) Ad taberna frigida* III, 1
Aque Populanie III, 2/3 Ad aquas IV, 4 Aque ange* VI, 1 Mindo fl. IV, 2
Fonte Timavi III, 5 Ad aquas Albulas IV, 5 Thermis VI, 1 Vacanas* IV, 3
Aquas Passaris IV, 1 Tres Tabernas V, 1
Aquas Tauri IV, 3 Ad nonum V, 3
Aquas Apollinaris IV, 3 Inuinias* V, 3
Aque Cutillie IV, 4/5 Syllas* V, 3
Aqua viva18 IV, 4/5 (Baiae)* V, 3
Aquas labodes VI, 1 Pretorium Lauerianum* V, 3
Oplontis V, 4/5
Ad teglanum V, 5
Oplontis* V, 5
Arciade VI, 2
(Columna Regia19)* VI, 2
Altri territori
Aquis (Convenarum) I, 1 Fontes caldis I, 3 Aquis Tibilitanis* III, 1 VI, 4 Pretorium Agrippine I, 2
Aquis Segeste I, 4 Fons camerata II, 1 X, 2 Indesina I, 5-II, 1
Aquis Calidis I, 4 Aquartille II, 4 Quaeri20 IV, 1
Aquis Bormonis I, 4 Fons Poramiano III, 2 Ad pretorium* IV, 5
Aquis Nisincii I, 4/5 Aqua viva IV, 3 Ad pretorum V, 1
Aquis Segete I, 5 Aquas Regias V, 1/2 Seruitio V, 1
Aquis sestis II, 1 Aquo V, 3 Ad horrea* V, 2
Ad aquas Herculis III, 1 Ad aquas VI, 4 Siclis* V, 3
Ad Aquas casaris III, 4 Aqua amara VI, 5 Inaronia* V, 4
Ad aquas III, 5 aquas arauenae IX, 1/2 Stanecli* VI, 1
Aquis IV, 3 Balnesi IX, 3
Ad aquas V, 1 Ad fontem felicem X, 3
Ad aquas V, 3fons Scabore
ad fontem Scaborem X, 3/4
Ad aquas V, 3 Aque frigide X, 4
Ad aquas VI, 3
Ad aquas VI, 5
Aquis calidis VII, 4
Aquis calidis IX, 2
Tab. 1 - Sintesi dei riferimenti a presenza di acque nella Tabula Peutingeriana.
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
le aCque termali nella tabula peutIngerIana 277
poteri terapeutici di esse (Aquas Apollinaris IV, 3; Aquis Bromonis I, 4; Aquis Nisincii I, 4/521). In altri casi vengono messe in evidenza le caratteristiche geomorfologiche dell’area nella qua-le sgorgano le sorgenti, come ad esempio per le Aque Cutillie (IV, 4/5), il cui nome, se corret-tamente riferito al greco kotyle -cavità-, potrebbe alludere alle depressioni naturali del terreno all’interno delle quali si è formano il lacus Cotiliae22 (fig. 2).
Un cospicuo numero di sorgenti non viene indicato con la vignetta, ma con il solo toponi-mo23, generico per alcuni siti (Ad aquas IV, 4; VI, 4), con un aggettivo per altri (Aqua viva IV, 3; Ad aquas Albulas IV, 5; Aquas Regias V, 1/2; Aqua amara VI, 5; Aque frigide X, 4), con specifiche che possono fare riferimento al tipo di utilizzo delle acque e ad eventuali strutture presso di esse (Piscinas III, 1; Balneis IX, 3), ed ancora con il termine fons affiancato da alcuni epiteti (Fontes cal-dis I, 3; Fons camerata II, 1; Fonte Poramiano III, 2; Ad fontem felicem X, 3; fons scabore X, 3/4).
Per altre aree, per le quali è noto un termalismo diffuso testimoniato da numerose fonti e da cospicui ritrovamenti ar cheo logici, curiosamente la Tabula non ha alcun segno grafico iden-tificativo, come ad esempio l’area flegrea, nella quale concorrono tuttavia alla definizione della zona i toponimi dei centri abitati, famosi e sicuramente associati da tutti alla presenza di acque calde e alle strutture per il loro sfruttamento.
Altri siti ancora sono segnalati, oltre che dal toponimo, da una vignetta differente rispetto al tipo convenzionale; per la città di Termini Imerese (Thermis VI, 1) viene utilizzato il tipo cosid-detto “a doppia torre”24, senza dubbio quello di uso più frequente nella Tabula e di funzione anco-ra molto discussa, con grande probabilità relativo a centri di particolare importanza logistica mi-litare ed economica25 (fig. 3); per due centri della penisola e uno dell’Africa (Aquis Tatelis II, 4/526;
18 La vignetta è di dimensioni ridotte rispetto alle altre analoghe.19 La vignetta indica il sito corrispondente all’odierna Bagnara Calabra, presso la quale le fonti documenta-
no presenza di acqua termale, segnalata anche dal toponimo attuale e da quello di “Acqua calda” nelle vicinanze del centro (anDroniCo 1991, p. 180).
20 (A)quae Ri(sani?) propone il Weber nell’indice del commentario della Tabula, identificando la località con l’odierna Koper (weber 1976, p. 46).
21 Gli appellativi di Bormo o Borvio e di Nisincius o Alisincius sono relativi alla divinità di Apollo in area celto/gallica (Croon 1965).
22 martinori 1930, p. 98; reggiani 1979, p. 97, nota 10.23 Nell’ambito di un più ampio studio dei toponimi presenti nella Tabula relativi all’area veneta è stato notato
che l’elemento idrico è quello che più ha influito nella scelta dei nomi dei luoghi (malipiero 1984, p. 268).24 levi, levi 1967, p. 65.25 Per la discussione dell’interpretazione della vignetta, cfr. bosio 1983, pp. 101-110.26 Odierna Acqui Terme.
Fig. 2 - Aquae Cutiliae (Tab. Peut. IV, 4-5). Fig. 3 - Thermis (Termini Imerese) (Tab. Peut. VI, 1).
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
278 franCesCa moranDini
Aque ange VI, 127; Aquis Thibilitanis III, 128) la segnalazione viene fatta sulla carta con un disegno costituito da un edificio visto a volo d’uccello con il prospetto frontale caratteriz-zato dalla facciata principale spostata verso sinistra, con un tetto a falde molto pronun-ciato e le varianti della corte aperta per Aque Ange e Aquis Thibilitanis, in questo caso an-che con merlature perimetrali. Il disegno di Aquis Tatelis resta invece un unicum (fig. 4). Il tipo viene considerato dai Levi e dal Bo-sio tra le varianti del tipo “ad aquae”, anche se ricorre, a parte i siti di Ad taberna frigida (III, 1) con probabile presenza di acqua, e di Queri (VI, 1), in base alla lettura dei Weber,
per altri centri non termali quali, ad esempio, Vacanas (IV, 3), Ad pretorium (IV, 5), Ad horrea (V, 2), Pretorium Lauerianum (V, 3) e Syllas (V, 3)29.
In altri tre casi la vignetta ad aquae viene utilizzata priva del nome (V, 2; VI, 4; X, 2); po-trebbe forse trattarsi di stationes del cursus publicus delle quali erano note l’esistenza e la pre-senza di strutture d’accoglienza ma che non erano associate a toponimi particolari, o sfuggiti al compilatore o al copista. Il disegno ricorre infine anche per mansiones e mutationes nel cui toponimo non compare alcun riferimento alla presenza di sorgenti (cfr. colonna «Vignetta ad aquae con toponimi che non indicano la presenza di acqua» della tabella) e che quindi non do-vevano essere centri dalle caratteristiche termali (Tres Tabernas V, 130; Ad nonum V, 3; Arciade VI, 2; Oplontis V, 4/5; Ad pretorium V, 1; Mindo fl. IV, 2).
Nella Tabula non vengono invece ricordati siti termali noti nel mondo antico e citati da altre fonti quali, ad esempio, le Aquae Pisanae (menzionate da Plinio31 e identificabili con gli odierni Bagni di San Giuliano presso Pisa) e le Aquae Ceretanae (ricordate da Livio, Valerio Massimo e Strabone, riconoscibili nelle strutture rinvenute in località Poggio della Carlotta, nel comune di Cerveteri32) per ricordane solamente alcuni.
rapporto tra inDiCazione CartografiCa (vignette e toponimi), strutture termali e viabilità
Senza addentrarsi in considerazioni di ordine cronologico o relative alle proprietà terapeu-tiche delle acque o dei culti ad esse legati, queste differenze di informazioni presenti nel docu-mento hanno suggerito una verifica, limitatamente alla penisola, dell’effettiva corrispondenza tra
27 Zona termale di acque calde sulfuree presso Sambiase, in provincia di Cosenza.28 Odierna Hammam Meskoutine, in Algeria.29 Per quanto riguarda il sito di Aquis Tatelis, alla luce dei dati emersi da scavi recenti relativi ad un edificio
interpretabile come emporio e riconducibile ad una committenza pubblica in ragione della monumentalità delle strutture e della qualità degli ornati, la Antico Gallina ritiene che la vignetta sia da riferirsi principalmente alla struttura dell’emporio più che agli impianti termali del sito; il disegno cartografico sembra inoltre presentare forti analogie con le strutture dell’horreum, con un piano superiore e numerose aperture lungo i lati, identificabili con i porticati di questo (antiCo gallina 1990).
30 Il sito costituiva un importante luogo di tappa lungo la via Appia (malipiero 1984, p. 265; Crogiez 1990, pp. 102-103).
31 plin. nat. 227.32 liv. 22 1, 10; val. max. 1 6, 5; strabo 5 2, 3. Per la descrizione delle strutture, databili tra la prima età imperiale
ed il III secolo d.C. cfr. Cosentino, sabbatini tumulesi 1989; Cosentino, sabbatini tumulesi 1991; Cosentino, sabbatini tumulesi 1992; sapelli ragni, mari 2011, p. 285.
Fig. 4 - Aquis Tatelis (Acqui Terme) (Tab. Peut. II, 4-5).
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
le aCque termali nella tabula peutIngerIana 279
vignetta, toponimo e strut-ture termali, tenendo pre-sente il criterio pratico con il quale era stata redatta la car-ta di età romana, che privile-gia soprattutto l’aspetto del-la viabilità e delle strutture lungo il cursus publicus.
Infatti, coerentementecon l’obiettivo di pratici-tà che ne ha determinato la stesura, nella carta sono sta-ti omessi, probabilmente anche per non infittire ec-cessivamente il disegno con annotazioni non necessarie, numerosi altri elementi che dovettero comunque carat-terizzare il paesaggio antico, ma che non si trovavano in prossimità del percorso viario o che per loro natura non dovevano essere di particolare utilità per chi viaggiava.
Ad esempio, l’assenza di alcuni siti, tra i quali proprio quelli dell’area termale euganea, può essere attribuibile alla selezione dei dati da riportare nella carta in relazione al percorso viario, in particolare alla facilità di raggiungimento senza divagazioni di troppe milia dall’asse di percorren-za principale (fig. 5). Sulla Tabula infatti per l’area veneta vengono segnalate la via litoranea, co-stituita dal sistema Popilia-Annia33, e la cosiddetta Claudia Augusta Padana34, trascurando altre direttrici intermedie grazie alle quali era possibile raggiungere gli impianti aponensi. È noto infat-ti che per Abano e Montegrotto, oltre ad altre direttrici di raggio ridotto, passava la via stesa nel 175 a.C. dal console Emilio Lepido tra Bologna ed Aquileia, lungo la quale, in prossimità di que-sti centri, furono effettuati numerosi rinvenimenti ar cheo logici, tra i quali anche iscrizioni e mo-numenti funerari ad indicare l’importanza di questo percorso e la sua frequentazione35.
L’assenza della menzione di altri siti potrebbe essere dovuta al fatto che essi, al momento della redazione della carta, riconducibile come già detto alla seconda metà del IV secolo d.C., non erano più attivi o ne era cessato lo sfruttamento e furono quindi tralasciati; questa possibilità risulta pur-troppo difficilmente verificabile e non sembra essere in linea comunque con la tendenza, riscon-trata in altri loci della Tabula, a ricordare luoghi ed elementi naturali che al momento della stesura non dovevano avere più grande importanza se non nella memoria storica del cartografo, oppure dovevano essere presenti nelle fonti utilizzate e meccanicamente trascritti da esso36.
Alla luce di tanta varietà di indicazioni, emerge la difficoltà di individuare un criterio unico utilizzato nella stesura del documento; anzi, sembra molto probabile che ad un criterio omogeneo sia stato preferito un adattamento alle esigenze cartografiche delle specificità delle singole situa-zioni, di cui è noto, nel caso di complessi termali, l’ampio spettro di caratteristiche sia dal punto
33 bosio 1991, pp. 59-81.34 Per questa direttrice, cfr. da ultimo il contributo di Stefania Pesavento Mattioli (pesavento mattioli 1998). 35 bosio 1991, p. 35; lazzaro 1981, pp. 81-85; cfr. lazzaro 1983, pp. 53-57, che menziona la strada come
Patavium-Bononia; zanovello 2011, pp. 218-219.36 Si vedano ad esempio i casi del fiume Rubicone, riconducibile ad un testo geografico di alta datazione
utilizzato nella stesura della Tabula, o del fiume Arsia, la cui importanza era senza dubbio legata alla funzione di confine della Regio X nella divisione augustea e non certo al segno lasciato da questo modesto fiume nel territorio (bosio 1991, p. 157 e note).
Fig. 5 - La zona termale euganea (Tab. Peut. III, 4).
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
280 franCesCa moranDini
di vista idrico, sia archi-tettonico, sia cultuale.
In ragione delle dif-ficoltà di resa cartografi-ca e quindi della selezione delle informazioni a fa-vore della chiarezza e im-mediatezza del documen-to, può ad esempio essere giustificata l’assenza della vignetta per indicare l’im-pianto delle Aquas Albu-las, lungo la via Tiburti-na37 (fig. 6); infatti questa stazione si trova in pros-simità della personifica-zione della città di Roma, dalla quale si dipartono a raggiera tutte le principa-li strade del sistema viario romano e che per il carto-grafo costituiscono ele-mento di primaria impor-
tanza, essendo il tematismo dominante della Tabula. Con i segni fitti che indicano le arterie viarie e i nomi che le accompagnano venne occupato praticamente tutto lo spazio intorno al capoluogo, costringendo chi stese la carta ad una drastica riduzione delle informazioni disegnate; oltre alla vi-gnetta relativa a queste terme mancano infatti anche quelle relative ad altri insediamenti quali, ad esempio, Nomento (IV, 5) (Nomentum) e Fidenis (IV, 5) (Fidenae), segnalati solo con il toponimo, che in altri spazi della Tabula avrebbero avuto forse un’indicazione più completa con vignetta38.
In ambiti geografici per i quali era presente con certezza nel mondo antico una situazio-ne di termalismo diffuso, non riconducibile ad una singola sorgente di acqua calda, le modalità di segnalazione del fenomeno rispetto alla strada principale e l’utilizzo della vignetta ad aquae sembrano ancora sfuggire a regole precise, in favore di un adattamento alle singole situazioni.
Per esempio, la vignetta accompagnata dal toponimo Aquas Passaris (IV, 1), lungo la via Cassia tra Volsinas e Forum Cassii, rimanda alle sorgenti calde solforose della zona, ricordate solamente in un epigramma di Marziale39 e nel testo di un’epigrafe40 (fig. 7).
I dati ar cheo logici relativi a queste sorgenti (attualmente 14 divise in tre gruppi principali) sono piuttosto consistenti e fanno pensare ad una monumentalizzazione generalizzata delle sin-gole polle di acqua calda: oltre alle tracce di numerose strutture architettoniche visibili a tutt’og-gi e di apparati decorativi, soprattutto mosaici pavimentali, sono noti anche rinvenimenti di reper-ti mobili quali, ad esempio, ritratti, statue in marmo e manufatti in bronzo41. Il particolare nome
37 Cfr. da ultimi, per questo sito, sapelli ragni, mari 2011, pp. 289-296.38 Solamente in questo luogo della Tabula vengono riportati i nomi delle strade, a indicarne la funzione di
caput viarum all’interno dell’Impero; è chiaro quindi che questa specifica dovette comportare un’alta selezione delle altre informazioni che avrebbero dovuto essere segnalate nei dintorni della città.
39 mart. 6, 42.40 CIL XI, 3003 = ILS 5771. 41 In particolare questi reperti furono rinvenuti nel corso di scavi effettuati nel 1835 presso le cosiddette
“Terme del Bacucco” (martignoni 1979, p. 31; zei 1917, p. 167; blake 1959, p. 76; ganzert 1981, pp. 131-142;
Fig. 6 - Personificazione della città di Roma con indicate le principali strade che da essa si dipartono. La statio “ad aquas albulas” è ricordata dal toponimo lungo la via Tiburtina (Tab. Peut. IV-V).
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
le aCque termali nella tabula peutIngerIana 281
con il quale sono ricordate le acque, che non sembra riferirsi né ad un centro urbano dal quale esse potevano dipendere, né a qualche loro caratteristica specifica o elementi cul-tuali ad esse correlati, ma piuttosto ad un co-gnomen, suggerisce l’ipotesi che le sorgenti lungo la Cassia fossero non pubbliche ma di proprietà privata, e che il loro utilizzo fos-se limitato al proprietario del fundus all’in-terno del quale sgorgavano. La menzione nell’epigrafe anche di un’aquam vegetia-nam sembra infatti confermare quest’ipote-si; l’insieme delle sorgenti sarebbe poi sta-to ricordato genericamente con il nome di quella più significativa, o per il prestigioso ruolo politico del possessore, o per il mag-gior grado di monumentalizzazione che la distingueva dalle altre. Nella Tabula Peutin-geriana inoltre il toponimo riferito a que-ste acque costituisce l’unica indicazione di presenza antropica nell’area e sembra qua-si sostituire il nome dell’antica Viterbo (Sur-rena). Per quanto riguarda il rapporto con il dato viario, il Colonna osserva che per la stesura della Cassia in questa zona sembra che non siano stati tenuti in considerazione né gli abitati etruschi, né quelli romani, ma che siano stati privilegiati i nuclei sorgentife-ri, in modo tale da collegarne il maggior nu-mero possibile42. Come in altri casi analoghi risulta molto difficile stabilire se in effetti il tracciato dell’antica via venne condizionato a tal punto dalla realtà idrotermale della zona; non si può d’altra parte escludere l’ipotesi secondo la quale fu invece il tracciato della strada a costituire motivo di valorizzazione per queste sorgenti.
Per la zona della Toscana molto interessanti sono le due vignette delle Aquas Volaternas (III, 2) e delle Aque Populanie (III, 2/3), separate da un lago di forma pressoché circolare ed en-trambe collegate all’Aurelia da due strade secondarie (fig. 8); anche in questo caso con grande probabilità i disegni si riferiscono a comprensori termali di largo raggio facenti capo ai due cen-tri di Volterra e Populonia, da cui il nome alle acque. Tutta l’area è infatti ricca di sorgenti calde solforose, con resti di strutture monumentali legate all’utilizzo medico di esse; il lago tra le due vignette potrebbe fare riferimento alla zona dei “lagoni” di Larderello, ricca di spettacolari fe-nomeni naturali quali soffioni e putizze che certamente anche in età antica dovevano catturare l’attenzione di chi vi si imbatteva43.
Ancora aperto resta il problema dell’attribuzione della vignetta Aquas Apollinaris al centro di Vicarello o a quello di Bagni di Stigliano o, come sembra più probabile, ad entrambi (fig. 9). I
barbieri 1991, p. 33), identificabili secondo il Martinori con la villam Calvisanam menzionata nell’epigrafe di Nummio Nigro Valerio Vegeto (martinori 1930, p. 71). Il complesso del Bacucco sembra rimanere l’impianto di maggior rilievo nell’area individuata con la vignetta (sapelli ragni, mari 2011, p. 284).
42 Colonna 1970, pp. 41-42.43 bosio 1983, p. 98.
Fig. 7 - Aquas Passaris, lungo la via Cassia (Tab. Peut. IV, 1).
Fig. 8 - Aquas Volaternas e Aque Populanie (Tab. Peut. III, 2-3).
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
282 franCesCa moranDini
due siti presentano infatti numerose caratte-ristiche comuni quali, ad esempio, sorgen-ti di acque sulfuree calde, strutture architet-toniche relative allo sfruttamento di queste acque a scopi terapeutici e culto dedicato alla divinità di Apollo, da cui il nome delle acque, documentato da numerose iscrizio-ni votive. La differente posizione topogra-fica dei due impianti, anche se non lontani tra di loro, sembra comunque aver determi-nato un diverso tipo di utenza di queste ac-que. Le evidenze ar cheo logiche rinvenute a Bagni di Stigliano suggeriscono un uso delle sorgenti per scopi esclusivamente terapeu-tici e cultuali, documentati questi ultimi da
una struttura templare, da iscrizioni e da ex voto anatomici databili tra IV secolo a.C. e II secolo d.C., offerte di frequentatori di modeste condizione economiche e probabilmente locali, concen-trati prevalentemente in età protostorica44. Ben diversa è la situazione di Vicarello, sulle sponde del lago di Bracciano e nei pressi della via Claudia. Le strutture rinvenute sembrano riconducibili ad un impianto molto articolato, con ambienti e spazi dalle funzioni specifiche, sicuramente tera-peutiche e cultuali, ma anche in relazione con altre pratiche che spesso hanno luogo presso i cen-tri termali45. Le strutture stesse e alcuni bolli presenti sui laterizi rinvenuti suggeriscono un floruit architettonico dell’impianto nella seconda metà del I secolo d.C., riconducibile forse all’interven-to dell’imperatore Domiziano; l’epiteto domitianae riferito alle ninfe in un’iscrizione votiva tro-vata presso queste acque rende plausibile infatti questa ipotesi46.
La stipe votiva rinvenuta nel 1852 presso la sorgente ha reso famose queste acque; si ricor-dano brevemente le numerose iscrizioni dedicate ad Apollo, alle Ninfe, a Silvano ed Esculapio, l’elevato numero di offerte monetali che coprono un arco cronologico dall’VIII secolo a.C. al IV d.C., e, tra il prezioso vasellame, le celeberrime 4 tazze in argento, dono di un ricco pelle-grino caditano, che recano inciso appunto l’itinerario da Cadice a Roma47. Proprio questo dono suggerisce una stretta relazione tra la strada e il centro termale, nei pressi dell’arteria principale, lungo la quale la fama di queste acque venne probabilmente diffusa, mentre la frequentazione di Stigliano, più lontano da essa, venne limitata ad un raggio più circoscritto.
Non si può comunque escludere ancora una volta che la vignetta Aquas Apollinaris facesse riferimento ai due siti, con un toponimo che li richiamasse entrambi48. A questo proposito è cal-
44 gasperini 1976, pp. 9-12, 15-34; broise, Jolivet 1991, p. 93.45 Sono stati infatti rinvenuti un ninfeo monumentale, vasche e numerose statue, oltre a spazi interpretati come
giardini o palestre (marChi 1852, p. 56; künzl, künzl 1992, p. 286; Colini 1968, pp. 45-49; Colini 1979, pp. 10-12; Chellini 2002, pp. 99-104). Da ultimi sapelli ragni, mari 2011, p. 283.
46 CIL XI, 3286. Alla luce di questa dedica e delle cronologie delle strutture alcuni studiosi ritengono che Domiziano avesse contribuito alla monumentalizzazione di queste sorgenti; l’Imperatore da alcuni studiosi è ritenuto il proprietario di una villa rinvenuta nei pressi delle acque (marChi 1852, p. 20; Colini 1968, pp. 38, 50; 1979, p. 19; künzl, künzl 1992, p. 285; guiDobalDi, angelelli 2001, pp. 360-361).
47 Per quanto riguarda i materiali della stipe, cfr. marChi 1852, pp. 7-32; panvini rosati 1968, pp. 58-61; Colini 1968, pp. 50-56; Colini 1979, pp. 17-18; taylor 1923, p. 131; torelli 1980, p. 24; künzl, künzl 1992, p. 285.
48 Per dovere di completezza si segnala che in passato due studiosi hanno cercato di risolvere il problema dell’individuazione delle Aquae Apollinares attraverso i dati toponomastici, focalizzando la loro attenzione sulla statio “ad novas” (IV, 3) riferendola alle acque sananti ed alla località di Vicarello, più recente rispetto a quella di Stigliano, sebbene il toponimo in questione sia chiaramente su di un altro asse viario rispetto alle Apollinares (garruCCi 1864; gasperini 1976).
Fig. 9 - Aquas Apollinaris (Tab. Peut. IV, 3).
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
le aCque termali nella tabula peutIngerIana 283
zante l’esempio attuale delle “Terme euganee”, denominazione generica ma a tutti chiara e facil-mente comprensibile con la quale viene designato il comprensorio termale aponense, costituito dai centri principali di Abano e Montegrotto, dalle caratteristiche molto simili.
La vignetta di Aquas tauri (IV, 3) indica invece un preciso insediamento, sicuramente svi-luppatosi intorno a sorgenti di acque calde utilizzate a tutt’oggi dagli abitanti della zona di Ci-vitavecchia. Il sito, menzionato da Plinio tra i centri romani dell’Etruria49, si trovava lungo la via Clodia, che univa la litoranea Aurelia alla zona dei rilievi della Tolfa, e sembra debba il suo nome a Statilio Tauro, generale di Augusto e consul suffectus nel 37 a.C. che, sua pecunia, pro-mosse la costruzione di numerose opere pubbliche nella zona50. I resti dell’antico centro sono da individuarsi in quelli ancora visibili in località Ficoncella, caratterizzati da strutture sia abi-tative sia relative allo sfruttamento delle acque calde; tra le varie strutture murarie è ben rico-noscibile una vasca in opera reticolata con i lati corti stondati e gradini per facilitare l’accesso al bagno51. Sulle imponenti strutture rinvenute a circa 1 km di distanza, note con il nome di “Ter-me taurine”, non è ancora univoca l’interpretazione, se si tratti di un impianto di uso privato, forse di proprietà imperiale52, o di utilizzo pubblico53.
Ancora in un altro caso sembra univoco il riferimento della vignetta ad un centro preciso, anche se non è sempre possibile stabilire l’esatta corrispondenza tra vignetta e strutture ar cheo-logiche note. Con il disegno e il toponimo di Aque Cutillie (IV, 4/5) il cartografo volle segnalare lungo la via Salaria questo sito, importante non solo per le acque sulfuree fredde ed i laghetti da esse formate, che tanto attirarono l’attenzione degli scrittori di età romana54, ma in quanto cen-tro religioso della Sabina e sede del culto della dea Vacuna-Vittoria, operando nell’indicazione una crasi tra gli impianti relativi alle pratiche terapeutiche e quelli destinati all’uso cultuale, for-se già propria, a livello toponomastico, del mondo antico55.
Strettamente legata al dato viario potrebbe essere la ragione che ha indotto il cartografo a segnalare, di tutti i centri termali della Sicilia, solamente Sciacca con la vignetta ad aquae e il to-ponimo (Aquas Labodes VI, 1). Questo centro infatti occupava un posto di primaria importan-za per i collegamenti stradali dell’isola, costituendo il punto di partenza e di arrivo di numero-si itineraria; in Sciacca inoltre, come si evince da un’iscrizione, dovevano risiedere i magistrati preposti alla cura del cursus publicus56. L’indicazione del centro di Termini Imerese con la vi-gnetta a doppia torre (Thermis V, 1) al posto di quella convenzionale dei centri termali sembra trovare spiegazione nella diversa importanza attribuita dal cartografo al momento della stesura della Tabula alle prerogative di questo centro urbano. Il sito di Termini non viene infatti rico-nosciuto come significativo all’interno della viabilità dell’Isola per la presenza delle acque bensì come centro in sé, con una propria identità amministrativa e politica.
In altri casi, pochi in verità, l’indicazione della vignetta è stata ricondotta ad un preciso impianto; nell’area geografica che dovrebbe oggi corrispondere a quella indicata nella Tabu-la dal toponimo di Fons Timavi, sono stati individuati due edifici di notevoli dimensioni desti-nati a residenza e impianto termale, in stretta relazione fisica con il complesso sacrale dedica-
49 “...Aquenses cognomine/nomine Taurini...” plin. nat. 3, 8. 50 bastianelli 1954, p. 64; solari 1976, p. 15; gazzetti, stanCo 1990, p. 108; stanCo 1990, p. 112.51 mengarelli 1923, p. 323; blake 1973, p. 292; torelli 1973, p. 234; torelli 1980, p. 117; heinz 1986, pp. 22-27.52 Il vasto impianto, non indagato ancora completamente, risulta costituito da un nucleo più antico, databile all’età
tardorepubblicana o augustea, e da un altro più tardo, riconducibile all’età adrianea; per la descrizione del complesso e per i problemi relativi alla datazione si vedano mengarelli 1923; bastianelli 1942; bastianelli 1954, pp. 67-82; bastianelli 1961; bastianelli 1985; torelli 1980, pp. 116-117; broise, Jolivet 1991, pp. 92, 95; steingräber 1999, pp. 67-68.
53 yegül 1992, pp. 112-116; Chellini 2002, pp. 89-93; sapelli ragni, mari 2011, pp. 285-286.54 varro l.l. 3, 12 e V, 71; vitr. 8 3, 5; strabo 5 3, 1; sen. nat. 3, 25, 8; Celsus 4, XII; plin. nat. 3, 109 e 31, 10
e 59; svet. Vesp. 24; maCr. Sat. 1, 7, 28.55 Da ultimi sapelli ragni, mari 2011, p. 286.56 CIL X, 7200.
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
284 franCesCa moranDini
to a Diomede-Timavo sulla collina che sovrasta le risorgive del fiume, tanto da poter esserne considerato uno degli annessi57 (fig. 10). La pla-nimetria inoltre di uno dei due edi-fici, di forma a P con spazio centrale scoperto, presenta forti analogie con l’edificio riprodotto nella Tabula58.
A parte il caso unico e per ora isolato di Fons Timavi, emerge con evidenza dalla rassegna delle situa-zioni proposte che anche la vignet-ta cosiddetta ad aquae doveva esse-re un simbolo cartografico, come i molti altri che ricorrono nella Tabu-la, lontani dal riprodurre fedelmente
edifici specifici, ma richiamando, tramite alcuni particolari, un’ampia categoria facilmente rico-noscibile da chi doveva avvalersi per necessità di documenti di questo tipo.
A fronte di tanta varietà di situazioni, sia disegnative sia effettive, è possibile affermare che questo tipo di disegno poteva svolgere una funzione polivalente; doveva senza dubbio fungere da richiamo per la presenza di una particolare caratteristica idrografica e nella maggior parte dei casi indicare acque termali.
Il posizionamento della vignetta da parte del cartografo rispetto all’asse viario e rispetto al luogo che doveva essere indicato sembra rispondere di volta in volta a criteri differenti deter-minati dalle singole situazioni: la segnalazione poteva infatti essere in corrispondenza di centri abitati, il cui nome veniva talora omesso, o lungo la strada principale, mentre le sorgenti pote-vano anche trovarsi in posizione leggermente discosta dalla via, ma ben collegata ad essa. All’e-conomia generale della stesura si devono inoltre ascrivere, come si è visto, una selezione dei dati riportati nella Tabula e l’impiego di una sola vignetta per riassumere situazioni di termalismo diffuso, in modo tale che non fosse necessario ricorrere ad una pluralità di segni appesantendo la resa cartografica.
riassunto
Nel contributo vengono prese in considerazione le vignette cosiddete “ad aquas” della Tabula Peu-tingeriana (copia medievale di un originale del IV secolo d.C.), per verificarne il significato carto-grafico, il rapporto con l’effetiva presenza di acque salutifere ed eventuali strutture termali e, infine, con il sistema viario di età romana.
abstraCt
The paper is dedicated to the pictures socolled “ad aquas”, draw in the Tabula Peutingeriana, a medieval copy of an original map dated on 4th Century AD. A brief survey about their number and their significance allows to understand the relation between the pictures and the presence of thermal springs, of thermal building and, at last, their relationship with the ancient road system.
57 marChiori 1984, pp. 80-82. Cfr. da ultima veDalDi iasbez 1994 con bibliografia.58 marChiori 1982. Cfr. da ultimi ventura, Casari 2011.
Fig. 10 - Fonte Timavi (Tab. Peut. III, 5).
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
le aCque termali nella tabula peutIngerIana 285
bibliografia
anDroniCo e. 1991, La viabilità romana nel territorio dell’odierna Calabria, in Viae publicae romanae, Roma, pp. 177-181.
antiCo gallina m. 1990, La vignetta di Aquae Statiellae (Aqui terme, Al.) nella Tabula Peu-tingeriana: un’ipotesi interpretativa, in CivPad, III, pp. 9-18.
Aquae patavinae 2011 = Aquae patavinae. Il termalismo antico nel comprensorio euganeo e in Italia, Atti del I Convegno Nazionale (Padova, 21-22 giugno 2010), a cura di M. Bassani, M. Bressan, F. Ghedini, Antenor Quaderni 21, Padova, 2011.
arnauD p. 1993, L’itinéraire d’Antonin: un témoin de la littérature itinéraire du Bas-Empire, in GeoAn, II, pp. 33-49.
barbieri G. 1991, Visita alle zone ar cheo logiche del territorio viterbese. Itinerario 1 e 2, in Vi-terbo e il suo territorio, a cura di G. Barbieri, Roma, pp. 28-42.
bastianelli S. 1942, Nuove esplorazioni eseguite nelle Terme Taurine (Civitavecchia), in NSc, pp. 235-252.
bastianelli S. 1954, Centumcellae (Civitavecchia), Castrum Novum (Torre Chirauccia), Regio VII Etruria, Italia romana: municipi e colonie, serie I, vol. XIV, Roma, pp. 18-82.
bastianelli S. 1961, Le Terme Taurine, in Civitavecchia. Pagine di storia e di ar cheo logia, a cura dell’Associazione Archeologica Centumcellae, Civitavecchia, pp. 24-37.
bastianelli s. 1985, Le Terme Taurine, Civitavecchia.blake M.E. 1959, Roman construction in Italy from Tiberius through the Flavians, Washington.blake M.E. 1973, Roman construction in Italy from Nerva through the Antonines, Philadelphia.bosio L. 1983, La Tabula Peutingeriana: una descrizione pittorica del mondo antico, Rimini.bosio l. 1991, Le strade romane della Venetia e dell’Histria, Padova.broise h., Jolivet v. 1991, Le bain en Ètrurie à l’époque ellenistique, in Les Thermes romaines,
Actes de la table ronde organisée par l’École française de Rome, Roma, pp. 79-95.Caere 1990 = Caere ed il suo territorio. Da Agylla a Centumcellae, Roma.Calzolari m. 1996, Introduzione allo studio della rete stradale dell’Italia romana: l’Itinera-
rium Antonini, in MemLinc, s. IX, volume VII, fascicolo 4, Roma.Chellini R. 2002, Acque sorgive salutari e sacre in Etruria (Italiae Regio VII). Ricerche ar cheo-
logiche e di Topografia antica, BAR International Series 1067, Oxford.Coarelli f. 1984, Lazio, Guide ar cheo logiche Laterza, Roma-Bari.Colini a. m. 1968, La stipe delle acque salutari di Vicarello. Notizie sul complesso della scoper-
ta, in RendPontAc, s. III, XL, pp. 35-56.Colini a. m. 1979, Vicarello. La sorgente termale nel tempo, Roma.Colonna e.g. 1970, Castel d’Asso, Sancasciano Val di Pesa.Cosentino r., sabbatini tumulesi p. 1989, L’edificio termale delle Aquae Caeretanae, in Mi-
scellanea ceretana, 1, pp. 95-112.Cosentino r., sabbatini tumulesi p. 1991, Cerveteri (Roma). Località Piano della Carlotta.
Aquae Caeretanae. Il sito e le terme. Novità epigrafiche dalle Aquae Caeretanae, in BA, VII, pp. 75-82.
Cosentino r., sabbatini tumulesi p. 1992, Il complesso termale di Aquae Caeretanae, in Pa-pers of the Fourth Conference of Italian Archaeology, 3-4. New developments in Italian Archaeology (London, 2nd-5th January 1990), a cura di E. Herring, R. Whitehouse, J.B. Wilkins, London, pp. 17-22.
Crogiez S. 1990, Les stations du cursus publicus de Rome à Terracine, in La via Appia. Decimo incontro di studio del comitato per l’ar cheo logia laziale, in Quaderni del centro di studio per l’ar cheo logia etrusco-italica, 18, Roma, pp. 95-103.
Cuntz o. 1929, Itineraria romana, I, Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense, Lipsia.
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
286 franCesCa moranDini
ganzert J. 1981, Einige Beobachtungen am Thermensaal von Bacucco bei Viterbo, in AA, 96 pp. 131-142.
garruCCi r. 1864, Dissertazioni ar cheo logiche di vario argomento, Roma.gasperini l. 1976, Scoperte ar cheo logiche a Stigliano (Canale Monterano), in Quaderni della
Forum Clodii, Catalogo della mostra, Bracciano.gazzetti G., stanCo E.A. 1990, Il popolamento in età romana, in Caere 1990, pp. 104-108.guiDobalDi f., angelelli C. 2001, I sectilia pavimenta come indizio della funzione: i casi delle
“Terme Taurine” e dei “Bagni di Vicarello”, in Atti dell’VIII Colloquio dell’Associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico (Firenze, 21-23 febbraio 2001), a cura di F. Guidobaldi, A. Paribeni, Ravenna, pp. 355-368.
heinz w. 1986, Die “Terme Taurine” von Civitavecchia - ein römisches Heilbad, in Antike Welt 17, 4, pp. 22-43.
künzl e., künzl s. 1992, Aquae Apollinares/Vicarello (Italia), in Les eaux thermales et les cul-tes des eaux en gaule et dans les provinces voisines, Actes du colloque (28-30 septembre 1988), a cura di R. Chevallier, pp. 285-286.
lazzaro l. 1981, Fons Aponi. Abano e Montegrotto nell’antichità, Abano Terme.lazzaro l. 1983, Le terme d’Abano nell’antichità, in Per una storia di Abano Terme, I, Dall’età
preromana al Medioevo, a cura di B. Francisci, Abano Terme, pp. 46-106.levi A., levi M. 1967, Itineraria picta. Contributo allo studio della Tabula Peutingeriana, Roma.malipiero M. 1984, Mansiones e Mutationes nella Venetia romana, in AVen, VII, pp. 261-283.marano Y.A. 2011, Variae 2, 39. Cassiodoro e Fons Aponi, in Aquae patavinae 2011, pp. 195-208.marChi g. 1852, La stipe tributata alle divinità delle Acque Apollinari, Roma.marChiori A. 1979-1980, Fonti termali e acque salutifere nella Venetia romana, tesi di laurea,
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, rel. Prof. L. Bosio.marChiori A. 1982, Le terme romane di Monfalcone. Localizzazione del centro termale, in
AquilNost, 53, pp. 102-128.marChiori a. 1984, le acque salutifere della Venetia: l’utilizzazione razionale di una risorsa,
in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Il caso veneto, Modena, pp. 74-84.
martignoni a. 1979, Le antiche terme viterbesi, in Viterbo e le sue acque termali, Viterbo, pp. 22-37.
martinori e. 1930, Via Cassia (antica e moderna) e sue deviazioni, Roma.mengarelli R. 1923, Civitavecchia. Scavi eseguiti nel 1922 nelle “Terme Taurine” o “Trajane”,
in NSc, pp. 321-348.peréx agorreta m.J., roDriguez morales J. 2001 Las stationes con aquae... en la Tabula de
Peutinger, in Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Nueva época. Prehistoria y arqueología, t. 4, pp. 153-170.
panvini rosati f. 1968, Monete della stipe di Vicarello nel Museo Nazionale Romano, in RendPontAcc, s. III, XL, pp. 57-62
pesavento mattioli S. 1998, La strada della valle dell’Adige da Verona a Trento e il problema della via Claudia Augusta, in Tesori della Postumia. Ar cheo logia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell’Europa, Catalogo della mostra (Cremona, 4 apri-le-26 luglio 1998), a cura di G. Sena Chiesa e M.P. Lavizzari Pedrazzini, Milano, pp. 263-265.
pettenò e. 1992-1993, Acque salutifere e fonti naturali dell’Africa romana, tesi di laurea, Uni-versità degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, rel. Prof. E.F. Ghe-dini.
pettenò e. 1998, Le Aquae e le terme curative dell’Africa romana, in Antiquités africaines, 34, pp. 133-148.
reDDiti S. 1997, Le testimonianze letterarie antiche sul bacino termale euganeo, in Delle antiche
Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo
le aCque termali nella tabula peutIngerIana 287
terme di Montegrotto. Sintesi ar cheo logica di un territorio, Montegrotto Terme, pp. 15-19.reggiani A.M. 1979, Le terme di Cotilia, in ArchLaz, II, pp. 91-98.rigoni a.n. 1982, La Venetia nella Cosmographia dell’Anonimo Ravennate, in AVen, V, pp.
207-234.sapelli ragni m., mari z. 2011, Il termalismo terapeutico antico nel Lazio. Stato della ricerca
ed esemplificazioni, in Aquae patavinae 2011, pp. 281-296.sChnetz J. 1940, Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, Lipsia.solari A. 1976 (1915-1920), Topografia storica dell’Etruria, Roma.stanCo E.A. 1990, Amministrazione ed assetto del territorio in età romana, in Caere 1990, pp.
109-112.steingräber S. 1999, La villa romana di Cazzanello presso Tarquinia e la costiera etrusco-la-
ziale, in Le ville romane dell’Italia e del Mediterraneo antico, Academic Meeting at the University of Tokyo (Tokyo, 13-15 november 1996), a cura di M. Aoyagi, S. Steingräber, Tokyo, pp. 52-71.
taylor l.r. 1923, Local cults in Etruria, in Papers and monographs of the american Academy in Rome, II, pp. 130-145.
torelli m. 1973, Civitavecchia (Centumcellae), in EAA, III, pp. 233-235.torelli m. 1980, Etruria, Guide ar cheo logiche Laterza, Roma-Bari.veDalDi iasbez v. 1994, La Venetia orientale e l’Histria. Le fonti letterarie greche e latine fino
alla caduta dell’impero Romano d’Occidente, Roma.ventura p., Casari p. 2011, Un caso di termalismo dell’agro aquileiese. Le terme di Monfalco-
ne, riletture e nuovi dati, in Aquae patavinae 2011 pp. 245-259.weber e. 1976, Tabula Peutingeriana. Codex Vindobonensis 324, Graz.zei C. 1917, Le terme romane di Viterbo, in BA, XI, pp. 155-167.yegül F. 1992, Bathing in the Roman World, New-York.zanelli C., rizzi a., mantovanelli L. 2012, Acque e siti termali nell’Italia romana. Le testi-
monianze degli autori antichi, in Aquae patavinae. Montegrotto Terme e il termalismo in Italia. Aggiornamenti e nuove prospettive di valorizzazione, Atti del II Convegno Na-zionale (Padova, 14-15 giugno 2011), a cura di M. Bassani, M. Bressan, F. Ghedini, An-tenor Quaderni 26, Padova, pp. 365-377.