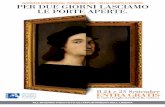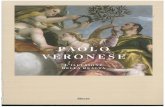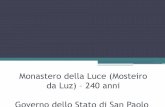Un figlio per due madri: Paolo Veronese e il tema del Mosè salvato dalle acque, in "Paolo Veronese....
-
Upload
independentresearcher -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Un figlio per due madri: Paolo Veronese e il tema del Mosè salvato dalle acque, in "Paolo Veronese....
© 2016 lineadacqua edizioni srl© 2016 Fondazione Giorgio Cini onlus isbn 978-88-95598-53-6
RedazioneChiara Ceschi, Silvia Bandolin
Progetto grafico e impaginazioneMadSans
lineadacqua edizioni srlSan Marco 3716/b30124 Venezia
FoNTI E ISPIRAZIoNI
3 Veronese e l’arte classica: riletture antiche e moderne, Alessandra Zamperini15 The Genesis of Inspiration: Veronese’s Early Look at Parmigianino,
Beverly Louise Brown25 Veronese e Roma: fonti, spunti documentari, indizi stilistici, Vittoria Romani39 Il programma iconografico della Sala del Collegio: un disegno inedito di Veronese,
Martin Gaier
CREAZIoNE SIGNIFICATo, PARTE I
55 Qualche riflessione sul colorito di Veronese, Michel Hochmann67 L’“Ultima Cena” di Veronese, il “Galateo”, Giovanni della Casa e l’Inquisizione,
Andrew John Martin79 Un figlio per due madri: Paolo Veronese e il tema del Mosè salvato dalle acque,
Claudia Terribile
CREAZIoNE SIGNIFICATo, PARTE II
91 Invenzioni di linguaggio, ragioni di significato, Augusto Gentili101 Ars adulandi: Veronese and the rivalry with Titian and Tintoretto, Benjamin Paul111 Drafting Characters: Action and Enactment in Veronese’s Creative Process,
Giorgio Tagliaferro
PERCoRSI CoLLEZIoNISTICI
125 Veronese in the Collection of the 2nd Marquess of Stafford, Peter Humfrey137 I Veronese degli Asburgo, Francesca Del Torre Scheuch
TEATRo E ARCHITETTURA
151 Paolo Veronese e il teatro: i disegni per i costumi dell’“Edipo tiranno”, Xavier F. Salomon165 “Sier Paulo Veronese” in casa di Vincenzo Zeno “sopra le fondamenta de Crozachieri”,
Lionello Puppi175 Veronese’s Painted Architecture Vocabulary and Application, David Hemsoll
SoMMARIo
bisogna scrivere con il contributo di ?con il patrocinio?
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell’editore.
Con il patrocinio del Dipartimento di Culture e Civiltà
7978
Tra i soggetti sacri affrontati in maniera seriale da Paolo Veronese e dalla sua bot-tega si contano ben dieci versioni del Mosè salvato dalle acque, tutte databili agli anni ottanta. I formati e le dimensioni variano molto: si spazia dai 58 × 44,5 cm delle tele “gemelle” del Prado e di Washington (fig. 1), ai 337 × 510 cm della mo-numentale versione della Sabauda (fig. 2), passando per diversi formati interme-di, da quello quadrangolare e rettangolare da cavalletto al grande telero (fig. 3). Questi ultimi, pur presentando una maggior quantità di dettagli paesaggistici e narrativi, replicano sostanzialmente l’impostazione delle tele di minor formato (unica eccezione il dipinto di Torino). Con una certa versatilità, Veronese adatta il soggetto sia all’arredo di alcove e studioli sia a quello di principeschi saloni di rappresentanza, declinandolo in diversa scala e in contesti esclusivamente privati e domestici.
Passando in rassegna l’iconografia del soggetto, si può constatare che non sono molti i cicli narrativi che includono anche questo episodio del libro dell’Esodo, poiché di norma prediligono la vita adulta di Mosè. Tra i pochi contesti pubblici in cui troviamo un riferimento alla sua infanzia, possiamo cita-re il ciclo musivo dell’atrio della basilica di San Marco (1270-1280), l’affresco tre-centesco di Roberto d’oderisio all’Incoronata di Napoli1 e poi, nel Cinquecento, Raffaello alle Logge Vaticane. Passando alla committenza privata, restando però sempre alla dimensione narrativa, ricordiamo le Storie di Mosè dipinte da Pro-spero Fontana in Palazzo Poggi a Bologna (1556) e il ciclo di Brusasorci, Farinati e Canera (1584) in Palazzo Ridolfi a Verona2. La particolare diffusione del sog-getto come episodio autonomo e a sé stante si registra proprio nell’area veneta a partire dagli anni quaranta del Cinquecento con la produzione di Bonifacio Veronese e della sua bottega, su diversi pannelli di cassone (fig. 4), oltre che nel
1. Vitolo 2008.2. Bertolaso 2013.
UN FIGLIo PER DUE MADRI PAoLo VERoNESE E IL TEMA DEL MoSè SALVATo DALLE ACQUE Claudia Terribile
1.
2.
1. Paolo Veronese, Mosè salvato dalle acque. Washington, National Gallery of Art
2. Paolo Veronese, Mosè salvato dalle acque. Torino, Galleria Sabauda
8180
grande telero oggi conservato a Brera. Veronese è di fatto il primo a portare alla ribalta con tanta insistenza il soggetto isolandolo dalla logica del ciclo narrativo3.
Pur nelle diversità di impostazione e concezione delle scene, e nonostante lo scarto dalla dimensione narrativa a quella iconica, c’è in ogni caso una caratteristica che accomuna tutta la tradizione iconografica. Sia che si osservino le opere appena citate, o l’antico affresco nella sinagoga di Dura Europos (fig. 5), le miniature dei codici medievali, o le eleganti tele di orazio Gentileschi, emerge con estrema chia-rezza che questo è un soggetto tutto declinato al femminile e che non Mosè, ma le donne che di lui si prendono cura sono le indiscusse protagoniste della scena. A loro dobbiamo rivolgere la nostra attenzione e i nostri sguardi.
Come accade per ogni eroe che si rispetti, anche Mosè ha un’infanzia ecce-zionale e avventurosa, che traccia tuttavia una parabola inversa rispetto a quella di molti personaggi della storia e della leggenda. Non nasce re per esser poi adottato da umili pastori o contadini, ma, al contrario, venuto al mondo in una semplice e modesta famiglia ebrea, viene adottato dalla figlia del faraone d’Egitto, sfuggendo alla persecuzione che lo stesso aveva ordinato per ogni maschio ebreo nato nella sua terra (Es 2,1-10).
Vedendo crescere e prosperare i figli di Israele, nonostante la schiavitù e i lavori forzati cui aveva costretto gli ebrei, il faraone ordinò infatti alle ostetriche di ucci-dere al momento del parto ogni figlio maschio. Ma le levatrici, con un coraggioso atto di ‘disobbedienza civile’ e una casta bugia per mascherarlo, si rifiutarono di es-sere ambasciatrici di morte. Il sovrano intimò allora a tutto il suo popolo di gettare nel fiume ogni bambino ebreo4. La madre di Mosè, dopo aver nascosto il figlio per tre mesi e non potendo occultarlo oltre, prepara una cesta spalmandola di pece e bitume e lì lo adagia prima di abbandonarlo alle acque del fiume (una pratica co-mune a molte altre leggendarie storie di abbandono coatto, da quella del re Sargon ai gemelli Romolo e Remo). La cesta, seguita nel suo percorso lungo le acque dalla sorella del bimbo, viene avvistata dalla figlia del faraone che stava prendendo il bagno nel Nilo con le sue ancelle.
Essa vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a pren-derlo. 6 L’aprì e vide il bambino: ecco, era un fanciullino che piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «È un bambino degli Ebrei». 7 La sorella del bambino disse allora alla figlia del fa-raone: «Devo andarti a chiamare una nutrice tra le donne ebree, perché allatti per te il bambino?». 8 «Va’», le disse la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. 9 La
3. La bottega di Paolo realizzò anche un ciclo con cinque Storie di Mosè, che nel Settecento era conservato nella villa medicea di Poggio a Caiano (Chiarini 2010).
4. Es 1,15-20. Per la “disobbedienza” delle ostetriche, origene 1991, pp. 53-58; Agostino, La men-zogna, 5, 2; una riflessione sul loro coraggio anche in Esposito 2013.
claudia terribilecreazione significato / i
3.
4.
5.
3. Paolo Veronese e bottega, Mosè salvato dalle acque. Digione, Musée des Beaux-Arts
4. Bonifacio Veronese (attr.), Mosè salvato dalle acque. Ubicazione ignota
5. Mosè salvato dalle acque. Damasco, Museo Nazionale
8382
figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allatta-lo per me; io ti darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò. 10 Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli divenne un figlio per lei ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l’ho salvato dalle acque!».
Mosè viene quindi accolto e preparato alla sua nuova vita nella segreta intimità di un gineceo. Per quanto tipologicamente egli sia una prefigurazione di Cristo e le vicissitudini della sua infanzia rimandino in parallelo alla strage degli inno-centi dalla quale analogamente si salverà il figlio di Dio, sono appunto le donne che in questo episodio creano l’interesse narrativo5. Il fulcro del racconto sta proprio in quanto da esse viene disposto nell’ameno luogo del ritrovamento, con la risolutezza e il tempismo nell’agire tipici del femminile. In un baleno, la figlia del faraone decide di adottare un figlio − peraltro ebreo − salvandolo dalla morte; ordina che sia trovata una balia in grado di allattarlo e dispone di pagarla per il servizio offerto. Il piccolo Mosè in tutto questo si limita a subire tanta operati-va capacità di cogliere l’attimo. Ed è l’attimo paradossale in cui, pur andando a ricongiungersi per lo svezzamento con la sua vera madre, è già figlio di un’altra donna e acquisisce in virtù di questa adozione un’identità (peraltro, nessuno dei protagonisti viene presentato per nome in questa parte del racconto).
Tutti questi aspetti, già sufficientemente evidenti dalla sola lettura del rac-conto biblico, appaiono ancor più chiari sfogliando i testi di Filone Alessan-drino e di Giuseppe Flavio che, più volte tradotti e ristampati anche nel Cin-quecento, avevano aggiunto ulteriori dettagli alla storia. Gli uomini del XVI secolo sapevano anche che il faraone aveva quest’unica figlia di nome Termuti, la quale era sposata, non poteva avere figli e si crucciava assai per l’impossibi-lità di offrire al padre un erede per il regno. Il giorno in cui decise di andare al fiume a bagnarsi era per l’appunto molto contrariata da questi pensieri e una volta avvistato il bambino nella cesta, “tutta si sentì commuovere vedendolo piangere, destandosi in lei lo affetto della materna pietà non altrimenti che s’ella stessa lo avesse partorito”. Nel risolversi ad adottarlo e nelle more del migliore svezzamento presso una balia del suo stesso sangue, Filone Ebreo specifica che Termuti si finse “con donnesca astuzia” incinta, in modo che agli occhi di tutti questo figlio apparisse “non adottivo, ma proprio suo”6.
Appare piuttosto evidente che ancor prima di scomodare le omelie di orige-ne, le leggende ebraiche, i padri della chiesa e di addentrarsi in tutte le implica-zioni esegetiche e cristologiche relative al libro dell’Esodo e alla (futura) vita di Mosè, questo episodio − soprattutto quando narrato per immagini − parli anzi-tutto di maternità; mostra donne che allattano e si curano della miglior crescita;
5. Vedi anche Yavneh 2011.6. Filone Alessandrino 1560, I, pp. 5-7.
claudia terribile
82
creazione significato / i
6.
8.
9.
7.
6. Jacopo Tintoretto e bottega, Mosè salvato dalle acque. Washington, National Gallery of Art
7. Jacob de Backer (attr.), Mosè salvato dalle acque. Londra, Sphinx Fine Art
8. Paolo Veronese e bottega, Mosè salvato dalle acque. Liverpool, Walker Art Gallery
9. William Hogarth, Mosè salvato dalla figlia del faraone. Londra, Foundling Museum
8584
10. Dopo Veronese, altro artista che mostra un evidente panneggio rigonfio sul ventre è Cavallino nel dipinto oggi a Braunschweig. Nel quadro di Liverpool vediamo anche Yochebed già pronta ad allattare, genuflessa in riva al fiume e in atto di toccarsi il seno di fronte al figlio; nella versione della Sabauda, Yochebed è direttamente la donna che con un generoso e scoperto décolleté offre alla figlia del faraone il bambino appena tolto dalla cesta. In una stampa pubblicata in Patina 1691, si dà conto di una perduta versione del soggetto a opera di Veronese (posto che l’attribuzione sia corretta), in cui vediamo la madre/balia allattare Mosè direttamente in riva al fiume.
11. Nichols-Wray 1935, pp. 20-21. Il sigillo, disegnato dallo stesso Coram, è pubblicato anche in Bowers 1996, p. 8.
fronde di due sinuosi alberi, fanno da cornice al raccolto gineceo disposto in un ventaglio che procede dall’inserviente di colore sulla sinistra al nano sulla destra, entrambi ben segnalati dal colore arancio delle vesti. Tra questi estremi gradi del-la scala gerarchica (non ci sono altri uomini, e quelli presenti sono per l’appunto dei subalterni), premurose e solerti ancelle sono impegnate a mostrare il piccolo Mosè alla figlia del faraone, qui per l’occasione raffinata nobildonna veneziana in abiti di broccato e ornamenti di perle. Il bimbo viene offerto alla sua vista nudo, appena prelevato dalla cesta, con la nuca rivolta verso lo spettatore, a significare efficacemente l’uscita da quel fiume/fonte battesimale che gli guadagnò il nome di “salvato dalle acque”. La nutrice sta per avvolgerlo premurosamente in un telo e lui rivolge lo sguardo a colei che tra breve sarà la sua nuova madre, pronto a ricevere nuove vesti e la sua nuova identità.
A guardar bene, la posa della nobildonna evoca proprio il tipico atteggiamento di una donna incinta, la mano sul fianco, il ventre leggermente prominente (en-fatizzato dalla fascia che lo adorna e ne sottolinea la rotondità), il braccio sulle spalle di un’ancella quasi a cercare equilibrio e a sorreggersi. Il richiamo visivo, se si isola la figura, va immediatamente alla celebre Madonna del parto di Piero della Francesca. A eccezione del dipinto della Sabauda, il dettaglio della veste rigonfia e dell’asse del corpo fuori baricentro viene ripetuto in tutte le versioni e reso con maggior enfasi in quella di Liverpool (fig. 8), che sembra letteralmente illustrare il deliquio provato da Termuti alla vista del fanciullo nei termini descritti da Filone Ebreo: un parto desiderato al punto da essere contestualmente vissuto in quel for-tuito momento. E per ritrarre quest’istantanea, Veronese gioca con le movenze del corpo e il panneggio delle vesti per dar conto con estrema intelligenza figurativa di questa gravidanza non portata e provvidenzialmente ricevuta in dono10.
Per dirla con le parole di Thomas Coram, poteva essere un soggetto partico-larmente adatto a un istituto per orfani, “Moses being the first Foundling we read of”. E infatti, considerandolo come il primo e il più illustre archetipo del trovatello, Coram volle per l’appunto un ritrovamento di Mosè sul sigillo del Foundling Ho-spital di Londra, da lui fondato nel 173911. Qualche anno dopo, Francis Hayman e William Hogarth decorarono gli ambienti dell’orfanotrofio con due dipinti di analogo soggetto che ancora oggi si trovano nel loro originario contesto. Nel Mosè salvato dalle acque di Hayman è interessante la compresenza di Termuti e Yoche-bed sulla sponda del fiume, entrambe sedute. L’ancella esce dall’acqua con il
claudia terribile
7. “The two Hebrew midwives were Jochebed, the mother of Moses, and Miriam, his sister” (Ginzberg 2013, p. 446). Sull’origine e l’evoluzione della storia della nascita di Mosè, Cohen 1993. In Borsetto 2003-2004, una ricognizione dei midrashim relativi alla nascita di Mosè.
8. La sposa madre costretta a scegliere tra l’adempimento del dovere coniugale e il nutrimento del figlio (nel periodo dell’allattamento, per garantire un latte puro e incontaminato ci si do-veva astenere dai rapporti), spesso affidava quest’ultimo a una balia che si votava a castità (e il contratto veniva stipulato con suo marito). L’astinenza dei più poveri facilitava dunque la sessualità dei più ricchi e la loro ricerca di un erede (Muzzarelli 2003, cap. 6). Sul baliatico, anche Sandri 1991.
9. Della plurisecolare tradizione critica in proposito, cito da ultimo solo il catalogo della mostra di Sarasota: “Veronese treated the religious subject with a decidely secular flair, offering a profusion of profane detail. […] The biblical narrative seems simply to have provided Veronese with a pretext for evoking the splendor and pleasures of courtly life” (Brilliant 2012b, p. 138).
racconta di scampato infanticidio e di salvezza, di pacifica e costruttiva reazione femminile alle distruttive imposizioni degli uomini. Così come le ostetriche Si-fra e Pua (secondo alcune leggende ebraiche identificabili in realtà nelle stesse figure della madre e della sorella di Mosè7) rifiutarono di uccidere i primogeniti maschi mentendo al faraone, anche Termuti “ebbe compassione” di questa crea-tura consegnatagli dal destino e seduta stante scelse di farne l’unico erede di chi lo avrebbe in realtà voluto morto.
Se di scena “di genere” non si trattasse, difficilmente potremmo giustificare immagini come quella di Tintoretto oggi a Washington (fig. 6), che ci offre un’ef-ficace sineddoche al femminile dell’episodio. Solo due donne intorno al neonato: la madre naturale Yochebed che lo nutre al seno mentre la figlia del faraone nel suo regale abbigliamento si adopera contestualmente per allestirne al meglio la culla. Per ben tre volte nel passo dell’Esodo si ripete il verbo “allattare” e, nell’impossibili-tà di provvedere personalmente a farlo, Termuti ricorre al baliatico mercenario, che era peraltro un fenomeno capillarmente diffuso nelle società di Antico Regime8. In un interessante dipinto attribuito a Jacob de Backer (fig. 7), Yochebed compare in scena offrendo con la mano sinistra il suo seno scoperto e guarda verso Mosè che non giace più in una cesta, sebbene ancora in riva al fiume, ma già dorme beato in una regale culla, dotata di lenzuola perfettamente tirate e rincalzate.
Questo è dunque il primo orizzonte di significati che dobbiamo tenere a mente quando approcciamo il soggetto in pittura, soprattutto quando viene trattato come scena a sé stante attualizzata con abiti e costumi di un altro tempo, destinata a palazzi privati e non a cicli narrativi all’interno di luoghi sacri. In particolare per Ve-ronese, sarà necessario prendere definitivo congedo dall’idea di trovarci al cospetto di amene scampagnate utili solo a illustrare la grazia e il piacere tutto profano della vita di corte9. osserviamo, due esempi per tutti, i dipinti del Prado e di Washin-gton, le prime tra le molte realizzate da Paolo e dalla sua bottega.
Insolite e preziose miniature per un pittore maestro nei grandi formati, le due piccole tele sono davvero dei delicati gioielli, indubbiamente contraddistinti da freschezza di tono e leziosità di tocco. Un arioso paesaggio che si apre su una città nello sfondo e un cielo azzurro che occupa metà della tela, percorso dalle
creazione significato / i
8786
14. Gli atti del processo, risalenti al febbraio 1568, sono conservati nella Biblioteca del Museo Cor-rer di Venezia, Archivio Pisani, b. 72, fasc. 1. Una parziale trascrizione in Terribile 2009, p. 111.
15. Per i figli d’anima nel contesto veneto del XV secolo, vedi Rossi 2010. Questo l’incipit del roman-zo Accabadora di Michela Murgia, ambientato in Sardegna nella metà del secolo scorso: “Fillus de anima. È così che li chiamano i bambini generati due volte, dalla povertà di una donna e dalla sterilità di un’altra. Di quel secondo parto era figlia Maria Listru, frutto tardivo dell’anima di Bonaria Urrai”. Al contrario di quanto accade nel romanzo, per il patriziato veneziano l’eredità materiale era altra cosa e la trasmissione del patrimonio restava una priorità legata alla discenden-za dei consanguinei. Per una disamina delle dinamiche di trasferimento dei bambini dalle realtà di accoglienza – ospedali e istituti caritatevoli – alle famiglie adottive, che in età moderna si rivelano dunque dei nuclei estremamente fluidi e permeabili, si veda ora Garbellotti 2014.
16. Nel Vocabolarius utriusque iuris, Venezia, Comin da Trino, 1555 (cit. in Rossi 2010, p. 395), alla voce Adoptio si legge la seguente definizione: “Adoptio est gratuita quedam electio qua quis ali-quem sibi eligit in filium, et hoc faciunt plerumque hi qui filios habere non possunt ad ipsorum solatio. Et talis qui sic recipitur in filium dicitur adoptivus quasi a patre legittimo sic ei datur et ille qui sic eum adoptat dicitur adoptivus pater”. La versione latina dell’episodio dell’Esodo (2,10) recita così: “quem illa adoptavit in locum filii”.
tempo del matrimonio”. Aggiunge poi che il Pisani fu molto discreto nell’elargizio-ne di questa dote, per il rispetto che aveva “maxime per le sue parente gentildonne” e non volle che la notizia venisse propalata ai quattro venti14.
Al di là della veridicità o meno circa l’impegno al pagamento di tale dote da parte del Pisani, quel che emerge con evidenza da questi documenti è l’assoluta normalità del fatto che Elena fosse vissuta per i primi diciotto anni di vita in casa di una parente della madre, con il consenso e l’approvazione della medesima. Se gli eredi avessero regolarmente pagato l’ultima parte della sua dote non ci sarebbe stato il processo e questa storia non sarebbe venuta alla luce. Non era questa infatti l’ano-malia lamentata dalle carte, bensì il mancato pagamento di una dote da parte degli eredi di un genitore adottivo, viventi quelli naturali − e benestanti − della sposa.
Prendiamo quindi atto che per crescere non dei trovatelli, ma una prole di ga-rantito lignaggio, nel Veneto del XVI secolo ci si poteva tranquillamente soccorrere tra consanguinei, tenendo in casa figli di parenti che magari ne avevano troppi e li cedevano volentieri a chi ne aveva pochi o non poteva averne. In tale modalità di adozione “tra pari”, questi bambini avevano di fatto (e di diritto, come abbiamo visto nelle carte del processo Molin), quattro genitori. Le famiglie erano più aperte e ai figli naturali si mescolavano con altrettanta naturalezza questi “figli d’anima”, così come ancora oggi ancora si chiamano, anche in altre aree geografiche15. Sebbe-ne un caso isolato non faccia primavera (ma credo che un sistematico spoglio degli archivi ne farebbe fiorire molte), dobbiamo dedurne che la possibile compresenza di due madri per un solo figlio era pacificamente accettata nel sistema familiare del-la Serenissima e con ogni probabilità la spinta a conferire autonomia iconografica al tema del ritrovamento di Mosè fu favorita proprio da un simile contesto, che aveva elastiche convenzioni sociali e un diffuso concetto di genitorialità16.
Questo non significa che a ogni adozione simile a quella di Elena Molin corrispondesse una raffigurazione di un ritrovamento di Mosè, quanto piuttosto che l’auspicio dell’arrivo di un erede in una famiglia del patriziato potesse essere
claudia terribile
12. Per i tesori del Foundling Hospital vedi Nicholson 1972; in particolare per le opere di Hogarth, Paulson 1991-1993, II, cap. 13, Public Paintings e Bowers 1996, Introduzione. La consegna di Mosè bambino alla figlia del faraone dopo lo svezzamento è anche nei mosaici di Santa Maria Maggiore a Roma (432-440 d.C.).
13. Ma anche la Ca’ di Dio a Padova, i Battuti di Treviso e molte altre ancora. A Roma fu il papa a farsi garante della salute dei bambini destinati a morire annegati nel Tevere e a fon-dare l’ospedale di Santo Spirito. Sulle adozioni degli esposti e gli infanticidi, Hunecke 1997, Bianchi 2005, Presciutti 2011 e Mélanges 124-1, 2012, con particolare riguardo ai contributi di Bianchi, Garbellotti e Rossi.
bambino ed è la vera madre che mostra le braccia protese per accoglierlo. Alle cure di quella adottiva sarà affidato solo nel Mosè condotto dalla figlia del farao-ne di Hogarth (fig. 9), dove sulla sinistra vediamo i genitori Amram e Yochebed che entrano in una sala, preceduti dal piccolo Mosè, già in grado di camminare. Il fanciullo guarda la regale, bella e giovane donna seduta al suo cospetto, e mentre sua madre conta malinconicamente il denaro nel palmo della mano, egli le stringe preoccupato la veste e, come un piccolo Ercole al bivio, appare incerto se procede-re o meno verso questo nuovo, estraneo destino12.
Nell’Inghilterra del XVIII secolo, come nel Veneto del Cinquecento, molti bambini esposti trovarono salvezza presso le istituzioni caritatevoli fondate allo scopo, su tutte la Pietà a Venezia13. Ma certo i dipinti di Veronese o di Bonifacio de’ Pitati, per restare all’area geografica e temporale che ci interessa, non furono pensati per essere collocati all’interno di ospedali o istituti di carità. L’evidenza numerica di tante opere d’arte con questo soggetto destinate alle case del patrizia-to − dal quadro da cabinet, ai pannelli di cassone, al telero da portego − restituisce testimonianza di un interesse che doveva potersi circoscrivere entro quelle nobili mura domestiche in relazione a questo episodio.
Durante le mie ricerche sulla Famiglia di Dario di Veronese oggi conservata a Londra, mi sono imbattuta in un caso piuttosto interessante. Il committente del telero, il patrizio veneziano Francesco Pisani, non aveva eredi e la sua sterilità, la-mentata con rammarico anche nei testamenti, non costituiva mistero: finanche la laconica genealogia del Barbaro sotto gli estremi biografici aggiunge la lapidaria definizione “ditto capon”. Ma il Pisani e la sua consorte Marietta Molin trovaro-no modo di dispensare cure e affetto nutrendo e allevando in casa propria Elena Molin (una cugina di Marietta) dall’età di sei mesi fino al giorno delle nozze, che furono organizzate e celebrate a spese del Pisani, “festa, pasti et cose in similibus occorrenti”, dote di cinquemila ducati inclusa. Un trattamento di un certo favore, considerata l’estrazione sociale della ragazza che era figlia di un procuratore di San Marco. Accadde però che, dopo la morte del Pisani, i suoi eredi non corrisposero al marito di Elena l’ultima quota della pattuita dote. Si istituì un processo, nelle carte del quale troviamo raccontata questa storia e dove compaiono anche diverse dichiarazioni di Isabella Contarini, madre naturale di Elena: è proprio lei a specifi-care − testimonianza per noi oggi assai curiosa − che sua figlia fu “da esso m.co m. Francesco et m.ca sua consorte de mesi sei tolta per fiola et tenuta in casa fino al
creazione significato / i
88
CREAZIoNE SIGNIFICAToPARTE II
17. A livello iconografico, la scelta di raffigurare il momento dell’esposizione di Mosè invece di quella del suo ritrovamento è più rara. Esistono un’incisione di Marten De Vos, il dipinto di Poussin (oxford, Ashmolean Museum, 1654) e quello di Eustache Le Sueur (San Pietroburgo, Ermitage, 1649).
18. Già Coutts (1985) aveva messo in relazione la commissione del telero da parte di Carlo Emanuele I di Savoia con l’auspicio di avere un erede maschio a guida del suo popolo. Con ogni probabilità, le nozze del duca con Caterina d’Austria, figlia di Filippo II, preparate da lunghe contrattazioni diplomatiche e celebrate a Saragozza nel marzo 1585, costituirono l’occasione per la richiesta al Veronese del telero, che non è ricordato insieme a quelli giunti a corte nel 1582, ma presente in un inventario del 1605. Il primogenito della coppia, Filippo Emanuele, nacque nel 1586. Per le nozze, vedi Bianchi 2010, in part. pp. 47-49. Per le committenze artistiche si parta da Il Veronese 2013.
19. Ad esempio, in casa Grimani dai Servi, il soggetto era associato all’incontro di Cristo e il Cen-turione (entrambi i teleri sono oggi a Dresda). L’abbinamento in questo caso può trovare una giustificazione in relazione al tema della fede. Yochebed abbandonò fiduciosa il figlio al proprio destino, così come il centurione romano seppe credere in Cristo senza aver visto i suoi miracoli. L’esposizione di Mosè da parte di Yochebed non fu ovviamente motivata dall’intento di sba-razzarsi di un figlio indesiderato, quanto, paradossalmente, quello di preservarlo da una morte certa. Qui l’abbandono non è un’alternativa all’infanticidio (Boswell 1988, pp. 145-146). Per il tema del centurione, rimando alla mia scheda, in Verona 2014, pp. 256-257.
20. De Luca 2011, pp. 19-20. Per l’adozione nella sacra scrittura, Agostino, Discorso 51 e Contro Fausto Manicheo, III, 1-2.
raffigurato naturalmente anche in questo modo. Grazie alla sua rocambolesca nascita, la storia di Mosè era adatta a scongiurare apotropaicamente sia le even-tuali difficoltà legate al parto che la sterilità. Yochebed mise alla luce suo figlio in circostanze avverse e, pur costretta a metterne a repentaglio la vita, con fede lo abbandonò al suo destino, garantendogli di fatto la sopravvivenza17. Termuti, d’altro canto, consapevole della sua incapacità riproduttiva, riuscì inaspettata-mente a riscattarsi grazie all’impossibilità di un’altra madre di tenere il proprio figlio. Era quel che avveniva nella società di Antico Regime e la figlia del fara-one poteva ben indossare abiti moderni per poterlo raccontare. A volte anche allargando la condivisione di questo desiderio al futuro padre, come testimo-niano gli abbracci o i gesti della coppia che accoglie il neonato nei dipinti di Bonifacio de’ Pitati (fig. 4), o la presenza dell’elegante uomo in gorgiera che nel Veronese della Sabauda tocca significativamente la cesta del neonato (fig. 2)18.
Per ragioni di spazio mi è impossibile argomentare ulteriormente in questa sede i molteplici livelli di lettura che possono collegarsi al Ritrovamento di Mosè se analizzato sotto questi rispetti e nelle diverse relazioni di contesto19. Chiudo allora ricordando con Erri De Luca che la vita nella sacra scrittura è opera di costruzione, sia per le donne che partoriscono che per quelle impossibilitate a farlo: “donne sterili come Sara e Rachele danno la loro serva in prestito ai mariti dicendo ‘sarò costruita da lei’. Il verbo banà, costruire, dà voce alla parola figlio, ben”20. Allo stesso modo, nella Venezia del XVI secolo, la presenza nelle dimore del patriziato di figli “tolti per fioli” come Mosè non costituiva pregiudizio alcuno ai fini dell’espressione degli affetti e della “costruzione” della genitorialità. Né, tantomeno, era di ostacolo alla rappresentazione artistica di una madre.
creazione significato / i