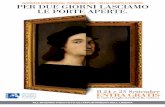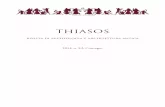Tradizione lessicografica ed enciclopedismo bizantino, in Giornate filologiche genovesi....
Transcript of Tradizione lessicografica ed enciclopedismo bizantino, in Giornate filologiche genovesi....
Estratto da:Giornate filologiche genovesiL’enciclopedismo dall’Antichità al Rinascimento
Renzo Tosi
Tradizione lessicografica ed enciclopedismo bizantino
49
Tradizione lessicografica ed enciclopedismo bizantino
1. Se per enciclopedismo si intende l’atteggiamento che deriva dalla volontà di inserire in una stessa opera tutto lo scibile, due sono i momenti della storia della lessicografia greca in cui è chiaramente ravvisabile tale modo di pensare: in entrambi si avverte la volontà di salvare e di rendere disponible il materiale elaborato in età preceden-ti, condensandolo in opere monumentali. È della prima età imperiale l’enciclopedia di Panfilo, che doveva riprendere tutto quanto era stato prodotto a livello erudito dall’eà alessandrina in poi, e della quale nulla è rimasto; essa, comunque, doveva presentarsi come un prodotto di con-sultazione difficile e faticosa, che fu poi presto compendiato nel lessico di Diogeniano, anch’esso perduto, dal quale sono a loro volta derivati i nostri lessici dell’età tardo-antica (in particolare quello di Esichio)1, la cui stesura si caratterizza per un progressivo processo di epitomazione, semplificazione e commistione dei materiali.
Un problema non secondario riguarda la struttura dell’opera di Panfilo, se fosse onomastica, cioè tematica, secondo un’antica ma mo-rente tradizione2, oppure alfabetica (questo tipo di ordinamento, che probabilmente era stato usato per la prima volta in età alessandrina e in particolare da Zenodoto, stava sempre più prendendo piede), se dun-que fosse organizzata per campi semantici o trovasse la sua raziona-lizzazione nell’ordine alfabetico. La voce biografica della Suda (p 142 A. Pavmfil: Alexandrev, grammatik; jAristavrcei. e[graye Leimwna: e[sti de; pikivlwn perichv, Peri; glwsswn h[ti levxewn bibliva e: e[sti de; ajp; t e sticeiv e{w t w: ta; ga;r ajp; t a mevcri t d Zwprivwn ejpepihvkei. Eij ta; Nikavndr ajnexhvghta kai; ta; kalvmena Opikav, Tevcnhn kritikhvn, kai; a[lla pleista grammatikav), invero, ne testimonierebbe l’ordine alfabetico, ma ciò è in chiaro
1 Da segnalare che derivano da Diogeniano due lessici papiracei, PSI VIII 892 e P.Oxy. 3329.
2 Rinvio a questo proposito al mio La lessicografia e la paremiografia in età alessandrina e il loro sviluppo successivo, «Entretiens Hardt», 40 (1994), pp. 148-150.
RENZO TOSI
50 RENZO TOSI
contrasto con tutta una serie di indizi3, ed in particolare con le caratteri-stiche delle tante sezioni, che, con ogni verisimiglianza, sono riprese da Ateneo. Si è pure tentato a più riprese di giungere a un compromesso, postulando una combinazione tra le due strutture, un insieme di glosse alfabetiche miste a una rassegna di nomi, suddivisi per campi semantici, ma la questione rimane aperta, soprattutto perché non è possibile piega-re la notizia della Suda ad altre interpretazioni: in essa si distingue tra un Leimwvn, che doveva essere un compendio enciclopedico, e un lessico di enormi proporzioni (95 libri!); che si trattasse in realtà della stessa opera si può solo ipotizzare4.
2. Nella cultura bizantina posteriore alla Rinascenza foziana l’ansia di recuperare tutto il possibile di una perduta classicità porta alla stesu-ra di prodotti lessicografici dagli intenti e dalla struttura enciclopedica. Innanzi tutto, non si può non prendere in considerazione la Suda, che non è solo un’inesauribile fonte di frammenti e notizie, ma costituisce anche l’opera-simbolo dei gusti culturali e degli interessi di un’epoca: in essa vengono agglutinati materiali dalle più diverse fonti (letterarie, lessicografiche, paremiografiche, biografiche, esegetiche); in particolare, i suoi compilatori avevano a disposizione per vari autori (come Sofo-cle, Aristofane, Tucidide) manoscritti forniti di scolî, e riprendevano tali annotazioni, anche se non sempre nel modo più opportuno. I materiali venivano accostati, agglutinati, con scarsi tentativi di armonizzazione: se la storia della lessicografia è innanzi tutto una storia di materiali epitomati, la Suda mette insieme in modo enciclopedico materiali già fortemente decurtati e spesso svisati, e li accosta a testi che origina-riamente non avevano nulla a che fare con le annotazioni. Un esempio: Suda c 570 crsiv: hJ crsh fiavlh. i[m j wJ ejlehvmwn ei[m j ajei; twn crsivdwn. ajjnti; t h{ttwn presenta nella prima parte la tradizionale spiegazione metafrastica del lemma (cf. Hesych. c 791 H.-C. crsiv: pthvrin. iJ de; fiavlh crsh, Hesych. c 788 H.-C. crsivda: th;n
3 Cf. I. Schoenemann, De lexicographis antiquis qui rerum ordinem secuti sunt, Hannoverae 1886, pp. 63 sg., C. Wendel, RE, 18/1 (1939), cc. 336-349.
4 Anche nella voce biografica su Callimaco (k 227 A.), in realtà compaiono vari titoli che, secondo molti studiosi, sono non di opere a sé stanti, ma di sezioni delle jEqnikai; jnmasivai (cf. R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship, Oxford, Oxf. University Press, 1968, p. 135, nonché La lessicografia cit., p. 150).
5 A. Hansen e I.C. Cunningham (Hesychii Alexandrini Lexicon, IV, Berlin-New York, De Gruyter, 2009, p. 233) citano come fonte Cratin. fr. 132 K.-A. crsivdi spevndwn †
Tradizione lessicografica ed enciclopedismo bizantino 51
crshn fiavlhn, Harpocr. c 13 Keaney crsiv: hJ fiavlh. Dhmsqevnh ejn tw Kat j Andrwtivn [22,69 etc.], jAristfavnh Eijrhvnh [v. 425]), segue la citazione di Ar. Pac. 425 (i[m jwJ ejlehvmwn ei[m j ajei; twn crsivdwn) ed infine uno strano ajjnti; t` h{ttwn. Quest’ultimo elemento non è che una chiosa banalizzante di ejlehvmwn, come dimostra schol. (vet Tr) Ar. Pac. 425 dwrn divdwmi. tt parepigrafhv. tt ga;r eijpw;n divdwsin ajtw fiavlhn crshn. i[m j wJ ejlehvmwn: devn eijpein “h{ttwn” fhsi;n “ejlehvmwn”. wJ ... ajeiv: ajnti; t eijpein “h{ttwn” “ejlehvmwn” fhsivn. crsivda th;n fiavlhn. twn crsivdwn: th fiavlh: il fatto che nel passo della Pace Hermes confessi che ‘si commuove’ di fronte alle coppe d’oro è interpretato come se egli dicesse che ‘è vinto’, non ha forze per resistere a tali preziosi doni. Lo sforzo dei compilatori di inserire più materiale possibile nelle voci porta a copiare non solo i testi, ma anche gli scolî, talora a discapito della struttura logica della glossa.
Il fine e il metodo enciclopedico della Suda devono essere sempre presenti allo studioso, che solo così potrà evitare errori e semplifica-zioni. Si deve sempre ricordare, ad es., che spesso le voci di questo lessico sono dovute all’agglutinazione di materiali i quali nulla avevano originariamente a che vedere tra di loro. Si prenda ad es. la gl. a 1763 ajmfisbhtein: mh; smfwnein, ajll jin cwri; baivnein kai; ajmfibavllein. J de; Ptlemai eijdw; t; eJat prgvn ejschkvta th;n Kivlhn Srivan paraskea; ejpieit megavla ajmfisbhtwn tavtai: h[lpize ga;r th;n ajdivkw plevmw prvtern ajneimevnhn tvte dikaivw ti ajti nvmi ajnakthvsasqai. kai; Aijlianv: hjmfisbhvtn ga;r t; eJtevr e{teri prballvmeni. jkevti \n h\n ajmfisbhthvsima t; mh; j ttn ejkeinn ei\nai t;n teqnhkvta. Dopo una prima parte che deriva dalla tradizione lessicografica (ajmfisbhtein: mh; smfwnein, ajll in cwri; baivnein kai; ajmfibavllein) e che ha precedenti in Syn. ant. a 435 Cunn. ajmfisbhtein: mh; smfwnein, ajll jin cwri; baivnein kai; ajmfibavllein = Phot. a 1366 Th., nonché in altri lessici che riportano
gevgrafe † ti [fesi piein didv, a proposito del quale Ateneo (11,496e) riporta la corrotta annotazione rJsiv: fiavlh crsh, che si ritrova anche in Esichio (r 526 H.). Tutto ciò può certamente essere un indizio del fatto che la glossa derivi dall’esegesi antica di Cratino, ma, a mio avviso, è più probabile che l’interpretamentum riprenda una spiegazione generale, utilizzata per tutti i passi in cui compariva crsiv e che peculiare del luogo di Cratino sia solo la corruzione di crsiv in rJsiv (da cui ovviamente dipende Hesych. r 526 H.).
6 Hansen-Cunningham citano come fonte Hermipp. fr. 38 K.-A. crsivd j i[n pansevlhnn ejkpiw;n Jfeivlet, attestato da Athen. 11, 502b.
52 RENZO TOSI
solo alcuni interpretamenta, come Hesych. a 4104 L., Cyr. (S) amf 25 (cf. anche Ael. Dion. a 110 Erbse), si hanno varie citazioni desunte dagli Excerpta di Costantino Porfirogenito, la prima (J de; Ptlemai eijdw; t; eJat prgvn ejschkvta th;n Kivlhn Srivan paraskea; ejpieit megavla ajmfisbhtwn tavtai: h[lpize ga;r th;n ajdivkw plevmw prvtern ajneimevnhn tvte dikaivw ti ajti nvmi ajnakthvsasqai), di Diod. 30,2, dagli Excerpta de legationibus (401,31; 402,1), le altre – un passo di Eliano (fr. 133 H.: hjmfisbhvtn ga;r t; eJtevr e{teri prballvmeni) e un altro passo attribuito a Giamblico (Babyl. fr. 5: jkevti \n h\n ajmfisbhthvsima t; mh; j ttn ejkeinn ei\nai t;n teqnhkvta) – derivate da Excerpta a noi non pervenuti. Si noti come nell’ultimo passo non compaia il verbo ajmfisbhtein, bensì il sostantivo corrispondente (ajmfisbhthvsima).
Ovviamente, non sempre si ha accumulo di materiale nella stessa glossa: talora si trovano allineate, con lo stesso lemma, glosse distinte, che derivano da fonti diverse (questo è particolarmente frequente quan-do una è biografica, desunta dall’Onomatologo di Esichio Milesio7). C. Theodoridis, il grande studioso di lessicografia da poco prematuramente scomparso, ha poi, nel primo capitolo (Das Verhältnis des Lexicons des Photios zum Lexicon des Suidas) dei Prolegomena del secondo volume della sua edizione di Fozio (Berlin-New York, De Gruyter, 1998), sup-posto che l’operato dei compilatori della Suda sia meno meccanico e più consapevole di quanto di solito si creda8: significativo è il caso di Suda w 46 w[keilen: kai; ejxwvkeilen. { ejstin e[xw t kevllein gevgnen, dove figura l’interpretamentum e[xw t kevllein, che è in realtà un’in-terpretazione etimologica di ejxwvkeilen (cf. Et.Gud. 491,1-3 De Stef., EM 350,14-26); il lemma, secondo Theodoridis, deriverebbe dalla parte finale del corrotto Phot. k 554, dove – dopo l’indebita intromissione di
7 Per tale fonte della Suda, cf. Ada Adler, Suidae Lexicon, I, Lipsiae, Teubner, 1928, p. XXI e K. Alpers, Untersuchungen zu Joannes Sardianos, «Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft», 2009, 151-158.
8 Si tratta di un corollario della sua teoria, secondo cui la Suda deriverebbe direttamente dal lessico di Fozio: ciò era stato a suo tempo supposto da S.A. Naber (Photii Patriarchae Lexicon. Prolegomena, I, Leiden 1864, pp. 164-167), ma poi confutato da G. Wentzel (Beiträge zur Geschichte der griechischen Lexicographen, «Sitzungsberichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin», 1895, pp. 477-487), il quale ipotizzò che che la Suda non avesse ripreso Fozio, ma che entrambi i lessici dipendessero da una Sunagwghv allargata. La teoria di Wentzel divenne poi la communis opinio; la presa di posizione di Theodoridis non è certo immotivata: nutro tuttavia qualche serio dubbio (rinvio a «Byzantinische Zeitschrift », 94, 2001, pp. 347-353).
Tradizione lessicografica ed enciclopedismo bizantino 53
un’altra glossa – si legge keilen, { ejstin e[xw t kevllein gevgnen: di qui l’invenzione di un autonomo quanto inesistente keilen che sa-rebbe stato assunto a lemma – e poi corretto – nella w 46. Stando così le cose, il compilatore sarebbe abbastanza dotto da supplire <w[>keilen, anche se non sufficientemente intelligente da integrare il pur diffuso e logico <ejxwvv>keilen. Un altro esempio9 è costituito da Phot. k 453 katevcesqai: t; katarasqai: {tw Plavtwn (Resp. III 393a), k 454 katevcesqai twn jAcaiwn: ajnti; t kata; twn jAcaiwn e[cesqai: {tw Sfklh (OT 246), e Suda k 1015 katevcesqai: t; katarasqai: {tw Plavtwn. kai; Sfklh· “katevcmai de; t;n dedrakvta tavde”. ajnti; t katarwmai. È indubbio che in Fozio ci sia un’inversione dei nomi di Platone e Sofocle: Theodoridis suppone che il compilatore della Suda, che conosceva bene il passo della Repubblica, «stolperte über die Zuweisung dieser platonischen Wendung an Sophocles», per risolvere poi il problema aggiungendo una citazione dall’Edipo Re. È, come si è visto, abituale l’inserimento di citazioni nelle glosse della Suda (anche qui viene aggiunta quella di Aelian. fr. 77 H.), ma, se la ricostruzione di Theodoridis è esatta, nel nostro caso non abbiamo a che fare con un processo di giustapposizione di materiali, bensì con una vera e propria consapevole ricerca di fonti. Qualche dubbio invero permane: si potreb-be, ad es., supporre che alla base della tradizione lessicografica ci fosse una sola glossa, con lemma katevcesqai ed entrambe le citazioni, pla-tonica e sofoclea: essa comparirebbe frammentata – con un banale errore – in Fozio e compendiata nella Suda. In altri casi, l’intervento autonomo del compilatore della Suda è postulabile con maggiore sicurezza: tale, ad es., va reputato il peri; t;n $Aidhn di h 272 JHlvsin: iJer;n peri; t;n $Aidhn. La glossa è conservata nella sua forma più completa in Hesych. h 399, dove si conclude con un h] iJervn. kai; paravdeis, che dimostra come l’ jHlvsin: iJervn, paravdeis di Cirillo10 e Synagoge (ant. h 67 Cunn.) sia sano (cf. del resto anche schol. Hes. Op. 171, Hesych. t 1050, nonché Greg.Naz. Epit. Basil. 23,7). Nella Suda compare l’Ade, Fozio reca un assurdo perivdn, gli Etimologici offrono variazioni su un inattestato peri; Rvdn: si tratterà di diversi stadi di corruzione e di ten-tativi di razionalizzazione; non credo che si possa in assoluto essere certi – come sostiene Theodoridis – che il compilatore della Suda avesse di
9 Cf. Teodoridis, Das Verhältnis cit., pp. XXXIV sg.10 Il testo di questo inedito lessico è desumibile dall’apparato di I.C. Cunningham
(Synagoge, Berlin-New York, De Gruyter, 2003, p. 255).
54 RENZO TOSI
fronte il perivdn di Fozio, e che questo imbarazzante interpretamentum derivasse a sua volta da peri; JRvdn. Mi parrebbe più logico che fosse la fantasiosa inserzione di Rodi ad essere originata dall’incomprensibile perivdn, e che all’origine di tutta questa serie di interpretamenta senza senso ci fosse paravdeis. Comunque stiano le cose, le osservazioni di Theodoridis risultano preziose, perché sfatano l’idea di compilatori che avrebbero operato in modo escusivamente passivo, ed evidenzia qualche tentativo di rendere non disorganiche le glosse.
3. L’enciclopedismo trova un fertile campo anche negli Etimolo-gici. L’interesse dei Greci per l’etimologia dal quinto secolo fino all’e-tà alessandrina si sposava da una parte con la speculazione filosofica sull’origine del linguaggio (che ebbe il suo apice nel Cratilo platonico), dall’altra con la ricerca sull’origine di singole ‘glosse’ poetiche (soprat-tutto omeriche), in vista dell’individuazione del loro vero (e[tm) si-gnificato, condotta soprattutto dai Sofisti. Se il primo titolo concernente questo àmbito è il Peri; ejtmlgiva di Eraclide Pontico, i primi a fornire sistematicità a tali ricerche furono gli Stoici (in particolare Cri-sippo), che – partendo da una concezione anomalista del linguaggio – enuclearono un complesso sistema di derivazione, in cui si prendeva le mosse dai ‘primi’ sostantivi e verbi per dar conto della lingua nella sua interezza. Diversa era l’impostazione dell’alessandrinismo analogista (il cui rappresentante più maturo fu Filosseno): non più parole originarie, bensì radici monosillabiche, dalle quali procedeva l’evoluzione, regola-ta da precise norme. Una fase successiva fu quella della creazione dei primi veri e propri lessici etimologici nel V sec. d.C.: i principali loro compilatori furono Orione ed Oro, delle cui opere ci sono pervenuti solo excerpta e frammenti, dai quali si può dedurre che se Oro riprendeva soprattutto Filosseno, il primo procedeva in modo, per così dire, enci-clopedico, affastellando tutto il materiale a sua disposizione, etimologico e non, senza fare differenze d’impostazione e di scuole (in particolare, però, sembra che riprendesse materiali di Erodiano). Si trattava comun-que di raccolte quantitativamente modeste, come pure quelle fiorite tra VI e VIII sec.11; dall’età di Fozio in poi, invece, si ebbe la compilazione di Etimologici molto più ampi, che presupponevano un cosciente intento enciclopedico: il primo – che la tradizione vuole composta dallo stesso
11 Come il Lessico AiJmwdein, quelli di Metodio ed Anastasio Sinaita, le Ecloghe del Cod. Barocc. 50 e – nel IX sec.. – l’Etymologicum Parvum.
Tradizione lessicografica ed enciclopedismo bizantino 55
Fozio e che sappiamo terminato il 13 maggio 865 o 882 – è quello co-munemente chiamato, dopo la Geschichte der griechischen Etymologika di R. Reitzenstein (Lipsiae 1897), Etymologicum Genuinum (e che in-vece F. Lasserre e N. Livadaras12 denominano Etymologicum Magnum Genuinum), di cui ci sono pervenute due redazioni, entrambe in codici vergati nel X sec. nell’Italia meridionale13. Questo Etimologico inglobava materiale derivante dalle fonti più disparate (Cherobosco, Oro, Erodiano, Teognosto, Orione, Metodio, gli Epimerismi ad Omero, gli Epimerismi ai Salmi, le tradizioni esegetiche di tutti i più importanti autori, nonché il problematico Rhtrikvn, un lessico strettamente imparentato con quel-lo di Fozio (probabilmente distinto da esso: l’identificazione è invece ipotizzata da Ch. Theodoridis14). Da esso derivarono, nei secoli succes-sivi, numerosi altri Etimologici: quanto ai loro rapporti e alle loro reda-zioni, va ricordato che tali opere venivano copiate per fini strumentali, e che quindi siamo di fronte a una tipica tradizione aperta, in cui ogni copista si sentiva in diritto e in dovere di procedere ad epitomazioni ed interpolazioni, a seconda degli interessi suoi e del suo centro culturale; ciò fa sì che siano spesso labili i confini tra opere diverse e differen-ti redazioni della stessa opera. A questa tradizione appartiene innanzi tutto l’Etymologicum Magnum (metà del XII sec.; così chiamato già in Eust. 834,46 e 1443,65, ridenominato Etymologicum Magnum auctum da Lasserre-Livadaras), il più imponente, integrato con numerosi mate-riali desunti da varie fonti15. Sempre nel XII sec, forse di poco antece-dente al Magnum, è l’Etymologicum Symeonis, del quale conosciamo tre diverse redazioni: due manoscritti (Parm.Gr. 2139 [XIV sec.] e Vindob.Phil.Gr.131 [seconda metà XIII sec.]) riportano una versione ‘minor’; al-tri tre una più ampia: il Laur.S.Marc. 303 [a. 1291] e il Voss.Gr. 20
12 Cf. Etymologicum Magnum Genuinum. Symeonis Etymologicum. Etymologicum Magnum Auctum, Roma, Ateneo, 1976, vol. I, pp. V-XI.
13 La A, conservata nel Vat.Gr. 1818, in gran parte mutila (proprio per ovviare alla lacuna iniziale, nel XIII sec. fu redatto l’Etymologicum Casulanum) e la B, tramandata dal Laur. S.Marc. 304, molto più completa (manca solo il folio iniziale), ma rovinata a tal punto, da essere in certi passi assolutamente illeggibile
14 Cf. Photii Patriarchae Lexicon, Berlin-New York, De Gruyter, 1982, vol. I, pp. XXXV-LX; di contro si veda in particolare K. Alpers, Das Lexikon des Photios und das Lexicon Rhetoricum des Etymologicum Genuinum, JÖB, 38 (1988), pp. 171-191.
15 Di esso abbiamo sette manoscritti, divisi in due famiglie: in particolare nel Marcian. 530 [XIII sec.] vanno distinte due mani, non appartenenti alla stessa famiglia, e il Matrit. N 21 [XV sec.] presenta una raccolta miscellanea in cui compaiono anche sezioni del Gudianum e della Suda e che – per quanto riguarda il Magnum – è imparentata con le interpolazioni del Voss. Gr. 20.
56 RENZO TOSI
[XIII sec.] costituiscono cosiddetta Megavlh grammatikhvv, che supplisce alla mancanza della parte iniziale, fino alla glossa abal, utilizzando il Magnum; il Vat.Gr. 1276 – il cosiddetto Etymologicum Casulanum (dal monastero di S.Nicola a Casole) – assume una posizione a sé stante. Nel Voss.Gr. 20, infine, le cui lezioni sono riportate in calce all’edizione del Magnum di Gaisford, furono inserite in margine, nell’interlinea e in una parte supplementare (da f. 210r.) glosse provenienti dal Magnum (in una redazione simile a quella del Matrit. N 21, ma meno scorretta). Impor-tante è infine il Lessico dello Pseudo-Zonara (XIII sec.), che riprende sia il Genuinum (in una redazione migliore rispetto a quella offerta dai no-stri codici) sia il Symeonianum (in una versione simile a quella del Vat.Gr.1276). Per completare il quadro, bisogna ricordare che il Genuinum è invece una fonte tra le tante dell’Etymologicum Gudianum16, per il qua-le siamo nella fortunata situazione di conoscere il codice (Vat.Barb.Gr. 70 [XI sec.], di origine otrantina), da cui derivano tutti gli altri. Questi vanno distinti in quattro classi: la prima, costituita da tre manoscritti del XIII sec. e da due del XV, è abbastanza fedele al Vat.Barb. 70, anche nell’indicazione delle fonti; la seconda è limitata al Paris.Suppl.Gr. 172 del XIII sec. (il cosiddetto Etymologicum Sorbonicum); la terza presenta un’ampia contaminazione col Genuinum ed è costituita da una parte dal Vat.Gr. 1708 (XII sec.), dall’altra dall’Etymologicum Cretense, un suo ge-mello passato a Creta, di cui ci rimangono moltissimi apografi; la quarta dipende da una copia del Cretense che aveva subito ulteriori interpola-zioni, in particolare dal Lessico di Cirillo (tra i suoi codici il più antico è il Vindob.Phil.Gr. 158 [XIII sec.], uno dei peggiori il Guelpherbyt.Gr. 29-30 [a. 1293], del quale l’edizione dello Sturz rappresenta una trascrizione diplomatica). Ovviamente molte furono le interrelazioni fra le tradizioni derivate dal Genuinum e dal Gudianum: se interpolazioni dal Genuinum si hanno già nel Vat.Barb. 70, il Gudianum va annoverato tra le fonti del Symeonianum e del Magnum, ma il concetto fondamentale da cui partire se ci si deve inoltrare in questo ginepraio è quello già espresso di ‘tradizione aperta’; in altri termini, l’interesse enciclopedico, sposato all’intento strumentale, in questo àmbito, da vita a opere non standardizzate, ma dal contenuto estremamente fluido, in cui i materiali sono di volta in volta ripresi, talora semplicemente giustapposti, altre
16 Dal nome dell’umanista danese del XVIII sec. M. Gude proprietario del cod. Guelferbytanus Gr. 29-30.
Tradizione lessicografica ed enciclopedismo bizantino 57
volte – come mi è capitato di constatare per l’Etymologicum Magnum17 – riadattati con un’opera congetturale e razionalizzante. Se questi materiali sono tuttora, in gran parte, inediti è perché per essi non è possibile fare un’edizione con i criteri tradizionali, lachmanniani e post-lachmanniani: forse una via nuova e percorribile è quella della cosiddetta ‘edizione digitale’.
4. Nella cultura bizantina esistono altre forme di opere enciclo-pediche. L’esempio più evidente è costituito dal commento all’Iliade e all’Odissea di Eustazio di Tessalonica (XII sec.), che non è finalizzato alla sola comprensione del testo omerico, perché il suo autore finisce per inserire – partendo dai termini e dalle espressioni omeriche – tutto il sapere erudito a sua disposizione. Egli riprende dunque innanzi tutto gli scolî ma ingloba poi materiale dalle più varie fonti18: quella princi-pale va probabilmente identificata nei Deipnosofisti di Ateneo, ma sono altresì ripresi vari lessici (da quelli atticisti di Elio Dioniso e Pausania alla Suda, altri derivati da Diogeniano se non Diogeniano stesso, altri ancora di tipo sinonimico-differenziatore19 come quelli di Erennio Filone ed altri ancora), opere grammaticali (ad es. quelle di Erodiano, di Che-robosco e il libro di Filopono sugli accenti), la tradizione etimologica, quella paremiografica, opere geografiche (Strabone, Dionigi il Periegeta e il lessico di Stefano di Bisanzio), i più diversi autori con la loro esegesi antica (poeti come Aristofane, i tre tragici, Licofrone, Pindaro, Esiodo, Oppiano, Teocrito, retori come Ermogene, storici come Diodoro Siculo, Arriano, filosofi come Platone e Aristotele, nonché altri come Senofonte, Plutarco, Eliano, Imerio), biografi come Diogene Laerzio, mitografi come lo Pseudo-Apollodoro. Il commento dunque trova nel testo omerico il
17 Cf. Casi di emendatio ope ingenii nell’Etymologicum Magnum, «Lexis», 18 (2000), pp. 261-265. Esemplare è il caso di Thuc. I 6,3 crswn tettivgwn ejnevrsei krwbvln ajnadvmeni twn ejn th kefalh tricwn, rispecchiato da Sb a 1271 Cunn. ~ Phot. a 1820 Th. ~ Etym.M. 106,33sgg. ajneivrein: ajnapeivrein. {qen (inter ajnapeivrein et {qen Etym.M. add. Plavtwn: «scivn labw;n a[neire ta; kreva» [fr. 225 K.-A.]) kai; hJ a[nersi para; Qkdivdh: «kai; crswn tettivgwn ejnevrsei (ajnevrsei Etym.M.)». La lezione ajnevrsei riportata dall’Etymologicum Magnum non sarà da ritenersi antica, ma frutto di una razionalizzazione (la forma degli altri lessici, che offrono il corretto ejnevrsei è con ogni probabilità viziata da un’epitomazione che ha tolto il richiamo a ejneivrw ed e[nersi).
18 Per una loro analisi completa rinvio a M. van der Valk, Eustathii Archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Lugduni Batavorum, Brill, 1971, vol. I, pp. XVI sg., LIX-CXVI.
19 Per questa denominazione cf. F. Bossi - R. Tosi, Strutture lessicografiche greche, BIFG, 5 (1979/80), p. 15.
58 RENZO TOSI
pretesto per un’ampia trattazione enciclopedica, ordinata non alfabetica-mente né tematicamente, ma secondo la successione dei passi dell’autore commentato. Si ha quindi la controprova di una generale tendenza del-la cultura bizantina posteriore all’età di Fozio: se la Suda era nei suoi intenti una vera e propria enciclopedia, gli Etimologici partono dalla prospettiva di un’analisi grammaticale, Eustazio da quella dell’esegesi del più venerando autore della grecità per dare comunque vita a opere enciclopediche, tipiche di un’età caratterizzata dalla volontà e dall’ansia di salvare e tramandare tutto un ampio bagaglio di conoscenze passate, includendole in grandi collettori, forse di non agevole consultazione, ma comunque tali da preservarle da naufragi futuri.