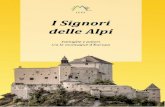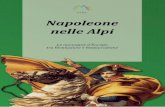Crinali e passi dagli Appennini alle Alpi. Atti delle giornate di studio (Capugnano, 8 settembre...
-
Upload
incontritramontani -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Crinali e passi dagli Appennini alle Alpi. Atti delle giornate di studio (Capugnano, 8 settembre...
STORIA E RICERCA SUL CAMPO FRA EMILIA E TOSCANANUOVA SERIE 2
INCONTRI TRA/MONTANI XXII
CRINALI E PASSIDAGLI APPENNINI
ALLE ALPIAtti delle giornate di studio
(Capugnano, 8 settembre 2012)
nuèterGRUPPO DI STUDI
ALTA VALLE DEL RENOPorretta Terme
2013
CRIN
ALI E
PAS
SI D
AGLI
APP
ENNI
NI A
LLE
ALPI
INCONTRI TRA/MONTANIXXII
STORIA E RICERCA SUL CAMPO FRA EMILIA E TOSCANANUOVA SERIE 2
Gruppo di studi alta valle del RenoPorretta Terme
2013
CRINALI E PASSIDAGLI APPENNINI ALLE ALPI
Atti delle giornate di studio(Capugnano, 8 settembre 2012)
a cura di Renzo Zagnoni
Le immagini alle pagine 81, 86, 87 e 88 sono state pubblicate con l’autorizzazio-ne dell’Archivio di Stato di Firenze con nota del 21 maggio 2013, prot. n. 3036/cl. 28.28.01/569. L’immagine a pag. 82 è stata pubblicata con l’autorizzazione dell’Ar-chivio di Stato di Pistoia con nota del 28.05.2013, prot. n. 1401/cl. 13.13.22/1.6
La revisione dei testi è stata curata da Gian Paolo Borghi e Paola Foschi
L’organizzazione del convegno “Crinali e passi dagli Appennini alle Alpi” è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’associazione Beata Vergine della Neve, della Parrocchia e della Pro Loco di Capugnano e del Comune di Porretta Terme.
GIORNATE DI STUDIO
“INCONTRI TRA/MONTANI”, XXII“STORIA E RICERCA SUL CAMPO FRA EMILIA E TOSCANA”, nuova serie 2CRINALI E PASSI DAGLI APPENNINI ALLE ALPI
8 settembre 2012
Organizzazione: Paola Foschi, Renzo Nelli, Marco Tamarri, Elena Vannucchi, Carlo Vivoli, Renzo Zagnoni
Coordinamento: Renzo Zagnoni
In copertina: Il crinale del Corno alle Scale (m. 1945) fra Emilia e Toscana. In primo piano il campanile della chiesa di Castelluccio di Porretta Terme, foto di Stefano Semenzato.
Impaginazione e stampa a cura di: AGV Studio, Pioppe di Salvaro (Bo)
© 2013 Gruppo di studi alta valle del Reno (Porretta Terme – Bo)
3
Quest’anno l’oramai consolidato incontro annuale di Capugnano si è svolto su un duplice binario. Da un lato questo convegno rappresenta il pri-mo della nuova serie di “Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana”, successivo all’uscita dall’organizzazione della Società pistoiese di storia pa-tria ed al diretto coinvolgimento dell’Accademia Lo Scoltenna che ha sede nel Modenese a Pievepelago. Dall’altro lato abbiamo vissuto la novità molto importante dell’incontro tra la realtà appenninica e quella alpina cosicché questo convegno rappresenta il 22° degli Incontri Tra/montani, che da molti anni raccolgono numerose realtà culturali delle valli alpine, che vogliono discutere, insieme ed in amicizia, di temi di comune interesse. Per la prima volta questi convegni hanno coinvolto la realtà parallela degli Appennini in un incontro che crediamo e speriamo possa avere nel futuro ulteriori proficui sviluppi.
Il convegno ha avuto il suo momento di avvio nell’incontro di venerdì 7 settembre presso la Pro Loco di Capugnano, con una cena che ha mostrato in tutta evidenza la sua novità. Prima di tutto mettere in relazione i due versan-ti dell’Appennino, quello toscano con quello emiliano, non è sempre facile anche dal punto di vista amministrativo. Ma l’iniziativa del Gruppo di studi alta valle del Reno assieme alle Deputazioni di storia patria per le provincie di Romagna e per la Toscana e agli Incontri Tra/montani, organizzatori di questo incontro, vuole fare riflettere sul fatto che il confine amministrativo ed il crinale spartiacque non sono luoghi della separazione, ma del passag-gio: continue e determinanti sono infatti le relazioni di ogni tipo che sono intercorse ed intercorrono fra i due versanti per pensare che quelle linee im-maginarie rappresentino davvero un ostacolo. Basta pensare al tentativo di salvare la ferrovia Porrettana nel tratto Porretta-Pistoia, che vede uniti molti enti pubblici e privati dei due versanti.
Seconda, ma non per importanza, la novità che è rappresentata dal sotto-titolo: “dagli Appennini alle Alpi”, che vuole proporre un’ampia riflessione relativa al fatto che i due mondi rappresentati dalle due catene montuose più importanti d’Italia, hanno molto, anzi quasi tutto in comune: i problemi della viabilità, quelli dello spopolamento, del decadimento delle superfici coltivate, dell’abbandono delle attività economiche primarie e secondarie.
La riflessione storica e sulle tradizioni che questi Incontri Tra/montani propongono, credo che possa servire a far crescere il senso di appartenenza, perché la storia non è mai fine a sé stessa, ma serve sempre a comprendere meglio il presente.
Un’ultima segnalazione: questo convegno di Capugnano è stato il vente-simo della serie “Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana”: un bel tra-guardo per una serie di incontri nati in sordina, che però si sono conquistati
4
un posto nella realtà della montagna, soprattutto perché studiano in modo serio e rigoroso la realtà storica, ma si rivolgono con linguaggio accessibile a tutta la popolazione dell’Appennino, ed oggi dobbiamo dire anche delle Alpi!
Renzo Zagnonipresidente del Gruppo di studi alta valle del Reno
5
Innanzitutto debbo ringraziare il Gruppo di studi della valle del Reno con il suo presidente Renzo Zagnoni e l’amministrazione Comunale di Porretta Terme per aver organizzato il XXII Convegno Incontri Tra/montani. È la pri-ma volta che i Tra/montani si tengono negli Appennini e ciò ci rende par-ticolarmente felici perché i temi della montagna sono simili ovunque e non hanno quindi ragioni di esistere artificiose divisioni fra nord e sud, oriente o occidente. Del resto i Tra/montani fanno riferimento non alle Alpi, ma alla montagna sic et simpliciter. I montanari hanno modellato la montagna e la montagna li ha a sua volta modellati. Le terre alte hanno subito e subiscono un processo di spopolamento che è in atto ovunque e se vogliamo evitare l’abbandono dobbiamo cercare le soluzioni assieme. Culturali innanzitutto.
Per gli Itm si sono negli ultimi mesi aperte nuove interessanti prospet-tive. Il tutto à partito da un seminario che ha avuto luogo a il 10 dicembre 2011 a Milano presso la sede delle Regione Lombardia. Sono stato invitato come relatore in rappresentanza degli Itm e ho esposto le mie idee. In quel convegno c’erano presenti i nostri amici della Lessinia, diversi piemontesi e alcune valli lombarde tra le quali la Valtellina. In seguito a quell’appunta-mento l’associazione “Valtellina nel futuro” mi ha contattato per avere un rapporto continuativo con l’associazione Itm. Da lì è scaturito il movimento “Le montagne si parlano” che ha cercato di coinvolgere diversi amministra-tori delle valli lombarde.
Nel giro di pochi mesi abbiamo organizzato 5 convegni: il 18 febbraio a Sondrio, il 2 marzo a Edolo, il 19 maggio a S. Pellegrino dove si è costituito un Comitato di sindaci della montagna, il 16 giugno di nuovo a Sondrio con la rivista della Regione Lombardia Confronti. Il 13 luglio il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Dellai, incontra in Valtellina sindaci e asso-ciazione de “Le montagne si parlano”. Il presidente dice esplicitamente che non è più possibile difendere l’autonomia e il buongoverno della montagna se le valli non riescono ad unirsi in un progetto comune. Il 28 luglio, a Passo S. Marco che collega val Brembana e Valtellina si ritrovano di nuovo le asso-ciazioni e i sindaci e chiedono di incontrare il presidente della Regione che accetta e il presiedente della Commissione parlamentare che si occupa di riforme istiuzionali.
Siamo nel bel mezzo della riforma o cancellazione di molte province e anche la montagna vorrebbe dire la sua per quanto riguarda i nuovi assetti istituzionali. Come vedete un attivismo che non c’era mai stato in tanti anni e una nuova coscienza dei problemi delle valli attorno alla quale noi stiamo lavorando dal 1990, anno del primo convegno tramontano. Più o meno lo stesso movimento è partito in Piemonte ad opera di Mariano Allocco, pre-sente sia a Milano, sia a Sondrio.
6
Ma quali sono i temi che ci stanno più a cuore e che credo siano larga-mente condivisibili da parte o di tutti i gruppi che negli anni hanno organiz-zato e partecipato ai nostri appuntamenti:
1) La produzione di energia idroelettrica che non può più spogliare le montagne lasciando solo le briciole dei sovraccanoni ai Bim. È necessario che più risorse rimangano alla montagna per poter investire in alcuni settori che possono diventare strategici anche in una situazione di crisi economica che induce a riscoprire valori e produzioni tipiche delle terre alte. Dove realizza-re la green economy se non nelle valli dove un po’ di green è rimasto e non è stato cancellato dall’urbanizzazione e dalle industrie consumatrici di suolo?
2) Agricoltura quindi in mano a giovani colti che hanno voglia di speri-mentare nuove forme di vita oltre che di lavoro;
3) Più autonomia non separatista e più Europa;4) Scuole di qualità che non possono che passare attraverso un tempo
scuola dilatato di cui debbono diventare protagoniste le amministrazioni lo-cali e le gli istituti di montagna;
5) Banda larga ovunque perchè le imprese possano usufruire delle nuove tecnologie e possano comunicare velocemente con tutto il mondo.
La strada è in salita e partiamo svantaggiati su molti punti. Negli studi di Irene Tinagli che mettono in evidenza come lo sviluppo sia sempre legato alle famose tre T (Talento, Tecnologia, Tolleranza) le province di montagna sono le ultime. Ciò vuol dire che dobbiamo trovare un nuovo protagonismo e una nuova spinta che tenga conto che solo coloro che sono colti possono vivere in montagna. Gli altri, la manovalanza ignorante poco creativa e di-pendente scenda pure al piano.
Parleremo domenica mattina della candidatura già pronta per il 2013. Ciò che fin da subito auspichiamo è che il Gruppo di studi alta valle del Reno, or-ganizzato questo convegno continui a collaborare per i futuri appuntamenti.
Giancarlo Maculotticoordinatore degli Incontri Tra/montani
7
LA RICERCA SUL CAMPO
Porretta TermeTeatrino parrocchiale “Don Enrico Testoni”
Sabato 8 settembre 2012Concerto “Crinali” di Banda Italiana
Sambuca Pistoiese Domenica 9 settembre 2012
Visita guidata
8
La ricerca sul campo si è svolta in due momenti, uno spettacolo ed una visita guidata.
Nella serata di sabato 8 settembre 2012 presso il teatro parrocchiale “E. Testoni” abbiamo avuto il piacere di ospitare Banditaliana (Riccardo Tesi: organetto diatonico, Claudio Carboni: sassofoni, Maurizio Geri: voce e chi-tarra, Gigi Biolcati: percussioni), che ha tenuto uno splendido concerto con brani originali e riproposizioni di un disco dal titolo Crinali, produzione di-scografica realizzata dal Comune di Porretta Terme dedicata alla tradizione musicale popolare tra Emilia e Toscana, tradizione che è stata presentata, non attraverso un percorso solo filologico, ma grazie al talento di questi mu-sicisti, reinterpretata anche con sonorità moderne.
Il giorno dopo, domenica 9 settembre 2012 il gruppo degli ospiti pro-venienti dalle Alpi sono stati condotti a visitare il castello della Sambuca Pistoiese, che rappresenta quasi un prototipo dell’insediamento nella mon-tagna fra Pistoia e Bologna. Il tutto si è concluso con una visita diciamo così gastronomica a Granaglione per scoprire anche l’aspetto culinario della cul-tura montana, in particolare coi rivoltoni, un tipo di ravioli, che richiamano i rapporti di questa parte della montagna con la Maremma toscana, derivanti da secoli di transumanza delle greggi.
10
Elenco dei relatori
Relazione introduttivaGiuseppe Albertoni, Università di Trento Sezione AppenniniGian Paolo Borghi, Gruppo di studi alta valle del Reno, Porretta Terme (Bologna)Renzo Nelli, Deputazione di storia patria per la ToscanaPaolo Pirillo, Igor Santos Salazar, Università di BolognaElena Vannnucchi, Associazione Storici associati, PistoiaCarlo Vivoli, Deputazione di storia patria per la ToscanaRenzo Zagnoni, Gruppo di studi alta valle del Reno, Porretta Terme (Bologna)
Sezione AlpiGiulio Orazio Bravi, Centro studi e ricerche “Archivio Bergamasco”, BergamoBruno Ciapponi Landi, Museo Etnografico Tiranese, Tirano (Sondrio)Roberto Fantoni, Gruppo Walser, Carcoforo (Vercelli)Attilio Ferla, Associazione culturale Walser, Riva Valdobbia (Vercelli)Luca Giarelli, Incontri di Storia delle Tradizioni Alpine, Nadro di Ceto, Circolo Culturale Ghislandi, Cividate Camuno (Brescia)Nadia Massella, Vito Massalongo,Curatorium Cimbricum Veronense, VeronaMonica Ronchini, Museo Alto Garda, Centro studi Judicaria, Tione di Trento
AbbreviazioniASF = Archivio di Stato di FirenzeASP = Archivio di Stato di PistoiaASBr = Archivio di Stato di BresciaAMR = “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna”BSP = “Bullettino storico pistoiese”
11
Giuseppe Albertoni
LE ALPI E GLI APPENNINI NEL MEDIOEVO:VALICHI, PASSAGGI FRONTIERE
Sommario: 1. Alcune considerazioni metodologiche. 2. L’alto Medioevo: dal-la frammentazione all’unità d’età carolingia. 3. Il pieno e il basso Medioevo: verso una nuova frammentazione politica
1. Alcune considerazioni metodologiche
In un recente saggio dedicato al ruolo dei Franchi nell’arco alpino alto-medievale lo storico statunitense Patrick J. Geary ha ricordato come - non solo per la fase storica al centro del suo interesse - sia impossibile far rientrare lo sviluppo politico delle regioni alpine in un generale denominatore comune sen-za incorrere nel pericolo di asserire insignificanti banalità1. Si tratta di un’osser-vazione che a sua volta riprendeva considerazioni analoghe riportate in un saggio del medievista tedesco Theodor Mayer, il quale, già agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso, giustamente metteva in guardia da possibili, pericolose, generalizzazione sulle Alpi medievali non solo per quel che ri-guarda l’ambito politico, ma anche per temi ad esso più o meno strettamen-te correlati come la viabilità2. Condividendo questo ammonimento, valido anche per l’area appenninica e per la comparazione tra Alpi e Appennini, in questo breve saggio cercherò di mettere in risalto soprattutto alcune fasi critiche della storia dei “transiti” nelle Alpi e negli Appennini del Medioevo, leggendole alla luce di alcune sollecitazioni storiografiche emerse nella lun-ga e feconda stagione di “studi alpini” degli ultimi decenni3, una stagione che ha visto per protagonisti, tra gli altri, storici come Jean-François Bergier4 e Giuseppe Sergi5, i quali con i loro studi hanno contribuito in modo determi-nante a superare il pericolo delle generalizzazioni semplificanti paventato da
1 Cfr. P. Geary, I Franchi sull’arco alpino, in Carlo Magno e le Alpi, Atti del XVIII Congresso internazionale di studio sull’alto medioevo (Susa, 19-20 ottobre 2006 – Novalesa, 21 ottobre 2006), Spoleto 2007, p. 2.
2 Cfr. T. Mayer, Die Alpen als Staatsgrenze und Völkerbrücke im europäischen Mittelalter. Eine Einleitung und Zusammenfassung, in Die Alpen in der europäischen Geschichte des Mittelalters, Reichenau-Vorträge 1961-1962, Stuttgart 1965 (Vorträge und Forschungen, 10), pp. 7-14.
3 Per una sintesi dei principali esiti di questa stagione cfr. M. Cuaz, Le Alpi, Bologna 20054 Cfr. J. F. Bergier, Clio sur les Alpes, in Histoire des Alpes. Perspectives nouvelles / Geschichte der Alpen in
neuer Sicht, Basel 1979, pp. 9-13 e Id., Pour une histoire des Alpes. Moyen âge et temps modernes, Aldershot 1997.
5 Tra i suoi numerosi testi dedicati alle Alpi può essere utile partire da G. Sergi, Aperture e chiusure: regioni alpine e problemi di metodo, in Id., Antidoti all’abuso della storia. Medioevo, medievisti, smentite, Napoli 2010, pp. 173-190.
12
Mayer e Geary. Tenendo conto di queste sollecitazioni penso sia innanzitutto opportuno riflettere su alcuni aspetti metodologici, utili per chiunque si av-vicini allo studio della mobilità in aree montane.
In primo luogo vorrei richiamare l’attenzione sul tema del rapporto tra valichi, confini e frontiere6. Il suo studio, infatti, non può prescindere dalla consapevolezza di come dall’età tardo-antica a tutto il basso Medioevo, ma forse potremmo inoltrarci anche nella Modernità, sia nelle Alpi, sia negli Ap-pennini estremamente rari furono i casi di confini lineari posti sulla linea di displuvio o in prossimità dei passi; al contrario, il principio di base adottato da sovrani e signori territoriali, sul modello di quanto avveniva per altro già in età romana, fu sempre quello del controllo di ambedue i versanti dei prin-cipali valichi, col conseguente ulteriore controllo “globale” della viabilità che su essi convergeva7.
In secondo luogo vorrei ricordare l’importanza di considerare la storia dei valichi non solo dal punto di vista di “chi passa”, ma anche da quello dei residenti, delle popolazioni montane, il tutto non da una prospettiva di con-trapposizione, ma di interazione, eventualmente anche conflittuale, con le comunità locali8, la cui formazione e il cui ruolo nell’alto e nel pieno Medioe-vo si sono imposti all’attenzione degli storici, non solo dell’area appenninica, almeno a partire dalla pubblicazione de La montagna e la città, il magistrale studio sull’Appennino toscano pubblicato da Chris Wickham nel 19889.
In terzo luogo vorrei ricordare la questione del rapporto tra grande viabi-lità e poteri pubblici in un sistema politico, come quello medievale, a lungo privo di un’organizzazione statuale di tipo romano. Anche in questo caso una delle possibili, e per me auspicate, prospettive d’analisi è quella dell’in-terazione a partire dalla nozione di “area di strada”, elaborata ormai alcuni decenni fa da Giuseppe Sergi contro l’imperante ricerca del tracciato “vero” di vie e strade10. In numerosi studi egli ha messo in risalto come la ricerca del “vero tracciato” di una strada ci possa condurre, nel migliore dei casi, a una conoscenza erudita che poco spiega il contesto nel quale la strada si inseriva, mentre la ricostruzione delle “aree di strada” – e cioè delle fasce di territorio
6 Valichi, confini e frontiere sono spesso stati al centro del recente dibattito storiografico, anche per quel che riguarda la loro definizione. Per un primo, preciso inquadramento rimando a P. Marchetti, De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna, Milano 2001.
7 Cfr. Geary, I Franchi, p. 10. In generale sui confini e le frontiere nell’alto Medioevo cfr. The Transformation of Frontiers from late Antiquity to the Carolingians, a cura di W. Pohl, I. Wood, H. Reimitz, Leiden-Boston-Köln 2001.
8 Geary, I Franchi, pp. 13-14.9 Cfr. C. Wickham, La campagna e la città. Gli Appennini toscani nell’alto Medioevo, Torino 1997 (ed.
or.: Oxford 1988). Uno degli esiti più recenti della stagione di studi avviata da Wickham è costituito da I. Santos Salazar, Una terra contesa. Spazi, poteri e società nell’Emilia orientale dei secoli VI-X, Firenze 2011.
10 Cfr. G. Sergi, Alpi e strade nel Medioevo, in Gli uomini e le Alpi – Les hommes et les Alpes, Atti del convegno (Torino 6-7 ottobre 1989), a cura di D. Jalla, Torino 1991, pp. 43-51.
13
che, su tempi lunghi, risultano essere interessate da un transito significativo - ci permette di porre in rapporto i singoli percorsi viari con la storia politica, economica e sociale del territorio in cui essi si collocavano. L’area di strada – ha scritto, infatti, Sergi – può contenere volta per volta un percorso, oscillante nel tempo, oppure può contenere contemporaneamente varianti quasi parallele. Se adottiamo questo concetto risulta agevole – e più aderente alla realtà – ogni valuta-zione storica sul rapporto fra vie di comunicazione e società11. Tutto ciò risulta di particolare importanza per le Alpi e gli Appennini medievali, spesso caratte-rizzati, sia pur in forme per alcuni aspetti molto diverse, dal frazionamento e dall’instabilità dei poteri, da una forte militarizzazione del territorio e dal costante passaggio di persone che seguivano itinerari di raggio diverso, lo-cali, regionali, sovra-regionali e internazionali. Un frazionamento che ebbe parziale inizio negli anni immediatamente successivi alla caduta dell’Impero romano, età dalla quale ora partiremo per richiamare alcune fasi storiche in cui, lungo il millennio medievale, avvennero significativi cambiamenti strut-turali di cui dobbiamo sempre essere consapevoli quando conduciamo le nostre ricerche su ambiti territoriali, o su fasi storiche, più circoscritti.
2. L’alto Medioevo: dalla frammentazione all’unità d’età carolingia
Per la storia delle Alpi e degli Appennini la caduta dell’Impero romano d’Occidente segnò l’avvio di un processo di frammentazione del controllo politico, un processo che ebbe una sua accentuazione dopo la morte di Teo-dorico, con l’avvio della guerra greco-gotica (535-553). Per quel che riguarda le Alpi, dobbiamo ricordare innanzitutto come esse abbiano assunto un’im-portanza strategica e militare di grande rilievo soprattutto dopo il cedimento del limes del Danubio, quando a tutti gli effetti divennero un’area di frontiera attraversata da una rete di fortificazioni difensive, che solo gradualmente furono abbandonate nel corso del lungo conflitto che contrappose Ostrogoti a Bizantini. La fine di questo conflitto, con la conseguente effimera “restau-razione” bizantina, segnò, di fatto, anche la fine dell’unità politica delle Alpi e degli Appennini, una situazione che si accentuò con l’avvio della domina-zione longobarda. In questo contesto assistiamo nell’arco alpino, sia pure in modi e tempi molto diversi, all’affermazione di poteri locali che, di fatto, controllavano vie e valichi12. Rispetto a questa frantumazione del controllo territoriale, la grande forza dei Franchi fu quella di riuscire a cooperare con
11 Ibidem, p. 45.12 Sulle alpi altomedievali si veda il recente quadro d’assieme proposto in K. Winkler, Die Alpen im
Frühmittelalter. Die Geschichte eines Raumes in den Jahren 500 bis 800, Wien-Köln-Weimar 2011.
14
le popolazioni locali, sia pure con diverse strategie in quelle che, già a partire da questa fase storica – siamo ormai all’inizio dell’VIII secolo – si delinea-rono come le tre principali “aree” delle Alpi: quelle delle Alpi occidentali, che avevano il loro perno in Susa; quelle delle Alpi retiche, unite politica-mente nella Rezia curiense; e quelle delle Alpi Giulie, dove le popolazioni locali assieme a quelle slave, di nuovo insediamento, avrebbero dato vita alla Carantania/Carinzia13. La cooperazione franca con le popolazioni alpine divenne particolarmente preziosa attorno a metà del secolo VIII, con l’acuirsi del contrasto tra i Longobardi e la Chiesa di Roma. In questo contesto, com’è noto, Pipino III, divenuto re nel 751 in seguito alla deposizione dell’ultimo re merovingio – Childerico III – e i papi Stefano II e Zaccaria stabilirono un nuovo patto d’alleanza per consolidare le reciproche posizioni. Iniziò così una nuova fase storica, che ebbe importanti ricadute sul ruolo politico delle Alpi e dei suoi valichi. Non a caso questa nuova fase si aprì con due attraver-samenti delle Alpi, il primo ad opera di papa Stefano II, che nel 754 giunse nel regno franco per ungere re con l’olio sacro i figli di Pipino III14; il secondo ad opera del re franco, che discese con le sue armate forse attraverso il Mon-cenisio e la val di Susa15, una valle, quest’ultima, da tempo sotto l’influenza franca, come testimonia la fondazione in essa nel 726 dell’importante abba-zia di Novalesa da parte di Abbone, un personaggio strettamente legato a Carlo Martello16. Nonostante si trovasse sul versante “italiano” delle Alpi, infatti, il territorio di Susa, a conferma di quanto detto poc’anzi, non era sotto diretto controllo dei Longobardi che, qui come altrove, si erano premurati soprattutto di impedire l’accesso alle Alpi attraverso un sistema difensivo basato sulle chiuse costruite all’imbocco meridionale delle valli che porta-vano ai principali valichi alpini17. Questo sistema, già messo in atto, sia pur invano, dal re longobardo Astolfo per contrastare nel 754 la prima “discesa” di Pipino III18 apparve funzionare bene agli inizi degli anni Settanta del seco-lo VIII quando un altro papa, Adriano I, volle inviare dei suoi messi a chie-dere l’intervento militare del figlio e successore di Pipino III, Carlo Magno,
13 Cfr. Geary, I Franchi, pp. 3-4, a cui rimando anche per ulteriori riferimenti bibliografici.14 Cfr. Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829, qui dicuntur Annales Laurissenses maiores
et Einhardi, a cura di G. H. Pertz e F. Kurze, Hannover 1985 (MGH SS rer. Germ. in usum scholarum, 6), pp. 11-12.
15 Ibidem, pp. 12-15.16 Per un primo inquadramento di Abbone e della fondazione di Novalesa cfr. il commento all’atto di
fondazione di Novalesa di Patrizia Cancian riportato in Carlo Magno e le Alpi. Viaggio al centro del Medioevo, a cura di F. Crivello e C. Segre Montel, Milano 2006, pp. 46-47, a cui si può far riferimento anche per ulteriori indicazioni bibliografiche.
17 Su questi aspetti cfr. E. Mollo, Le “chiuse” alpine fra realtà e mito, in I Longobardi e le Alpi, Atti della giornata di studio Clusae Langobardorum, i Longobardi e le Alpi (Chiusa di San Michele, 6 marzo 2004), Susa 2005, pp. 47-66.
18 Annales regni Francorum, p. 13.
15
e dovette farli giungere a Marsiglia, in Franciam, via mare19. Nulla poterono, invece, le chiuse contro l’intervento armato del giovane re franco auspicato da papa Adriano I. Partendo da Diedenhofen, presso Treviri, dove aveva passato l’inverno in uno dei suoi palazzi, Carlo Magno secondo i sempre ben informati Annales regni Francorum - una sorta di “cronaca” redatta agli inizi del IX secolo in ambienti strettamente legati ai Carolingi - scese con il suo esercito sino a Ginevra dove, in base a uno schema già collaudato, divise le sue armate in due contingenti, uno da lui guidato, che entrò in Italia dal Moncenisio e dalla val di Susa, l’altro guidato da suo zio Bernardo, che scese dal Gran San Bernardo, allora ancora noto come mons Iovis, per congiungersi con il primo contingente poco oltre le chiuse di Susa, rivelatesi inutili in que-sta circostanza20. Tutti sappiamo come si concluse quest’impresa: dopo un lungo assedio, nella primavera del 774 Carlo Magno conquistò Pavia e, con essa, il regno dei Longobardi.
Dopo questa prima “discesa” Carlo Magno tornò in Italia altre quattro volte, attraverso itinerari che, purtroppo, non vengono descritti dalle fonti21. Sappiamo, però, che egli aveva piena consapevolezza dell’importanza delle Alpi per il consolidamento delle sue nuove dominazioni, completate, per quanto riguarda l’area al centro del nostro interesse, tra il 772 e il 774 con l’“annessione” di fatto della Rezia curiense e nel 788 con la conquista del ducato di Baviera; in tal modo, per la prima volta dopo circa trecento anni, l’intero arco alpino tornava a far parte di un unico “Impero” che, com’è noto, divenne realtà con l’incoronazione imperiale avvenuta il giorno di Natale dell’80022.
Il riconoscimento dell’importanza attribuita alle Alpi da Carlo Magno è confermato dalle disposizioni che egli emanò nell’806 per predisporre la sua successione, prospettando la costituzione di un regno che comprendesse l’I-talia e la Baviera - assegnato al figlio Pipino - con il conseguente controllo delle Alpi orientali; un altro regno che comprendesse grossomodo gli odierni territori della Francia e della Germania centrale, assegnati a un altro figlio – Carlo – a cui era aggiunta la val d’Aosta con il Gran San Bernardo; un terzo regno costituito dall’odierna Francia meridionale, assegnato al futuro impe-ratore Ludovico il Pio con la val di Susa e il Moncenisio23. In tal modo anche
19 Ibidem, p. 34.20 Ibidem, pp. 34-36.21 Su questi aspetti mi permetto di rimandare a G. Albertoni, Carlo Magno e la Valcamonica: il contesto
politico della donazione al monastero di San Martino di Tours, in La leggenda di Carlo Magno nel cuore delle Alpi. Ricerca storica e turismo culturale, a cura di G. Azzoni, Milano 2012, p. 150.
22 Per una ricostruzione più dettagliata di tutto ciò cfr. G. Albertoni, La politica alpina dei Carolingi, in Carlo Magno e le Alpi, pp. 49-74, in particolare pp. 59-66.
23 Ibidem, pp. 66-67.
16
Carlo e Ludovico avrebbero avuto modo di giungere in Italia ad auxilium ferendum fratri suo, si ita necessitas extiterit24.
Queste disposizioni non furono mai messe in atto a causa della morte precoce di Pipino e Carlo. Esse furono la base, tuttavia, di un altro provvedi-mento, questa volta operativo, assunto alcuni decenni più tardi, quando con il trattato di Verdun nell’843 i figli di Ludovico il Pio, dopo una drammatica guerra fratricida, si divisero i territori dell’Impero. Purtroppo le disposizioni prese a Verdun non ci sono giunte nel dettaglio, ma sappiamo che fu creato un regno dei Franchi orientali, che comprendeva i territori a est del Reno e, con molta probabilità, le Alpi orientali con l’esclusione delle propaggini più meridionali; un regno dei Franchi occidentali, con i territori a ovest del Reno e, infine, un terzo regno dalla strana fisionomia, che comprendeva l’Italia, gran parte dell’odierna Svizzera e i territori che lambivano il Reno sino alle sue foci25. Si trattò di una suddivisione che diede ulteriore importanza alla regione del Lago di Costanza, vero punto di snodo per le vie che portavano ai passi delle Alpi retiche, alla regione dell’alto Rodano, al Gran San Ber-nardo e al Moncenisio. L’importanza di queste aree regionali nei trasporti e negli equilibri politici dell’Impero carolingio è testimoniata dal ruolo, non solo religioso, assunto da alcune abbazie come Reichenau sul Lago di Co-stanza, San Gallo nell’odierno Cantone dei Grigioni o St.-Maurice d’Agaune nel Vallese. In questo contesto si consolidò un asse viario tra nord e sud che da Aquisgrana giungeva, appunto, al Lago di Costanza, attraversava i passi retici o il Gran San Bernardo e il Moncenisio, giungeva nella pianura padana per convergere poi su Parma, da dove era possibile valicare gli Appennini attraverso il passo della Cisa.
Il trattato di Verdun, con le sue disposizioni, non riuscì a impedire il defi-nitivo sfaldamento dell’Impero carolingio, giunto al termine nell’883, quan-do l’imperatore Carlo il Grosso, forse non a caso visto quanto abbiamo detto poc’anzi, una volta deposto si rifugiò e poi morì proprio sul Lago di Co-stanza, presso Reichenau, dove ancor oggi giacciono le sue spoglie. Per quel che riguarda la storia delle Alpi, la sua morte ebbe conseguenze più gravi rispetto ad altri territori.
24 In MGH, Capitularia regum Francorum, a cura di A. Boretius, I, Hannover 1883, n. 43, Divisio regnorum (6 febbraio 806), cap. 3, p. 127.
25 Albertoni, La politica alpina dei Carolingi, p. 71.
17
3. Il pieno e il basso Medioevo: verso una nuova frammentazione politica
La fine dell’Impero carolingio, infatti, significò anche la fine dell’unità politica delle Alpi, le quali, tuttavia, come mise chiaramente in risalto Theo-dor Mayer nel saggio ricordato in apertura, continuarono ad essere il princi-pale – e al contempo il più necessario - anello di congiunzione dell’Occidente europeo26. Ciò vale in particolare a partire dall’età ottoniana, quando il regno italico e quello teutonico – e per una fase non trascurabile anche quello di Borgogna - ripresero a intrecciare le loro vicende nel nuovo Impero romano-germanico, un Impero assai diverso da quello carolingio per innumerevoli aspetti, tra cui anche l’effettivo controllo dei territori che ne facevano parte, spesso delegati, in cambio della fedeltà politica, a esponenti dell’aristocrazia locale27. In questo contesto attorno alle “aree di strada” che convergevano sui principali valichi alpini vennero a crearsi, per opera dei medesimi esponenti dell’aristocrazia locale o su delega a enti ecclesiastici da parte degli impe-ratori, delle “signorie” territoriali che diedero vita a degli “stati regionali di passo”. Fu ciò che accadde, ad esempio, nell’alto Rodano, nella regione che convergeva sul Moncenisio, sull’abbazia di St.-Maurice d’Agaune e sul castello di Chillon con i Savoia; nei territori collegati al Gran San Bernardo e sul Simplon con gli Zähringer e gli Asburgo o nei territori posti attorno al Brennero con i Tirolo28. Spesso queste famiglie nobiliari, espressione per lo più della frammentazione e localizzazione dei poteri avvenuta in età post-carolingia, si erano innestate su un processo già avviato in precedenza da enti ecclesiastici quali abbazie e, soprattutto, sedi episcopali, le quali, nella dialettica di collaborazione e opposizione che caratterizzava i rapporti tra i “grandi” del regno e i sovrani, non di rado erano riuscite, soprattutto a par-tire dai primi decenni dell’XI secolo, a ottenere i poteri esercitati altrimenti dai “funzionari” pubblici. Non a caso i gruppi familiari a cui abbiamo fatto riferimento iniziarono ad auto-assegnarsi il titolo comitale per legittimare il loro potere signorile, espresso anche dalle loro residenze, i castelli, che proprio in questa fase storica – in “ritardo” dunque verso l’incastellamento padano o appenninico – iniziarono a moltiplicarsi nelle vallate, per lo più a mezza costa, da dove era più agevole controllare i movimenti lungo le vie di comunicazione.
26 Mayer, Die Alpen, p. 11.27 Per una ricostruzione sintetica ma puntuale di questi aspetti cfr. H. Keller, Gli Ottoni. Una dinastia
imperiale fra Europa e Italia (secc. X e XI), Roma 2012, in particolare pp. 109-120.28 Su ognuna delle dinamiche territoriali qui ricordate la bibliografia è assai ampia. Per un primo
quadro d’assieme mi limito a rimandare a Mayer, Die Alpen, pp. 12 e 14. Come modello d’analisi per un singolo caso è sempre di grande validità, anche metodologica, G. Tabacco, La formazione della potenza sabauda come dominazione alpina, in Die Alpen in der europäischen Geschichte, pp. 233-243.
18
Fu spesso proprio per iniziativa di questi signori territoriali che la viabi-lità interna alle Alpi fu agevolata grazie all’esercizio, per delega regia o per assunzione “spontanea”, di un potere di controllo che garantiva la sicurezza ai viaggiatori in cambio del pagamento di pedaggi garantiti dalla creazione di posti di dogana situati in posizioni strategiche, quali l’imboccatura di una valle o le zone di valico, dove per iniziativa signorile o ecclesiastica inizia-rono a essere costruiti anche ospizi che potessero garantire un ricovero. Il tutto, però, in un contesto “aperto”, che poteva dare, a partire da condizioni analoghe, esiti spesso assai diversi tra loro29.
Tra coloro che attraversavano le Alpi vi era, poi, una categoria partico-larmente incentivata non solo a percorrere le vie, ma anche a fare tappa in luoghi deputati. Facciamo riferimento ai mercanti, che furono attratti per lo più grazie alla fondazione di borghi nuovi, dalla vocazione commerciale, testimoniata dalla loro particolare topografia urbana incentrata sulle botte-ghe e i luoghi di mercato30. Essi venivano a completare una rete di rapporti commerciali per lo più già esistenti con i principali centri urbani posti nelle pianure, non lontane dalle Alpi. Si pensi, per esempio, ai casi di Verona, Mi-lano o Torino. Si trattava di rapporti commerciali che percorrevano le prin-cipali arterie in direzione longitudinale, ma che non di rado si riflettevano in commerci a carattere più locale anche nelle direttrici est-ovest, in contesti che integravano la “grande” viabilità con itinerari che non di rado potevano procedere via fiume31.
Le modifiche dell’habitat promosse nelle valli alpine dai signori locali nel corso dei secoli centrali del Medioevo s’innestarono in un contesto insedia-tivo e sociale assai complesso, nel quale il passaggio di mercanti, pellegrini o eserciti conviveva con una realtà più stanziale, basata sull’agricoltura e il pascolo e, a sua volta, fortemente differenziata in base alla tipologia degli insediamenti, nucleari o sparsi, alla loro altitudine, alla loro densità. In que-sti contesti rurali spesso si venivano a creare delle “comunità”, il cui ambito d’azione e i cui rapporti con i poteri signorili solo negli ultimi decenni sono tornati al centro dell’attenzione della ricerca, con la definitiva rinuncia a vi-sioni mitizzanti che le proiettavano sul lunghissimo periodo ed enfatizzava-
29 Cfr. ad esempio il caso ricostruito in G. Sergi, Contro il determinismo stradale: esiti diversi di due rami della Via Francigena, in Id., Antidoti, pp. 217-221.
30 Su questi aspetti si veda, ad esempio, il caso della regione tra Inn e Adige da me ricostruito in G. Albertoni, Il ruolo di vescovi e conti nello sviluppo urbano del Tirolo meridionale in età medievale (secoli XI-XIII), in Semifonte in Val d’Elsa e i centri di nuova fondazione dell’Italia medievale, a cura di P. Pirillo, Firenze 2004, pp. 39-63.
31 Su questi aspetti si possono vedere, a titolo di esempio, i casi ricostruiti in Vie di terra e d’acqua. Infrastrutture viarie e sistemi di relazioni in area alpina (secoli XIII-XVI), a cura di J.-F. Bergier e G. Coppola, Bologna 2008.
19
no le loro “libertà”32. Queste comunità talvolta furono degli efficaci alleati dei sovrani impegnati ad attraversare le Alpi e costretti a percorsi alternativi dall’ostilità dei signori territoriali che controllavano tratti di strade o i vali-chi a percorsi alternativi. In parte diverso fu il caso degli Appennini centro-settentrionali, dove le famiglie nobiliari che riuscirono a costruire delle ege-monie signorili lungo le principali vie e i valichi ad esse connesse – si pensi, per esempio, ai Canossa per una fase più risalente e poi agli Alberti, ai Guidi o ai Malaspina – dovettero confrontarsi costantemente con una controparte cittadina assai più presente rispetto all’ambito alpino.
Le Alpi e gli Appennini, così frammentati politicamente ed economica-mente, a partire dai secoli centrali del Medioevo non solo dovettero con-frontarsi costantemente con il nuovo protagonismo politico ed economico delle città, ma anche con le necessità logistiche e militari dei re di Germania che aspiravano alla corona imperiale e, di conseguenza, aspiravano anche di poter giungere senza eccessivi ostacoli a Roma: un’impresa notoriamente tutt’altro che facile in una realtà politica italiana segnata almeno dal Duecen-to da quella che Giovanni Tabacco definì come “coordinazione guelfo-ghi-bellina”, una coordinazione che legava strettamente gli ambiti politici locali a quelli sovra regionali33. In questo contesto i sovrani “tedeschi” che ambiva-no all’incoronazione imperiale cercarono di costruire una rete di alleanze che li accompagnasse lungo l’asse privilegiato delle loro “discese” in Italia, un asse che dal XII secolo si consolidò lungo un percorso che aveva i principali capisaldi in due passi: l’alpino Brennero e l’appenninico Cisa.
Ma la fedeltà di chi era posto a presidiare i valichi e le vie andava sempre contrattata, come dimostra il caso della drammatica spedizione di Enrico VII di Lussemburgo – l’Arrigo VII di Dante - una spedizione iniziata nel 1310, che ha lasciato traccia anche in un codice miniato fatto predisporre da suo fratello Balduino – arcivescovo di Treviri - a pochi anni dagli eventi, in cui è raffigurato per la prima volta il passaggio delle Alpi da parte di un sovrano
32 Cfr. ad esempio la recente ricostruzione proposta in L. Provero, Le parole dei sudditi. Azioni e scrit-ture della politica contadina nel Duecento, Spoleto 2012. Sui “miti” costruiti a partire dalle attestazioni delle comunità alpine medievali, e non solo, sono assai valide le considerazioni riportate in R. Rao, Le comunità rurali tra mito e realtà, in «Mundus. Rivista di didattica della storia», III, n. 5-6 (gennaio-dicembre 2010), pp. 135-141. Sulla “diversità” degli Appennini si veda, ad esempio, il caso di Firenze e del suo contado ricostruito in P. Pirillo, Creare comunità. Firenze e i centri di nuova fondazione della Toscana medievale, Roma 2007.
33 Cfr. G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano, Torino 1979, pp. 316-318.
20
medievale col suo seguito34.Quella di Enrico VII, infatti, fu una delle poche “discese” di un futuro
imperatore che dovette procedere attraverso percorsi alternativi rispetto a quelli consolidati sia nelle Alpi, sia negli Appennini. Per quel che riguarda il primo caso, si trattò di una scelta obbligata, dettata dai nuovi equilibri poli-tici nelle Alpi centro-orientali dove nel 1308 le ambizioni del conte Enrico di Tirolo, “signore” del Brennero, erano entrate in rotta di collisione con quelle del futuro imperatore per la contesa della corona di Boemia. Sconfitto, il con-te tirolese rimase per un certo periodo nel fronte contrario ai Lussemburgo, circostanza che costrinse Enrico VII a entrare in Italia da un passo per lui assai scomodo, il Moncenisio, controllato dai Savoia, suoi alleati. Giunto in Italia, dopo essere stato incoronato re a Milano dovette affrontare quella che, un po’ sommariamente, possiamo definire la “resistenza guelfa”, guidata da Firenze. Di essa ci offre un vivido quadro Dino Compagni nella sua Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi, quando ci ricorda il tradimento di Ghiberto da Correggio, allora signore di Parma e già stretto alleato di Enrico VII, e la conseguente “chiusura” della via che portava alla Cisa35. Dopo che i Fioren-tini avevano costituito una lega co’ Bolognesi, Sanesi, Lucchesi, e Volterrani, e Pratesi, e Colligiani e con l’altre castella di lor parte, stando a Compagni dissesi che i marchesi Malispini il voleano mettere per Lunigiana, e feciono acconciare le vie e allargare nelli stretti passi36. Si trattava di una “trappola”, ma, scrisse il Com-pagni, il futuro imperatore non vi cascò, perché Iddio lo ammaestrò. Dovette così abbandonare il proposito di valicare gli Appennini e, giunto a Genova, si imbarcò per l’alleata Pisa, dove “lo Imperadore” giunse a dì VI di marzo 1311 (=1312, n. d. R.) con XXX galee37. Da qui proseguì la sua tragica impresa che si concluse nel 1313 con la morte a Buonconvento, nel Senese. Con questo drammatico epilogo iniziò una nuova fase nella storia tra Impero e Roma, una fase che ebbe tra i suoi esiti una graduale rinuncia imperiale al dominio in Italia, con il conseguente disinteresse nei confronti del controllo dei prin-cipali valichi alpini e appenninici, risucchiati sempre più in una dimensione locale. Ma questa, come si suol dire, è ormai un’altra storia.
34 Il codice è oggi conservato presso il Landeshauptarchiv di Coblenza con la segnatura 1 C 1. ed è stato di recente oggetto di una mostra di cui segnalo il catalogo e un volume di saggi ad essa collegato: Kaiser Heinrichs Romfahrt: zur Inszenierung von Politik in einer Trierer Bilderhandschrift des 14. Jahrhunderts. Eine Ausstellung des Landeshauptarchivs Koblenz/Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz vom 15. März bis 26 Mai 2000 im Landeshauptarchiv Koblenz, Koblenz 2000 e Kaiser Heinrichs Romfahrt: zur Inszenierung von Politik in einer Trierer Bilderhandschrift des 14. Jahrhunderts. Begleitpublikation zur gleichnamigen Ausstellung im Landeshauptarchiv Koblenz, a cura di W. Schmid, Koblenz 2000.
35 Cfr. D. Compagni, Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi, introduzione e note di G. Bezzola, Milano 1982, XXX, pp. 249-250.
36 Ibidem, XXXIV, pp. 256-258.37 Ibidem, XXXV, p. 259.
21
Giuliano BiolchiniGian Paolo Borghi1
ESEMPI DI ESPRESSIVITÀ TRADIZIONALE FRA APPENNINI E ALPI:L’ESEMPIO DEI CARNEVALI NELLA VALLE DEL PANARO
Sommario: 1. Premessa. 2. I Carnevali nella Valle del Panaro modenese. 3. Aspetti etnografici del Carnevale itinerante dei Mascheri e dei Lacchè nella Valle del Panaro
1. PremessaCon il nostro intervento ci prefiggiamo di analizzare un rituale del ca-
lendario tradizionale che presenta accentuate attinenze tra i mondi popolari appenninico e alpino. Si tratta, in specifico, di una tipologia di carnevale che conserva tuttora particolari peculiarità e che è a tutt’oggi stata soltanto ri-scontrata, per il territorio emiliano, nell’area appenninica della Valle del Pa-naro modenese. Di questo carnevale verranno fornite due chiavi di lettura, la prima specificamente antropologica e la seconda con connotazioni più pro-priamente etnografiche. Per ulteriori approfondimenti e riscontri analogici rimandiamo al nostro studio sul Carnevale di Benedello, citato nella biblio-grafia in calce alla relazione. Specifichiamo che il presente contributo è il pri-mo di una serie che ci proponiamo di dedicare a riti e a tradizioni variamente riscontrabili sia nelle culture tradizionali alpine sia in quelle appenniniche.
2. I Carnevali nella Valle del Panaro modenese
Tra le diverse forme di espressività tradizionale, i Carnevali occupano senz’altro un ruolo di rilievo. I recenti studi e le ricerche sui Carnevali defi-niti di “tradizione” o “rurali” ci confermano che queste particolari forme ri-tuali erano un tempo diffuse su un ampio territorio. Di queste antiche forme oggi è possibile trovare testimonianze e riscontri in alcune particolari “isole” geografiche delle Alpi e dell’Appennino Settentrionale, come si potrà legge-re nella Bibliografia. Esempi interessanti possiamo trovarli ancora in funzio-ne in alcuni Carnevali dei paesi situati lungo la valle modenese del Panaro, ma anche in Trentino, ed in particolare nelle Valli di Fassa e di Non, nonché
1 Giuliano Biolchini ha redatto il primo paragrafo; a Gian Paolo Borghi si devono l’introduzione e il secondo paragrafo. La bibliografia è stata curata congiuntamente dai due relatori.
22
in Veneto e, in particolare, nel bellunese di area ladina. Allo stesso tempo, in Provincia di Alessandria, nel Carnevale della Lachera di Rocca Grimalda, possiamo riconoscere nella figura del Lacchè, una “maschera” condivisa e presente in tutti questi Carnevali, segnalata anche dal Giannini relativamen-te al contado lucchese. La particolarità di questo “dato” consiste nel fatto che fino a pochi anni or sono non esisteva tra queste diverse realtà folkloriche una conoscenza reciproca. Del resto, a tutt’oggi non sono state rilevate tracce che dimostrino particolari elementi di “contatto” o di “relazione” né econo-mica né politica tra queste diverse aree, tali da ipotizzare qualsiasi tipologia di scambio, influenza o contaminazione. Pertanto, l’ipotesi più accreditata, che potrebbe giustificare questa convergenza, è data dall’idea di una forma rituale “comune”, presente e diffusa non solo nell’Italia Settentrionale ma anche in diverse aree dell’Europa, che, con il passare del tempo si è gradual-mente trasformata fino a perdere o, meglio, a nascondere molti degli elemen-ti originali. Del resto, già a partire da metà ’800, i Carnevali di tipo “urbano” rispondevano in modo più coerente a finalità di tipo economico/turistico piuttosto che a ritualità propiziatorie in cui i significati, come ben sappiamo, erano riferiti al purificarsi, al rinascere della natura, alla fecondità e all’ab-bondanza della comunità di appartenenza. Questa trasformazione avrebbe avuto come conseguenza una “soppressione” di questa festa in molte aree geografiche ed una “sopravvivenza” limitata e riscontrabile solamente in al-cune “isole” particolarmente refrattarie al cambiamento.
Molti sono gli etnologi, gli studiosi di tradizioni popolari e di antropo-logia, che ci propongono un tipo di interpretazione secondo cui i Carnevali possono essere ricondotti ad un’unica forma rituale che intende celebrare la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Lo stesso Paolo Toschi, insigne studioso di tradizioni popolari e direttore per decenni della rivista “Lares”, ci suggerisce, nel suo testo fondamentale, Le origini del Teatro italiano, una stimolante chiave interpretativa relativa a tutte queste antiche pratiche ritua-li, ricostruendone il percorso storico e simbolico. Attraverso la sua attenta ed approfondita analisi è possibile ricondurre gran parte di queste forme espressive a ritualità già presenti presso antiche Civiltà in epoche remote. Allo stesso tempo, in base alla comparazione di queste feste, è possibile nota-re come, nella ricerca della sopravvivenza, esse si siano “adattate” ai diversi contesti religiosi, storici e culturali.
Del resto non sembra casuale nemmeno il fatto che queste ritualità coin-cidano con momenti particolari dell’anno in cui avvengono variazioni im-portanti dal punto di vista climatico (con variazioni della luce, del calore) che hanno come risultato la maturazione dei prodotti e degli alimenti del-la terra. Questi passaggi e scansioni temporali sono stati “misurati” e “se-
23
gnati” nel corso della storia utilizzando calendari diversi. Se prendiamo ad esempio il calendario Celtico, l’inizio dell’anno viene fissato a Novembre, alla conclusione del ciclo agrario, mentre nel calendario Giuliano il capodan-no è convenzionalmente datato al 1° gennaio, sulla base di considerazioni e avvenimenti più di tipo politico che non climatico/metereologico. Infine, sappiamo che nel calendario agrario viene preso in considerazione il mese di marzo come data di inizio anno, esattamente alla ripresa dei lavori nei campi dopo la pausa ed il riposo invernale. Secondo tale ipotesi questi tra-sferimenti di data di inizio anno, dovuti certamente all’adozione dei diversi calendari, ma anche ad un adattamento al nuovo clima religioso introdotto dal Cristianesimo, avrebbero finito per favorire un “fiorire” di tipologie di feste, una pluralità ed una molteplicità di rituali “declinati” secondo varie modalità celebrative. Inevitabilmente i continui trasferimenti avrebbero age-volato contaminazioni, sostituzioni, sovrapposizioni di feste, rituali, ma an-che divinità, rendendo difficile e non agevole riconoscerne l’origine comune. Un ulteriore elemento “comune”, essenziale al fine di una possibile decodi-ficazione/interpretazione, lo troviamo nelle indicazioni che Frazer espone ne Il ramo d’oro. Lo studioso sostiene che alla base di queste ritualità vi fosse un antico principio magico molto praticato presso le antiche Civiltà e meglio conosciuto come “magia simpatica”. Seguendo questo principio, tutte queste cerimonie avrebbero avuto l’intento di “risvegliare” le affinità tra due ele-menti simili nella speranza di creare un effetto che fosse protratto nel tempo. Ecco quindi che ad un’intensa manifestazione di tripudio, gioia, abbondanza doveva corrispondere altrettanta generosità nei raccolti. La finalità sarebbe dunque da ricercarsi nel tentativo di provocare, propiziare ed assicurare un prosperoso svolgersi degli avvenimenti ed una generosa raccolta dei prodot-ti per l’anno agricolo appena nato.
D’altronde, sempre il Toschi sostiene di “avere la certezza” che tutte que-ste feste che celebrano la fine dell’inverno e l’inizio della primavera fossero legate tra di loro da un filo ininterrotto. Dagli antichi Saturnali romani ai Carnevali, possiamo ritrovare gli stessi elementi e le stesse modalità celebra-tive in cui l’orgia alimentare vuole festeggiare la fine degli stenti e l’inizio di un nuovo periodo di abbondanza e fertilità, dove il caos primordiale dovuto alla fine di un ciclo e l’inizio di un altro, è rappresentato dal punto di vista sonoro/musicale con eccesso di rumore, chiasso, baccano. Sembra quindi più che convincente l’ipotesi secondo la quale sia da scartare l’idea che ad una determinata data corrisponda una determinata cerimonia. Se abbando-niamo anche solo per un attimo una visione così rigida e schematica, possia-mo raggruppare tutti questi eventi, che si sviluppano su un arco di tempo che inizia a novembre e si conclude dopo Pasqua, per ricondurli ad un unico
24
evento che ha lo stesso scopo e la stessa funzione. È più che comprensibile, del resto, che durante il lungo tempo invernale queste popolazioni svolges-sero riti di buon auspicio, affinché i raccolti dell’estate fossero benevoli, che i raggi del sole irradiassero la terra in modo uniforme, che vi fosse pioggia, ma in giusta quantità in modo da non danneggiare i raccolti, i frutti della terra. Tra i diversi elementi utilizzati in queste ritualità, oltre al fuoco, al fumo, un posto di rilievo è occupato da suoni e rumori. Questa osservazione ci ripor-ta a quel “mondo magico” cui Frazer fa riferimento, basato sul concetto di “risonanza” o “simpatia” la cui finalità sarebbe quella di allontanare, esor-cizzare gli spiriti nefasti e malvagi. Ecco che se prendiamo in considerazio-ne questa chiave interpretativa, osservando ed analizzando attentamente lo svolgimento e le modalità espressive nelle diverse fasi della festa, è possibile uscire da una visione semplicemente folkloristica per indirizzarci verso una decodificazione del linguaggio simbolico. Infine è importante tenere nella giusta considerazione il fatto che molti di questi processi di trasformazione e ri-elaborazione sono avvenuti seguendo modalità non dichiarate, inconsape-voli, lasciando quindi anche pochissime tracce visibili e riconoscibili.
Paolo Toschi, nelle sue analisi, riserva una particolare attenzione allo stu-dio del Carnevale indicandolo come la “più importante forma espressiva” del Teatro popolare che, peraltro, sta alla base sia del Teatro italiano “erudi-to” sia della Commedia dell’Arte. In tutte le sue varie espressioni, che com-prendono anche “mascherate” e “cortei”, i Carnevali pongono alla base di tutto la rappresentazione di un “mondo alla rovescia” in cui i servi diven-tano temporaneamente padroni e i padroni diventano servi, il Re diventa giullare e il giullare diventa Re, le cose ordinarie divengono importanti e le cose importanti vengono sminuite e derise. Il rovesciamento delle gerarchie coinvolge non solo l’aspetto sociale ma anche quello corporale, per cui i sensi corporali emergono e vengono posti in primo piano. Le forme espressive po-etiche teatrali e musicali, infine, assumono, attraverso la parodia, lo scherno, la satira, la funzione di sfogo e di denuncia burlesca delle ingiustizie, degli abusi. Il ridere e lo sbeffeggiare il potere, la cultura ufficiale, la gerarchia divengono un modo per condividere punti di vista, rendendo esplicita una chiara consapevolezza del proprio vivere. Detto questo, si può ben compren-dere come questa favolosa eredità che ci arriva dal Medioevo abbia trovato “terreno fertile” e si sia innestata, a sua volta, su una precedente tradizione, che ri-utilizza elementi teatrali, musicali, coreutici secondo una prassi di una continua trasformazione e continuo adattamento di elementi preesistenti.
Il rovesciamento di ciò che è ordinario, assieme all’eliminazione di tutto ciò che è vecchio e contaminato, assume un significato simbolico di purifi-cazione, rinnovamento e propiziazione. Queste modalità espressive, come
25
noto, appartengono ai riti di fertilità, i cui princìpi sono ben conosciuti e riscontrabili in tutte le religioni, anche precedenti il cristianesimo. Per soste-nere questa tesi non è necessario cercare forme rituali analoghe nell’etnolo-gia oppure nella storia delle religioni o nelle interpretazioni psicologiche del periodo contemporaneo, è sufficiente osservare ed analizzare attentamente ciò che di questi elementi è riuscito a trasmigrare nel folklore. Attraverso la soppressione del capro espiatorio, nella mentalità popolare, si realizza quel principio grazie al quale è possibile eliminare il male trasferendolo su un oggetto: una bestia, un fantoccio, un essere umano in cui vengono concen-trati tutti i mali della comunità. Basta quindi sopprimere questo “qualcuno” o “qualcosa” che l’intera comunità può trarne vantaggio ritornando pura, sana. Anche il piacere della mensa, del mangiare e del bere, dello stare insie-me, dell’amore e dell’unione dei sensi, del canto, della musica e della danza, così come dello scherzo, della satira, hanno una valenza che può essere sia psicologica sia spirituale. Lo scopo principale è riconducibile al sollecitare e stimolare uno stato d’animo di apertura e rinnovamento: a ciò contribuisco-no il riso, la gioia, l’ebbrezza e, paradossalmente, la follia.
Da qualche tempo sono stati avviati studi approfonditi che stanno cer-cando di documentare come queste feste, che intendono celebrare il rin-novarsi della natura e la propiziazione dell’annata agricola, possano esse-re ricondotte a rituali già presenti nel Neolitico, cioè nel periodo in cui le persone, le popolazioni, cessando di girare e divenendo stanziali, vivevano prevalentemente di ciò che l’agricoltura poteva offrire loro. La “dipendenza” del loro livello di “benessere” e della stessa sopravvivenza dall’abbondanza del raccolto avrebbe quindi dato vita a forme magico/rituali al fine di propi-ziare il terreno per l’annata successiva. Queste modalità interpretative, che forse possono apparire semplicistiche, in realtà contengono una forte base di veridicità, sono verosimili in quanto il mondo quotidiano di queste persone era essenzialmente legato alla terra, su ciò che essa poteva offrire, e basato su cose semplici. Queste popolazioni non conoscevano altri linguaggi se non quello dell’osservazione della natura.
Al fine di comprendere meglio la materia di cui stiamo trattando, pro-poniamo una suddivisione schematica dei Carnevali utilizzando il seguente schema: da un lato possiamo inserire i “Carnevali turistici” (Caro Bajora, 1989), che si sviluppano con una certa popolarità a partire da metà ’800 e che hanno avuto come centro di interesse l’aspetto economico legato alla curiosi-tà che un evento di questo tipo poteva suscitare. Dall’altro lato invece possia-mo collocare i “Carnevali di tradizione” o “Carnevali rurali”, spesso definiti più semplicemente “Mascherate”. Analizzando attentamente quest’ultima tipologia espressiva è possibile scoprire “sedimenti” rituali che si intreccia-
26
no con la storia delle Civiltà che si sono susseguite lungo il corso dei secoli. Molto spesso coloro che ancora oggi promuovono e sostengono questi eventi tradizionali non sono consapevoli di essere portatori di una antica cultura.
I Carnevali che si sono svolti almeno sino a metà ’900 lungo la vallata del Panaro modenese appartengono a quella forma definita appunto “di tradi-zione”, che si distingue dai Carnevali “turistici” sulla base delle finalità: essi non intendono soddisfare l’aspetto economico, ma vogliono invece esprime-re e rafforzare la coesione all’interno della comunità di appartenenza. Anzi, uno degli aspetti fondamentali di questa pratica è proprio basato sul senso dell’offerta, del dono come manifestazione esplicita di partecipazione e di appartenenza. D’altronde, una delle principali caratteristiche risiede appun-to nella funzione che svolge e cioè nel rinsaldare legami di parentela, di ami-cizia, utilizzando linguaggio e riferimenti caratteristici del mondo agricolo e contadino.
La scoperta di un’attestazione archivistica, risalente alla fine del ’700, in cui viene riportato un fatto realmente accaduto durante un Carnevale a Benedello (frazione di Pavullo nel Frignano), ha confermato la presenza ed ha arricchito la già notevole documentazione orale sulla esistenza di questa festa popolare che tutt’oggi si svolge ancora attorno al Bal di Màscher (Ballo dei “Mascheri”, in quanto praticati, secondo i canoni tradizionali, solo da uomini). La stessa tipologia di Carnevale era in uso, almeno fino alla prima metà del ’900, in molti altri paesi lungo tutta la valle del fiume Panaro, tra cui Ponte Samone, Castagneto, Iddiano, Verica, Coscogno (frazioni di Pavullo nel Frignano), Pazzano di Serramazzoni, Salto, San Giacomo e San Martino di Montese, Montecorone di Zocca e Marano sul Panaro. Il lavoro di docu-mentazione relativo alle fasi e alle modalità espressive della festa si è basato da una parte sulla “mappatura delle fonti scritte” disponibili, dall’altra sulla ricerca di fonti orali e iconografiche, riportando alla luce alcune foto di inizio Novecento (Biolchini-Borghi). A questo si deve aggiungere un lavoro di do-cumentazione etnografica svolto da Giorgio Vezzani, Romolo Fioroni e Gian Paolo Borghi, finalizzato alla pubblicazione di alcuni articoli sulla rivista di tradizioni popolari “Il Cantastorie” ad inizio degli anni ’80.
Negli ultimi decenni, tuttavia, si sono verificate importanti trasforma-zioni, che hanno condotto all’interruzione oppure all’integrazione delle ma-nifestazioni più piccole all’interno di altre realtà più consistenti. Per alcuni di questi Carnevali la via intrapresa si è indirizzata verso una forma di ri-chiamo, di attrazione turistica o comunque di stimolo commerciale. Altre esperienze invece hanno intrapreso la via dello spettacolo folklorico vero e proprio, grazie soprattutto a finanziamenti regionali che ne hanno favorito la prosecuzione e la sopravvivenza. In ogni caso, un aspetto comune, che può
27
essere facilmente rilevato, riguarda il coinvolgimento e la relativa valoriz-zazione sia della parte femminile sia del “vivaio”, composto da bambini in grado di garantire e motivare, in questo modo, una certa continuità. Ritengo sia importante, al fine di comprendere meglio il processo di modificazione avvenuto, riassumere e sintetizzare questi continui, costanti ed inevitabili cambiamenti in almeno tre momenti specifici, di rilevante impatto e cambia-mento. In ordine di tempo, il più recente momento di forte trasformazione coincide con il passaggio da una Civiltà prevalentemente contadina ad una società industrializzata avvenuto negli anni ’70 del Novecento. Altro forte momento trasformativo che ha condizionato ed influenzato tutti i temi ine-renti la “tradizione” si è verificato durante il “ventennio” fascista. Infine, un altro passaggio importante coincide con l’azione dei Parroci (in modo parti-colare verso la fine dell’800), secondo i quali la diffusione di queste pratiche erano causa principale del decadimento morale della società e occasione di sfogo di passioni. Le polemiche relative a queste tematiche sono facilmente rintraccia-bili sulle cronache dei giornali. Queste semplici osservazioni possono aiu-tarci a comprendere la ragione per cui molti di questi significati appaiono o siano sopravvissuti solamente in secondo piano, semi-nascosti.
La musica nei Carnevali, come del resto in tutte le ritualità, è funziona-le allo svolgimento della rappresentazione, è il motore, lo stimolo che ne scandisce i tempi, che dà inizio e chiude le danze. Diversi sono gli studi e gli approfondimenti dedicati al ballo ed alla musica strumentale che accom-pagna queste feste. Si tratta di corpi in movimento, di processioni festose che producono senso e significato in relazione alla musica. I “mascheri” ac-compagnati dal suono si muovono nella piazza, per le strade, si spostano da un luogo all’altro, da una borgata all’altra, si incontrano, si salutano e si separano nuovamente. Nel caso specifico, la musica utilizzata per l’esecu-zione di questo ballo saltato è eseguita su un ritmo di 2/4 (quindi una polca, anzi i suonatori popolari la indicavano come pulcrina, ovvero una polca di facile esecuzione in quanto doveva essere eseguita e ripetuta per un tempo considerevole e in condizioni atmosferiche non sempre ottimali). Nella me-moria popolare questo ballo è noto come Bal di Màscher, ed è stato “tradotto” in italiano con il termine “manfrina”. Molto probabilmente la mutazione del nome è avvenuta nel momento in cui si è cercato di dare visibilità a que-sto evento sugli organi di informazione, giornali, radio e televisioni locali, nel tentativo di esprimere l’idea di un ballo “ripetitivo” ed “antico”. Diversi sono i titoli di brani utilizzati: Oggi nevica, Fiocca la neve, Marsala bella, Giro-tondo, Primo dagli del gas, Carnevalina e molti altri (per approfondimenti si veda Il Carnevale di Benedello, di Biolchini-Borghi). All’interno del Carnevale possiamo trovare, oltre al caratteristico ballo, altri interessanti elementi so-
28
nori, come ad esempio la nécia (nicchia). Questo strumento, ricavato da una conchiglia di mare, ha la funzione di annunciare l’arrivo del Carnevale e dei mascheri, di segnalare la posizione del corteo grazie alla qualità e all’inten-sità del suono prodotto che può essere udito anche da molto lontano. Un elemento sonoro aggiuntivo lo troviamo nei grilìn (che richiamano il canto dei grilli), i campanellini fissati sull’abito del Lacchè, che producono suono ad ogni minimo movimento del ballerino.
Seguendo questo approccio è possibile notare come gli studi sul “Paesag-gio sonoro” di Schaefer e le prospettive di ricerca di Stefen Feld abbiano avu-to una certa importanza anche in relazione agli studi sui Carnevali. Diversi studiosi hanno dedicato un’attenzione particolare alle relazioni che il suono ha con le attività sociali e ciò ha permesso, in un certo senso, di riconside-rare e reindirizzare la ricerca etnomusicologica avviando la disciplina verso un’antropologia della musica, portandola fuori ed oltre i limiti di un’analisi comparativa dei repertori e dei testi musicali. Del resto, sull’uso del suono e del rumore come elemento propiziatorio, sono stati avviati diversi studi le cui conclusioni però, da diversi punti di vista, sono ancora da scrivere. Da qualche tempo a questa parte l’osservazione e l’analisi dell’elemento mu-sicale, che viene ad esprimersi durante questi eventi, sono state allargate all’elemento sonoro nella sua globalità includendo quindi anche il rumore, il frastuono e il chiasso come espressioni sonore caratteristiche del Carne-vale. In particolare, le analisi si sono concentrate sull’uso dei campanacci, campanelli, campanellini, e di tutti quegli strumenti che producono suoni metallici e che richiamano alle mente gli studi e le ricerche sullo Charivari, ovvero quelle forme sonore rumorose a carattere propiziatorio che venivano utilizzate in occasione di matrimoni tra vedovi. Sempre sull’uso dei campa-nacci e sul loro significato propiziatorio possiamo trovare interessanti studi dedicati al Trato marzo, riferiti alla pratica dell’alpeggio in Trentino. Rumori, mortaretti, scoppi di petardi, ma anche il chiasso delle persone che parlano e si salutano, le automobili e macchine di vario tipo, divengono un frastuono organizzato, un fragore, un’orgia acustica, che non solo trasgredisce norme sociali ma diviene anche, secondo questa prospettiva, apotropaico. Il suono, assieme al fuoco, assume una valenza come elemento morfologico antagoni-sta del demonio, che serve per allontanare spiriti ed entità nefaste.
Oltre alla musica, al suono, alla danza, vi sono altri importanti ingredien-ti che contribuiscono alla costruzione di questa forma espressiva di Teatro popolare. Ne è, ad esempio, una chiara manifestazione la ripresa, il prolun-gamento a metà Quaresima della festa di Carnevale. Qui troviamo più mar-catamente presente l’elemento narrativo che si manifesta durante la rappre-sentazione del processo e del testamento. Diverse sono le figure in costume
29
e i personaggi che si muovono all’interno di un “canovaccio”, collaudato da tempo, la cui parte finale prevede la messa in scena di un processo, con relativa condanna e rogo finale del Carnevale personificato nella Vecchia, che nel frattempo si è trasformata in grande fantoccio. Questi elementi sono ca-ratterizzati da un’esplosione di gioia collettiva, propiziatoria del bene della comunità, che utilizza il riso, lo scherzo, la satira e la burla come mezzo per eliminare il male e nello stesso tempo dare il benvenuto all’anno appena nato.
Volendo analizzare brevemente alcune tra le figure più importanti, con elementi decisamente originali, accenniamo al Lacchè. Il suo compito è quel-lo di annunciare l’arrivo dei mascheri, per questa ragione precede il corteo con degli “avanzamenti” che hanno, inoltre, la funzione anche di preparare e delimitare lo spazio scenico della piazza o del cortile nel quale avverrà la rappresentazione. Svolto questo compito, il Lacchè, sempre di corsa, rientra a ballare nel corteo assieme ai mascheri. È interessante notare come nell’im-maginario popolare, nell’interpretazione di questa figura, abbia prevalso l’a-spetto della prestanza fisica, della resistenza e dell’agilità nel ballare. Questa maschera esprime quindi valore e prestigio, ma chi ha approfondito gli studi sulla Commedia dell’Arte ed in particolare sulla figura dello Zanni, cono-sce bene l’importanza del “servo” come elemento carnevalesco, con il tipico ruolo di rovesciamento gerarchico dell’ordine prestabilito. Del resto nel si-gnificato italiano del termine Lacchè ritroviamo ben espressa tutta la conno-tazione negativa del servitore che, vestito in livrea, corre e scorta per strada la carrozza padronale. Si tratta evidentemente di un gioco del rovesciamento caratteristico del Carnevale in cui la persona che è sottomessa, ossequiosa nei confronti dei potenti e che si umilia, si disonora in modo servile, diviene nel periodo di carnevale il Re, il principale protagonista della festa. Il Lacchè non cammina ma balla e salta, fa inchini reverenziali fino a toccare la terra con la punta del lungo cappello, ha un bastone che tiene nella mano destra che rimanda all’idea dello scettro e del comando.
Altre figure essenziali sono rappresentate dal Vecchio e dalla già citata Vecchia. Sono gli sposi del Carnevale, gli unici personaggi con la maschera, che si esprimono prevalentemente a gesti, con movimenti grotteschi e che alternano momenti affettuosi a litigi e bisticci. La Vecchia, che è incinta, par-torisce proprio durante il Carnevale e sin dalla nascita inizia a maltrattare il neonato senza una ragione apparente. Appare invece chiaro il riferimento simbolico/rituale all’inverno, rappresentato dalla Vecchia, contrapposto alla primavera che sta per sorgere, con un nuovo inizio, una rinascita che segue il ciclo agricolo e calendariale della cultura contadina. La Vecchia, costretta a confessare tutte le malefatte ed i maltrattamenti procurati al figlio neonato,
30
viene processata e condannata a morte mediante rogo. Prima di morire però chiede di poter esprimere le proprie volontà nel “testamento”.
Troviamo, infine, il Dottore. Un po’ medico e un po’ notaio, si esprime utilizzando come forma poetica un metro libero in rima baciata. Attraverso questa struttura vengono confessati e denunciati pubblicamente “fatti” inu-suali, mancanze, errori, sgarbi, il tutto condito naturalmente da qualche stra-falcione grammaticale. Il Dottore deve sempre essere pronto e disponibile nel prendere le difese del suo gruppo durante gli incontri con altri Carnevali, in una sorta di “duello” verbale con Dottori di altre mascherate, deve assi-stere il parto della vecchia e procurarsi i rimedi contro i mali del neonato. A volte si esibisce come chirurgo con l’intento di togliere il “male” localizzato dentro la pancia della Vecchia con “scene” grottesche e ridicole. Ha, infine, il compito di preparare e leggere le ultime volontà, i “lasciti” che la Vecchia, prima di essere messa al rogo, vuole consegnare alla comunità. Quella del dottore è una figura che sotto molti aspetti ricorda la maschera del Balanzo-ne (o del Graziano) nella Commedia dell’Arte.
Molte altre sono le figure presenti in questa tipologia di Carnevale: il Portabandiera, le Guide, le Guardie, i figli della Vecchia, l’Arlecchino, i Mascheri. Mentre alcune di queste hanno assunto nel tempo un ruolo diverso, altre hanno perso di importanza e sono decadute.
Concludendo, ci sono fondati motivi per sostenere che in questa tipo-logia di espressività tradizionale sia possibile ritrovare quegli elementi che rappresentano la culla del Teatro in tutte le sue forme, sia erudito sia popo-lare. La caratterizzazione, inoltre, del luogo nel quale l’azione drammatica viene rappresentata, sulle piazze, nei crocevia, sull’aia o lungo le strade, di-venta elemento distintivo che qualifica la sua origine, la sua funzione e la sua modalità di elaborazione espressivo/comunicativa. È possibile quindi individuare in questi modelli di Carnevale un magnifico esempio di “Te-atro popolare” ricco di riferimenti simbolici e di collegamenti più o meno evidenti con il “mondo antico” ed una festa “profana” densa di significati semi-nascosti nei suoi elementi musicali, teatrali e coreutici.
3. Aspetti etnografici del Carnevale itinerante dei Mascheri e dei Lacchè nella Valle del Panaro
Ai nostri giorni sono due le località del territorio appenninico modene-se nelle quali si continua ad organizzare un Carnevale di questa tipologia: Benedello e Verica. Le modalità operative sono sostanzialmente coincidenti con quelle analizzate nel precedente paragrafo. Tra le due località permane
31
tuttora un forte spirito di emulazione. Erano pressoché mancanti, fino agli anni ’80 del ’900, studi specifici intor-
no a questo carnevale, ad eccezione di un riferimento in una relazione conve-gnistica e di un lavoro monografico redatto da Emilio Iacoli, dato alle stampe nel 1937. Quest’ultimo autore trattò sommariamente di tali cortei carnevale-schi, poiché aveva come quasi esclusiva finalità il mettere in risalto la figura e il ruolo della Vecchia, condannata in seguito al rogo, a Mezza Quaresima. Scrisse, tra l’altro, Iacoli:
Quasi in ogni anno, in qualche frazione di Pavullo, e più precisamente nelle frazioni situate lungo la sponda sinistra del Panaro, l’ultima settimana di carnevale, fra i giovani del posto, viene costituita la cosiddetta ‘Mascherata’. – Si tratta di un corteo carnevalesco formato di musici, di danzatori, di guardie armate e di una vec-chia che è la figura centrale del corteo, corteo creato in suo onore e di cui essa dispone a suo capriccio. Accanto alla vecchia, sta poi un’altra figura notevole, il così detto Dottore, una specie di ministro e di cancelliere, il quale dà forma al pensiero ed alla volontà della vecchia, esprimendoli in rozza rima.
Il corteo, sonando e danzando, va in giro per la frazione, accolto ovunque con grande deferenza e quasi in ogni casa gli vengono offerti cibo e vino.
Attributo caratteristico della vecchia è la più sfrenata libertà di atti e di parole, ed il dottore che ne esprime il pensiero, e che, di solito, è uno degli spiriti più salaci del paese, nell’incontrare i compaesani, di cui conosce vita e miracoli, mette in evidenza le loro malefatte, scendendo talvolta fino a rivelazioni, che non sempre restano senza conseguenze. Il pellegrinaggio di questo corteo da una casa all’altra, si traduce ine-vitabilmente in un’orgia che raggiunge il suo colmo nell’ultimo giorno di carnevale, dopo di che il corteo scompare.
La ricerca etnografica, effettuata grazie all’apporto di testimoni storici del carnevale, ha evidenziato una situazione che, nonostante il trascorrere del tempo, ha consentito di mantenere in essere sino ai giorni nostri alcune tra le principali specificità tradizionali.
Il testimone benedellese, Erio Baruffi, in particolare, ha ricordato come il cerimoniale più antico mettesse in atto i suoi primi passi durante le festività natalizie e di capodanno quando, in osteria, veniva discussa l’eventualità dell’organizzazione della cerimonia carnevalesca. In caso positivo, la noti-zia al paese (e ai dintorni) veniva diffusa attraverso l’inconfondibile suono della nécia, la già menzionata grossa conchiglia marina a forma conica. Lo stesso suono veniva in seguito prodotto dalle Guide (figure di compaesani che riscuotevano il rispetto generale e che garantivano il regolare svolgersi del corteo carnevalesco) per avvertire dell’arrivo della mascherata itinerante.
Di pari interesse risultava l’organizzazione di tre sere di ballo pubbli-co di fine carnevale, da domenica a martedì (con obbligo incondizionato di
32
“chiudere” alla mezzanotte del martedì grasso), durante le quali le ragazze, in compagnia del loro ballerino (unico per tutte e tre le sere), servivano gli “zuccherini” (dolci preparati esclusivamente per carnevale), collocandoli in un cestino di vimini infioccato con carte multicolori. I loro compagni di danza avevano invece il compito di servire il vino agli astanti. Il tutto veniva com-mentato salacemente dal Dottore. Altri zuccherini venivano poi ritirati dai giovani a casa dalle ragazze, la prima domenica di Quaresima.
I Lacchè e l’Arlecchino avevano anche il compito sia di annunciare l’arrivo del corteo mascherato sia di salutare con inchini alla sua partenza.
Un altro testimone, di Castagneto (in un suo memoriale dato alle stampe da Roberto Vaccari), ribadisce il ruolo fondamentale del Lacchè, marcata-mente sottolineato dal copricapo a forma conica (alto fino a 70-80 centime-tri), abilmente lavorato, con sottogola e con un pennacchio sulla estremità, simile a quelli portati dai carabinieri in alta uniforme. La sua autorità era (ed è an-cora oggi) sottolineata dal bastone del comando, guarnito di nastri colorati, che rimandano ai futuri colori della primavera. Tra gli altri personaggi della mascherata, il medesimo testimone ricorda il Vecchio, solitamente munito di bastone, e la Vecchia, che portava con sé molte cose, come la rocca, il fuso, un po’ di stoppa da filare, una sporta e un pupazzo (il figlio neonato). Entrambi indossavano (e indossano tuttora) maschere aventi sembianze tutt’altro che rassicurabili, un tempo preparate da loro stessi.
Da Verica perviene, invece, una preziosa testimonianza di Domenico Corsini sulla preparazione delle camicie dei Lacchè e sulla descrizione dei loro “berrettoni”:
Altro lavoro consisteva nelle preparazione delle camicie (la fioccatura); la cami-cia era preparata dalle donne di casa, le quali, non essendovi abbondanza di materiali e di denaro, usavano materiali di recupero, carte colorate recuperate dagli involucri delle cioccolate, delle caramelle, impiegavano con maestria tutto quant’altro potesse luccicare e rendere vistosa ed elegante la camicia […]. Sulla schiena, una moltitu-dine di cordelle multicolori, ognuna sapientemente fissata ed addobbata di roselline di carta o di altro materiale, mentre sulle spalle, a mo’ di gradi militari, spalline ricoperte di cartoncino rigido, rivestito di carta multicolore.
Il berrettone, usato tuttora dai vari gruppi folcloristici che si riallacciano ai tra-dizionali carnevali della vallata del Panaro, a tronco di cono, era e rimane un’opera d’arte. Di cartone leggerissimo, modellato sul capo del lacchè, era dotato di un cintu-rino sottogola che ne assicurava la stabilità.
La mascherata di riuniva (e si riunisce) a Metà Quaresima per processare la Vecchia e condannarla al rogo. La modifica del ruolo del Dottore, trasfor-matosi in Giudice, scandisce le fasi finali del rito attraverso la lettura del te-stamento della condannata (oggi questi testi sono notevolmente “smussati”
33
dei loro contenuti più hard, per evitare strascichi extracarnevaleschi…). Ieri come oggi, la sostituzione della Vecchia in carne e ossa con un fantoccio, fa-vorita dall’arrivo delle prime ombre serali, è un autentico esempio di teatro popolare di tradizione.
Così ricordò queste ultime fasi Emilio Iacoli:La vecchia [prima di essere processata] non è più il simbolo di un’orgia; essa
è mesta e piangente, e le guardie armate, che una volta erano gli esecutori dei suoi ordini, sono ora divenuti i suoi carcerieri. Essa viene trascinata verso uno spiazzo, dove è preparata una catasta di legna e quivi, con un’abile sostituzione di persona, un fantoccio preparato con gli stessi abiti della vecchia, viene in sua vece issato sul rogo e dato alle fiamme, tra gli evviva del popolo.
Mentre la Vecchia brucia, il Dottore, salito su un palco, legge il cosiddetto “te-stamento della vecchia” cioè una serie di lasciti scherzosi ed una lunga filza di rive-lazioni piccanti a carico dei compaesani, espressa con pochi eufemismi, che qualche volta ha richiesto l’intervento dell’autorità di P.S. per sospenderne la lettura.
Ai nostri giorni il corteo e la festa si mettono in moto (e verso la piazza del paese) l’ultima domenica di carnevale, mentre le Guide ordinano il via alle danze, alle quali partecipano anche donne e bambini. I Lacchè e i vari al-tri figuranti danno dimostrazione dei loro virtuosismi; il Vecchio e la Vecchia iniziano le loro scaramucce e la Vecchia comincia ad accusare dolori, assistita dal Dottore (spesso anche a colloquio, in rima baciata, con il pubblico), che la assisterà nel parto. Lunedì e martedì grasso la mascherata diviene itinerante e si caratterizza, durante i percorsi, per le continue accuse di infedeltà alla Vecchia e con la conseguente “scoperta” di “colpevoli”. La sera del martedì, una festa collettiva coinvolge fattivamente tutto il paese.
L’attuale composizione del corteo della mascherata è qui di seguito de-scritta da Erio Baruffi. Occorre anche precisare che durante il corteo itineran-te, non di rado alcuni giovani appostati volutamente in retrovia provano a giocare qualche scherzo alla popolazione: tolgono le imposte delle finestre, portano con sé qualche oggetto, spostano in altro luogo cesti, biancheria ste-sa ad asciugare ecc.. Ma ecco l’ordine gerarchico con cui si muove questo corteo:
… davanti tre Lacchè, vestiti con abiti aderenti, guarniti con fiocchi e decora-zioni di carta e con un curioso copricapo a cono altissimo e in mano una bacchetta infioccata, poi viene l’Arlecchino, che, vestito come l’omonima maschera, segue le mosse dei Lacchè. Seguono due o tre “guide”. Mentre i Lacchè debbono essere buoni ballerini, le “guide” sono scelte per la loro rispettabilità; esse infatti non ballano ma sono garanti dell’organizzazione e della serietà della mascherata. Segue l’orchestra, composta da quattro o cinque elementi tradizionali: clarino, fisarmonica, chitarra e trombone. Viene poi il “portabandiera”, altro ottimo ballerino, che procede danzando
34
e sostenendo uno stendardo che inneggia al paese e al carnevale. Seguono poi elemen-ti che rappresentano maschere varie, tra queste, forse la più simpatica è quella dei fanciulli ballerini, vera “scuola” per futuri protagonisti della mascherata.
In chiusura, alcuni frammenti di testi letti dal Dottore prima del rogo del-la Vecchia, nel pieno rispetto della grafia dialettale utilizzata dagli anonimi autori. Il primo, che inusualmente si avvale di un modo discorsivo misto tra italiano (nella stesura del verbale della sentenza di condanna) e dialetto, è stato ideato a Verica:
Oggi… alle ore… si riunisce in seduta straordinaria questo Tribunale per deci-dere, sentite le parti in causa ed i testimoni della sorte della Vecchia del Carnevale, signora Casimira Fattiavanti, assistita dall’avvocato di fiducia Fattinquà. La signora Fattiavanti, è chiamata a rispondere di una serie non definita di reati contro la pro-prietà, contro l’ordine pubblico, contro la morale, il buon costume, ed in specie il di lei marito Pietro Fattindietro, assistito dall’avvocato Fattinlà. Silenzio ed in piedi…entra la Corte!!!
E il Giudice-Dottore del Tribunale si presenta subito:Mè a sun al giòdèz dal Tribunèl,…cù la toga e e capel,/c’a cundan senza remi-
siùn… i delinquent e i pùc ed bùn.(Io sono il giudice del Tribunale,… con la toga e il cappello,/che condanno sen-
za remissione… i delinquenti e i poco di buono).Questa è la lettura di un verdetto pronunciato a Benedello:A nom attota la maschereda, che an e an la bala par la streda/le agié secon giu-
stezia/le agié in mod che vaga veia la cattiveria e che estaga su l’amicezia/la vecia per al so cuip/le cundanà e proma etzira in piaza lavagna da brusà/e vec alam brisa vlò cundanee/perché lu de mel ennevre brisa fa/cuol cla fat alam perdunà/i fio perché ingavien più la veta dura/tent che is disintosichen i mandam in cà at cura/acsè iam perdunà/parchè isposen inserì in dla società.
(A nome di tutta la mascherata/che [da] anni e anni balla per la strada/si è agito secondo giustizia/si è agito in modo che vada via la cattiveria e che stia su l’amicizia/la vecchia per le sue colpe/è condannata e prima di sera in piazza l’abbiamo da bru-ciare/il vecchio non lo abbiamo mica voluto condannare/perché lui del male non ne avrebbe fatto/[per] quello che ha fatto lo abbiamo perdonato/i figli perché non abbiano più la vita dura/tanto che si disintossichino li mandiamo in casa di cura/così li abbia-mo perdonati/perché si possano inserire nella società).
Un lascito, infine, letto a Castagneto. La sua motivazione fu avvalorata dal fatto che un soldato, congedatosi, si era portato a casa una grossa padel-la, che in famiglia veniva riempita d’acqua e usata come catino per lavarsi:
A las a la muiera de stradìn/e savò e e cadìn/e po s’la vôl dventèe più bèla/ch’la lasa ste ed laves in tla padela.
(Lascio alla moglie dello stradino/il sapone e il catino/e poi se vuole
35
diventare più bella/che lasci stare di lavarsi nella padella).Occorre anche specificare che nella tradizione popolare quando si vole-
vano, in sintesi, descrivere le non eccelse doti estetiche di una donna o di un uomo, si sentenziava che era bella (o bello) come il c… della padella!!!.
Bibliografia essenziale
- “SM. Annuali di San Michele”, Rivista annuale del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige, Trento, XXI, 2008.
- E. Baruffi, Un Carnevale montanaro: la Mascherata di Benedello, in “Il Cantastorie”, XX, 8, 1982, pp. 51-55.
- G. Biolchini, G.P. Borghi, Il Carnevale di Benedello, Reggio Emilia 2011 (e bibliografia ivi cita-ta).
- J. Blacking, Com’è musicale l’uomo, Lucca 1986.
- Guida bibliografica del Carnevale di tradizione nell’Appennino modenese e reggiano, a cura di G.P. Borghi con la collaborazione di G. Biolchini e G. Vezzani, Ferrara 2007.
- G.P. Borghi-R. Fioroni-G. Vezzani, Benedello, i protagonisti della “mascherata” e del rogo della “Vecchia”, in “Il Cantastorie”, XIX, 2,1981, pp. 40-48.
- J. Caro Bajora, Il carnevale, Genova 1989.
- F. Castelli, La danza contro il Tiranno. Leggenda storia e memoria della “Lachera” di Rocca Grimal-da, Ovada (Alessandria) 1995.
- J. Frazer, Il ramo d’oro: studio sulla magia e la religione, Torino 1987.
- G. Giannini, Il carnevale nel contado lucchese, in “Archivio per lo studio delle tradizioni popo-lari”, VII, 1889, pp. 301-343; rist. anast., Sala Bolognese (Bologna) 1977.
- E. Iacoli, Sull’uso di “bruciare la Vecchia”. Folklore Frignanese (“Quaderno” n.112 de “La Gio-vane Montagna”), Parma 1937.
- Guida allo studio della cultura del mondo popolare in Emilia e Romagna. II. Lo spettacolo, a cura di R. Leydi e T. Magrini, con la collaborazione di G.P. Borghi, Bologna 1987.
- G. Secco, Viva viva Carnevale! Maschere e riti nei carnevali della montagna veneta, Belluno 1989.
- G. Secco, Mata. La tradizione popolare e gli straordinari personaggi del Carnevali arcaici delle mon-tagne venete, Belluno 2001.
- P. Toschi, Le origini del teatro italiano, Torino 1976 (i riferimenti specifici sono alle pp. 75 e 112).
- U. Preti-R. Vaccari, Maschere e mascherate della Provincia di Modena, in La drammatica popolare nella valle padana, Atti del 4° convegno di studi sul folklore padano (Modena 23-24-25 mag-gio 1974), Modena 1976, pp. 557-583.
- Castagneto di Pavullo (Storia-Folklore-Tradizioni). Dal diario di Giuseppe Lucchi, a cura di R. Vaccari, con la collaborazione di A. Bortolotti, Modena 1991.
- www.verica.it, sito Internet con testi folklorici di Domenico Corsini, consultato nel 2010.
37
Renzo Nelli
VIAGGI E VIAGGIATORI IN TRANSITO DAI PASSI APPENNINICIPRIMA DEL GRAND TOUR
Mi corre l’obbligo di esordire con una precisazione: il titolo originario che mi era stato assegnato per questo intervento terminava, in realtà, con l’agget-tivo “appenninici”. La successiva precisazione, che vuole essere contempo-raneamente cronologica e tematica, si deve ad un ripensamento operato sul tema affidatomi e che cercherò brevemente di motivare.
Innanzitutto, non solo i testi prodotti dal cosiddetto Grand Tour - che, almeno dal XVIII secolo in poi prende sempre più l’aspetto pressoché esclu-sivo di Viaggio in Italia - riempiono intere biblioteche, ma sull’analisi e l’in-terpretazione di essi sono stati ormai versati oceani di inchiostro che hanno investito caratteri e discipline multiformi: dalla storia, con i suoi inevitabili corollari geografici, all’antropologia, dalla critica letteraria alla psicologia, dalla filosofia alla storia della scienza e molti altri ancora; spesso - almeno nei casi migliori - intersecandoli e fondendoli gli uni con gli altri. Inoltre, agli studi di carattere generale si sono aggiunte nel corso degli anni, e in particolare dagli ultimi decenni del secolo scorso, tutta una serie di “anto-logizzazioni” che hanno interessato alcuni territori particolarmente battuti dagli itinerari dei viaggiatori: itinerari che, sempre a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, cominciano ad essere ormai sufficientemente codifica-ti. Così abbiamo assistito alla pubblicazione di lavori dedicati non solo alle grandi città o a macroaree più o meno estese, ma anche a città che del Viaggio furono tappe assai più “marginali”, o addirittura ad aree periferiche che ne costituirono però nevralgici punti di passaggio1.
Il risultato di simili considerazioni è stato che affrontare i testi prodotti nel periodo “canonico” del Grand Tour avrebbe significato non solo una mole insostenibile di lavoro, ma anche aver a che fare con tutta una serie di proble-matiche e implicazioni che molto devono alla “codifica” del genere e sono, in ultima analisi, relativamente “indipendenti” dalle situazioni concrete che i singoli luoghi proposero al viaggiatore. Senza contare il fatto che sarebbe
1 Cfr., fra gli innumerevoli, Bologna e il Grand Tour. Settima settimana per i beni culturali e ambientali, Aula Magna, dicembre 1991, a cura di L. Orlandi Frattarolo, Roma 1991; A. Mozzillo, La frontiera del Grand Tour. Viaggi e viaggiatori nel Mezzogiorno borbonico, Napoli 1992; Roma e la campagna romana nel Grand Tour, Atti del convegno interdisciplinare (Monte Porzio Catone, Roma, 17-18 maggio 2008), a cura di M. Formica, Roma-Bari 2009. Ma vedi anche G. Moly Feo, Livorno nel Grand Tour. Guida ai luoghi letterari, Pisa 2006 e A. Boncompagni, Il Grand Tour nel Mugello. Itinerari e percezione del paesaggio nei viaggiatori inglesi dal XVII al XIX secolo, Firenze 1998.
38
stato pressoché impossibile, almeno a chi vi parla, proporre qualcosa di re-lativamente nuovo e che non fosse già stato detto - e in modo assai migliore - dai più accreditati studiosi dell’argomento, Attilio Brilli su tutti2.
Così è nata l’idea di concentrare l’indagine sui secoli precedenti, quando fra le spinte del viaggiatore non c’erano ancora né la formazione culturale e intellettuale né la passione storico-antiquaria né i molti altri motivi che sot-tesero al viaggio - in Europa prima e, fondamentalmente, in Italia poi - nei secoli dal tardo XVI al XIX e oltre. Anche nel Medioevo si viaggiava: e molto più di quanto comunemente non si pensi. Ma si viaggiava soprattutto per ne-cessità, anche se poteva trattarsi - e spesso fu così - di necessità, per così dire, non materiali e appartenenti più alla sfera dello spirito che a quella del cor-po. In sostanza, i viaggi medievali furono essenzialmente - per riprendere il titolo di un famoso saggio di Franco Cardini - viaggi di religione, di ambasceria e di mercatura3. Il che ha alcune conseguenze fondamentali per lo scopo che qui ci siamo prefissi: in primo luogo, il viaggiare non implica, nella maggior parte dei casi, lasciare una traccia scritta del proprio viaggio; quest’ultimo è, a sua volta, quasi sempre un semplice mezzo per raggiungere altri scopi e quindi occupa generalmente una parte assai ridotta della narrazione, quasi sempre limitata a notizie e considerazioni di ordine eminentemente pratico (specialmente nel caso dei vari manuali di mercatura). Quello che interessa al viaggiatore medievale è quasi sempre la mèta: o quantomeno gli interessa molto di più del percorso fatto per arrivarci. Tutto ciò ha effetti collaterali piuttosto “pesanti” per il mutamento di cronologia e di prospettiva che qui ci siamo prefissi: le testimonianze si riducono di numero e sono molto più “reticenti”. Tuttavia, qualcosa si può comunque dire: e cercheremo di dirlo.
I più numerosi e interessanti fra questi testi, almeno fino a tutto il Quat-trocento, sono indubbiamente i resoconti di pellegrinaggio, ma anche in que-sto caso la precisazione geografica (l’Appennino) ci obbliga a una selezione che ne escluderà non pochi. Nel periodo di maggior fioritura di questi testi - a partire cioè più o meno dagli ultimi decenni del Trecento - il dominio sulle coste dalmate e le basi navali nel Peloponneso hanno consentito a Venezia di mettere in piedi una sorta di vero e proprio “servizio di linea” navale per la Terrasanta, con partenze più o meno periodiche, e praticamente tutti i pellegrini che hanno lasciato un resoconto del proprio viaggio si imbarcano
2 Fra le numerose opere da lui dedicate all’argomento si veda soprattutto l’eccellente sintesi (ma il termine è in questo caso assai riduttivo) di A. Brilli, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale, Bologna 2006.
3 F. Cardini, I viaggi di religione, d’ambasceria e di mercatura, in Storia della società italiana, 7, La crisi del sistema comunale, Milano 1982, pp. 157-220.
39
a Venezia4. Questo ci porta automaticamente a dover escludere tutti i testi dei viaggiatori provenienti da zone dalle quali non c’era alcuna necessità di passare l’Appennino per recarsi nella Serenissima: come, ad esempio, l’inte-ra pianura padana. Dovremo così escludere i testi, pur interessanti, del ve-ronese frate Giacomo, dei milanesi Santo Brasca, Bernardino Dinali e Iacopo da Sanseverino, del mantovano Antonio da Crema, dei ferraresi Niccolò III e Meliaduse d’Este e altri ancora. In pratica - e speriamo che questo non ci frutti l’accusa di “toscanocentrismo” - i testi esaminati saranno quindi, e per questi ovvi motivi, dovuti quasi esclusivamente alla penna di viaggiatori toscani. È bene premettere subito che essi si riveleranno, per quanto qui ci interessa, estremamente deludenti: ma ne facciamo ugualmente una breve rassegna, tentando di trarre qualche considerazione.
Innanzitutto, non si può non notare una evidente, e assai indicativa, spro-porzione tra la durata delle varie fasi del viaggio e il relativo spazio ad esse dedicato nei testi: a fronte di un viaggio di andata e di uno di ritorno general-mente piuttosto lunghi e di permanenze in Terrasanta in genere non superio-ri a qualche settimana, gran parte dei resoconti sono dedicati ovviamente a quest’ultima fase, mentre i due viaggi sono spesso liquidati in poche pagine, talvolta addirittura in poche righe5. Pur con queste poco incoraggianti pre-messe, è comunque d’obbligo un minimo di esemplificazione.
Il primo personaggio in ordine di apparizione è il frate francescano Nic-colò da Poggibonsi, che si reca in Terrasanta nel 1345. Partito appunto da Poggibonsi, enumera semplicemente le tappe della sua marcia di avvicina-mento a Venezia: Firenze, Bologna, Ferrara e Chioggia, senza nessuna spe-cificazione o commento. Identica, e ugualmente sintetica, la descrizione del viaggio di ritorno dopo lo sbarco, sempre a Venezia: Chioggia, Ferrara, Bolo-gna, Firenze e Poggibonsi. Unica concessione al “dettaglio”, l’affermazione che dopo Bologna tenni per gli Alpi, il che fa pensare che la strada seguita sia stata quella allora più comune e usata anche dalla maggior parte dei suoi col-leghi, ovvero quella che collegava Firenzuola a Scarperia attraverso il passo del Giogo.
La stessa strada viene percorsa dai tre fiorentini che compiono insieme - e, per la verità, insieme anche ad altre tre persone, che però non ne hanno la-sciato testimonianza scritta - il pellegrinaggio nel 1384. Anche in questo caso,
4 Una delle poche eccezioni è il notaio campano Nicola di Martoni, che si imbarca a Gaeta diretto ad Alessandria nel 1394: cfr. Io notaio Nicola de Martoni. Il pellegrinaggio ai Luoghi Santi da Carinola a Gerusalemme. 1394-1395, a cura di M. Piccirillo, Jerusalem 2003. Sull’organizzazione dei viaggi da parte della Serenissima si veda U. Tucci, I servizi marittimi veneziani per il pellegrinaggio in Terrasanta nel Medioevo, Venezia 1991.
5 Su questi argomenti si veda F. Cardini, In Terrasanta. Pellegrini italiani tra Medioevo e prima età moderna, Bologna 2002, in particolare il capitolo Gli spazi e i tempi, pp. 297-349.
40
però, le indicazioni sono a dir poco scarne. Lionardo Frescobaldi si limita ad elencare anche lui le tappe del viaggio verso Venezia, e sono le stesse viste in precedenza, con l’aggiunta di Scarperia, il che ci consente di confermare che l’itinerario più seguito doveva essere quello che passava attraverso il passo del Giogo; per quanto riguarda il ritorno, invece, l’unica tappa intermedia menzionata è Bologna. Il suo compagno di viaggio Giorgio Gucci ripete al-trettanto sinteticamente gli stessi dati, considerando però inutile menzionare Chioggia all’andata e facendoci altresì sapere che nel viaggio di ritorno è stata fatta anche una sosta a Padova, forse per visitare la basilica del Santo (ma il motivo non viene esplicitato). Il terzo “sinottico”, Simone Sigoli, non si dà neppure la pena di dire che ha seguito la via di Bologna e non fa alcun cenno al viaggio di ritorno dopo lo sbarco a Venezia.
Se la strada per Scarperia e Firenzuola era già allora la via più comune per valicare l’Appennino da parte di un fiorentino, non altrettanto si può dire per un senese. Nel 1431 il prete Mariano di Nanni, rettore della parrocchia di San Pietro a Ovile, compie tutt’altro itinerario, e assai più lungo e tortuoso, per recarsi all’imbarco a Venezia. Passa infatti per Buonconvento e Sarteano seguendo la Cassia fino a Chiusi. Da lì piega ad est verso Perugia, risalendo poi per Gubbio e Urbino fino a ritrovare la costiera a Rimini, da dove prose-gue per Ravenna e Venezia. Anche in questo caso non abbiamo indicazioni particolari sul viaggio, se non una annotazione in cui l’umile prete afferma, con una certa malcelata soddisfazione, di essere stato ospitato a cena insieme coi suoi compagni di viaggio dal conte d’Orbino6, tramite i buoni uffici di un compatriota: il mercante senese Giovanni Saracini. Ben più lungo e tortuoso l’itinerario di ritorno, anche perché la nave sulla quale Mariano si è imbarca-to non lo porta fino a Venezia: una tempesta danneggia gravemente l’imbar-cazione e consiglia lo sbarco dei passeggeri nei dintorni di Otranto. Da qui Mariano prosegue via terra verso nord (Lecce, Mesagne, Ostuni, Monopoli, Polignano, Mola, Bari, Giovinazzo, Molfetta, Barletta, Manfredonia). Giunto sul Gargano, ne approfitta per compiere una visita al santuario di San Mi-chele e poi prosegue lungo la costa adriatica fino all’altezza de L’Aquila: qui piega verso l’interno e le tappe successive (Cascia, Norcia, Preci) fanno sup-porre che l’attraversamento dell’Appennino sia avvenuto in corrispondenza del passo di Forca Canapine o nelle sue immediate vicinanze. In seguito pro-segue attraverso l’Umbria (Foligno, Assisi, Perugia), per poi tagliare verso la Valdichiana ripercorrendo così finalmente a ritroso più o meno la stessa strada fatta all’andata (Chiusi, San Quirico d’Orcia, Siena). Anche le indica-zioni del buon Mariano non vanno oltre una rapida elencazione delle varie
6 Mariano da Siena, Viaggio fatto al Santo Sepolcro. 1431, a cura di P. Pirillo, Pisa 1991, p. 74.
41
tappe, sebbene unite quantomeno a una puntuale indicazione delle distanze (secondo una usanza abbastanza tipica dei resoconti di pellegrinaggio - che talvolta però la limitano alla parte del viaggio che si svolge in Terrasanta - e ancor più delle varie pratiche di mercatura). Durante il viaggio di ritorno il nostro si lascia però finalmente andare a qualche annotazione personale. In primo luogo racconta una brutta avventura che gli è occorsa dopo aver lasciato Foggia, nei pressi dell’attuale comune di Serracapriola: A dì 23 fum-mo a rinfrescharci alla Serra della Chapriuola et qui pigliamo un guida per questo dì perché si truova grandiximi pericholi e a grandi pericholi siamo venuti poy che smontamo in terra pe’ malandrini et ladronciegli et passi scurissimi7. L’episodio apre una parentesi sulla insicurezza delle strade, anche se non è riferito a un percorso propriamente “appenninico”. L’altra annotazione può invece ser-vire, tra l’altro, anche a spiegare la tortuosità del viaggio di andata: A dì tre fummo a Chiuci a rinfrescharci e da le Chiane per infino a Siena venimo con grandi pericholi et paura per la guerra che era fra ‘l Chomuno di Siena e’ fiorentini. Eviden-temente per un senese non doveva essere troppo consigliabile in quei tempi (come del resto in molti altri, fino alla definitiva annessione di Siena ad opera di Cosimo I nel 1555) attraversare non solo Firenze, ma lo stesso territorio fiorentino e forse fu questo genere di prudenza a guidare la pianificazione dell’itinerario di andata.
Circa quarant’anni dopo Mariano, anche il domenicano fiorentino Ales-sandro Rinuccini intraprende il suo viaggio in Terrasanta. Anzi, lo intrapren-de due volte perché il primo tentativo non va a buon fine: dopo aver aspetta-to inutilmente per alcuni giorni di potersi imbarcare a Venezia, decide di tor-narsene indietro e di ritentare in seguito. A differenza dei suoi predecessori, e soprattutto dei suoi concittadini di quasi un secolo prima, il Rinuccini non è così avaro di particolari sulle circostanze del viaggio e sui suoi “accidenti”. Innanzitutto il suo percorso è assai meno lineare di quello che ci aspetterem-mo da un fiorentino: tocca infatti le località di Pontassieve, Dicomano, San Godenzo, Castel dell’Alpe (il che fa pensare che abbia valicato l’Appennino al passo del Muraglione) ma, invece di dirigersi direttamente verso Forlì, una volta giunto a Meldola piega a est verso Cesena, dove viene ospitato dai confratelli del locale convento. Non è chiaro se questa deviazione sia dovuta al desiderio di passare a trovare il fratello Alessio, monaco presso il monastero benedettino cesenate di Santa Maria a Monte, o al desiderio di riaversi e rifocillarsi da un violento temporale che lo coglie nei pressi di una
7 Ibidem, p. 128.
42
località chiamata Bagno8. In altre parole, non sapendo se il desiderio di pas-sare a trovare il fratello a Cesena fosse fin dall’inizio nei piani del Rinuccini, non possiamo neppure sapere se la scelta di un itinerario così diverso dal consueto - quantomeno per un fiorentino - fosse dovuta a questo motivo o, invece, al fatto che la ormai abituale via attraverso il passo del Giogo fosse in quel periodo meno sicura perché teatro di operazioni di guerra o altri motivi analoghi. Quel che è certo è che, quando il Rinuccini intraprende di nuovo - e stavolta con successo - il viaggio verso Venezia, ripercorre la più “classica” via attraverso San Piero a Sieve, Scarperia, Pietramala, Pianoro e Bologna, per proseguire poi per Ferrara e Chioggia: e la stessa via viene percorsa al ritorno dopo lo sbarco a Venezia.
In confronto ai suoi predecessori, il Rinuccini si può quasi definire “pro-digo” di particolari sui suoi viaggi per e da Venezia: ma anche nel suo caso il passaggio dell’Appennino non sembra certo aver rappresentato un’espe-rienza particolarmente degna di nota. I particolari più interessanti, e spesso addirittura divertenti, riguardano piuttosto i disagi che gli ha procurato la pianura padana: sia dal punto di vista dell’ambiente naturale (è nota la de-scrizione dell’attraversamento del delta del Po, funestata da un caldo sof-focante e dalla presenza di numerosi animali e soprattutto insetti molesti, che elenca, da buon domenicano, con precisione e categorizzazione quasi tomistica) sia da quello dell’ambiente umano9. In ultima analisi, l’unica cosa veramente notevole del tratto appenninico del suo percorso è il maltempo che lo coglie nel viaggio di ritorno prima e durante l’attraversamento del passo del Giogo e che gli stimola una descrizione così colorita da meritare una citazione puntuale:
[dopo Bologna] chominciò a piovere una aquicella minuta, la quale in tut-to il giorno non mi abbandonò. Finalmente la sera, tutto straccho et molle et infanghato, mi trovai avere chavalchato a grande stento miglia xij et allogiai a j° luogho fra Pianoro et Lugliano che.ssi chiama La Guardia, lasciandomi adrieto passi che non so se mai mi chavalchassi i piggiori.
8 Alessandro di Filippo Rinuccini, Sanctissimo peregrinaggio del Sancto Sepolcro. 1474, a cura di A. Calamai, Pisa 1991, pp. 40-41. Per quanto riguarda la località citata, ritengo dubbio che possa trattarsi dell’attuale Bagno di Romagna in quanto ciò presupporrebbe una eccessiva tortuosità del percorso. La zona, del resto, era ed è tutt’ora ricca di sorgenti termali - si pensi anche solo a Castrocaro - e un tale toponimo avrebbe potuto essere riferito anche ad altre località.
9 Nel primo viaggio si veda la lamentela contro il “trattamento differenziato” imposto ai forestieri: “E così, chon grande molestia e faticha, pervenimo fino al Po, dove per passaggio, dove quelli del paese paghano quatrini septe , a me ne fu fatti paghare quatordici” (cfr. ibidem, p. 42). Nel secondo viaggio è invece godibilissimo l’episodio dell’incontro a Francolino in attesa di imbarcarsi per Venezia, con una schiera di soldati anch’essa in procinto di recarsi a Venezia per andare a combattere i turchi nei Balcani al comando di un tal capitano Francesco Cento Ossa, vero e proprio prototipo del soldataccio di ventura, uomo rude d’aspetto e di modi e gran bestemmiatore. L’incontro è così sgradevole da convincerlo a non imbarcarsi sullo stesso naviglio e ad aspettare il successivo (cfr. ibidem, pp. 44-45).
43
Domenicha a dì xviiij° di febrayo, fatto il giorno, montai a chavallo et chavalchai miglia iiij°, cioè fino a Logliano et quivi, celebrata la messa et rimontando a chavallo, n’andai a desinare a Ischarichalasino all’oste-ria dell’Agniolo et poi, tirando oltre, arrivai la sera a Firenzuola, avendo avuto quasi tutto il giorno l’aqua adosso et alloggiai all’osteria della Cho-rona. Lunedì a dì xx di febrayo, la mattina a hore xij o circha, montando a chavallo, chavalchai a stomacho digiuno tutto quel giorno et quasi con-tinovamente con l’aqua addosso, in modo che io et il chavallo et nostra tascha con libri et lettere et tutto ciò che v’era drento, tutti ci bagnamo infino sulle granella10.
Non è un caso che gli accidenti atmosferici si registrino, in genere, du-rante il viaggio di ritorno: i pellegrini avevano infatti cura di programma-re la partenza verso la Terra Santa nel periodo compreso fra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, proprio per avere condizioni climatiche più favorevoli a un viaggio così lungo e pericoloso, specialmente per il suo tratto marittimo. Ben più imprevedibile era invece il periodo del viaggio di ritor-no, anche perché gli eventuali “accidenti” che potevano verificarsi durante la permanenza in Oriente ne costituivano una variabile impazzita: si veda il caso dei tre fiorentini del 1384, costretti a fermarsi a lungo a Beirut a causa della malattia che lì coglie uno dei loro compagni - Andrea Rinuccini - fino a portarlo alla morte. In ogni caso, mentre nel viaggio di andata Alessandro Rinuccini si trova a dover combattere contro l’afa della pianura padana e del delta del Po, al ritorno deve invece fare i conti con un piovoso inverno.
Se il frate domenicano mostra una relativa abbondanza - almeno a para-gone coi suoi predecessori - di aneddotica e di annotazioni personali anche in merito al viaggio per e da Venezia, il suo successore prete Michele da Figline ripiomba, almeno per quanto riguarda l’andata, nella reticenza più assoluta. Oltre alla consueta elencazione delle tappe intermedie (peraltro li-mitata alle località più grandi e famose: Firenze, Bologna e Ferrara), che co-stituisce comunque una “regola” di questo “genere” letterario, non vi è alcun commento o ricordo personale, tanto che il percorso da Figline a Venezia è letteralmente liquidato in tre righe11. Notevolmente più lungo e “accidenta-to” il viaggio di ritorno, anche perché Michele e i suoi compagni non sbarca-no a Venezia, ma ad Ancona. Non è chiaro se la nave avesse già in partenza questa destinazione o se, invece, fosse comunque diretta a Venezia. Fatto sta che Michele e molti dei suoi compagni decidono di scendere ad Ancona in seguito a una tempesta che li sorprende in Adriatico e li convince della
10 Ibidem, p. 97. Si lascia all’immaginazione del lettore capire cosa si intenda con “granella”: il termine suona particolarmente inatteso nella bocca di un colto domenicano.
11 Cfr. M. Montesano, Da Figline a Gerusalemme. Viaggio del prete Michele in Egitto e in Terrasanta (1489-1490), Roma 2010, p. 47.
44
necessità di fare un breve pellegrinaggio alla Madonna di Loreto - già allora riconosciuta protettrice dei naviganti - per rendere grazie dello scampato pe-ricolo. Curiosamente il pellegrinaggio a Loreto viene poi obliterato nel resto del racconto. Sono invece elencate con una certa precisione le altre tappe del viaggio: Ancona, Fano, Senigallia, per poi piegare verso l’interno attraverso Fossombrone, Mercatello, Sansepolcro, Anghiari, Montevarchi, San Giovan-ni e giungere finalmente a Figline. Considerando il percorso da Mercatello sul Metauro a Sansepolcro, è quindi presumibile che l’Appennino sia stato valicato nei pressi dell’Alpe della Luna. Anche in questo caso, però, il viag-gio si svolge in pieno inverno e c’è spazio per lamentele dovute al maltempo e agli spiacevoli incontri. Se per i secondi non vi è una connessione più o meno stretta con il transito nelle parti più disagevoli dei valichi appenninici, tanto che l’episodio più spiacevole avviene poco fuori delle porte di Urbi-no12, il primo sembra invece aumentare via via che ci si avvicina al valico:
Et caminamo lungho un fiume et giugnemo a uno borgho di case chiama-to la Mole, et passando questo luogho et lasciamo el fiume, pigliamo el cammino verso la montagna et chominciamo a salire et trovare di molta neve, et quella salendo al meglio potavamo et giugnemo al giogho et pas-samo con neve assaj, che più volte ci cadde el cavallo per la neve … Et come avemo alquanto delle montagna smontati, trovamo uno romitorio. Abbiavano uno pezo sopportato la sete: a quelli frati picchiamo, chiede-mo loro da bere et dettoncene volentieri et sia ringratiato Iddio13.
Questo breve brano ci consente, fra l’altro, di trovare una ulteriore prova della ben nota funzione di ospitalità e di supporto al viandante che anche alle soglie del Cinquecento continuavano a svolgere sulle strade - e in particolare proprio in corrispondenza dei tratti di valico - certe strutture ecclesiastiche, monastiche soprattutto, fossero esse spedali, monasteri, romitori o altro.
Con Michele da Figline terminano i testi editi di pellegrini toscani o co-munque centro-italiani: quelli cioè che dovevano passare gli Appennini per andare a imbarcarsi a Venezia e poi per tornare a casa, avessero o meno fatto tappa nella Serenissima anche al ritorno. Anche se le fonti sono state, come si è visto, scarse e reticenti, tuttavia qualche considerazione generale si im-pone. Potremmo pensare che questi testi contengano solo pochissime testi-monianze interessanti per questo tipo di indagine perché l’attenzione dei loro estensori è rivolta fino dalla partenza da casa al loro obiettivo finale,
12 Ibidem, p. 161.13 Ibidem, pp. 161-162. Per quanto riguarda il luogo citato all’inizio del brano, dal quale sembra avere
inizio l’ascensione verso il valico, ci pare inaccettabile la proposta di identificazione con Imola fatta dal curatore del testo di Michele, sia perché a quei tempi Imola era qualcosa di più che un semplice “borgho di case” sia, soprattutto, per la totale incongruenza delle coordinate geografiche.
45
cioè il pellegrinaggio ai Luoghi Santi: ma questa ipotesi, pur fondata, spiega solo in parte la loro reticenza alla narrazione del proprio viaggio verso e dalla Terrasanta. Anche perché è una reticenza parziale e selettiva: se le tap-pe terrestri sono riassunte spesso in poche righe, non altrettanto si può dire della permanenza a Venezia - ma questo è dovuto al fatto che le numerose reliquie custodite dalla Serenissima costituivano già di per sé una prima e significativa tappa di pellegrinaggio - e soprattutto del viaggio marittimo. Così sintetici nel descrivere l’andata via terra - spesso limitata all’enuncia-zione di tempi di percorrenza e distanze da un luogo all’altro, in ossequio al fatto che ogni autore si prefiggeva non solo di narrare la propria esperienza, ma anche di far da guida a eventuali successori - essi sono quasi sempre ben più prodighi di aneddoti e particolari nel descrivere il viaggio per mare. Si comincia con le querimonie sulla insopportabilità della vita a bordo, fatta di cibo scarso e spesso avariato nonché di eccessiva densità di esseri umani in spazi angusti e dall’igiene discutibile, per continuare con le angherie a cui i pellegrini vengono frequentemente sottoposti da parte di ciurme assai poco rispettose dei passeggeri e, talvolta, dagli stessi comandanti delle navi, ma anche con descrizioni spesso piuttosto dettagliate delle coste dalmate e albanesi e delle varie città avvistate dalla nave durante il tragitto; per termi-nare, infine, con narrazioni lunghe e piene di pathos di quelle tempeste così frequenti in quell’Adriatico apparentemente chiuso e tranquillo (tanto da es-ser comunemente chiamato “golfo di Venezia”) anche nel periodo estivo, di solito privilegiato per le partenze.
E allora, alla fin fine, a cosa si deve questo quasi totale velo di silenzio sul-la parte “terrestre” del viaggio, che non si squarcia neppure nelle occasioni che ci aspetteremmo costituirne gli aspetti più “critici”, come il superamento di più o meno impervi valichi? Fermo restando che le dimostrazioni e silen-tio sono quasi sempre le più “pericolose”, a nostro parere la spiegazione sta nel fatto che quei momenti non erano affatto così critici. In altre parole, il viaggio via terra, anche per lunghe percorrenze e attraverso vie di comuni-cazione disagevoli, costituisce per l’uomo del tardo medioevo un’esperienza assolutamente normale e non particolarmente degna di essere raccontata: almeno, non in quanto tale e a prescindere dai singoli eventi notevoli in essa accaduti. Le stesse strutture di supporto del viaggio (stazioni di posta, locan-de, osterie: oltre, come si è visto, alle tradizionali e ben più antiche strutture dell’ospitalità monastica) formavano ormai una rete consolidata e ben fun-zionante, anche se di queste strutture, della loro pulizia e organizzazione e della rapacità e tendenza all’imbroglio dei loro gestori si avrà spesso di che lamentarsi, anticipando anche sotto questo aspetto quello che diventerà un vero e proprio topos nei viaggiatori del Grand Tour.
46
A possibile controprova di ciò, abbiamo preso in esame anche due testi di viaggiatori stranieri, uno del tardo Quattrocento e l’altro della prima metà del secolo successivo, provenienti da Germania e Svizzera e diretti entram-bi all’imbarco a Venezia per verificare se per caso i più impervi e pericolo-si passi alpini non avessero stimolato in chi li attraversava sensazioni più forti e degne di essere annotate su carta. Il canonico tedesco Bernhard von Breydenbach parte da Oppenheim, nei pressi di Magonza, nel 1483 preoc-cupandosi solo di dire che la distanza tra questa città e Venezia è pari a 100 miglia tedesche14 e che ha impiegato quindici giorni per percorrerle15: nessun accenno, neppure minimo, all’attraversamento delle Alpi. La parte maritti-ma del viaggio di ritorno è invece ricca di particolari e occupa uno spazio notevole nel testo16, salvo ricadere in un pressoché totale mutismo quando si tratta di descrivere il viaggio via terra da Venezia in poi.
Quasi sessant’anni dopo, nel 1542, anche il gentiluomo svizzero Jost von Meggen intraprende un pellegrinaggio in Terrasanta e parte dalla natia Lu-cerna per andare a imbarcarsi a Venezia e l’itinerario è descritto anche da lui molto brevemente, con l’enunciazione delle tappe e poco più: solo Verona e Padova gli strappano poche righe di descrizione, peraltro piuttosto ammira-ta. Il passaggio delle Alpi avviene al valico del San Gottardo e, nonostante avvenga intorno alla metà del mese di maggio, provoca qualche problema al nostro, che così lo descrive:
Da lì [Urania, oggi Artdorf], non senza grave pericolo, bisognava supe-rare la sommità delle Alpi (il passo del monte chiamato San Gottardo), con la sua sterminata distesa di neve ghiacciata lungo i bordi e altrove si scioglieva in rigagnoli: ovunque si aprivano buche estremamente insidio-se per uomini e cavalli. Non solo: di schianto, con gran fragore e impeto precipitavano masse di neve: una volta mancò poco che ne restassimo bloccati17.
Evidentemente von Meggen è buon conoscitore delle montagne alpine e sa bene che i pericoli maggiori vengono proprio nel momento del parziale di-sgelo. Ma, al di là di questa peraltro scarna annotazione, neanche lui si lascia prendere da particolare slancio descrittivo per una realtà che evidentemente conosce benissimo. Ben più accurata è, anche nel suo caso, la descrizione
14 Bernhard von Breydenbach, Peregrinationes. Un viaggiatore del Quattrocento a Gerusalemme e in Egit-to, traduzione italiana e note di G. Bartolini e G. Caporali, con saggio introduttivo di G. Bartolini, Roma 1999, p. 16.
15 Ibidem, p. 15.16 Ibidem, pp. 245-257.17 Jost von Meggen, Pellegrinaggio a Gerusalemme. Avventure di viaggio per mare e a cavallo di un
gentiluomo svizzero del Cinquecento, Milano 1999.
47
che gli strappano i due viaggi per mare e anche la prima parte del viaggio di ritorno via terra. Questo è infatti particolarmente lungo perché anche von Meggen sbarca sulle coste meridionali, nei pressi di Crotone e ci regala subi-to una conferma alle nostre supposizioni: Avendo ormai raggiunto il continente (benché per arrivare in patria ci fosse ancora da fare tanta strada), preferii, dietro consiglio tuttavia di molti, continuare il cammino via terra: dei pericoli di mare ne avevo già abbastanza18. Il viaggio prosegue quindi via terra attraverso una dili-gente elencazione delle singole tappe, corredata di distanze tra l’una e l’altra, ma alle più importanti tra le città attraversate (Napoli, Gaeta e naturalmente Roma, dove decide di fermarsi per qualche giorno) dedica una sommaria descrizione. Questo modo di narrare il proprio viaggio continua fino a Bolo-gna e il viaggiatore svizzero trova il modo di dedicare qualche riga perfino a Scarperia, appena stravolta da un terremoto19. Neppure per lui, però, l’at-traversamento dell’Appennino, compiuto verso la fine di maggio del 1543, comporta episodi degni di nota. Lasciata Bologna, il ritmo di narrazione del viaggio muta completamente e si riduce a un puntuale elenco di località e distanze, senza nessuna delle pur sintetiche annotazioni che lo avevano con-traddistinto fino ad allora. È proprio questo repentino mutamento di registro a costituire, a nostro parere, una ulteriore - ancorché indiretta - conferma all’ipotesi azzardata in precedenza: per il pellegrino medievale (anche se con von Meggen siamo ormai ben più che alle soglie dell’età moderna) il viaggio per e dai Luoghi Santi, pur essendo fondamentalmente una sorta di inevita-bile e quasi fastidioso intermezzo che lo separa dalla vera mèta (il che vale, ovviamente, soprattutto per quello di andata) ha comunque un posto nella narrazione (anche perché la funzione di “guida” che questi testi devono ave-re resta sempre presente nella mente dei loro estensori), ma questo posto è comunque inversamente proporzionale alle conoscenze preesistenti. In altre parole, c’è soprattutto spazio per la descrizione di luoghi e situazioni che si conoscono meno e, evidentemente, l’attraversamento dei valichi appenninici (ma anche alpini) rientrava invece nell’ambito delle esperienze di viaggio ben note: solo la coincidenza con situazioni di particolare disagio, in genere dovuto al maltempo, ne rendeva meritevole la menzione, quasi a voler evi-denziare ulteriormente i sacrifici affrontati nel compiere il pellegrinaggio e quindi, in un certo senso, la funzione “penitenziale” del medesimo.
E che i passi alpini non fossero affatto considerati più difficili e pericolosi di quelli appenninici ce lo conferma anche Francesco Guicciardini nel suo Diario del viaggio in Spagna compiuto nel 1511. Dopo aver evidenziato alcuni
18 Ibidem, p. 167.19 Ibidem, p. 174.
48
aspetti potenzialmente pericolosi della via di valico del Monginevro, che per via stretta ha salita repente, ed in luogo che se si inciampassi si cadrebbe in uno pre-cipizio grandissimo, conclude in maniera rassicurante che non è mala montagna né difficile, e chi la cavalcassi in stagione non avessi a combattere con neve e con diaccio, sarebbe cosa agevole20.
D’altra parte, in certe località il maltempo doveva essere tutt’altro che una rara eccezione, specialmente in certi periodi dell’anno. E se i “viaggiatori di religione” potevano se non altro scegliere il periodo della partenza per cer-care di ridurre al minimo gli inconvenienti climatici (quello del ritorno era, come si è visto, molto meno preventivabile e doveva sottostare a tutta una serie di accidenti), altri erano costretti dal proprio “mestiere” e dal proprio ruolo a doversi mettere in cammino in ogni tempo e soprattutto “con” ogni tempo. Nel 1431 il monaco camaldolese Ambrogio Traversari, colto e raffi-nato umanista e uomo di lettere, fu eletto abate generale dell’Ordine e gli fu affidata la guida della congregazione per il diritto canonico. Questo doppio ruolo lo “costrinse” a stare, fin quasi alla morte avvenuta nel 1439, in pres-soché perenne movimento, dividendosi tra le continue visite a monasteri, a proposito dei quali giungevano poco edificanti notizie in merito alla vita dei monaci e delle monache, e missioni diplomatiche di più alto profilo, a partire dalla partecipazione al Concilio di Basilea, poi spostato a Ferrara e infine a Firenze. I movimenti compiuti dall’ottobre 1431 fino al giugno 1434 sono registrati con precisione e dovizia di particolari nel suo Hodoeporicon21, vero e proprio diario ricco non solo di eventi, ma anche di pensieri e annotazioni personali. La figura di Traversari e il suo stesso diario di viaggio richiedereb-bero una trattazione a parte che ovviamente esula dallo scopo di queste brevi note. Qui ci limiteremo a dire che il monaco camaldolese si trova varie volte a dover attraversare i passi appenninici: né avrebbe potuto essere altrimenti, vista la prossimità della casa madre dell’Ordine al valico dei Mandrioli. Per la verità, l’attività di Traversari si svolse soprattutto, per quanto riguarda la sua attività di abate generale e “visitatore”, tra il convento fiorentino di Santa Maria degli Angeli - vero e proprio centro “culturale” della congregazione - e i conventi camaldolesi del territorio fiorentino e casentinese, e, per quan-to attenne invece al suo ruolo di diplomatico e rappresentante papale, tra Venezia e Ferrara: partendo però spesso da Firenze, il che fece sì che l’abate camaldolese avesse molta più familiarità con il consueto itinerario Firenze - Bologna attraverso il passo del Giogo che non con quel passo dei Mandrioli così vicino alla casa madre di Camaldoli. Ma nelle vicinanze di quest’ultimo
20 F. Guicciardini, Diario del viaggio in Spagna, Pordenone 1993, p. 10.21 A. Traversari, Hodoeporicon, a cura di V. Tamburini, Firenze 1985.
49
si trovò ovviamente a passare spesso nei suoi frequenti ritorni all’eremo che sembrano aver avuto, per sua stessa più o meno esplicita ammissione, anche lo scopo di “ricaricare le pile”. E quasi sempre questi ritorni prevedevano un pernottamento nella casa che i monaci possedevano a Soci, prima di affron-tare di buon mattino l’ultimo tratto di strada che conduceva all’eremo.
È proprio negli immediati dintorni di Soci che il Traversari si trova a vi-vere, nel dicembre del 1431, due esperienze abbastanza drammatiche, delle quali non manca di fornire una descrizione vivida e assai “partecipata”. Il primo episodio avviene il 6 dicembre, dopo che ha lasciato Poppi per rag-giungere Fontebuona (Camaldoli):
Feci una sosta a Soci per un brevissimo riposo; ma ne ero appena uscito che una violentissima bufera di neve e di vento mi investì da ogni direzio-ne. Caddi preda del terrore. La neve, sospinta dal vento, s’appiccicava al viso, agli occhi, perfino sotto gli indumenti; l’urlo della tormenta squas-sava la foresta con forza terrificante; sul lato destro della strada mi assor-dava la cascata del torrente che scorre tra sponde rocciose. Finalmente, dopo una marcia estenuante, fui in vista di Fontebuona, che mi riservò un’accoglienza calorosissima22.
Ancora più “drammatico” il secondo episodio, che accade appena un paio di settimane dopo, il 21 dicembre, allorché parte da Arezzo sempre in direzione dell’eremo:
Nonostante il parere contrario di tutti mi rimisi in viaggio per ritornare all’eremo. Nuvole minacciose e un’improvvisa tempesta di vento face-vano presagire la tempesta vicina. Ma io preferii sobbarcarmi ai disagi della burrasca e della neve, piuttosto che rimanere ad Arezzo: era mio desiderio festeggiare all’eremo la imminente solennità di Natale. La neve, incominciata a cadere appena uscito di porta, mi accompagnò per tutto il viaggio, senza un attimo di respiro. Me la sentivo di continuo sugli occhi e in faccia: non cessò di cadere se non quando fui in vista di Soci, a tramonto ormai vicino. Ma prima di Soci, a circa due miglia dal pae-se, dovetti battere dei sentieri perché la strada maestra era ostruita dalla neve; e se un brav’uomo non mi avesse fatto da guida per riportarmi su di essa, avrei corso un pericolo grave per l’enorme dispendio di forze e la disperazione. Passai la notte a Soci, nella casa di nostra proprietà e il giorno dopo m’incamminai alla volta di Fontebuona. Eppure, in quel breve tratto di strada, fu tale la violenza del vento e della bufera, che mi flagellavano da ogni parte, che durai fatica a tenermi in sella. Inoltre un grande spavento m’incuteva sia il rombo del torrente con i macigni che rotolava a valle, sia il frastuono della foresta, in cui le cime e i rami degli
22 Ibidem, p. 41.
50
alberi urtavano gli uni contro gli altri. Finalmente, con la protezione di Dio, arrivai al monastero di Fontebuona23.
Specialmente in questo secondo episodio, la paura provata dall’abate è evidente e lui stesso la comunica con molta chiarezza. Ma non c’è solo que-sto. Pur con la cautela dovuta al fatto che stiamo utilizzando una traduzione italiana e non l’originale testo latino del Traversari, tuttavia l’uso di certi termini ed espressioni salta agli occhi: il rombo del torrente, il frastuono della foresta e, nel primo episodio, l’urlo della tormenta. Accanto alla paura sem-bra quasi di sentire l’“attrazione” per queste prepotenti manifestazioni della forza della natura, che nel loro provocare terrore al viandante (non a caso si parla anche di forza terrificante), gli strappano tuttavia anche un sentimento quasi di “ammirazione”. Certo ci vorranno ancora oltre quattro secoli perché l’estetica del Romanticismo elabori quel concetto di “sublime” al quale molti viaggiatori ottocenteschi faranno spesso più o meno consapevolmente ricor-so: qui ne scorgiamo però, forse, qualche del tutto involontario prodromo24.
Ma qui ci fermiamo. Un secolo e mezzo dopo Traversari quello che è con-siderato una sorta di precursore del “viaggiatore moderno” e certo l’antesi-gnano del Voyage en Italie, Michel de Montaigne, attraverserà nel novembre 1580 l’Appennino tra Firenze e Bologna per la consueta via del passo del Giogo notando che procedemmo su una strada che in verità fu la prima, nel no-stro viaggio, da potersi dichiarar difficile e sgradevole, e frammezzo a montagne più impervie che in nessun’altra parte da noi visitata25. E, in effetti, il passaggio delle Alpi al passo del Brennero gli aveva suscitato annotazioni ben più entusia-stiche e quasi una sorta di difesa d’ufficio: Tutti questi passi sono assolutamente sicuri, e li percorrono mercanti, vetturali e carrettai in gran numero. Invece del fred-do con cui screditano questo passo, v’incontrammo un caldo quasi insopportabile26. In ogni caso, Montaigne dedicherà le sue attenzioni descrittive soprattutto al cattivo stato delle osterie e locande e ai mezzi truffaldini e ingannatori con cui gli osti cercano in ogni modo di procurarsi clienti, blandendoli con lusin-ghe e promesse che non trovano la minima rispondenza nei servizi forniti. Per certi aspetti il “viaggiatore” sta già lentamente cominciando a diventare “turista”.
23 Ibidem, pp. 48-49.24 Per un approfondimento su queste tematiche si veda R. Bodei, Paesaggi sublimi. Gli uomini davanti
alla natura selvaggia, Milano 2008.25 M. de Montaigne, Viaggio in Italia, introduzione di G. Greco, traduzione e note di E. Camesasca,
Milano 2003, p. 215.26 Ibidem, p. 181.
51
Paolo Pirillo
L’APPENNINO MEDIEVALEDA LIMITE LABILE A CONFINE TRA STATI
(secc. XIII-XV)
Anche per i crinali appenninici degli ultimi secoli del medioevo, la de-finizione di “confine tra Stati”, è un evidente ma voluto anacronismo: basti qui ricordare che, per le linee di displuvio, una compiuta elaborazione ide-ologica del concetto di confine ‘naturale’ non è anteriore al secolo XVIII1. Malgrado ciò, nella documentazione di età medievale - e ripeto cose note2 - non è poi così difficile imbattersi in descrizioni relative al tracciamento di delimitazioni lineari ottenute unendo, anche con l’ausilio della memoria di uomini e comunità, dei punti di riferimento topografici chiari e potenzial-mente incontestabili sia all’interno delle città o in aree pianeggianti, dove comunque l’operazione era relativamente più semplice, ma anche in zone montane come quella appenninica3. In quest’ultimo caso, e mi riferisco ai ter-ritori comitatini limitrofi di città comunali come Bologna e Firenze - al centro delle pagine che seguono - il crinale avrebbe finito per costituire il punto di riferimento per la determinazione dei limiti tra le due realtà politiche e giuri-sdizionali, inserendosi a pieno titolo, in particolare nel corso del XIV secolo, nelle dinamiche di formazione e di consolidamento dei due Stati cittadini4.
1 P. Marchetti, Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo medioevo, in Confini e fron-tiere nell’età moderna. Un confronto fra discipline, a cura di A. Pastore, Milano 2007, pp. 65-80 (anche in “Reti Medievali Rivista”, 7, 1 (2006), http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3185) e dello stesso Autore, “De iure finium”. Diritto e confini tra tardo Me-dieovo ed età moderna, Milano 2001.
2 Si veda l’approfondita sintesi di G. Francesconi, F. Salvestrini, La scrittura del confine nell’Italia comu-nale: modelli e funzioni, in Frontiers in the Middle Ages, Proceedings of the Third European Congress of Me-dieval Studies (Jyväskylä, 10-14 June 2003), P. Pahta, Louvain-la-Neuve 2006, consultato in versione digi-tale in “Reti Medievali” (http://fermi.univr.it/rm/biblioteca/scaffale/f.htm#Giampaolo Francesconi).
3 Arrivando anche – come nel caso modenese (1222) – alla descrizione di un intero contado: cfr. P. Bonacini, Il confine militare tra Modena e Bologna nel secolo XIII, in Il confine appenninico: percezione e realtà dall’età antica ad oggi, a cura di P. Foschi e R. Zagnoni, (“Storia e ricerca sul campo tra Emilia e Toscana”, 11), Porretta Terme-Pistoia 2001, pp. 71-92, in particolare p. 84, nota 45.
4 Paola Foschi data il compimento dell’espansione bolognese ai primi del secolo XIII, quando il territorio venne diviso con il prolungamento dei quartieri cittadini (P. Foschi, I castelli montani del Comune di Bologna fra XIII e XIV secolo, in I castelli dell’Appennino nel Medioevo, a cura di P. Foschi e R. Zagnoni, (“Storia e ricerca sul campo tra Emilia e Toscana”, 10), Porretta Terme-Pistoia 2000, pp. 115-134, in particolare p. 118). La riorganizzazione del contado sulla base del prolungamento delle ripartizioni cittadine - che non mi pare corrispondere sempre all’effettivo compimento di un processo espansionistico - costituisce l’indizio di un’affermazione politica e istituzionale capace di disegnare una “nuova geografia amministrativa fiscale dei distretti cittadini in formazione” (G. M. Varanini, L’organizzazione del distretto cittadino nell’Italia padana nei secoli XIII-XIV (marca Trevigiana, Lombardia, Emilia), in L’organizzazione del territorio in Italia e in Germania nel basso medioevo, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 133-233, in particolare pp. 147-148).
52
Un simile processo non è sicuramente lineare e pone degli interrogativi cui è necessario tentare di dare delle risposte, osservando alcuni momenti durante i quali andava articolandosi la politica territoriale delle due Dominanti nei confronti del crinale appenninico5.
Le vicende che sto per narrare furono senza dubbio elementi di rilievo nelle dinamiche confinarie tra proto-Stati nascenti ma per le città costituiro-no, prima di tutto, delle risposte pragmatiche a problemi di natura milita-re, economica, giurisdizionale e politica. Così, nella fase degli assestamenti dell’espansione trecentesca fiorentina e bolognese su singole aree appennini-che, la scelta dei governi cittadini di consolidare delle linee di demarcazione proprio sui crinali, mutuandole anche dalle pratiche dei conflitti locali, sem-bra appunto dettata - a questa altezza cronologica - dall’esigenza di un con-trollo puntuale sia sui passi appenninici, sia sugli insediamenti ubicati lungo le direttrici stradali che ne permettevano l’accesso. In pratica, un tentativo di sovrapposizione dell’egemonia cittadina e comunale su quella esercitata dai signori della montagna prima che si completasse il controllo totale dello spazio compreso entro i limiti dei due contadi6.
Possiamo definire questo momento come un tenue indizio, almeno per l’ambito fiorentino, di quella nascente nuova accezione geografica che sareb-be stata interpretata dagli statuti del primo Quattrocento, dove la territoria-lità stava assumendo i caratteri propri di una sempre più strutturata egemo-nia sugli spazi e non soltanto, com’era stato in precedenza, tendenzialmente sugli uomini7. Una popolazione, pur in un contesto regionale notoriamente caratterizzato da un’alta densità demografica come quello della Toscana set-tentrionale che però - è bene ricordarlo - sulle aree di crinale o in prossimità di esse era assente o rarefatta, al punto da aver talvolta costituito un movente per la fondazione ex novo di abitati8.
5 Rinvio qui ai lavori citati nel testo. Si veda inoltre P. Guglielmotti, Confini e frontiere come problema storiografico, in “Rivista storica italiana”, a. 121, 2009, pp. 176-183. La discontinuità nel processo di ‘linearizzazione’ delle frontiere è chiaramente messa in evidenza da D. Nordman, Frontières de France. De l’éspace au territoire, XVI-XIX siècle, Paris 1998.
6 Un esempio di organizzazione territoriale finalizzata al controllo dei passi appenninici fin dall’area di pianura prospiciente i rilievi è illustrato per i Rossi di Parma del XV secolo da M. Gentile, Giustizia, protezione, amicizia: note sul dominio dei Rossi nel Parmense all’inizio del Quattrocento, in Poteri signorili e feudali nella Lombardia alla fine del medioevo. Legittimità e forme di esercizio, Atti del seminario di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di F. Cengarle, G. Chittolini, G.M. Varanini, Firenze 2005 (“Quaderni di Reti Medievali Rivista”, 1), pp. 89-104, in particolare p. 90.
7 Cfr. E. Fasano Guarini, Gli statuti delle città soggette a Firenze tra ‘400 e ‘500: riforme locali e interventi centrali, in Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 69-124, passim.
8 Come la fallita Terra nuova fiorentina che avrebbe dovuto sorgere (1329) in prossimità del crinale appenninico confinante con il Casentino. Per altre realtà geo-politiche, cfr., ad esempio, l’insistenza per popolare delle aree montane nell’area vicentina duecentesca come tentativo di affermazione del dominio cittadino spintosi fino all’acquisto di terre (Varanini, L’invenzione dei confini. Falsificazioni
53
Questa dimensione - per così dire più organica - di tentativo di dominio territoriale era stata preceduta da esperienze simili a quelle che vorrei ora descrivere iniziando dal pieno XIII secolo, quando Firenze era ancora assai lontana dalla possibilità di un effettivo e stabile controllo su molte aree del proprio contado, in larga parte coincidenti con un Appennino dominato da signorie come quelle dei conti Guidi, degli Ubaldini, dei Pagani di Susinana. Allora, la necessità di tenere un passo e la sua strada si realizzava spesso in maniera diversa da quanto sarebbe accaduto nel secolo successivo. Così, ad esempio, lungo il tracciato della direttrice che collegava il territorio fiorenti-no a Faenza, Firenze aveva cercato di occupare il maggior numero possibile di abitati col risultato di scatenare in seguito un’analoga risposta di contrasto da parte dei signori dell’area intenzionati a ristabilire gli equilibri di potere precedenti9. Per questo, nel corso degli anni Ottanta del Duecento, si pensò di assicurare una presenza fiorentina sull’alto versante appenninico roma-gnolo cercando di popolare l’area più vicina al passo della Colla di Casaglia con almeno cinquanta famiglie. L’esperimento, iniziato nel 1284, fallì subito dopo per l’intervento dei signori locali, così che venne decisa la più modesta costruzione di una torre in prossimità del valico, questa volta sul versante meridionale10. Nel 1325, sempre allo scopo di controllare la strada per Faen-za e Ravenna prossima al passo ma sul lato fiorentino, il Comune, in accor-do con la badia vallombrosana di Razzuolo, avrebbe tentato di ripopolare la zona vicina al monastero a pochi chilometri dal valico attirando, con un qualche successo, delle famiglie di Lombardi la cui opera di diboscamento - si diceva - avrebbe reso più sicura quella via11. Intanto, sul versante opposto, nelle valli del Lamone e del Senio, la minaccia continuava a essere rappre-sentata da Guidi, Pagani da Susinana e Ubaldini nuovamente padroni del
documentarie e identità comunitaria nella montagna veneta alla fine del medioevo e agli inizi dell’era moderna, in “Reti Medievali Rivista”, 7, 1 (2006), [http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3190], p. 6). La Terra Nuova di Castel San Pietro la cui fondazione venne annunciata nel 1329, doveva popolare l’ultimo tratto disabitato della strada che portava al passo della Consuma e al Casentino, cfr. D. Friedman, Terre Nuove. La creazione delle città fiorentine nel tardo medioevo, Torino 1996, pp. 298-300.
9 Nel 1207, Firenze aveva iniziato a fare pressioni sul monastero di Crespino del Lamone al punto che, nel 1220, Federico II avrebbe assegnato il monastero di Crespino ai conti Guidi di Modigliana. Nel 1258, Firenze era riuscita a tenere per un breve periodo di tempo alcuni castelli della valle del Lamone appartenenti ai Pagani di Susinana mentre, nello stesso anno, l’abbazia di Marradi cedeva a Firenze alcuni degli abitati dipendenti dal monastero in cambio di protezione contro dei non meglio precisati nemici. Nel 1284, dopo aver perduto il controllo su tutte queste località, il Comune fiorentino avrebbe progettato la fondazione della piccola Terra Nuova di Casaglia, in prossimità delle sorgenti del Lamone. Una sintesi di questo primo tentativo di occupazione dell’alta valle del Lamone è in P. Pirillo, Passaggio a Nord-Est. Firenze e le vie per la Romagna (secc. XIII-XIV), in AMR, n.s., LXII, 2011-2012 ma: 2013, pp. 41-54.
10 Sulla vicenda di Casaglia e sul tentativo di controllo fiorentino della parte iniziale della Valdilamo-ne dai primi anni Ottanta del secolo XIII, cfr. P. Pirillo, Creare comunità. Firenze e i centri di nuova fondazione della Toscana medievale, Roma 2007, pp. 181 e sgg.
11 Ivi, p. 204.
54
campo. Il quadro geo-politico era ridivenuto in larga parte simile a quello del settore nord-occidentale dell’Appennino fiorentino. Qui - come sappiamo bene da tutta una serie di contributi anche recenti - tra le aree effettivamente controllate da Bologna e da Firenze, ancora ai primi del XIV secolo, sussi-stevano grandi e piccole signorie territoriali come quelle degli Alberti, Da Panico, Stagnesi e anche Ubaldini, per limitarsi ai nomi di maggior spicco12.
Per converso, l’espansione di Bologna e di Firenze sui rispettivi contadi puntava al crinale appenninico quale limite storico corrispondente a quello diocesano, assottigliando progressivamente, fino a eliminarla, la presenza dei lignaggi presenti nell’area montana tra le due città o costringendoli tal-volta a ripiegare su uno dei due versanti13. In queste occasioni di frizione tra le due realtà comunali, sempre più frequenti nel corso del XIV secolo, si manifestarono, come vedremo, gli indizi di un nuovo modo di impostare e risolvere i problemi relativi alla legittimazione del dominio sulle aree di cri-nale e di passo che, col tempo, sarebbero divenute sempre meno grigie, per usare una definizione di Giorgio Chittolini14.
Non si tratta di un caso d’eccezione perché le vicende dell’area confinaria compresa tra Bologna e Firenze trovano riscontro un po’ dovunque: dal Friu-li, al Piemonte, al Veronese, al contado di Reggio Emilia, ai più vicini territori appenninici del Pistoiese15. Il dato comune è che, laddove il territorio fosse caratterizzato dal punto di vista orografico (condizione assai diffusa nella dorsale appenninica della Penisola), città e signori tendevano a completare,
12 T. Lazzari, Comunità rurali e potere signorile nell’Appennino bolognese: il dominio dei conti Alberti, in Signori feudali e comunità appenniniche nel Medioevo, “Storia e ricerca sul campo tra Emilia e Toscana”, n. 2, Pistoia-Porretta Terme, 1995, pp. 81-89, in particolare p. 81. Cfr. i due saggi di R. Zagnoni in Il Medioevo nella montagna tosco-bolognese, uomini e strutture in una terra di confine, Porretta Terme 2004, pp. 345-406 (Alberti), 407-434 (Stagnesi) e Id. Gli Ubaldini del Mugello nella montagna oggi bolognese nel Medioevo, in AMR, n.s., vol. LIX, 2008, pp. 69-162.
13 Un chiaro esempio di ripiegamento su un solo versante dell’Appennino è offerto da Foschi, La fa-miglia dei conti di Panico: una mancata signoria interregionale, in Signori feudali, pp. 69-79, in particolare p. 75.
14 G. Chittolini, Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo, in Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, IV, Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l’egemonia, Torino 1981, pp. 589-676, in particolare pp. 618-621.
15 In area friulana si sarebbe dovuta attendere la metà del sec. XV per giungere a una definizione confinaria tra Venezia e l’Impero (D. Degrassi, Dai confini dei villaggi ai confini politici. L’area friulana nel tardo medioevo, in “Reti Medievali Rivista”, 7, 1 (2006) [http://www.rmois.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3182], p. 10; Per l’area piemontese, cfr. R. Bordone, “Promiscuità territoriale” e delimitazione del confine in Piemonte. Il caso di Piovà Massaia e Cerreto d’Asti, in “Reti Medievali Rivista”, 7, 1 1 (2006) [http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3181] e L. Provero, Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento, in “Reti Medievali Rivista”, 7, 1 (2006) [http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3188]; per quella veronese e vicentina: Varanini, L’invenzione dei confini; per il Pistoiese: Francesconi, Salvestrini, Il “Liber finium districtus Pistorii”: modelli e scritture del confine in età comunale, in Il confine appenninico, pp. 29-61; per l’area appenninica del territorio comunale di Reggio Emilia: A. Gamberini, La territorialità nel Basso Medioevo: un problema chiuso? Osservazioni a margine della vicenda di Reggio, in Poteri signorili e feudali, pp. 47-72.
55
ribadire e legittimare i limiti del loro dominio lungo i crinali, mentre le co-munità locali avrebbero invece continuato a guardare alle zone sommitali dell’Appennino come ad aree di potenziale sviluppo economico, prescin-dendo, laddove era loro più utile, dai tracciati confinari16.
In questa messa a punto delle linee di demarcazione tra crescenti realtà politico-territoriali, ebbero sempre più peso proprio quelle sentenze, carte di lodo, pacificazioni relative alla risoluzione di contenziosi e attriti a livello locale, per l’uso di pascoli, boschi e altri beni comuni. Cause poi approdate negli archivi e nei libri iurium cittadini che finirono per costituire, all’occor-renza, gli elementi probatori per la legittimazione e l’affermazione dei limi-ti dei nascenti Stati territoriali17. Ma non sempre i “fines publici” potevano corrispondere con gli interessi delle comunità locali che, come ho accennato, avevano una diversa percezione dei limiti finalizzata all’utilizzazione delle risorse18. Questo rendeva indubbiamente i processi di definizione più lenti, incerti e, come si è detto, non lineari dov’è possibile intravvedere la pluralità di risoluzioni pragmaticamente adottate dalle politiche territoriali cittadine per assicurarsi un controllo sulle strade con le Dominanti tese a coinvolgere in prima persona le comunità19. Una chiara esemplificazione delle conside-razioni appena fatte la si ottiene ripercorrendo una di queste vicende che ho già avuto modo di descrivere con maggiori dettagli in altra sede: quella relativa alla montagna di Montebeni (attuale Comune di Firenzuola), un ri-lievo di 1263 msl, la cui sommità dista due chilometri e mezzo in linea d’aria dall’odierno confine regionale tosco-emiliano20.
Alla fine degli anni Trenta del secolo XIV, un contenzioso opponeva la comunità di Pietramala (ubicata nel territorio allora controllato da Bologna) con quella di Le Valli, sotto il dominio fiorentino. L’oggetto della frizione era costituito dallo sfruttamento dei pascoli situati appunto sul rilievo di Montebeni che gli uomini di Pietramala rivendicavano come propri poiché, secondo la loro versione e di conseguenza anche per il Comune bolognese, il confine con il territorio di Le Valli comprendeva l’intero rilievo. L’affaire assunse subito i toni di una crisi ‘interregionale’ e, proprio per questo mo-
16 Provero, Una cultura dei confini, p. 9.17 Francesconi, Salvestrini, La scrittura del confine nell’Italia comunale, passim.18 Marchetti, Spazio politico e confini, p. 6. Il “finaggio promiscuo” piemontese costruiva un’intrecciata
topografia di beni comuni di comunità diverse fino a formare delle vere e proprie isole amministrative (Bordone, “Promiscuità territoriale”, p. 8). Lo stesso è stato osservato per l’area friulana (Degrassi, Dai con-fini dei villaggi ai confini politici, p. 6).
19 Come, ad esempio, recitava un dispaccio del settembre 1365 inviato alla comunità appenninica di San Godenzo (ASF, Archivi della Repubblica, Missive I Cancelleria, 13, c. 65v, 16 settembre 1365).
20 P. Pirillo, La sottile linea grigia. La montagna di Monte Beni e il confine appenninico tra Bologna e Firenze (secc. XII-XIV), in La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma 2004, pp. 69-90 cui rinvio senz’altro per tutti i particolari che invece sono stati per brevità omessi o compendiati nel presente contributo.
56
tivo, si decise di sottoporlo al parere di un giudice di Siena: la causa venne discussa in quella città, nel settembre del 133721. Questo evento seguiva di poco il passaggio sotto Firenze (1332) di quelle che, fino a quel momento, si erano chiamate le “Alpes Ubaldinorum” un’annessione che eliminava, alme-no in quella parte di Appennino, qualsiasi presenza significativa frapposta tra Firenze e Bologna22.
Gli elementi essenziali del dibattimento che qui ci interessano da vicino riguardavano proprio la localizzazione della linea di confine tra le due comu-nità e, di conseguenza, tra Firenze e Bologna. Il rappresentante di quest’ul-tima città sosteneva, come si è detto, l’appartenenza dell’intera montagna a Pietramala: le prove addotte si fondavano su una precedente confinazione tra i due contadi risalente a quarant’anni prima fatta, a sua volta, sulla base di un lodo del 1243 con cui gli Ubaldini, allora signori di entrambe le aree, erano intervenuti per dividere le terre delle curtes di Pietramala e di Le Val-li23. Quella confinazione, abbracciando l’intera montagna alla base meridio-nale del rilievo, lo attribuiva interamente a Pietramala (Fig. 1).
Per sostenere le ragioni della sua comunità e di conseguenza le proprie, Firenze aveva invece opposto una tesi diversa appoggiandosi a un altro lodo di casa Ubaldini più risalente, datato al 1189. In questo caso, a differenza delle testimonianze presentate da Bologna, la linea di confine tagliava in due il rilievo di Montebeni, passando per la cima e separando dunque in corri-spondenza del crinale le due comunità e i territori fiorentino e bolognese (Fig. 2).
Il lodo arbitrale prese per buona la versione fiorentina. È però evidente che, per la Repubblica di Firenze, i pascoli di Montebeni dovevano costituire l’ultima delle preoccupazioni rispetto all’affermazione della propria egemo-nia su un’ulteriore parte del comitatus storico24. In effetti, questa salomonica risoluzione aveva fissato il confine proprio sulla linea del crinale di Monte-beni ma celava un’altra motivazione che non era stata evocata durante tutta la discussione. Perché l’esistenza di un castello omonimo del rilievo o dei suoi resti sulla parte sommitale offriva la possibilità di controllare una del-
21 Ivi, pp. 72 e ss.22 Si trattava dei territori dei pivieri di Bordignano, Camaggiore e Riocornacchiaia (ASF, Archivi della
Repubblica, Capitoli, registri, 32, cc. 271r e ss., 9 aprile 1332).23 Pirillo, La sottile linea grigia, p.75. 24 Anche se si trattava di acquisire aree per il pascolo come risorsa collettiva di cui avrebbe
beneficiato anche la popolazione cittadina: un chiaro esempio può essere costituito dalla politica del Comune pistoiese di primo Duecento (G. Francesconi, “Pro lignis, aquis et herbis”. Comunità di villaggio e beni collettivi nel contado pistoiese (secoli XI-XIV), in Comunità e beni comuni dal Medioevo ad oggi, a cura di R. Zagnoni (“Storia e ricerca sul campo tra Emilia e Toscana”, n. 16), Pistoia-Porretta Terme 2007, pp. 61-83, in particolare le pp. 67, 71, 77. Vicende simili potevano poi tradursi in un forte controllo e nella proibizione di organizzazione delle comunità locali come nel caso del Comune di Reggio Emilia, cfr. Gamberini, La territorialità nel Basso Medioevo, p. 49.
57
Fig. 1. Montebeni (attuale Comune di Firenzuola, provincia di Firenze). La linea confinaria secondo la tesi bolognese (ricostruzione indicativa).
Fig. 2. Montebeni (attuale Comune di Firenzuola, provincia di Firenze). La linea confinaria secondo la tesi fiorentina (ricostruzione indicativa),
58
le direttrici di valico che univano il territorio fiorentino a quello bolognese. Quella fortificazione aveva già costituito una spina nel fianco per Firenze che nel 1309, quindi prima della sentenza senese, in nome della sicurezza sulla strada sottostante, aveva formalmente richiesto al Comune di Bologna di smantellare il castrum di Montebeni: prova evidente che il castello si trovava allora in un’area controllata da Bologna, malgrado si trattasse di territorio formalmente fiorentino25. Dopo aver messo il castello nelle condizioni di non nuocere, la necessità di controllare la strada fece sì che nel 1313 il Comune bolognese vi riportasse nuovamente delle truppe, a conferma dell’importan-za strategica di quel sito26.
Con la sentenza del 1337, il confine passante per il crinale costituiva dun-que il presupposto per una legittima presenza fiorentina sulla cima della montagna e una garanzia contro un’eventuale occupazione e una rifortifi-cazione del sito da parte di forze ostili. Dà valore a questa ipotesi quanto accadde qualche decennio più tardi, nel 1360, quando una parte del casa-to degli Ubaldini, con l’appoggio milanese, occupò il rilievo, fortificandolo nuovamente con l’intenzione - come ricordava Matteo Villani - di fare guerra ai Bolognesi rompendo le strade27. Così, all’indomani di questo avvenimento, si può dire che nessuno dei due Comuni era riuscito a mantenere il controllo militare del luogo e, dopo il 1360, a Firenze restava solo la possibilità di accu-sare i nemici per l’occupazione di quel piccolo lembo di contado fiorentino corrispondente alla metà del rilievo. Per converso, l’accaduto era la prova di quanto gli Ubaldini fossero ancora solidamente ancorati sui due versanti dell’Appennino da dove rivendicavano la loro egemonia su fideles, castelli e villaggi situati sia in Toscana sia in Romagna28. Lungi dall’essere giunta a conclusione, la questione di Montebeni si sarebbe riaperta nel 1375 quando Firenze e Bologna tornarono a disputarsi il dominio di quel rilievo, il cui controllo, ancora una volta, risultava esplicitamente connesso ai rischi cui sembrava sottoposta una delle direttrici viarie transappenniniche tra le due
25 Resti della cinta muraria sono oggi visibili in Rocche e castelli di Romagna, a cura di D. Berardi, A. Cassi Ramelli, F. Montevecchi, G. Ravaldini, F. Schettini, 3 voll., Bologna 1970-1972; p. 260. Un esempio di collaborazione tra i due Comuni di Firenze e Bologna aveva portato nel 1294 alla distruzione della rocca appenninica di Cavrenno dominio degli Ubaldini da parte di Bologna (Pirillo, Tra signori e città: i castelli dell’Appennino alla fine del Medio Evo, pp. 15-29, in particolare p. 18; la tesi di laurea di G. Pederzoli, La politica territoriale del comune di Bologna nel XIII secolo. Gli Ubaldini e Cavrenno, rel. A. L. Trombetti Budriesi, Università di Bologna, a.a. 2009-2010 e Zagnoni, Gli Ubaldini del Mugello, soprattutto le pp. 113-129).
26 Gli eventi sono illustrati in Pirillo, La sottile linea grigia, pp. 70 e ss. Il testo statutario bolognese del 1288 dava un’importanza di spicco ai castelli di aree confinarie (Foschi, I castelli montani del Comune di Bologna, p. 121 e Ead., Castelli e fortificazioni nel Bolognese: repertorio e cronologia, Porretta Terme 2012). Nel 1315 Montebeni venne occupato da armati dei conti Da Panico (Pirillo, La sottile linea grigia, p. 82).
27 L’occupazione degli Ubaldini trasformò il sito del castello in un campo trincerato: gli occupanti lo “steccarono di steccati e fossi e dentro vi feciono capanne” (M. Villani, Cronica, voll. 2, a cura di G. Porta, Parma 1995; II, Lib. IX, rub. 88, pp. 412-413).
28 Pirillo, Tra signori e città, p. 26.
59
città29. Soltanto l’annessione fiorentina del territorio di Pietramala, nel 1404, produsse lo spostamento più a nord del limite del contado inglobando così l’intera montagna che entrava adesso sotto il totale e indiscusso dominio di Firenze30.
Come abbiamo appena visto, l’arbitrato del 1337 aveva portato a ridise-gnare una linea confinaria sul crinale di Montebeni, disinnescandone, alme-no sul piano teorico, le potenzialità strategiche dal momento che questo ren-deva impossibile il controllo di una fortificazione. La documentazione rac-colta e prodotta nella causa discussa a Siena aveva ripercorso a ritroso una stratificazione di testimonianze risalendo, in pratica, fino agli ultimi anni del XII secolo e appoggiandosi a due documenti originati dagli stessi attori (gli Ubaldini e le due comunità) che avvaloravano entrambe le tesi essendo stati prodotti in due diverse occasioni successive.
Del resto, in mancanza di prove, niente impediva di fabbricarle: gli esem-pi non mancano e, per l’area appenninica tra Bologna e Firenze, mi limiterò a ricordare una causa, discussa nel 1358, dove venne prodotta una donazione del 1048 con l’evidente successiva inserzione su rasura di un riferimento ai comittatta (sic) bononienses et florentinos. Il testo fu esibito dal Comune fioren-tino per avvalorare il proprio dominio sulla piccola contea dello Stale inu-tilmente rivendicata da Bologna che perse così la possibilità di controllare il passo della Futa, uno dei valichi appenninici tra Emilia e Toscana allora più agevoli da attraversare31.
Non sempre, però, l’esigenza di un controllo sui passi e sulle relative direttrici poteva fare affidamento su scelte simili a quelle ricordate fin qui. Più si consolidava la definizione delle rispettive competenze tra le due città, più ardua diveniva la possibilità di estendere, come si era tentato nel secolo precedente, il controllo “ultra Alpes”, al di là delle linee di crinale: un atto che rischiava ora di configurarsi come un attentato alla sovranità territoriale della città vicina, obbligando a un cambiamento di strategie. Così, nel 1341, venuto in possesso del dominio appenninico un tempo appartenuto ai con-ti Alberti, il Comune fiorentino preferì cedere in vendita a privati la parte
29 Bologna era intervenuta perché alcuni alpigiani provenienti dal contado fiorentino avevano occu-pato Montebeni per prevenirne l’utilizzazione da parte di briganti che avrebbero costituito una minaccia per la strada: per questo motivo Firenze sosteneva che il Comune bolognese avrebbe dovuto esprimere riconoscenza invece di reagire come aveva fatto. Da questo evento non sembra sia stato estraneo il Legato pontificio (Pirillo, La sottile linea grigia, p. 87 e A. Gherardi, La guerra dei Fiorentini con papa Gregorio XI detta la guerra degli Otto Santi, estratto dallo “Archivio Storico Italiano”, Serie III, t. V, Firenze 1868, p. 129).
30 I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto, a cura di C. Guasti e A. Gherardi, voll. 2, Firenze 1866-1903, II, p. 266, 29 luglio 1404.
31 P. Pirillo, Una “drôle de guerre”: Firenze e le fortificazioni campali dello Stale (Appennino tosco-emiliano, 1357-1358), negli Atti del convegno Fortilizi e campi di battaglia nel Medioevo attorno a Siena, a cura di M. Marrocchi, Siena 1998, pp. 265-288.
60
situata nel Bolognese, trovando degli interessati acquirenti negli uomini di una comunità della vicina valle del Bisenzio. Così, per la non modica somma di 1800 fiorini, l’universitas di Mangona, in precedenza sotto il dominio degli Alberti e poi dei Bardi, divenne proprietaria di decine di poderi, di case com-preso un mulino e i resti di un fortilizio nel territorio di Le Mogne, al di là del crinale appenninico, nel Bolognese32. In questo modo, Firenze poteva contare sulla presenza oltre il confine di un cospicuo nucleo di proprietari terrieri suoi comitatini, in una configurazione assai simile ai precedenti tentativi di popolamento delle aree prossime ai crinali33. Rimane il fatto che si trattava comunque di proprietà fondiarie decisamente più esposte a rischi: così, alla fine degli anni Venti del Quattrocento, l’abate di San Godenzo lamentava di non aver più avuto niente, nei tre anni precedenti, da un podere della badia ubicato nel territorio romagnolo di Portico: a causa dei recenti eventi bellici, il contadino era stato imprigionato e la sua abitazione data alle fiamme34. Ma anche quando la situazione non degenerava fino a questo punto, gli attriti restavano all’ordine del giorno: le terre e le case appartenenti a residenti nel distretto fiscale limitrofo restavano comunque soggette a esazioni pretese da un’autorità fiscale diversa da quella principale di riferimento, alimentando in effetti i rischi di controversie. Per limitarsi a un paio di esempi, nell’ago-sto del 1367 una missiva fiorentina invitava gli abitanti di San Godenzo a mantenere dei buoni rapporti con gli uomini di Castel dell’Alpi, in partico-lare per casgione delle tagle ch’avete a pagare delle terre le quali avete in su quello de Castello de l’Alpe35. In un caso immediatamente successivo, dell’estate del 1375, lo stesso giorno di entrata in carica degli Otto Santi, Firenze inviava al rettore pontificio della Romagna una lettera di protesta che aveva come og-getto due situazioni simili a quelle appena evocate36. Da un lato, si trattava della pretesa da parte della Chiesa - cui Firenze ovviamente si opponeva - di esigere il versamento delle decime per alcuni appezzamenti di terra di pro-prietà pontificia ubicati nel territorio di Susinana che era parte integrante del
32 Dopo la cessione al Comune fiorentino della contea di Mangona da parte della famiglia dei Bardi, le terre e gli edifici ubicati oltre il crinale relativi al territorio di Le Mogne erano riconosciuti come parte integrante del contado bolognese, come risultava almeno dal 1288 (P. Pirillo, Il popolamento dell’Appennino fiorentino nella crisi trecentesca: il caso della contea di Mangona, in Villaggi, boschi e campi dell’Appennino dal Medioevo all’età contemporanea, (“Storia e ricerca sul campo tra Emilia e Toscana”, n. 5), Pistoia-Porretta Terme 1997, pp. 59-67, in particolare p. 65).
33 P. Pirillo, Signorie dell’Appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna alla fine del Medioevo, in Poteri signorili e feudali, pp. 211-226, in particolare le pp. 215-216.
34 Rispetto al podere nel territorio di Portico, l’abate di San Godenzo sosteneva che “inanzi la ghuerra ne solea avere l’anno XII corbe di grano ch’è già tre anni non n’à avuto niente né spera d’averne perché fu preso il lavoratore e arse la chasa e lle masserizie” (ASF, Catasto, 193, c. 72r).
35 ASF, Archivi della Repubblica, Missive I Cancelleria, 14, c. 70r, 31 agosto 1367.36 Sul conflitto fiorentino con il Papato, cfr. Gherardi, La guerra dei Fiorentini, l’elezione venne ratifica-
ta il 14 agosto 1375 (Ivi, pp. 22 e 117 e ss.). A quello stesso giorno si riferisce la data topica della missiva in-dirizzata al rettore di Romagna (ASF, Archivi della Repubblica, Missive I Cancelleria, 16, c. 6v, 14 agosto 1375).
61
comitatus fiorentino. Per converso, proprio nel rispetto di quello che doveva essere considerato un vero e proprio confine, la Repubblica si impegnava dal canto suo a costringere gli abitanti di Castagno e di San Godenzo, tutti comitatini fiorentini, a regolare con il Rettore le loro pendenze fiscali per le terre possedute nel territorio romagnolo di Premilcuore, dimostrando così un riguardo per le specifiche competenze37.
Quando poi risultava difficile, se non impossibile, intervenire ricorren-do alle vie della controversia giudiziaria, la necessità di controllare crinali e valichi nel rispetto di linee confinarie precedentemente negoziate veniva aggirata, facendo prevalere al diritto la ragione di Stato. È un altro caso che vorrei prendere qui in considerazione concernente la parte sommitale del Monte della Fine, all’interno del territorio di Piancaldoli, allora sotto il con-trollo bolognese, dove, almeno alla metà del XIV secolo, era ubicato un ca-stello38. Che non vi fossero dubbi su chi vi esercitasse un legittimo dominio lo dimostra il fatto che, avendo presentito l’imminente cessione di Bologna da parte dei Pepoli, Firenze decise di occupare il castrum per scongiurare l’eventualità che questo poi cadesse in mani milanesi. L’operazione militare fu dunque condotta con truppe regolari ma sprovviste di elementi distin-tivi che potessero farle riconoscere come fiorentine. L’ordine era infatti che nessun armato avesse stemmi, insegne o bandiere poiché altrimenti - recita-vano le missive - si sarebbe rischiato ciò che oggi potremmo definire come un incidente diplomatico. L’azione fu coronata da successo e, di lì a poco, la guarnigione, il cui anonimato era evidentemente solo formale, subì il preve-dibile attacco da parte delle truppe viscontee. Firenze non aveva sperato di annettersi il castello che era incontestabilmente in territorio bolognese, ma da una posizione di forza riuscì a negoziarne l’eliminazione che, in fondo, equivaleva al raggiungimento dello scopo. Infatti, l’accordo che mise fine all’assedio milanese prevedeva l’abbandono del castrum da parte degli occu-panti fiorentini e la sua distruzione con l’impiego di mano d’opera reclutata in entrambi i contingenti: la Repubblica fiorentina vedeva così scomparire un’altra minaccia sul crinale appenninico, con un conseguente alleggerimen-to di una potenziale pressione ostile su un passo la cui forte valenza stra-tegica si sarebbe confermata ancora una volta negli anni successivi. Infatti, Firenze non fece passare molto tempo per rendere nuovamente operativa la fortificazione e, a loro volta, i Bolognesi, pochissimi anni più tardi (nel 1359), se ne riappropriarono. La vicenda lascia ipotizzare il tentativo di cre-are un’area ‘smilitarizzata’ lungo una linea di confine ormai in progressivo
37 Ibidem.38 Pirillo, La sottile linea grigia, pp. 83 e sgg. Resti sono visibili sulla sommità del rilievo omonimo
(Rocche e castelli di Romagna, p. 262).
62
consolidamento forse senza prevedere che questo non avrebbe costituito un vantaggio per la popolazione. Era, ad esempio, quanto lamentavano nel 1427 gli uomini di Castiglioni (oggi Castiglioncello), un abitato tormentato dalla guerra forse fin dalla sua sottomissione a Firenze che risaliva al dicembre del 133139. La sua posizione al limite del territorio fiorentino e di quello imolese non garantiva una vita tranquilla: nel 1427, un tale Matteo sosteneva di aver perduto la propria casa per la guerra perché era la detta chaxa tanto apresso alla bastia di Chastiglioni che per fortezza della bastia fu fatta disfare40. Del resto, come scriveva uno degli abitanti, il confine sfiorava addirittura le case: abiamo el termine che parte fra el nostro magnificho Chomune e ‘l contado d’Imola a confine con le mura delle chaxe41 e, ancora oggi, la linea che divide le due regioni dista non più di 200 metri dai resti dell’abitato totalmente spopolato42.
In linea generale l’uso e anche l’abuso delle confinazioni di crinale da parte di città comunali in espansione, come Bologna e Firenze, aveva - come spero di aver dimostrato - una finalità legata alle esigenze politiche del pote-re centrale che si appoggiava, quando era possibile, a rivendicazioni locali di tutt’altra natura. Così, proprio puntando sull’interesse bolognese celato nella loro petizione, gli uomini di Camugnano, parte integrante del Capitanato della Montagna bolognese, rivendicando la protezione di Bologna contro le pretese della nobile Caterina di Guzzano, avrebbero richiesto - siamo negli anni Ottanta del Trecento - un nuovo posizionamento dei termini lapidei in netto contrasto con la loro domina, favorendo il consolidarsi della presenza bolognese su quell’area43.
Le due esigenze, locale e centrale, finivano per coincidere anche se l’otti-ca di fondo sarebbe a lungo rimasta duplice44. Le comunità locali avrebbero continuato a vivere montagne, passi, crinali e linee confinarie con una perce-zione geografica sostenuta dall’interesse per boschi, pascoli, usi civici, beni comuni, elementi base dell’economia montana, prescindendo, laddove ne-
39 Cfr. la nomina di un procuratore da parte di 14 “homines populi Sancti Pauli de Castiglioni, co-mitatus et districtus Florentie” perché si recasse a Firenze a presentare l’atto di sottomissione della co-munità. L’atto era stato rogato nella chiesa di San Paolo alla presenza del parroco, di un individuo della Massa degli Alidosi e di uno della vicina località imolese di Valsalva (ASF, Diplomatico, Riformagioni, 1331, dicembre 30).
40 ASF, Catasto, 146 (anno 1427), c.5r.41 Ivi, c. 11v.42 Ai piedi di Castiglioncello sarebbe stata successivamente edificata una stazione doganale. Il dise-
gno è in http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ 09cfbd8044225397aff4bf4e7aaa0be0/ Pianta+della+Dogana+del+Moranduccio_Castiglioncello_8.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=09cfbd8044225397aff4bf4e7aaa0be0.
43 R. Zagnoni, Il castello di Mogone dei conti Alberti nel Medioevo (secoli XII-XV), in I Castelli dell’Appennino nel Medioevo, pp. 31-50, in particolare p. 43.
44 E. Franzina, “Varcare i confini”: viaggi e passaggi degli emigranti. Il caso italiano e le teorie transnazionali, in Confini, costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni, a cura di S. Salvatici, Soveria Mannelli 2005, pp. 115-152, in particolare p. 128.
63
cessario ai loro bisogni, dai potenziali vincoli di una geografia politica da cui sarebbero rimasti sostanzialmente estranei45. Ancora gli uomini di Castiglio-ni, sul confine tra Firenze e Imola, nel 1427, dichiaravano di possedere boschi da ghiande e da legne […] e ancora le pasture tutte poste nella corte della Massa cioè nel contado di Imola, conviencine pagare el dacio ai Aleduxi o a chi è in loro luogo o non possemo pasturare con bestiame niuno senza loro parola: che quel territorio fosse sotto la signoria degli Alidosi o che non lo fosse, l’essenziale era in fondo continuare a disporre di risorse essenziali alla vita di una comunità abituata da sempre a lavorare senza confini, come il Tönle di Rigoni Stern46.
Quando non venivano superati con la forza, come accadde con la conqui-sta della Romagna ‘toscana’ da parte di Firenze, i crinali osservati in lonta-
45 Tenendo conto della lunga resistenza da parte delle culture montanare nei confronti di confini con andamento lineare imposte da una cultura dominante cittadina (Provero, Una cultura dei confini, p. 12). Localmente la pratica dei confini era intimamente legata alla nozione dello habitare in un determinato luogo (Ivi, pp. 1, 6). Anche nel Veronese, lo sforzo di definizione confinaria da parte del Comune resterà localmente incerto in relazione all’uso dei pascoli (Varanini, L’invenzione dei confini, p. 3).
46 ASF, Catasto, 146 (anno 1427), c. 11v. Per le considerazioni sulla valenza culturale del confine nella Storia di Tönle, cfr. M. Quaini, Ri/tracciare le geografie dei confini, in Confini, costruzioni, attraversamenti, pp. 187-198.
Fig. 3. Castiglioncello (Castiglioni) il sito del castello. La linea tratteggiata indica l’attuale confine regionale.
64
nanza dalle Dominanti andarono sempre più affermandosi come limiti dei contadi cittadini in un processo che soltanto molti secoli più tardi avrebbe trovato una sua caratterizzazione ideologica sia nell’invenzione dei “confini naturali”, sia di una territorialità percepita nei termini di pieno dominio dello spazio entro dei confini47. Ma alle dinamiche della prima formazione degli Stati territoriali come quelli di Bologna e Firenze al centro delle pagine preceden-ti erano legati i presupposti per una differenziazione sempre più netta tra la dimensione politica e territoriale della demarcazione e quella del confine percepito localmente come limite sociale e simbolico48.
47 La citazione puntuale da un contributo di C. S. Maier è in S. Salvatici, Introduzione a Confini, costruzioni, attraversamenti, pp. 7-20, a p. 12. Cfr. anche Marchetti, Diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna, pp. 20 e ss.
48 P.P. Viazzo, Frontiere e ‘confini’: prospettive antropologiche, in Confini e frontiere nell’età moderna, pp. 21-44.
65
Elena Vannucchi
UN CRINALE PER UN SANTO:SAN PELLEGRINO DELL’ALPE FRA MODENA E GARFAGNANA
In ricordo di Vanna Vignali, ora pellegrina verso l’Eterno
San Pellegrino in Alpe (provincia di Lucca), a 1525 m. di altezza, è un modesto agglomerato di case, poche, un ufficio postale, due ristoranti, un negozio di prodotti tipici della montagna. Minuscolo, ma collocato in una zona suggestivamente stupenda, il paese costituisce il collegamento ideale tra monti e mare, tra le Apuane e la Versilia, che digrada verso il Tirreno, ed è punto di arrivo o di partenza, a seconda della direzione di provenienza, dell’itinerario che sin dall’età romana connetteva il Modenese con la Garfa-gnana, attraverso il passo delle Radici. La denominazione alla località deriva dalla dedicazione del santuario ivi esistente a San Pellegrino, una chiesa mu-tata dal succedersi degli interventi costruttivi, che si erge a segnalare come un cippo il confine tra Emilia e Toscana, che mostra tracce significative del-la sua antica origine altomedievale come un significativo reperto del secolo VIII che rappresenta un pellegrino che riceve la benedizione. Una chiesa di confine per un personaggio senza confini, per un personaggio in cammino, così come l’uomo, da sempre, è in cammino, per esigenze di sopravvivenza prima; alla ricerca di una vita diversa da quella materiale poi. Esci dalla tua terra e va’ dice il Signore ad Abramo dove io ti condurrò (Genesi, 12, 1-10); il cammino dell’uomo diventa, alla luce delle sue credenze di fede un itine-rario verso la salvezza eterna, la cui materiale evidenza è il pellegrinaggio, sacro, appunto, nel corso del quale l’uomo abbandona le certezze dei luo-ghi per seguire la certezza della fede. Il peregrinus diviene allora straniero, perché la vera peregrinatio consiste nella separazione dal proprio ambien-te, dalle relazioni sociali e familiari, nella risposta alla chiamata; la sequela Christi (Matteo, 16, 24) è più forte di qualsiasi altro legame. I Greci avevano una parola per designare lo stato del pellegrino: xeniteia, un vocabolo che possiamo tradurre con “spaesamento”1. Ed è proprio questo spaesamento rispetto ai luoghi che rende i pellegrini stessi santificati o santificabili dallo
1 Sulla condizione di spaesamento A. Guillaumont, Le dépaysement comme forme d’ascèse dans le monachisme ancien, in Ecole Pratique de Hautes Etudes, Vème Section, Sciences religieuses, Annuaire 1968-69, 76, Paris 1968, 32 e C. Deluz, Partir c’est mourir un peu. Voyage et déracinement dans la société médiévale, in Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 26e Congrès, Aubazine 1996, pp. 291-303.
66
scopo, dalla meta e dalle intenzioni del loro viaggio, e talvolta anche santi. Santi pellegrini come il “nostro” San Pellegrino, che, però, è un personaggio di cui poco si sa, corredato da numerosi omonimi, fatto non insolito ma, nel nostro caso, quasi un’aggravante. Certo, la ricostruzione delle vicende agiografiche e l’individuazione ed autenticazione del personaggio risultano, in mancanza di documentazione sicura o, se non abbondante, almeno suf-ficiente, esercizio di lettura talvolta difficile da eseguire, anche se i tentativi non sono mancati. Ci si riferisce ad un volume recentemente edito2 nel quale si procede all’identificazione delle sante personalità recanti lo stesso nome di San Pellegrino, collegando a ciascuna di esse il culto o la dedicazione di chiese più o meno note. L’operazione ha recuperato una serie di personalità riconosciute alla cultura devozionale italiana (per la cronaca ben otto, di cui sette riconosciuti dalla Chiesa cattolica) ma, nel nostro caso, il problema resta insoluto3; nessuna notizia di rilievo o novità agiografiche su questo santo il cui culto, tra l’altro, non è neppure ammesso ufficialmente alla devozione dalla Chiesa cattolica. A dire il vero, può anche non essere poi così fonda-mentale conoscere o riconoscere chi fosse questo personaggio, ma la lunga persistenza della storia, seppur leggendaria, a lui riferita4, che dal secolo VII giunge fino a noi come fondamento di un culto popolare ancora riconosciuto e più lontani legami geografici, come vedremo, impongono di riservare al personaggio una particolare attenzione e lo spazio di uno studio, seppur di poche pagine.
Non c’è dubbio: un nome, un destino; così San Pellegrino non è che un’e-vocazione o meglio una vocazione ad un destino di vita: quello del viaggio o del viaggio sacro. E il nostro santo pellegrino viaggiatore dovette esserlo, e straniero, se prestiamo fede alle notizie della sua vita attestate nell’unica testimonianza restituitaci da un Liber choralis pro officio et missa sancti Peregri-ni5, conservato a Lucca e databile al secolo XV6. Vi si narra la storia del figlio
2 San Pellegrino tra mito e storia: i luoghi di culto in Europa, a cura di A. Trezzini, Roma 2009.3 Ibidem, pp.113-122; nella scheda relativa a san Pellegrino “scoto” si richiama senza discutere la
bibliografia edita.4 Per dovere di precisione si segnala anche la chiesa di san Pellegrino al Cassero, dedicata al san
Pellegrino dell’Alpe, e fondata nel XVI secolo. Cfr. San Pellegrino al Cassero, Storia e tradizioni: relazioni tenute a San Pellegrino nel mese di agosto 1996, a cura di F. Boschi, M. Tasi, R. Zagnoni, Porretta Terme-Pistoia 1997.
5 Biblioteca Governativa di Lucca, cod. membr. 1061, sulla cui datazione A. Mancini, Index codicum latinorum publicae bybliothecae Lucensis, in “Studi Italiani di Filologia Classica”, VIII, 1900, pp. 33-88, a p. 67.
6 Il racconto della vita di Pellegrino si diffuse a stampa a partire dal sec. XVI: cfr. G.B. Isachi, Vita di Pellegrino Santo figliuolo di Romano re di Scozia, Reggio Emilia 1586. La leggenda relativa al santo è ripor-tata in forma agiografica da P. Rossi, Compendio della vita di San Pellegrino figlio di un Re di Scozia, posto in luce dal Dottor Pellegrino Rossi modonese, Modena (s.d.). L’opera più recente e più completa sulla storia della chiesa e spedale e sulla leggenda del santo, che tiene di conto della bibliografia precedente, è L. Angelini, Storia di San Pellegrino, Lucca 19832. Ma si veda anche G. Parenti, Un cantastorie al Santuario di San Pellegrino dell’Alpe, a cura di G.P. Borghi, in “Le Apuane”, a. IV, 1985, n. 10, pp. 69-79; E. Lucchesi, L’
67
di un re di Scozia, a cui sarebbe stato dato il nome propiziatorio (o no?) di Pellegrino. Il giovane, intorno al secolo VII, lasciata la vita agiata, intraprese un pellegrinaggio verso la Terrasanta e di qui, con alterne vicende e fra mille pericoli, proseguì alla volta dell’Italia, con soste a Bari, presso le reliquie di San Nicola; a San Michele sul Gargano e a Roma, presso quelle degli Aposto-li. Ultima e definitiva tappa furono gli impervi balzi e le buie foreste d’Ap-pennino, dove il giovane si fermò e stabilì la sua dimora a modo di eremita; rese sicuri i luoghi ai viandanti con una serie di prodigi e miracoli; vinse la tentazione del diavolo ed ottenne la venerazione delle genti del luogo che, alla sua morte, santamente avvenuta nel tronco di un secolare faggio sulla cui corteccia avrebbe lasciate scritte le memorie di sua vita, raccolsero le sue spoglie ed eressero a venerazione un santuario. Più avanti, noto dall’inizio del XII secolo, ma sicuramente più antico, annesso al santuario esisteva uno spedale per il ricovero dei viandanti che di qui transitavano in direzione del valico d’Appennino. Ancora oggi quello che è considerato il corpo del santo Pellegrino, in compagnia di un suo discepolo di nome Bianco7, conservato alla devozione popolare, protegge i luoghi del santuario ove riposa e che siede sul crinale dell’Alpe, separando rigorosamente gli odierni confini di Emilia e Toscana, così lontano dalla sua patria, quella Scozia, la cui definizio-ne geografica per antonomasia indicava tutta la zona di precedente cultura celtica cristianizzata agli albori del V secolo. A proposito della collocazione della tomba e quindi del santuario, secondo la tradizione popolare, alla mor-te del santo sorse tra toscani ed emiliani un’aspra discordia sul luogo della sepoltura. Affidata la salma del santo ad un carro trainato da buoi, questi si fermarono in un luogo esattamente a metà strada, sul confine tra le due re-gioni. Là fu eretto il santuario, in luogo denominato in antico Termae Salonis. Ancora oggi, all’interno della chiesa i corpi dei due santi riposano per metà (dalla cintola in su) in territorio emiliano e per metà (dalla cintola in giù) in territorio toscano. All’esterno della chiesa, il confine è segnato da un cippo in cui sono indicate le iniziali delle due regioni.
Pellegrino era dunque un viaggiatore genericamente “nordico” partito
“Inventio corporis” de saint Pellegrino dell’Alpe di Chiozza, in “Analecta bollandiana”, 104, 1986, pp. 195-219. Sulla produzione poetico-popolare su San Pellegrino si veda G.P. Borghi, Testi poetico-popolari sulla vita di San Pellegrino, in Religione e religiosità in Garfagnana dai culti pagani al passaggio alla Diocesi di Massa (1822), Atti del Convegno di Castelnuovo di Garfagnana (8 e 9 settembre 2007), Modena 2008, pp. 365-387. Sui pellegrinaggi dall’appennino bolognese all’Alpe di San Pellegrino rimando a G.P. Borghi-R. Zagnoni, Dal bolognese a san Pellegrino. Aspetti della devozione dalla valle del Reno bolognese a San Pellegrino dell’Alpe: culto, pellegrinaggi tradizionali, reminiscenze folkloriche, in “Le Apuane”, II, 1983, n. 6, pp. 69-96; Id.-Id., Pellegrinag-gi tradizionali dal bolognese al santuario di san Pellegrino dell’Alpe: aspetti etnoantropologici, in La Garfagnana. Storia, cultura, arte, Atti del Convegno di Castelnuovo Garfagnana (12-13 settembre 1992), Modena 1993, pp. 266-290.
7 Il nome di Bianco come discepolo di pellegrino compare solo a partire dalle visite pastorali del secolo XVI ; cfr. Angelini, Storia di san Pellegrino, p. 122.
68
Il Santuario di San Pellegrino.
Reperto del secolo VIII che rappresenta un pellegrino che riceve la benedizione.
69
dalle zone più settentrionali dell’ecumene cristiano e venuto a morire tra le nostre montagne, nel corso di un santo viaggio. Viene alla mente quel parti-colare pellegrinaggio operato pro devotionis causa o pro voto che, a partire dal VI secolo, assunse, anche ad opera dei missionari irlandesi, la fisionomia di esercizio penitenziale obbligatorio, o volontariamente scelto come esilio per Cristo. Dunque questo pellegrinaggio penitenziale si distingueva da quello di matrice orientale per una diversa funzione del viaggio; i pellegrini ad limi-na, ad Jerusalem e poi a san Jacopo avevano come meta il luogo santo; i pelle-grini penitenti non hanno meta, ché la meta è il viaggio stesso, le cui insidie e difficoltà purificano l’uomo nel corso del viaggio; è il viaggio che diviene strumentale e non funzionale al pellegrinaggio. E quale purificazione mi-gliore che quella di attraversare lontane e sconosciute terre, inaccessibili per eccellenza, quelle folte di boschi e contornate da aspro e selvaggio paesag-gio, non ancora toccate dalla luce della fede, sicuramente infestate dal ma-ligno che si presenta sotto molteplici aspetti? Quale migliore esercizio peni-tenziale che la scelta di una difficile ed irta vita di romitaggio, di solitudine, di lontananza dal mondo, di straniamento dalla stessa realtà umana? Questo pio viaggiatore nordico sembra inserirsi in quella scia nutrita di altri pii pel-legrini che dal VII secolo in poi dall’Irlanda e dal nord giunsero in Italia: furono i grandi evangelizzatori del lungo tardoantico (VI-VIII secolo) come San Patrizio e i suoi discepoli, Sant’Orso vescovo di Aosta, San Colombano che nel 612 fondò il monastero di Bobbio, San Cumiano che a Bobbio visse, San Frediano vescovo di Lucca, San Silao, Santa Brigida e San Gallo, solo per citarne alcuni8. La storia ricorda inoltre anche viandanti nobili, proprio come il nostro giovane principe: re Riccardo, poi San Riccardo di Wessex, nell’VIII
8 Indispensabile il riferimento al classico, seppur datato, J. Ryan, Irish Monasticism, Dublin 1931, insieme a N.K. Chadwick, The Age of the Saints in the Early Celtic Church, London 1961.
Pietra collocata sulla parete esterna sinistra della chiesa di San Pellegri-no, che segna il confine fra Toscana ed Emilia Romagna.
70
secolo, ultimo di una stirpe di regnanti che, a partire dalla seconda metà del VII secolo, si consacrarono al pellegrinaggio espiatorio; o i cosiddetti “re mo-naci” irlandesi dei secoli VII e VIII9. Furono questi viaggiatori che portarono la loro ansia di espiazione e la loro cultura eremitica nelle zone in cui arriva-rono nei loro perigliosi viaggi, che si fermarono e sostarono in luoghi lontani, che morirono prima del ritorno o che tornarono fortificati e santificati da un itinerario così simile a quello che la leggenda di San Pellegrino, annotata dal tardo codice lucchese, indica. Sceso dal nord, forse di ritorno al nord, presso quello che oggi si chiama passo delle Radici, nel percorso che proseguiva quello della via romea nonantolana, alternativa alla percorrenza della Fran-cigena del passo della Cisa, e che collegava l’Emilia alla Toscana, il giovane pellegrino si fermò, come altri, colpito dall’illuminazione di una chiamata che lo rese eremita e santificato, irretito dal fascino di un luogo impervio e sconosciuto alla fede ed alla testimonianza di essa10. Eppure, a differenza de-gli altri viaggiatori e santi iroscoti, del suo viaggio, della sua santa vita e dei prodigi che la costellarono non si trova ricordo se non in quell’unica fonte tarda conservata a Lucca. E di lui non troviamo traccia neppure nella tradi-zione leggendaria irlandese; anche l’antica onomastica inglese sembra atte-stare come assai tardo l’uso del nome proprio a lui attribuito dalla tradizio-ne. Una ricerca sugli items onomastici anglici, infatti, ha dato come risultato, sicuramente non risolutivo, ma comunque da prendere in considerazione, che il nome Peregrinus compare a partire dalla fine del XII secolo (1189-98); nella versione Peregrine dal XIII (1243)11. Un altro elemento di perplessità proviene dal fatto il nostro santo pellegrino “scoto” non è annoverato tra i santi della chiesa cattolica; non solo, il giorno 1° agosto, data nella quale la tradizione popolare celebra (ancor oggi) la sua festa, il calendario litur-gico ricorda, invece, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, assieme a San Buono Martire, San Leo di Montefeltro e Santa Speranza martire. Questa mancata acquisizione agiografica è sicuramente un dato significativo, anche se non si può non notare come la Chiesa Cattolica sia sempre stata un po’ restia ad accettare certe candidature alla santità provenienti, per così dire, da fuori. Ne è un esempio, il fatto che San Colombano, altro santo e pellegrino iroscoto, è stato inserito nel calendario liturgico della Chiesa cattolica solo il 15 maggio 1969 da Papa Paolo VI, su domanda dell’allora vescovo di Bobbio. Dunque
9 Sul pellegrinaggio inglese cfr. A. Spiezia, Pellegrini inglesi nel Medioevo. Tradizione penitenziale e pratiche di pellegrinaggio, Annali dell’Università degli Studi ”Suor Orsola Benincasa”, 2009, pp. 395-423, con relativa bibliografia..
10 Sulla visione della montagna come luogo di esperienza mistica si veda P. Gautier Dalché, La montagne dans la description géographique au Moyen Âge, in La montagne dans le texte médiéval. Entre mythe et réalité, Paris 2000, p. 99-121, (“Cultures et civilisations médiévales”, XIX).
11 P.H. Reaney, R.M. Wilson, A Dictionary of english ancient surnames, Oxford 19953.
71
questo nostro personaggio fu solo un pellegrino tra tanti altri che trovò la sua Gerusalemme privata nel colmo dei monti della Garfagnana e che là santamente morì. E non fu diverso, nella morte, da tanti altri che trovarono, anonimi, la fine della loro vicenda umana in luoghi più o meno frequentati; resi venerabili per la vocazione ad un martirio incruento, quello della mor-te in terra straniera, da sconosciuti, con questa estrema la testimonianza di fede consentivano ad altri una “conversione” ed una interiore adesione al loro messaggio, una percezione della loro santità che si concretizzava con l’azione, con le pie sepolture, o, più ancora, con la sacralizzazione di luoghi nel ricordo della santa morte. Un esempio nella tarda ma significativa testi-monianza fornita da un frammento di una novella tratta dal Trecentonovelle di Franco Sacchetti, in cui si racconta, appunto, il gesto di estrema pietà di due modesti contadini nei confronti di un pellegrino crollato morto in strada. (...) e presso a quel luogo era fatta una fossa per sotterrare un pellegrino. Il signore, veggendo questo, dice: - Che questione è questa? Dicono i contadini: Signor nostro, egli è morto qui un pellegrino, il quale alcuna cosa non troviamo ch’egli abbia di che si possa sotterrare. Noi, per meritare a Dio, abbiamo fatta la fossa; preghiamo il prete rechi la croce e’ doppieri, acciò che lo sotterriamo12.
L’apprezzamento, il rispetto e poi la venerazione di cui probabilmente fu oggetto un santo penitente eremita, giunto da lontano e straniero, dovette dunque innescare un processo di amplificazione delle storie e leggende che intorno a lui inevitabilmente dovettero nascere, e che si consolidarono dopo la morte, nella testimonianza topica di una sepoltura visibile in luogo ove fosse possibile a tutti i viandanti incontrare e fermarsi, in luogo che rappre-sentasse una tappa importante, un punto nevralgico di congiunzione e lega-me di strada: il crinale. E non un crinale qualsiasi, ma un luogo che si trovava su una direttrice viaria importante, su una confluenza di itinerari e strade che connetteva due importanti bacini geografici: quello toscano della Garfa-gnana, quello emiliano del Modenese. L’hospitium sancti Peregrini, sorto dopo la morte del santo, serviva per il ricovero dei viandanti che utilizzavano il passo delle Radici per passare dall’Emilia in terra di Toscana. Era quella la via chiamata Bibulca, che, utilizzando il tracciato di una più antica via roma-na, collegava l’area emiliano padana con quella tirrenica attraverso le valli del Dragone e del Dolo fino, appunto al valico delle Radici.13 Questi ed altri itinerari segnarono la scelta di vita di altri personaggi che, probabilmente,
12 Franco Sacchetti, Il Trecentonovelle, a cura di E. Faccioli, Torino 1970, novella LIX (frammento), p. 62.13 R. Stopani, La via Francigena. Storia di una strada medievale, Firenze 1998; Id., Prima della Francigena.
Itinerari romei nel regnum Langobardorum, Firenze 2000. L. Angelini, La via di san Pellegrino, in Viabilità, traffici, commercio, mercati e fiere in Garfagnana dall’antichità all’unità d’Italia, Atti del Convegno di Castelnuovo Garfagnana (2005), Modena 2006.
72
persero la loro identità originaria per assumere, una volta ricevuta pietosa sepoltura sul luogo ove trovarono la fine del proprio viaggio santificante, quella più semplice, più generica, ma non meno denotativa, di “pellegrino”: una sorta di status symbol.
Ne è indicativa la numerosa segnaletica topografica che identifica nume-rosi luoghi ed edifici sacri collegati a percorsi di pellegrinaggio o valichi o strade antiche, o collocati su direttrici viarie di transito sacro; specialmente nei pressi delle porte cittadine, come ad iniziare percorsi di devozione (o a terminarli). Citiamo tra le testimonianze più suggestive una chiesetta di San Pellegrino a Roma, eretta nell’VIII secolo e collocata foris portam beati Petri apostoli non longe a muris civitatis leonine, e solo più tardi riferita al santo omo-nimo di Auxerre; attualmente la chiesa, ubicata in via dei Pellegrini, dopo aver subito varie vicende nel corso dei tempi riveste le funzioni di cappella del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. Anche a Lucca, presso l’antica posterula di SanGiorgio, sul percorso di accesso più a
nord alla città dalla via Francigena, si ergeva una piccola chiesa dedicata a San Pellegrino, che fu officiata fino al secolo XVII ed esiste ancor oggi, an-che se in pessimo stato, nell’attuale via Galli Tassi. Fu restaurata nel XIX secolo ed in seguito chiusa al culto; abbandonata e ridotta a magazzino, sulla facciata reca ancora un’interes-sante immagine di San Pellegrino. Da qui aveva inizio quello che ci pare un ideale itinerario che, fendendo a metà Longobardia e Toscana, collega-va la città di Lucca a quella di Reg-gio Emilia, ad un’altra antichissima chiesetta di San Pellegrino, fondata,
secondo la tradizione insieme ad altre sette, dal vescovo Sigifredo nel IX se-colo, in località ora inglobata nei sobborghi di Reggio stessa, su una direttrice viaria sud-ovest, verso Roma.
Ma il culto legato al “nostro” San Pellegrino ha valicato i confini della To-scana e si trova sorprendentemente diffuso in altri luoghi, lungo altre diret-trici viarie. Sul valico dolomitico denominato passo San Pellegrino (compre-so nei territori comunali di Moena, Soraga e Falcade e le province di Trento e di Belluno) ai primi del Trecento è attestato un ospizio per i viandanti fonda-to da fratelli che poi si denominarono di San Pellegrino dell’Alpe; oggi non
Un’immagine di San Pellegrino nell’attuale via Galli Tassi a Lucca.
73
resta niente dell’antico spedale e la chiesetta che ora insiste sul luogo è inti-tolata a sant’Antonio di Padova; la festa tradizionale che ancora si celebra, vestigia di una più antica, avviene però il 1° di agosto, anche se ha perso il carattere sacrale ed ha assunto la fisionomia di sagra. A Serravalle di Vittorio Veneto (provincia di Treviso) la traccia del “nostro” San Pellegrino delle Alpi è invece tangibile. Nella cappella dedicata a santa Augusta martire, arroccata su un costone roccioso, è venerato anche San Pellegrino scoto, le cui requie furono ritrovate nel Quattrocento, insieme a quelle della santa titolare che, secondo la leggenda, era figlia di un re visigoto e sarebbe morta intorno al V secolo per mano del padre, poiché si rifiutava di abiurare la fede cattolica. Ancora oggi se ne celebra la festa il 1° di agosto. La diffusione del culto in realtà territoriali anche lontane va ricercata nella fisionomia topografica dei territori, che presentano vari elementi in comune: la difficile accessibilità, su-perabile attraverso vie di comunicazione prossime ma non immediatamente utilizzabili; panorami geografici ostili e nei quali la natura avversa gioca un ruolo di fondo nella definizione della santità; quadri storico-religiosi assai problematici, come il difficile innesto della religione cristiana nel più gene-rale ambiente ancora paganizzante in zone di scarsa demografia. Siamo in presenza del fenomeno di diffusione ed assimilazione del cristianesimo in età tardoantica, caratterizzato, specie nelle zone interne appartate rispetto alle vie di comunicazione, proprio come la Garfagnana, da un graduale di-stacco da credenze pagane e dalla progressiva sostituzione dei principi del cristianesimo. Si leggono allora in questa chiave anche i vari topoi agiografici di cui anche il nostro San Pellegrino è protagonista: la lotta vittoriosa con-tro gli elementi della natura e la facoltà di ammansire gli animali feroci, in sostituzione dell’antico mito pagano del signore dei boschi e degli animali, l’intenzione di guidare i viandanti sulla retta via con la costruzione di piccole croci di legno, piantate lungo sentieri sicuri. Sono questi tutti elementi che riconducono ad un’opera infaticabile di collocazione di segni cristiani sul territorio, per sacralizzarlo e per definire i confini di appartenenza cristiana e di esaugurazione dei luoghi di culto pagani, fino all’esplicita vittoria sulle forze del male rappresentate dal diavolo in persona. Il giovane scoto, infatti, stando alla leggenda, dovette combattere anche con violenza il Diavolo, che scaraventò con la sua santa forza giù per un dirupo che mantiene ancora oggi il suggestivo nome di “Giro del diavolo”.
Ma la prova costituita dalla resistenza alla vita in regioni impervie sem-bra la testimonianza più forte di una fede certa, dettata dalla rinuncia al mondo per estraniarsi e divenire da pellegrini romiti; è la storia del nostro San Pellegrino ma anche di altri personaggi che hanno segnato con le loro vicende e con la loro santità solitaria i luoghi i più lontani e inaccessibili,
74
forti del potere trionfante della fede. Ed allora ecco fiorire eremiti in luoghi elevati e scoscesi, presso i crinali, presso i confini, sentinelle della fede, quasi a picchettare il territorio. Si ricordano, allora, nei dintorni dei luoghi pelle-griniani, legati dall’analogia delle loro vicende, San Viviano o Viano14, che si ritirò in eremitaggio in una zona in quota delle Alpi Apuane, dove ora si erge un santuario “in abri” presso il passo Tambura; ma vale anche ricorda-re, lontano dalla Garfagnana, ma accomunata ad essa dalla specificità delle storie e della scelta dei luoghi, la leggenda dei sette santi eremiti lariani che presidiavano sette luoghi in quota nella Valsassina. Una cintura sacra che ga-rantiva una protezione dall’alto ai fedeli e che, nello stesso tempo, indicava come un faro la via da seguire, e non solo quella ideale della fede, ma anche quella materiale verso i luoghi di fede.
14 Su san Viviano o Viano, si veda M. Verdigi, Vagli: terre di frontiera, Lucca 1986 (ristampa1994), pp. 99-108; Id., S. Viviano di Vagli, Lucca 1994, A.C. Ambrosi, La leggenda di San Viano in Garfagnana e i santuari di “abri” nella Liguria etnica del levante, in Miscellanea Formentini, “Memorie della Accademia lunigianese di scienze G. Cappellini”, v. 33. n.s., 10, 1961, pp. 5-37. Curiosamente, anche san Viano o Viviano non è riconosciuto dalla Chiesa cattolica.
Il suggestivo “Giro del diavolo”.
75
Carlo Vivoli
TRA GRANDUCATO DI TOSCANA, DUCATO DI MODENAE STATO DELLA CHIESA:
L’APPENNINO NELLA CARTOGRAFIA STORICA
Come cambia la percezione di un confine naturale quale certamente è la catena montuosa dell’Appennino tosco-emiliano che oggi separa le regioni Toscana ed Emilia Romagna e che nel passato è stato un confine politico che ha diviso città e stati sovrani. E ancora quale ruolo ha svolto nel corso del tempo questa barriera “naturale” che molto spesso si è configurata come un elemento capace di unire più che di dividere.
La lunga esperienza del “Gruppo di studi alta valle del Reno” e la serie di incontri di Capugnano, dedicati alla storia e alla ricerca sul campo fra Emi-lia e Toscana, hanno fornito nel corso degli anni già molte risposte a questi interrogativi.
Penso soprattutto al convegno del 20001, dedicato proprio al “Crinale ap-penninico”, ed in particolare agli interventi di Renzo Zagnoni, di Giampaolo Francesconi e Francesco Salvestrini, di Paola Foschi, di Leardo Mascanzoni, ma molti altri sono stati i contributi che hanno affrontato queste tematiche, sia in quell’occasione, che nelle molte altre succedutesi dal 1993.
Lo Zagnoni ripercorrendo da par suo in poche pagine duemila anni di storia metteva bene in luce, almeno secondo la mia interpretazione, due aspetti fondamentali della questione: il ruolo centrale svolto dal confine nel determinare l’odierna situazione sociale, economica, linguistica e dell’emigrazione del territorio di cui si discute in questa giornata di studio, ma anche il carattere in qualche modo unificante di quest’azione con un confine che non ha mai rappre-sentato un taglio netto, una cesura radicale, un limite invalicabile, ma quasi sempre il contrario di tutto ciò poiché le popolazioni dei due versanti da secoli sono state in stretto contatto ed in rapporto continuo anche dal punto di vista sociale2.
Anche le considerazioni dalle quali prendevano le mosse Marco Breschi e Lucia Pozzi in un intervento presentato ad un precedente convegno di Capu-gnano, quello del 1996 dedicato a “Villaggi boschi e campi”, andavano nella stessa direzione sottolineando come i territori di Sambuca e Granaglione,
1 Il confine appenninico: percezione e realtà dall’età antica ad oggi, Atti della giornata di studio (9 settembre 2009), a cura di P. Foschi e R. Zagnoni, Porretta Terme-Pistoia 2000 (“Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana”, 11).
2 R. Zagnoni, Un confine lungo duemila anni: sintesi delle vicende del confine appenninico, in Il confine appenninico, pp. 17-27.
76
seppure da tempo storicamente divisi, tendessero a ricomporsi nell’ampia confluenza del bacino del Reno3. Nel loro caso il Breschi e la Pozzi utilizzava-no due fonti documentarie di tipo demografico per argomentare e suffragare la loro ipotesi; in questa sede, riprendendo quanto fatto da Paola Foschi, si partirà dalla cartografia storica prodotta nel corso dell’età moderna dagli stati per organizzare il loro territorio, focalizzando l’attenzione sulla Tosca-na, per cercare di ricostruire quale percezione del confine si vada affermando e soprattutto come si modifichi nel corso dei secoli.
Più di dieci anni fa, come si è già ricordato, Paola Foschi, aveva in qual-che modo affrontato la stessa tematica partendo dalla cartografia prodotta da un altro dei soggetti in causa, la legazione di Bologna, allora compresa nello Stato della Chiesa4. Per chiudere in qualche modo il cerchio sarebbe necessario indagare quanto fatto dal terzo protagonista citato nel titolo, il Ducato di Modena, ed è con questo auspicio che si prendono le mosse per ricostruire, sia pure a grandi linee, quello che è successo tra Cinque e Sette-cento nella Toscana, prima Medicea e poi Lorenese.
Va innanzitutto ricordato come si stia trattando di un confine un po’ particolare, nel quale si confondono limiti naturali ed acquisizioni storiche: se dall’Alpe delle Tre Potenze ai Monti dell’Orsigna esso si presenta infatti come un confine ad un tempo idrografico e politico, proseguendo verso est il crinale si perde nelle testate delle valli padane del Reno e delle Limentre, conquistate da Pistoia sin dal Medioevo ed ancora facenti parte della “tosca-na” montagna pistoiese5.
Un confine che, partendo da est, dalle sorgenti del torrente Carigiola e per arrivare sino all’Alpe delle Tre Potenze, lambiva in età moderna i tre stati cui si fa riferimento nel titolo di questa relazione, ma anche, ai due estre-mi, rispettivamente la contea di Vernio e la Repubblica di Lucca, fornendo un elenco quasi completo delle varie tipologie di organizzazioni politiche che sopravvivevano nell’Italia centro settentrionale alla crisi della civiltà co-munale e cittadina. Una repubblica cittadina destinata a durare ben oltre la rivoluzione francese come Lucca, una signoria feudale spazzata via invece proprio dalle armate napoleoniche, due stati territoriali legati a due dinastie di differente formazione, ma proprio in quei secoli in lotta per questioni di
3 M. Breschi, L. Pozzi, Un territorio di frontiera. Popolazioni e villaggi dell’Appennino pistoiese e bolognese nell’Ottocento pre-unitario, in Villaggi, boschi e campi dell’Appennino dal medioevo all’età contemporanea, Atti delle giornate di studio (21 luglio, 6 agosto, 14 settembre, 17 novembre 1976), a cura di P. Foschi, E. Pennoncini, R. Zagnoni, Porretta Terme-Pistoia, 1997, (“Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana”, 5), pp. 83-108.
4 P. Foschi, Il confine montano fra Bologna, Modena e la Toscana fra XVII e XVIII secolo nelle mappe dell’Assunteria di Confini, in Il confine appenninico, pp. 117-138.
5 Per una visione d’insieme si rimanda, tra i tanti contributi, al quadro monografico dedicato alla Montagna pistoiese in I paesaggi dell’Appennino, a cura di C. Greppi, Venezia 1990, pp. 191-201.
77
precedenza, come i Medici e gli Este, e lo Stato della Chiesa, legato al potere temporale dei papi, anche esso destinato proprio in quei tempi a rafforzarsi e consolidarsi.
Coloro che si fronteggiano realmente, come cercheremo di vedere dalle carte, non sono però tanto queste compagini statuali, quanto le loro artico-lazioni territoriali e quindi la provincia di Frignano con le sue comunità e la legazione di Bologna con i vari “signori della montagna” da un lato, il capitanato della Montagna di Pistoia, le cortine di Pistoia e la podesteria di Montale dall’altro, territori dotati di particolari autonomie, retaggio dei par-ticolarismi medievali destinati a perdurare a lungo nel corso dei secoli6.
Del resto, ed è stato più volte notato, nelle opere dei geografi quattro-cinquecenteschi l’Italia veniva rappresentata come un agglomerato di cit-tà avulse da qualsiasi contesto territoriale che non fosse quello dato dalle grandi regioni “romane” descritte da Plinio e Strabone e che solo in piccola parte corrispondevano alle divisioni politiche del tempo. Anche se, proprio la Toscana o meglio l’Etruria era una delle poche che aveva mantenuto gran parte della sua antica fisionomia, come ci ricorda tra gli altri l’Italia illustrata di Flavio Biondo7.
Pure i viaggiatori di antico regime raramente nei loro diari segnalavano il passaggio delle frontiere interstatali rispetto all’ingresso in una nuova città e le carte corografiche, per lo meno fino ai tempi del Magini, nei primi decenni del Seicento, non erano solite segnare i confini fra gli stati, tanto che gli unici punti di riferimento della realtà politica coeva erano semmai dati dalle icone che rinviavano ai diversi centri urbani rappresentati nei diversi ordini di grandezza8.
Per cercare di capire come proprio nel nostro Appennino si sia andata de-finendo la percezione di una vera e propria linea di confine si sono prese in considerazione, privilegiando, come si è già detto, il punto di vista toscano, alcune tra le non molte carte tematiche che si soffermano su questa parte del crinale appenninico, prodotte soprattutto, ma non solo, dalle magistrature incaricate della tutela e della conservazione dei confini. Sono tutte dell’Ar-chivio di Stato di Firenze, salvo una conservata a Pistoia, ma anche in questo
6 Per un quadro introduttivo a queste tematiche si rimanda a L. Mannori, La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici, in Organizzazione del potere e territorio. Contributo per una lettura storica della spazialità, a cura di L. Blanco, Milano 2008, pp. 23-44.
7 Si veda E. Fasano Guarini, L’Italia descritta tra XVI e XVII secolo: termini, confini, frontiere, in Confini e frontiere nell’età moderna. Un confronto tra discipline, a cura di A. Pastore, Milano 2007, pp. 81-106; dell’opera del Biondo è in corso di pubblicazione l’edizione critica curata da Paolo Pontari da parte dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo.
8 Cfr. M. Folin, Principi e città in Italia fra Medioevo ed Età moderna: note a margine del caso ferrarese, in Aspetti e componenti dell’identità urbana in Italia e Germania (secoli XIV-XVI), a cura di G. Chittolini e P. Johanek, Bologna-Berlin 2003, pp. 25-43; per un quadro generale della cartografia storica toscana si rimanda a “Imago et descriptio Tusciae”. La Toscana nella geocartografia dal XV al XIX secolo, a cura di L. Rombai, Venezia 1993.
78
caso si tratta di una copia di un originale sempre prodotto e conservato a Firenze.
La prima mappa (tav. 1) sulla quale ci vogliamo soffermare è del 1578, la Nuova et riformata terminazione dell’Appennino delle comunità di San Marcello et di Cavinana fatta l’anno 1578 d’ordine della Magnifica Pratica segreta9. Si tratta di una pianta prospettica di notevole valore pittorico del territorio compreso tra il crinale appenninico (“confine con la Lombardia”) il fiume Reno e il torrente Verdiana. Al centro compaiono i due abitati di San Marcello e Ga-vinana, lungo il torrente Orsigna sono descritte le ferriere e il mulino della Magona, lungo il Reno un forno da ferro a Pracchia e lungo il Maresca il palazzo del signore di Piombino (Jacopo Appiani di Aragona). Oltre che agli insediamenti e alla principale via di comunicazione che attraversa il terri-torio (denominata “Via di Lombardia”), l’interesse del cartografo è attratto dalle foreste dell’area, con i castagneti da frutto (in parte destinati al pascolo: le “selve da porci castagnate”) e con i grandi squarci aperti nelle cerrete e nelle faggete dai boscaioli (le “tagliate” a capitozza) al fine di procurare il carbone necessario agli opifici industriali per la lavorazione del ferro. Qua e là si presentano pure terreni a pastura e a prato o seminativi e sono segnalate anche alcune “diacciaie” per la conservazione del ghiaccio.
Il confine che corre lungo tutta la parte alta della mappa, significativa-mente rappresentato come boscoso nel primo tratto dal fiume Reno fino a Porta Franca e poi prevalentemente a pascolo, non è certamente al centro dell’attenzione del cartografo, non solo perché la mappa era stata costruita per altre finalità, appunto la delimitazione delle zone di taglio concesse alle due comunità, ma anche perché non si aveva ancora un’idea esatta, una chia-ra percezione delle diverse entità territoriali che si fronteggiano nella zona. Si parla genericamente di “Lombardia” per indicare i paesi a nord della To-scana ed anche se si indicano con una certa esattezza le strade principali, il protagonista della carta è il bosco, descritto in modo dettagliato.
Non va tuttavia dimenticato come questa mappa sia quasi coeva ai primi provvedimenti presi dai Medici, che proprio in quel periodo stavano vincen-do la loro battaglia per fregiarsi del titolo di Granduchi a spese degli Este, per un maggiore controllo dei luoghi di confine dello stato. Nell’aprile del 1570 era stato, infatti, stabilito l’obbligo per tutte le comunità confinanti con stati esteri di effettuare annualmente una visita del confine sotto la diretta sorveglianza del rappresentante del governo centrale inviato ad amministra-re la giustizia: nel nostro caso il Capitano della Montagna, il commissario di
9 ASF, Miscellanea di piante, 614; questa mappa, per la quale manca uno studio specifico è stata più volte utilizzata a corredo di pubblicazioni sulla montagna pistoiese tra le quali anche l’inventario dell’archivio storico del comune di San Marcello Pistoiese.
79
Pistoia o il podestà di Montale10.Sono ancora le articolazioni locali ad essere investite di compiti per così
dire “statuali”; come ci ricorda Luca Mannori, almeno fino alle riforme leopol-dine quasi tutti i ‘servizi’ che il centro introdurrà all’interno del proprio spazio di governo saranno gestiti mediante vari sistemi di delega alle comunità11. Le visite si svolgono su tutto il territorio del cosiddetto stato vecchio, corrispondente grosso-modo all’attuale Toscana centro-settentrionale, ma la conservazione dei loro resoconti risente delle differenti norme che regolavano i rapporti tra le città soggette e la Dominante. Proprio il territorio pistoiese continuava ad avere particolari privilegi, che se non avevano potuto impedire l’obbligo della visita in quanto la legge esplicitamente derogava ai privilegi goduti da Pistoia, avevano di fatto determinato una scarsa trasmissione al centro dei processi verbali delle stesse. Si spiega anche così la mancanza di mappe specifiche sui confini appenninici compresi nel territorio pistoiese risalenti a prima della fine del ‘600. In quegli anni, infatti, il magistrato dei Nove, che non aveva competenza sul territorio pistoiese soggetto alla Pratica segreta, rivendica le sue prerogative in tema di confini e chiede con forza che si pro-ceda ad una ricognizione del territorio di confine compreso nella giurisdizio-ne di Pistoia12. Sulla base di queste pressioni, tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, si avviò una dettagliata ricognizione del confine, ricognizione che dette luogo a varie piante concordate tra i periti delle due parti, Giusep-pe Peraccini per la Toscana e Egidio Maria Bordoni, deputato per l’illustrissimo Senato di Bologna13.
Quella che si presenta in questa occasione è una copia del 1735 (anzi un’ulteriore copia della copia, tav. 2, richiesta nel 1783 dal vicario di Pistoia
10 Per un quadro di insieme su queste tematiche si rimanda ai lavori di Alessandro Stopani, in particolare a La memoria dei confini, in “Quaderni storici”, 118, 2005, pp. 73-96; si veda anche dello stesso autore Confini e processi di territorializzazione nell’Europa occidentale (secoli XVIII-XIX): il caso toscano, in Frontiere di terra. Frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo, a cura di E. Fasano Guarini e P. Volpini, Milano 2008, pp. 37-57.
11 L. Mannori, Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII), Milano 1994, p. 238.
12 ASF, Confini, 198, casella IX, cap. 27 secondo, “Montagna di Pistoia con Bologna”; Ibidem, 320, “Ragguaglio istorico dell’antico stato dei confini della Toscana con li Stati esteri”; sul riordinamento dell’archivio dei confini alla fine del secolo XVII e sulla conseguente opera di ricognizione si sofferma P. Volpini, Memorie e ricordi di confini e altro di Giuseppe Buonaventura del Teglia: le frontiere fra trattatistica e pratiche di cancelleria, in Frontiere di terra, pp. 58-77.
13 Ora conservate in ASF, Piante antiche dei confini, 108-110; si veda anche la descrizione per quelle di parte bolognese fornita da Paola Foschi nel già ricordato intervento al convegno di Capugnano del 2000.
80
Giovan Pietro Grisaldi Taia al perito Antonio Gamberai14), delle mappe dise-gnate tra il 1696 e il 1698 in occasione della prima terminazione concordata di cui resti traccia negli archivi, sia toscani che bolognesi. La scelta di questa copia, oltre a valorizzare una fonte dell’Archivio di stato di Pistoia, vuole te-stimoniare una delle principali caratteristiche di questa documentazione che fu quella di essere costantemente riutilizzata nel corso del tempo. In questo caso la richiesta avviene quasi un secolo dopo, in un contesto storico e poli-tico profondamente modificato, ma evidentemente era ancora più economi-co copiare un documento quasi secolare conservato negli archivi fiorentini, piuttosto che organizzare una nuova rilevazione sul campo. Vi è però un altro motivo che dà valore ai reperti più antichi: siamo infatti in presenza, sia per quanto riguarda gli originali della fine del ‘600 che per la copia del 1735, di mappe concordate e sottoscritte dai periti di ambo le parti o corroborate da un atto pubblico rogato da notai delle parti alla presenza di testimoni del posto. La mappa del 1735 era stata costruita dal perito Andrea Fabbri, incaricato dai due stati, copiando due piante fatte l’una l’anno 1696 dalli due periti dottor Giuseppe Peraccini, deputato per parte dell’altezza reale del Serenissi-mo Granduca di Toscana, ed Egidio Maria Bordoni deputato per parte dell’eccelso Senato di Bologna, e da loro sottoscritta sotto la data del 2 ottobre anno suddetto, di tutto l’andamento della confina fra gli stati di Toscana e di Bologna, incominciando dal Ponte dell’Orsigna e proseguendo sino a Porta Franca, e l’altra fatta l’anno 1698 nel mese di ottobre dalli medesimi due periti e da loro sottoscritta di tutto l’andamen-to della confina fra i due predetti stati, incominciando da Porta Franca sino alla cima del monte detto dell’Uccelliera15. Dal momento che la nuova mappa era servita per aggiornare le operazioni di accertamento del confine dei due stati, essa era stata approvata dai due commissari incaricati, Gabriello Manfredi per Bologna e Arrigo Micheli per Firenze, ed inserita nell’Instrumento sotto questo giorno [14 settembre 1735] fra i due medesimi signori Commissari stipulato e rogato in solido dalli signori dottore Giambatista Lupi, notaio fiorentino e dottore Flaminio Scarselli, notaio bolognese, in cui si ordina ancora che questa copia sia duplicata e
14 Cfr. ASP, Vicario regio, 18/I, cc. 376-395; nel settembre del 1783, Giovan Francesco Pagnini, diret-tore dell’archivio dei Confini, autorizza il vicario di Pistoia a trattare direttamente con i rappresentanti bolognesi la riapposizione di alcuni termini sul monte del Cocomero. A tal fine invia su richiesta dello stesso vicario “la pianta e l’instrumento originale del dì 14 settembre 1735 che ella crede indispensabile in questa congiuntura, confidando nella sperimentata sua diligenza che ne sarà tenuto buon conto et che verrà dopo averne fatto l’uso opportuno et averne fatta fare, se lo crede a proposito, la copia puntualmen-te rimessa a questo archivio dove è necessario che si conservi”. Il 24 settembre il vicario regio rimanda gli originali chiedendo di essere rimborsato per la spesa occorsa per la copia effettuata dal perito pistoiese Angiolo Gamberai.
15 Si cita dalla copia conservata a Pistoia che è sostanzialmente identica, anche se ridotta, a quella fiorentina (ASF, Piante antiche dei confini, 112); può essere significativo ricordare come la legenda dell’esemplare bolognese, anche esso descritto dalla Foschi, inverta l’ordine dei periti facendo precedere il bolognese Bordoni al dottor Peraccini, deputato dell’Altezza Reale del Serenissimo Granduca di Toscana.
83
che ciascheduno degl’originali di essa sia sottoscritto da amendue gli predetti signori commissari e da me perito e che a perpetua memoria uno di essi sia custodito nella cancelleria dell’illustrissimo magistrato dei Signori Nove conservatori della giuri-sdizione e dominio fiorentino e l’altro in quella dell’Eccelso Senato di Bologna16. Ora il confine è effettivamente al centro della scena, ma si continuano a segnalare anche altri oggetti che possono avere rilevanza, proprio per meglio definire l’andamento della linea confinaria che presenta ancora numerose ambiguità: così sono riportati, oltre ai vari termini riscontrati sul terreno anche i fossi e i torrenti, alcuni mulini e i principali centri abitati, da Pracchia, a Granaglione, a Biagioni, a Capanne.
Se le piante “moderne” di impianto cinque-seicentesco, continuando a soffermarsi su molti oggetti geografici, finiscono per lasciare in secondo pia-no un confine che di fatto non è ancora ben definito, nelle mappe della fine del Settecento, come aveva già sottolineato Paola Foschi, si riporta sostan-zialmente solo la linea del confine e pochi altri punti salienti per la deter-minazione dell’andamento dello stesso, proprio perché le operazioni coeve che erano state intraprese per avviare la delimitazione del territorio erano “finalmente” riuscite a determinare con una certa esattezza i contorni delle differenti compagini territoriali.
Sulla cartografia come strumento insieme di ricognizione e di legittimazione del confine si è soffermato in pagine di grande spessore critico Massimo Quai-ni17, qui si vuole solo sottolineare come tra le mappe prodotte prima degli anni Settanta del Settecento, con il loro corredo di testimoni del luogo, con l’intervento di notai e dei rappresentati dei corpi territoriali, con il rispetto di precise forme rituali e pratiche consuetudinarie18, e quelle legate alla con-finazione dello stato ci sia di mezzo una nuova costituzione territoriale nella quale il suolo non è più rivestito di alcuna sacralità giuridica, ma si present[a] come una semplice res, suscettibile di ricevere la qualificazione più opportuna in rapporto alle esigenze dei sudditi e del potere19.
Anche perché nel frattempo c’erano state in Toscana le riforme leopol-dine che, sebbene fossero falliti i tentativi pure avviati di costruire un ca-tasto geometrico-particellare, avevano comunque portato ad una migliore organizzazione non solo delle circoscrizioni amministrative e giudiziarie,
16 Anche in questo caso l’ordine di citazione dei commissari e delle cancellerie è invertito nei due esemplari ancora conservati negli archivi fiorentini e bolognesi.
17 M. Quaini, Ri/tracciare le geografie dei confini, in Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni, a cura di S. Salvatici, Soveria Mannelli 2005, pp. 187-198.
18 Per un esempio quattrocentesco riferito al confine tra Lucca e Pistoia cfr. G. Francesconi, Il «confine archiviato». Un frammento lucchese quattrocentesco del “Liber finium districtus Pistorii”, in Id., “Districtus civitatis Pistorii”. Strutture e trasformazioni del potere in un contado toscano (secoli XI-XIV), Pistoia 2007, pp. 327-345.
19 Cfr. Mannori, La nozione di territorio, p. 39.
84
ma anche di quelle ecclesiastiche: proprio il 27 agosto 1784 un breve di Pio VI aveva accresciuto la diocesi pistoiese di sette parrocchie della Montagna pistoiese già comprese nella diocesi di Bologna (Sambuca, Torri, Treppio, Fossato, Frassignoni, S. Pellegrino e Pavana), mentre altre tre erano passate a quella di Firenze (Bruscoli, Capreno e Pietramala), adeguando dopo molti secoli il confine ecclesiastico a quello politico tra il Granducato di Toscana e lo Stato della Chiesa20.
Il problema di fondo era collegato alla necessità di uniformare il territorio soprattutto per attuare quella riforma del sistema doganale che Pietro Leo-poldo considerava tra le cose più impegnative, ma anche più necessarie, del suo programma di riforme per favorire la libertà del commercio e stimolare l’economia toscana. Sin dal 1773 il granduca notava come anche all’interno del paese vi fosse un numero eccessivo di dogane che sono di grande impedi-mento al comercio (…), perché in molti luoghi per andare da una città ad un’altra con mercanzie bisogna pagare gabelle come se si andasse fuori di Stato; e le conti-nue dogane che ad ogni momento si incontrano causano una grandissima perdita di tempo colle continue visite che si fanno alle mercanzie, vessano, trattengono e non ridondano che in vantaggio delle guardie, le quali sono solite di esiggere maggiori emolumenti dei giusti, oltre la confusione che fanno nell’amministrazione”.
Il giovane granduca, che era al potere da meno di dieci anni, non sot-tovalutava i molti problemi che una riforma del sistema doganale avrebbe comportato, dato che la Toscana è un paese aperto da per tutto e che i suoi confini nelle montagne non si possono guardare; che adesso non si guadagna che poco a fare il contrabbando nel passare in Toscana con trasgredire la prima dogana, mentre a quelle si paga poco e che si trovano poi tutte le altre dogane intermedie (…), ma abo-lite che sarebbero e pagandosi tutto al confine, tornerà di conto farlo anche armata manu, perché passato una volta quel circondario di dogane liberamente e senza ga-belle, si trasporteranno per tutta la Toscana tanti e diversi generi di contrabbando21.
Una prima riforma è del 1781, una seconda del 1791 e non è un caso che nei provvedimenti normativi sulle dogane si parli espressamente di territo-rio “gabellabile o sia riunito” e della linea di confine del medesimo, territo-
20 Cfr. R. Zagnoni, Il passaggio alla Toscana di dieci parrocchie della diocesi di Bologna nel 1784, in Gente e luoghi della Sambuca Pistoiese: i settecento anni dello statuto della Sambuca, 1291-1991, Porretta Terme-Sambuca Pistoiese 1991, pp. 93-118, N. Rauty, Riordinamento delle parrocchie al tempo del vescovo Ricci, in Il territorio pistoiese nel Granducato di Toscana, Atti del convegno di studi (Pistoia, 14-15 maggio 2004), a cura di A. Cipriani, V. Torelli Vignali, C. Vivoli, Pistoia 2006, pp. 99-119; più in generale sulle riforme territoriali leopoldine si vedano i lavori di Diana Toccafondi e di Giuseppe Pansini in La Toscana dei Lorena nelle mappe dell’Archivio di stato di Praga. Memorie ed immagini di un granducato, Catalogo e mostra documentaria (Firenze, 31 maggio-31 luglio 1991), Roma 1991.
21 Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, Relazione dei dipartimenti e degli impiegati (1773), a cura di O. Gori, Firenze 2011, p. 218; per un approfondimento e per un confronto con i provvedimenti presi in altri territori asburgici si veda l’importante saggio di E. Suarer, Una contraddizione sistematica: i confini della monarchia asburgica fra Sette e Ottocento, in Confini, pp. 23-36.
85
rio gabellabile che non riguarda numerose zone di montagna, considerate appunto ancora poco sicure, ma che comprende tutta la montagna pistoiese anche perché nel frattempo era stata aperta la strada Ximenes-Giardini per collegare la Toscana ai Ducati estensi e ai territori controllati dagli austriaci22.
Commercio, viabilità e riassetto amministrativo sono alla base dei prov-vedimenti che portano alla confinazione di gran parte della Toscana con le potenze estere che negli stessi anni erano impegnate, tra difficoltà politiche e tecniche, in progetti simili: basti pensare al catasto Boncompagni che non solo fu osteggiato dalla classe dominante bolognese, ma pose non pochi pro-blemi ai periti per la misurazione dei terreni della Montagna bolognese nello Stato della Chiesa23.
Nella terza pianta che si presenta (tav. 3), la “Pianta che dimostra il con-fine fra lo stato di Toscana, mediante il vicariato di San Marcello e gli stati di Modena e Lucca”24, la linea di confine è decisamente al centro della scena. Così come accade anche nella quarta (tav. 4), la “Pianta del confine giuri-sdizionale fra lo Stato Pontificio ed il Granducato di Toscana mediante una parte della comune di Granaglione nella legazione di Bologna ed una por-zione del comune di Pracchia nel vicariato di San Marcello”, concordata tra gli ingegneri Luigi Kindt per la Toscana e Gian Giacomo Dotti, ingegnere della Deputazione Pontificia, per Bologna. Anche essa si caratterizza per l’at-tenzione specifica alla sola linea confinaria, ma nella tavola a corredo sono riportate in dettaglio le distanze dei cippi numerati e concordati, descritti negli atti di confinazione redatti dagli stessi periti ed approvati dai rispettivi uffici25. Oramai il confine non è più una linea immaginaria ed incerta, colle-
22 Sulla riforma doganale sono ancora fondamentali gli studi di V. Becagli, Un unico territorio gabellabile. La riforma doganale leopoldina. Il dibattito politico, 1767-1781, Firenze 1983; sulla strada modenese si veda P. Bellucci, Storia di una strada: i due secoli del valico dell’Abetone, Abetone 1980; più in generale, sul contesto della montagna pistoiese in quegli anni, si rimanda a F. Mineccia, Dinamiche demografiche e strutture economiche tra XIV e XVIII secolo, in Storia di Pistoia. III. Dentro lo stato fiorentino. Dalla metà del XIV alla fine del XVIII secolo, a cura di G. Pinto, Firenze 1999, pp. 170 e sgg.
23 Cfr. C. Salterini-D. Tura, Il catasto Boncompagni e la documentazione catastale bolognese tra XVIII e XIX secolo, in “In primis una petia terre”. La documentazione catastale nei territori dello Stato pontificio, Atti del convegno di studi (Perugia, 30 settembre-2 ottobre 1993), in «Archivi per la storia», VIII, 1995, pp. 257-266; sulle analoghe difficoltà per impiantare un catasto geometrico particellare in Toscana si veda A. Contini-F. Martelli, Catasti, fiscalità e lotta politica nella Toscana del XVIII secolo, in «Annali di storia di Firenze», 2007, pp. 151-183; A. Guarducci, L’ utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo: la questione dell’estimo geometrico-particellare nella seconda meta del Settecento, Borgo San Lorenzo 2009 e per un quadro generale L. Mannori, I catasti italiani del Settecento: uno spaccato istituzionale, in «Le Carte e la Storia», 2, 2010, pp. 5-16.
24 ASF, Piante moderne dei confini, 8.25 ASF, Piante moderne dei confini, 9; si veda anche la cospicua documentazione conservata sempre a
Firenze nell’Archivio dei Confini; oltre che a Bologna la documentazione sulle operazione di confinazione attivate alla fine del secolo XVIII è conservata o era conservata negli archivi delle comunità, nello specifico si vedano i documenti presenti a San Marcello per cui cfr. Inventario dell’archivio storico del comune di San Marcello Pistoiese, a cura di R. Barducci, Pisa 2000 (“Beni culturali – Provincia di Pistoia”, 19), p. 174.
87
gata a pochi riferimenti più o meno naturali, ma una vera e propria teoria ininterrotta di cippi in pietra, meticolosamente misurati e controllati, cippi che in molti casi sono ancora presenti dopo più di duecento anni.
L’ultima pianta (tav. 5) sulla quale ci soffermiamo non fa parte del mate-riale prodotto in occasione della confinazione dello stato, ma fu commissio-nata nel 1786, sempre al Kindt, dall’ufficio delle Dogane, con essa si vuole appunto sottolineare la stretta connessione che si stabilisce in quegli anni tra la confinazione dello stato e la riorganizzazione delle dogane26.
Con i provvedimenti presi negli anni ottanta del secolo XVIII dal governo leopoldino nuove regole vengono stabilite per la definizione e l’attraversa-mento dei confini; si correggono, non senza asprezze e infinite discussioni, le situazioni controverse, si permutano territori ritenuti più utili ad una delle parti e si seguono come regole di buon principio, quella del giusto confine e del reciproco abbeveraggio per gli animali nei pascoli, si concorda anche che in una fascia di cento metri dal confine non si possano, se non dopo autoriz-zazioni reciproche, costruire abitazioni, edifici rurali ed opifici industriali.
Si regolano infine gli accessi stabilendo per ogni dogana di confine quali siano le strade permesse da praticarsi dai conduttori di generi e mercanzie per giun-gere dal confine del territorio riunito alla prima dogana, descritte in un’apposita
26 ASF, Miscellanea di Piante, 75, “Pianta dimostrativa del confine del Granducato di Toscana con gli stati della Chiesa, Modena e Lucca da Treppio inclusive fino a Pietrabuona inclusive per uso delle Dogane di S. A. R.”; nella mappa non sono solo descritte le dogane attuali ma anche quelle proposte per razionalizzare il sistema lungo la linea di confine, sono pure segnalate le strade, distinte tra carrozzabili e someggiabili.
Tav. 4.
89
tabella27.Nel tratto che ci interessa e come descritto anche nelle mappe, l’unica
strada permessa per raggiungere la dogana di prima classe di Boscolungo all’Abetone è ovviamente la strada regia pistoiese; mentre quella di Cutiglia-no di seconda classe, detta la Capanna dei soldati alla Doganaccia, è raggiun-gibile dalla via della Croce all’Alpi, dalla via dell’Acqua Marcia e dalla via del Melo; quella di Lizzano (2° cl.) dalla strada maestra che viene dalla Croce dell’Alpi; quella di Pracchia (2° cl.) dalla strada maestra che viene da Mon-tauto e dal Vizzero, dalla via dell’Orsigna, dalla via di Porta Franca e dalla via di Maceglia che si divide per Pontepetri e San Marcello; quella di Ponte a Taviano (1° cl.) dalla strada maestra che viene dal Bagno della Porretta e dal-la strada che viene da Moscacchia; infine quella di Treppio dalle due strade maestre bolognesi, quella che viene da Bargi e Stagno e quella detta di Badi.
La documentazione cartografica si caratterizza per la sua tematicità, si specializza e, secondo le finalità per le quali è commissionata, enfatizza de-terminati oggetti, che possono essere la linea di confine con tutte le registra-zioni connesse, ovvero la rete delle dogane che si va in quegli anni riproget-tando, con le strade da percorrere per entrare o uscire dallo stato.
Prima di chiudere queste poche annotazioni su un tema che richiedereb-be ben altri approfondimenti, due parole sull’attualità del confine oggetto dei documenti cartografici che si sono presentati.
Quel confine che solo alla fine del secolo XVIII si stabilisce nelle sue ca-ratteristiche “moderne” di luogo di demarcazione, territoriale e simbolica, è destinato a durare meno di un secolo per trasformarsi, con il processo di unificazione nazionale, da limite politico tra stati in confine amministrativo tra province e poi tra regioni. Ma paradossalmente il confine amministrati-vo che, se si eccettua la piccola modifica provocata dall’istituzione del co-mune di Abetone nel 1936, quando una parte del territorio “modenese” di Fiumalbo viene annessa al nuovo comune della nuova provincia pistoiese28, continua ad essere ancora quello settecentesco che a sua volta segue sostan-zialmente quello medievale stabilito nel 1219, sembra, almeno a mio parere, separare molto di più che in passato i territori che ne sono delimitati.
Oggi il confine corre in gran parte lungo parchi e aree protette (dal par-co del Frignano a quello dei laghi di Suviana e Brasimone, all’area protetta dell’alto Carigiola-Monte delle Scalette); coincide per molti tratti con la GEA, la grande escursione appenninica ed ora anche con la progettata alta via dei
27 Cfr. la “Notificazione del 19 ottobre 1791” pubblicata con l’Editto del 18 ottobre in Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana…, codice XV, Firenze 1795, n. XXVI.
28 Cfr. La Toscana dal Granducato alla Regione. Atlante delle variazioni amministrative territoriali dal 1790 al 1990, Venezia 1992, pp. 86-87.
90
parchi. Ma nella prassi amministrativa di regioni e province sembra mancare quella visione di insieme presente invece nelle guide di Giovanni Bortolotti e nella preziosa opera del gruppo di studi dell’Alta valle del Reno.
La valorizzazione dal punto di vista ambientale e culturale di un territo-rio che si caratterizza proprio per la sua storia dovrebbe passare anche da un massiccio utilizzo della documentazione ed in particolare di quella prodotta proprio dalle magistrature che si sono occupate della tutela e della conserva-zione dei confini nei vari stati, come del resto aveva già segnalato proprio il Bortolotti, che definiva i vari strumenti di confinazione una inesplorata minie-ra di dati sulla geografia e toponomastica della zona29.
Qualcosa è stato fatto e si sta facendo, penso al progetto sugli antichi con-fini della Montagna pistoiese avviato alcuni anni fa dalla provincia di Pistoia o ai vari progetti di recupero della viabilità storica: proprio in questi mesi è uscita una guida promossa dall’associazione “Le Limentre” sulla via romea-nonantolana e sulla via della Sambuca30.
In genere però mancano a mio parere due cose: manca la storia, quella fatta sui documenti, sulle mappe e sulle descrizioni, troppo spesso rimpiaz-zata da improbabili rievocazioni e manca soprattutto, come si è già detto, la “trasversalità” di un approccio che non può partire da un solo versante o punto di vista, come peraltro e purtroppo è stato fatto anche in questo intervento. Proprio quel confine che non dovrebbe esserci più si ripropone troppo spesso nei vari progetti pur lodevoli e interessanti, che da un lato non sembrano fare i conti con la documentazione anche cartografica esisten-te e dall’altro con l’evidente necessità di attraversare i confini per ricomporre un’area certamente di frontiera, ma proprio per questo oggi da considerare nel suo insieme.
In questo senso gli incontri tra/montani, ma più in generale tutto il lavo-ro svolto dal Gruppo di studi, da sempre attento ai documenti e alle oppor-tunità offerte da una zona tipicamente di confine come quella dell’alta valle del Reno, possono essere di esempio e di stimolo per il lavoro da fare.
29 Il riferimento è appunto all’Istrumento di rinnovazione e stabilimento del confine, di descrizione delle linea dei termini e di rispettive convenzioni per la terza parte della confinazione fra la provincia di Bologna, Stato ecclesiastico e il Granducato di Toscana del 27 luglio 1791 citato da Giovanni Bortolotti nella bibliografia a corredo della Guida del lago Scaffaiolo e dell’alto crinale dall’Oppio all’Abetone, Bologna 1950, p. 331; oltre alle altre guide del Bortolotti, tra le quali anche quella ristampata nel 2010 dal Gruppo di studi dell’alta valle del Reno, si segnalano per l’attenzione alla documentazione storica il volume curato da Paola Foschi per il Club Alpino di Bologna dedicato al lago Scaffaiolo e la ristampa da parte del Gruppo Studi di Capotauro del Dizionario corografico di Serafino Calindri.
30 Cfr. Trekking sull’Appennino Tosco-Emiliano. Via Romea Nonantolana e Via della Sambuca, a cura di P. Balletti e S. Bonaiuti, Porretta Terme 2012.
91
Renzo Zagnoni
MONASTERI E OSPITALI DI PASSOIN APPENNINO NEL MEDIOEVO
Fra i secoli XI e XII nei territori montani compresi fra l’Emilia e la Tosca-na sorsero numerosi monasteri ed ospitali, in particolare presso i luoghi di valico del crinale spartiacque appenninico. Questo fenomeno ampiamente documentato deve essere messo in stretta relazione con una consistente pre-senza benedettina, soprattutto dei monasteri riformati legati a Vallombrosa, e con le loro tendenze riformatrici, che implicarono, anche per quanto riguar-da l’esercizio dell’ospitalità, un deciso ritorno alla regola di San Benedetto, la cui rubrica 53 recita: Tutti gli ospiti che giungono in monastero siano ricevu-ti come Cristo, poiché un giorno egli dirà: “Sono stato ospite e mi avete accolto”. Per l’accoglienza lo stesso testo prevede un vero e proprio rito, con espliciti richiami evangelici, tanto che all’arrivo dell’ospite il superiore e i monaci gli vadano incontro, manifestandogli in tutti i modi il loro amore; per prima cosa pre-ghino insieme e poi entrino in comunione con lui, scambiandosi la pace. Il rito si manifestava soprattutto nel riconoscimento del Cristo nell’ospite: adorando in loro, con il capo chino o il corpo prostrato a terra, lo stesso Cristo, che così viene accolto nella comunità. Queste prescrizioni derivano direttamente dal precetto evangelico contenuto nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo: “ero forestiero e mi avete ospitato”. Proprio per questo questa rubrica della regola benedet-tina sottolinea come in presenza dell’ospite si poteva addirittura rompere il digiuno: Se non è uno dei giorni in cui il digiuno non può essere violato, il superiore rompa pure il suo digiuno per far compagnia all’ospite, mentre i fratelli continuino a digiunare come al solito. L’ospitalità era infatti un precetto evangelico, che ovviamente prevaleva sul digiuno, che era un precetto di rango inferiore, poiché era legato alla regola monastica. Apparteneva al rito dell’accoglienza anche il versare l’acqua sulle mani degli ospiti da parte dell’abate e la lavan-da dei loro piedi da parte di tutta la comunità, rito che terminava col versetto “Abbiamo ricevuto la tua misericordia, o Dio, nel mezzo del tuo Tempio”. La regola prescrive precise norme anche per la cucina degli ospiti, che doveva essere separata da quella dei monaci per evitare distrazioni a questi ultimi. Ad essa dovevano essere destinati due monaci come per la foresteria, cioè per l’ospitale, nel quale dovevano essere tenuti dei letti forniti di tutto il neces-sario e la casa di Dio sia governata con saggezza da persone sagge.
I monasteri nati dalla riforma monastica del secolo XI ripresero anche questa fondamentale rubrica della regola ed iniziarono ad applicarla in
92
modo molto più rigoroso che per il passato. In particolare i Vallombrosani, che nella montagna tosco-bolognese ebbero molti monasteri, nelle loro co-stituzioni la richiamano ripetutamente. Ad esempio nel capitolo degli abati dell’anno 1139 stabilirono: Hospitalitatem quoque summo studio debere exhiberi firmaverunt, per quam plurimi placuerunt Deo. In quello del 1179 ribadirono che l’abate aveva l’obbligo di mangiare con gli ospiti ed in quello del 1206 che de hospitalitate vero ut omnes foretanei, et specialiter fratres nostre congregationis digno, secundum possibilitatem domus, susicipiatur honore. Infine nel capitolo degli abati del 1216 si riprende l’identificazione dell’ospite con il Cristo: in monasteriis aut eorum curiis tamquam Christus suscipiantur (Acta Capitulorum generalium Congregationis Vallis Umbrosae. I. Institutiones abbatum (1095-1310), a cura di N.R. Vasaturo, Roma 1985 (“Thesaurus Ecclesiarum Italiae”, VII, 25), pp. 18, 38, 47, 53).
Per questo motivo in tutti i monasteri di cui parleremo troviamo un edifi-cio destinato all’ospitalità di solito separato dall’edificio principale. In molti casi poi i monasteri organizzarono ed aprirono nelle loro dipendenze altre strutture ospitaliere, di solito ubicate lungo le direttrici di valico, quelle eo-rum curiae ricordate nella regola precedente.
Questo è il quadro, diciamo così teologico, in cui si inserisce l’argomento dei monasteri ed ospitali di valico lungo il crinale appenninico. Dal punto di vista storico occorre capovolgere la prospettiva delle ricerche condotte dall’angolo visuale della città e della pianura e guardare le cose dall’alto, appunto da quella linea immaginaria, non sempre segnata sulle carte ma concretissima sul terreno, che se da un lato separa i due versanti appenninici, dall’altro li unisce indissolubilmente. Li separa dal punto di vista idrografi-co, ma li unisce da tutti gli altri punti di vista: le fondazioni di nuovi mona-steri e ospitali di valico si comprendono proprio nell’ambito di questa stretta relazione fra i versanti ed anzi queste nuove fondazioni ne costituiscono uno degli elementi più rilevanti nei secoli che vanno dall’XI al XIII.
Il periodo in cui sorsero queste nuove istituzioni è compreso fra il secolo XI ed il successivo ed alle loro origini troviamo quasi sempre le direttive del-la riforma cosiddetta gregoriana dei monasteri benedettini, ma anche quella delle canoniche. Fra queste ultime ebbero uguale importanza sia quelle lega-te al vescovo, sia quelle autonome regolari, che ricominciarono anch’esse a rispettare in modo più rigoroso la regola del concilio di Aquisgrana dell’816, che regolamentava la vita comune del clero e promuoveva l’ospitalità gra-tuita.
Questo è anche il periodo del dirompente fenomeno dell’allargamento delle superfici coltivate, anche in montagna, dell’incremento demografico
93
altrettanto consistente e del sorgere di nuovi villaggi nella prospettiva di un popolamento montano enormemente più fitto che nei secoli dell’alto Medio-evo. Proprio questo fenomeno fece sì che le strade, che avevano continuato a svolgere la loro funzione anche nei primi secoli del Medioevo ma con un traffico decisamente scarso, ripresero in modo massiccio la loro funzione, assumendo un’importanza fondamentale per le nuove classi sociali cittadine che avevano nella mercatura la maggiore fonte di guadagno. Così le nuove istituzioni monastiche, che avevano anche una funzione ospitaliera, assieme a quelle più esplicitamente ospitaliere divennero strutture indispensabili per il transito lungo le strade di valico, come posti tappa e di controllo del terri-torio.
Questa loro funzione ebbe ancor più importanza se si pensa alle zone in cui sorsero: i territori prossimi al crinale spartiacque erano infatti i più im-pervi e disabitati, coperti di fitte foreste ed abitati da animali selvatici anche feroci. Basti pensare allo statuto della Sambuca Pistoiese del 1291, riformato nel 1340, che documenta l’esistenza sia di lupi, sia di orsi. Queste presenze sono confermate anche dalla toponomastica: dalla presenza di orsi deriva sicuramente anche quella silva Ursinia, che troviamo in molte carte fra XII e XIII in riferimento all’alta valle del Reno fra Pracchia e la sorgente del fiu-me, in particolare alla valle dell’affluente di destra che ancor oggi si chiama Orsigna.
Dal punto di vista politico i territori in cui sorsero i monasteri e gli ospi-tali di valico, nei secoli precedenti l’XI, come afferma lo Schneider, nell’alto Medioevo appartennero al fisco regio. In molti casi furono gli imperatori a concederli in epoche successive a signori laici o ecclesiastici, come i conti Guidi nel caso del territorio appunto della selva Orsigna o come il vescovo di Pistoia per la valle della Limentra Occidentale, confermatagli dall’imperato-re Ottone III nel 998, o come i Cadolingi per le valli fra Bisenzio, Setta e Sieve. Anche questo fatto favorì il sorgere di queste istituzioni monastiche e ospita-liere, poiché in molti casi anch’esse furono destinatarie di donazioni, spesso cospicue, da parte dei poteri superiori, che ne favorivano il consolidamento territoriale tramite la solidità patrimoniale, raggiungendo in questo modo anche lo scopo di permettere un maggiore controllo dei territori più sperduti e lontani dai centri abitati e della viabilità che per essi passava. Esempi di queste donazioni da parte di imperatori, marchesi di Toscana e conti territo-riali, sono numerosi per quasi tutte le istituzioni che prenderemo in esame.
La prevalenza del monachesimo benedettino anche in queste istituzio-ni di valico appare evidente. Tre monasteri su tre appartennero infatti a quell’ordine nella sua derivazione vallombrosana: San Pietro di Moscheta, San Salvatore della Fontana Taona e Santa Maria di Montepiano. Anche uno
94
degli ospitali di valico, quello che nella documentazione qualche volta è de-finito monastero e che si trovava presso il passo dello Stale fra Setta e Sie-ve, dipese dall’abbazia anch’essa vallombrosana di San Salvatore di Settimo presso Firenze. Uno degli ospitali, quello di San Giacomo di Val di Lamola oggi località Ospitale (Fanano), appartenne ad un’altra abbazia benedetti-na, quella di San Silvestro di Nonantola, mentre la cappella ad esso annessa dipese dal vescovo di Pistoia. Altri due ospitali, quello della Croce Bande-gliana, oggi località Prunetta, e quello dei Santi Bartolomeo e Antonino del Pratum Episcopi, oggi nella località Spedaletto, dipesero alla canonica pisto-iese di San Zeno ed in seguito anche dal comune di quella città. L’ospitale di San Bartolomeo di Rotì è documentato come dipendenza vescovile, poiché appartenne al vescovo di Pistoia, come quello garfagnino di San Pellegrino in Alpe che dipese dal vescovo di Lucca. Infine dell’ospitale di Vallechiara, nella località oggi di Cascina di Spedaletto, non conosciamo con sicurezza la dipendenza, anche se è stato ipotizzato che fosse legato all’abbazia della Fontana Taona.
Nel caso dei monasteri le strutture dell’ospitalità vennero gestite dagli stessi monaci, coadiuvati però dai numerosi conversi che abitavano in un proprio edificio annesso alle strutture monastiche. Negli ospitali decentrati rispetto alle case madri l’attività fu invece quasi sempre gestita direttamente dai conversi, una categoria di religiosi, tipica soprattutto delle congregazioni riformate, che era rappresentata da uomini e donne che donavano se stessi ed i loro beni all’istituzione promettendo di non vivere del proprio. Essi se-guivano una regola meno rigida di quella dei monaci, che non prevedeva il voto di castità: numerosi sono infatti i casi di conversioni di coppie di sposi. La presenza di conversi in queste strutture è davvero capillare e li troviamo agire a nome dell’istituzione soprattutto nelle attività economiche di gestio-ne del patrimonio e nell’esercizio dell’ospitalità gratuita.
Fra le varie realtà di cui ci stiamo occupando una in particolare mi sem-bra che spicchi fra le altre e possa essere considerata quasi un prototipo dei monasteri di crinale e di valico. Si tratta dell’abbazia di Santa Maria di Mon-tepiano, che conosciamo meglio degli altri per la notevole abbondanza della documentazione ad esso afferente e per i recenti studi storici di Sara Tondi, Ilaria Marcelli e del sottoscritto. Sorse sul valico appenninico che ne prese il nome, situato fra la valle tirrenica del Bisenzio e quella adriatica della Set-ta, proprio alle sorgenti di quest’ultimo fiume, affluente del Reno a Sasso Marconi, nella località che nei primi secoli della sua esistenza fu detta Caput Sittule, cioè Capo di Setta. Fu fondato, come la maggior parte di queste istitu-zioni, nel penultimo decennio del secolo XI, come frutto del ritiro su queste isolate montagne di un pio uomo, il beato Pietro, che, pur avendo intenzione
95
di condurre vita eremitica come molti altri fondatori di monasteri, raccolse attorno a sé un gruppo di seguaci e costruì la prima chiesetta e il primo ri-fugio per i suoi monaci, che si costituirono così in cenobio autonomo. Ben presto però lo stesso priore aderì alla riforma benedettina di Vallombrosa e ben presto i signori di questo territorio, prima i conti Cadolingi di Pistoia ed alla loro estinzione in linea diretta maschile all’inizio del secolo XII i conti Alberti di Prato, accolsero la nuova istituzione sotto la loro protezione, con-solidandola da punto di vista patrimoniale per mezzo di ampie donazioni. I primi negli anni 1088 e 1096 donarono all’abbazia vasti possessi posti attorno al primitivo nucleo. La seconda di queste donazioni riguardò in particolare entrambi i versanti dell’Appennino, dalla valle del Bisenzio a quella della Li-mentra Orientale, sottolineando ancor di più la valenza di questa istituzione come elemento di collegamento fra il nord e il sud dell’Appennino. In questo modo l’abbazia divenne centro di diffusione della riforma anche nel versante bolognese e punto importantissimo di controllo del valico lungo la strada che percorreva le valli della Setta e del Bisenzio. L’importanza di questa di-rettrice di valico è confermata dal fatto che a poca distanza da Montepiano sorsero ben tre monasteri benedettini, due dei quali ancora vallombrosani, Santa Maria di Opleta nei pressi di Castiglione dei Pepoli in val di Setta, e San Salvatore di Vaiano in val di Bisenzio, oltre a San Biagio del Voglio dipendente alle origini dall’abbazia di Leno nel Bresciano ed in seguito da Santo Stefano di Bologna.
Tutte le istituzioni sia monastiche sia ospitaliere che elencherò, fra la fine del secolo XIII e soprattutto nel Trecento subirono le conseguenze della gra-vissima crisi economica e demografica che colpì pesantemente anche questa parte dell’Appennino Tosco-emiliano. Basti pensare alla completa scompar-sa della maggior parte di esse, col correlato crollo sia delle strutture mona-stiche, sia di quelle per l’ospitalità sia delle chiese annesse. Scomparvero del tutto gli ospitali dello Stale, di San Giacomo di Val di Lamola, di Rotì, di Vallechiara presso la Cascina di Spedaletto e della Croce Bandegliana. Di altri rimasero poche strutture destinate ad altri usi, come nel caso del Pratum Episcopi, che venne annesso alla Pia Casa di Sapienza ed in età Moderna servì da chiesa parrocchiale per la popolazione del paese di Spedaletto, che nel to-ponimo conserva la traccia della sua antica vocazione. Diversa la sorte di San Pellegrino in Alpe, che cambiò del tutto l’antica vocazione ospitaliera, dive-nendo centro devozionale del culto di San Pellegrino, al quale nel secolo XV venne aggiunto anche San Bianco. Anche le vere e proprie abbazie vennero abbandonate dai pochi monaci superstiti, ancora presenti fra Due e Trecento. Alcuni di essi si trasferirono nelle case che i monasteri nei secoli precedenti avevano acquisito all’interno delle città. Significativa la lettura della visita
96
pastorale della fine del secolo XIV dell’abate di Vallombrosa ai monasteri da lui dipendenti. Egli descrisse la Fontana Taona come omnimodo destructum et inhabitabile (…) propter guerras ita quod nulla habitatio sit ibi nisi solum corpus ecclesie. Per questo motivo lo stesso abate necessitate compulsus cogit habitare in domibus dicti monasterii positis in civitate Pistorii. Egli vide poi a Pistoia nel monastero di Forcole Stefano del fu Baronto, abate della Fontana Taona, che lo informò che anche l’ospitale dipendente di San Michele della Corte del Reno, ubicato in territorio bolognese lungo il Reno fra Silla e Marano, era inhabitatum propter guerras e non si trovava chi lo volesse abitare e gestire. Questo abate Stefano risultò piuttosto indisciplinato, tanto che l’abate visi-tatore annotò che egli risiedeva in quadam domo dicti monasterii tamquam me-rum laycum conversantem in conspectu laycorum et mulierum. Per questo prese alcuni provvedimenti per evitare che questa condotta redundare in vituperium ordinis et in non parum periculum dicti abbatis. Per questo pro bono statu dicti mo-nasterii e pro salute anime ipsius abbatis ac pro honore Dei et ordinis Vallembrose, gli ordinò di lasciare la sua attuale residenza e di stabilirsi entro otto mesi in qualche monastero o priorato dell’ordine di Vallombrosa, pena la scomuni-ca. La situazione di questo monastero risulta emblematica di quella di tutti gli altri (Liber visitationum ordinis Vallisumbrosae ab anno 1372 usque ad annum 1402, in Biblioteca Nazionale Firenze, ms. II.I.136, c. 60r).
Descriverò sommariamente solamente i monasteri e gli ospitali di valico di questo tratto di crinale, non toccando neppure di sfuggita le numerosissi-me analoghe istituzioni monastiche ed ospitaliere che potremmo definire di valle, poiché sorsero lungo le valli appenniniche, anche come supporto alle strade di penetrazione verso il crinale. Il loro consistentissimo numero non ci permetterebbe infatti di concentrare l’attenzione sulle istituzioni di valico, che ebbero caratteristiche per certi aspetti analoghe e per altri decisamente divergenti da quelle di valle.
Il punto di partenza della nostra carrellata è il territorio della Romagna Toscana compresa fra la valle del Santerno e quella della Sieve, dalla quale proseguiremo verso ovest per arrivare al tratto di crinale compreso fra la Garfagnana e l’Appennino modenese e reggiano.
97
Abbazia vallombrosana di San Pietro di MoschetaLungo il tratto di crinale preso in esame per prima troviamo l’abbazia
benedettina vallombrosana di Santa Maria di Moscheta, ubicata nella valle del Santerno, a poca distanza dal passo del Giogo di Scarperia da cui passa la strada Scarperia-Firenzuola, che la collega alla valle meridionale della Sieve, il Mugello.
Fu una della abbazie fondate personalmente da San Giovanni Gualberto a metà del secolo XI e per questo fu vallombrosana dalle sue origini. Se ne parla infatti nella vita del Santo, dove si ricorda sia il primo abate Rodol-fo, sia vari avvenimenti ritenuti miracolosi, tutti legati alle tendenze troppo mondane di quei monaci, represse dal fondatore per mezzo di un’inondazio-ne e di un incendio.Bibliografia:- R. Angelini, La “Vita Sancti Iohannis Gualberti” di Andrea da Genova (BHL 4402), Firenze 2011, pp. 58, 65, 85-90.- S. Casini, S. Giov. Gualberto e la Badia di Moscheta, in Id., Dizionario biografico geografico storico del Comune di Firenzuola, Firenze 1914, vol. II, pp. 65-93.
Ospitale di San Salvatore allo StaleLa seconda istituzione, l’ospitale di San Salvatore allo Stale, si trovava
nella valle settentrionale del Gambellato affluente di destra della Setta, a poca distanza dal crinale che la separa da quella meridionale della Sieve e dai passi della Futa e dello Stale, il cui toponimo, ancor oggi esistente, deriva dall’ospitale medievale.
Dipese dall’abbazia vallombrosana di San Salvatore a Settimo presso Fi-renze. Il primo documento che ce ne parla risale all’anno 1048, quando il conte Guglielmo dei Cadolingi donò all’abbazia fiorentina l’oratorio nella località Gullano detto Ospitale, sicuramente al fine di stabilire in esso la regola benedettina seguita da quel monastero riformato. In altri documenti è defini-to anche di Valle Bona. Dal 1236 dipese dai cistercensi.Bibliografia:- M. Abatantuono, Il monastero e l’alpe dello Stale vicende religiose e politiche (secoli XI-XVIII), in “Nuèter”, XXVIII, 2012, n. 55 (“Nuèter-ricerche”, n.22), pp 161-192.
98
Abbazia vallombrosana di Santa Maria di MontepianoDi questa abbazia abbiamo già in precedenza parlato, presentandola come il prototipo delle istituzioni di valico in questa zona.Bibliografia:- Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano (1000-1200), a cura di R. Piattoli, Roma 1942 (“Regesta Chartarum Italiae”, 30).- S. Tondi, L’abbazia di Montepiano dalle origini alla metà del secolo XIII, Vernio 2001.- R. Zagnoni, Monasteri toscani e montagna bolognese (secoli XI-XIII), in Il Medioevo nella montagna tosco-bolognese, uomini e strutture in una terra di confine, Porretta Terme 2004, pp. 231-257, alle pp. 250-255.- I. Marcellli, I documenti del monastero di Montepiano (1250-1332). Uno spaccato di storia dell’Ap-pennino nel Medioevo, Porretta Terme 2012 (“Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana”, n.s. 1).
Ospitale di San Bartolomeo di RotìIl piccolo e quasi sconosciuto ospitale di San Bartolomeo di Rotì sorse
nell’alta valle della Carigiola, affluente di sinistra del Bisenzio, a poca di-stanza dal passo di crinale che oggi è detto del Tabernacolo di Gavigno, che separa quella valle meridionale da quella adriatica della Limentra Orientale ed è attraversato dalla strada da Fossato a Luicciana.
Viene citato per la prima volta nel 1105 quando papa Paquale II, nel con-fermare i possessi del vescovo di Pistoia, ricordò anche la cappella de Rotie. È ancora ricordato nelle decime del secolo XIII come appartenente alla diocesi pistoiese.Bibliografia:- Regesta Chartarum Pistoriensium. Vescovado. Secoli XI e XII, a cura di N. Rauty, Pistoia 1974 (“Fonti storiche pistoiesi”, 3), documento del 1105 novembre 14, n. 14, pp. 14-16.- Accenni in R. Fantappiè, Nascita d’una terra di nome Prato. Secoli VI-XII, in Storia di Prato, I, fino al secolo XIV, Prato 1981, p. 352 e in N. Rauty, Storia di Pistoia. I. Dall’alto Medioevo all’età precomunale 406-1105, Firenze 1988, p. 370.
Ospitale di Vallechiara, oggi località Cascina di SpedalettoL’ospitale di Vallechiara, oggi località Cascina di Spedaletto (anche in
questo caso il toponimo deriva dall’antico ospitale), si trovava alla testata di valle della Limentra Orientale a pochissima distanza dal passo omonimo, che la separa da quella meridionale dell’Agna, dal quale transita la strada che da Montale-Montemurlo conduce verso Treppio, Torri e Fossato.
Non si conosce la sua dipendenza, anche se qualcuno ha ipotizzato che fosse stato fondato dalla non lontana abbazia della Fontana Taona. Scarsa è
99
la documentazione che ce ne parla. In particolare il testamento di un crociato pistoiese degli anni 1219-1220 testimonia della donazione di 20 soldi hospitali de Valle Clare, un toponimo ancor oggi vivo in una sorgente che si trova a poca distante dal passo. Nel Liber finium è detto hospitale de Cavinis. Bibliografia:- M. Bruschi, Un altro “Pratum Episcopi” sulla montagna pistoiese, in “Pistoiaprogramma”, XXVIII, luglio-dicembre 1996, n. 35-36, pp. 31-34 a p. 31.- N. Rauty, Il testamento di un crociato pistoiese (1219-1220), in BSP, LXXXII, 1980, pp. 15-51, a p. 51.
Abbazia vallombrosana di San Salvatore della Fontana TaonaL’importante abbazia di San Salvatore della Fontana Taona si trovava
anch’essa a poca distanza dal crinale e vicinissima alle scaturigini delle tre Limentre (Orientale, Occidentale e Limentrella), fra queste e la valle meridio-nale della Bure, attraversato dalla direttrice che da Pistoia si conduce all’at-tuale Riola.
È controversa l’obbedienza alle sue origini all’inizio del secolo XI, ma siamo sicuri che nella seconda metà dello stesso divenne vallombrosana. Fu fatta oggetto di ampie e numerose donazioni da parte del potere politico, dal marchese Bonifacio negli anni 1004-1005, all’imperatore Enrico II che nel 1014 lo prese sub nostri mundiburdii tuitionem, ed ancora agli imperatori Corrado II nel 1026 ed Enrico III nel 1040. Nel 1082 il vescovo Lamberto di Bologna donò al monastero le decime del vico di Casio. Ebbe vastissimi possessi, il primo dei quali fu donato al monastero dal marchese Bonifacio (II) di Toscana nel primo decenni del secolo XI. Molti beni furono localizzati anche nel versante settentrionale dell’Appennino, in particolare l’importan-tissimo ospitale della Corte del Reno o di Bombiana, fatto oggetto nel 1098 di donazioni dalla marchesa Matilde, mentre nel 1118 l’imperatore Enrico V emise il banno in suo favore. L’abbazia ebbe giurisdizione anche sul ponte di Savignano, posto nei pressi dello sbocco della Limentra Orientale nel fiume Reno e dal 1175 anche sull’ospitale di Sant’Ilario di Badi, posto nella parte mediana della stessa valle.Bibliografia:- L. Chiappelli, Per la storia della viabilità nell’alto Medioevo. II. La Badia Taona, in BSP, XXIX, 1927, pp. 1-14.- Regesta Chartarum Pistoriensium. Monastero di San Salvatore a Fontana Taona. Secoli XI e XII, a cura di V. Torelli Vignali, Pistoia 1999 (“Fonti storiche pistoiesi”, 15).- R. Zagnoni, Monasteri toscani e montagna bolognese, pp. 238-243.- Regesta Chartarum Pistoriensium. Monastero di San Salvatore a Fontana Taona. Secolo XIII, a cura di A. Petrucciani e I. Giacomelli, Pistoia 2009 (“Fonti storiche pistoiesi”, 18).
100
Ospitale dei Santi Bartolomeo e Antonino del Pratum EpiscopiL’ospitale dei Santi Bartolomeo e Antonino del Pratum Episcopi si trova-
va nella valle settentrionale della Limentra Occidentale, a poca distanza dal passo del crinale spartiacque detto della Collina, che la separa da quella me-ridionale dell’Ombrone Pistoiese. Il valico era attraversato dalla principale strada di collegamento fra Pistoia e Bologna, che a metà del Duecento era detta Francesca della Sambuca per il tratto pistoiese e maestra di Saragozza per quello bolognese.
Fu fondato, assieme ad altri quattro ospitali, direttamente dalla cano-nica pistoiese di San Zeno, che fu anch’essa riformata alla metà del secolo XI. Il primo documento che ne attesti l’esistenza è dell’anno 1090, quando papa Urbano II assegnò una parte dei redditi della canonica stessa ai cin-que ospitali da essa dipendenti. Ebbe moltissimi possessi nel versante nord, fra i quali un ospitale a Casio, passato all’inizio del Trecento all’abbazia di Montepiano, ed anche attorno alla città di Bologna, dove gestì l’ospitale de Runcore, ubicato nella zona del suburbio nord. Un documento della metà del Duecento attesta che i fratelli curavano la manutenzione del ponte magnum sul Reno, che probabilmente si trovava nella zona dell’odierno Ponte della Venturina, oltre che degli altri ponti minori e di tutta la strada. Negli statuti del comune di Pistoia troviamo provvedimenti per questo ospitale, volti a renderne sicuro l’accesso ed il transito lungo la direttrice di valico. Bibliografia:- L. Chiappelli, Per la storia della viabilità nell’alto Medioevo. I. L’ospizio del “Pratum Episcopi”, in BSP, XXVIII, 1926, pp. 85-100.- R. Zagnoni, Monasteri toscani e montagna bolognese, pp. 244-247.
Ospitale della Croce Brandegliana, oggi PrunettaL’ospitale della Croce Brandegliana si trovava a poca distanza dall’odier-
na località di Prunetta, che rappresenta uno dei valichi fra le valli della Lima e del Reno, a pochissima distanza dalle sorgenti di quest’ultimo fiume, attra-versato dalla strada che risaliva da Pistoia e si dirigeva verso il passo della Croce Arcana e di qui verso Modena e Nonantola.
Fu fondato anch’esso dalla canonica pistoiese di San Zeno ed i primi do-cumenti che ne attestano l’esistenza sono compresi fra il 1085 ed il 1090. Da essi risulta la sua dipendenza dalla canonica, che mano a mano ne perdette però il controllo a favore del comune di Pistoia che si sostituì ad essa nella gestione. Per questo l’ospitale viene ripetutamente citato negli statuti fra i se-coli XII e XIII. A causa della decadenza, manifestatasi per la maggior parte di queste istituzioni fra XIII e XIV secolo, il Comune di Pistoia nel 1347 ordinò
101
la ricostruzione del campanile a fini difensivi, emanando precisi provvedi-menti per la sua custodia e per la sicurezza della strada che lo collegava alla città ed al versante nord dell’Appennino. Ma pochi anni dopo dell’ospitalità si perdono del tutto le tracce.Bibliografia:- R. Zagnoni, L’ospitale della Croce Brandegliana nel Medioevo: dalla canonica di San Zeno al Comu-ne di Pistoia, in BSP, CX, 2008, pp. 43-86.
Ospitale di San Giacomo di Val di Lamola, oggi OspitaleProseguendo verso occidente occorre rilevare che, dopo i passi della Col-
lina, delle Piastre e dell’Oppio, che si mantengono a quote piuttosto basse comprese fra 800 e 900 metri sul livello del mare, il crinale improvvisamente si impenna verso i 1600-2000 metri, a cominciare dalla zona dell’Uccellie-ra e del Corno alle Scale e proseguendo verso occidente attraverso il Libro Aperto, l’Alpe delle Tre Potenze, il Rondinaio ed il Giovo. Questa situazione orografica è la causa per cui in questa zona le istituzioni ospitaliere di valico si rarefanno, mentre quelle monastiche scompaiono del tutto.
Il primo ed unico ospitale che si incontra in queste terre alte è quello che nel Medioevo era detto di San Giacomo di Val di Lamola, ubicato nella valle modenese dell’Ospitale a pochi chilometri dal passo di crinale detto della Croce Arcana, che la separa da quella meridionale della Lima, attraversato dal principale itinerario da Pistoia a Modena. Anche in questo caso il toponi-mo Ospitale, riferito oggi sia al torrente che concorre a formare il Panaro, sia al paese, è la traccia dell’antica struttura ospitaliera.
Poiché l’autore della Vita Anselmi ricorda come il santo prima di fondare il suo più importante monastero di Nonantola ne costruì uno a Fanano, che era uno dei territori donatigli a metà del secolo VIII dal cognato Anselmo re dei Longobardi, è stato ipotizzato che tale monastero fosse lo stesso che trovere-mo nella località Ospitale nei secoli del basso Medioevo. Di questo monastero, se si esclude una citazione dell’898, non si parla più, fino a quando, all’inizio del secolo XIII, compare l’ospitale di Val di Lamola. Questo fatto mi spinge ad ipotizzare che quest’ultimo non fosse lo stesso monastero fondato da An-selmo a Fanano, ma una nuova fondazione ospitaliera, sorta ugualmente alle dipendenze di Nonantola, ma in epoca molto più tarda, nello stesso periodo in cui era stata costruita la maggior parte delle istituzioni analoghe. La cap-pella dell’ospitale è confermata al vescovo di Pistoia una prima volta nel 1218 ed una seconda dall’imperatore Ottone IV nel 1210. Nel 1225 presso l’ospitale venne sottoscritto un trattato stradale fra i comuni di Modena e Pistoia.Bibliografia:- N. Pedrocchi, Storia di Fanano, a cura di A. Sorbelli, Fanano 1927, pp. 59-73.
102
Ospitale di San Pellegrino in AlpeL’ultimo degli ospitali che prendo in esame è quello di San Pellegrino
in Alpe che si trova nell’alta Garfagnana, quindi nella valle del Serchio, a pochissima distanza dai valichi del crinale, fra i quali quello che oggi è detto delle Radici. A monte delle strutture ospitaliere si trova l’Alpe di San Pelle-grino, anch’essa ubicata sul crinale, ed a nord di essa, nel versante setten-trionale, le valli del Perticara, che concorre a formare il Panaro, e del Dolo, affluente della Secchia. Da qui transitava la strada di collegamento fra Lucca e Modena e Reggio.
Anche in questo caso i primi documenti che ce ne parlano sono riferibili ad un momento compreso fra XI e XII secolo. La prima attestazione, del 1110, ci presenta una donazione alla chiesa ed all’ospitale, che si trovavano nella località definita terme Saloni. Anche San Pellegrino venne presto sottoposto la protezione imperiale; ciò avvenne nel 1187 da parte di Enrico VI. Dalla do-cumentazione risulta che fosse un’istituzione autonoma e perciò non dipen-dente, come molti altri ospitali, da un monastero, ma solamente dal vescovo di Lucca. Ci limitiamo a queste poche annotazioni poiché questo ospitale è oggetto di uno specifico intervento di Elena Vannucchi in questo stesso convegno.Bibliografia:- L. Angelini, Storia di San Pellegrino dell’Alpe, Lucca, tre edizioni dal 1979 al 1996.- G.P. Borghi-R. Zagnoni, Pellegrinaggi tradizionali dal Bolognese al santuario di San Pellegrino dell’Alpe. Aspetti etnoantropolo gici, in La Garfagnana. Storia, arte, cultura, Atti del Convegno (Ca-stelnuovo Garfagnana, 12-13 settembre 1992), Modena 1992, pp. 265-290 (“Biblioteca” della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi, n.s., 127).- E. Vannucchi, Un crinale per un santo: San Pellegrino dell’Alpe fra Modena e la Garfagnana, in questo volume.
103
Giulio Orazio Bravi
LA GUIDA PER VIAGGIATORI DE REGIMINE ITER AGENTIUM DI GUGLIELMO GRATAROLI DEL 1561
Guglielmo Grataroli1 nasce a Bergamo il 16 maggio 1516. Discende da
una famiglia che nel Quattrocento si è trasferita in Città dall’originaria Valle Brembana, e precisamente dalla contrada di Oneta in San Giovanni Bianco2. Il padre, Pellegrino, dottore in medicina, muore di peste nel 1528. Compiuti i primi studi a Bergamo, iscrittosi all’Università di Padova nel 1531, Gugliel-mo si laurea in Arti e Medicina il 10 maggio 1539 e il 26 giugno dello stesso anno è aggregato al Collegio dei medici fisici di Bergamo3, di cui diverrà Priore nel 1547, a soli 31 anni. Una carriera precoce e brillante.
Sia per motivi professionali sia per desiderio di apprendere Grataroli ama viaggiare, leggere, osservare la natura e gli uomini con il rigoroso me-todo razionale appreso all’Università patavina. Si interessa anche alle nuove idee teologiche delle chiese riformate d’Oltralpe, e ne apprezza, oltre alla condivisa critica di pratiche religiose ritenute contrarie allo spirito evange-lico, il possibile accordo con il suo metodo di ricerca scientifica. Mentre ai primi del 1544 si trova a Milano, è accusato di sostenere pubblicamente le dottrine di Zwingli e Calvino. Il 4 febbraio pronuncia l’abiura di fronte all’in-quisitore Melchiorre Crivelli4. Ritornato a Bergamo, perseverando nelle sue opinioni eterodosse, viene nuovamente aperto contro di lui nel 1550 un pro-cedimento inquisitoriale. Lo si accusa di aver “molto straparlato dele cose pertinenti a la fede et di essa fede et de la potestà del papa”, nonché di aver negato il purgatorio, le indulgenze, i suffragi per i defunti, la venerazione dei
1 A. Pastore, Grataroli (Gratarolo) Guglielmo, voce nel Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 58, Roma 2002; G. Gallizioli, Della vita, degli studi e degli scritti di Gulielmo Grataroli filosofo e medico, in Bergamo, Dalla Stamperia Locatelli, 1788, consultabile in Rete: Google Books.
2 T. Salvetti, San Giovanni Bianco e le sue contrade, Clusone 1993; a p. 84 albero genealogico della fami-glia Grataroli: capostipite Giacomo, creato cittadino di Bergamo nel 1474; alle pp. 85-89 notizie biografi-che su Guglielmo Grataroli, ricavate dalla consultazione di atti notarili dell’Archivio di Stato di Bergamo: la moglie si chiama Barbara de Nicolis (o Nicosis ?) e ha recato in dote la somma considerevole di 880 scudi; Guglielmo ha acquistato in Bergamo il 17 marzo 1545 da Bernardo Lazerono (atto rogato dal notaio Girolamo Della Valle) una casa con corte, forno, orto, campi e vite, nella Vicinia di S. Lorenzo, nei pressi del ponte sulla Morla; possiede la terza parte di una casa con terreni in Verdellino, che il padre Pellegrino ha lasciato in eredità ai figli.
3 Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, Acta Collegii medicorum, ms., sec. XVI, AB 391, c. 42. Grataroli scompare dall’elenco dei medici collegiati nel 1542; ricompare nel settembre 1546; nel 1547 (c. 60v) è eletto Priore del Collegio.
4 Sulla Riforma in Italia: S. Caponetto, La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, Torino 1992. Sul caso Grataroli una lunga nota in M. Firpo-S. Pagano, I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo (1550-1580), 2 tomi, Città del Vaticano t. 1, p. 60, nota 17.
104
santi, la presenza del corpo di Cristo nell’eucarestia5. Raggiunto dall’ordine di presentarsi ai giudici ecclesiastici, Grataroli si rifugia a Tirano in Valtellina, territorio di dominio grigionese, dove è possibile vivere in libertà la propria fede6. Il 23 gennaio 1551 il vescovo di Bergamo Vittore Soranzo e l’inquisitore Domenico Adelasio pronunciano la sentenza in contumacia, che dichiara il medico bergamasco eretico “pertinace et relapso”, ne ordina la confisca del patrimonio e la consegna al braccio secolare. La ratifica della sentenza da parte veneziana, datata 4 luglio 1551, indica come pena la decapitazione e il rogo del corpo. Alla moglie Barbara de Nicolis, che ha scelto di condividere la sorte del marito, seguendolo nell’esilio, viene confiscata la dote di 880 scu-di7.
Ritrovatosi a Tirano con altri esuli bergamaschi per fede, Cristino del Bot-to di Ardesio e il prete Pietro Parisotto di Bergamo, Grataroli si impegna per qualche tempo nell’invio in Italia di libri eterodossi e nella propaganda delle dottrine riformate8. Ma dopo il 1547, con la sconfitta dei Protestanti a Mühlberg e la conseguente decisione politica di Venezia di schierarsi con il vincitore, la speranza che le cose possano cambiare in Italia è ingenua e vana. Tra il 1551 e il 1552 Grataroli si trasferisce a Basilea, città colta, aperta, dove è ancora vivo lo spirito erasmiano. Immatricolatosi all’Università, nel 1558 viene accolto nel Consiglio della Facoltà di medicina, della quale è nominato Decano nel 1566. Ripartito dal nulla, dopo che tutti i beni gli erano stati con-fiscati, senza conoscenze, in un ambiente del tutto nuovo per lingua, costumi e tradizioni, riesce con intelligenza e molto lavoro a rifarsi una dignitosa e onorata carriera. Per circa un anno, nel 1562, insegna anche nell’Università di Marburgo, nell’Assia.
Muore di tifo epidemico a Basilea il 16 aprile 1568, a 52 anni.A Basilea, oltre a svolgere la professione di medico e di docente all’Uni-
versità, Grataroli si dedica ad una intensa attività pubblicistica9. Gli argo-menti trattati, affidati a libri di modesto formato, con testi brevi tutti editi in latino, sono vari: si va dalla previsione di eventi naturali stabilita sulla osser-vazione della natura e delle congiunzioni astrali, ai rimedi utili a recuperare
5 ASV, S. Uffizio, busta 10, fascicolo Gratarolo. Sulle prime manifestazioni ereticali a Bergamo nel Cinquecento cfr. G.O. Bravi, Note e documenti per la storia della Riforma a Bergamo (1536-1544), in «Archivio storico bergamasco», n. 11, 1986, pp. 185-228.
6 Riforma e società nei Grigioni, Valtellina e Valchiavenna, a cura di Alessandro Pastore, Milano 1991.7 Sulle vicende legate al riscatto della dote da parte dei parenti di Grataroli cfr. Salvetti, San Giovanni
Bianco, p. 88.8 Bergamo, Archivio storico diocesano, Processi per eresia e superstizione, ms., sec. XVI, c. 56r. Volume
descritto da Bravi, Note e documenti, p. 187.9 Il più valido approccio al pensiero medico-scientifico di Grataroli resta sempre L. Thorndike, A
History og magic and experimental Science, 8 voll., New York 1941, vol. 5, pp. 600-616. Questo autore si sof-ferma anche sull’opera De regimine iter agentium del 1561.
105
e a conservare la memoria; dalle virtù terapeutiche delle acque termali, alla disamina dei caratteri fisiognomici delle persone come indizio per conoscer-ne l’indole morale, anticipando su questo tema Giovanni Battista Della Porta (1535-1615); dalla descrizione eziologica della peste e dai mezzi per contra-starla, ai consigli dati alle persone di studio per mantenersi in buona salute (massimamente giovevole per loro l’esercizio fisico); dagli elogi per la vita di campagna contrapposta alla vita cittadina, all’uso moderato del vino.
Nelle sue pubblicazioni Grataroli è costantemente mosso dalla volontà di ricondurre le cose naturali ed umane, mediante l’osservazione e l’analisi, a leggi stabili, capaci di prevedere, ricorrendo anche all’astrologia, gli ac-cadimenti futuri, sottraendoli in tal modo, per quanto è possibile, alle false opinioni, al caso, all’incertezza, che generano ansie e timori. Questa tenden-za di Grataroli, che è propria di ogni mente scientifica, non resta confinata nel campo dell’astrazione, ma persegue un riscontro pratico sul terreno del benessere psicofisico della persona, pur sempre concepito sulla base del si-stema anatomo-fisiologico della medicina antica, per la quale è essenziale la dottrina dell’equilibrio dei quattro umori e del loro temperamento10. Pierre Bayle (1647-1706), nel Dictionnaire del 1697, elogia l’attività editoriale di Gra-taroli, che mira, scrive, al bien public, al benessere pubblico11.
Tra le opere di pubblica utilità composte da Grataroli spicca per origina-lità e fama il De regimine iter agentium del 1561, riedito nel 1563, 1571, 159112: una guida per quanti si mettono in viaggio, sia che vadano a piedi, a cavallo, in carrozza, per nave.
Nella lettera dedicatoria a Egenolph III von Rappolstein (1527-1585), l’au-
10 Sulle antiche concezioni mediche chiara, essenziale, con rimandi alle fonti e alla bibliografia più aggiornata, l’esposizione di G. Silini, Umori e farmaci. Terapia medica tardo-medievale. With an estended summary in english, Gorle 2001, in particolare il cap. V, la dottrina medica.
11 P. Bayle, Dictionnaire historique et critique, A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1697, T. I, Parte seconda, p. 1284, alla nota (D), traduco dal francese: “non si può rifiutargli l’elogio di aver avuto a cuore il bene pubblico, avendo egli cercato rimedi che non solo giovano ai magistrati, ma anche a ogni sorta di viaggiatore”. Ha dato consigli pratici agli uomini di studio, come mantenersi in buona salute e come conservare la memoria, per questo “merita gli onori divini nella Repubblica delle Lettere”. Nel primo discorso tenuto nel 1562 all’Università di Marburgo, dal titolo Laudes medicinae ut ad eam addiscendam iuvenes animentur, pubblicato con altri saggi a Strasburgo [s.n.] nel 1563, alle pp. 8-26, Grataroli scrive, p. 17: “vanae enim sunt quaestiones logicae in arte, quae non manuducunt nos ad finem verum, nimirum ad sanitatem”, e a p. 23: “cum mea studia omnia publicae utilitati, quantum in me est, semper dicarim”.
12 G. Grataroli, De regimine iter agentium vel equitum, vel peditum, vel navi, vel curru seu rheda etc., viatoribus et peregrinantibus quibusque utilissimi libri duo, Basileae, [Nicolaus Brylinger], 1561, pp. [14], 152, [2], 1c. di tav. ripieg, 8°. M.L. De Nicolò ha curato una “libera traduzione” (p. 5) italiana dell’edizione di Strasburgo del 1563: Homo viator. La medicina del viaggio nel Rinascimento, Roma 1999; Ringrazio la prof.ssa Angela Donati dell’Università di Bologna per avermi segnalato questa pubblicazione.
Per l’inquadramento generale sul tema del viaggio e dei viaggiatori nel Cinquecento A. Maczak, Viaggi e viaggiatori nell’Europa moderna, Roma-Bari 2000 (Ediz. orig. Varsavia 1978) scrive dell’opera di Grataroli alle pp. 162-164. Dei titoli che ho consultato per questa ricerca, è il più completo di dati e di informazioni, con ampia presentazione, analisi e discussione delle fonti.
106
tore afferma, con un certo orgoglio, che il suo testo è il primo in lingua latina ad affrontare il tema nella sua complessità e con la dovuta organicità, pur con la semplicità e la brevità che si richiedono a una guida. Scrive di aver vo-luto dare forma unitaria a testi di autori che, in modo sporadico e frammen-tario, hanno già trattato l’argomento, anche se quasi sempre dal solo punto di vista dietetico: Ippocrate di Coo (460 a.C. circa-prima del 377), Galeno di Pergamo (129-216), Avicenna (980-1037, filosofo e medico, dalla cui opera, Libri canonis quinque, Grataroli ha tratto sicuramente il titolo De regimine iter agentium, che compare nel testo di Avicenna al Lib. I, Fen. 3, Doctrina 5, cap. 2)13, Paolo Egineta (medico del VII sec.), Alban Thorer (1489-1550, medico docente all’Università di Basilea), Girolamo Cardano (1501-1576, matemati-co, astrologo e medico). Dichiara anche il debito contratto con l’opuscolo in tedesco pubblicato a Strasburgo nel 1557 dal medico Georg Pictorius (Georg Maler 1500ca.-1569)14. Ma la fonte principale, come ricorda Grataroli in vari passaggi dell’opera, è la sua lunga esperienza di viaggiatore a piedi e a ca-vallo.
Il testo, per essere compreso secondo le intenzioni dell’autore e la cultura dei lettori del XVI secolo, va considerato alla luce delle concezioni anatomo-fisiologiche della medicina antica. Queste si basavano: a) sulla teoria del mo-vimento nel corpo attraverso i nervi, le vene e le arterie dei tre spiriti cui erano attribuite le funzioni e le operazioni vitali (virtutes) dell’organismo: spirito animale nel cervello, spirito naturale nel fegato, spirito vitale nel cuore; b) sulla teoria degli umori (sangue, bile gialla, bile nera, flemma) che avevano rispettivamente sede nel cuore, nel fegato, nella milza e nel cervello, e delle loro rispettive qualità caldo-umida, caldo-secca, freddo-secca, freddo-umi-da; c) sulla teoria del temperamento equilibrato degli umori e delle qualità e del regolare movimento dei tre spiriti come condizione ottimale di un corpo sano. La malattia era causata dall’insorgere di uno squilibrio tra gli umori e le qualità o per eccesso o per diminuzione dell’uno o dell’altra, per cui la terapia praticata dal medico consisteva nella somministrazione di farmaci dotati delle qualità opposte a quelle nocive da espellere o da accrescere o da attenuare. Gli spiriti e gli umori si producevano, si rafforzavano, si rin-novavano mediante l’alimentazione e la respirazione, e mantenevano il loro
13 L’espressione ricorre nei taccuina sanitatis medievali. Adamo da Cremona, intorno al 1228, compone un De regimine iter agentium vel peregrinantium, prendendo molto da Avicenna, destinato ai crociati che partivano per la Terra Santa: L. Esposito, Per l’edizione del “De regimine” di Adamo da Cremona: note preliminari, in Vie e mete dei pellegrini nel Medioevo euromediterraneo, Atti del convegno (Bologna 21 ottobre 2005), Bologna 2007, pp. 95-120.
14 G. Pictorius, Raiss Buchlin. Ordnung wie sich zu halten so einer raisen will in weite und onerfarne Land und wie man allen zufällen so dem raisenden zu stehn mögen mit guten mitteln der artzney begegnen soll, Strassburg, in Hans Knoblauch Druckerey, 1557; l’altra importante fonte di Grataroli, da cui prende alla lettera interi passi, è G. Cardamo, De rerum varietate, Basileae, per Henrichum Petri, 1557.
107
equilibrio in un regolato rapporto di quiete e moto, di veglia e sonno, delle passioni dell’animo, per cui tutta la medicina antica poneva grande attenzio-ne alla dieta, alla qualità dei cibi, alla qualità dell’aria, al clima, alle stagioni, al movimento e al riposo, alla serenità e tranquillità dell’animo. I fondamenti generali della teoria umorale permettevano di giustificare deviazioni a se-guito, ad esempio, di anomalie del tempo atmosferico: le rapide escursioni della temperatura e dell’umidità erano considerate pericolose perché pro-ducevano subitanei squilibri umorali; anche la quantità e la qualità dei cibi, dell’aria, dell’acqua, ed in genere il regime di vita si riteneva che avessero effetti sulla quantità di particolari umori e potessero quindi influenzare l’in-sorgenza delle malattie15. La concezione quindi che la salute era dovuta al perfetto equilibrio degli umori e delle loro qualità e al graduato e naturale movimento degli spiriti, mentre la malattia era causata dal loro turbamen-to per fattori esterni (alimentazione, aria respirata, condizioni ambientali, condizioni psicologiche), ancorché fallace nella sua impostazione di fondo, faceva tuttavia in modo che i trattati di medicina antica dessero molta impor-tanza all’azione preventiva di una dieta sana, di buone condizioni ambien-tali, di un sereno e tranquillo stato d’animo16. Ed è su questo terreno della prevenzione, non certo su quello della terapia, che la medicina antica può ancora offrire motivi di attualità e validità17.
Il medico bergamasco parte dunque dal presupposto, ampiamente ri-scontrato nella vita quotidiana, che il viaggio rischia sovente di mettere la persona nelle condizioni favorevoli all’insorgere di uno squilibrio umorale e delle qualità interne del corpo, e quindi di malattie, a motivo del repentino cambiamento delle abitudini alimentari e delle consuete condizioni ambien-tali, per la fatica cui il corpo viene sottoposto e alla quale non è abituato o preparato, per l’assunzione di cibi di scarsa qualità o per i quali non si è predisposti, per il variare delle condizioni psicologiche, che influenzano le condizioni fisiche, dovuto a novità, sorprese, incertezze, incidenti. Grataro-li vuole dunque proporre ai viaggiatori un corretto regime di vita, utile a prevenire le malattie, gli incidenti, i pericoli che più facilmente accadono durante il viaggio.
15 Silini, Umori e farmaci, pp. 99-100. Grataroli riassume i punti essenziali della scienza medica nella sua operetta De sanitate tuenda, pubblicata con altri saggi nel 1565 a Strasburgo da Rihel
16 M. Nicoud, Aux origines d’une médicine préventive: les traités de diététique en Italie et en France (XIIIe-XVe siècles), Paris 1998.
17 Silini, Umori e farmaci, p. 110: “L’indubbia intrinseca fondatezza di certe intuizioni degli antichi (il concetto di salute e malattia come equilibrio e squilibrio di stati dinamici; l’associazione tra malattie e sta-gioni, luoghi e stili di vita; la naturale tendenza del corpo a riparare; l’azione del medico che deve favorire questa tendenza; e così via) hanno mantenuto e mantengono intatta la loro validità”.
108
Il periodo migliore per mettersi in viaggio è la primavera, la stagione più temperata e quindi più adatta al corpo umano (tempus saluberrimum ob temperatas qualitates et humano corpori aptas, p. 1), a meno che non si debbano passare i monti della Rezia, ancora nevosi in primavera, o che motivi urgenti non ci obblighino a viaggiare in altro periodo. Chi deve affrontare un lungo viaggio è bene che alcuni giorni prima della partenza si purghi degli umori nocivi in eccesso18 (pp. 2-8). Gli sarà anche molto utile, visto che i cambia-menti repentini sono dannosi al corpo, assuefare gradualmente il proprio organismo, prima di partire, a quanto lo attende, con un buon esercizio fisico e con l’assunzione di cibi e di bevande che ritiene di dover trovare nel viag-gio (p. 8).
Durante il viaggio, nonostante tutte le precauzioni che prenderemo e i rimedi che adotteremo nelle varie circostanze negative, potrà sempre acca-dere qualcosa di imprevisto cui dovremo far fronte, in mancanza d’altro, con molta pazienza, una virtù che vince i casi avversi della fortuna e che ci man-tiene padroni di noi stessi (in reliquis sciat victricem fortunae patientiam dici, et oportere in patientia nostra ut nostras possideamus animas et vitas, p. 9)19.
D’estate è bene vestire leggero con abiti di lino, d’inverno con abiti di lana o di pelli (p. 9). Chi va verso regioni d’aria più calda del suo luogo nati-vo, scelga nella località di destinazione una residenza rivolta a settentrione, si rinfreschi con acqua con fiori ed erbe di qualità fredda quali rose, viole, foglia di vite. Viceversa, chi va verso regioni fredde procuri di avere buone vesti e cibi calorici, beva vino generoso (potenti, p. 9) ma moderatamente, si tenga al caldo con fuoco di legna secca. Durante il viaggio, sia che andiamo a piedi sia a cavallo, è preferibile a pranzo mangiare e bere poco, astenersi da cibi di difficile digestione (nimis durae concoctionis, p. 10), d’inverno bere vino forte ma poco, specialmente a pranzo, d’estate vino bianco, leggero, chiaris-simo (vino oligophoro, p. 11). Giunti lungo il cammino ad una fonte, non ingur-gitiamo acqua, che causa poi dolori al ventre: basta sciacquarsi la bocca e fare dei gargarismi (os solummodo abluere ac gargarizzare, p. 10). Nelle locande20 guardiamoci dal pesce servito freddo o riscaldato di troppi giorni. Lo stesso si dica per le carni non cotte bene oppure cucinate ancora calde dell’animale appena macellato (p. 11). Chi va a piedi, appena giunto alla locanda non si
18 Sulla purgazione, Silini, Umori e farmaci, pp. 155-158.19 Grataroli cita qui tre versi latini: “Perfer et obdura: dolor hic tibi proderit olim” (Resisti e sta’ saldo:
questa pena un giorno ti sarà di giovamento, Ovidio, Amores, III, 11, 7); “Durate et vosmet rebus servate secundis” (Resistete, e serbatevi alla fortuna, Virgilio, Aeneis, I, 207); “Fortiaque adversis opponite pectora rebus” (e alle avversità contrapponete i petti gagliardi, Orazio, Sermonum libri, II, 2, 136).
20 Sulle locande nel Cinquecento in territorio tedesco si veda il dialogo Diversoria, “Locande”, del 1523, in Erasmo da Rotterdam, Colloquia, a cura di Cecilia Asso, Torino 2002, alle pp. 452-465; Maczak, Viaggi e viaggiatori, cap. II, “La locanda e il soggiorno”; M.L. De Nicolò, Homo viator: alberghi, osterie, luoghi di strada dal Trecento al Cinquecento, Fano 1997.
109
metta subito a tavola: aspetti almeno una mezz’ora che il calore accumulato nel corpo per il molto movimento si attenui (p. 11). Appena mangiato non ci si rimetta subito in cammino, ma fatti due passi ci si riposi per circa due ore (circiter horas duas quiescat, p. 12), a meno che non si disponga di un cavallo che va d’ambio (equum gradarium, p. 12) o che non decidiamo di avviarci con passo molto lento (lente incedat, p. 12). Quando siamo in viaggio, lasciamo da parte pensieri, preoccupazioni, ansie (caveat ab animi curis et perturbationibus, p. 12), che debilitano le forze del corpo già stanche per il molto camminare21. Come l’eccessiva apprensione e la malinconia (che i tedeschi, e non solo loro, scacciano con il vino) anche la troppa allegria indebolisce: ogni estremo è vizioso (p. 13). La cosa essenziale è questa: chi viaggia deve guardarsi in tutti i modi di non ammalarsi, e la prima regola da osservare è di cibarsi bene e poco (cibus sit bonae substantiae et quantitatis paucae, p. 14), e di mangiare a suo tempo, quando si è arrivati alla locanda; tuttavia anche lungo il cammino si può assumere un po’ di zucchero rosaceo (sacchari rosacei, p. 14)22.
Chi cammina nella stagione estiva tenga avvolti lombi e addome con una fascia morbida; d’inverno, usando una fascia più lunga, avvolga anche dorso e petto (p. 16). Durante il cammino stiamo sempre coperti, non esponiamoci nudi agli ardori del sole perché il corpo, se troppo caldo-secco, si indurisce, e di conseguenza cresce col movimento la fatica. Scrive Girolamo Cardano nel libro 13, cap. 63 del De varietate rerum che due cose sono per la nostra sa-lute più nocive addirittura delle guerre e dei bagordi: se accaldati passiamo repentinamente in ambiente freddo; se teniamo troppo a lungo i piedi freddi o umidi, soprattutto mentre mangiamo. Guardiamoci dal bere troppa birra, fa più male del bere troppo vino. E non fidiamoci degli osti: non chiedete mai a un oste se la sua birra o il suo vino sono buoni, la risposta è scontata. Attenti a bere acqua piovana: se proprio occorre servirsene, prima fatela bol-lire. L’acqua tiepida provoca nausea, ma qualche volta può servire a lavare lo stomaco (p. 23). L’acqua fresca, quando presa nel modo dovuto e a suo tem-po, conforta tutte le virtù naturali del corpo. Quando si è in marcia è meglio parlare il meno possibile, d’estate poi il troppo parlare fa aumentare la sete e
21 L’influenza di fattori psicologici sull’organismo fisico, e viceversa, è particolarmente teorizzata da sistemi filosofici quali quello aristotelico, soprattutto nella versione pomponazziana, da Galeno e da Avicenna, che Grataroli segue, sistemi nei quali l’anima non è un ente a sé stante, metafisico, separato dal corpo, ma intimamente e indissolubilmente unita al corpo, come atto di un corpo organico, per cui anche la psicologia tende a ridursi a fisiologia degli spiriti vitali. Grataroli, nel primo discorso tenuto all’Università di Marburgo, Laudes medicinae, p. 14: il medico “non modo corpus, sed animam etiam curat ob maximam amborum necessitudinem et communicationem […] illa demum integra est sanitas, quae ex corpore et animi incolumitate provenit et consistit”.
22 Su come comporre “Saccharum roseum”: Pharmacopoea seu de usitatiorum medicamentorum compo-nendorum ratione Liber Collegii medicorum Bergomensium, Bergomi, apud Iosephum Pigoccium Bibliopo-lam, Typis Comini Venturae, 1580, p. 187.
110
non va bene. Evitate carni e cibi troppo salati. Dopo una giornata di duro cammino è facile prender sonno. Ma a volte
le preoccupazioni del viaggio o altri incomodi possono causare insonnia: ci addormenteremo più facilmente se prima di coricarci, due ore dopo la cena, laviamo piedi e braccia in acqua nella quale sono stati bolliti fiori di ninfea gialla (nenupharis flores), di viole, di camomilla (p. 37) e se dopo un quarto d’ora berremo uno sciroppo di viole o di ninfea gialla o di papavero. Perso-ne di poco conto dicono che bere molto vino durante e dopo la cena conci-lia il sonno, mentre invece provoca solo pesantezza e dolori al capo23. Resta sempre validissimo l’aforisma di Ippocrate: il riposo sarà sempre la migliore medicina per un corpo affaticato dal troppo movimento (contraria contrariis curari, p. 39).
Per chi è stanco e spossato dal viaggio fanno bene cibi di buon succo (boni succi cibis, p. 39) come carni di galline castrate, di capponi, di perni-ci, di fagiani, vino profumato e gradevole (vinum odorum et sapidum, p. 40), uova fresche, un buon pane inzuppato in vino malvasia (vino malvatico, p. 40). Per togliere la stanchezza e stare in buona salute il viaggiatore segua, scolpite nella memoria, le otto regole di Avicenna: 1) assumere cibo leggero e facilmente digeribile, che genera sangue sottile e gli spiriti (p. 41); 2) bere vino delicato che fa bene al cuore (ad confortandum cor conveniens et ad mul-tiplicandum vitales spiritus, p. 42)24; 3) odorare aromi fragranti che rianimano gli spiriti (spiritus refovent, p. 42)25; 4) rimanere tranquilli e sereni nell’animo
23 Nella seconda edizione del De regimine, Strasburgo, Rihel, 1563, Grataroli a questo punto aggiunge che se proprio il sonno tarda a venire e si deve vegliare, p. 50. Traduco dal latino“compenserai la veglia con pensieri lieti, con lo studio, con i colloqui, con la visione di immagini amene; o ti difenderai con il canto delle acque e dei boschi, con l’immagine delle solitudini dei monti, con il mormorio dell’acqua”. Il naturalista e geografo svizzero Konrad Gessner, amico di Grataroli, aveva anch’egli scritto: “Ho deciso che finché Iddio mi concederà di vivere, ogni anno salirò sulle montagne, almeno su una sola, nel periodo in cui i fiori sbocciano, proprio per vederli e per dare esercizio al mio corpo, e insieme gioia alla mia anima” (Maczak, Viaggi e viaggiatori, p. 12).
24 Il cuore, nella concezione galenica, era ritenuto sede del calore intrinseco del corpo, energia primordiale e propulsiva dell’organismo umano, sede degli spiriti vitali, organo che con la sua azione estraeva dal sangue, proveniente dal fegato, gli umori dai cibi e li manteneva in uno stato di equilibrio dinamico secondo proporzioni ottimali (Silini, Umori e farmaci, p. 97).
25 Odorare gli aromi ha la funzione di rianimare il corpo stanco. Gli spiriti erano prodotti dal cibo e dall’aria introdotta con la respirazione. Il sangue, passando dal fegato, al cuore, al cervello veniva arricchito dei tre spiriti, naturale, vitale, animale (Silini, Umori e farmaci, pp. 92-93). Michel de Montaigne, 1580: “I medici potrebbero, credo, trar dagli odori più profitto di quanto non fanno; infatti mi sono accorto spesso che essi mi cambiano, e agiscono sul mio spirito secondo la loro natura; e questo mi fa accettare quel che si dice, che cioè l’invenzione degli incensi e dei profumi nelle chiese, tanto antica e diffusa in tutti i popoli e in tutte le religioni, miri a rallegrarci, risvegliarci e purificarci i sensi per renderci più disposti alla contemplazione” (Saggi, Milano 1970, vol. I, cap. LV, p. 408). Grataroli, De sanitate tuenda, p. 738: “Odor est cibus animae”.
111
e nel corpo, lontani da rumori che disturbano26; 5) stare moderatamente al-legri, che giova a mantenere florida l’età (gaudium moderate receptum, quod aetatem floridam facere solet, sicut tristis spiritus ossa desiccat)27; 6) evitare motivi di irritazione quali dispute, diverbi, risse che conturbano il sangue e l’animo; 7) ricercare il conforto di cose amabili ma lasciando stare il sesso (sine veneris accessu vel appetitu, p. 42); 8) stare con persone gradite e amate, dalle quali sappiamo che non ci verrà alcun male.
Anche un buon bagno toglie la stanchezza (p. 43). Arrivati alla locanda, dopo aver riposato un’ora, fate un gradevole bagno in acqua tiepida, strofi-nando leggermente tutto il corpo (totum corpus leniter fricetur, p. 43), poi unge-te il corpo, specialmente le giunture, d’inverno con olio caldo di ruta o di ane-to, d’estate con olio di rosa o di camomilla28, dormite in letto morbido stando ben coperti, risvegliati fate un altro bagno se volete, poi mangiate e bevete.
Per la difesa degli occhi dall’abbaglio delle nevi è bene vestirsi di scuro e tenere una veletta nera davanti agli occhi (p. 67). Ma la cosa migliore è di procurarsi, visto che si vendono a poco, occhiali di vetro o di cristallo (vitreis aut crystallinis conspiciliis oculis superligandis) che servono anche a riparare gli occhi dalle polveri. Quando fa freddo è bene prima di partire mandar giù qualcosa di caldo, e portare poi con sé aromi caldi come il pomo d’ambra o di ladano o di muschio, che confortano gli spiriti e tengono caldo il cervello; chi ha meno possibilità economiche usi puleggio o menta29 (Confert calida
26 Questo motivo ritorna spesso nell’opera di Grataroli, come a p. 56, guardarsi dall’ira, dalla tristezza, dai troppi pensieri, ma anche dalla troppa allegria, vivere con serenità d’animo; è motivo ricorrente in tutte le opere dei medici-filosofi antichi, da Ippocrate a Galeno ad Avicenna. Grataroli, De sanitate tuenda, p. 716: “ad quietem corporis accedat animi tranquillitas et sensuum imperturbatio”. Vedi anche nota 32.
27 Grataroli, De sanitate tuenda, cap. V, “De refectione et hilaritate animae”, p. 736: “Hilaris anima et refecta vigorem viribus corporis tribuit et naturam excitat et in omnibus adiuvat actionibus: confert et gaudere facit, retinet iuventutem et conservat sanitatem”. Recano gioia e letizia (gaudium et laetitiam) per Grataroli vestire bene e con varietà, ascoltare musica e canto, leggere libri piacevoli, sentire un bel discorso, contemplare cose belle come il cielo stellato e sereno o l’acqua chiara, stare in compagnia di donne belle e facete, prendere parte a giochi piacevoli (p. 737).
28 Su olio di ruta, aneto, rosa, camomilla: Pharmacopoea, alle pp. 238-243. Su composizione e virtù di questi olî Castore Durante, Herbario nuovo, in Roma, nella stamperia di Bartholomeo Bonfadino e Tito Diani, 1585: olio di ruta pp. 402-403, olio di aneto p. 29, olio di rosa p. 395, olio di camomilla p. 85. Anche per Durante gli olî di ruta e di aneto erano di natura “calda”, e quindi più adatti per il periodo invernale, mentre gli olî di rosa e di camomilla “mitigavano gli ardori del sole”. Ancora oggi l’acqua profumata di rosa è consigliata come rinfrescante nel periodo estivo.
29 Gli aromi d’ambra grigia e di muschio sono d’origine animale, il primo da secrezione intestinale del capodoglio che, espulsa, galleggia sugli oceani e si deposita sulle spiagge, il secondo da secrezione contenuta in una tasca addominale del capriolo muschiato che vive nell’India, nel Tibet e in Cina, e che sin dall’antichità i mercanti lo trasportavano nella sua vescica; il ladano, una sostanza resinosa che essuda da alcune varietà di cisto fra cui quello di Creta, della Siria, di Cipro, tre aromi assai costosi che, ridotti in una pallina (pomo) venivano poi inseriti in una piccola custodia sferica (globi profumati, pomander), spesso riccamente decorata, filigranata d’oro e d’argento, traforata per lasciar esalare il profumo, che si poteva portare, a seconda delle dimensioni, appesa al collo, alla cintura, unita ad un bracciale o ad un anello, simbolo sociale e segno di ricchezza, di origine orientale sia gli aromi sia i globi contenitori; pu-leggio, varietà di menta.
112
odoramenta habere ut pomum ambre vel ex ladano aromatis et moscho habere, ut cerebrum calefiat et confortentur spiritus, p. 68). Capo, collo e orecchi devono sempre rimanere ben coperti con lana o con pelli. Se un membro si è conge-lato si eviti di metterlo subito vicino a fonti di calore (p. 70); prima si ponga in acqua fredda e lo si lasci per un po’, dopo lo si strofini con olio caldo. Il viaggiatore che deve attraversare regioni fredde non manchi mai di olî cal-di coi quali ungersi collo e nuca, di vesti adeguate e di buoni aromi (p. 72). L’ebbrezza durante il viaggio nuoce tantissimo a sé e agli altri perché toglie il senno e fa compiere azioni inconsulte30. Non è infrequente a chi fa lunghi viaggi, in particolare se persona povera, venire infestato dai pidocchi (p. 76): capita comunque a chi non si lava, a chi tiene addosso vesti luride e non le dà a lavare, come avviene per vergogna e negligenza negli ospizi. Per tenere lontani i pidocchi lavare le vesti in acqua bollente con dentro bacche di alloro o tamarisco o allume, e tra le vesti pulite e riposte mettere fiori di lavanda (p. 77).
Colui che per qualsiasi motivo si mette in viaggio si comporti sempre con buona coscienza davanti a Dio, che scruta i nostri cuori, si conduca secondo la sua parola e Dio benedirà il suo partire e questa benedizione gli sarà di grande vantaggio, come dice Salomone nei Proverbi31. Ma il viaggiatore deve sempre agire con molta circospezione. Quando si arriva in una locanda la prudenza non è mai troppa (p. 87): ovunque sono ladri e furfanti che vanno per strade e sostano nelle locande con il solo scopo di compiere misfatti e ru-berie32. Sono furbi, fanno domande: «donde vieni? dove vai?». I viaggiatori esperti e avveduti conoscono bene questi tipi; gli inesperti ci cascano, a meno che non vi sia un oste vigile e onesto che li metta in guardia. Non mostrare mai di avere con te oro o argento. Se alla locanda persone che non conosci ti fanno troppe domande, rispondi il falso: con le volpi bisogna essere vol-pi. Grataroli ricorda, a questo proposito, quanto accadutogli in una locanda della Valle Camonica nel maggio del 1550, dove di notte un tizio, forse il servo dell’oste, gli rubò la borsa che teneva sotto il guanciale con dentro 50 corone (p. 89). Qualcuno la sera prima l’aveva visto maneggiare quel denaro con un mercante tedesco di cavalli, dal quale il medico aveva acquistato un cavallo più giovane di quello col quale era giunto sin lì. La mattina, accor-tosi dell’accaduto, Grataroli inferocito si era messo con una spada sull’uscio
30 Cita Ecclesiastico 32,19: “Non fare nulla senza deliberazione, per non pentirtene a cose fatte”.31 Proverbi 10, 22: “La benedizione di Jahve fa arricchire, la nostra fatica non vi aggiunge nulla”.
Più avanti Grataroli cita anche Proverbi 20, 24: “I passi dell’uomo li dirige Jahve; perciò, che cosa capisce l’uomo del proprio cammino?”. E ancora cita Geremia 10,23: “Io so, o Jahve, che l’uomo non è padrone della propria via, non è in potere dell’uomo che cammina il dirigere i suoi passi”.
32 Degli accidenti occorsi lungo il viaggio al mercante Rinaldo d’Asti, vittima di “masnadieri”, vedi la novella di G. Boccaccio, Decameron, Milano 1998, II giornata, II novella.
113
della locanda, deciso a tutto se la borsa non saltava fuori. L’oste, spaventato dalla furibonda reazione del bergamasco, non ci mise molto a far saltar fuori la borsa. In Germania, precisa Grataroli, simili disavventure sono molto più rare, specie nelle città e nei borghi fortificati; ma c’è da stare attenti a per-nottare nei piccoli villaggi o nelle locande isolate: non solo per tutta la notte senti contadini ubriachi, ma il letto non ti viene mai dato pulito (p. 91). Se vai a piedi e non sei conosciuto dall’oste ti trattano male, a meno che non sganci una bella mancia ai servi. Comunque non farti mai mancare un buon libro, che ti terrà compagnia dove ti fermi ad alloggiare (p. 92).
Viaggiare per le Alpi Retiche non solo è faticoso, ma anche disagevole per la penuria di molte cose33. Può mancare il pane, può mancare il fieno per il cavallo: però bisogna sempre pagare, e questo ormai ovunque (bene tamen numerare oportet: sed hoc nunc ubique fere commune, p. 92). Se si deve camminare per montagne impervie o su ghiacciai si mettano ai piedi, legati alle calzature, dei robusti ramponi di ferro (chalybeae cuspides ferreis laminis iunctae ac continuae, p. 93), che si possono acquistare facilmente. Camminan-do in montagna si presti attenzione nello scendere: è più facile infatti cadere in discesa che in salita (p. 94), per una questione di postura del nostro corpo ma anche per il timore che ci prende la vista di un precipizio e dell’altezza; i cavalli invece tendono a scivolare di più in salita che in discesa. Se si va a pie-di, avere sempre il bastone: meglio camminare con tre appoggi che con due.
Procuriamo di avere una carta geografica della regione che percorriamo (tabellam regionis depictam, p. 97). Se ci si perde, teniamo sempre la via più battuta, arriveremo più facilmente ad una locanda o incontreremo qualcuno cui chiedere informazioni (p. 98). Se sei giunto alla riva di un fiume e non sai più che direzione tenere, segui il corso del fiume, perché città, villaggi, locande si trovano solitamente lungo i fiumi, come si vede lungo il Reno in Germania. Se si devono attraversare zone fangose, paludose, le calzature migliori sono quelle di legno, come si usa in Francia: non si inumidiscono facilmente e asciugano anche presto; essendo di legno possono ledere i piedi, è bene quindi imbottirle di stoppa (p. 99). Se ci è possibile, cerchiamo di non viaggiare mai da soli ma sempre in compagnia di qualcuno: in caso di peri-colo ci si aiuta. E non poniamo riguardo alla religione di chi ci è compagno nel viaggio: aiutarsi l’un l’altro nella reciproca assistenza e difesa è proprio della socievole natura umana (p. 101). Per questo è ingiusto che gli anabat-tisti, gente fanatica, si sottraggano al dovere della pubblica difesa. Essi non
33 Sui consigli di Grataroli per chi viaggia in montagna: V. Ricci, Montagna e scienza nell’opera di un italiano del XVI secolo, in «Bollettino del Centro Alpinistico Italiano», vol. XLIV, 1939, pp. 234-248 (con traduzione in italiano di alcune parti dell’opera); G. Castellana, Guglielmo Grataroli e i viaggi nelle Alpi nel secolo XVI, in «Club Alpino Italiano. Rivista mensile», vol. LXXIV, luglio-agosto 1955, pp. 218-220.
114
vogliono portare alcuna arma quando sono in viaggio: si sentono spirituali e quindi, dicono loro, immuni34 (p. 102). Altri invece, superstiziosi, ignoranti della pura religione, prima di mettersi in viaggio fanno tre volte il segno della croce e recitano preghiere davanti alle immagini dei santi pensando che così andranno sicuri; si comportano come i pagani, i quali si inventavano dèi fittizi, buoni per ogni circostanza, come la dea di cui ironicamente scrive Arnobio nel quarto libro di Adversus gentes: “dai pericoli delle vie ci libera la dea Vibilia”; oggi il posto della dea Vibilia è preso dai Re Magi 35.
Dunque, volendo rispondere con poche, riassuntive parole al quesito di Grataroli: come viaggiare e rimanere sani? Partire preparati, procurarsi un abbigliamento che si addice ai luoghi e alle stagioni, mangiare leggero, bene e lentamente, moderarsi nel bere, riposare e dormire a sufficienza, curare l’igiene del corpo, non avere mai fretta, prendere gioia da quanto il viaggio reca di amabile, rimanere sereni, essere sempre prudenti, avere molta pa-zienza.
Alle pagine dedicate al regime di vita dell’accorto viaggiatore, Gra-taroli fa seguire la descrizione di quaranta itinerari lungo le principali città europee, in parte composti da lui, in parte, dice, ripresi da altri che li han-no percorsi o sui quali hanno scritto. Queste pagine riservate agli itinerari sono da vedere strettamente e logicamente connesse con quanto Grataroli ha esposto in precedenza, vale a dire come una naturale conclusione del De regimine, rientrando anche queste pagine nella prospettiva tipica del lavoro di Grataroli, già ricordata, che è quella di offrire al lettore informazioni, noti-zie, saperi che gli siano utili e proficui nell’affrontare con fondata previsione le incognite del futuro: nel caso in esame, le incognite che sempre riserva un lungo viaggio.
La forma con la quale Grataroli descrive gli itinerari è quella tipica del ge-nere guidistico che ha le sue origini nella tradizione manoscritta medievale, a sua volta fondata sugli Itineraria Antonini del IV-V secolo, il cui primo testi-mone noto risale al sec. VII (Escorialensis R II 18). L’itinerario, identificato in senso unidirezionale da una località di partenza e una località di arrivo e che
34 U. Gastaldi, Storia dell’anabattismo dalle origini a Münster 1525-1535, Torino 1992, a p. 217 l’articolo sulla non resistenza della Confessione anabattista di Schleitheim, 24 febbraio 1527: “…Perciò saranno respinte da noi indubbiamente anche le non cristiane anzi diaboliche armi della violenza, come la spada, l’armatura e simili e ogni loro uso a favore degli amici e contro i nemici, in forza della parola di Cristo: Non resistere al male”, vedi anche le pp. 328-329.
35 Non deve sfuggire, per la comprensione della personalità di Grataroli, il senso di queste parole. Ritenere che con un segno di croce e una preghiera rivolta ai santi il viaggio andrà bene, riducendo così Dio e la religione al servizio dei bisogni e degli interessi umani, è l’opposto di tutto quello che pensa Grataroli per il quale il viaggio, come ogni altra azione umana, va preparato e condotto con razionalità e responsabilità, riservando a Dio, con coscienza pura, come ha scritto poche pagine prima, il culto dovuto alla sua eterna gloria e sovranità.
115
può svilupparsi lungo una o più strade, è costituito dalla lista, quasi sempre incolonnata, delle località di transito, con indicazione della loro tipologia e della distanza di una località dall’altra. Jacques Signot è il primo autore, a me noto, che nel 1515, reca a stampa il genere, seguito poi in Francia dalle edi-zioni di Charles Estienne del 1552; mentre in Italia questo particolare genere di guide itinerarie ha avuto come primi autori operatori professionisti del servizio postale quali Giovanni l’Herba, Cherubino Stella, Ottavio Codogno. Il genere guidistico di cui stiamo discorrendo non va confuso con diari, rela-zioni, descrizioni di viaggio, materiali che appartengono alla memorialistica e alla letteratura di viaggio; e nemmeno con le ampie descrizioni di stati e regioni, destinate a un pubblico colto, opere spesso di grande formato, ricche di dati storici, geografici, naturalistici, architettonici e artistici, di cui in Italia abbiamo gli esempi di Flavio Biondo, Leandro Alberti, Francesco Sansovino, e nella Svizzera di Sebastian Münster. Il nostro genere ha, ai suoi inizi tipo-grafici, carattere e destinazione popolari: è affidato a stampe di piccolo for-mato, maneggevoli, libretti da tenere in bisaccia, poco curati nella composi-zione grafica e nei caratteri, con testi in volgare. Il genere tenderà col tempo a migliorarsi nella qualità tipografica e ad arricchirsi nei contenuti, attingendo sicuramente alla letteratura odeporica e ai testi descrittivi di regioni e città, ma manterrà sempre l’originaria strutturazione, dovendo assolvere alla fun-zione di essere uno strumento appositamente destinato a futuri viaggiatori, quindi fornito di dati aggiornati, utili e oggettivi, tra i quali sono essenziali il percorso da tenere per raggiungere una determinata località, i caratteri della località raggiunta (possibilità di pernottamento, ristorazione ecc.), le distan-ze, le eventuali difficoltà del percorso.
Nella descrizione dei suoi itinerari Grataroli si conforma al genere, ma anche per alcuni versi da esso si distingue36. L’opera, scritta in latino, desti-nata ad un pubblico di buona cultura, è ben curata nella stampa. A differenza di quanto il genere prevede, le località di transito non sono incolonnate, ma date di seguito (per risparmio di carta?). Nella descrizione l’autore usa indif-ferentemente la lingua tedesca e la lingua latina, anche se prevale il tedesco per gli itinerari che dal Nord scendono verso l’Italia, e possiamo capirne il motivo, e la lingua latina per gli itinerari italiani e per gli itinerari che dall’Italia vanno verso il Nord. Le località di transito sono indicate preva-lentemente col nome d’uso locale: questo, dice Grataroli, per facilitare chi in viaggio si trova nella necessità di dover chiedere informazioni sul percorso;
36 Discute l’opera di Grataroli, confrontandola con la letteratura di viaggio di carattere popolare tra Quattro e Seicento F. Lestringant, Litterature populaire et litterature savante dans les écrits de technique géographique de la Renaissance, in «Bullettin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la renaissance», n. 11, 1980, pp. 134-141.
116
ma non mancano nomi di località nella forma latina, soprattutto negli iti-nerari italiani. La distanza tra le località di transito è data quasi sempre in miglia germaniche, mentre negli itinerari italiani è espressa in miglia italiche (1 miglio, mt. 1.480). Nella tavola delle misure di distanza inserita in fine al volumetto, il miglio germanico ‘comune’ è equiparato a quattro miglia itali-che, quindi a mt. 5.920, il miglio germanico ‘grande o svevo’ a cinque miglia italiche, quindi a mt. 7.400.
Dei quaranta itinerari pubblicati da Grataroli, curo qui l’edizione critica dell’itinerario Basilea-Roma. Nella edizione ho preferito, per facilitare la let-tura, incolonnare le località di transito, metodo non adottato, come già detto, da Grataroli. Indico dapprima il nome della località come compare nel testo di Grataroli seguito tra parentesi quadre dal nome nella forma attuale. Tra-duco in italiano sia il testo tedesco sia il testo latino. Nell’annotazione storica degli itinerari pubblicati da Grataroli mi servo di fonti, qui sotto elencate, scelte sia tra guide itinerarie edite nella forma del genere guidistico sopra esposta, sia tra resoconti e diari di viaggio:1. Itinerari romani in Itineraria Antonini del IV-V secolo37. 2. Guida di itinerari dalla Francia all’Italia di Jacques Signot, pubblicata nel 151538. 3. Diario di viaggio attraverso la Germania, la Svizzera, le Fiandre e la Fran-cia compiuto dal cardinale Luigi d’Aragona (1474-1518) negli anni 1517-1518, steso dal suo segretario Antonio de Beatis39. 4. Guida di itinerari italiani e svizzeri pubblicata nel 1562 da Giovanni L’Her-ba e Cherubino Stella40.5. Diario di viaggio compiuto in Italia nel 1580 dall’umanista francese Michel de Montaigne (1533-1592)41. 6. Guida di itinerari di Ottavio Codogno pubblicata nel 160842.
37 Itineraria romana. Volumen prius. Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense, edizione a cura di Otto Cuntz, Stoccarda 1929 (edizione anastatica, 1990). Descrizione nella forma degli itineraria adnotata, che per le età successive costituiranno l’exemplum del genere: elenco in colonna delle località di transito, distanze tra una località e l’altra, tipologia delle località (civitas, mutatio, mansio, statio).
38 J. Signot, La totale et vrai description de tous les passaiges, lieux et destroictz par lesquels ont peut passer et entrer des Gaules es Ytalie, Paris, en la maison de Toussains Denys libraire, 1515.
39 A. Chastel, Luigi d’Aragona. Un cardinale del Rinascimento in viaggio per l’Europa, Bari 1987, pp. 189-280 (copia fotografica dell’edizione del diario curata da L. Pastor, Die Reise das Kardinals Luigi d’Aragona, Freiburg im Breisgau 1905).
40 G. L’Herba-C. Stella, Itinerario delle poste per diverse parti del mondo, opera piacevole, et utile a quelli che de lei se vorranno servire, Roma, per Valerico Dorico, 1563.
41 Michel de Montaigne, Journal de voyage, a cura di Fausta Garavini, Paris 1983.42 O. Codogno, Nuovo itinerario delle poste per tutto il mondo, In Milano, Appresso Girolamo Bordoni,
1608.
117
Itinerario da Basilea a Roma (pp. 131 - 133)
Testo in tedesco, nomi di località di transito nella lingua d’uso locale, tipologia delle località di transito (città statt, cittadina stattin, villaggio dorff, sede di mercato marckt), distanze in miglia germaniche espresse alcune coi numeri romani altre in lettere. La distanza indicata si intende dalla preceden-te località contrassegnata dal numero di miglia. Grataroli indica come città o cittadine località che oggi sono dei piccoli abitati. Oltre a dover tener conto di mutamenti sopraggiunti nel corso dei secoli, che possono aver trasforma-to profondamente l’assetto urbanistico di molti luoghi, serve notare che nel momento in cui scrive Grataroli, con il termine di città o di cittadina si voleva indicare un borgo spesso fortificato, una sede di istituzioni amministrative o di poteri signorili, di importanti edifici di culto, di scambi commerciali, località che godevano, rispetto ad altre, di maggiore autonomia politica. Le località indicate come città o cittadine sono più numerose in Italia che nei territori nordici.
Itinerario da Basilea a Roma: miglia Germaniche43.
Krentzach [Grenzach], villaggio44.Vuilen [Wyhlen], un breve miglio.Vuarmbach [Warmbach], villaggio.Rinfelden [Rheinfelden], città, I miglio45.Möli [Möhlin], villaggio.Mumpff [Mumpf], villaggio, I miglio.Stein [Stein], villaggio.Seckingen [Bad Säkingen], città.Lauffenberg [Laufenburg], città, mezzo miglio46.
43 Titolo in latino “Ex Basilea Romam iter: miliaria Germanica”.44 Usciti da Basilea per il ponte di legno sul Reno, che collega il centro cittadino con “Basilea-Piccola”
(una bella silografia in Hartmann Schedel, Libri cronicarum, Nurembergae, Anthonius Koberger, 12 VII 1493, fol. CCXLIIII), sino a Rheinfelden si viagga alla destra del Reno.
45 A Rheinfelden, passato il ponte, si raggiunge Möhlin. L’itinerario descritto da Grataroli è stato percorso, nel senso inverso, da Costanza a Basilea, nel 1517 dal card. Luigi d’Aragona, Chastel, Luigi d’Aragona, a p. 202 è descritto il ponte di Rheinfelden: “Rainveldin che ha un longho et largo ponte de legnamo su l’acqua”.
46 A Laufenburg si attraversa nuovamente il Reno, portandosi sulla sua destra. Chastel, Luigi d’Aragona, pp. 201-202: “et se andò ad cena a Loffinbergh quale è posta sopra una riva et l’altra del Rheno […]. Dicta terra non è molto grande, et il Rheno li passa per dentro in una grande strictura, sopra il quale è un ponte di pietre, et lli tiene un’altra fractura o cascata de acqua [prima ha già descritto la cascata di Sciaffusa] che fa un suono grandissimo per li saxi grossi vi sono et corso violentissimo. Et per dicto ponte si passa a la riva sinistra dove è una gran parte de l’habitatione. Et da lla incomincia decto fiume ad essere navigabile per fine al oceano”. Il ponte attuale è stato realizzato nel 1911 in luogo di un altro, parte in pietra parte in legno, del 1804.
118
Lütlingen [Lüttingen], villaggio47.Houuenstein [Hauenstein], piccola cittadina.Tougern [Dogern], villaggio.Vualdshout [Waldsuth], città, I miglio.Burtwil48 [Gurtweil], villaggio.Tirngen [Tiengen], piccola cittadina.Neukilch [Neunkirch], cittadina, un miglio e mezzo.Scaffhusen [Schaffhausen], città, I miglio49.Diessenhofen [Diessenhofen], cittadinaStein [Stein], cittadina, II miglia.Steckboren [Steckborn], cittadina.Ermetingen [Ermatingen], villaggio.Constantz [Costanza], città, II lunghe miglia50.Arb [Arbon], cittadina, III miglia51.Roschach [Rorschach], mercato, mezzo miglio52.Rineck [Rheineck], cittadina, I miglio. Qui si oltrepassa53.Da Rinech [Rheineck] alla cittadina di Veltkilch [Feldkirch], III miglia54.Pluditz [Bludenz], città, II miglia.Klösterlin [Klösterle], qui è un villaggio, II migliaArlenberg [Arlberg Pass55 ], mezzo miglio.Landeck [Landeck], mercato, III miglia56.Finstermuntz [Hochfinstermüntz].Federspil uff Marsel57 [Nauders?].Heide [St. Valentin an der Heide – S. Valentino alla Muta], locanda, due
miglia e mezzo58.
47 Le località da Lüttingen sino a poco prima di Neunkirch sono oggi in territorio tedesco.48 Probabilmente un refuso, Burtwil invece di Gurtwil, ripetuto anche nell’edizione del 1563.49 Si ripassa il Reno. Chastel, Luigi d’Aragona, p. 201: “Sciaffush […], posta sopra la riva dextra del
Rheno, dove passaimo per un bel ponte di legno, per lo quale se intra a la porta de la terra”. 50 Da Costanza sino a Rheineck l’itinerario costeggia il Lago di Costanza (Bodensee).51 Località “Arbore Felice”, citata negli Itineraria Antonini, a p. 36, n. 251,2-252,1: itinerario da Brigantia
[Bregenz] ad Augusta Raurica [Basel-Augst] passando per Arbore Felice [Arborn], Finibus, Vitudoro [Ober Winterthur], Vindonissa [Windisch presso Brugg], Rauracis [Basel-Augst].
52 Rorschach, allora di pertinenza dell’Abbazia di San Gallo, nell’847 ottiene da Ottone I il diritto di aprire un mercato, riscuotere il dazio e battere moneta.
53 Si oltrepassa il Reno. La costruzione del primo ponte che unisce Rheineck a Gaissau è del 1874. Prima si attraversava il fiume su una chiatta.
54 Da Feldkirch, borgo fortificato, l’itenerario risale la Walgautal, poi la Klostertal, in Austria.55 Il passo è a mt. 1.803.56 Da Landeck sino alla Valsugana è il percorso della antica via romana Claudia Augusta, che colle-
gava Altino (Venezia) ad Augusta (Augsburg).57 Forse da identificare con Nauders. 58 Venendo da Nauders per il Passo di Resia, mt. 1504, si raggiunge S. Valentino alla Muta. Questo
valico fu preferito anche dai popoli del Nord che scesero in Italia alla fine dell’Impero Romano, per questo chiamato Janua barbarorum.
119
Mals VII kilchen, [Mals – Malles o Sette Chiese], I miglio59.Vueron60 [Meran – Merano], città, sei miglia.Calteren [Kaltern – Caldaro], villaggio, IIII miglia.Traumin [Tramin – Termeno], Alla cantina61.Sant Loran [Salurn – Salorno], villaggio, si va sul ponte62.Sant Michael [San Michele], villaggio63.Trient [Trento], città, V miglia64.Rufereyt [Rovereto], città, III miglia.Alla Berner clus [Chiusa Veronese o di Rivoli] si va in Lombardia, cin-
que miglia65.Vuillefranken [Villafranca], villaggio.Mantua [Mantova], città, sei miglia.
59 “Sette torri” o “Sette chiese”, antico toponimo di Mals-Malles.60 “Vueron” per Merano, un refuso? Ripetuto anche nell’edizione del 1563. Da Mals-Malles a “Vue-
ron” sono indicate 6 miglia di distanza, pari a Km. 44,400: per le carte stradali attuali ce ne sono 61; Da “Vueron” a Kaltern-Caldaro sono indicate 4 miglia pari a Km. 29,600: per le carte stradali attuali, evitando Bolzano, ce ne sono 34. Da notare che tutte le distanze che Grataroli indica nella parte ‘settentrionale’ di questo itinerario sono imprecise per difetto.
61 Rinomata zona di vini pregiati, percorsa oggi dalla turistica “Strada del vino”.62 Si attraversa l’Adige per portarsi sulla sponda sinistra e scendere verso Trento. Nel suo viaggio
verso la Germania, il card. Luigi D’Aragona si ferma a pernottare a Salurn-Salorno la sera del 13 maggio 1517: Chastel, Luigi d’Aragona, p. 192, “se andò a cena a Soloron distante [da Trento] tre miglia todeschi. (Advertendo che ciascuno miglio dessi son cinque de Italiani). Et in la Magna se intra ad uno miglio todesco da Trento”.
63 Da S. Michele sino a Roma l’itinerario indicato da Grataroli coincide con quello illustrato nella carta silografica disegnata da Erhard Etzlaub e stampata a Norimberga nel 1500 in occasione del Giubileo, per servire ai pellegrini che dalla Germania si sarebbero recati a Roma: tit. Das ist der Rom weg von meylen zu meylen mit puncten verzeychnet von eyner stat zu der andern durch deutzsche lantt. Gli itinerari sono indicati con tante piccole lineette che uniscono una località all’altra, ogni lineetta sta per un miglio germanico. L’itinerario illustrato da Etzlaub scende dal Brennero e si congiunge a San Michele con quello indicato da Grataroli che proviene dal Passo Resia. Sussistono tra i due itinerari alcune differenze: l’itinerario di Etzlaub tocca Verona mentre Grataroli la evita; quello di Etzlaub fa attraversare il Po a Ostiglia mentre Grataroli, dopo aver toccato Mantova, supera il Po a S. Benedetto Po; superato il Po, Grataroli tocca Concordia sulla Secchia, S. Giovanni in Persiceto e arriva a Bologna; Etzlaub, passato il Po a Ostiglia, tocca Mirandola, Bomporto, S. Giovanni in Persiceto, quindi Bologna. È probabile che già a Mirandola i due itinerari si riunissero. Anche Codogno, Nuovo itinerario delle poste, per chi viene da Mantova, indica lo stesso itinerario di Grataroli, De regimine iter agentium vel equitum, p. 130, località di tappa incolonnate: “Mantova città / Passerete il lago, e poi il Po / A S. Benedetto / Passerete Secchia / Alla Concordia / Alla Mirandola / a S. Martino / a Bomporto”.
64 In questi anni si sta tenendo a Trento il Concilio, che chiuderà le sessioni nel 1564. Grataroli avrà pensato, nel comporre questo itinerario con una maggiore attenzione e precisione rispetto ad altri, anche ai molti viaggiatori del Nord e del centro Europa che potevano servirsi di questa sua guida per raggiungere Trento, prelati, principi, teologi, funzionari dell’Impero, segretari; vi parteciparono anche i rappresentanti dei cantoni svizzeri cattolici.
65 Breve e stretta gola, dalle pareti verticali, fortificata, che faceva da confine tra la Repubblica di Venezia e il Principato vescovile di Trento. Così la descrive il segretario del card. Luigi d’Aragona, nel viaggio verso la Germania l’11 maggio 1517, Chastel, Luigi d’Aragona, pp. 191-192: “passo della Chiusa […], i Venetiani tengono bona guardia et in certe casecte fabricate in mezzo del monte dentro del saxo vivo molte boche de artellaria […] Decto passo è a la banda dextra volendo andare a la Magna. Se serra con porta et è cossi strecto et mal sentiero di pietra viva che non ce può andare più che un cavallo, et non senza periculo”. Bern per Verona è testimoniato in ambito tedesco sin dall’alto Medioevo.
120
Sant Benedict [San Benedetto Po], un ricco Monastero, II miglia.Concordia [Concordia sulla Secchia], piccola cittadina66.Castella minor sive Castellum S. Ioannis [Castello S. Giovanni in Persi-
ceto], cittadina.Bononia [Bologna], città, dieci miglia67.Florensola [Firenzuola], città68.Scarperia [Scarperia], città69.
66 L’itinerario attraversa una regione già abitata in età romana e fortificata nel Medioevo. Ebbe im-portanza crescente prima come possesso dell’Abbazia di Nonantola, quindi del Comune di Modena e degli Estensi, grazie al ruolo di polo dei commerci fluviali tra Modena e il Po, Ferrara e Venezia. Zona gravemente colpita dal terremoto del maggio 2012 con il crollo di antiche torri e castelli. In questa regione, l’itinerario indicato da Etzlaub nella carta, Das ist der Rom weg, del 1500 (Vedi Appendice II) corre un poco più a oriente, toccando Ostiglia e Mirandola: probabilmente i due itinerari si riunivano a Mirandola pri-ma di raggiungre Bomporto e poi S. Giovanni in Persiceto. Questo tratto d’itinerario, Bologna-Mantova, è descritto anche da L’Herba-Stella, Itinerario delle poste alle pp. 11-14 (itinerario da Bologna a Bruxelles pas-sando per Augsburg), dove è indicata una “hosteria” a Bomporto “et qui si passa una fiumara per barca” [Panaro], indica poi “a la Concordia, borgo, al Po hosteria. Qui si passa per barca, a S. Benedetto, borgo et Monasterio bello, a Mantova, città bellissima”. Negli Itineraria Antonini, p. 42, n. 282.3-7, il percorso da Verona a Bologna è il seguente: “Hostilia m.p. XXX [Ostiglia] / Colicaria m.p. XXV [ località Tesa, comune di Mirandola ?] / Mutina m.p. XXV [Modena] / Bononia m.p. XXV [Bologna]”.
67 Il tratto descritto da Grataroli, che va da Bologna a Roma, fu percorso tra il 20 e il 30 novembre 1580 dall’umanista francese Michel de Montaigne, il quale in un primo tempo voleva raggiungere Roma prendendo la strada per le Marche per poi attraversare l’Umbria. Fu un tedesco, derubato a Spoleto dei suoi beni, a consigliargli la strada dell’Appennino. Il tratto di percorso che da Bologna va a Roma è lo stesso descritto da Signot, La totale et vrai description, alle pp. 28-29 nel suo itinerario Parigi-Roma; pas-sato il Moncenisio l’autore indica le seguenti principali tappe prima di Bologna: Susa, Moncalieri, Asti, Alessandria, Tortona, Piacenza, Parma, Modena. Lo stesso itinerario, ma da Roma a Bologna, è descritto da L’Herba-Stella, Itinerario delle poste (primo itinerario dell’operetta), a p. 9. L’Herba incolonna le località facendole precedere dal numero di posta, indica la tipologia del toponimo (“città, borgo, castello, villa, hosteria”) e la distanza tra una località e l’altra in miglia romane; annota molte più località di transito rispetto a Grataroli, 24 contro 13, dovuto al fatto che L’Herba descrive un itinerario delle poste, le quali erano collocate tra le sette e le dieci miglia, a seconda delle caratteristiche e delle difficoltà di percorrenza delle strade.
68 Borgo fondato nel 1332 dal Comune di Firenze; ebbe nome e assetto urbanistico dallo storico Giovanni Villani. Nel 1488 Lorenzo de Medici lo fortificò secondo le esigenze del tempo.
69 Per raggiungere Scarperia l’itinerario non poteva che passare per il Giogo di Scarperia, mt. 882, uno dei più bassi valichi dell’Appennino Settentrionale. Già percorribile come sentiero, il Passo fu aperto dai Fiorentini con l’edificazione nel 1332 di Firenzuola e l’apertura della strada che congiungeva, passan-do per il Giogo, Firenzuola a Scarperia, fondata nel 1306. Anche la carta di Etzlaub, Das ist der Rom weg, del 1500, fa transitare il percorso dalla Germania a Roma per il Giogo di Scarperia con l’indicazione delle seguenti località: Bolonia [Bologna], Planor [Pianoro], Covaleyson? [Covigliaio?], Florenzola [Firenzuo-la], Scarparia minor [Scarperia], Scarparia maior [Scarperia], Florentia [Firenze]: tra Scarperia minor e Scarperia maior è indicata la distanza di un miglio tedesco pari a Km. 7,400: oggi la distanza, per la strada provinciale 503 (da ritenere quindi un poco più lunga rispetto all’antico tracciato), che separa il Giogo da Scarperia è di Km. 10; con “Scarparia minor” il cartografo tedesco pare dunque aver voluto indicare la località del Giogo. Anche Signot, La totale et vrai description, nel 1515 indica il Giogo di Scarperia nell’i-tinerario da Parigi a Roma, c. 28r nn., località di transito incolonnate: “de Boulogne la grace [Bologna la grassa] a Pregnore [Pianoro] / de Pregnore [Pianoro] a Louen [Loiano] / de Louen [Loiano] a Pietremalle [Pietramala] / de Pietremalle [Pietramala] a Florenserolles [Firenzuola] / de Florenserolles [Firenzuola] a Lescarperie [Scarperia] / de Lescarperie [Scarperia] a Florence [Firenze]”.
Montaigne, partito di buon’ora da Bologna, ha sostato per il pranzo a Loiano; alle pp. 173-174, dell’e-dizione citata, il suo compagno di viaggio, Ch. Dédéyan, che scrive il diario, annota le condizioni del percorso: “il primo del nostro viaggio che si può dire scomodo e selvaggio, e tra le montagne più difficili incontrate in questo nostro viaggio”. Annota che a Scarperia vi sono molte locande, “gli osti ti vengono
121
Florentia [Firenze], città, tredici migliaSan Cassan [San Casciano in Val di Pesa], città.Senis [Siena], città, sette miglia e mezzo.Bon convent [Buonconvento], piccola cittadina.Sant Clerico [San Quirico d’Orcia], cittadina.70
Aqua pendente [Acquapendente], città.Sant Lorentz [San Lorenzo Nuovo], cittadina.Monteflascon [Montefiascone], cittadina.Viterbo [Viterbo], città.Ronsilion [Ronciglione], cittadina.Monteross [Monterosi], cittadina.Roma, venticinque miglia.La somma è di 660 miglia italiche o lombardiche e 130 miglia alemanica71.
incontro a cavallo invitandoti a sostare nelle loro locande di cui decantano le lodi […], ma alla fine qualco-sa manca sempre o la legna o il lume o altro ancora […]. La strada è piena di viandanti, perché è il grande cammino e ordinario per Roma”.
L’itinerario da Bologna a Firenze descritto da F. Schott-G. Giovannini (Itinerarium nobiliorum Italiae regionum, urbium, oppidorum et locorum; nunc serio auctum, et tabellis chorographicis et topographicis locuple-tum; in quo, tamquam in theatro, nobilis adolescens, etiam domi sedens, praestantissimae regionis delicias spectare cum voluptate poterit. Auctoribus Francisco Schotto antverpiensi I. C. et F. Hieronymo ex Capugnano Bonon. Predicatorio, 3 voll., vol. I, Vicentiae, Apud Petrum Bertelium Bibliopolam Patavij, 1601) passa per il Giogo di Scarperia; Girolamo Giovannini da Capugnano, vol. I, pp. 170-171, scrive che al Giogo vi è una taver-na molto modesta dove ci si può riposare dopo l’erta e faticosa salita “superatis saltibus, relictisque ad laevam immensis profunditatibus […] angusta et difficilis est via”. Anche per Codogno, Nuovo itinerario delle poste, p. 106, l’itinerario più breve tra Milano e Roma passa per il Giogo e poi prosegue da Firenze a Roma secondo le tappe indicate nell’itinerario di Grataroli. Con la costruzione nel 1752 della strada carrozzabile della Futa, il Giogo di Scarperia viene tagliato fuori dalle correnti di traffico che avevano fatto la sua fortuna.
70 Il 18 ottobre 1581 Montaigne, nel viaggio di ritorno, ripassa da questa località e annota nel diario di suo pugno in lingua italiana, Montaigne, Journal de voyage, p. 494: “Tutte queste strade sono state assettate uguanno per ordine del duca di Toscana: la quale opera è molto bella, e profittevole al servigio publico. Dio glielo rimeriti, perché le vie difficillime sono per questo mezo speditevoli e commode come le vie d’una città. Era cosa stupenda di sentire il numero infinito di gente che andava a Roma”. Codogno, Nuovo itinerario delle poste, p. 113, scrive che la via da Firenze a Roma per la Valdarno e Orvieto “non è frequentata”, mentre oggi vi passa la ferrovia e l’autostrada A1.
71 Nell’edizione di Strasburgo, Rihel, 1563 Grataroli corregge questa somma, p. 167, in 580 miglia italiche e 116 miglia germaniche, che corrispondono a km. 858. Le carte stradali attuali, per lo stesso tinerario indicato da Grataroli da Basilea a Roma danno Km. 1.055. Gli errori, tutti per difetto, di Grataroli si concentrano nel tratto ‘settentrionale’ dell’itinerario, che sicuramente non conosceva.Va inoltre osservato che le strade dei passi alpini e appenninici al tempo di Gratroli erano sicuramente più ripide di quelle attuali e quindi più brevi.
122
Carta di Erhard Etzlaub, Norimberga 1500 (vedi nota 93), con indicati gli itinerari che dalla Germania (allora intesa come territorio molto più vasto dell’odierna Repubblica Federale) portavano a Roma, stampata in occasione del Giubileo. Gli itinerari sono tracciati con line-ette, ogni lineetta corrisponde a 1 miglio germanico (mt. 7.400). Nella carta il Sud (Penisola Italiana) è in alto, in basso la Germania. Dalla “deutzsche lantt” partono diversi itinerari: da Nieuwpoort (Belgio), da Utrecht (Olanda), da Brema (Germania), da Klipev (Danimarca), da Rostoch (Germania), da Danzica (Polonia), da Cracovia (Polonia), itinerari che poi convergo-no o su Bologna, da dove si raggiunge Firenze per il Giogo di Scarperia e poi Roma passando per Siena e Viterbo; oppure su Ravenna, da dove proseguendo per Rimini si raggiunge Roma passando per Fossombrone e Spoleto. Il passaggio degli itinerari attraverso le Alpi avvie-ne per i passi Septimer o Spluga (il tracciato Chur-Clef, Coira-Chiavenna, non consente di stabilire per quale dei due passi), Brennero, Villach (per l’itinerario che parte da Cracovia e attraversa l’Austria).
123
Bruno Ciapponi Landi
VALTELLINA, VALCHIAVENNA E GRIGIONI:indagine sui rapporti culturali
fra il Cantone dei Grigioni, la Valtellina e le ex contee di Bormio e Chiavenna
Le valli dell’Adda e della Mera che compongono l’attuale Provincia di Sondrio sono state per quasi tre secoli, dal 1512 al 1797, sotto il dominio della Libera Repubblica delle Tre Leghe, attuale cantone svizzero dei Grigioni.
E’ tuttora aperta la questione se si trattò di un’occupazione o di un patto di unione disatteso, trasformato di fatto in occupazione.
La sopraggiunta questione religiosa introdotta dalla riforma protestan-te e dalla libertà di culto, ammessa dai Grigioni nel proprio territorio e nei domini d’oltralpe, complicò pesantemente un rapporto di sudditanza mal sopportato da una popolazione vessata dall’arbitrio di amministratori (go-vernatore, commissari e podestà) che avendo comprato all’asta la carica si rifacevano con ammende e con i proventi dalle condanne che comminavano (confische, grazie concesse a pagamento, ecc.).
L’argomento fu certo enfatizzato al punto che la cultura popolare tra-manda tuttora incredibili aneddoti, come quello che vorrebbe sentenziati da un giudice, “nullo il matrimonio, vergine la madre, legittima la prole, con l’aggiunta di una multa per chi avesse sparlato della sentenza”.
Le componenti determinanti per il crescente degrado del rapporto fra dominatori e sudditi furono, senza dubbio, il mancato riconoscimento di parità nelle rappresentanze all’interno degli organi di governo (circostan-za paradossale per uno stato di antica democrazia) e la questione religiosa indotta dalla riforma protestante. D’altra parte l’applicazione delle regole democratiche non era propriamente esemplare nemmeno nella Repubblica delle Tre Leghe essendo sottoposte a pressioni dei maggiorenti, voti di scam-bio, ricatti, corruzione, violenza giunta fino alla costituzione di arbitrari tri-bunali penali contro gli avversari politici e religiosi, come quello che portò a morte sotto tortura l’arciprete di Sondrio Nicolò Rusca, ora Beato, e di molti cittadini d’ambo le confessioni.
La profonda radicazione del cattolicesimo e l’importanza non solo reli-giosa dell’organizzazione cattolica fu un terreno facile per la propaganda controriformistica tanto che la combinazione fra interessi religiosi (o presun-ti tali) e interessi politici delle potenze divennero il terreno ideale per una sanguinosa rivolta denominata, con macabra ironia, “Sacro macello”, che
124
scoppiò il 19 luglio 1620 e nella quale i cattolici uccisero senza pietà, distin-zione di sesso e di età, quanti più protestanti poterono. La rivolta, appoggiata dalla Spagna, si inserisce nel grande quadro delle guerre dei Trent’anni e delle contese territoriali fra le potenze dell’epoca. Valtellina e Valchiavenna rivestivano in quel contesto una grande importan-za strategica per i transiti alpini, trovandosi con la Spagna verso Ovest alla confluenza fra le due valli alla sommità del Lago di Como; i Grigioni, alleati dei Francesi, a Nord; l’impero austriaco a Nord-Est; la potente Repubblica di Venezia a Sud. Il pericolo di una iniziativa che portasse allo scontro fra potenze cattoliche preoccupava il papa la cui diplomazia seguiva con ap-prensione gli eventi.
La rivolta ebbe come esito un periodo di autogoverno sostenuto dalla Spagna che durò quasi vent’anni, poi caduto l’interesse strategico le potenze si accordarono per un ritorno delle due valli ai Grigioni, sia pure con accordi che prevedevano per le terre suddite la sola religione cattolica e il divieto di residenza per i protestanti.
Tutti i tentativi di costituire le due valli in cantone o in quarta lega annes-sa alla Repubblica Reta (le Tre leghe) non ebbero seguito né allora né succes-sivamente. Ci volle Napoleone che nel 1797, benché convinto che le due valli dovessero essere annesse ai Grigioni e con essi alla Confederazione Elvetica, di fronte al mancato rispetto dei termini temporali da lui fissati per le deci-sioni delle Leghe, che per giunta gli chiedevano ancora tempo per decidere, persa la pazienza, decretò motu proprio di assegnare Valtellina e contadi alla Cisalpina. Le richieste valtellinesi di mantenere un proprio statuto di parti-colare autonomia anche nel nuovo stato (religione cattolica unica ammessa compresa) non vennero tenute in alcun conto. Da allora le valli hanno segui-to la storia della Lombardia.
Le vicende politiche hanno sempre influito relativamente sui commerci, soprattutto su quello del vino, per secoli prodotto base dell’economia delle valli esportato largamente nel Grigioni. A soffrirne sono stati i rapporti cul-turali, sia a causa della crescente importanza linguistica del tedesco per il Cantone Grigioni, sia per i timori di contaminazione in ambito religioso, sia per la gravitazione politica ed economica verso la Svizzera interna.
Nel 1997, ricorrendo i 200 anni dal distacco della Valtellina e delle ex con-tee di Bormio e di Chiavenna dai Grigioni, il Museo Etnografico Tiranese si propose al Governo cantonale e alla Provincia di Sondrio quale riferimento organizzativo di un programma di manifestazioni culturali che, all’insegna dei due secoli di buon vicinato trascorsi, permettesse di fare punto sullo stato dei rapporti, di realizzare uno spettacolo che mettesse in scena aspetti della storia comune dei due territori, di organizzare un convegno storico che co-
125
stituisse un momento di approfondimento comune, ponendo in dialogo, at-traverso la traduzione dei testi, due storiografie sostanzialmente sconosciute l’una all’altra per la diversità della lingua.
E’ in questo ambito che mi sono occupato della “Indagine sui rapporti culturali fra il Cantone dei Grigioni e le ex contee di Bormio e Chiavenna” nel periodo 1859-1997, vale a dire di buona parte dei due secoli di buon vici-nato argomento della manifestazione.
L’indagine, che è strutturata come un diario, elenca gli avvenimenti sus-seguitisi nel periodo riferendoli in estrema sintesi. 1
Se dopo il distacco i rapporti culturali “ufficiali” erano sopiti o inesistenti (quelli economici a corto raggio erano continuati senza problemi o quasi), un convinto rilancio inizierà nell’ultimo decennio dell’Ottocento con reci-proci scambi di visite di delegazioni di società operaie e bande musicali. Vi contribuì anche il poeta chiavennasco Giovanni Bertacchi nelle cui opere i riferimenti alla “Libera Elvezia” e al patrimonio culturale comune delle valli lombarde e svizzere-italiane sono ricorrenti.
Nel 1921 le menti migliori delle due valli daranno vita alla Società Storica Valtellinese che, inevitabilmente, si farà carico degli antichi legami italo-sviz-zeri e della necessità di instaurarne di nuovi. Non a caso nel 1941 il secondo libro della sua collana di studi storici riguarderà un letterato poschiavino del Seicento, Paganino Gaudenzio.
Un momento privilegiato per la reciproca conoscenza e per i rapporti istaurati fu il travagliato periodo della guerra 1943-45 quando nell’ospitale Svizzera trovarono rifugio molti antifascisti, sbandati dell’esercito dopo l’8 settembre e molti ebrei.
Nel 1931 era nata a Coira, per iniziativa della PGI, la rivista “Quaderni del Grigione Italiano” fondata dal prof. Arnoldo Marcelliano Zendralli, che andava ampliando i suoi interessi anche oltre confine, acquisendo collabora-tori e lettori anche in provincia di Sondrio.
Nel dopoguerra i rapporti fra le valli confinanti (Valtellina e Valchiaven-na da un lato, Valle di Poschiavo e Val Bregaglia dall’altro) si intensificarono ad opera di gruppi spontanei con singole iniziative estemporanee. Fra esse, nel 1960, la fondazione dell’Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro, un florido borgo della Val Bregaglia italiana sommerso da una frana nel 1618, fondato anche con l’intento dichiarato di “rinsaldare i vincoli di amicizia,
1 Valtellina/Valchiavenna e Grigioni 1859-1997. Indagine sui rapporti culturali fra il Cantone dei Grigioni, la Valtellina e le ex contee di Bormio e Chiavenna a cura di Bruno Ciapponi Landi, Sondrio 1997. Il testo si può scaricare dal sito web della Provincia di Sondrio all’indirizzo: http://www.provincia.so.it/ente/storia/grigioni/grigioni.html
126
comprensione e pace fra i popoli d’Italia e di Svizzera”. Il crescente interesse delle associazioni culturali dei due territori per
incontri e scambi di iniziative, la nascita in Svizzera di associazioni fra gli emigrati valtellinesi e valchiavennaschi, l’ovvia opportunità di conoscersi fra responsabili amministrativi e politici dei due territori, furono le premesse che indussero nel 1977 la Provincia di Sondrio a indirizzare al Governo can-tonale una lettera in cui si auspicava un incontro fra le due istituzioni.
L’incontro ebbe luogo l’anno stesso e venne di fatto istituzionalizzato con successivi incontri annuali alternando le sedi fra Italia e Svizzera. Tre anni dopo, nel 1980, furono organizzate le “Settimane Valtellinesi di Coira”, una iniziativa che vide ristoranti e alberghi della capitale del Grigioni proporre menù con piatti e vini delle nostre valli, le vetrine del centro esporre i pro-dotti tipici, le sale mostre ospitare una esposizione rappresentativa dell’arte contemporanea di artisti della Provincia Sondrio ed una mostra fotografica di opere di artisti del passato operanti nei due territori.
Un momento significativo della manifestazione fu l’arrivo a Coira di un treno speciale della Ferrovia del Bernina (ora nella lista del patrimonio dell’Umanità) con un’ampia delegazione politica e numerose società filar-moniche che per una notte animarono ogni angolo della città.
Non c’è dubbio che l’iniziativa ebbe un forte effetto, a tutti i livelli, sui rapporti con un incremento degli scambi soprattutto nelle valli confinanti, con l’organizzazione di conferenze, convegni, mostre e concorsi d’arte, ricer-che e pubblicazioni. Importante fu l’effetto sulle diverse realtà e istituzioni interessate che promossero a loro volta iniziative, dal Lions Club, ai sodalizi di ricerca storici, linguistici, etnografici, ai musei e ai parchi.
Diverse iniziative furono realizzate con l’apporto della Pro Grigioni Ita-liano, il sodalizio istituzionale che sostiene la cultura italiana nel Grigioni che, nel 1991, organizzò a Poschiavo un convegno intitolato “Grigioni, Tici-no, Valtellina e Lombardia fra presente e futuro” promosso d’intesa con la Provincia di Sondrio, con il patronato del Consiglio d’Europa, dei Cantoni Ticino e Grigioni e della Regione Lombardia, che coinvolse anche le scuole dei due territori.
Valtellina e Valchiavenna furono coinvolte in tutte le manifestazioni più significative, a cominciare dal 700° di fondazione della Confederazione che diede occasione alla pubblicazione di un numero speciale dei Quaderni del Grigioni Italiano intitolato “Rezia antica e moderna dall’Adda al Reno”, un modo nemmeno troppo nascosto per sottolineare l’interesse per la propria storia, rispetto a quella della Svizzera in cui il Grigioni era entrato a far parte come cantone solo nel 1803.
Sono numerose, spesso importanti e non limitate al solo ambito locale,
127
le iniziative artistiche promosse in collaborazione, soprattutto per iniziativa del Museo Etnografico Tiranese, che ha sempre considerato la cura dei rap-porti transfrontalieri uno dei suoi compiti primari.
Sulla scorta di ciò nel 1996 il museo elaborò - come s’è accennato - un programma di iniziative da organizzarsi l’anno seguente in occasione del 200° dal distacco delle valli dell’Adda e della Mera dai Grigioni inteso a va-lorizzare i due secoli di buon vicinato intercorsi dal distacco e lo propose alla Provincia perché se ne facesse promotrice. L’ente fece proprio il progetto e costituì per la sua gestione, che affidò al museo, una apposita commissione di rappresentanti di enti e istituzioni e di esperti.
L’indagine sui rapporti 1859-1997 venne realizzata per fornire una docu-mentazione per la commissione e quindi non riporta le iniziative successive, a cominciare da quelle derivate dalla sua attività. Chi la volesse consultare in rete (l’indirizzo web è riportato alla nota 1), vi troverà, oltre agli eventi in successione, la possibilità di approfondimenti e di contestualizzazione oltre alle schede biografiche delle persone che ebbero un ruolo significativo nello sviluppo dei rapporti, la bibliografia e l’emerografia.
Quello che segue è un aggiornamento dell’indagine dal 1997 ai giorni nostri.
Ottenuti i necessari finanziamenti (fra i quali 100.000 franchi stanziati dal Cantone) si procedette alla realizzazione del programma denominato “1797 – 1997 Provincia di Sondrio e Cantone Grigioni due secoli di buon vicinato” coordinato da un comitato promotore composto da personalità rappresen-tative dei due territori e da operatori fra i più attivi dei rapporti culturali e dello stesso programma. La coralità degli intenti e l’importanza conferita alla manifestazione sono testimoniate anche dall’adesione degli enti e istituzioni a vario titolo coinvolti.
Come si è detto il programma prevedeva la produzione dello spettacolo teatrale che fu affidata al regista grigione Gian Gianotti che si avvalse di una compagnia teatrale sondriese. Lo spettacolo, intitolato “Confini e no”, andò in scena a Coira, a Sondrio con tre repliche e in un’altra decina di località della provincia di Sondrio, del Grigioni e a Milano. Fu anche ripreso dalla Televisione della Svizzera Italiana che la mandò in onda.
Nell’ambito della manifestazione furono realizzate numerose iniziative, fra cui la ristampa degli Statuti di Valtellina2, l’annullo con il logo della ma-nifestazione di tutta la posta in partenza dagli uffici della Provincia, fu co-niata una medaglia commemorativa, venne riallestita a Tirano una mostra di
2 L’iniziativa si è concretata nella pubblicazione del libro “Li Magnifici Signori delle e Tre Eccelse Leghe”. Gli statuti di Valtellina e ordinamenti nel periodo grigione, a cura di Diego Zoia, Sondrio 1997.
128
artisti ticinesi attivi in Ticino e in Valtellina3. La rivista “Contract” della ditta Pezzini di Morbegno (diffusione 40.000 copie), dedicò un intero numero alla manifestazione e la Fondazione Credito Valtellinese pubblicò nella sua col-lana storica un importante saggio sulle vicende che portarono al distacco.4
Le manifestazioni ebbero ampia eco sulla stampa e diedero luogo a nu-merosi servizi e interviste radio e televisive e ad uno speciale programma di due ore trasmesso da Livigno dalla 2a Rete della Radio della Svizzera Italiana.
L’aspetto più qualificante del programma fu senza dubbio rappresentato dal convegno “La fine del governo grigione in Valtellina e contadi: presup-posti, modi ed effetti” che coinvolse i sodalizi di studi storici dei due territori (Società storica valtellinese, Centro studi storici valchiavennaschi, Società per la ricerca sulla cultura grigione e Società storica grigione) con il coordi-namento scientifico del prof. Guglielmo Scaramellini dell’Università di Mi-lano e del dott. Georg Jäger della Società per la ricerca sulla cultura Grigione. Il convegno si svolse in tre giornate, il 26, 27 e 28 settembre 1997, a Sondrio, Chiavenna e a Tirano, dove fu anche allestita una mostra con i documenti di particolare interesse per il periodo della dominazione grigione conservati nell’archivio storico comunale.
Venne anche attivato un gruppo di studio sulla storia dei rapporti Val-tellina, Valchiavenna e Grigioni che raccolse anche le esperienze dei coor-dinatori delle manifestazioni artistiche italo svizzere più significative. In particolare vennero realizzati: “Progetto S. Remigio” e Gruppo di Studio “S. Perpetua” sul tema dell’intervento artistico contemporaneo nelle chiese del passato; “Linea Retica” e “Carte incise/segni nella storia”, collettive itine-ranti di grafica a tema con la partecipazione di incisori e poeti.
Negli intenti degli ideatori il convegno, opportunamente preparato e co-ordinato fino alla pubblicazione degli atti, doveva rappresentare un even-to nella storiografia dei due territori, un’occasione di approfondimento da parte di ciascuno e di confronto, facilitato (o addirittura reso possibile) dalle traduzioni previste dei testi avendo accertato che la diversità della lingua costituiva la causa maggiore nella reciproca difficoltà di informazione.
Gli atti, che videro le stampe nel 2001 in una edizione bilingue curata da Georg Jäger e Guglielmo Scaramellini5, tennero fede a quanto ci si aspettava dalla loro pubblicazione e costituiscono una pietra miliare nella storiografia
3 I Righini di Bedigliora. La storia di una famiglia di pittori dal Ticino a Tirano e Valposchiavo.4 S. Massera, Napoleone Bonaparte e i valtellinesi. Breve storia di una grande illusione, Sondrio 1997, p. 240.5 La fine del governo grigione in Valtellina e nei contadi di Chiavenna e Bormio 1797 (p. 153) / Das Ende der
Bündner Herrschaft im Veltlin und in den Grafschaften Chiavenna und Bormio 1797, a cura di G. Jäger e G. Sca-ramellini, Sondrio 2001, p. 137. Edizione congiunta della Società storica valtellinese, del Centro di studi storici valchiavennaschi, della Società storica grigione e della Società per la ricerca sulla cultura grigione.
129
dell’antica Repubblica delle Tre Leghe e dei suoi domini d’oltralpe.A quel momento di particolare animazione seguirono anni segnati dal
diradarsi delle iniziative ufficiali di contatto, quando non da regressi, quanto meno significativi, come la cessazione delle due rubriche di informazione sulle iniziative culturali del Ticino e della provincia di Sondrio, pubblicate sui Quaderni del Grigioni Italiano decretata da quella redazione, dalla so-spensione degli incontri tra Governo cantonale e Giunta provinciale fino al tentativo di una associazione sostenuta dalla parrocchia cattolica di Brusio di impossessarsi della millenaria chiesetta di san Romedio/ Romerio/ Remi-gio, ab immemorabili legata al santuario della Madonna di Tirano. La chiesa, che è in territorio svizzero ma di proprietà del Comune di Tirano, è un luogo di grande significato anche per la sua alta potenzialità ecumenica, essendo precedente alla Riforma. E’ vero che il maldestro tentativo non trovò alcun sostegno a livello locale e ancor meno da parte della diocesi di Coira, ma è pur sempre un sintomo di un rapporto che meriterebbe di essere rilanciato e sottratto alle derive nel comune interesse delle popolazioni coinvolte.
Le iniziative di contatto fra i due territori hanno da sempre nelle due città confinanti, di Chiavenna e di Tirano, i due poli operativi naturali, condizione che negli ultimi tempi ha fatto registrare un forte vantaggio di Tirano per la sua condizione di capolinea ferroviario della Milano-Tirano e della Tirano-St. Moritz.
Deriva da questa condizione il momento di particolare unità d’intenti fra la Valle di Poschiavo e la Valtellina che si ebbe nel 2004 quando la Ferrovia Retica decise di candidare la sola linea dell’Albula per l’iscrizione nella Lista del patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, escludendo quella del Bernina (Tirano-St.Moritz). La disponibilità italiana e l’impegno delle autorità valtel-linesi, sollecitato dalle autorità poschiavine, ben consapevoli dell’interesse in gioco, ebbero la meglio e la candidatura, non solo incluse la tratta del Bernina in territorio svizzero, ma si estese anche al tratto italiano di poco più di un paio di chilometri di strada ferrata che hanno reso la stazione di Tirano capolinea italiano della celebre ferrovia turistica, dal 2008 entrata a far parte del patrimonio dell’Umanità.6
Con lo stesso spirito nel 2010 furono festeggiati anche a Tirano, con l’in-tervento delle autorità provinciali, regionali e nazionali, i 100 anni della Fer-rovia del Bernina con varie manifestazioni, fra le quali mostre d‘arte, inizia-tive filateliche e concerti.
Un’iniziativa di particolare interesse fu organizzata nel 2009 (fra l’ingres-
6 La candidatura della Ferrovia Retica nel paesaggio culturale Ambula/Bernina per il Patrimonio Mondiale UNESCO, che fu formalmente consegnata a Parigi il 21.12.2006, venne accolta nel 2008. Approfondimenti in rete sul sito http://www.rhb.ch/Il-Patrimonio-mondiale.1070.0.html?&L=1
130
so nel patrimonio Unesco e i festeggiamenti del centenario) nell’ambito della “Convenzione delle Alpi”. Si trattò di un convegno internazionale dedica-to alla promozione locale della Dichiarazione “Popolazione e cultura” della Convenzione stessa, intitolato: “Paesaggi senza frontiere. Opportunità per lo spazio economico, sociale e demografico delle Alpi” che si tenne a Tirano e a Poschiavo il 13 e il 14 febbraio 2009. In tale occasione Tirano fu anche sede della 3° riunione del Gruppo di lavoro “Patrimonio Mondiale Unesco” della Convenzione delle Alpi. Attualmente va segnalato un regresso (numerico e qualitativo) nelle iniziative un tempo frequenti con la PGI, in particolare con la sezione valposchiavina, la cui sala mostre di Poschiavo fu sede di collaborazioni di ampio respiro in ambito artistico. Non è invece mai venuta meno l’attenzione che da sempre riserva alla provincia di Sondrio la Radio-televisione svizzera, in particolare la radio, con il suo programma “Voci del Grigioni Italiano” (che, fra l’altro, è il magasin d’informazione più longevo del mondo).
Ottima si è rivelata una recente iniziativa di cui è stata promotrice la So-cietà Storica Val Poschiavo intesa a celebrare con un nuovo convegno storico la ricorrenza dei 500 anni dall’inizio del dominio grigione sulla Valtellina e i contadi. Superata una certa ritrosia iniziale indotta dalla convinzione che poco o nulla di nuovo ci fosse da dire sull’argomento e soprattutto dalla scarsità dei mezzi economici, grazie alla tenacia dei responsabili della società proponente e alla loro capacità di reperire le risorse occorrenti, è stato possi-bile organizzare il convegno che si è tenuto il 22 e 23 giugno 2012 a Tirano e a Poschiavo7.
Aggiungo che, cosa quasi incredibile, gli organizzatori sono riusciti a pubblicare gli atti curati da Augusta Corbellini e Florian Hitz8, nello stesso anno in cui si è celebrato il convegno e a presentarli ufficialmente a Coira il 20 novembre 2012 e Sondrio il 18 gennaio scorso.
La pubblicazione ha dato modo al prof. Guglielmo Scaramellini, al quale erano state affidate le conclusioni finali del convegno, di pubblicarne una versione ridotta con l’eloquente titolo di “Considerazioni su un convegno fondamentale per la storiografia retica”. Una trattazione più ampia e docu-mentata sarà pubblicata sui Bollettini della Società Storica Valtellinese e del Grigioni.
Il “buon vicinato” continua, con momenti di maggiore o minore consa-pevolezza e intensità, ma continua, anche grazie all’opera di associazioni
7 La documentazione sul convegno è reperibile sul sito web http://www.ssvp.ch/index.php/it/presentazione2
8 1512 I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna/ Die Bündner im Veltlin, in Bormio und in Chiavenna, Atti del Convegno storico (Tirano e Poschiavo, 22 e 23 giugno 2012), Sondrio- Poschiavo 2012, p. 270.
131
come la “Grytzko Mascioni” che nel nome del narratore, poeta, saggista e drammaturgo italo/italo-svizzero (come amava definirsi), probabilmente la voce più alta che in tali campi si sia levata dalle nostre valli, prosegue il suo impegno per il superamento delle barriere e dei confini ovunque si trovino.
Appendice
Commissione dei rappresentanti di enti e istituzioni e di esperti che nel 1996 ebbero l’incarico di organizzare, assieme al Museo Etnografico Tiranese, un programma per celebrare nell’an-no seguente il 200° dal distacco delle valli dell’Adda e della Mera dai Grigioni: Provincia di Sondrio, Società Storica Valtellinese, Centro Studi Storici Valchiavennaschi, Società Economica Valtellinese, Pro Grigioni Italiano, Società per la ricerca sulla cultura Grigione, Società Cultu-rale di Bregaglia, Ispettore scolastico del Grigioni. In qualità di esperti: ins. Dario Monigatti, vice parlamentare dei Grigioni di Brusio, professori Giulio Spini di Morbegno e Guglielmo Scaramellini di Chiavenna, dott. Paolo Raineri di Milano ed il sottoscritto.
Membri del Comitato promotore dell’iniziativa “1797 – 1997 Provincia di Sondrio e Cantone Grigioni due secoli di buon vicinato”: Enrico Dioli presidente della Provincia di Sondrio, Pietro Biavaschi assessore della Provincia di Sondrio, Cristian Brosi rappresentante del Cantone dei Grigioni, prof. Laura Meli Bassi presidente della Società Storica Valtellinese, don Tarcisio Salice presidente del Centro di Studi Storici Valchiavennaschi, Rodolfo Fasani segretario centrale del-la Pro Grigioni Italiano, dr. Massimo Lardi redattore dei “Quaderni grigionitaliani”, dr. Georg Jäger segretario della Società per la ricerca sulla cultura grigione, m.° Gustavo Lardi ispettore scolastico di Poschiavo, m.° Dario Monigatti vice parlamentare dei Grigioni, m.° Gianandrea Walther della Società Culturale di Bregaglia, prof. Guglielmo Scaramellini Università degli Stu-di di Milano, dr. Paolo Raineri consigliere Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, dr. Mauro Rovaris del Museo Etnografico Tiranese, dr.ssa Bianca Bianchini dirigente del settore Cultura della Provincia di Sondrio, ins. Bruno Ciapponi Landi responsabile organizzativo.
Enti e istituzioni coinvolti a vario titolo nell’iniziativa dal titolo “1797 – 1997 Provincia di Son-drio e Cantone Grigioni due secoli di buon vicinato”: Amministrazione Provinciale di Sondrio, Governo del Cantone Grigioni, Comunità Montane di Valtellina e della Valchiavenna, Regioni della Valle di Poschiavo e della Val Bregaglia, Comuni di Tirano e di Chiavenna, Pro Grigioni Italiano, Società per la ricerca sulla cultura grigione, Società Storica Valtellinese e quella del Grigioni, Centro Studi Storici Valchiavennaschi, Società Storica della Valle di Poschiavo, Socie-tà Culturale di Bregaglia, associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro, Archivio di Stato di Sondrio, Archivio Cantonale Coira, Museo Etnografico Tiranese,Università della Terza Età di Tirano, Biblioteca della Montagna di Tirano, compagnia teatrale Gente Assurda, Fondazione CARIPLO, Banca Popolare di Sondrio, Gruppo Bancario Credito Valtellinese.
Apporti e collaborazioni per il convegno storico promosso dalla Società Storica Val Poschiavo tenutosi il 22 e 23 giugno 2012 a Tirano e a Poschiavo per celebrare la ricorrenza dei 500 anni dall’inizio del dominio grigione sulla Valtellina e i contadi: Istituto grigione per la ricerca sto-rica, Società storica Valtellinese, di Valposchiavo e dei Grigioni, Centri di studi storici valchia-vennaschi e Alta Valtellina, Associazione Ad Fontes. Contributi di: Banca Cantonale Grigione, Banca Popolare di Sondrio, Comuni di Brusio di Poschiavo, Bim dell’Adda e Mera, Fondazioni Pro Valtellina, Credito Valtellinese, Winterhalter, Muntwyler, della Kulturförderung Graubün-den e della Provincia di Sondrio.
133
Roberto FantoniAttilio Ferla
LA FRUIZIONE DI UN COLLE ALPINODAL TARDO MEDIOEVO AL NUOVO MILLENNIO:
IL COLLE VALDOBBIA (ALPI CENTRO-OCCIDENTALI)
Sommario: 1. Introduzione. 2. Due comunità unite da un colle. 3. Un colle per il commercio. 4. Una via per la peste. 5. Un colle per gli emigranti. 6. Un ospizio per gli emigranti. 7. Un ospizio per la scienza. 8. Un rifugio per gli escursionisti. 9. Crinali e passi delle Alpi
1. Introduzione
Il colle di Valdobbia è ubicato lungo i contrafforti meridionali del Monte Rosa, a 2480 metri di quota, tra la val Vogna, confluente nel Sesia a Riva Val-dobbia (1112 m), e la val Dobbia, tributaria della valle del Lys presso Gresso-ney St Jean (1385 m). Il passo non unisce i due lati delle Alpi ma consente la comunicazione tra due sistemi di valli laterali ubicati sul versante meridio-nale dell’imponente massiccio alpino (fig. 1).
Il colle è stato ripetutamente celebrato nella letteratura locale, soprattutto per l’esistenza di un ospizio fondato nei primi decenni dell’Ottocento. La fa-cile accessibilità del passo ha favorito i rapporti tra le due comunità ubicate alla base dei suoi versanti e ha sempre costituito un elemento di rilievo per la storia valsesiana. Attraverso l’analisi dettagliata dell’ampia documentazione disponibile in diversi archivi locali questo lavoro propone una ricostruzione della diversa fruizione del colle dal tardo-Medioevo al nuovo millennio da parte delle popolazioni locali.
2. Due comunità unite da un colle
La colonizzazione della val Vogna, confluente nel Sesia a Riva Valdobbia, avvenne ad opera di coloni walser di origine gressonara, documentati alla frazione Peccia nei primi decenni del Trecento1.
Le relazioni genealogiche e i percorsi di colonizzazione sono ricostruibili grazie alla declinazione negli atti notarili del luogo di provenienza, del luogo
1 E. Rizzi, Sulla fondazione di Alagna, in “Boll. St. Prov. No.”, LXXIV, 1983, n. 2.
134
di residenza (quando risultava diverso dal precedente) e della discendenza patrilineare dei soggetti stipulanti. In un documento del 1325 compare un Guiglincinus de la Peccia filius quondam Gualci de Verdobia, località limitrofa a Gressoney St. Jean. Alla Peccia si era trasferita, probabilmente con lo stesso Gualcio di Verdobbia, tutta la sua discendenza. In un documento di pochi anni dopo (1334) si dichiarava habitator Pecie anche Nicolinus flius quondam Gualci de Aput Verdobia, che acquisiva i beni di un altro abitante della Peccia proveniente dalla valle del Lys, Johannes filius quondam Perni Zamponali de Graxoneto (figg. 2-3)2.
La provenienza gressonara è osservabile anche nei segni culturali lasciati da questi coloni. Ad un santo tipicamente aostano, san Grato, è infatti dedi-cato uno degli edifici religiosi della Peccia, documentato sin dalla fine del Quattrocento.
3. Un colle per il commercio
I legami commerciali tra le comunità ubicate alla base dei versanti del colle di Valdobbia furono favoriti anche dalla fiera di Riva, che si svolgeva al termine della stagione d’alpeggio, il giorno di san Michele (29 settembre).
Nelle Alpi occidentali sin dal Trecento sono documentate numerose fiere tra fine agosto e metà ottobre, con una forte concentrazione nei giorni pros-simi alla festa di san Michele3.
La fiera di Riva era già riconosciuta da una concessione del duca Filippo Maria Visconti del 1424 agli uomini di Pietre Gemelle. Nel documento si pre-cisava che la fiera era antica ed era già stata riconosciuta da Giovanni Gale-azzo Visconti; risulta quindi antecedente al 1402, anno della morte del duca. Ma la sua origine è probabilmente più antica. Già nel 1321 era fissata nella festa di san Michele la data per la restituzione di un prestito. Altri contratti dei primi decenni del Trecento sono stipulati super ripam il 29 settembre4. La fiera fu confermata da Francesco Sforza nel 1451 e viene menzionata nel ca-pitolo 26 dei privilegi concessi agli uomini della Valsesia dal duca Francesco
2 R. Fantoni, La Val Vogna (Alta Valsesia). Un insediamento multietnico tardomedievale sul versante meridionale del Monte Rosa, Augusta 2008, pp. 57-62.
3 R. Comba, A. Dal Verme, Allevamento, transumanza e commercio del bestiame nel Piemonte occidentale, in Greggi mandrie e pastori nelle Alpi Occidentali (secoli XII-XX), a cura di R. Comba, A. Dal Verme, I. Naso, Cuneo 1996, pp. 13-31.
4 Briciole di storia patria, manoscritto inedito dell’abate Carestia, sezione di Archivio di Stato di Varallo, Museo Calderini, b. 12, s.d., ma fine Ottocento.
135
Fig. 1.Ubicazione del Colle di Valdobbia.
Fig. 2. I percorsi di colonizzazione della montagna valsesiana in età tardo medievale.
136
II Sforza nel 15235. Un documento del 1669 riporta che alla fiera concorrevano bestiame, mer-
canzie e mercanti da parti lontane, ed in particolare dalla Savoja. L’area d’influen-za doveva essere notevolmente ampia. Sicuramente partecipavano alla fiera gli uomini delle valli aostane limitrofe (Lys e Ayas). A Riva per la fiera di san Michele si recavano anche notai della val d’Ayas (Petrus de Vaserio) che roga-vano atti (1427) tra abitanti di Orsia di Gressoney alla presenza di testimoni di Resy abitanti in Herens, di Orsia e di Ayas6.
4. Una via per la peste
Nel biennio 1628-1629 la peste era diffusa in tutti i paesi d’oltralpe. Nel 1630 la peste raggiunse la val d’Aosta, dove il primo caso documentato risale al 19 aprile 1630. In seguito all’epidemia, secondo la ricostruzione, probabil-mente sovrastimata, di Ansaldo7, la valle passò da 90.000 a 20.000 abitanti, con una perdita di circa 70.000 persone. Mentre il contagio imperversava in val d’Aosta, il colle continuava ad essere frequentato da mercanti ed emi-granti, che portavano soldi, merci e ricordi. Nel 1630, senza saperlo, porta-vano anche qualcos’altro, perché anche le epidemie prendono la via del passo8. La comunità di Riva, ubicata alla base del colle, lungo la principale via di co-municazione con la val d’Aosta, fu la più colpita della Valsesia. La diffusione dell’epidemia è ricostruibile attraverso l’esame dei libri parrocchiali; la mag-giore concentrazione di decessi fu registrata nelle frazioni della val Vogna ubicate immediatamente a valle del colle (Montata e Peccia). I dati dei cen-simenti contenuti negli Atti di Visita pastorale indicano che la popolazione di Riva scese dai mille e dieci abitanti del 1628 ai settecentonovanta del 1641 (fig. 4), con una perdita di duecentoventi unità, un valore prossimo a quello dei morti per peste nel biennio 1630-1631 registrati nei libri parrocchiali9.
5 E. Rizzi, Le fiere medioevali di Macugnaga e di Pietre Gemelle e l’evoluzione dell’economia walser nelle valli del Monte Rosa, in I walser nella storia della cultura materiale alpina, Atti del V convegno internazionale di studi walser (Macugnaga, 3-5 luglio 1987), Anzola d’Ossola 1988, pp. 231-271.
6 R. Fantoni, A. Ferla, La fiera di San Michele a Riva, in La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione, Atti della XXI edizione degli “Incontri tra/montani”, a cura di R. Fantoni, S. Del Bello, G. Maculotti, J. Ragozzi, Carcoforo 2011, pp. 273-280.
7 M. Ansaldo, Peste, fame, guerra. Cronache di vita valdostana del XVII secolo, Aosta 1977, p. 348.8 E. Neubronner, La Valle Nera. Genti del Piemonte. Un approccio, Magenta 1999, pp. 239.9 R. Fantoni, A. Ferla, A. Negro, E. Zanoletti, 1630, Colle di Valdobbia: una via per la peste, in “Notiziario
CAI Varallo”, 20, 2006, pp. 61-64; anche in Augusta 2009, pp. 41-48 e in La Montagna attraversata: pellegrini, soldati e mercanti, Atti del convegno (Bard 16-17 settembre 2006), a cura di R. Fantoni e M. Spotorno, 2010, pp. 55-67.
137
Fig. 3. La discendenza di Gualcio di Verdobbia (Gressoney) alla Peccia (Val Vogna, Riva) durante il Tre-cento.
Fig. 4. Andamento della popolazione di Riva nel Seicento (Archivio Storico Parrocchia di Riva, Atti di battesimo, Status animarum).
138
5. Un colle per gli emigranti
Nel corso del Cinquecento si può collocare il debutto dell’emigrazione valsesiana di massa.
Un indice sensibile al fenomeno migratorio è offerto dalla stagionalità delle nascite: negli insediamenti caratterizzati da migrazione stagionale con rientro a dicembre-gennaio (caso diffuso in Valsesia) si verificava, infatti, una forte natalità nei mesi di settembre-ottobre (fig. 5). Un forte incremento delle nascite a partire dall’ultimo decennio del Cinquecento è descritto per Alagna da Viazzo10. La percentuale delle nascite registrate ad Alagna nel periodo autunnale (nove mesi dopo il periodo di rientro degli emigranti) aumentava sensibilmente negli ultimi decenni del Cinquecento, passando in pochi anni da valori prossimi alla norma (41.6%) a valori superiori al 60%. Una confer-ma qualitativa a questa fonte viene dal Giordani11, il quale riteneva che gli Alagnesi avessero iniziato ad emigrare verso il Seicento. Questa percentuale si mantiene poi elevata, anche se con notevoli oscillazioni, sino alla metà dell’Ottocento (fig. 6). Valori simili sono state calcolati per Rima, su serie più limitate nel tempo (1683-1899), da Axerio12. Un andamento analogo presenta anche la distribuzione mensile delle nascite a Riva13.
I valsesiani, dediti prevalentemente ad attività del settore edilizio come impresari, architetti, gessatori, muratori, piccapietre, emigravano soprattut-to in Svizzera e Francia. Per tutti loro il colle di Valdobbia era la via di acces-so alla val d’Aosta, da cui si disperdevano per diverse mete.
Gli emigranti rientravano in Valsesia nel periodo di sospensione dell’at-tività. Il transito per il colle avveniva dunque tra novembre e dicembre (rien-tro in valle) e febbraio-marzo (partenza per il luogo di lavoro). Raggiungere la via del colle era un’impresa spesso pericolosa. Per tutto il Seicento e Set-tecento le disgrazie si susseguirono con un ritmo drammaticamente serrato. Lungo la via del colle trovarono la morte emigranti provenienti da tutti i pae-si dell’alta valle. Trovarono la morte per seppellimento sotto le valanghe, per assideramento nella tormenta lungo la via del colle o, più frequentemente, lungo una via che non saliva al colle.
Il 21 febbraio 1633 Pietro di Fervento morì travolto da una valanga in
10 P. Viazzo, Comunità alpine. Ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo a oggi, Bologna 1999, pp. 427.
11 G. Giordani, La colonia tedesca di Alagna Valsesia e il suo dialetto, Torino 1891; ristampa anastatica, Bologna 1974, pp. 201.
12 M.C. Axerio, Rima e il suo territorio. La “perla della Valsesia” tra natura e storia, Novara 2002, pp. 110.13 R. Fantoni, Pastori orobici sul versante meridionale del Monte Rosa tra Cinquecento e Settecento, in Da
montagna a montagna. Mobilità e migrazioni interne nelle Alpi italiane nei secoli XVII-XIX, Atti del convegno (Macugnaga-Kongresshaus, 5 luglio 2008), a cura di P.P. Viazzo e R. Cerri, Magenta 2009, pp. 130-151.
139
Fig. 5. Distribuzione mensile delle nascite a Riva tra 1555 e 1915 (Archivio Storico Parrocchia di Riva, Atti di battesimo; da R. Fantoni, Pastori orobici).
Fig. 6. Andamento della percentuale di nascite nei mesi compresi tra agosto e dicembre (media mobile a base 10) ad Alagna tra Cinquecento ed inizio Novecento (Archivio Storico Parrocchia di Alagna, Atti di battesimo; da R. Fantoni, Pastori orobici).
140
loco Vardobbia, mentre si stava recando a Gressoney per esercitare la sua arte. Il 27 febbraio 1645 una valanga uccise Antonio Chiaveggia di 20 anni. Il 2 dicembre 1676 sul Monte Vardobia morì Antonio Giacomini di 30 anni. Il 29 febbraio 1677 sulla strada del colle perse la vita Giacomo Rondo di 45 anni di Gressoney. Il 29 ottobre 1678 morì assiderato un certo Antonio di 63 anni. Il 26 novembre 1702 sul Monte Valdobbia morì, nivis rigore, Giacomo Schenobal, che fu seppellito a Riva il 1 dicembre. Il 21 novembre 1709 perì in montibus Vardobia Isaia Molini di 20 anni di Campertogno. Il 22 dicembre 1714 nei pressi dell’alpe Larecchio morì sotto una valanga Giovanni Francesco Mar-chetti di 18 anni, che fu sepolto il 24 dicembre.
Esemplare è la vicenda di Giuseppe Gallinotti della Rusa di Camperto-gno di 40 anni, che il 31 gennaio 1728 morì sotto una valanga in Valdobbia. Il Gallinotti stava rientrando dalla Val d’Aosta, ove esercitava “l’arte di mura-tore”. Non essendo rientrato nel tempo previsto, la moglie pregò Giacomo Antonio di Mollia di portarsi a Gressoney per ottenere informazioni. L’inca-ricato, arrivato sul posto si recò da Michele Graulio, che gli raccontò che il Gallinotti era transitato davanti a casa sua in un giorno in cui era caduta molta neve e, nonostante i consigli del Graulio, si era avviato per il colle. Verso la metà di giugno Giuseppe Maria di Nicola Maria della Grampa di Mollia, passato per il Colle, durante la discesa verso la Valsesia, nel luogo che si dice la Croce Grande, scoprì il corpo del Gallinotti, quale era voce comune esser restato morto circa il fine dello scorso mese di genaro in detta Valdobbia. Lo stesso giorno una valanga scesa lungo il croso Grabo, presso la Peccia, aveva travolto Mi-chele Perello di 50 anni, suo fratello Giacomo di 33 anni, Giovanni Battista Perello di 70 anni e Pietro Nicola Calcia di 17 anni.
Il 14 novembre 1741 morì sotto una valanga Antonio Grandi di Mollia di 77 anni. Nell’aprile 1743 trovarono la morte sulla via del colle Pietro Lob-bietto di Goreto di Campertogno, sua cognata e Caterina Miretta della Rusa di Campertogno, soffocati dal vento impetuoso e dalla neve dal medemo portata ed initirizziti dal freddo. Due croci in ferro con la data 1743 e il moncone della ter-za sono ancora presenti su un masso al Piano del Ciletto. Il 21 gennaio 1746 un uomo morì per assideramento.
Il 4 novembre 1746 Martino Giorgio di Bartolomeo, Antonio Barro Rafael e Pietro Perruca di Vico nella Valle di Brossio, minatori, valicavano il colle per recarsi alle miniere di Alagna. Durante la discesa dal colle, giunti in pros-simità del Ciletto, furono sopra gionti dalla notte. Martino Giorgio a cagione della stanchezza disse di non puoter più andare avanti ed invitò i compagni a proseguire. All’osteria della Montata i due vennero raggiunti da alcune per-sone di Alagna, che raccontarono di aver visto Martino ormai morto nello stesso luogo in cui era stato lasciato.
141
Il 5 febbraio 1758 morì sotto una valanga in Vallis Dobbiae Pietro Giu-seppe Zenone di 26 anni. Talvolta alle salme non si riusciva nemmeno ad assegnare un nome. Il 29 aprile 1768 il servittore di certo Giuseppe Lischio vide al Ciletto un affiorare dalla neve. La ricognizione trovò il cadavere, che per le condizioni fu probabilmente vittima di una valanga; nessuno riuscì a riconoscere la salma14.
6. Un ospizio per gli emigranti
Dopo quattro secoli i rapporti tra le due comunità ubicate sui due lati del colle si erano allentati. Le antiche relazioni parentali non erano state rinnova-te; gli aostani non frequentavano più la fiera di Riva, che aveva perso il suo ruolo centrale nel commercio in questo settore delle Alpi centro-occidentale. Ma le disgrazie che continuavano a ripetersi lungo la strada del colle riuni-rono le due comunità che, di comune accordo, decisero di presidiare il colle. Nel 1787 Gian Giuseppe Liscotz di Gressoney e Giovanni Giuseppe Gianoli di Riva fecero costruire al colle una cappella ed una piccola stalla, realizzata dai maestri muratori Gianbattista Perazio e Giovanni Giacomo Iachetti di Riva. L’intervento si dimostrò però insufficiente. Nel febbraio 1820 i coniugi Giacobino di Riva, valicato il colle si apprestavano a scendere verso Gresso-ney quando furono investiti dalla bufera e si rifugiarono sotto una rupe; la donna morì assiderata e l’uomo, soccorso da altri viaggiatori, perse le dita delle mani15. Questa ennesima tragedia spinse all’azione un personaggio che ebbe un ruolo fondamentale nelle vicende del passo: il canonico Nicolao Sot-tile16, che decise di erigere al colle un ospizio per il ricovero dei viandanti17. I lavori iniziarono nel 1822 e l’anno seguente l’edificio era ultimato Negli anni successivi al corpo originario furono aggiunti anteriormente un ingresso con una cappella a destra e una stalla a sinistra; il piano superiore fu ampliato con una nuova camera sopra la stalla (fig. 7).
Dal 1824 al 1833 l’ospizio rimase aperto nei mesi di novembre-dicembre e marzo, rivelandosi presto utile a salvare vite umane. Il 20 dicembre 1828 una tormenta di neve investì le valli del Monte Rosa; 27 persone che transitavano per il colle si rifugiarono all’ospizio e poterono il giorno seguente riprendere la loro strada per la valle d’Aosta o la Valsesia18.
14 E. Fontana, Inverni valsesiani, Borgosesia 1983, pp. 199; Storie di antichi inverni, Varallo 1991, p. 130.15 G. Lana, Guida ad una gita entro la Vallesesia, ristampa anastatica Bologna 1977, pp. 203-204.16 Sul canonico Sottile cfr. Nicolao Sottile (1751-1832). Il sacerdote l’intellettuale il benefattore, Atti del
convegno (Rossa, 24 agosto 2002), a cura di F. Tonella Regis, Borgosesia 2004, pp. 318.17 A. Orsi, Il Sottile lume dell’ospizio, Borgosesia 2007, p. 176, con bibliografia.18 E. Fontana, Inverni valsesiani, 1983, pp. 183-184.
142
Dopo pochi anni i promotori dell’ospizio si resero conto che per essere ef-ficace l’ospizio doveva essere presidiato e la struttura fu affidata alla gestio-ne di due custodi. La percezione del servizio prestato dall’ospizio è traman-data dalle memorie di un emigrante: in cima all’ospizio che ci dano adallogio e da mangiare ai viandanti senza costo di spesa e se il tempo fosse brutto e pericoloso si puo fermarsi fino a 3 giorni anno dei cani che vengono incontra addomesticati aposta ai viaggiatori sono grossi come vitelli 19.
7. Un ospizio per la scienza
Nella seconda metà dell’Ottocento la montagna si aprì, fisicamente e cul-turalmente, alla ricerca scientifica. Meteorologia e geologia furono i campi di studio più frequentati durante questa scoperta. Negli anni Sessanta -Ottanta del secolo si diffusero in Italia, soprattutto in ambito subalpino, gli osserva-tori meteorologici, con un incremento esponenziale delle rilevazioni di preci-pitazioni e temperature (fig. 8). Nel 1864 fu fondato l’osservatorio di Torino, nel 1870 quello di Vercelli. Negli stessi anni Pietro Calderini ospitava nella sua casa varallese una stazione meteorologica di cui fu osservatore.
Verso la fine del 1870 il teologo Farinetti e l’abate Carestia ipotizzarono la possibilità di insediare un osservatorio meteorologico all’Ospizio Sottile al Colle di Valdobbia, dove i custodi eseguivano rilevazioni estemporanee sin dal 1833, ottenendo l’approvazione di Giacomo Mongini, parroco di Riva e presidente dell’Amministrazione dell’Ospizio. Il Calderini aderì subito all’i-niziativa, aprendo una sottoscrizione pubblica su Il Monte Rosa, per racco-gliere la somma necessaria all’acquisto della strumentazione e l’insediamen-to della stazione. Grazie anche al concorso di diverse sedi del Club Alpino e di alcuni direttori di altre stazioni meteorologiche, ben presto si superarono i 2000 franchi. Il verbale dell’amministrazione del 6 giugno 1871 riferisce che la sottoscrizione per la fondazione di un osservatorio meteorologico aveva dato un inaspettato esito, raggiungendo la cifra di 1800 lire. L’osservatorio fu inaugurato il 1 settembre 187120.
19 Vita di Iosti Giovanni-girovago ambulante, Archivio dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli.
20 P. Calderini, Per la fondazione dell’Osservatorio Meteorologico sul Colle di Valdobbia. Breve discorso del professore Pietro Calderini, Varallo 1872, p. 1; F. Denza, Gli osservatori meteorologici di Valdobbia e di Domodossola, in “Bollettino del Club Alpino Italiano”, vol. V, n. 18, 1871-72, pp. 432-446; Le stazioni meteorologiche stabilite presso alle Alpi ed agli Appennini italiani nell’anno 1873, in “Bollettino del Club Alpino Italiano”, vol. VIII, n. 23, 1874, pp. 358-360; R. Fantoni, R. Cerri, A. Vercellino, Pietro Calderini, Carlo Montanaro e Carlo Regaldi. Un progetto integrato di progresso, scienza e montagna, in Alle origini del Club Alpino, Un progetto integrato di politica, progresso, scienza e montagna, Magenta, in stampa.
143
Fig. 7. L’Ospizio Sottile.
Fig. 8. Misure strumentali in Italia (da M. Brunetti, M. Maugeri, F. Monti. T. Nanni, Temperature and preci-pitation variability in Italy in the last two centuries from homogenized instrumental time series, in “International Journal of Climatology”, 26, 2006, pp. 345-381) e fondazione di alcuni osservatori meteorologici dell’arco alpino (da R. Fantoni, R. Cerri, A. Vercellino, Pietro Calderini).
144
8. Un rifugio per gli escursionisti
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, come testimoniato dall’andamento degli indici demografici (fig. 6), l’emigrazione stagionale si è trasformata in emigrazione permanente. Il colle non venne più attraversato dagli emigranti e l’ospizio perse la sua funzione originaria.
Da metà Novecento la strada del colle è frequentata però da un numero sempre crescente di escursionisti culturalmente attenti21, che percorrono il “sentiero dell’arte” della bassa val Vogna22 e frequentemente raggiungono il colle per pernottare nel vecchio Ospizio, che attualmente unisce al fascino di un edificio storico tutti i pregi di un moderno ed accogliente rifugio.
9. Crinali e passi delle Alpi
In molti testi recenti si è spesso ripetuto, nella convinzione di proporre tesi innovative, che le montagne non separano ma uniscono. L’affermazione non è neanche discutibile se non è riferita ad una particolare modalità di fruizione della montagna.
In relazione al tema del convegno (dedicato a crinali e passi) e all’area analizzata (il versante meridionale del massiccio del Monte Rosa), possiamo constatare che i crinali, almeno in alcuni contesti storici, hanno separato due sistemi di valli; le hanno separate sino a togliere all’uomo la cosa più pre-ziosa che ha: la vita. I passi, se presidiati (soprattutto culturalmente), hanno attenuato questa separazione.
21 R. Fantoni, O. Raiteri, S. Pitto, I sentieri dell’arte sui monti della Valsesia, in Con passo sicuro. Stato dell’arte e nuove proposte per un escursionismo consapevole e sicuro, Atti del convegno (Santa Margherita Ligure 23 ottobre 2010), a cura di L. Costa, F. Faccini, R. Fantoni, CAI Comitato scientifico Ligure–Piemontese e Parco di Portofino, 2010, pp. 17-23; anche in “Notiziario CAI Varallo”, 24, pp. 51-56.
22 A. Ferla, M. Soster, Sentieri dell’arte sui monti della Valsesia. Rimella. Val Vogna. Alta via dei walser (a quota 1500 m), CAI Varallo, Commissione “Montagna Antica, montagna da salvare”, s.d.; R. Fantoni, A. Ferla. e P. Carlesi, Guida ad un’escursione in val Vogna. L’eredità tardo-medievale: allevamento e cerealicoltura in una valle alpina, in La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione, pp. 227-240.
145
Luca Giarelli
LA FRONTIERA DI SAN MARCO:I PASSI ALPINI NELLA VAL CAMONICA
DEL PRIMO SEICENTO
Risalendo lungo lo stretto viottolo che, partendo da Pisogne sul Lago d’Iseo, raggiungeva l’alta Valle Camonica, dopo aver lasciato il territorio di Sonico per addentrarsi in quello di Edolo, nel primo Seicento ci si sarebbe trovati di fronte ad un insolito elemento: un lungo sbarramento che, parten-do dal versante occidentale della vallata, attraversava il fondovalle e il fiume Oglio per poi risalire sulla sponda opposta fino a lambire l’abitato di Mu. Lungo questo restello militare si sarebbero notati alcuni fortilizi a pianta di stella, presidiati sia dalle fedelissime milizie territoriali della Serenissima Re-pubblica di Venezia, che da una variegata guarnigione di soldati esteri. Detta muraglia rappresentava l’estrema difesa del nord Italia davanti ad un’even-tuale invasione proveniente dalla Valtellina, territorio trafficato da Spagnoli e Grigioni ed inserito nel turbinio degli eventi contestuali alla Guerra dei Trent’anni. Un esemplificativo elenco della consistenza delle truppe e dei nomi dei graduati per gli anni 1636-1637 si trova nella Notta delli capitani, et numero de loro fanti ch’hanno servito nella Valcamonica per il tempo et nelli mesi infrascritti, tratta dalla cancelleria dell’Illustrissimo Signor Sebastian Venier Prov-veditore di essa valle1.
La barriera di Edolo, di cui rimane un pregevole disegno del 16352, venne descritta in questi termini da Gio’ Batista di Apolone nominato il Fortuna il 5 ottobre nel 1627 in un libretto conservato nell’Archivio di Stato di Brescia3: il sito di Edolo, considerato bene, lo stimo io tanto quanto stimo Palma Nova, il Covel, la Chiusa, Crema, Forzzi Novi, il Forte di Fuentes e molte altre fortezze poste alle frontiere come la Roca Danf e altre che per brevità tralassio.
Di questo Giovanni Battista Apollonio sappiamo che era originario di Vico frazione di Edolo ed era il fratello maggiore del celebre notaio Martino Apollonio, che ricoprì numerose cariche nel paese dell’alta Valle Camonica. A differenza del parente non si hanno molte notizie di Giovanni, se non che nacque nel 1581 da Giovanni Giacomo Apollonio e Cristina Serotti, figlia di
1 Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, b. 165 fasc. 1. Nella lista si legge di combattenti di origine francese, corsa, albanese od oltramontana.
2 Dissegno del sito e fortificacioni vicino a Edolo in Valchemonica. All’Illustrissimo Signor Sebastian Venier Provveditore in detta Valle anno 1635, ASV, Raccolta Terkuz, dis. 102.
3 ASBr, Martinengo dalle Palle 382, m.1 n.1, Apolone Gio Batta, Passi dalla Valcamonica alla Valtellina 1627 ms.
146
un altro illustre notaio e cancelliere di Edolo, Andrea Serotti, e da adulto ebbe due figli. Di lui però non si hanno più notizie dopo l’anno 1630. Inter-pretando alcuni passaggi del manoscritto sembra di intuire una sua possibile posizione militare: me dette ordine con mandato di comandare doi cento guasta-dori4.
Ma torniamo al manoscritto, che l’autore camuno dedicò Al Illustrissimo Signor Giovanni Martinenghi, mio Signore e Padron Colendissimo. Esso contiene un’interessantissima collezione d’informazioni riguardanti le vie di collega-mento che legavano anticamente la Valle Camonica ai territori esteri circo-stanti: la vallata infatti, a quel tempo Terra Separata del distretto di Brescia, confinava sia a meridione che a occidente con la Terraferma Veneta, ma a settentrione e a oriente con importanti stati quali lo Stato Libero delle Tre Leghe e il Principato Vescovile di Trento.
Da tempo era desiderio di Giovanni Battista Apollonio mettere per iscrit-to le sue congetture, come confessa nelle prime righe: Sono scorssi anni e mesi, Illustrissimo mio Signore, che havevo stabilito di far un libretto compagnato con un disegno de tutti i passi che stransitano dalla Valcamonica nella Valtellina con la notitia di tempi che si possono transitare essi passi. Un’opera non solo descritti-va, ma anche animata dal proposito di segnalare alcune criticità strategiche all’amatissima patria, poiché con grant raggione la Serenissima Repubblica si è mossa per il mantenimento della Libertà della Patria, perché l bello giardino della Italia è portato in gelosia di amanti che lo vorebbe in suo dominio.
Dopo una breve introduzione dedicata alle chiavi estere (Pos-chiavo e Chia-venna) che, se girate, avrebbero permesso agli invasori d’entrare nel bel giardino d’Italia, l’autore focalizza l’attenzione sull’estremo confine del nord della Dominante, la Valle Camonica, che ai suoi occhi mi si rapresenta la Valca-monica come un arboro la quale il tronco è del Cidegolo in zoso e dal Cidegolo in suso siano i rami come qui: [Immagine, nda] Al Cidegolo aman destra vi el Passo che va verso Levante nel Trentino, ciove alla Terra de Davone in Val Rendena. Il Passo di Tonale nel Trentino. Il passo di Val Ombrina nel Trentino. Il Passo di Gavia a Bormio. Il Passo della Val di Vezza a Sondalo in Valtellina. Il Passo di Mortirolo. Il Passo de Mola - non è da considerazione. Il Passo di Piatolta, principale alli altri. Il Passo di Zapelli de Averigha. Il Passo alla Valle di Paisco. A uno per uno mostrarò il modo e tempo che si usano essi passi.
Con dovizia quindi l’Apollonio inizia a descrivere, da est a ovest, tutti i valichi verso gli stati esteri.
Il primo della lista è l’attuale Passo di Campo (2.288 metri s.l.m.) che dal-
4 G. Gasparotti, Vicende storiche del piccolo paese di Vico in va1 di Corteno, Esine 1987, pp. 82, 90-92 e L. Leonardo, Edolo e i passi dell’alta Valcamonica in una relazione del 1627, in “Commentari dell’Ateneo di Brescia”, 1988, p. 114.
147
la valle del Lago d’Arno conduce alle sorgenti del Chiese in Trentino, allora Principato Vescovile di Trento.
1. Il Passo della Valle de Savior, si usa in tempo che non vi siano nevi dificile e de pedoni e de animali, si va in sei hore dal Cidegolo a Davone in Val Rendena, del Trentino ma non è usato perché è una strada molto cativa e pessima pericolosa da falare.
Il secondo valico è il Passo del Tonale (1.883 metri s.l.m.) che lega la Pon-te di Legno in Valle Camonica a Vermiglio nella trentina Valle di Sole. Esso è ancora oggi uno dei principali collegamenti alpini ed è attraversato dalla Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola. Di notevole interesse è la de-scrizione delle lezole, slitte trainate da buoi che permettevano di spazzare la strada dalle nevi permettendo il transito anche d’inverno.
2. Il Passo del Tonale ciove a Ponte di Legno caminando verso matina miglia cin-que fino alla somita della montagna dove apresso alla confine della banda del Trenti-no vi è una ostaria [del cardinal di Trento] e poi si cala per altri miglia cinque alla prima terra del Trentino detta Vermej. Si tiene aperta la montagna benche vi siano nevi grandi per causa delle mercantie che giornalmente transita per Elemagna ma-sime le panine Bergamasche per le quatro fiere di Bolzano, la fiera di San Giovanni a Trento [per lo più a San Giovanni vi sono nevi]. La tengono aperta con certe cose di legno che li dicono Lezole, ciove carette seza rote tirate da un bue solo sopra le nevi, così fanno strata pubblica da usare facilmente. Da Edolo alla confine de Tonale vi fanno quindici miglia.
I due passi successivi, sempre diretti verso l’allora Principato Vescovi-le di Trento, partivano dalla Valle di Viso alle spalle dell’abitato di Pezzo, frazione di Ponte di Legno. Essi corrispondevano forse agli attuali Passo dei Contrabbandieri (2.681 metri s.l.m.) e Forcella di Montozzo (2.613 metri s.l.m.), valichi oggigiorno frequentati da escursionisti e alpinisti in direzione di Pejo in Val di Sole.
3. Da Ponte di Legno vi è un altro passo caminando verso tramontana fino alla Terra de Pez poi si volta verso matina e si va nel Trentino a una Terra detta Pej per la Valle detta Valombrina. Strada da fare se non quando non vi è nevi abbondanti altrimenti non si può fare.
4. Vi è un altro sentiero poco più nianzi che va alla medesima Terra di Pej detto l’ Sentiero delle Casaiole, ma de pedoni solamente quando non vi sono nevi.
Il quinto passo è rappresentato dal valico del Gavia, oggi percorso dalla Strada Statale 300 del Gavia (2.618 metri s.l.m.) che da Ponte di Legno scende in Valfurva e quindi connette a Bormio. La Valtellina, dal 1512 all’età napole-onica, fu assoggettata dal Libero Stato delle Tre Leghe. L’autore segnala che vi era anche un ulteriore valico, il Passo di Pietrarossa (3.013 metri s.l.m.), raggiungibile da un sentiero che, deviando verso occidente alla fine della
148
Val delle Messi, scendeva poi Val di Rezzalo congiungendosi con Sondalo in Valtellina.
5. Il Passo de Gavia che va da Ponti di Ligno a Bormio, 18 miglia de strada cami-nando sempre verso tramontana. Strada cativa. Si può fare anco con animali carichi ma difficilmente. Se vi sono nevi è difficilissima e ne meno si potria tenirla aperta come si fa con il Tonale per esser precipitosa e longha. Passato il monte Gavia si va in Magnavacca e Val de Forba, dove vi sono 3 contrate: San Nicolò, S. Antonio e San Colombano contado de Bormio.
Dentro della Terra de Pez vi è anco un sentiero che volta a man sinistra da pe-doni solamente. Va in Val de Rez del Commun de Sondelo e poi alle Prese. Cativo, e luongho.
Il sesto passaggio risaliva la Val Grande alle spalle di Vezza d’Oglio e si dirigeva, probabilmente, verso il Passo di Dom Bastone (2.546 metri s.l.m.): da qui si valicava il crinale per scendere nella terra di Sondalo.
6. Il Passo della Val di Veza. Vi è una strada da pedoni al tempo che non vi siano nevi dificili per condurvi animali. Questa camina per dritura verso tramontana e si mete capo a Sondelo in Valtellina. Il camino de 4 hore.
Nella detta Valle de Vezza discosto dalla Terra un miglio piccolo vi è anco un sentiero che va in Mortirolo. Si può anche condurvi animali ma che non siano ca-richi. Si traverssa la Valle verso sera fuori dalla strada suddetta che va a Sondelo.
Il settimo posto spetta al Passo del Mortirolo (1.852 metri s.l.m.), oggi at-traversato da strade provinciali che connettono gli abitati di Monno in Valle Camonica e Mazzo in Valtellina. L’autore sceglie di non descrivere il Passo di Mola poiché troppo disagevole e quindi da sconsigliare.
7. Il Passo di Mortirolo è strada usata da animali vodi, carichi, caretti da doi rode. Questo serve per Bormio, Sondelo, Tiolo [attuale frazione di Grosio, nda], Grosio, Grossotto et a Maz in Valtellina. Il montar alla montagna de Mortirolo è 3 miglia piccoli, la calata dalla banda de Valtellina è 3 miglia grossi e cativi ciove andar a Maz, andar a Grosio e Tiolo sono quasi cinque miglia, ma cativi pendenti e sassosi.
Mortirolo, non vi sono precipitij ne strade pericolose, ma si dice bene Mortirolo perché è montagna mortale di passare in tempo che vi sia nevi e che regna venti in tal caso non è posibile a tenirla aperta per niuna maniera. L’espirientia si vede che ogni anno ne moreno qualchuni in questa montagna. L’anno 1626 ste serata per le nevi quatro mesi che mai si puoté aprire per alcun muodo, se non vi sono nevi e poi altrimenti buona montagna e presta.
In cima alla montagna vi è una fontana grossa d’acqua chiarissima: d’estade freschissima d’inverno calda. È dalla banda de Valcamonica lontana dalla confine il tiro di un moschetto - poco più, vi sono assai casine si dalla banda de Valcamonica come anco della banda de Valtellina. Alla fontana si parteno le strade che vanno in
149
Valtellina: quella che va a Grosio, Sondelo et Bormio la camina dritto verso tramon-tana; quella che va a Maz, va verso sera nel boscho e poi cala sopra la terra de Maz.
Non tratto del Passo de Mola per non essere usato e alto e cativissimo.Il passo numero otto è quello della Guspessa (1.824 metri s.l.m.), ancora
oggi valico transitato e facile da raggiungere, che da Edolo in Val Camonica giungeva a Sernio in Valtellina.
8. Guspessa. La strada de Guspessa è buona se non vi sono nevi sebene che dalla banda di Valcamonica e seguente fina in cima, ma dalla banda di Valtellina è tanto subita che pare proprio che si voglia traboccare avanti perché ella è troppo in piedi. Per questa vi fu condotto, l’anno 1624, i canoni al muodo che si gioca al loto5 e la sorte volsse che non vi erano nevi, il tempo stete sempre in bonassia, ma l’anno 25 e 26 non saria stato posibile se non con gravissimi pericoli si delle persone come anco delli animali e robbe. Un’altra cosa che si può andare in Valtellina perché nel discen-dere si va pur a qualche muodo, ma ritornare non saria posibile.
Non è così sbatuta da venti come Mortirolo che quella è batuta da quatro bocche galiarde, ma questa se non da doi per dritura, tramontana e mezzogiorno.
Il miglior valico di collegamento tra Valle Camonica e Valtellina è, secon-do l’Apollonio, il Passo di Piatolta. Tale nome, ormai caduto in disuso, do-vrebbe corrispondere all’attuale Passo di Santa Cristina (1.427 metri s.l.m), agilmente raggiungibile dalle frazioni di Corteno Golgi, che consentiva di raggiungere il Pian del Gembro per poi scendere verso la città di Tirano. Questo transito, probabilmente non molto conosciuto né usato neppure all’e-poca, viene descritto quasi come una notizia esclusiva del nostro scrittore, che si dilunga assai nell’elogiarne le buone qualità. L’insistenza con la quale l’Apollonio si sofferma su questo passo trasmette al lettore l’idea che egli voglia vantarsi d’aver scoperto una via più comoda e più veloce di quella normalmente presa in considerazione, ovvero il limitrofo passo dell’Aprica.
9. (disegno di corona in capo al foglio) Il Passo de Piatolta. Questo era il Passo anticho e la strada ordinaria avanti che si facesse i Zapelli de Averigha. Che sia vero l’anno 1625 del mese di martio vene ordine dalla Serenissima Repubblica che si doveva condure in Valtellina certi canoni per servitio del armata dove ritrovandossi a Edolo l’Illustrissimo Signor Providitore Giovan Batista Basadone me fece chiamare dicendomi dove si havesse potuto transitare con li canoni a condirli sicuri in Valtelli-na. Ritrovandosi le montagne coperte de grant quantità de nevi, che non era posibile a passare senza pericoli grandissimi di morti di huomini, animali e far andare in precipitio ogni cosa, dove so mi sottopose sotto obligho della vitta che si saria passati
5 L’attuale formula del Gioco del Lotto sembra derivare in maniera abbastanza diretta da una pratica in uso a Genova nel XVI secolo che permetteva di scommettere sui nomi di cittadini candidati a cariche pubbliche (1576: si legalizza il gioco in Storia del Lotto, risorsa elettronica (12/10/2012), pagina web: ‹http://www.lottomaticaitalia.it/lotto/gioco/giuoco_seminario.html›).
150
per Piatolta senza un minimo pericolo, etiam si vi fusse stata alter tanta neve.Come si vede che esso Signor Providetore me dette ordine con mandato di co-
mandare doi cento guastadori dove in 3 giorni fece accomodare la strada fina pasato la confine un miglio grosso in quello de Valtellina, nel farla accomodare trovassimo le strade ciove le pietre antiche cove vi era pasato sopra le rode di carri longamente dove havevano fatte le cave nelle pietre a modo di canale, ebbero a dire i guastatori paesane e anco quei Signori Capitani che stavano a Edolo in presidio quali videro essa strada facendola certo pare che sia più presto miracolosa che artificiosa vi si può andarvi con una carozza de sei cavalli tanto è commoda e buona. Si può far di ogni stagione benche vi fusse dieci brazza de nevi non è pericolosa de venti, ne de lavine ne de pericoli de montagna precipitosa de precipitare.
Si può fare andare e ritornare con ogni gravissimo peso, vi sono casine in mezzo alla montagna nella sommità e dal altra banda ancora. Non può esser tagliata da nemici per alcun tempo. Serve al Passo di Puschiavo et a Tirano più che ogni altra strada che possa esser immaginata, insoma è degna di grant considerazione e conto.
Per rimarcare l’eccezionalità della segnalazione, l’Apollonio si sofferma in una digressione nella quale racconta L’muodo come io ho trovata la strada de Piatolta, indicatagli dal mio avo padre di mia madre Andrea Serotto Notaro, il quale a me dette un libro scritto a mano da legere come che li Valtellini al tempo che la Valtellina era de Duci de Milano […] dimandarono in suo soccorso i Signori Veneziani dove vi andò un esercito sotto condotto de un generale nominato Giorgio Cornero, il quale esercito entrò nella Valtellina a Sazzona per la via de Piatolta detto libro lo prestai de legere a un Signor Capitano Antonio Negri che fu qui per maggio-re ma non lo riauto più. Era questo signor maggiore tanto mio patrone che non fece forza farmelo restituire.
Al decimo posto si elenca il Passo dell’Aprica (1.181 metri s.l.m.), oggi comodamente attraversato dalla Strada Statale 39 dell’Aprica, ma un tempo caratterizzato dai famosi zappelli, ovvero dei particolari gradini intagliati nel-la roccia che rendevano il “cammino scabro e difficoltoso” 6.
I Zapelli di Averiga. Veramente sono usati i Zapelli di Averiga per la basezza del Piano di Camuzzone e comodità di rinfrescarsi al Terra di Averiga, ma levato che fussero i zapelli vi sono anco casine nella montagna di Piatolta che vi si potriano fare delle Hostarie.
I Zapelli per doi miglia sono pericolosissimi de precipitio guarda che vada fuori della strada qualche cosa non vi è più redentione de puoter haver niente e quanti ge ne sono andati e ge ne vanno ne sanno render conto, anco quej che condicevano fornimenti de monitioni publice quanti ve ne sono andati, animali e forti fornimenti e possono in una hora essere tagliati in maniera de farli impossibbili a commodare se
6 G.B. Rampoldi, Corografia dell’Italia, Milano 1834, vol. III, p. 1475.
151
non con grande spesa e tempo.Da Edolo a Tirano per Piatolta, miglia 14; per Zapelli, miglia 16; per Guspessa,
miglia 13.Non faccio discorso lungho sopra i Zapeli de Averiga basta a dire che sono Zapel-
li de brigha. Brigha de andarvi, brigha a mantenerli, sariano solamente poca brigha a levarli. Non hanno altro di buono se non che si faria presto presto a levarli.
L’ultimo transito descritto, l’undicesimo, portava in Valtellina tramite la Valle di Belviso. Esso corrispondeva probabilmente all’attuale Passo Selle-rino (2.412 metri s.l.m.), posto in capo alla Valle di Paisco, e non all’attuale Passo di Belviso (2.518 metri s.l.m.) che fa comunicare la Valtellina con la Val di Scalve bergamasca.
Il Passo della Valle de Belvis. Si va per la Valle de Belvis in Bergamasca in Val de Scalvo a una Terra nominata Ronc, si passa il Monte Murocolo dificile e cativo, si serra per le nevi spesse volte. Dentro nella Valle de Belvis vi è una contrata di casine e fucine detta San Pol si volta a man sinistra per un sentiero che salisse nel Monte Celer e mete capo dentro in fondo della Valle di Paisco che viene aperesso al Cidegolo in Valcamonica, ma solamente de pedoni in tempo che non vi siano nevi. Comincia la valle de Belvis a man sinistra poco discosto da Averigha verso mezo giorno ne esce di questa valle il fiume detto val Varina sotto Averiga.
Quel libretto nominato di sopra diceva che fu in Lombardia guerra e li spagnoli volssero venire da Valtellina in Valcamonica per il Monte Celer, ma vi stavano guar-dia de huomini de Paisco e Loveno e questo fu del 1514 fin a 1519.
Ho visto anco nei libri del Comune de Paischo sono nominati li soldati che sta-vano alla guardia e quelli che portavano il vivere e quelli che davano fuori formaio e formento e altre robbe.
Terminata la descrizione dei collegamenti alpini, il libretto prosegue con una descrizione della terra d’Edolo e della sua posizione favorevole per com-mercio qualora la Dominante stabilisse di far delle fiere come quelle famose di Trento o Bolzano7.
In conclusione, di tutti gli undici passi elencati, quattro sono ancora oggi le fondamentali arterie di collegamento montano della Valle Camonica: il Passo del Tonale, il Passo dell’Aprica e, in misura minore, poiché subiscono chiusure invernali, il Passo del Mortirolo e il Passo del Gavia. I restanti vali-chi elencati si sono ridotti ad esclusivo interesse turistico, alpinistico o legati agli usi agro-silvo-pastorali. Dalla lettura è per di più possibile tracciare un dislivello dei passi utilizzati nel primo Seicento che spazia di oltre mille e ottocento metri, da quello più basso, l’Aprica posto a circa 1.181 metri s.l.m,
7 Per una trascrizione integrale del documento: Leonardo, Edolo e i passi dell’alta Valcamonica, pp. 111-133.
152
fino ai 3.013 metri s.l.m del Passo di Pietrarossa.La relazione non tiene conto degli ulteriori valichi presenti in Valle Ca-
monica al di sotto del nodo di Cedegolo, ma sicuramente utilizzati anche all’epoca: dal Passo di Crocedomini, che si dirigeva a oriente verso il Lago di Garda, a quelli che a occidente portavano in territorio bergamasco. All’oc-chio di Giovanni Battista Appollonio tutti questi erano transiti interni, che connettevano il territorio camuno con altre vallate della Repubblica di Ve-nezia, ma esulavano dalla sua mera descrizione dei collegamenti verso stati esteri (oggi Provincia di Sondrio e Trentino-Alto Adige).
Mappa Valcamonica.
153
Nadia MassellaVito Massalongo
Marta Tezza
CONTRABBANDIERI E MILITARISULLE TERRE DI CONFINE DEI MONTI LESSINI
Come avete visto la Lessinia ha dei confini naturali dati dalle valli che la delimitano, in particolare verso Nord la valle dei Ronchi e a ovest la profon-da incisione della Val d’Adige. La Lessinia è diventata territorio di confine politico nel Medioevo, dopo aver fatto parte dell’impero romano, del regno dei longobardi e dei franchi e dell’impero germanico. Con la dissoluzione dell’impero germanico e la nascita di comuni il nostro altopiano entra dap-prima a far parte del territorio del Comune di Verona, che confina a nord con il principato vescovile di Trento, e poi della signoria degli Scaligeri. Questi ultimi prendono il potere a Verona nel 1262 con Mastino I Della Scala e il loro potere dura fino al 1387. Durante la dominazione degli Scaligeri, preci-samente nel 1287, i Cimbri, una popolazione di origine germanica, si stabili-rono nella zona di Roverè e iniziarono il popolamento della Lessinia modifi-candone il paesaggio: nacquero le contrade circondate da prati e bosco, che fornivano le risorse necessarie per la sopravvivenza della popolazione.
Con la concessione del 5 febbraio 1287 i Cimbri ottennero dai signori di Verona l’esenzione dalle tasse sul sale e sul macinato e dalle corvé, in oc-casione dell’edificazione di opere fortificate e di utilità pubblica, in cambio degli obblighi di fornire materiali e generi alimentari a Verona e di sorveglia-re i passi di montagna. Questi obblighi e questi privilegi furono confermati successivamente anche dai Visconti e poi dalla Repubblica di Venezia fino alla sua decadenza nel 1797.
Il controllo dei confini non era così efficace tanto che gli Scaligeri incorag-giarono le denunce anonime dei contrabbandieri e la Repubblica di Venezia nel 1472 emanò un ducale con il quale prevedeva la pena capitale per chi praticava il contrabbando e ordinava di rendere i sentieri impraticabili a chi li percorreva a piedi o a cavallo.
Per sorvegliare i passi i montanari utilizzavano degli archibugi a miccia e moschettoni, successivamente queste armi furono trasformate in un’arma particolare chiamata trombino, il cui nome sembra derivare dal termine trom-bolon di origine belga o olandese. Si ha notizia che nel 1611 furono incaricati 24 soldati per la difesa dei passi Pertica, della Lessinia e del Vajo dei Falconi, armati di archibugi a miccia e moschettoni. In Lessinia i trombini non furono
154
mai utilizzati come armi, ma divennero nei secoli schioppi da festa per sotto-lineare avvenimenti particolari delle comunità come l’ingresso del parroco o la vista pastorale del vescovo.
La Repubblica di Venezia concesse varie volte il permesso ad eserciti o truppe straniere di attraversare i suoi territori: l’impresa più significativa fu quella di Eugenio di Savoia. Nel 1701 era scoppiata la guerra di successione spagnola perché Carlo II re di Spagna aveva nominato come successore il duca Filippo d’Angiò, nipote del re di Francia Luigi XIV. Anche altri stati europei però vantavano dei diritti di successione al trono di Spagna e que-sto portò alla guerra. Francia e Baviera si schierarono con la Spagna contro Austria, Inghilterra, Paesi Bassi e alcuni stati dell’impero tedesco. Eugenio di Savoia compì un’impresa ritenuta impossibile, come attesta la dichiarazione del maresciallo Catinat, comandante delle truppe francesi. Nel 1701 Euge-nio, comandante supremo dell’esercito imperiale austriaco, arrivato in Val d’Adige con una mossa inaspettata decise di risalire in Lessinia per poi scen-dere in pianura e prendere l’esercito franco-spagnolo alle spalle, evitando così di trovarsi l’esercito avversario che gli sbarrava il passo in Val d’Adige. Ingaggiò tremila braccianti per aprire la via della val Fredda e permettere il passaggio dei soldati, dei cavalli e dei cannoni, che furono smontati per poterli trasportare. Tutto questo in condizioni climatiche sfavorevoli perché c’era la neve nonostante si fosse alla fine di maggio. Le truppe salite dalla Sega, a Fosse si riunirono con quelle salite da Peri per poi scendere verso la Valpantena e la Valpolicella. La tattica di Eugenio di Savoia si rivelò vincente e i franco-spagnoli vennero sconfitti a Villa Bartolomea e Chiari.
I confini della Lessinia non furono visitati solo dalle truppe di Eugenio di Savoia, altri eserciti e guarnigioni attraversarono il territorio dell’altopiano per partecipare a guerre che si svolgevano nelle zone di pianura. Lo testimo-niano i documenti nei quali i malghesi presenti in montagna chiedono un risarcimento per i danni causati dal passaggio dei soldati.
I confini settentrionali della nostra montagna continuavano ad essere at-traversati dagli abitanti che si trovavano su entrambi i lati e per questo alla metà del Settecento la Repubblica di Venezia e l’imperatrice d’Austria Maria Teresa istituirono una commissione a Rovereto per stabilire il confine nella zona tra il monte Baldo e la Lessinia. I commissari esaminarono il territorio, vari documenti, le carte notarili, le richieste degli abitanti legati alle loro pro-prietà e, dopo tre anni di lavoro, sulla base della relazione della commissione nel 1753 un trattato pose fine alle controversie legate ai confini. L’anno suc-cessivo si iniziarono a posizionare i cippi di confine in pietra recanti la data 1754 e il numero progressivo da 1 a 200 a partire dalla Bocca di Nago sul Bal-do fino al monte Sparvieri sui Lessini. Gli Austriaci nel secolo successivo ai
155
200 cippi originari ne aggiunsero degli altri verso est per completare la linea di confine fino al Carega.
Con la conquista napoleonica dell’Italia i privilegi di cui godevano le po-polazioni della Lessinia cessano e non verranno più concessi, anche perché con il Congresso di Vienna la Lessinia diventa parte del Lombardo-Veneto austriaco.
Tra il 1814 e il 1866 Verona diventa il cardine del sistema difensivo del Lombardo-Veneto per la sua posizione strategica di controllo delle principali vie di comunicazione con Vienna e le altre parti dell’Impero. Gli austriaci creano un sistema di difesa che si espande nel territorio della pianura, con la creazione nell’area ad ovest dei forti di Rivoli e di Pastrengo, e il Quadrilate-ro che comprendeva oltre a Verona, Peschiera, Mantova e Legnago.
Con la terza guerra d’indipendenza la Lessinia diventa confine di stato e per il sistema difensivo veronese inizia una nuova fase, infatti ora il pericolo poteva venire da nord.
I primi ad attraversare i confini sono i contrabbandieri. Le impervie vie dell’Alta Lessinia favorirono il contrabbando clandestino a causa delle poli-tiche protezionistiche del Regno d’Italia, per cui i prodotti stranieri divenne-ro introvabili e carichi di dazi pesantissimi, tali da non essere più disponibili per la povertà dilagante e per curare il colera e la pellagra con il sale. I generi contrabbandati erano il salgemma tirolese, lo zucchero, il tabacco. In cimbro i contrabbandieri erano detti de tragan dal verbo tragan = portare; i finanzieri pinter dal verbo cimbro pinten = legare e quindi ammanettare, arrestare; de traghe era il carico. I Carabinieri (che non erano temuti come i finanzieri) era-no chiamati Koular, carbonai per il colore della divisa.
A causa anche delle tasse, dei dazi e dell’odiosa tassa sul macinato nei primi decenni del regno d’Italia vi è una impennata della mortalità e un dete-rioramento del tenore di vita. Le pene inflitte vanno dall’ammonizione della pretura fino a multe pesanti ed anche al carcere. I comuni chiedono spesso la commutazione della pena pecuniaria, sempre esorbitante, con un periodo breve di carcere, in quanto le famiglie erano in condizioni miserevoli.
L’esistenza del contrabbando mise in difficoltà il commercio ufficiale di prodotti di “privativa” per la lontananza e per la scarsa remunerazione. Nel-la zona di confine ci fu un rigido controllo doganale: la fascia di vigilanza era larga 10 chilometri lungo tutta la linea di confine e i prodotti sottoposti a vincolo doganale erano: caffè, pepe, zucchero, cannella,chiodi di garofano, olii minerali e di resine.
156
INNO DEI CONTRABBANDIERINoantri contrabanderiVegnmo su da AlaE co la carga in spalaPasemo el confin.Noantri contrabanderiSemo sensa creansaBastonemo la finansaSensa farse ciapar.Noantri contrabanderiGhe disemo al brigadiereChe una de ste sereLa pele ghe farem.No ghe sarà VitorioE gnanca GaribaldiCo i so stronsi caldiEl ne sapia fermar.
Nonostante ciò molti sono stati gli episodi nei quali questi contrabban-dieri sono stati catturati e costretti a pagare multe molto salate o a subire anche il carcere. I comuni di confine generalmente dichiaravano che le per-sone catturate non erano contrabbandieri, ma individui in gravi difficoltà economiche. Talvolta i finanzieri si lasciavano corrompere con qualche chilo di burro o di formaggio, perché capivano le difficili condizioni delle persone. Si hanno notizie anche di numerosi incidenti mortali, soprattutto durante le bufere di neve, di morti di giovani che attraversavano il confine.
Accanto ai contrabbandieri e ai finanzieri vi erano i soldati che avevano il compito di sorvegliare i confini. Numerose sono le caserme che sorgono nei paesi confinanti della Lessinia tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del No-vecento. La presenza di soldati, soprattutto alpini, rendeva la vita dei paesi montani più vivace e costituiva un introito per molte famiglie del posto, che fornivano generi alimentari e lavori di manutenzione e pulizia. Per quanto riguarda la difesa del territorio il Ministero della Difesa, su richiesta del capo di Stato Maggiore dell’esercito, decide dapprima di utilizzare i forti austriaci di Rivoli e Ceraino, che vennero modificati e poi fu decisa la realizzazione di nuovi forti: Forte Masua, Forte Monte Tesoro, Forte Santa Viola, Forte Ca-stelletto e Forte San Briccio, distanti circa 20 chilometri l’uno dall’altro, che creavano una sorta di arco difensivo a nord di Verona. Questi forti furono edificati o riammodernati tra il 1880 e il 1913.
Con lo scoppio della prima guerra mondiale ai forti si aggiungono i chi-
157
lometri di trincee, gallerie, rifugi e strade. Un esempio per tutti la strada della Podestaria costruita da Carlo Stuparich, comandante dell’84 battaglio-ne, in soli 45 giorni, che percorre tutta l’alta Lessinia e poi le gallerie che da Cima Borghetto controllano la val d’Adige scavate tra il settembre del 1915 e l’aprile del 1916. Fortunatamente i forti e tutte le opere militari e i circa 5/7 mila soldati di stanza in Lessinia non furono mai oggetto di attacchi, come invece avvenne nel vicino altopiano di Asiago.
Con la fine della grande guerra e lo spostamento della linea di confine molto più a nord la presenza dei militari in Lessinia diminuisce notevolmen-te. Le vecchie caserme vengono in parte riutilizzate per ospitare i militari e i giovani delle organizzazioni fasciste, che durante l’inverno venivano in Lessinia per le esercitazioni, come la caserma dei Tracchi, o diventano al-berghi. Durante il secondo conflitto risiederanno in Lessinia militari fascisti, tedeschi ed anche gruppi di partigiani. Si verificheranno anche scontri ar-mati e la distruzione, soprattutto nella parte orientale, di intere contrade per rappresaglia.
Anche il contrabbando con la zona di Ala, occupata dai tedeschi, nono-stante i pericoli continua a sopravvivere come testimonia una signora, che tra il 1943 e il ‘45 portava burro e formaggio in val d’Adige, scambiandolo con farina, polenta, grappa, zucchero e caffè. Percorreva la val Bona con una carga di 20 chili quando andava ad Ala, perché il sentiero era in discesa e ne portava una di 5 chilometri, perché la salita di oltre 1400 metri di dislivello era molto faticosa.
Con la fine della guerra i sentieri percorsi da militari e contrabbandieri diventano le strade che portano gli emigranti in cerca di fortuna nelle città industriali della pianura o in altri continenti. Inizia lo spopolamento della Lessinia, segno dei nuovi tempi che stanno cambiando e dei nuovi equilibri geopolitici che questa volta vedranno arrivare nel nostro altipiano le basi militari della NATO.
159
Monica Ronchini
ATTRAVERSO LA STORIA:ANTICHI SENTIERI DEL TERRITORIO DELL’ALTO GARDA
Premessa di questa relazione è la convinzione che vi siano modi concreti per riportare al centro delle nostre comunità il paesaggio e che, di questo patrimonio, la tutela è strettamente connessa alla capacità collettiva di co-glierne la complessità, la profondità storica e il senso di coimplicazione fra ambiente e cultura. Cappelle votive, semplici pietre di confine, la disposizio-ne dei campi e dei boschi ad esempio sono come tessere di quel mosaico che è un territorio, nella sua materialità, risultato concreto dei rapporti secolari di reciprocità fra comunità umane e ambienti naturali. Azioni secolari di ma-nipolazione delle risorse ambientali, una conoscenza raffinata dello spazio geografico, della composizione geologica dei luoghi, della vegetazione, dei fattori climatici e dell’ecosistema locale hanno reso attori e responsabili le comunità che vivono in luoghi caratterizzati dalla secolarità degli insedia-menti1. Tutto ciò è nello spazio nella sua fisicità, e si traduce in quello che Lucio Gambi ha definito l’invisibile del paesaggio2, perchè lo spazio non è dato, ma prodotto3, e idealità e materialità vi sono intrecciate strettamente4.
Da queste considerazioni ha avuto origine la serie di iniziative che sono l’oggetto di questo testo.
Il progetto è nato all’interno dell’attività culturale del MAG Museo Alto Garda, che da tempo si occupa di paesaggio attraverso percorsi espositivi, pubblicazioni, ricerche che negli anni hanno coinvolto associazioni, scuole, studiosi, istituzioni culturali e comunali del territorio.
La riscoperta degli antichi percorsi viari ha condotto a scoprire aree vici-ne ai centri abitati spesso ignote, ma dalle quali acquisire uno sguardo nuovo sul paesaggio. Partendo dai sentieri trovati sulle carte catastali storiche e poi nel territorio, le ricerche hanno recuperato vicende storiche e caratteristiche naturalistiche degli ambienti ed hanno sollecitato l’interpretazione artistica, attraverso la fotografia, la narrazione e la produzione musicale. Infine questi stessi luoghi sono stati ‘riconsegnati’ alle comunità che li abitano, alle scuole, alle associazioni, alle singole persone e famiglie, perchè moltiplicassero la
1 E. Turri, Antropologia del paesaggio, Venezia 2008.2 L. Gambi, Una geografia per la storia, Torino 1973.3 H. Lefebvre, La production de l’espace, Paris 1974.4 F. Lai, Antropologia del paesaggio, Roma 2000; E. Turri, Il paesaggio come teatro: dal territorio vissuto al
territorio rappresentato, Venezia 2001.
160
consapevolezza della ricchezza di questi territori e si facessero scudo alla loro fragilità.
Il termine Alto Garda non è un toponimo storico, ma un’espressione ge-ografica recente per indicare l’area trentina posta a nord del maggiore lago italiano. È una piana alluvionale formatasi in seguito allo scioglimento dei ghiacciai e al deposito dei detriti lasciati lungo il bacino dal fiume Sarca, che anticamente qui si ramificava in diversi dotti secondari5.
Il paesaggio qui si impone per i suoi spiccati valori estetici naturali. E come ovunque nelle nostre montagne, lo spettacolo si gode non solo perché è segno dell’autogenerarsi della natura, ma anche per la percezione, che vi si insinua sottile, degli interventi realizzati dalle comunità umane, e che sono determinanti per quella precisa configurazione visibile: le limonaie in disu-so, le linee disegnate dagli uliveti e dai vigneti, le esili tracce di aree coltivate a cereali, il distendersi nella piana dei frutteti, l’estendersi sulle cime delle aree boschive per l’abbandono della fienagione.
In questo contesto ruolo importante ha la viabilità, il sistema oggi è costi-tuito da tre direttrici principali: una fra Riva del Garda e Arco con andamento assiale nella piana e da qui a nord verso Trento, l’altra di collegamento verso est con la valle dell’Adige e infine l’ultima costituita dal sistema viario lacu-stre, lungo il perimetro del lago, che fu realizzato solo nel primo Novecento.
L’impianto stradale attuale è complessivamente molto differente da quel-lo rimasto inalterato fino a metà Ottocento e non solo per l’apertura del-la strada gardesana che costeggia il lago. L’efficacia degli interventi tecnici ha infatti permesso di superare limiti ambientali primari, come il carattere scosceso dei monti sul lago, e lo spazio, nella sua configurazione odierna, è l’effetto di un intervento antropico massiccio, ritenuto ancora oggi essen-ziale nelle prospettive di sviluppo dell’area. È sulle pagine dei giornali di quest’estate la questione di un tunnel di collegamento fra Rovereto e la pia-na del Basso Sarca con la perforazione del monte Creino, o l’ipotesi di una pista ciclabile nella sponda orientale del lago fra Torbole e Malcesine, con una soluzione a sospensione sul lago; nessuna invariante ambientale risulta insormontabile, e, ancorchè dichiarato ‘naturale’, il risultato è uno spazio è dominato, soggiogato alle esigenze urbane di una sua piena accessibilità.
In questo contesto i percorsi antichi hanno invece offerto un’altra visione degli stessi luoghi.
Nelle sue fasi concrete, come detto, il progetto si presenta di una partico-lare semplicità e replicabilità ovunque, ma soprattutto nei territori montani,
5 U. Sauro, La macchina idraulica, in Il lago di Garda, Sommacampagna (VR) 2001; B. Parisi, Spazio geografico e glacialismo, in Là dove nasce il Garda, Verona 1994, pp. 41-59.
161
dove sono importanti i valori paesaggistici.Le strade antiche sono state trovate sulle mappe del catasto austriaco del
1856, dove lo spazio è rappresentato su base geometrica e con grande det-taglio. La cartografia storica ha offerto numerosi elementi di conoscenza dei luoghi, indicando l’estensione delle aree urbane e l’arretramento dei coltivi a vantaggio dei boschi, ma anche ha fornito dati su tipologie colturali scom-parse, ambiti produttivi e localizzazioni puntuali di aree abitate.
Il secondo momento è consistito nel rintacciare quegli stessi sentieri nel territorio, spesso in condizioni di abbandono e sconosciuti a coloro che vi abitavano accanto da decenni. Sono quindi stati percorsi per coglierne gli aspetti naturalistici prevalenti e per scoprire anche esili tracce della loro an-tichità, depositate lungo la strada.
La ricerca è stata successivamente completata con la documentazione raccolta negli archivi ed è confluita in una serie di pubblicazioni, una per ogni sentiero studiato.
I sentieri si prestavano però anche ad una lettura estetica dello spazio, essenziale a superare il livello puramente descrittivo delle informazioni e a dare valore e forza alle sensazioni che si sprigionavano da questi percor-si. Per ogni strada sono state proposte diverse interpretazioni artistiche: un itinerario fotografico, una breve composizione narrativa6 commissionata a scrittori estranei ai luoghi e infine l’invenzione di musiche e di spettacoli creati appositamente da giovani compositori.
A conclusione, l’organizzazione di giornate dedicate ai sentieri, una per ogni percorso, ha coinvolto le scuole, le associazioni, le amministrazioni lo-cali, in un momento di riappropriazione collettiva dello spazio.
Nel dar conto dei cinque percorsi finora studiati, i primi tre nel 2010 e gli ultim due nel 2012 si vuole brevemente suggerire la ricchezza di spazi così dimessi e il fascino esercitato dalla loro orgogliosa semplicità.
La vecchia Maza7 è un tracciato antico di collegamento fra Nago e Arco, centri ambedue dotati di castelli di età medievale eretti su preesistenti siti preistorici.
Del sentiero, come ovvio e com’è di tutti questi tracciati, non esiste do-cumentazione che ne attesti la nascita, ma lungo il percorso sono numerose le tracce della sua antichità: ripari sottoroccia di età mesolitica, frammenti di cuspidi di freccia e raschiatoi dell’età del Bronzo recuperati durante gli scavi degli anni Settanta, rocce incise con segni che richiamano il gioco della tria, una pietra di confine datata 1573, uno stemma del 1640 appartenente ad una
6 I racconti dei primi tre sentieri sono confluiti in un’unica pubblicazione: G. Falco, S. Ragucci, M. Mari, G. Mozzi, Racconti, Arco 2010.
7 F. Martinelli, M. Ronchini, M.L. Viaro, La vecchia Maza, Arco 2010.
162
famiglia nobile locale murato in una casa delle più antiche nella campagna, cappelle private settecentesche.
Dagli archivi la strada risultava di pertinenza della comunità di Oltre-sarca, che ne affidava la manutenzione ordinaria ai saltari. Come tutti que-sti percorsi, che congiungevano centri abitati chiusi da cinte murarie, anche questo si snodava nei boschi il cui sfruttamento era disciplinato; in questo caso i boschi di olivo lungo la strada e il loro uso conservano tracce di questa antichità, quando ad esempio delle piante, di proprietà comunale, è ceduta a privati all’asta la potatura. Le memorie delle campagne napoleoniche rac-contano che il sentiero fu percorso dalle truppe francesi inseguite e accer-chiate dagli austro tirolesi nel novembre del 1796, mentre una ruota lasciata lungo la strada ricorda i mulini di Nago ora scomparsi e le condotte forzate parlano della caduta dell’acqua che genera elettricità nella centrale a valle.
Notevoli tracce sono i microtoponimi, a memoria di vicende accadute in quegli spazi: persa la condizione istantanea, i fatti acquistano forma spazia-le nei nomi. Così è per il toponimo Bruttagosto, a ricordo di una notte del 1283 quando fu eseguito l’ordine di sterminare la famiglia nobile dei Sejano concorrente dei signori d’Arco, da quel momento padroni incontrastati del territorio, di Arco, appunto, e delle sue campagne.
Quello che abbiamo chiamato la Via Occidentale è un sentiero ricco di stratificazioni storiche e di una grande varietà di paesaggi8. Il nome è ispira-to ad un percorso molto più lungo e frequentato, che congiungeva il lago di Garda con le valli Giudicarie e i passi svizzeri. L’ampiezza del solco stradale ora in condizioni di completo abbandono e altre tracce più esili confermano che questa strada doveva essere un’importante via di commercio di transito nell’età moderna e fino all’Ottocento. In direzione di questa strada, ora un sentiero sconnesso, era situata la (La!) Porta di Riva che portava verso le frequentatissime Valli Giudicarie9 mentre gli estimi di Riva del Quattrocento attestano che lungo questo tracciato si collocavano i maggiori investimenti fondiari in olivaie dei ‘forestieri’ provenienti dalle valli occidentali appunto.
Altri dati rafforzano la sensazione di abbandono: lungo il pendio che costeggia il sentiero, proprio sotto il monte di Tenno, dove ora lo spazio è ripreso dal bosco, la memoria degli abitanti riferisce di una vivacissima fre-quentazione di bambini e di donne, un susseguirsi di voci e di passi per la raccolta della foglia per i bachi, per la cura dei prodotti degli orti, per la se-lezione delle piante usate nella farmacopea popolare. Uno spazio luminoso
8 M. Ballardini, T. Benamati, G. Menotti, M. Ronchini, La Via Occidentale, Arco 2010.9 Da notare che le Valli Giudicarie ora si raggiungono ‘naturalmente’ in automobile con un lungo
giro da nord, dato che il tracciato stradale attuale che si avvicina al vecchio sentiero esiste ed è forse più breve, ma è meno frequentato
163
per il sole e per l’animazione , dove oggi il contrasto è davvero fortissimo.Poco più a monte, nel giro di poche centinaia di metri, il succedersi di tre
mulini vicini al torrente e completamente invasi dalla vegetazione richiama una produzione scomparsa, ma anche un sapere ed una socialità radicalmen-te assenti.
La via al Castello è il terzo percorso10. Strada che si inerpica come molte nelle nostre Alpi, mostra pochi segni della propria antichità, attestata invece dalla cartografia storica.
In questo caso sono maggiori i dati immateriali a certificare la lunga du-rata del sentiero. Come sempre i toponimi presenti sulla cartografia storica, che indicano un tratto come Brozzera, o strada dei broz, i carri che diven-tavano a due ruote per assecondare il pendio della strada, o il fatto che il sentiero sia disegnato in mappa più antica come percorso delle truppe del generale francese Vendôme, ricordato per le numerose distruzioni inflitte ai castelli del Basso Sarca, nel 1703 di ritorno da Trento.
L’arrivo del percorso è al castello medievale di Drena che domina tutta la vallata, da un’altura strategica, in linea diretta di comunicazione visiva con la rupe e il castelliere di Arco. Anche in questo caso reperti dell’età del Bronzo e soprattutto dell’età del Ferro documentano, in un piccolo museo, l’interesse umano per i punti apicali. Da lassù la vista si apre alle Marocche, formazioni franose di dimensioni notevoli, una storia geologica attestata dalla concavità imponente del monte e dalle macerie enormi a valle. Piccole e rare orchidee selvatiche puntellano discretamente il percorso.
Recentemente, nel corso del 2012, sono state studiate altre due vie antiche, ancora una volta due semplici linee nella montagna che sembrano sfuggire alla grande storia dei grandi eventi. Una prima che unisce direttamente Riva del Garda, centro turistico sul lago, al piccolo villaggio montano di Campi, la seconda un percorso che si inabissa nel bosco, prima di congiungere i due piccoli paesi di Dro e Pietramurata, nella piana del Sarca.
Nel sentiero di Campi,11 i segni della storia sono molti. Oltre al Bastio-ne, un torrione del Cinquecento veneziano recentemente restaurato e che domina il lago, si trovano un eremo e una chiesa sconsacrata, dei torrioni alto medievali e diversi punti di fortificazioni della Prima Guerra Mondia-le abbandonate. A contrasto con ciò la memoria e gli archivi raccontano di una sorprendente vitalità. Il susseguirsi di azioni per contenere le frane della Rocchetta, la presenza di brevi filari di vigne per sfruttare piccole sorgenti di acqua, i numerosissimi castagni piantati e catalogati con cura di cui si rac-
10 M. Ronchini, R. Turrini, M. Viaro, La Via al Castello, Arco 2010.11 M. Ballardini, C. Girardi, G. Menotti, M. Ronchini, La Via ai Monti di Riva, Arco 2012.
164
contano storie leggendarie, la mappatura mentale e accurata del bosco per sapere dove estrarre legna adatta a far assi da carri, i muri alti presso le case a difesa dagli orsi.
Il secondo sentiero, fra Dro e Pietramurata, presenta soprattutto valori naturalistici.12 Inoltrandosi nel bosco, si percepiscono anche in un breve tra-gitto la varietà delle specie arboree e gli adattamenti ai terreni più impervi, ma anche in questo sentiero si parla come negli altri della sapiente capacità umana di interagire con lo spazio, o di forzare simbolicamente l’ambiente naturale, come con le riforestazioni di sempreverdi importati dagli austriaci, segno di una presa di possesso dei luoghi non solo politica.
I risultati del progetto, ancora in corso e destinato a replicarsi, sono con-fortanti, non solo perché hanno ancora una volta permesso di percepire la ricchezza della montagna al di là della fruizione veloce e superficiale di un turismo banalizzante, ma anche perché l’impegno e l’attenzione che vi han-no dedicato scuole, ragazzi, insegnanti, associazioni, genitori, cittadini sem-plici e amministrazioni pubbliche locali fanno davvero ben sperare.
Inoltre ci pare che per la montagna sia più che mai urgente una storia naturalistica puntuale, che racconti le vicende del prodursi del paesaggio dei nostri territori e che smentisca l’apparente immutabilità della natura ri-costruendo l’entità, la sapienza e l’efficacia degli atti di manipolazione dello spazio; ma è anche importante che descriva quella specie di resistenza che i luoghi naturali sembrano opporre, come attesterebbero le frane, le processio-narie che si riproducono lente a danno dei pini e il rigoglio della vegetazione nei luoghi dell’arretramento antropico.
Il territorio e il paesaggio sono il patrimonio indiviso delle collettività, di tutti, ma hanno bisogno dell’impegno collettivo perché si possa averne cura, come avviene di ciò che vale. E le nostre montagne lo sono in maniera straordinaria.
12 M. Ronchini, R. Turrini, M. Viaro, Il sentiero dei Molinei, Arco 2012.
166
INDICE
Introduzioni di Renzo Zagnoni e Giancarlo Maculotti pag. 3
LA RICERCA SUL CAMPO 7
RELAZIONI 9
Giuseppe Albertoni Le alpi e gli appennini nel medioevo: valichi, passaggi frontiere 11
Giuliano Biolchini - Gian Paolo Borghi Esempi di espressività tradizionale fra appennini e alpi: l’esempio dei carnevali nella valle del Panaro 21
Renzo Nelli Viaggi e viaggiatori in transito dai passi appenninici
prima del Grand Tour 37
Paolo Pirillo L’appennino medievale da limite labile a confine tra stati
(secc. XIII-XV) 51
Elena Vannucchi Un crinale per un santo: San pellegrino dell’Alpe
fra Modena e Garfagnana 65
Carlo Vivoli Tra Granducato di Toscana, Ducato di Modena e Stato della
Chiesa: l’appennino nella cartografia storica 75
Renzo Zagnoni Monasteri e ospitali di passo in appennino nel medioevo 91
Giulio Orazio Bravi La guida per viaggiatori De regimine iter agentium di Guglielmo Grataroli del 1561 103
167
Bruno Ciapponi Landi Valtellina, Valchiavenna e Grigioni: indagine sui rapporti culturali fra il Cantone dei Grigioni, la Valtellina e le ex contee di Bormio e Chiavenna 123
Roberto Fantoni - Attilio Ferla La fruizione di un colle alpino dal tardo medioevo al nuovo
millennio: il Colle Valdobbia (Alpi Centro-Occidentali) 133
Luca GiarelliLa frontiera di San Marco: i passi alpini nella Val Camonicadel primo Seicento 145
Nadia Massella - Vito Massalongo - Marta TezzaContrabbandieri e militari sulle terre di confine dei Monti Lessini 153
Monica Ronchini Attraverso la storia: antichi sentieri del territorio dell’Alto Garda 159