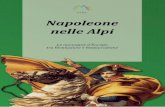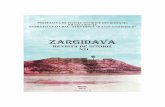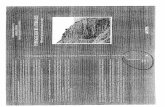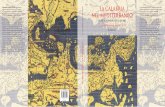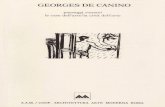Paesaggi del culto nelle Alpi centro-orientali
Transcript of Paesaggi del culto nelle Alpi centro-orientali
PPE.Atti XI
PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA
Paesaggi cerimonialiRicerche e scavi
ATTI DELL’UNDICESIMO INCONTRO DI STUDI
CENTRO STUDI DI PREISTORIA E ARCHEOLOGIAMilano
PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA
ATTI DELL’UNDICESIMO INCONTRO DI STUDI
Paesaggi cerimonialiRicerche e scavi
volume II
Centro Studi di Preistoria e ArcheologiaMilano
Atti dell’Undicesimo Incontro di StudiValentano (VT) – Pitigliano (GR), 14-16 Settembre 2012
Paesaggi cerimonialiRicerche e scavi
a cura di Nuccia Negroni Catacchio
In copertina disegno di Ercole Negroni
ISBN 9788894035520
© 2014 by Centro Studi di Preistoria e Archeologia – Onlus viale Lazio 26, 20135 Milano www.preistoriacsp.it
Tutti i diritti riservati
315
Paesaggi del culto nelle Alpi centro-orientali
Franco Marzatico* La definizione dei paesaggi cultuali di epoca protostorica nelle Alpi centro-orientali da oltre un ventennio costituisce uno degli argomenti di maggiore interesse nel dibattito scientifico, con pre-se di posizione contrastanti. Pubblicazioni, convegni, iniziative espositive, riletture di vecchi scavi, insieme al susseguirsi di inda-gini sistematiche (condotte in particolare in Alto Adige/Südtirol a S. Valburga/St. Walburg in Val d’Ultimo/Ultental, al Rungger Egg presso Siusi/Seis, sull’Hahnehütter Bödele presso il Ganglegg di Sluderno/Schluderns, a Schöllberg-Göge presso Rio Bianco/Weissenbach in valle Aurina/Ahrntal, in Nord Tirolo a Pillerhöhe a settentrione del passo di Resia/Reschenpass, a Demlfeld presso Ampass, Bergisel e in altri siti, nonché in Baviera a Forggensee e a Farchant nei pressi di Garmisch-Partenkirchen, nel Cantone di San Gallo in Svizzera a Wartau-Ochsenberg, in Trentino ai Campi Neri di Cles e in Valcamonica a Breno), offrono in effetti un ricco quadro di riferimento, tanto articolato quanto discusso (Weiss 1997, Zainer 1999; Zemmer-Plank 1997; Niederwanger, Tecchiati 1999; Gleirscher 2002; Zemmer-Plank 2002a; Tomedi 2004; En-drizzi et alii 2009; Rageth 2013; Steiner 2013; Waffen… 2012).
A suscitare grande attenzione è stato senza dubbio il fenomeno dei cosiddetti Brandopferplätze o roghi votivi, sulla cui classifica-zione e interpretazione si confrontano opinioni anche profonda-mente diverse, come indicano numerosi contributi scientifici, a partire dall’opera di Werner Krämer che, per primo, nel 1966, ha introdotto il termine in questione nella bibliografia di lingua tede-sca (Krämer 1966). Secondo questo studio pionieristico, i roghi votivi si connotano essenzialmente come aree cerimoniali a sfondo sacro, indiziate dal ritrovamento di livelli più o meno consistenti di ceneri, carboni e di ossi calcinati, spesso in relazione con la presenza – peraltro fortemente variabile – di resti ceramici e di oggetti in metallo, osso e corno, soggetti o meno ad alterazioni meccaniche o del fuoco, secondo procedure definite “cruente”, come si ricava ad esempio nel caso di fibule spezzate o ripiegate o delle situle miniaturistiche schiacciate portate alla luce a Mechel in Val di Non. Si è già avuto modo di rilevare peraltro che, al di là dei “minimi comuni denominatori”, per l’appunto costituiti dalla presenza di livelli con ceneri, carboni, ossi calcinati di animali e
* Castello del Buonconsiglio, monu-menti e collezioni provinciali, Trento.
Si ringraziano Carmen Calovi, Mi chele Dalba e Dora Giovannini.
Paesaggi del culto nelle Alpi centro-orientali
317
offerte di varia natura, i roghi votivi presentano di volta in volta forti peculiarità con una certa variabilità sotto il profilo topografi-co-ambientale, delle fasi di frequentazione, dei resti strutturali e dei sacrifici (Endrizzi et alii 2009). Questa eterogeneità si rispec-chia in interpretazioni discordanti a proposito della natura di alcuni siti privi di informazioni di dettaglio che, a seconda degli autori, sono annoverati o meno fra i roghi votivi, come si può facil-mente dedurre da difformità nelle carte di distribuzione (fig. 1).
Alla prima classificazione di ordine generale dovuta a Krämer sono seguiti vari contributi che hanno tentato di approfondire la determinazione crono-tipologica di questo genere di testimonian-ze la cui presenza coinvolge non solo l’area alpina – dove peraltro si registra il maggiore addensamento – ma anche, in misura alter-na, territori circostanti. Verso settentrione l’ambito geografico interessato comprende la Svizzera centrale con i cantoni di San Gallo, dei Grigioni e di Berna, la Germania meridionale fino oltre il corso del Danubio, con il Giura svevo. Il sito più occidentale è quello di Les Sagnes - Valée dell’Ubaye nelle Alpi dell’alta Pro-venza mentre quelli più orientali, seguendo Paul Gleirscher, sono St. Nikolai im Sölktal in Stiria e Lokavec in Slovenia presso Gori-zia (Zemmer-Plank 2002; Gleirscher 2002; Endrizzi et alii 2009; Steiner 2010; Rageth 2013). A sud delle Alpi il sito con roghi voti-vi presso Custoza nella pianura veronese ha restituito frammenti ceramici che corrispondono significativamente a tipologie dell’a-spetto culturale alpino di Luco/Laugen del Bronzo Finale ma livelli con ceneri e carboni, interpretati come esito di pratiche cul-tuali con l’accensione di fuochi rituali più o meno assimilabili a quelle delle Alpi, sono stati ultimamente riconosciuti anche più a meridione, come evidenziato in questo volume (Salzani 1996-1997).
Dal punto di vista topografico si registra una notevole variabi-lità della localizzazione dei roghi votivi, dato che sono attestati in siti di fondovalle e su rilievi, come ad esempio nell’insediamento dei Montesei di Serso in Valsugana in connessione con un masso con coppelle, inoltre su pendii e versanti, come a Stenico località Calferi nelle Valli Giudicarie e in alta quota, in diversi casi in pros-simità di specchi d’acqua. Ai siti più noti individuati sullo Sciliar/Schlern (Monte Castello/Burgstall - m 2510, frequentato a partire dall’avanzato Bronzo Antico fino in epoca romana e di Plörg (m 2525 s.l.m.), si aggiungono, fra quelli accertati, Sölkpass/Sölktal in Stiria – m 1800 e, in prossimità di specchi d’acqua, Lago Nero Schwarzsee am Seeberg – m 2038 dove fra le offerte votive
1. Carta di distribuzione dei roghi votivi (Brandopferplätze) o di complessi avvicinabili secondo Gleirscher (da Gleirscher, Nothdurfter, Schubert 2002).
2. Palette in legno dal luogo di culto in alta quota di Schöllberg-Göge presso Rio Bianco/Weissenbach in valle Aurina/Ahrntal (da Steiner 2013).
3. a-b. Lamine in bronzo ritagliate a figura umana; c. Bronzetto di tipo Marzabotto; d-e. Pendagli a forma di scudo ricavati da manufatti decorati secondo i canoni dell’Arte delle Situle; f. Paragnatide in ferro; g. Ascia-alabarda in ferro dal luogo di culto di Pillerhöhe in Nord Tirolo (da Tschurtschenthaler, Wein 1998).
4. A. Sezione del rogo votivo dell’età del Bronzo Antico e Medio sull’Hahnehütterbödele presso il Ganglegg di Sluderno/Schluderns; B. Ipotesi ricostruttiva tridimensionale dell’area di culto con cumulo di ceneri ed edificio adiacente (da Steiner 2010).
Franco Marzatico
318
figurano anche scorie di fusione connesse alle vicine aree di pro-duzione metallurgica, Lago Santo/Lech Sant - m 2096 in Val Gar-dena/Grödnertal, in uso fra l’età del bronzo e la seconda età del ferro, Grubensee-Maneid in Val Venosta/Vinschgau - m 2435 che ha restituito materiali databili fra il XII secolo a.C. e il II d.C. e Les Sagnes nella valle dell’Ubaye - m 1900) (Haupt 2010; Steiner 2013). Fra le più recenti acquisizioni vanno menzionati inoltre i siti di Fossa Finale/Finailgrube in Val Senales/Schnalstal (m 2460), dove oltre a resti ceramici sono stati portati alla luce numerosi vaghi in ambra e perle in materiale vetroso inquadrabili fra il XIII e il X secolo a.C. che segnano direttrici di collegamento fra la pia-nura padana e la Svizzera e infine la torbiera del Schöllberg-Göge (m 2197) presso Rio Bianco/Weissenbach in valle Aurina/Ahrntal che presenta una situazione del tutto eccezionale (Putzer 2012; Steiner 2013). Le ricerche condotte da Hubert Steiner nella palu-de e su un’altura vicina hanno infatti portato alla luce livelli carbo-niosi con ossi calcinati, resti ceramici della cultura di Luco/Lau-gen, uno spillone in bronzo e un deposito di oltre un centinaio di palette in legno che, in diversi casi, recano tracce di utilizzo in relazione con il trasporto di materiale incandescente (Steiner 2013, fig. 2). È stato ipotizzato che questi oggetti realizzati sul posto, che trovano confronti presso abitati palafitticoli, fossero deposti a intervalli regolari dopo cerimonie rituali, con una fre-quentazione del luogo protrattasi per circa trecento anni, dal IX al VI secolo a.C. (Steiner 2013).
Per quanto riguarda questo genere di siti di alta montagna, si confrontano diverse opinioni in merito al loro significato e alle dinamiche storiche che secondo Gleirscher vedono nell’età del bronzo una iniziale proiezione dei luoghi di culto in quota, seguita nell’età del ferro da un ripiegamento verso i fondovalle (Gleir-scher 1996; 2002). L’autore distingue zone di culto a carattere locale che si configurano come “santuari di villaggio” e di impor-tanza sovralocale (Gleirscher 1996). Umberto Tecchiati rileva la loro ricorrenza nel corso del Bronzo Recente e Finale, segnalando che “La componente paesaggistica estrema, ‘la prossimità al cielo’ ed eventualmente all’acqua come a Seeberg, e comunque l’estra-neità all’ecumene, fanno di questi santuari… una porta sul mondo ultraterreno” mentre nell’età del ferro i santuari tenderebbero a svilupparsi in prossimità degli insediamenti con connessioni fun-zionali (Niederwanger, Tecchiati 2000). Hubert Steiner invece mette in relazione i roghi votivi d’alta quota con l’intensificarsi, soprattutto nel Bronzo Recente e Finale, dello sfruttamento eco-
Paesaggi del culto nelle Alpi centro-orientali
319
nomico dei versanti montuosi per attività pastorali e di produzio-ne metallurgica (Steiner 2013).
In ambito nordalpino Hermann Parzinger ha individuato una tipologia di roghi votivi distinta da quella “canonica” per la man-canza di ritrovamenti ossei (Denk 2010). Più recentemente Paul Gleirscher, cui si deve il merito di avere ripreso l’argomento, in particolare alla luce delle indagini sistematiche condotte al Rung-ger Egg presso Siusi/Seis, ha proposto una più articolata chiave di lettura del fenomeno (Gleirscher 2002). Con interpretazioni inno-vative, lo studioso ha suscitato un vivace dibattito nel quale sono intervenuti vari autori di saggi e monografie dedicati al tema in generale e a risultati di scavi. Secondo Gleirscher i Brandopfer-plätze costituiscono l’elemento connotativo di zone santuariali dell’età del bronzo e del ferro nell’area alpina orientale e corri-spondono a siti con altari, luoghi di deposizione (Bothroi) e aree cerimoniali che possono presentare diverse caratteristiche (Gleir-scher 1996; 2002). Fra gli aspetti strutturali sempre Gleirscher segnala l’esistenza di altari “monumentali” definiti di tipo Rung-ger Egg, costituiti da grandi cumuli conici di pietre in qualche caso con tracce di alterazioni dovute al calore, talvolta considerati nella precedente letteratura come castellieri. I resti ossei combusti di animali domestici sono soprattutto di capre e pecore, con una particolare incidenza delle estremità (quest’ultima evoca la nota ripartizione delle vittime sacrificali attribuita nella dimensione del mito greco alla scaltrezza di Prometeo che avrebbe destinato gli arti alle divinità e le parti migliori agli uomini (Mandruzzato 2004), unitamente al dono di prodotti della terra, indicato da semi carbo-nizzati di cereali e di altre specie vegetali, inducono Gleirscher a riconoscere nei primi roghi votivi dell’età del bronzo aree santua-riali all’aperto di tipo agreste, a carattere comunitario (Gleirscher 1996; 2002). Nel corso dell’età del ferro la presenza fra le offerte di attrezzi, armi, elementi d’ornamento e oggetti votivi figurati, sono considerati dallo stesso autore riflesso dei contatti intercorsi fra le comunità alpine e quelle del mondo mediterraneo (fig. 3) (Gleirscher 2002; Waffen… 2012).
Come noto, quello dei roghi votivi rappresenta un’espressione di culto di lunga durata, riscontrabile dall’età del bronzo a quella del ferro e per tutta l’epoca romana, con un esaurimento nel Tar-do Antico e, secondo alcuni studiosi, addirittura agli esordi dell’Alto Medioevo (Zanier 1999; Appler 2006; Zemmer-Plank 1997; 2002). In alcune aree santuariali il ritrovamento di monete se da un lato testimonia una continuità di frequentazione del sito
Franco Marzatico
320
5. Istogramma della ricorrenza di manufatti in alta quota (da Neubauer, Stöllner 1994).
6. Pugnale in bronzo da Martell, Flur “Altkaser”, Val Martello/Martelltal (da Steiner, Mahlkencht 2008).
7. “Deposito sacro” di Ried nell’alta valle dell’Inn (da Sölder 2002).
fino in epoca romana, dall’altro lato non appare sufficiente per stabilire se e fino a che punto siano effettivamente proseguiti i precedenti rituali con l’uso di roghi votivi o se siano state intro-dotte nuove pratiche di culto.
Secondo le ricerche condotte da Gerhard Tomedi, la più antica attestazione di roghi votivi è emersa a Goldbichl presso Igls nella valle dell’Inn e si pone nell’avanzato Bronzo Antico (Bz A2), dato che l’autore non considera sufficientemente significative le tracce di fuochi rituali riconosciute al centro della valle dell’Adige nel sito del Pigloner Kopf dove, in uno scenario roccioso di forte sug-gestione, caratterizzato da correnti geotermali di aria calda, sono stati portati alla luce un ripostiglio di asce miniaturistiche in rame a occhio di tipo Fresach, materiali litici e ceramici (Tomedi, Nico-lussi Castellan 2007; Gleirscher, Oberrauch 2002). Anche altri siti di culto caratterizzati dalla presenza di fuochi rituali e offerte, fra i quali i Campi Neri di Cles, Mechel, Col de Flam e Lech Sant in Val Gardena/Grödental, Plörg sullo Sciliar/Schlern, Rungger Egg e Stenico nelle Valli Giudicarie, mostrano frequentazioni colloca-bili fra l’avanzata età del rame, il Bronzo Antico e Medio che sol-levano la questione dell’esatta determinazione dell’avvio del ritua-le, documentato in diversi siti perlomeno a partire dal Bronzo Medio, come indicano datazioni radiocarboniche e uno spillone del Bz C2 posto alla base dell’altare di ceneri sull’Hahnehütter Bödele (fig. 4) (Gleirscher 2002; Endrizzi et alii 2009; Steiner 2013). Le fasi di massimo sviluppo si collocano comunque fra la fine del Bronzo Recente e il Bronzo Finale, con l’affermarsi della cultura di Luco/Laugen e in concomitanza con il fiorire della cul-tura di Fritzens-Sanzeno (Marzatico 2000).
Tralasciando le testimonianze funerarie (molto alterne dal pun-to di vista sia della distribuzione geografica sia della rappresenta-tività sotto il profilo cronologico-culturale), i roghi votivi sono un fenomeno a carattere non “esclusivo” in quanto, come risaputo, coesistono con altre manifestazioni che rientrano pure nella sfera delle credenze magico-religiose. Ci si riferisce da un lato a reperti che, per quanto presenti anche in contesti d’abitato, esprimono intrinsecamente credenze magico-religiose, come astragali o altri resti ossei o in corno con iscrizioni e sigle alfabetiche, alle cosid-dette verghette divinatorie e ai probabili trofei costituiti da elmi, ma anche a oggetti, come le chiavi, che al di là della loro destina-zione pratica possono assumere valenze simboliche e rituali (Zem-mer-Plank 2002). Dall’altro lato vanno annoverati i ripostigli che per la loro composizione o ubicazione sono ricondotti nell’alveo
Franco Marzatico
322
delle espressioni del culto e i ritrovamenti collegati alla presenza di specchi e corsi d’acqua – ai Flussfunde – già ampiamente analiz-zati da Umberto Tecchiati e da altri autori (Gleirscher 1996; Tec-chiati 2002; Steiner 2010). La coesistenza con i roghi votivi come noto include anche i cosiddetti Hohenfunde, le deposizioni di sin-goli oggetti in quota su valichi, vette o lungo vie di collegamento, presentati a suo tempo da Neubauer e Stöllner con diagrammi statistici che mostrano un picco del fenomeno nel corso del Bron-zo Recente (fig. 5) alla cui conclusione, con la cultura di Luco/Laugen, i roghi votivi conoscono, come già accennato, un’ampia diffusione (Neubauer, Stöllner 1994). Nel medesimo studio la diversa incidenza di ritrovamenti delle stesse classi di materiali in quota, entro fiumi, in tombe e in ripostigli sembra mostrare pro-babili interferenze dal punto di vista dei rituali di deposizione. D’altra parte nel caso della scoperta a 1800 metri s.l.m. in Val Martello/Martell Flur ad Alkaser di un pugnale datato al Bronzo Antico avanzato (fig. 6), all’ubicazione in alta quota si aggiungono condizioni d’ambiente umido e pertanto in questa circostanza paiono sommarsi caratteristiche topografiche considerate deter-minanti per i “paesaggi” del culto (Steiner, Mahlkencht 2008).
Per altri ritrovamenti, come ad esempio i famosi diademi del Bronzo Medio provenienti dalla palafitta di Molina di Ledro che recano motivi decorativi simbolici legati a credenze magico-reli-giose, al di là della loro connessione con la sfera cerimoniale, l’e-segesi resta ambigua per via della carenza di dati di scavo e del contesto apparentemente insediativo. Sempre a titolo d’esempio, margini di incertezza sussistono anche per il ritrovamento a Ried nella valle dell’Inn di un’alabarda, un collare a capi aperti con estremità a rotolo, un’ascia, spirali coniche in bronzo e vaghi in ambra della fine Bronzo Antico (fig. 7) che non è accertato se costituissero un corredo tombale o una sorta di ripostiglio (Sölder 2002). Alla luce del significato probabilmente cultuale ascritto alle figurine fittili di cavalli scoperte nella terramara di Poviglio è pos-sibile – ma non accertabile in modo incontrovertibile – che anche gli esemplari di bovini dalla palafitta di Fiavé e quello zoomorfo stilizzato da Romagnano si inseriscano nell’ambito delle espressio-ni di credenze magico-religiose (Marzatico 2012). E per i boccali di tipo Luco/Laugen che ricorrono presso roghi votivi, in genere in stato molto frammentario, resta a livello di ipotesi suggestiva la loro caratterizzazione ginecomorfa, dovuta alla coppia di bitorzo-li frontali che alluderebbero ai seni (Niederwanger, Tecchiati 2000).
Paesaggi del culto nelle Alpi centro-orientali
323
Per quanto riguarda i ripostigli, come risaputo, non sempre è possibile operare una netta distinzione fra “connotazione sacra” o “destinazione profana”, peraltro secondo una dicotomia che più autori considerano eccessivamente rigida, frutto di un’imposta-zione “modernista” che tenderebbe a sottovalutare il peso deter-minante delle componenti mistico-religiose di cui in epoca antica doveva essere pervasa l’intera esistenza, comprese le attività pro-duttive (Denk 2010). In questo senso si può citare l’interpretazio-ne discordante del ripostiglio di Arbedo in Canton Ticino che, deposto attorno alla metà del V secolo a.C., è costituito da oggetti riferibili in prevalenza al VI secolo a.C. ma anche da manufatti di origine greca ed etrusca e di fasi precedenti, con limite superiore nell’età del Rame (Schindler 1998). Gleirscher ritiene che questo ricco complesso di materiali in metallo fosse in relazione con pra-tiche di culto, forse con l’usanza di roghi votivi (Gleirscher 1996; 2002). Martin Schindler reputa invece si tratti di materiale metal-lico destinato al riciclaggio nell’ambito di attività di fonderia, identificate anche a Parre nel Bergamasco e a Vandoies di Sopra/Obervintl in Alto Adige/Südtirol dove il primo autore riconosce invece una funzione cultuale del sito (Schindler 1998).
A nord del Passo di Resia nel territorio di Fliess, attraversato da un antico percorso di importanza strategica, il ripostiglio del Bronzo Medio di Piller, composto da circa 360 pezzi che coprono un arco di tempo fra il 1550-1330 a.C. e quello di Fliess costituito da 385 manufatti deposti nel VI secolo a.C., definiscono un vasto paesaggio cultuale che comprende anche altari di pietra (fig. 8) e ceneri nel santuario di Pillerhöhe e offerte di singoli oggetti a par-tire dal Bronzo Antico fino a epoca romana, quando vengono uti-lizzate monete (Tomedi 2004; Stefan 2010). Mentre in questo sito le offerte sembrano definire una sorta di rete di itinerari “sacri”, ai Campi Neri di Cles, in Val di Non, dove poderose opere di boni-fica furono realizzate a più riprese (nel Bronzo Finale, seconda età del ferro ed epoca romana) per contrastare il dissesto idrogeologi-co, sono stati portati alla luce veri e propri percorsi stradali, delle vie “con evidenti funzioni rituali” (fig. 9) (Endrizzi et alii 2009). Nello stesso sito sono state individuate quasi 200 fosse di combu-stione colmate da pietre e ciottoli che, inquadrabili fra il Bronzo Recente e Finale (fig. 10), trovano confronti nel luogo di culto in alta quota sullo Sciliar ma anche in abitati (Endrizzi et alii 2009; Haupt 2010).
Il repertorio dei manufatti portati alla luce in corrispondenza di roghi votivi è piuttosto vario e comprende diverse classi di
Paesaggi del culto nelle Alpi centro-orientali
325
materiali, da oggetti d’ornamento in metallo – soprattutto fibule – e pasta vitrea a elementi d’armamento, attrezzi da lavoro, conte-nitori in ceramica e metallici, bronzetti, lamine ritagliate in forma di scudo o con profili zoomorfi e antropomorfi (fig. 3a-b, d-e), questi ultimi senza dubbio introdotti attraverso contatti con il mondo etrusco-italico. Sono inoltre rappresentati, ma più occa-sionalmente, scorie di fusione e oggetti semi lavorati, come nel caso del sito di Farchant presso Garmisch-Partenkirchen in Bavie-ra e del Ciaslir del monte Ozol in Val di Non dove a m 1515 sono stati individuati roghi votivi della cultura di Luco/Laugen, seguiti nella prima età del ferro dall’impianto di un’officina metallurgica e dal sacrificio di diciotto capre (Marzatico 2000; Lang 2002).
Il ritrovamento presso roghi votivi di prodotti esotici, da fibule a pendagli, a elementi di cintura come quelli di tipo sannitico o di tipo celtico da Mechel, insieme a resti di ceramica attica, lascia aperta la possibilità di frequentazioni da parte di individui “stra-nieri” di passaggio o integrati nel contesto sociale locale, oppure che fossero donati alle divinità bottini o oggetti di scambio. La presenza di santuari in punti nodali “di frontiera”, come quello di Pillerhöhe a nord del passo di Resia, indica chiaramente, insieme ai manufatti esotici, che tali luoghi potevano connotarsi come cen-tri di scambio (Stefan 2010).
In base alla natura delle offerte, nel sito di Farchant presso Garmisch-Partenkirchen in Baviera si suppone che i devoti fosse-ro esponenti della componente maschile della comunità (Lang 2002).
Fra la documentazione ceramica la ricorrenza di frammenti di boccali e di tazze hanno indotto in qualche caso a ipotizzare, oltre all’accensione di fuochi con offerte sacrificali, libagioni e pratiche di tipo simposiale, peraltro in una cornice che sembra caratteriz-zata da nessi con situazioni ambientali e fenomeni naturali, piutto-sto che dall’elevazione di strutture architettoniche complesse e durature (se si escludono gli altari in pietra emersi in più siti e le poderose opere di bonifica con le “vie sacre” dei Campi Neri di Cles) (Gleirscher 2002; Endrizzi et alii 2009; Steiner 2010). Gli elementi strutturali consistono infatti generalmente in altari for-mati da accumuli di pietre (attestati ad esempio al Pillerhöhe, S.Valburga/St. Walburg e Breno), di ceneri (come sull’Hahnehüt-ter Bödele, fig. 4a, e sempre a Pillerhöhe), fosse di combustione, avvallamenti, allineamenti e recinti litici, assimilati da alcuni auto-ri a bothroi e temenoi. D’altra parte le relazioni fra gli altari alpini e quelli del mondo mediterraneo, in particolare greco, inizialmen-
8. Altare in pietra di Piller Sattel presso Fliess, Nord Tirolo (da Zemmer-Plank 1997).
9. Campi Neri di Cles, in valle di Non, “Via sacra” in uso nel corso della seconda età del ferro (da Endrizzi et alii 2009).
10. Campi Neri di Cles, in valle di Non, fossa di combustione dell’età del Bronzo Finale (da Endrizzi et alii 2009).
11. Planimetria dell’area di culto di S.Valburga/St.Walburg in Val d’Ultimo/Ulten con dieci altari in argilla allineati (nn. 1-10) (da Steiner 2010).
12. Campi Neri di Cles, in valle di Non, struttura a recinto circolare connessa a pratiche cultuali/funerarie dell’età del rame (da Endrizzi et alii 2009).
Franco Marzatico
326
te prospettate da Krämer, non hanno trovato sostegno con la pro-secuzione delle ricerche, come evidenziato, in base a considerazio-ni di ordine cronologico e tipologico-culturale, da Rainer-Maria Weiss e inoltre da Heiko Riemer cui si deve la pubblicazione degli altari di ceneri emersi nel santuario di Reitia di Este, avvicinati ai roghi votivi (Weiss 1997; Riemer 2005, p. 335; Steiner 2010). Nel caso singolare di dieci piattaforme in argilla allineate, individuate a S. Valburga/St. Walburg (fig. 11), fra i raffronti richiamati da Hubert Steiner sono comunque annoverati gli altari di Lavinio (Steiner 2010).
I roghi votivi si configurano in definitiva come aree santuariali all’aperto, dato che allo stato attuale delle ricerche mancano evi-denze di edifici templari, per quanto sull’Hahnehütter Bödele presso il Ganglegg, a S. Valburga/St. Walburg, a Farchant e a Scuol-Motta Sfondraz in Engadina siano state riconosciute tracce di modeste costruzioni che è possibile avessero una qualche fun-zione sacra, così come non è escluso per i il sito di Goldbichl pres-so Igls (Gleirscher 2002; Endrizzi et alii 2009; Rageth 2013). Ana-loga ipotesi su una particolare destinazione nella sfera del culto e cerimoniale è stata avanzata per la costruzione n. 2 dei Montesei di Serso presso Pergine Valsugana, in quanto eccezionalmente dotata di due ingressi e contenente iscrizioni in caratteri dell’alfa-beto retico su ciottoli e su segmenti di corna di cervo (Endrizzi et alii 2009). Discussa resta la funzione degli edifici della seconda età del ferro accorpati con muri a secco in comune dei Casalini di Sanzeno: se nella bibliografia italiana sono generalmente conside-rati come luoghi di residenza e case-botteghe per la produzione metallurgica, in quella di lingua tedesca sono invece per lo più definite come “case tesoro” - Schatzenhäuser per via dell’abbon-danza di manufatti in metallo tesaurizzati e per il ritrovamento di oggetti che esprimono credenze magico-religiose, come nel caso dei celebri bronzetti, già definiti come “ex-voto” (Bergonzi Piana Agostinetti 1997; Zemmer-Plank 1997; Adam 2006) .
Il ritrovamento di sepolture o di ossa umane in aree santuariali interessate in tempi diversi dai roghi votivi, come ad esempio al Rungger Egg, Campi Neri di Cles, Mechel, Stenico, Noafer Bühl nei pressi di Gries e a Le Sante in Valcamonica dove secondo Serena Solano fra il III-II secolo a.C. fino al IV-V d.C. si sviluppò “una sorta di Brandopferplatz che aveva probabilmente una valen-za funeraria”, così come la discussa situazione di Kundl in nord Tirolo pongono interrogativi sul significato di queste presenze. Ci si chiede infatti se siano rapportabili a qualche forma di culto di
Paesaggi del culto nelle Alpi centro-orientali
327
antenati eroizzati, come ipotiz-zato per la necropoli golasec-chiana di Pombia in Piemonte o se oltre all’offerta di animali, vegetali e manufatti, fossero sacrificati esseri umani (Gamba-ri 2001; Gleirscher 2002; Endrizzi et alii 2009). Il tumulo del Bronzo Medio di Stenico in corrispondenza del quale si svi-lupparono roghi votivi attivi fino nel La Téne D e le più anti-che evidenze dei Campi Neri di Cles, rappresentate da strutture circolari di pietre con presenze
di resti umani e strumenti litici dell’età del rame esposti al calore o frammentati (fig. 12), potrebbero in effetti deporre in questo senso (Marzatico 2000; Endrizzi et alii 2009). D’altra parte se si esclude un’iscrizione che menziona a Tesero in valle di Fiemme, in una “casa di tipo retico”, il dio celtico Taranis, le divinità oggetto di culto non sono ancora state identificate e ci si deve pertanto limitare a constatare che nel quadro delle testimonianze figurative accanto a devoti che seguono i modelli etruschi, sono attestati bronzetti di Ercole, di Marte o di guerriero e di una “Signora dei cavalli” (fig. 13), nonché il tema simbolico della barca solare con uccelli (Vitali 2001; Bagnasco Gianni 1999; Gleirscher 2002, Ros-si 2010; Marzatico 2012). È stato ipotizzato che i roghi votivi cor-rispondano a un culto di tipo agreste della fertilità “con legami in direzione del culto romano di Saturno (che in area alpina rappre-senterebbe una interpretatio romana), o che vi siano dei paralleli-smi in direzione di Artemide” (Endrizzi et alii 2009). A Spinera di Breno il succedersi a roghi votivi di aree santuariali dedicate a Minerva offre un indizio importante (Solano 2008; Rossi 2010). A Breno fontane e cavità mostrano il legame del santuario romano monumentale – dove è emersa l’immagine della divinità (una sta-tua in marmo pentelico, copia dell’Athena Hygeia di Pirro) – con “la pratica di un culto delle acque” e grazie anche ad altre testimo-nianze si individua “nella rupe percorsa da grotte e ricca di sorgi-ve naturali l’elemento principe della sacralità del luogo” (Solano 2008, p. 191). La sorgente del Rungger Egg, l’acqua presso la fen-ditura rocciosa di Telfes nella Stubaital a nord del passo del Bren-nero, la fonte sulfurea di San Maurizio/Moritzing presso Bolzano
13. Pendagli del tipo “Signora dei cavalli” retico alpino: a-b. Da Sanzeno; c. Da Cavedine; d. Dal luogo di culto di Ampass Demlfeld; e. Luogo sconosciuto (da Marzatico 2002).
Franco Marzatico
328
dove sono stati portati alla luce oltre 3000 anelli in bronzo, insie-me ad altri siti dove l’acqua pare una componente paesaggistica determinante, lasciano in definitiva intravedere un nesso partico-lare fra questo elemento naturale e l’accensione di fuochi rituali, accompagnati da sacrifici e offerte di manufatti (Gleirscher 1996; Niederwanger, Tecchiati 2000; Steiner 2010). È del resto noto come il “rapporto tra divinità del fuoco e le acque” faccia parte della tradizione mitico-religiosa occidentale e come intercorra per entrambe una relazione con riti catartici (Mandruzzato 2004).
Paesaggi del culto nelle Alpi centro-orientali
329
A.-M. AdAM 2006Dépôts d’objets métalliques du second âge du Fer dans le nord-est de l’Italie et les Alpes orientales, in G. Bataille, J.P. Guillaumet (a cura di), Les dépôts métalliques au second âge du Fer en Europe tempérée, Atti della tavola rotonda, Collection Bibracte 11, Glux-en-Glenne, pp. 135-145.
H. Appler 2006Das Köchler Köpfl. Ein Opferplatz der Bronze-, Eisen- und römischen kaiserzeit im Nordtiroler Inntal, in Römisches Österreich. Jahresschrift der Österreichischen gesellschaft für archäologie 29, pp. 37-87.
H. Appler 2007Zwei Opferplätze der Eisen- und Römischen Kaiserzeit im Grossraum Innsbruck, in Römisches Österreich. Jahresschrift der Österreichischen gesellschaft für archäologie, 30, pp. 1-43.
G. BAGnAsco GiAnni 1999L’Harpax come corona di luce, in M. Castoldi (a cura di), Koivά. Miscellanea di studi archeologici in onore di Piero Orlandini, Milano, pp. 123-142.
G. BerGonzi, p. piAnA AGostinetti 1997 La seconda età del ferro nelle Alpi centrali, in La Valle d’Aosta nel quadro della Preistoria e Protostoria dell’arco alpino centro-occidentale, Atti della XXXI Riun. Sc. IIPP, Firenze, pp. 368-369.
i. denk 2010(Brand-) Opferplätze im außeralpinen Bereich. Ein Diskussionsbeitrag, in F. Mandl, H. Stadler (a cura di), Archäologie in den Alpen. Alltag und Kult, Anisa 3, pp. 7-14.
l. endrizzi, n. deGAsperi, F. MArzAtico 2009Luoghi di culto nell’area retica, in Altnoi. Il santuario altinate: strutture del sacro a confronto e i luoghi di culto lungo la via Annia, Atti del convegno, Altinum. Studi di archeologia, epigrafia e storia, 5, pp. 263-292.
F.M GAMBAri 2001Aspetti del rito nella necropoli di Pombia, in M.F. Gambari (a cura di), La birra e il fiume. Pombia e le vie dell’Ovest Ticino tra VI e V secolo a.C., Catalogo della mostra, Beinasco, pp. 93-98.
p. GleirscHer 1996Brandopferplätze, Depotfunde und Symbolgut im Ostalpenraum während der Spätbronze- und Früheisenzeit, in P. Schauer (a cura di), Archäologische Forschungen zum Kultgeschehen in der jüngeren Bronzezeit und frühen Eisenzeit Alteuropas, Atti del convegno, Regensburger Beiträge zur prähistorischen Archäologie 2, Regensburg, pp. 429-449.
p. GleirscHer 2002Brandopferplätze in den Ostalpen, in P. Gleirscher, H. Nothdurfter, E. Schubert, Das Rungger Egg. Untersuchungen an einem eisenzeitlichen Brandopferplatz bei Seis am Schlern in Südtirol, Römisch-Germanische Forschungen 61, Mainz, pp. 173-262.
p. GleirscHer, H. oBerrAucH 2002In dono agli dei - Culti al tempo di Ötzi, Catalogo della mostra, Bolzano.
p. GleirscHer, H. notHdurFter, e. scHuBert 2002Das Rungger Egg, Römisch-Germanische Forschungen 61, Mainz am Rhein.
p. HAupt 2010Bronze- und eisenzeitliche Brandopferplätze auf dem Schlern, in F. Mandl, H. Stadler (a cura di), Archäologie in den Alpen. Alltag und Kult, in Anisa, 3, pp. 63-72.
s. Hye 2013Das eisenzeitliche Heiligtum am Demlfeld bei Ampass, Tirol, in H. Stadler, S. Leib, T. Gamon (a cura di), Brandoferplätze in den Alpen. Das Scheibenstuhl in Nenzing, “Nenzing 6 / Praearchos”, 3, pp. 49-58.
W. kräMer 1966Prähistorische Brandopferplätze, in R. Degen, W. Drack, R. Wyss (a cura di), Helvetia Antiqua. Festschrift Emil Vogt. Beiträge zur Prähistorie und Archäologie der Schweiz, Zürich, pp. 111-122.
A. lAnG 2002Der hallstattzeitliche Brandopferplatz auf dem Spielleitenköpfl bei Farchant, Lkr. Garmisch-Partenkirchen, in L. Zemmer-Plank (Hrsg.), Kult der Vorzeit in den Alpen: Opfergaben – Opferplätze - Opferbrauchtum / Culti nella preistoria delle Alpi: Le offerte - I santuari – I riti (Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer / Collana della Comunità di lavoro regioni alpine; Arge Alp, 1), Bozen / Bolzano, Parte 2, pp. 811-831.
e. MAndruzzAto 2004 Introduzione a Eschilo. Prometeo incatenato, Milano.
F. MArzAtico 2000La seconda età del Ferro, in M. Lanzinger, F. Marzatico, A. Pedrotti (a cura di), Storia del Trentino, I, La preistoria e protostoria, Bologna, pp. 479-573.
Bibliografia
Franco Marzatico
330
F. MArzAtico 2012Testimonianze figurative nel bacino dell’Adige fra l’età del Bronzo e l’età del Ferro, in “Preistoria alpina”, 46, II, pp. 309-332.
W. neuBAuer, t. stöllner 1994Überlegungen zu bronzezeitlichen Höhenfunden anhand eines kürzlich in der ostschweiz gefunden Vollgriffmessers, in JahrZentrMusMainz 41, pp. 95-145.
G. niederWAnGer, u. teccHiAti 2000Acqua Fuoco Cielo. Un luogo di roghi votivi di minatori della tarda età del Bronzo, Bolzano-Wien.
A. putzer 2012Von Bernstein und Hirtinnen - Prähistoriche Widewirtschaft im Schnalstal in Südtirol, in ArchKorrespondenzblatt 2, pp. 153-170.
J. rAGetH 2013Brandopferplätze in Graubünden, in H. Stadler, S. Leib, T. Gamon (a cura di), Brandoferplätze in den Alpen. Das Scheibenstuhl in Nenzing, Nenzing 6 / Praearchos 3, pp. 59-68.
H. rieMer 2005Die aschenältare aus dem Reitia-Heiligtum von Este im Mitteleuropäischen und Mediterranen vergleich (mit beiträgen von Henriette Manhart und Rainer Pasternak) / Gli altari di Ceneri del Santuario di Reitia a Este nel contesto centro-europeo e mediterraneo (con contributi di H. Manhart e R. Pasternak), Studien zu vor- und frühgeschichtlichen heiligtümern 4; Il Santuario di Reitia a Este 3, Mainz am Rhein.
F. rossi 2010(a cura di), Il santuario di Minerva. Un luogo di culto a Breno tra protostoria ed età romana, Milano.
l. sAlzAni 1996-1997Il sito protostorico di Custoza (Sommacampagna – Verona), in Padusa XXXII/XXXIII, n.s., pp. 7-45 [stampa 1999].
G. sAssAtelli 1999Nuovi dati epigrafici e il ruolo degli etruschi nei rapporti con l’Italia nord-orientale, in Protostoria e Storia del “Venetorum Angulus”, Atti del XX Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Pisa - Roma, pp. 453-474.
M.p. scHindler 1998Der Depotfund von Arbedo TI und die Brobnzedepotfunde des Alpenraums vom 6. bis zum Beginn des 4. Jh. V.Chr. Il ripostiglio di Arbedo TI e i ripostigli di bronzi della regione alpina dal VI all’inizio del IV sec. A.C. Antiqua 30, Basel.
B. scHMid-sikiMić 1999Wartau Ochsenberg (SG) – Ein AlpinerBrandopferplatz, in P. Della Casa (a cura di), Prehistoric alpine environment, society, and economy, Atti del Colloqui internazionale PAESE ‘97, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 55, Bonn, pp. 173-182.
s. solAno 2008L’area archeologica di Capo di Ponte (Brescia), loc. Le Sante: ustrinum o Brandopferplatz?, in Notizie archeologiche bergomensi 16, pp. 169-213.
W. sölder 2002Zur Urgeschichte und Römerzeit in Nordtirol, in Zeugen der Vergangenheit. Archäologisches aus Tirol und Graubünden, Innsbruck, pp. 19-75.
W. steFAn 2010(a cura di), Der Brandopferplatz auf der Piller Höhe in Fließ, in Schriften mvsevm Fliess 3.
H. steiner, M. MAHlkencHt 2008Ein frühbronzezeitlicher Dolch aus Martell, Flur „Altkaser“, Der Schlern 82, pp. 4-25.
H. steiner 2010Alpine Brandopferplätze. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen, Forschungen Zur Denkmalpflege in Südtirol, vol. V, Trento.
H. steiner 2013Vorgeschichtliche Brandopferplätze im Hochgebirge, in H. Stadler, S. Leib, T. Gamon (Hrsg.), Brandoferplätze in den Alpen. Das Scheibenstuhl in Nenzing, Nenzing 6 / Praearchos 3, pp. 89-111.
u. teccHiAti 1999(a cura di), Culti nella preistoria delle Alpi. Le offerte - I santuari - I riti, Catalogo della mostra itinerante, ed. italiana a cura di U. Tecchiati, Bolzano-Vienna.
u. teccHiAti 2007Manifestazioni di culto nella preistoria e nella protostoria del corso alpino dell’Adige. Proposte interpretative e spunti metodologici, in Il Baldo nell’antichità, Atti del primo incontro di studi e ricerche archeologiche, Quaderni culturali caprinesi - Archeologia 2, pp. 40-61.
G. toMedi 2004Der bronzezeitliche Schatzfund vom Piller. (Gemeinde Fließ, Nordtirol), Begleitheft zur Ausstellung im Archäologiemuseum Fließ, Schriften Museum Fliess 1, Oberndorf (Salzburg).
Paesaggi del culto nelle Alpi centro-orientali
331
G. toMedi, H. Appler 1999Die Siedlungskammer Ampass nach ihren archäologischen Quellen, in G. Tomedi, J. Zeisler (a cura di), ArchaeoTirol, Kleine Schriften 1, Schriften zur Archäologischen Landeskunde Tirols, Wattens, pp. 60-86.
G. toMedi, s. nicolussi cAstellAn 2007Ein Heiligtum der Bronze- und Eisenzeit am Goldbichl bei Igls, in Ur- und Frühgeschichte von Innsbruck, Catalogo della mostra, Innsbruck, pp. 69-77.
G. toMedi, A. putzer 2007Siedlung und Kultplatz auf dem Bergisel, in Ur- und Frühgeschichte von Innsbruck, Catalogo della mostra, Innsbruck, pp. 79-87.
M. tscHutscHentHAler, u. Wein 1998Das Heiligtum auf der Pillerhöhe und seine Beziehungen zur Via Claudia Augusta, in E. Walde (a cura di), Via Claudia. Neue Forschungen, Innsbruck, pp. 227-259.
d. VitAli 2001Luoghi di culto e santuari celtici in Italia, in S. Vitri, F. Oriolo (a cura di), I Celti in Carnia e nell’arco alpino centro orientale, Atti della Giornata di studio, Trieste, pp. 279-301.
Waffen… 2012Waffen für die Götter. Krieger Trophäen Heiligtümer, Catalogo della mostra, Innsbruck.
r.-M. Weiss 1997Prähistorische Brandopferplätze in Bayern, Internationale Archäologie 35, Espelkamp.
W. zAnier 1999Brandopferplatz Forggensee, Münchner Beiträge zur vor- und Frühgeschichte, 52.
L. zeMMer-plAnk 1997(a cura di), Kult der Vorzeit in den Alpen: Opfergaben - Opferplätze - Opferbrauchtum, Catalogo della mostra, Innsbruck.
L. zeMMer-plAnk 2002(a cura di), Kult der Vorzeit in den Alpen: Opfergaben - Opferplätze - Opferbrauchtum / Culti nella preistoria delle Alpi: Le offerte - I santuari - I riti, Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer / Collana della Comunità di lavoro regioni alpine; Arge Alp, 1, Bozen / Bolzano.
332
Franco Marzatico
Riassunto / Abstract
332
La definizione dei paesaggi cultuali nell’area alpina centro-orientale e, più in particolare, il fenomeno dei cosiddetti Brandopferplätze o roghi votivi, da oltre un ventennio sono al centro del dibattito scientifico. Dal punto di vista topo-grafico si registra una notevole variabilità della localizzazione di queste aree di culto, indicate dalla presenza di livelli con ceneri, carboni e ossi calcinati, ac-compagnati dalla presenza (molto variabile) di manufatti e di strutture come altari di pietre e di ceneri, fosse di combustione e allineamenti. Questo genere di aree santuariali è infatti nota in siti di fondovalle e su rilievi, su pendii e ver-santi, inoltre alle alte quote, in diversi casi in prossimità di specchi d’acqua. Quello dei roghi votivi rappresenta un’espressione di culto di lunga durata, ri-scontrabile dall’età del Bronzo a quella del Ferro e per tutta l’epoca romana, con un esaurimento nel Tardo Antico e, secondo alcuni studiosi, addirittura agli esordi dell’Alto Medioevo. È stato ipotizzato che corrispondano a un culto di tipo agreste della fertilità “con legami in direzione del culto romano di Satur-no (che in area alpina rappresenterebbe una interpretatio romana), o che vi sia-no dei parallelismi in direzione di Artemide”.
For more than twenty years, the definition of cultural landscapes in the Central Eastern Alpine area, particularly the phenomenon of the so-called Brandopfer-plätze or burnt-offerings, is the focus of scientific debate.From a topographical viewpoint, there is a notable variability in the localization of these cult areas, indicated by the presence of levels of ash, charcoal and calci-fied bone, accompanied by the presence (highly variable) of artefacts and struc-tures such as stone and ash altars and combustion pits and alignments of stones. This type of sanctuarial area is in fact noted at sites in valleys and elevations, on hill and mountainsides and in addition to the high altitudes, near bodies of water in many cases.The burnt-offerings represent a long-term worship ascertained in the Bronze Age to that of the Iron Age, throughout the Roman period, dwindling in Late Antiq-uity but present even up to the beginnings of the early Middle Ages, according to some scholars. It has been speculated that they correspond to a rural type of fertility cult “with connections towards the Roman worship of Saturn (that would represent a Roman interpretation in the Alpine area), or that there are parallelisms in the direction of Artemis.”
13
25
35
53
65
77
89
101
129
143
157
159
160
163
169
191
193
Volume IEtruria e Lazio
Paesaggi cerimoniali: la messa in scena dell’ideologia funerariaNuccia Negroni Catacchio
Discussione
I luoghi di culto dell’età del rame in ItaliaDaniela Cocchi Genick
Luoghi di culto e arte rupestre in siti particolari o lungo vie di comunicazioneRenata Grifoni Cremonesi
Alla ricerca degli spazi nascosti: cerimonie, riti e sacralità pubbliche e private in contesti domestici toscani del Neolitico e dell’età dei metalliLucia Sarti - Nicoletta Volante
Riflessioni sui paesaggi cerimoniali delle statue stele della LunigianaEmanuela Paribeni - Roberta Iardella - Ivo Tiscornia
La Grotta di Diana (Mulazzo, MS) Anna Maria Tosatti - Francesco Carrera
Rituali d’altura: il monte Amiata e l’inghiottitoio di Poggio La SassaiolaChristian Metta
Tombe a camera del Bronzo MedioRituali di deposizione e rituali di celebrazioneMatteo Aspesi - Giulia Pasquini
Dietro il sacro sigillo. Testimonianze dell’età del bronzo dal santuario rupestre di Demetra-Vei-Cerere a Macchia delle Valli (Vetralla, VT) Patrizia Petitti - Carlo Persiani - Anna Maria Conti
Discussione
Paesaggi cerimoniali e società: continuità e discontinuità delle forme del culto in Italia centrale alle soglie della svolta proto urbana (riassunto)Flavia Trucco - Vincenzo d’Ercole - Giorgia Francozzi - Claudio Cavazzuti
Discussione
I rapporti dei luoghi funerari e rituali-cultuali con le aree insediative nel Bronzo FInale. Considerazioni sui criteri di analisiRita Paola Guerzoni
I luoghi funerari e rituali-cultuali del Bronzo Finale in rapporto con le aree insediative in ambiti del versante medio-tirrenicoRita Paola Guerzoni - Giovanni Anselmi - Elisa Capuccella - Annarita Cataldo - Emanuel Di Pietro - Maria Francesca Gioia - Benedetta Martini - Gian Marco Volpi
Discussione
Considerazioni sulle aree rituali della valle del fiume FioraIl caso dell’Acropoli A delle Sparne Alessandro Zanini
Indice generale
209
211
231
233
234
245
263
269
281
301
315
333
347
351
363
385
Un luogo di culto sulla vetta del Monte Cimino alle soglie della svolta protourbana (riassunto)Barbara Barbaro - Andrea Cardarelli - Isabella Damiani - Francesco di Gennaro - Nicola Ialongo - Andrea Schiappelli - Flavia Trucco
Gli strumenti del rituale Una forma ceramica da Sorgenti della Nova: uso, significato, distribuzioneMassimo Cardosa
Discussione
Gli strumenti del rituale. Forme miniaturizzate dall’abitato di Sorgenti della Nova (Farnese, VT) (riassunto)Marco Romeo Pitone
Discussione
Lo spazio mentale del “maschile” a confronto: Verucchio e Veio spunti di riflessioneGiorgia Di Lorenzo
Le indagini archeologiche 2003-2007 nella stipe etrusca del Lago degli Idoli sul monte FalteronaLuca Fedeli
Paesaggio cerimoniale e senso di appartenenzaIl “complesso monumentale” di TarquiniaMaria Bonghi Jovino
Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei LariAngelo Amoroso - Francesco di Gennaro
Un paesaggio sacro del Latium vetus: l’evidenza archeologica e storicaAnna De Santis
Volume II Aree di confronto
Paesaggi del culto nelle Alpi centro-orientaliFranco Marzatico
Rocce a coppelle, elementi di un paesaggio progettato e monumentalizzatoContestualizzazione archeologica e ambientale nella regione alpinaAndrea Arcà - Francesco Rubat Borel
Il contributo del G.I.S. all’analisi del paesaggio funerario anticoIl caso della provincia di Cuneo nel I millennio a.C.Stefano Marchiaro
Paesaggi funerari ed evidenze cerimoniali: il caso della necropoli eneolitica di Celletta dei Passeri a ForlìMonica Miari
Luoghi di culto e culto dei luoghi nelle Marche durante l’età del bronzoGaia Pignocchi
I luoghi rituali e cultuali in rapporto con le aree insediative nel versante marchigiano tra le valli dell’Esino e del Musone nel corso del Bronzo FinaleIsabella Piermarini
391
401
407
419
433
443
461
481
497
515
529
543
551
565
579
Il complesso di Monte Primo di Pioraco lungo la vallata del Potenza tra sacralità e controllo del territorioGaia Pignocchi
Luoghi rituali e cultuali della tarda età del bronzo in rapporto con le aree insediative nell’ambiente eugubinoNicola Bruni
Un paesaggio cerimoniale della protostoria: il contesto della Grotta Di Cicco (Civitaluparella, CH)Tomaso Di Fraia
La monumentalizzazione del paesaggio funerario mediante circoli nel Bronzo Medio Casi di studio a confronto tra Italia meridionale e area transadriaticaIlaria Matarese - Elisabetta Onnis
Aspetti cultuali di alcuni ipogei neolitici nella Puglia centraleAlfredo Geniola - Rocco Sanseverino
Il popolo degli ipogei: religione, società e paesaggioAnna Maria Tunzi
Atti rituali e spazi cerimoniali paleolitici nell’ambiente di grottaLe evidenze di Grotta del Romito in CalabriaFabio Martini - Domenico Lo Vetro
Il paesaggio del sacro nella Sardegna nuragica Architetture celebrative e spazi cerimoniali nei luoghi di culto e nei santuari Anna Depalmas
Il villaggio-santuario di S’Arcu ’e is Forros in Ogliastra. Il più importante centro metallurgico della Sardegna nuragica e i suoi rapporti con l’Etruria minerariaMaria Ausilia Fadda
The Neolithic Ceremonial Landscape on the Coast of Litorina (Baltic) SeaIlze Biruta Loze
Paesaggi cerimoniali sotterranei: rituali di sepoltura in alcune caverne dell’ArmeniaArtur Petrosyan - Boris Gasparyan
Le tombe 229, 230 e 232 della necropoli di Lchashen (Armenia)Neda Parmegiani
Rituali suttee a confrontoSrednij Stog II e Rinaldone durante il IV millennio a.C.Javier Celma Ortiz de Guzmán
I santuari megalitici, paesaggi rituali e percorsi sacri a Malta tra IV e III millennio a.C.: il caso di Tas-SilgAlberto Cazzella - Giulia Recchia
La Necropole Megalithique De Kef Jder: Oued M’zi-Monts Des Amours (Atlas Saharien-Algerie)Aziz Tarik Sahed
595
615
625
637
641
651
653
667
669
681
689
691
709
731
733
747
751
755
775
777
781
Ricerche e scavi
Analisi tipologica e funzionale delle punte à cran epigravettiane della Grotta delle Settecannelle (Viterbo)Paola Ucelli Gnesutta - Emanuela Cristiani
Grotta dello Scoglietto (Alberese, Grosseto): aggiornamento sulle nuove ricercheLucia Sarti
La Collina di Spaccasasso: evidenze funerarie e minerarie nel Parco regionale della Maremma. Nuovi datiNicoletta Volante
Discussione
Dalla forma alla funzione. Analisi dei manufatti ceramici di un abitato dell’età del Rame (Le Cerquete-Fianello, Maccarese)Nadia Marconi
Discussione
Ricerche archeominerarie in Etruria meridionaleClaudio Giardino - Giuseppe Occhini - Patrizia Petitti - Daniel Steiniger
Discussione
Castiglion Fiorentino (AR), località Montecchio Vesponi Un punto d’insediamento della fine dell’età del bronzoLuca Fedeli - Roberta Iardella - Ada Salvi - Alessandro Zanini
Duna Feniglia (Orbetello, GR)I risultati delle ultime campagne di scavo (2011-2012) nell’area nord-occidentaleFabio Rossi - Lucia Campo - Irene Cappello - Massimo Cardosa - Alessandra Lepri - Mirko Luciano
Discussione
Sorgenti della Nova (Farnese VT). Il settore XII: una nuova struttura abitativaNuccia Negroni Catacchio - Chiara Fizzotti - Carlotta Finotti - Veronica Gallo - Christian Metta
Sorgenti della Nova: l’US 60 e la fase tarda dell’abitatoMassimo Cardosa, Matilde Kori Gaiaschi
Discussione
Paesaggi vulcanici nella Maremma tosco-laziale: un progetto di ricognizioneMatteo Aspesi - Christian Metta - Giulia Pasquini
La catalogazione delle collezioni private: le collezioni BocciClarissa Belardelli - Silvana Vitagliano
Trasformazione e uso del territorio lungo il paleoalveo dei Camaldoli in età protostorica (Villaricca, NA)Patrizia Gargiulo - Maria Ester Castaldo - Atala Grattarola - L. Caprio - M. De Luca
Navicelle nuragiche e tirreniche, testimonianze di marinerie protostoricheGiuseppa Lopez
Discussione
Elenco dei partecipanti
Elenco delle abbreviazioni