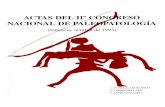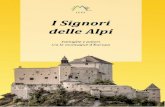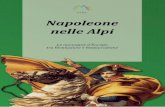Arqueología funeraria. Estado actual de la investigación en España
« Archeologia funeraria dei cimiteri altomedievali al sud delle Alpi svizzere : stato della...
Transcript of « Archeologia funeraria dei cimiteri altomedievali al sud delle Alpi svizzere : stato della...
A CURA DI VALERIA MARIOTTI
DINAMICHE INSEDIATIVENELLE ALPI CENTRALI TRA ANTICHITÀ E MEDIOEVO
STUDI E RICERCHEDI ARCHEOLOGIA2
ATTI DEL CONVEGNO (SONDRIO, 29 NOVEMBRE 2014)
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:21 Pagina 1
CON IL CONTRIBUTO DI
Curatela e redazione scientificaValeria Mariotti
Redazione, impostazione grafica, impaginazioneFrancesca Benetti - SAP Società Archeologica s.r.l.
© SAP Società Archeologica s.r.l.Strada Fienili, 39a - 46020 Quingentole (Mantova)
Tel. 0386-42591www.archeologica.it
ISBN: 978-88-99547-05-9
in copertina:Appiano, San Paolo: parte residenziale della villa romana
Mazzo di Valtellina: torre di PedenaleMuseo di Sondrio: iscrizione da Stazzona
in quarta di copertina: Grosio, Dosso dei Castelli: recipiente ceramicoRiva del Garda, via Brione: corredo di tomba
Grosio: Dosso dei Castelli Canton Grigioni (CH): chiesa di San Lucio
COORDINAMENTO SCIENTIFICO
la Conservazione Programmata nello spazio comune REtico
Provincia di Sondrio
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:21 Pagina 2
1Dinamiche insediative nelle Alpi centrali tra antichità e medioevo | a cura di Valeria Mariotti
indice
3
5
9
23
29
37
49
61
73
95
111
129
155
PresentazioneSergio Schena
PremessaValletellina quae coniungitur: le genti della Valtellina dalla protostoria alla storiaFilippo Maria Gambari
La Valtellina prima dei RomaniRaffaella Poggiani Keller
Un esempio di tutela del territorio Valtellinese: TeglioMaria Giuseppina Ruggiero, Stefania Lincetto
Epigrafia e lingua in Valtellina tra camuno e reticoAlessandro Morandi
Prima di Roma: modelli d’abitato ed edilizia nel mondo reticoFranco Marzatico
La romanizzazione della Valtellina nel contesto alpino centraleSerena Solano
Le Alpi, muraglione d’Italia... con tante porte (con riguardo alle Alpi centrali)Michel Tarpin
Tarda antichità e alto medioevo tra Alpi retiche e Prealpi tridentine: vecchi e nuoviprotagonistiEnrico Cavada
La regione Atesina tra tarda antichità e alto medioevo. Dati archeologici eclimatici a confrontoElisa Possenti
Archeologia funeraria e cimiteri altomedievali nelle Alpi svizzere meridionali: statodella ricerca e prospettive futureAixa Andreetta
Antichi percorsi di ValtellinaCristina Pedrana
ConclusioniElvira Migliario
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:21 Pagina 1
PREMESSA
La cronologia delle tombe, la loro connessione con gli edifici di culto così come la popolazione e le con-dizioni di vita dell’alto medioevo, sono tutt’oggi ancor poco conosciute nelle Alpi svizzere meridionali.
La nostra ricerca, condotta nell’ambito di una tesi di dottorato1, si propone di documentare questo pe-riodo, studiando approfonditamente 15 aree funerarie, indagate negli attuali territori dei cantoni Ticino eGrigioni, con un approccio interdisciplinare, che unisce dati archeologici in parte noti, dati antropologicidel tutto inediti e analisi chimiche sugli isotopi stabili intraprese per la prima volta.
Lo studio antropologico si basa sulle determinazioni di base, quali il sesso e l’età alla morte degli individuimediante analisi morfometriche, nonché lo studio delle patologie, in particolare le carenze vitaminiche.
Le analisi sugli isotopi stabili sono utilizzate per risalire alla provenienza degli alimenti e ricostruire i mo-vimenti migratori delle popolazioni, considerando nel nostro caso innanzitutto gli elementi di azoto, carbonioe zolfo. Con i risultati ottenuti si potranno delineare le modalità di interazione col territorio e in particolareconfrontare le risorse alimentari dei vari cimiteri studiati e quindi ricostruire, in parte, lo stile di vita2.
INTRODUZIONE E METODI
Le sepolture medievali delle Alpi svizzere meridionali si caratterizzano per l’assenza di corredo d’accom-pagnamento, quindi l’analisi archeologica, sulla quale ci focalizziamo in quest’articolo, si appoggia essenzial-mente sullo studio dell’architettura funeraria, il tipo di deposizione e la ripartizione spaziale delle sepolture3.
Affinché l’elaborazione dei dati potesse essere scientificamente valida, è stato essenziale affinare la cro-nologia dei contesti studiati. Per le datazioni assolute si è proceduto con una serie di analisi al radiocarbonio4,eseguite presso il laboratorio dell’istituto politecnico di Zurigo e poi calibrate secondo gli standard propostida Bronk Ramsey5: queste ci permettono di confermare o meno le ipotesi emerse dalla ricerca archeologicadi terreno, seppur l’intervallo di attendibilità (ritenuto quello a 2σ) comprenda generalmente qualche secolo.Con i risultati ottenuti abbiamo costruito le basi di una cronologia, che comprende ugualmente l’analisi dellesovrapposizioni e della stratigrafia orizzontale delle sepolture.
La sintesi delle osservazioni archeologiche raccolte e correlate permette di definire la crono-tipologiadelle tombe e di approcciare la topografia delle aree funerarie medievali e la loro organizzazione, sia a livellolocale che regionale6.
1 Ricerca presso l’Università di Berna, sotto la tutela della Prof. ChristaEbnöther, Dr. Susi Ulrich-Bochsler, Dr. Reto Marti, Dr. Sandra Lösch;finanziata dal Fondo Svizzero per la Ricerca scientifica (progettoCR11I1_143798) e l’Istituto Promozione Cultura Grigioni e in colla-borazione con i Servizi di Archeologia del Cantone Ticino e del Can-tone Grigioni. 2 Ulteriori dettagli sul progetto di ricerca in ANDREETTA 2013. 3 Si ringrazia Rossana Cardani Vergani per la rilettura critica.
4 Grazie al sostegno finanziario di: Fondazione Nägeli, AssociazioneArcheotalpa, Associazione Archeologica Ticinese.5 BRONK RAMSEY 2010. 6 I risultati dell’analisi antropologica verranno pubblicati nella RivistaArcheologica dell’Antica Provincia e Diocesi di Como, negli atti delconvegno “Luoghi, funzioni, trasformazioni tra tardoantico e primoMedioevo. Il territorio dell’antica provincia e diocesi di Como nei se-coli V-VI d.C.”, 24-25 ottobre 2014, n. 197, Como.
111Dinamiche insediative nelle Alpi centrali tra antichità e medioevo | a cura di Valeria Mariotti
ARCHEOLOGIA FUNERARIA E CIMITERI ALTOMEDIEVALI NELLE ALPI SVIZZERE MERIDIONALI: STATO DELLA RICERCA E PROSPETTIVE FUTURE
AIXA ANDREETTA
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 111
SITI STUDIATI
I cimiteri studiati sono collocati esattamente lungo le principali via di transito e rappresentano la migliorforma di attestazione dell’occupazione del territorio e dell’organizzazione dei villaggi medievali, vista la scarsadocumentazione scritta e i pochi villaggi conosciuti per l’epoca considerata, che va dal VI al XII secolo d.C.
Per questa ricerca sono stati esclusi casi isolati o piccoli insiemi e sono stati invece considerati tredici sitisul territorio dell’attuale canton Ticino (Leontica-San Giovanni Battista, Bellinzona-Castelgrande, Bioggio-San Maurizio, Ascona-Proprietà Wildi e Santi Fabiano e Sebastiano, Rovio-Santi Agata e Vitale, Gravesano-San Pietro, Melide-Santi Quirico e Giulietta, Rossura-Santi Lorenzo e Agata, Origlio-San Vittore, Stabio-SantiPietro e Lucia, Sonvico-San Martino, Muralto-San Vittore e Park Hotel) e due nella grigionese Val Masolcina(Mesocco-Benabbia, Gorda, Castello, e Roveredo-Valasc) (Fig. 1).
112 Dinamiche insediative nelle Alpi centrali tra antichità e medioevo | a cura di Valeria Mariotti
N
50 Km© U F F I C
I O C A N T O N A L E D E I B E N I C U L T U R A L I - S E R V I Z I O A R C H E O L O G I A - B E L L I N Z O N A
11
10
3
1
8
9
4
6
2
13
12
5
7
14
1. Airolo(SS. Nazario e Celso)
2. Bioggio(S. Maurizio)
3. Leontica(S. Giovanni Battista)
4. Gravesano(S. Pietro)
5. Bellinzona(Castelgrande)
6. Melide(SS. Quirico e Giulitta)
7. Ascona(SS. Fabiano e Sebastiano; Proprietà Wildi)
8. Sonvico(S. Martino)
9. Muralto(S. Vittore;Park hotel)
10. Origlio(S. Vittore)
11. Stabio(SS. Pietro e Lucia)
12. Roveredo(Valasc)
13. Mesocco(Gorda;Benabbia;Grotto)
14. Rovio(SS. Vitale e Agata)
15. Rossura(S. Lorenzo e Agata)
15
Fig. 1. Posizionamento dei siti studiati.
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 112
113Aixa Andreetta | Archeologia funeraria e cimiteri altomedievali nelle Alpi svizzere meridionali: stato della ricerca e prospettive future
È fondamentale ribadire il fatto che i cimiteri studiati dell’odierno Canton Ticino sono tendenzialmentesituati in prossimità di chiese tutt’oggi esistenti, tranne il contesto di Bellinzona, situato sulla collina del Ca-stelgrande, che tuttavia non è da considerare un cimitero rurale, in quanto si sviluppa in prossimità di unachiesa, dedicata a San Pietro o a San Michele, in uso solo fino al XII secolo e poi trasferita7; o ancora il con-testo di Muralto Park Hotel, di cui la relazione con l’area sacra da collegare alla chiesa, distrutta e oggigiornonon più visibile, di Santo Stefano è indubbia e comunque non è molto discosta dalla chiesa di San Vittore.Meno evidente è l’associazione dei cimiteri mesolcinesi considerati, che rappresentano un altro tipo di or-ganizzazione, disconnessa ma ciononostante non dissociata da edifici di culto. Questa differenza non è unarealtà storica o archeologica, ma il risultato di una diversa politica di interventi da parte dei servizi cantonalidi archeologia, che ha il vantaggio di mettere a confronto due sfaccettature diverse di un rituale che deve es-sere compreso nel suo insieme. Quindi proprio il confronto dei rispettivi dati potrà eventualmente aiutarcia valutare quali similitudini o al contrario quali discordanze emergono rispetto allo statuto degli individuisepolti in prossimità di edifici sacri e quelli nei cimiteri, apparentemente, indipendenti.
In molti casi il limite dell’area investigata non corrisponde all’area funeraria reale e quindi sia l’organiz-zazione al di fuori delle chiese, che la relazione tra le tombe coeve e le reali dimensioni dei cimiteri sono dif-ficili da identificare. Questo sottolinea il divario che ci potrebbe essere tra il materiale osteologico rinvenutoe gli individui realmente inumati: le indagini attuali ci obbligano, quindi, a confrontarci con la questione dellarappresentatività della popolazione studiata.
Nel nostro caso il problema è ancora più rilevante, poiché i siti considerati sono il frutto di una precisascelta finalizzata a studiare le aree meglio documentate e con un numero sufficientemente rappresentativodi sepolture.
Non bisogna dunque omettere altre aree funerarie, catalogate ma non ancora analizzate nel dettaglio, chehanno il merito di certificare rituali funerari in molti altri spazi, seppure siano di dimensioni più ridotte,come quelle ad Arosio, Castel San Pietro, Pregassona, Gudo, Giornico, Gnosca, Novazzano, Arbedo-Ca-stione, Quinto-Deggio, Morbio Inferiore e che ingloberemo nelle considerazioni finali; o ancora altri edificisignificativi già studiati, privi di resti scheletrici, come Riva San Vitale, Balerna, Maroggia8.
CONTESTO GEOGRAFICO
La geografia e la topografia del Canton Ticino e della Mesolcina hanno avuto un destino comune, colle-gato in particolare all’importanza dei passi e delle valli che collegano queste terre a ridosso del massiccio al-pino, a meridione con l’Italia e il mondo mediterraneo e a settentrione con l’Europa centrale. Le vie ditransito hanno favorito dunque l’apporto culturale, materiale e religioso delle popolazioni da sempre e nonsolo in epoca medievale.
Per i periodi che più direttamente ci interessano è opportuno sottolineare che già dal V secolo d.C. perproteggere le ricche città lombarde, Goti e Bizantini hanno dovuto e voluto controllare il punto focale delsistema, ossia il Castrum di Bellinzona, rafforzando i transiti che conducevano al Lucomagno, che era di certouna delle vie principali per raggiungere la Rezia insieme al San Bernardino, sul versante opposto o eviden-temente al San Gottardo, che era collegato trasversalmente con la valle di Blenio attraverso il Nara.
Le valli trasversali Traversagna e Morobbia, collegando il Lago di Como allo snodo tra Arbedo e Rove-redo, svolgevano un ruolo fondamentale nella mobilità transalpina, come già riportato sulla Tabula Peutinge-riana9, in cui il collegamento tra Milano e Coira, passando da Chiavenna e il Lario, per esempio, è identificabile.
Milano svolse in epoca tardo-imperiale un’importante funzione strategica, proprio perché, come sottolineaXeres10, non lontano partivano le vie transalpine verso Cuneus aureus (Spluga), Summus poenius (Gran San Ber-nardo), l’Alpis Graia (Piccolo San Bernardo). Como stessa divenne il perno di un sistema di comunicazione trai due versanti delle Alpi, essendo una località di notevole importanza logistica nei collegamenti fluvio-terrestridi Milano/Ticinum (Pavia) con la Rezia, anche grazie alla flotta fluviale11.
7 BRENTANI 1928; MEYER 1977, p. 124.8 CARDANI VERGANI 2006.9 Più precisamente si fa riferimento al Segmentum III, dove si possonoidentificare Mediolanum, Curiae e Clavenna, quali località e tappe del tran-
sito, senza dimenticare Cuneus Aureus che come sappiamo oggigiornoconduceva al Lucus major, ossi al passo del San Bernardino.10 XERES 2001, p. 28.11 ARDENNA 2002, p. 7.
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 113
CONTESTO CULTURALE E CRONOLOGICO
La transizione tra l’epoca romana e l’alto Medioevo non è documentata storicamente tramite fonti esplicitee di conseguenza le conoscenze archeologiche diventano ancor più essenziali. Quello che ci è dato sapere ri-guarda principalmente l’assetto militare e, nonostante la fine dell’epoca romana sia segnata da crisi sociali e re-cessione economica, l’occupazione dei territori nelle Alpi svizzere meridionali sembra subire dei cambiamentimeno radicali di quanto non avvenga al nord12. A questo proposito sia l’invasione alemanna del 457, conclusasinei Campi Canini nei pressi di Bellinzona, sia il periodo della tarda antichità, caratterizzato dalla dominazioneostrogota (493-522), non ebbero apparentemente effetti a lungo termine. L’apparizione graduale di fortificazionisuggerisce l’affermarsi di nuove gerarchie, sicuramente da relazionare con un controllo del territorio, intenzio-nate ad assicurarsi diritti di proprietà e di passaggio. Non dimentichiamo a questo proposito che la Chiesaeredita il sistema burocratico e amministrativo romano, avendo un ruolo centrale nella società altomedievale13.
Nel 588, con l’abbandono dell’Isola Comacina da parte dei Bizantini dopo la conquista di Autari, il suddella Svizzera sembra essere in parte integrato al regno longobardo e l’episodio narrato da Paolo Diaconoe confermato da Gregorio di Tours, che vede Olone, uno dei cento duchi franchi penetrare dal Lucomagnoe attaccare Bilitionem14 per poi morire ai piedi delle sue mura, testimonia per la prima volta Bellinzona e lapresenza dei Longobardi nella regione considerata15. Le tombe dell’élite longobarda, solitamente provvistedi ricchi corredi, sono meno rare di quello che possa apparire in Ticino, ma sono state in grande maggioranzarinvenute a metà del XX secolo e quindi i corredi sono stati per lo più stati trasportati al Museo nazionale aZurigo e le ossa, già mal conservate, sono state totalmente compromesse. Abbiamo potuto disporre solo diquella di Stabio (tomba 11 di Santi Pietro e Lucia), studiata sia archeologicamente che antropologicamente.
Il limite cronologico inferiore della cristianizzazione delle campagne è tradizionalmente fissato tra il VIe il VII secolo, sotto il pontificato di Gregorio Magno, mentre sin dal IV secolo si moltiplicano nell’Italiasettentrionale le comunità organizzate attorno ad un vescovo, nelle grandi città, quali Torino, Aosta, Milano,Brescia, Cremona, Como.
In generale con il regno di Carlo Magno lo Stato feudale si afferma e con esso anche l’autorità dei conti:tuttavia, sia in Italia settentrionale che nelle Alpi svizzere meridionali, le famiglie locali sembrano conservareun forte potere sui beni privati. Nell’803 Carlo Magno conferma ai vescovi di Como la dominazione e idiritti sul territorio di Bellinzona e sui mercati di Locarno, nonché sulla dogana di Lugano16.
Per quanto riguarda la Valle Mesolcina, nel 773 sempre Carlo Magno stabilisce un nuovo confine per laRezia a Monticello, attuale frazione divisa tra il Cantone Ticino e Grigioni, nei rispettivi comuni di Luminoe San Vittore. A partire da questo momento sembra certa l’appartenenza alla Rezia della Mesolcina, e all’or-bita del ducato di Svevia, nonostante i contatti col nord Italia non si arrestino17.
A partire dall’VIII secolo inoltre fu obbligatoria la corresponsione della decima ecclesiastica anche nellelegislazioni dei sovrani carolingi, come già era in vigore nel regno franco. Per ogni pieve furono assegnatidegli ufficiali che con i sacerdoti potessero accertare l’avvenuta o mancata retribuzione18.
Nelle valli Riviera, Blenio e Leventina dal X secolo i possedimenti appartengono alla chiesa di Milano,come è certificato nel testamento risalente al 945 di Attone, vescovo di Vercelli19. Questo vescovo, vissutotra il 924 e il 961 rappresenta la tipica personalità di un membro del clero, istruito e inserito in un sistemapolitico favorevole, tanto da essere nominato arcicancelliere. La sua storia e il suo testamento sono tuttoraoggetto di studio. Le ipotesi dei ricercatori, infatti, sono molteplici e non sempre convergenti, poiché la ten-denza è quella di ridurre i beni e i doni fatti da Attone e di proporre un’evoluzione più graduale delle con-cessioni dei suoi territori a Milano20.
Per noi questa figura risulta interessante, dato che ha il merito di sottolineare come ogni Pieve rappre-sentasse un’unità economica e ecclesiastica a sé stante, dove il vescovo conservava il potere supremo dei
114 Dinamiche insediative nelle Alpi centrali tra antichità e medioevo | a cura di Valeria Mariotti
12 WINDLER et al. 2005.13 BROGIOLO 2007.14 «Olo Autem Dux, ad Bilitionem huius urbis castrum in campis situmCaninis, importune accedens, iaculo sub papilla sauciatus,cecidit etmortus est», Gregorio di Tours, Historia Francorum, livre X, III.15 ROSSI, POMETTA 1941, p. 46.
16 ROSSI, POMETTA 1941, p. 55.17 GRÜNIGER 2006, p. 555.18 CASTAGNETTI 1985, p. 256.19 ROSSI, POMETTA 1941, p. 56.20 MEYER 1977, p. 64.
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 114
115Aixa Andreetta | Archeologia funeraria e cimiteri altomedievali nelle Alpi svizzere meridionali: stato della ricerca e prospettive future
diritti di proprietà sui beni della diocesi di appartenenza. L’intervento dell’autorità civile a sostegno di dirittidi natura ecclesiastica, peraltro, rientra perfettamente nella politica carolingia21. Probabilmente questo fe-nomeno evolve e, a partire dall’XI secolo, si instaura una nuova organizzazione: si affermano i cittadiniricchi e i funzionari, i quali desiderosi di esercitare la loro influenza nella vita pubblica, tolgono poteri aivescovi, a cui rimane la sola competenza spirituale22. Parallelamente non bisogna sottovalutare la presenza,oltre alle chiese parrocchiali e a quelle minori, di chiese private in parte destinate con il tempo a diventarepievi anch’esse.
TOPOGRAFIA CIMITERIALE
Nell’antichità pagana l’associazione delle tombe allo spazio abitato era raro: solitamente le necropoli ro-mane, luoghi di sepoltura comunitari, venivano dissociate dalle villae o dai vici.
Quello che però cambia notevolmente in epoca paleocristiana è, da un lato, l’apparizione di culti legatialla figura specifica di Santi e Martiri, fenomeno dal quale deriva la definizione “sepoltura ad sanctos”; e dall’altrola coabitazione tra vivi e morti: essendo gli edifici all’interno e/o perlomeno nelle strette vicinanze dell’abitato,la separazione netta di questi due mondi, caratteristica delle epoche precedenti, non è più la regola, per l’areagrigionese-svizzera soprattutto a partire dall’epoca carolingia ossia dall’VIII secolo d.C.23, mentre in Italiasettentrionale il fenomeno si evidenzia nelle città romane fin dal IV-V secolo: si pensi al grande cimiterodella Basilica Apostolorum di Milano, poi dedicata a Sant’Ambrogio.
Basandoci sulla definizione di Chavarría Arnau (2009), riteniamo opportuno dare una definizione per itre tipi di cimiteri operanti dall’alto medioevo. Difatti seppure ci sia una certa regolamentazione, occorrecogliere le diverse sfumature delle aree funerarie per capirne la funzione e quindi distinguiamo:- il coemeterium, termine che ha primeggiato nei secoli, ossia il luogo designato quale dormitorio degli indi-
vidui;- il polyandrium, che rappresenta un luogo di sepoltura collettiva (verosimilmente con una predominanza di
uomini) e associato alla sepoltura di un santo;- l’atrium che, in questo caso, definisce la sala all’entrata di un edificio religioso.
Questa precisazione ci aiuta a comprendere il valore intrinseco delle sepolture e la loro associazione congli edifici religiosi: assistiamo ad un avvicinamento della sfera pubblica e di quella privata, fenomeno che implicauna polarizzazione dell’organizzazione sociale, atta ad integrarvi pure la dimensione amministrativa e civica.
La Chiesa, difatti, eredita il sistema burocratico e amministrativo romano, diventando organo centraledella società e una delle poche istituzioni che esce più forte dopo la caduta dell’impero romano e che si facarico anche dell’istruzione. Con lei il patrimonio intellettuale del mondo greco e latino perdura, soprattuttonei monasteri. Questo spiega il motivo per cui l’élite longobarda è disposta a concedere privilegi e doni perassicurasi il supporto della Chiesa, come si evince da vari testi del Codex Diplomaticus Langobardiae24.
I cimiteri cristiani dunque, si instaurano gradualmente quali spazi delimitati ed è soprattutto grazie alleevidenze archeologiche che la loro evoluzione può essere compresa, tenendo conto del contesto nel qualesi sviluppano25. Partiamo quindi dall’analisi delle strutture tombali per poi arrivare ad associarle agli edificidi culto o alle aree funerarie adiacenti.
Analisi tipologica delle sepolture
Abbiamo preso in esame vari elementi caratteristici, basandoci sulle distinzioni proposte da Colardelle26,ossia osservando la forma della fossa e della struttura tombale, il materiale impiegato per le pareti e la co-pertura, la loro tecnica costruttiva, la presenza di elementi lapidei o lignei sul fondo, la presenza di elementiparticolari come l’alveolo cefalico, ma ugualmente studiando i segmenti anatomici disconnessi a causa difattori tafonomici, tramite la documentazione grafica di scavo, secondo gli standard dell’archeotanatologia27.
21 CASTAGNETTI 1985, p. 256.22 GIVONCELLI 2001, p. 323.23 TREFFORT 1996.24 Regis Caroli Alberti, Historiae patriae monumenta, Codex diplomaticusLongobardiae 1873.
25 LAUWERS 2005; REBILLARD 2003.26 COLARDELLE 1983.27 DUDAY 2006.
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 115
Emergono sia riferimenti crono-tipologici, sia interessanti elementi relativi alla deposizione degli individui:alcune strutture tombali sono utilizzate in modo costante durante lunghi periodi e dunque meno direttamentesignificative in termini diacronici, ma altre hanno una fase ben delimitata, sulle quali possiamo stabilire deiriferimenti, atti a confrontare le aree funerarie studiate tra loro e in una prospettiva interregionale.
Le datazioni al radiocarbonio hanno permesso di stilare una crono-tipologia delle sepolture per indivi-duare delle tendenze architettoniche in periodi più o meno determinati (Fig. 2).
In totale sono state datate 53 tombe ticinesi e 4 tombe mesolcinesi. Di queste 57 sepolture, 50 hanno unlegame diretto con la nostra ricerca, poiché rientrano nell’intervallo considerato, mentre altri 7 campionihanno fornito datazioni o troppo recenti o troppo antiche, ma sono comunque state impiegate per affinarei dettagli della tipologia tombale in una prospettiva più ampia. A queste datazioni vengono ad aggiungersiquelle effettuate indipendentemente dal Servizio archeologico del Canton Grigioni, relative a tre sepolturedi Roveredo (Valasc) e due di Mesocco (Gorda).
Le strutture tombali sono principalmente costruite in materiali non deperibili, saltuariamente supportateda elementi di legno, con forme che possono essere globalmente considerate rettangolari, con alcune varia-zioni che raggiungono forme trapezoidali, comunemente definite “a barchetta”. La struttura può, però,essere diversa nella tipologia delle pareti e si distinguono essenzialmente le tombe con pareti in lastre verticali,posate “a coltello” dalle tombe con pareti murate, o da quelle miste che combinano le due categorie e so-prattutto sono da distinguere le tombe con un fondo lastricato o un “cuscino” in pietra.
Le tombe in materiali deperibili, legno soprattutto, sono presenti solo a partire dal XIII secolo, così comele tombe in piena terra che, contrariamente a quanto avviene nel resto della Svizzera, non compaiono proprionegli orizzonti altomedievali sudalpini, o perlomeno ad oggi non sono mai state identificate.
Le tombe “a cappuccina” in contesti altomedievali sembrano essere presenti solo a Castel San Pietro(tombe 10 e 11), ma la datazione in questo caso non è assoluta e sarebbe da precisare. Solitamente questotipo di struttura è relazionabile con una tradizione gallo-romana fino al VII-VIII secolo, come nei cimiteridella Svizzera romanda – Sézegnin, Genolier, Nion28 – ed è una tipologia che è ugualmente attestata nell’Italiasettentrionale, durante la tarda antichità e l’alto medioevo, come ad esempio a Garlate29.
Come si evince dallo schema, nei secoli VII-VIII si delinea una predominanza di strutture tombali conpavimentazione sul fondo, a forma rettangolare. Le pareti possono essere a coltello, come nel caso di Me-socco-Gorda e Muralto-Park Hotel; o in muratura, e di dimensioni molto ampie, come nel caso di Stabio eBioggio.
In particolare la tomba 11 di Stabio (Santi Pietro e Lucia) è molto grande e la presenza di chiodi dinotevoli dimensioni suggerirebbe che all’interno della struttura in pietra, fosse contenuto anche un sarcofagoin legno. La pessima conservazione delle ossa potrebbe confermare questa ipotesi: oltre all’acidità del terrenoargilloso di Stabio, una cassa lignea avrebbe compromesso ulteriormente il mantenimento dei resti scheletricie metallici, visto che i liquidi liberati durante la decomposizione dei tessuti molli – di tenore altamente acido– sarebbero stati trattenuti all’interno della cassa.
La tomba 9, annessa, è di simile struttura: non ha un fondo lastricato, bensì un cuscino sotto il capo chefa pensare ad un supporto per un’eventuale asse in legno, così come anche la tomba 35 a Sonvico potrebbefar credere. Quest’ultima però essendo stata riutilizzata, contiene le ossa di un individuo deposto successi-vamente e al destinatario originale potrebbe essere stata riservata una deposizione secondaria.
La presenza di cuscini in materiali organici è invece ipotizzabile per le tombe 8, 2, 6 e probabilmente 9a Mesocco-Gorda, che decomponendosi hanno creato un vuoto responsabile della dislocazione della man-dibola, una delle articolazioni più labili, che si è dunque staccata dal resto del cranio. Da notare inoltre chel’orientamento delle tombe di Mesocco-Gorda segue l’asse nord-sud e dunque non segue il consono asseovest-est – tipico per le sepolture cristiane – che, difatti, ritroviamo nella maggior parte dei siti studiati(Fig. 3).
Anche a Bellinzona il primo gruppo di tombe sembra distinguersi da quello successivo proprio per unorientamento che da nord-sud diventa ovest-est.
La tipologia più comune, tuttavia, è quella che comprende pareti con lastre a coltello senza pavimenta-
116 Dinamiche insediative nelle Alpi centrali tra antichità e medioevo | a cura di Valeria Mariotti
28 STEINER 2000. 29 POSSENTI 2000.
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 116
117Aixa Andreetta | Archeologia funeraria e cimiteri altomedievali nelle Alpi svizzere meridionali: stato della ricerca e prospettive future
Pareti con piode posatea coltello
Coffres en pierres
Pareti di tipologia mista
Fossa in terra piena
Pareti in muratura
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
Roveredo (639)
Gravesano (26)
Bellinzona (10)
Ascona (40)
Sonvico (10_2)
Cadro (19)
Deggio (1_2)Airolo (7)
Airolo (18, riutilizzata)
Ascona (7)
Bioggio (24) Gravesano (19,9,18,11,13)
Leontica (40)Origlio (7)
Melide (19)
Melide (20)
Stabio (12)
Rovio (7_2)
Rovio (10)
Mesocco Grotto (47)
Mesocco Grotto (14)
Mesocco Benabbia (21)
Pareti con piode a coltelloe fondo lastricato
Mesocco Gorda (8)
Stabio (11)
Mesocco Gorda (9)
Pareti con piode a coltello, a barchetta
Pareti in muratura e fondo lastricato
Bioggio (16)
500
Gravesano (8)
Gravesano (27)
Bellinzona (24)
Sonvico (24)
Leontica (28)
Park hotel (11)
Park hotel (25)
Park hotel (33)
Park hotel (35)
Pareti in muratura, con piode nelle testate
Muralto 87(27)Rossura (9)
Muralto 87(26)
Muralto 87(29)
Muralto 87(9)Pareti con piode a coltello e piodelle laterali
Muralto 89 (2)
Muralto 89 (2)
Rossura (12, 13,15,16)
1400
Fig. 2. Crono-tipologia delle strutture tombali (nella parentesi è indicato il numero della sepoltura datata col radiocarbonio).
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 117
zione. Il suo utilizzo è dilatato per vari secoli, anche oltre il XII secolo esovente possiede una copertura ugualmente in lastre di pietra. Probabil-mente proprio per la posa di questa copertura, le pareti sono supportateda piodelle poste orizzontalmente sul contorno della struttura, al fine dicreare una superficie pianeggiante e regolare, come è ben visibile a Rove-redo, ma anche in alcune tombe a Mesocco, Muralto ed Ascona. Questacaratteristica sembra concentrarsi dall’VIII fino all’XI secolo. Nello stessoperiodo sono diffuse le sepolture “a barchetta”, anch’esse relativamenteben omogenee a livello cronologico. Le ritroviamo sia a Bellinzona, che aMelide, che a Muralto.
Le tombe di simile fattura ma con una predominanza di sassi in parete,sembrano essere sopratutto presenti nei X-XI secoli. Per contro, quellecon pareti totalmente in muratura o di tipologia mista (con piode in testatao pareti che combinano piode e sassi) hanno una diffusione molto ampia,difficile da delimitare cronologicamente.
ORGANIZZAZIONE DELLE AREE FUNERARIE
I cimiteri selezionati necessitano di una prima distinzione tra le sepol-ture che non hanno alcun rapporto diretto con un edificio di culto e se-polture situate in prossimità o all’interno di una chiesa.
Cimiteri associati a edifici di culto non certificati o distrutti
I cimiteri non direttamente riferibili a chiese attuali, di cui abbiamo ap-profondito le ricerche archeologiche e antropologiche, riguardano l’area fu-neraria di Mesocco (Gorda; Benabbia, Castello), Roveredo (Valasc), Bellinzona (Castelgrande) e Muralto (ParkHotel; Sagrato San Vittore). Queste quattro località hanno la caratteristica di possedere diverse aree funerarie,sparse sul loro territorio corrispondente, la cui documentazione è però sovente frammentaria. Affiancando idati relativi agli insiemi studiati, si ottiene una migliore visione complessiva, il più fedele possibile alla realtàarcheologica disponibile.
MesoccoIn base allo stato di conservazione dei materiali osteologici e alla documentazione messa gentilmente a di-
sposizione dal Servizio di Archeologia del Canton Grigioni, si possono chiaramente distinguere tre zone prin-cipali, risalenti all’epoca altomedievale – che non sono poi così diverse dalle aree occupate sin dal Mesolitico– verosimile grazie all’enorme valore strategico delle colline di Mesocco, affacciate sulla Valle Mesolcina.
Il primo gruppo di 13 tombe evidenziate si situa a Mesocco Gorda, il cui lo scavo è stato condotto nel2001. Le tombe sono datate all’VIII secolo30 con il radiocarbonio e la loro architettura funeraria si caratterizzada pareti posate a coltello e pavimentazione in lastre di sasso. Si trovano sulla sommità di una collina, conuna particolare situazione topografica; sono orientate lungo l’asse nord-sud, fatta eccezione per la tomba 4disposta trasversalmente, secondo l’asse est-ovest, e quindi si rivolgono verso il promontorio fortificato. Ve-rosimilmente su quest’ultimo non vi era ancora alcuna traccia di quello che sarebbe divenuto il castello, con-trariamente alla chiesa di San Carpoforo, le cui le fondazioni potrebbero essere precedenti alla chiesaromanica e quindi risalire all’VIII secolo, stando alle indagini condotte nel 1926 da Poeschel31, o addiritturapotrebbero risalire al VI secolo stando a quanto riportato da Mazza32.
La seconda frazione in questione si situa proprio ai piedi dalla collina, denominata Grotto, dove poi sorseil maniero, scavato nel 1971. Questa zona si inserisce in una lunga occupazione, palesataci dai numerosi rin-venimenti preistorici e protostorici, come la presenza di focolari dell’età del Ferro, messi in evidenza ai mar-
118 Dinamiche insediative nelle Alpi centrali tra antichità e medioevo | a cura di Valeria Mariotti
30 ETH-37890 / ETH-37891, tomba 8 660-780 AD cal e ETH-37892/ ETH-37893 tomba 9: 660-780 AD cal.
31 POESCHEL 1945, p. 310.32 MAZZA 1981, p. 72.
Fig. 3. Mesocco-Gorda (Tomba 8, pareticon piode a coltello e fondo lastricato), conmandibola dislocata, probabile sehno dellapresenza di un cuscino in materiale organico(Foto ADG).
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 118
119Aixa Andreetta | Archeologia funeraria e cimiteri altomedievali nelle Alpi svizzere meridionali: stato della ricerca e prospettive future
gini nel cimitero studiato. Questo, che deve aver avuto una connessione con la chiesa di Santa Maria del Ca-stello poco distante, seppure la prima menzione scritta della chiesa risulti attestata solo con le visite pastoralinel 121933 e l’area funeraria sia ben discosta dall’edificio.
Nel cimitero si distinguono due fasi, essenzialmente identificate dalla stratigrafia orizzontale e confermatedalle datazioni assolute: le tombe 11, 12, 13, 14, 45, 46, 48 orientate lungo l’asse nord-sud sono datate VIII-IX secolo34, mentre tutte le altre tombe seguono un orientamento ad ovest e sono successive, ossia appar-tengono ai secoli IX-XI35.
La distinzione è ugualmente tangibile grazie alla tipologia delle sepolture che prevede strutture rettangolaricon lastre di pietra in parete (a coltello) e sul fondo, che rimandano a quelle della collina di Gorda, per le piùantiche, mentre pareti in sasso murate o miste per quelle successive.
In località Benabbia, scavo dell’inverno 2004-2005, è stato possibile distinguere due gruppi di tombe,tutte rettangolari e orientate a nord-est/sud-ovest, ma con tipologie costruttive diverse, cui la datazione alradiocarbonio è la seguente: le tombe 2, 4, 5, 24, 41, 4036 appartengono al II-IV secolo e sono delle fosse inpiena terra oppure delle sepolture con delle pareti murate in sasso, mentre le altre si situano tra l’VIII e il IXsecolo37 e hanno pareti miste, sempre in sasso, ma non sono dotate di lastre sul pavimento.
Ai piedi della collina di Benabbia sembra esserci stata un’area funeraria usata ininterrottamente almenodall’epoca romana al medioevo. Sembra opportuno immaginare che l’intera collina su cui sorge la chiesa diSan Pietro abbia una funzione funeraria. Le oltre 24 tombe mal conservate indagate nel 1971 in localitàSotto Cresta, confermano questa tendenza, così come alcune tombe isolate, rinvenute durante lavori ediliprivati dagli anni Trenta agli anni Sessanta del secolo scorso, cui la documentazione è sovente molto incom-pleta (ritrovamenti durante lavori edili nelle proprietà Anotta, Vivalda, Tamò, Abächerli).
RoveredoIndagini puntuali sparse nel comune di Roveredo hanno fornito testimonianze relative all’epoca medievale
già a partire dagli Trenta. Si pensi ad esempio alle 12 tombe rinvenute durante la costruzione della scuola se-condaria in Riva, o ancora ai ritrovamenti negli anni Sessanta-Set-tanta, seguito a interventi edili o in vigneti38. In base a questiinterventi è possibile identificare alcune aree funerarie, caratterizzatedalla presenza di tombe prive di corredo che sembrano poter rien-trare nel quadro cronologico da noi considerato, come ad esempiole frazioni ad est del villaggio, ancora a Riva (tre tombe) e a Rugno(quattro tombe) o la zona di Carasole-Beffen, non molto discostadal futuro Palazzo Trivulzio, che svolgerà un ruolo di primo pianonel basso medioevo.
Queste testimonianze sparse attestano la presenza dei resti in di-verse aree del comune di Roveredo, lasciando presupporre uno sce-nario analogo a quello di Mesocco, ma la documentazione rimanetroppo poco precisa per poter entrare nel dettaglio. Scavi sistematicisono stati compiuti solamente durante i lavori autostradali alla fine del1960 (in zona Tri Pilastri, occupazione romana) e nel 2007-2008 pressola circonvallazione dell’autostrada A13 in zona Valasc, ossia ai piedidalla Val Traversagna. Questo sito ha restituito 50 tombe medievali,di cui il materiale osteologico molto mal conservato è stato studiatoda Ch. Papageorgopoulou39 e ripreso per questo progetto di ricerca.
Le tombe sono datate X-XII secolo e nessun elemento di strati-grafia relativa o orizzontale le distingue. Possiedono pareti in lastre
33 Il campanile risale perlomeno all’XI secolo e la navata centrale, com-posta da due absidi semicircolari, ricorda la struttura della chiesa deiSanti Pietro e Paolo poco distante, che potrebbe risalire all’alto Me-dioevo, CORFU 2010.34 ETH-41263, tomba 14: 680-890 AD cal.35 ETH-41264, tomba 47: 890-1180 AD cal.
36 ETH-41262, tomba 40: 120-340 AD cal.37 ETH-41261, tomba 21: 760-900 AD cal.38 RAGETH 1975.39 Rapporto presso ADG.
Fig. 4. Cappella carolingia dedicata a San Lucio,a San Vittore (GR) (foto M. Zanetti).
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 119
di pietra (a coltello) o in muratura, senza pavimentazione e sono orientate sud-ovest/nord-est seguendo laconformazione del terreno. Nessun edificio di culto è stato rinvenuto, ma dovendo rispettare il perimetrodi intervento dettato dal progetto autostradale, non sono stati identificati i limiti di quest’area e di conse-guenza non ci è concesso sapere la reale estensione e non possiamo dunque escludere la presenza di un edi-ficio. La topografia religiosa del comune di Roveredo è in ogni caso ben confermata, sia per la vicinanzacon la cappella carolingia dedicata a San Lucio (Fig. 4) sia per quella con la chiesa, orientata con abside se-micircolare e dedicata a San Giorgio, scomparsa in seguito ad un’alluvione già nel XVI secolo40.
BellinzonaSebbene Bellinzona non sia stata protagonista di scavi estensivi nel centro storico, la sua storia è indub-
biamente lunga: la collina su cui sorge il Castelgrande è occupata, infatti, sin dal Neolitico, come Donati hadimostrato con la ricerca nel 1985.
Eppure le informazione archeologiche riguardanti l’occupazione della collina durante l’alto medioevo,non sono così esplicite, anche se le indagini relative allo sviluppo e restauro del castello nel 196741 hannopermesso di condurre una ricerca sistematica, almeno nelle zone direttamente annesse. Altri ritrovamentisparsi sulla collina e avvenuti per interventi casuali, soprattutto legati a lavori agricoli nei vigneti, danno qual-che elemento supplementare per ricostruire l’occupazione della collina, che appare relativamente complessa.Al riguardo possiamo segnalare la scoperta fortuita di quattro sepolture, una avvenuta nel 1954 e tre nel1959, per le quali la documentazione grafica o fotografica della localizzazione è poco precisa, ed è relativaal versante settentrionale della collina. Queste tombe hanno un’architettura funeraria analoga a quella dellesepolture indagate da Meyer e sono prive di corredo.
Si noti che le 18 sepolture studiate sono solo una parte della popolazione sepolta sulla collina, perchénessuna indagine è stata condotta per definire i limiti dell’area funeraria e quindi la struttura del cimiteronon è da considerarsi completa. Ugualmente è presumibile ammettere che queste sepolture abbiano avutouna connessione con l’antica chiesa dedicata o a San Pietro o a San Michele, la cui ubicazione è dubbia.
Si osservano due gruppi, a seconda dell’orientazione delle tombe. Quelle orientate seguendo l’asse nord-
120 Dinamiche insediative nelle Alpi centrali tra antichità e medioevo | a cura di Valeria Mariotti
40 STANGA 2004, p. 32. 41 MEYER 1976.
Gruppo A Gruppo B
3 m
Tombe studiate
Individui non prelevatiIndividui datati
Fig. 4. Area funeraria medievale a Castegrande, suddivisione in due fasi.
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 120
121Aixa Andreetta | Archeologia funeraria e cimiteri altomedievali nelle Alpi svizzere meridionali: stato della ricerca e prospettive future
sud sono più antiche (Gruppo A) e risalgono all’VIII-IX secolo42, mentre quelle orientate ovest-est sonodatate IX-X secolo43 (Gruppo B) (Fig. 5).
MuraltoMuralto riveste un ruolo da protagonista soprattutto durante l’epoca romana, dove si afferma come im-
portante insediamento, situato all’estremità settentrionale del Verbano, meglio definito quale Vicus, con unaconnotazione commerciale e artigianale ancora in piena attività nel IV-V secolo. Le ricerche tuttora in corsocondotte da R. Janke44 porteranno nuovi elementi di interpretazione, che faciliteranno la comprensione del-l’occupazione umana anche per i periodi che più ci coinvolgono. Difatti le aree funerarie considerate attornoal sagrato di San Vittore, scavate nel 1987 e nel 1989, hanno conservato i resti osteologici in 43 sepolture. Tut-tavia non si conoscono i limiti delle aree, che sembrano essere occupate intensamente attorno al X-XI secolo.
Nell’area relativa alla località Park Hotel le 24 tombe studiate risalgono all’alto medioevo, seppure le da-tazioni che abbiamo ottenuto siano più recenti di quanto ipotizzato fino ad oggi e sono da situare in un in-tervallo cronologico tra il VII secolo45 e il X secolo46; queste sono da relazionare con i resti della chiesa,demolita, dedicata a Santo Stefano, che verosimilmente precede il San Vittore, di cui la successione dellefasi non è certa.
Dunque, omessi gli esempi di Bellinzona e Muralto, la situazione dei cimiteri dislocati o annessi a chiesenon certificate nell’attuale Canton Ticino è meno nota, seppure abbiamo indizi espliciti che ne attestanol’esistenza. Per esempio, l’area funeraria denominata “Galletto” a Castione si compone da una serie di se-polture, appartenenti all’età del Ferro, ma anche al medioevo ed è stata scavata nella seconda metà dell’Ot-tocento, a seguito dei lavori per la costruzione della ferrovia del San Gottardo e pubblicata da Ulrich47. Èstata di recente nuovamente indagata in una piccola porzione, nella Cava ex Ambrosini, sulla quale sonostate messe in luce altre quattro sepolture48: datate al radiocarbonio, confermano un’occupazione sia nel IVsecolo a.C.49 sia nel VII secolo d.C.50.
Il sito diventa quindi per noi estremamente interessante, sia per l’aspetto cronologico, sia per l’organiz-zazione intrinseca dell’area, ma ugualmente per il discorso pertinente ai cimiteri dissociati da edifici di culto,che trova evidenze più o meno isolate anche a Gordola, Aquila, Solduno.
Cimiteri direttamente associati a edifici di culto attuali
La mancanza di scavi in chiese nella valle Mesolcina non ci permette di conoscere nel dettaglio le fasi co-struttive e quindi il loro secolo di fondazione. Gli edifici presenti nel territorio mesolcinese presentano ele-menti ed indizi che ci lasciano presupporre un’occupazione già ben affermata in epoca carolingia, cometestimonia la cappella San Lucio a San Vittore.
L’origine di vari edifici potrebbe essere ben più antica di quanto venga attribuita dalle fonti scritte (visitepastorali a partire dal XIII secolo) e ad ogni modo la presenza di sepolture sembra non mancare, sebbenenon sia accertata sistematicamente, in chiese quali Santi Bernardo e Abate a Leggia, San Pietro a Mesoccoe San Vittore nel villaggio eponimo.
Per contro sono numerosi gli edifici situati in Ticino che possiedono una lunga tradizione di interventiarcheologici condotti a partire dagli anni Sessanta dall’Ufficio dei Beni Culturali, sotto la tutela scientifica diPierangelo Donati e poi di Rossana Cardani Vergani.
La successione delle varie fasi costruttive degli edifici di culto è stata proposta dai collaboratori che hannopartecipato agli scavi o da studiosi che ne hanno redatto le sintesi, a seconda della tematica approfondita51.
42 ETH-53995 tomba 24: 770-970 AD.43 ETH-41243 tomba 10: 890-1050 AD.44 JANKE 2011 (in collaborazione con Simonetta Biaggio Simona, MariaIsabella Angelino e Emanuela Guerra Ferretti).45 ETH-53988 tomba 11: 670-780 AD; ETH-53989 tomba 25: 670-780 AD.46 ETH-53990 tomba 33: 940-1030 AD; ETH-53991 tomba 35: 990-
1160 AD.47 ULRICH 1914.48 CARDANI VERGANI 2015.49 ETH-53987, tomba 5: 410-350 BC.50 ETH-53986, tomba 2: 600-665 AD.51 FOLETTI 1997; ULRICH 1914; SENNHAUSER 2003; CARDANI VERGANI2006; TABERNERO DIAZ 2012.
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 121
122 Dinamiche insediative nelle Alpi centrali tra antichità e medioevo | a cura di Valeria Mariotti
Fig. 6. Fasi evolutive degli edifici correlate alle tombe datate.
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 122
123Aixa Andreetta | Archeologia funeraria e cimiteri altomedievali nelle Alpi svizzere meridionali: stato della ricerca e prospettive future
Con i nostri risultati è dunque possibile confermare o in rari casi ridefinire l’evoluzione di questi edifici,relazionando le sepolture (Figg. 6-7).
Proponiamo una sintesi delle evidenze archeologiche in chiave cronologica, senza ripetere le tipologie diedifici già ampiamente elaborate, per poi poterle completare con i risultati delle analisi antropologiche.
Gli oratori e le prime costruzioni
A Rovio, ma anche a Gravesano, Santi Pietro e Paolo, si deve segnalare la presenza di sepolture antecedential primo edificio di culto cristiano, certificato solo per un periodo successivo. La tomba 752 nella chiesa deiSanti Agata e Vitale a Rovio precede la prima costruzione attestabile, che provvista di abside semicircolare,è da collocare nel periodo romanico. Le macerie segnalate quale strato sottostante a questo edificio, lascianopresumere la presenza di una costruzione più antica53.
52 ETH-41241 tomba 7_2, 590-690 AD. 53 CARDANI VERGANI 2013, p. 165.
N
ASCONA SS. Fabiano e Sebastiano
Aula rettangolare con abside semicircolare
Ingrandimento
N
ASCONA SS. Fabiano e Sebastiano
N
ROVIO SS. VItale e Agata ROVIO SS. VItale e Agata
N
590-
690
AD
o 5m
Tombe studiate
Individui non prelevatiIndividui datati al radiocarbonio
LEONTICA S. Giovanni Battista
N
1030
-121
0 A
D
ROSSURA SS. Lorenzo e Agata
N
1020
-118
0 AD
N
ROVIO SS. VItale e Agata
Tombe senza edificio certificatonei pressi di una futura chiesa
T.35770-
990
AD
N
LEONTICA S. Giovanni Battista
ASCONA SS. Fabiano e Sebastiano
N
760-
900
AD
T. 28 T. 14
T. 20
T. 24
T. 7
T. 29
T. 30
T. 8
T. 1
T. 17
Fig. 7. Correlazioni tombe - fasi costruttive delle chiese ededifici accertati o non accertati.
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 123
La tomba 854 a Gravesano leggermente discosta dal primo edificio a pianta rettangolare – che più volen-tieri denominiamo “oratorio”, anziché “mausoleo” e collegabile ad una sepoltura privilegiata – confermaquello che gli altari votivi già suggerivano, ossia che la zona è occupata sin dall’epoca romana. Non è difficileimmaginare che il carattere funerario di questa zona era già in atto ben prima che le manifestazioni cristianepotessero essere esplicite. Altre tombe adiacenti alla tomba 8, però, non sembrano appartenere a questaprima fase (tombe 9, 11, 1355) e quindi la topografia di questo sito parla a favore di una occupazione pluri-secolare, presumibilmente priva di interruzioni.
Analoga, seppure più tarda, la situazione a Leontica, dove il gruppo di tombe collegato alla sepoltura 40indica la presenza di una zona funeraria precedente al primo edificio di culto rilevato, da collegare dunquead un’altra costruzione, le cui tracce non sono state identificate.
A Sonvico, la tomba 10 conteneva i resti di due individui, non deposti contemporaneamente: il primo56
risale al VII-VIII secolo e il secondo57 è datato solo al IX -X secolo. Questa tomba potrebbe dunque suggerireugualmente la presenza di un’area funeraria che si sviluppa pian piano attorno ad una costruzione verosi-milmente in legno, la cui identificazione non è unanime tra i ricercatori, e che si trasforma poi nella chiesettaorientata con l’abside semicircolare.
Un altro caso particolare che merita di essere nuovamente menzionato è Stabio, Santi Pietro e Lucia. Latomba 11 è databile grazie al suo corredo funerario di notevole prestigio: si tratta di un corredo longobardo,comprensivo di un’arma, uno scramasax con resti del fodero ed elementi appartenenti alla cintura e una borsain cuoio, contenente un acciarino e la pietra focaia, deposta accanto al torace a destra del corpo58. La tombarisale alla seconda metà del VII secolo ed è direttamente collegata alla tomba 9, di simile struttura – ossiadotata anch’essa di pareti murate e una pavimentazione lastricata. Entrambe si situano nell’area antistante alsagrato di quella che si considera la prima chiesa, con abside rettangolare. Sarebbe interessante indagare ul-teriormente quest’area per capire se queste due tombe del VII secolo siano effettivamente state in originecollocate all’esterno della costruzione, peraltro conclusa con un’abside rettangolare, o se sono da relazionaread un altro edificio, non più conservato.
Evidentemente non possiamo omettere le testimonianze longobarde provenienti da altre tombe in varielocalità del comune di Stabio – Barico, alla Vigna, fondo Riva – rinvenute sin dalla prima metà del XIXsecolo e i cui corredi sono stati parzialmente studiati. Malgrado il pessimo stato di conservazione dei materialiosteologici e anche di quelli metallici, queste testimonianze descrivono uno scenario colorito e complessodi cui fino ad ora possediamo solo alcuni tasselli, che si vanno ad aggiungere alle scoperte archeologichedegli anni Trenta di Simonett59 attorno alla chiesa di Sant’Abbondio e alla chiesa di Santa Margherita o ancoraalle scoperte più recenti grazie agli scavi condotti nel 201160.
L’esempio di Bioggio offre un altro aspetto particolare che ci preme sottolineare, ossia la presenza di piùtombe (15, 16, 17, 18), associate sin dalla fase più antica al primo edificio, che in questo caso è a pianta ret-tangolare. Queste, databili verso il VII secolo61 presentano una tipologia architettonica analoga, caratterizzatada pareti in muratura, pavimentazione lastricata e copertura con piode. Sarà fondamentale verificare se l’ana-lisi antropologica permetta di ricostruire eventuali legami famigliari per questo gruppo di tombe coeve.
A Melide, Santi Quirico e Giulitta, e ad Airolo, Santi Nazario e Celso, ritroviamo ugualmente edifici apianta rettangolare, oratori dunque, ma ad essi solo una sepoltura sembra direttamente associabile. Per controin tutt’e tre i casi la costruzione evolve in una chiesetta orientata con abside semicircolare, in cui la funzioneliturgica diviene esplicita. A Melide le tombe situate dietro abside sono datate del IX-X secolo62, contempo-ranee dunque a quelle ubicate davanti alla facciata principale, come se queste due zone funerarie coesistessero(Fig. 8).
Segnaliamo che ad Airolo la tomba associata al primo edificio rettangolare è stata riutilizzata più volte,quindi l’individuo oggetto di datazione63 potrebbe non essere quello per il quale la tomba è stata allestita.
124 Dinamiche insediative nelle Alpi centrali tra antichità e medioevo | a cura di Valeria Mariotti
54 ETH-53993 tomba 8: 530-640 cal AD.55 ETH-55843 tomba 9: 944-1024 AD; ETH-55844 tomba 11: 1010-1154 AD; ETH-55845 tomba 13: 1032-1160 AD.56 ETH-41247 tomba 10_2: 640-780 AD.57 ETH-41246 tomba 10_1: 810-1020 AD 58 AMREIN 2006, p. 105.
59 SIMONETT 1941.60 CARDANI VERGANI 2014, pp. 129-135.61 ETH-41239 tomba 16_2: 660-780 AD.62 ETH-41253 tomba 19: 880-1020 AD; ETH-41253 tomba 20: 890-1020 AD.63 ETH-41256 tomba 18: 890-1020 AD.
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 124
125Aixa Andreetta | Archeologia funeraria e cimiteri altomedievali nelle Alpi svizzere meridionali: stato della ricerca e prospettive future
Quello che invece è certo è che a partire dal IXsecolo, l’area antistante la facciata è riservata asoggetti immaturi, come avremo modo di met-tere in evidenza nell’elaborazione dei dati an-tropologici.
Il cimitero che si sviluppa all’esterno dellaChiesa di Santi Fabiano e Sebastiano adAscona, scavata nel 1980, nasce in epoca caro-lingia. Questo sepolcreto era associato proba-bilmente ad un edificio non certificato, comedimostra la tomba 4064 e si amplia fino all’XIsecolo65, quindi potrebbe essere associabile allachiesetta romanica. Probabilmente alcunetombe potranno essere identificate all’esternoe all’interno della chiesa ingrandita, risalente alXIII-XIV secolo (Fig. 7).
Nonostante vi sia una sola sepoltura, il caso di Quinto Deggio è molto interessante, sia per l’evoluzionedella cappella di San Martino, sia perché questa sepoltura contiene i resti di due individui. Le datazioni al ra-diocarbonio confermano che la tomba è stata inserita nella prima fase edilizia databile all’VIII-IX secolo:tale primitivo edificio era verosimilmente di forma rettangolare, ad aula unica. La seconda fase, di un secoloposteriore, si caratterizza da una nuova struttura, con un’aula rettangolare dotata di un’abside anch’essa ret-tangolare, che si orienta di 180 gradi rispetto la prima costruzione, mantenendo la sepoltura in una posizioneprivilegiata. Questa trasformazione sembra avvenire in contemporanea con la deposizione di un secondopersonaggio: l’individuo già presente viene dislocato sul lato per fare posto al secondo66.
Dopo l’anno Mille
A sud delle Alpi Svizzere, si attesta un aumento delle costruzione ecclesiastiche dall’VIII-IX secolo cheverranno poi ampliate e allungate a partire dal X-XI secolo.
Durante il IX secolo dovrebbe comparire una vera e propria legislazione, riguardante il controllo dellesepolture nelle chiese, parallelamente ad una nuova concezione degli edifici, la quale sottolinea il ruolo del-l’eucaristia e tende a circondarli di spazi dediti al mondo dei morti67. Inoltre le chiese battesimali, che nelnostro caso potrebbero riallacciarsi a quelle di Riva San Vitale e Balerna, acquistano nuove responsabilità:ad esse viene assegnato un distretto clericale, sottomesso all’arciprete, per operare nelle regioni periferichedella Chiesa Madre e ad esse viene affidata la gestione degli oratori rurali vicini. Lo scopo è assicurare lacura delle anime, l’amministrazione dei sacramenti, la formazione del clero. Da ritenere è che l’unità allaquale si aspirava tramite questo sistema pur semplice, ma tanto gerarchico, si scontrò per certo con le aspi-razioni indipendentiste dei villaggi68.
Ci si aspetterebbe, dunque, di assistere ad una diminuzione di sepolture all’interno di edifici di culto apartire dal X secolo, eppure le evidenze archeologiche attestano una continuità e addirittura un aumento delnumero di tombe, atte ad illustrare un fenomeno significativo ed esplicito, poco documentato storicamentema di cui non si possono avere dubbi.
A Bioggio, per esempio, un gran numero di tombe è stato identificato a ridosso della parete sud dell’edificio,dove le molteplici sovrapposizioni, rendono la rispettiva cronologia difficile da rilevare. L’individuo inumatonella tomba 24, seppure solo in parte conservato, è datato al XII secolo69 e viene successivamente manomesso,confermando il dinamismo legato alle riutilizzazioni delle tombe, che a Bioggio riguarda almeno 10 tombe.
64 ETH-41238 tomba 40: 760-900 AD.65 ETH-41237 tomba 7: 1020-1220 AD.66 Per ulteriori informazioni: ANDREETTA, CARDANI VERGANI 2014.
67 CHAVARRÌA ARNAU 2009, p. 186.68 CHIESI 2003.69 ETH-41240, tomba 24_1: 1220 -1310 AD.
Fig. 8. Tombe del X secolo situate dietro l’abside, Melide, Santi Quirico eGiulitta (foto UBC).
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 125
Lo stesso discorso vale per i casi di Leontica70, Sonvico71, Rovio72, Stabio73 dove le sepolture all’internodell’edificio perdurano aldilà del XIII o anche del XIV secolo.
A Cadro, chiesa Sant’Agata, le sepolture 18 e 1974, bisome e contemporanee, datate al XV secolo, sonocollocate all’interno dell’odierna chiesa; questa nasce su una struttura civile romana e le prime fasi evolvonoda un oratorio rettangolare ad una chiesetta con abside semicircolare, alle quali però poche tombe sono as-sociate e quindi di difficile datazione assoluta.
Inoltre a Rossura, nella chiesa dedicata ai Santi Agata e Lorenzo, si registra la presenza di individui im-maturi sepolti all’interno dell’edificio romanico, orientato e concluso da un’abside semicircolare75. La data-zione delle tombe76 suggerisce un intervallo tra l’XI e il XII secolo; e le recenti indagini archeologiche,effettuate nel 2012, ci permettono dunque di affrontare un fenomeno piuttosto atipico, in quanto normal-mente i bambini non ancora battezzati non potevano accedere alle aree funerarie ubicate dentro gli edificicristiani; ciononostante potremmo supporre una funzione specifica, cimiteriale, di questa chiesetta. Lo scavonon comprendeva le aree esterne alla chiesa attuale, dunque non possiamo sapere se altri individui sono statidepositi nel perimetro annesso o se fosse in uso contemporaneamente un cimitero esterno.
CONCLUSIONI
Le evidenze archeologiche a sud delle Alpi svizzere riguardanti la diffusione del cristianesimo illustrano unoscenario che conferma un processo molto graduale e tutto sommato non ancora dominante nel IV-V secolo.
È da ritenere che i dati archeologici disponibili e presentati suggeriscano una pluralità di situazioni, la cuicomplessità non è da sottovalutare. Si intravedono solo parzialmente alcuni modelli già conosciuti altrove,mentre si delinea più francamente una realtà atipica e colma di casi particolari, emersi da influenze esternee connessioni, ma anche da sviluppi locali e confinati. Da un lato una cristianizzazione direttamente connessaall’iniziativa vescovile, delle città di Como, Milano e forse anche Coira, dall’altra la persistenza di comunitàaristocratiche o rurali che esprimono la loro identità e il loro potere, organizzandosi in spazi specifici.
Le tombe costruite con lastre di pietra e con una pavimentazione sembrano caratterizzare il VII-VIII se-colo e quelle con le pareti con lastre a coltello dominano tutti i secoli successivi, seppure a tratti si identificanodelle tipologie meno in voga ma usate per periodi più delimitati, come le tombe a parete in muratura o informa trapezoidale. Fosse in piena terra sono molto tarde così come sarcofagi in cassa lignea, fatta eccezioneper qualche caso isolato e comunque accompagnato da una struttura in materiale non deperibile.
I primi edifici rettangolari attestati per l’alto medioevo furono indubbiamente e principalmente costruitinei pressi di occupazioni tardoantiche. Senza fonti epigrafiche è difficile risalire a chi abbia preso l’iniziativadi costruire questi edifici e a chi fosse poi affidata la gestione, ma la maggior parte sembra nascere per com-memorare i defunti e forse solo alcuni, quelli ubicati lungo la rete viaria, hanno uno scopo di evangelizzazionee di controllo del territorio.
Si confermano dunque quali edifici con funzione funeraria, per poi assumere un carattere liturgico, evi-denziato dall’annessione di un’abside semicircolare. Questa trasformazione sembra avvenire tra l’VIII e ilIX secolo, ossia circa un secolo dopo quando immaginato fino a qualche anno or sono.
La ricerca sulla gestione degli spazi cimiteriali disconnessi e connessi agli edifici di culto in Ticino è agli al-bori. Sarà essenziale integrare i risultati emersi dalle analisi antropologiche per capire quanto queste aree fosseroaccessibili alla popolazione o quanto fossero, al contrario, riservate a nuclei famigliari. Sappiamo che questearee diventano uno spazio privilegiato e probabilmente anche uno strumento di espressione di potere e di af-fermazione della memoria, ma conosciamo poco degli schemi sociali che ne regolavano l’organizzazione.
L’elaborazione di scavi passati e l’integrazione dei dati antropologici, insieme a quelli emersi dalle analisiisotopiche apporteranno elementi chiarificatori, per la comprensione dei gesti e dei rituali funerari, così comesull’ideologia e sulla vita delle popolazioni medievali nelle regioni considerate.
126 Dinamiche insediative nelle Alpi centrali tra antichità e medioevo | a cura di Valeria Mariotti
70 ETH-53992, tomba 28: 1030-1210 AD.71 ETH-41248 tomba 35: 1220-1320AD; ETH-55848, tomba 24:1262-1300 AD.72 ETH-41242, tomba 10: 1410-1520 AD.73 ETH-55847, tomba 13: 1304-1365 AD.
74 ETH-41249, tomba 19 (tomba bisoma): 1460-1640 AD cal.75 CARDANI VERGANI 2014, p. 135.76 ETH-44620 tomba 12: 1030-1210 AD; ETH-44622 tomba 9_1:1020-1160 AD; ETH-44623 tomba 9_7: 1040-1230 AD; ETH-44625tomba 13: 1030-1210 AD.
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:23 Pagina 126
127Aixa Andreetta | Archeologia funeraria e cimiteri altomedievali nelle Alpi svizzere meridionali: stato della ricerca e prospettive future
ANDREETTA A. 2013, Archeologia e antropologia dei cimiteri altomedievalial sud delle Alpi svizzere. Caratterizzazione della popolazione e delpopolamento: tra ecologia locale e mobilità transalpina, Mitteilungen:IKG, Coira, pp. 18-21.
ANDREETTA A., CARDANI VERGANI R. 2014, Mort violente et sépultureprivilégiée dans la chapelle San Martino de Quinto (TI): une étude decas, “Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Anthro-pologie”, 20(2), pp. 31-32.
AMREIN H. 2006, La tomba di un nobile longobardo scoperta nel 1999 e altriimportanti ritrovamenti dell’alto Medioevo, in Stabio antica. Dal re-perto alla storia, Locarno, pp. 99-120.
ARDENNA G. 2002, Linea Ticino. Sull’unità culturale delle genti del fiumenel Medioevo, Bellinzona.
BRENTANI L. 1928, L’antica chiesa matrice di S. Pietro in Bellinzona,Como.
BROGIOLO G.P. 2007, Archeologia e società tra tardo antico e alto medioevo,in BROGIOLO, CHAVARRÍA ARNAU 2007, pp. 7-22.
BROGIOLO G.P., CHAVARRÍA ARNAU A. 2007 (a cura di), Archeologia esocietà tra tardo antico e alto medioevo, 12° seminario sul tardoantico e l’alto Medioevo (Padova, 29 settembre-1 ottobre2005), Mantova.
BRONK RAMSEY C. 2010, OxCal 4.1 Manual, University of Oxford,radiocarbon Accelerator Unit.
CARDANI VERGANI R. 2006, Le radici della cristianizzazione nelle terredell’attuale Canton Ticino, in Stabio Antica. Dal reperto alla storia,Locarno, pp. 121-134.
CARDANI VERGANI R. 2013, Dalla protostoria al Medioevo : novità dal ter-ritorio del Cantone Ticino, “Rivista archeologica dell’antica pro-vincia e diocesi di Como”, pp. 161-172.
CARDANI VERGANI R. 2014, Ricerche archeologiche : novità dal territorio delCantone Ticino, “Rivista archeologica dell’antica provincia ediocesi di Como”, pp. 129-140.
CARDANI VERGANI R. 2015, Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel2014, “Bollettino dell’Associazione Archeologica Ticinese”,27, pp. 30-37.
CASTAGNETTI A. 1985, Il peso delle istituzioni: strutture ecclesiastiche e mondorurale. L’esempio veronese, in ANDREOLI B. et al., Le campagne ita-liane prime e dopo il Mille: una società in trasformazione, Bologna,pp. 253-273.
CHAVARRÌA ARNAU A. 2005, Splendida sepulcra ut posteri audiant. Aristo-crazie, mausolei e chiese funerarie nelle campagne tardoantiche, inBROGIOLO, CHAVARRÌA ARNAU 2007, pp. 127-146.
CHAVARRÌA ARNAU A. 2009, Archeologia delle chiese. Dalle origine all’annomille, Roma.
CHIESI G. 2003, ll cristianesimo nelle terre ticinesi dalle origini al tardo me-dioevo, Terre del Ticino, Diocesi di Lugano, pp. 3-35.
COLARDELLE M. 1983, Sépultures et traditions funéraires du V au XIIIsiècle a.J.-C., dans les campagnes des Alpes françaises du Nord(Drome, Isere, Savoire, Haute-Savoie), Grenoble.
CORFU L. 2010, Identità e metamorfosi di un castello, in Castello di Mesocco,passato e futuro, “Quaderni Grigionitaliani”, 79(2), pp. 7-33.
DUDAY H. 2006, Lezioni di archeotanatologia: archeologia funeraria e antro-pologia di campo, Roma.
FOLETTI G. 1997, Archeologia altomedievale nel Canton Ticino, in Archeo-logia della Regio Insubrica, Atti del convegno (Chiasso, 5-6 ot-tobre 1996), Como, pp. 113-179.
FOLETTI G. 2013, Appunti per una storia dei cimiteri nel Canton Ticino,“Archi: rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbani-stica”, 5, pp. 43-47.
GIOVINCELLI S. 2001, Il testamento di Attone di Vercelli, in Alle Originidel Cantone e delle Tre Valli: il testamento di Attone da Vercelli (se-colo X): omaggio a Romano Broggini per i suoi 85 anni, XVI Con-vito dei Verbanisti (Verbanus, 25 settembre 2010), Biasca,Milano, pp. 323-348.
GRÜNIGER S. 2006, Grundherrschaft im frühmittelalterlichen Churrätien,Ländliche Herrschaftsformes, Personenverbände und Wirtschaftstruk-turen zwischen Forschungsmodellen und regionaler Quellenbasis,Staatsarchiv Graubünden, Chur.
LAUWERS M. 2005, Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terre des mortsdans l’Occident médiéval, Paris.
JANKE R. 2011, Il Vicus di Muralto e l’Alto Verbano in epoca romana, inInteralpes. Insediamenti in area alpina tra preistoria e età romana,Atti del convegno in occasione dei quarant’anni del GruppoArcheologico Mergozzo (23 Ottobre 2010), Mergozzo, pp.137-146.
MAZZA S. 1981, S. Michele di Gornate, St-Félix de Géronde, S. Carpoforodi Mesocco: tre chiese dei secoli bui, Tradate.
MEYER W. 1976, Il Castel Grande di Bellinzona. Rapporto sugli scavi e sul-l’indagine muraria del 1967, Olten.
POESCHEL E. 1945, Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden VI, Pu-schlav, Misox und Calanca, Basel.
RAGETH J. 1975, Neue archëologische Funde in Roveredo-Rugno (Grabung1973), “Bündner Monatsblatt”, 7/8, pp. 1-15.
ROSSI G., POMETTA E. 1941, Storia del Cantone Ticino dai tempi più remotifino al 1922, Lugano.
REBILLARD E. 2003, Religion et sépulture. L’Église, les vivants et les mortsdans l’Antiquité tardive, Paris.
SENNHAUSER H.R. 2003, Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet. Von derSpätantike bis ottonische Zeit, Band 2, München.
SIMONETT CH. 1941, Tessiner Gräberfelder, Basel.
STANGA P. 2004, Ricerche storiche su Roveredo (GR), Locarno.
STEINER L. 2000, La nécropole du Pré de la Cure à Yverdon-les-Bains (IVe-VIIe s. ap. J.-C.), Lausanne.
TABERNERO DIAZ J., GEIGER H.-U., MATZKE M. 2012, Canton Ticino:ritrovamenti monetali da chiese, Inventario dei Ritrovamenti Mo-netali Svizzeri, 10, Berna.
TREFFORT C. 1996, L’église carolingienne et la mort. Christianisme, rites fu-néraires et pratiques commémoratives, Diss. Univ. Lyon II).
ULRICH R. 1914, Die Gräberfelder in der Umgebung von Bellinzona, Kt, Tes-sin, Zurigo.
WINDLER R., MARTI R., NIEFFELER U., STEINER L. 2005, Haut Moyen-Âge, SPM VI, Basel.
XERES S. 2001, Origini cristiane a Como (IV-V), in BONATI F. (a curadi), Prime pietre. Gli esordi del cristianesimo a Como: uomini, fonti eluoghi, Como, pp. 13-58.
BIBLIOGRAFIA
Valtellina_convegno-def.qxp_Valtellina 09/11/16 10:56 Pagina 127