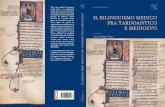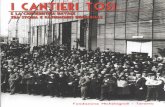F.R. Stasolla, L’architettura funeraria. Periodo tardoantico e medievale, in Il mondo...
Transcript of F.R. Stasolla, L’architettura funeraria. Periodo tardoantico e medievale, in Il mondo...
©PROPRIETÀ ARTISTICA E LETTERARIA RISERVATA
Copyright by
ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.p.A.
2002
FotolitoMARCHESI GRAFICHE EDITORIALI S.p.A.
Via Bomarzo, 32 - 00191 Roma
StampaGRAFICHE ABRAMO
Traversa Cassiodoro, 19 - 88100 Catanzaro
Printed in Italy
Per quanto riguarda i diritti di riproduzione, l’Istituto si dichiara pienamente disponibile a regolare
eventuali spettanze per quelle immagini di cui non sia stato possibile reperire la fonte
nastero in posizione d’altura, incentrato sulla chiesa principa-le e difeso da una cinta muraria con torri angolari.
Le nuove fondazioni cistercensi e certosine sono frutto diuna progettazione più organizzata e complessa, con impiantiche, pur rispettando gli schemi condizionanti della vita co-munitaria, appaiono più rigidi e modulari nel primo caso, piùliberi nel secondo. Il contributo delle indagini archeologicheper queste categorie di edifici si è rivelato particolarmente in-teressante per la conoscenza dei cicli produttivi ed artigianaliche ne caratterizzavano l’economia, come ad esempio la lavo-razione della lana a Fountains Abbey (North Yorkshire) e gliimpianti metallurgici nell’abbazia gallese di Tintern (Mon-mouthshire), cenobi fondati entrambi nel secondo decenniodel XII secolo. Nello schema cistercense grande importanzaassume la strutturazione degli ambiti produttivi, in linea conil ruolo delle attività lavorative imposto dalla regola riforma-ta. Finisce comunque per assumere un valore emblematico edi prototipo la pianta dell’aula di culto ripartita in tre navatecon transetto, coro dotato di terminazione rettilinea con cap-pelle allineate alle estremità, impianto definito dalla storio-grafia plan bernardin o bernhardinischer Grundtypus e che pre-vede un alzato variamente articolato.
A partire dal XII secolo circa, gli esiti architettonici del-l’architettura religiosa occidentale sono ancora apprezzabilinelle città e nelle strutture monastiche e conventuali, in unprosieguo di vita e di funzione che ne ha garantito la soprav-vivenza. Il contributo dell’archeologia nella definizione degliimpianti romanici è sostanzialmente riservato alla lettura de-gli alzati, per cogliere le tracce di strutture precedenti o le vi-cende subite, secondo il metodo stratigrafico, oppure alle in-dagini degli ambienti annessi, al fine di ricomporne gli assettiarchitettonici. Ciò non toglie che singoli siti rivelino possibi-lità di indagini archeologiche importanti ai fini della ricom-posizione di complessi più tardi, ma comprensibili solo graziead interventi, come nel caso delle indagini nel centro di Assisi,in relazione ai luoghi della tradizione francescana, di pievi ru-rali dell’Italia settentrionale, di complessi ecclesiastici d’Oltralpe.Ai fini delle ricostruzioni volumetriche e dei moduli decora-tivi, lo studio si compone strettamente con quello specifica-tamente storico-artistico.
Bibl.: Oltre agli atti dei Congressi Nazionali e Internazionali di ArcheologiaCristiana, si vedano: K. Conant, Carolingian and Romanesque Architecture800-1200, Harmondsworth 1978; C. Heitz, L’architecture religieuse caro-lingienne: les formes et leurs fonctions, Paris 1980; P. Testini, ArcheologiaCristiana, Bari 19802, pp. 545-751; R. Krautheimer, Architettura paleo-cristiana e bizantina, Torino 19855; G. Pugliese Carratelli (ed.), Dall’eremoal cenobio, Milano 1987; G. Cantino Wataghin, Monasteri di età longo-barda: spunti per una ricerca, in CARB XXXVI (1989), pp. 73-100; M.E.Savi et al., s.v. Architettura in legno, in EAM, II, 1991, pp. 397-406; V.Ascani - G. Binding, s.v. Cantiere, ibid., IV, 1993, pp. 159-75; M. RighettiTosti-Croce, s.v. Cistercensi. Strutture di produzione, ibid., pp. 852-71; R.Hodges - J. Mitchell (edd.), San Vincenzo al Volturno, I-IV, London 1993-2000; A.M. Giuntella, Cornus I, 1-2, Oristano 1999-2000 (con bibl. prec.);L. Pani Ermini (ed.), Christiana Loca (Catalogo della mostra), Roma 2000.
Francesca Romana Stasolla
L’ARCHITETTURA FUNERARIA
L’architettura funeraria postclassica è ben nota nelle sue for-me pienamente medievali grazie ai numerosi monumenti an-cora in elevato, spesso conservatisi all’interno di aule di culto,e ampiamente studiati dagli storici dell’arte. Il contributo del-l’indagine archeologica appare determinante invece per i pe-riodi tardoantico e altomedievale, quando le fonti attestano ladiffusa presenza di edifici funerari, conservatisi per felici coin-cidenze o spesso noti attraverso scavi. Non sempre è agevole
distinguere le forme dell’architettura funeraria, soprattuttoquando queste assumono funzioni e valenze differenti, quan-do cioè diventano, come nel caso degli edifici destinati ai cul-ti martiriali, monumentalizzazione della sepoltura e contem-poraneamente sede e strumento del rito: allora i legami conl’architettura religiosa sono talmente stretti da risultare talorainscindibili e si assiste alla polivalenza delle forme architetto-niche e alla concatenazione degli spazi, che si intersecano e siarticolano al fine di consentire la celebrazione sia della me-moria che del culto. La diffusione del culto dei martiri e la vo-lontà di residenti e pellegrini di trovare sepoltura accanto aicorpi venerati determinarono nelle aree suburbane la nascitadi veri e propri nuclei cimiteriali dalle peculiari caratteristichearchitettoniche. Il suburbio romano, per la precocità e le di-mensioni del fenomeno, costituisce un vero e proprio exem-plum, anche per il costituirsi di strutture di ricezione funzio-nali alla celebrazione dei riti funebri. Alcuni impianti basili-cali nascono sicuramente con vocazione funeraria e nonliturgica, tanto da essere definiti, almeno tra IV e VIII secolo,coemeteria dal Liber Pontificalis della Chiesa di Roma.
Si devono a Costantino alcuni dei primi impianti nei pres-si delle sepolture degli apostoli e dei più importanti martiriromani, impianti caratterizzati sul piano architettonico dauna particolare icnografia: un’aula basilicale nella quale la na-vata centrale è circondata dalle due laterali che si congiungo-no sul retro dell’abside semicircolare in un corridoio anula-re. Di tali strutture se ne conoscono con certezza sei, tuttecollocate presso i più importanti santuari o nuclei funerari:S. Lorenzo, S. Agnese, S. Sebastiano (Basilica Apostolorum),Ss. Marcellino e Pietro e le basiliche anonime della via Ar-deatina e del cimitero di Callisto, cui va aggiunta in via ipo-tetica quella nei pressi della catacomba di Pretestato. Cro-nologicamente si collocano tutte nella prima metà del IV se-colo, con la supposta eccezione dell’aula laurenziana, per laquale è stata proposta una datazione alla prima metà del Vsecolo, sotto il pontificato di Sisto III. Le dimensioni parti-colarmente ampie (66-99,5 ™ 28-40 m) erano in qualche ca-so accresciute dalla presenza di portici (Ss. Marcellino e Pietroe la basilica del comprensorio callistiano); sia questi che glispazi interni erano invasi da sepolture pavimentali. Si è vo-luto vedere il prototipo di tale impianto nell’architettura cir-cense, donde la denominazione di “circiformi” per queste ba-siliche, che sovente erano circondate da mausolei, che pote-vano essere comunicanti con l’aula di culto, nella definizionedi uno spazio privo di un punto focale, né liturgico, né cele-brativo di una specifica memoria, ma dinamico nella poli-percorrenza degli spazi e all’occorrenza utilizzato per il ritodel refrigerium collettivo.
PERIODO TARDOANTICO E MEDIEVALE
171
201
Interno del mausoleo di S. Costanza a Roma.
Il pasto funebre rituale infatti prosegue nel periodo postclassico,servendosi di strutture che vanno dalle semplici mensae addossate allesepolture a vere e proprie costruzioni, come nel caso della cosiddetta“abside occidentale” a Cimitile. In quest’ultimo caso, proprio le in-dagini archeologiche hanno consentito di riconoscere in questa strut-tura, contrapposta e cronologicamente successiva alla basilica di S.Felice, la sede di riti funebri e commemorativi sia in occasione dellafesta del martire che per i semplici defunti, le cui sepolture affollava-no il santuario, riti noti dalle fonti e testimoniati dalla presenza dei re-sti ributtati all’esterno dell’abside. Anche in ambito catacombale, talepratica viene rivelata sia dalla presenza di tombe a mensa, sia soprat-tutto da impianti ad essa specificatamente destinati. È questo il casoad esempio della grande sala con pozzo e bancali (precedente la metàdel IV sec.) originariamente all’aperto, antistante l’Ipogeo dei Flavi,poi inglobata nella catacomba di Domitilla a Roma. Allo stesso scopoera destinato il triclinio scavato nel tufo delle catacombe di Malta, concratere centrale per la deposizione delle offerte.
Edifici con funzione funeraria, veri e propri cimiteri copertisia pure nelle forme architettoniche di aule di culto, si riscon-trano nel periodo paleocristiano ed altomedievale presso al-cuni santuari martiriali anche fuori Roma, come nel caso del-la basilica di S. Tommaso nel complesso feliciano di Cimitile,databile su base stratigrafica tra VI e VII secolo e nella qualele sepolture sono state previste in connessione fisica con le fon-dazioni della chiesa. Strutture analoghe sembrano essere sor-te anche in relazione ad un abitato, come per la basilica diPianabella ad Ostia e per quella di S. Ilario ad Bivium a Val-montone, entrambe note grazie alle indagini archeologiche.Dal punto di vista architettonico, si tratta di aule basilicali diriutilizzo o di nuova costruzione nelle quali lo spazio appareprogrammaticamente articolato in sepolture a forno, anche apiù piani, che occupano l’intera superficie pavimentale. In am-bito monastico, la necessità di circoscrivere uno spazio fune-rario per i membri della comunità comportò la costruzione dianaloghe basiliche appositamente dedicate alle deposizioni.
Esempi ben conservati sono rintracciabili sia in Oriente (nu-merosi i casi siriani, come ad Antiochia, a Qasr al-Gharbi,Qalat Seman, ecc.), sia in Occidente (S. Saba a Roma).
Un esempio particolare di chiese in ambiente funerario è costituitodalle basiliche ad corpus, la cui struttura appare fortemente condizio-nata dalla tomba venerata, che viene a trovarsi sempre sotto l’altare ocomunque nell’area absidale, e che per questa ragione talvolta sono se-mi-ipogee. In molti casi questa costruzione rappresenta la prima mo-numentalizzazione architettonicamente rilevante della sepoltura, anchese nella maggior parte dei casi l’aula di culto assume connotazioni li-turgiche. Dal punto di vista strutturale, però, questi martyria rispon-dono ai canoni della coeva architettura funeraria, e almeno in alcunicasi appare evidente la volontà di distinguere l’aspetto legato alla me-moria da quello liturgico. Già all’inizio del IV secolo, presso Salona, ilmausoleo di Asclepia prevedeva due livelli, l’inferiore destinato ad ospi-tare le spoglie del martire Anastasio e il superiore funzionale alla litur-gia, con l’altare posto in corrispondenza della sepoltura venerata; que-sta articolazione spaziale si ritrova in epoca appena successiva anche inaltri siti dell’area balcanica (Pécs, Travnik, ecc.). Un’estensione di que-sto concetto si attua con la realizzazione di basiliche destinate ad ospi-tare non i corpi santi, ma le reliquie, la cui valenza simbolica si espri-me in maniera pregnante nell’esempio delle quattro costruzioni am-brosiane a Milano, disposte a croce a difesa della città.
Il primo e più significativo esempio di costruzione funeraria dedi-cata alla memoria è rappresentato dalla chiesa costantinopolitana dedi-cata agli apostoli, in realtà una sorta di martyrium a pianta cruciformedestinato ad accogliere le reliquie degli apostoli e le spoglie dello stessoimperatore. La stessa pianta ricorre in edifici sia orientali, ad esempio ilmartyrium di S. Babila ad Antiochia, che occidentali, come nel caso del-le chiese milanesi degli Apostoli e di S. Simpliciano. La pianta cru-ciforme, nel suo pregnante significato cristologico, ben si prestava a que-sto tipo di edifici, che all’incrocio dei bracci accoglievano le memoriedei martiri, imagines Christi, per altro ben visibili da ogni parte dellastruttura. Un esempio particolarmente eclatante è costituito dal san-tuario siriaco di Qalat Seman, dedicato a s. Simeone Stilita, nel qualeal centro ottagonale sorge la colonna venerata. I bracci, spazi seconda-ri, potevano essere utilizzati in vario modo, ad esempio per ospitare l’al-tare, essere suddivisi in navate, avere terminazione rettilinea o absidata.Dipendono dalla coeva architettura funeraria con schema a pianta cen-trale anche edifici memoriali come la Basilica della Natività a Betlemmee il santuario del Monte degli Ulivi. L’esempio più caratteristico è co-stituito comunque dall’Anastasis di Gerusalemme, voluta da Costantinosul sepolcro di Cristo, che si innalzava sotto un baldacchino al centrodel monumento a pianta circolare con deambulatorio esterno.
In questo filone vanno considerate anche le strutture edifi-cate per ospitare le reliquie venerate in urbe quando, a partiredalle guerre greco-gotiche, le condizioni del suburbio appar-vero precarie sia per l’integrità dei corpi santi che per la sicurez-za dei devoti, in un processo che troverà a Roma in Pasquale I(817-824) il più attivo realizzatore. A tale pontefice si devono,tra l’altro, la costruzione della cappella di S. Zenone, realizzataquasi interamente con materiale di spoglio in parte rilavorato,annessa alla chiesa di S. Prassede con le stesse modalità archi-tettoniche che in altri contesti legano i mausolei all’edificio diculto principale. Dalla monumentalizzazione della sepolturavenerata e dalla corrispondenza tra questa memoria e la cele-brazione liturgica che si svolge sull’altare immediatamente so-vrapposto nasce la creazione delle cripte al di sotto degli alta-ri. Se ne hanno esempi già in ambiente catacombale, come nelcimitero romano ad duas lauros, in connessione con le sep-polture dei ss. Marcellino e Pietro, negli anni attorno al 330-340. Appare comunque evidente il rapporto tra basiliche funera-rie e/o liturgiche, mausolei e cripte in complessi ormai noti an-che grazie a indagini archeologiche globali (ad es., S. Lorenzoa Grenoble), in qualche caso con mutamenti funzionali checonsentono ad un mausoleo di essere trasformato in cripta,come a S. Gervasio a Ginevra. Più isolate rispetto al com-plesso funerario sono le cripte semianulari, inaugurate da Gre-gorio Magno per S. Pietro in Vaticano e poi ampiamente dif-fuse in relazione alle reliquie venerate ricondotte in urbe.
BACINO DEL MEDITERRANEO, EUROPA E MONDO ISLAMICO
172
202
Il Mausoleo
di Teodorico a Ravenna
in un disegno
di ignoto (XVI sec.).
Vienna,
Graphische Sammlung
Albertina.
Un aspetto particolare di architettura “in negativo” è datodalle catacombe, cimiteri sotterranei che, pur non essendo diorigine specificatamente cristiana, vennero intensamente svi-luppati a partire dalla fine del II secolo e soprattutto dalla pa-ce religiosa (313) da parte della Chiesa nascente, complici an-che l’incremento demografico e il prevalere della pratica del-l’inumazione. L’uso delle catacombe si diffuse nelle aree dovela costituzione geologica ben si adattava allo scavo di gallerie,che sovente utilizzarono, riadattandoli, cave di arenaria (cata-comba di Priscilla a Roma) e cunicoli idraulici (catacomba diS. Giovanni a Siracusa), oppure ipogei precedenti (di età pu-nica nel caso di S. Antioco in Sardegna). Se ne conosconoesempi, oltre ai celeberrimi casi romani, nell’Italia centro-me-ridionale (Venosa), a Malta, nel Nord Africa, in Palestina, siain ambito cristiano che giudaico. Le gallerie, cui si accedevamediante una scala o più raramente a livello del terreno, me-
diante un ingresso scavato alle falde di un rilievo, avevano unadisposizione diversa, a seconda del tipo di terreno e dell’even-tuale sfruttamento di preesistenze, quali condotte idriche onuclei ipogei precedenti.
Alle sepolture in semplici loculi scavati sui lati delle galle-rie si alternano strutture più curate, sempre prodotte in nega-tivo, mediante escavazione, o con integrazioni murarie chehanno dato luogo ad ambienti come il mausoleo funerario del-la catacomba di Pretestato a Roma e la Cappella Greca nel ci-mitero di Priscilla o a soluzioni sepolcrali particolari, quali ibaldacchini dei cimiteri a Malta e in Sicilia e della catacombadei Ss. Marcellino e Pietro a Roma, oppure le teorie di sarco-fagi scavati nella roccia della “rotonda dei sarcofagi” dell’ipo-geo di S. Lucia a Siracusa. In qualche caso la presenza di strut-ture aggiunte arricchisce e completa i risultati dell’escavazio-ne, come a Milo, in Grecia, dove arcosoli familiari, intonacatie decorati ad affresco, dotati di nicchie per le lampade, pre-sentano una chiusura con transenne su pilastri. Alcune di que-ste necropoli ipogee potevano essere segnalate in superficie daingressi monumentali o da scale di accesso, come ad esempioin Siria (Qalat Kalota, Ruwayha), dove la diffusa pianta qua-drata prevede coperture a cupola o cuspidate, nella connes-sione inscindibile tra le sepolture del piano inferiore e la mo-numentalizzazione in superficie (mausoleo di Diogene ad Hass).Nella medesima regione, tentativi di monumentalizzazione disepolture più modeste sono rappresentati da sarcofagi su baserialzata e copertura cuspidata. Sviluppo particolarmente este-so in superficie, sia pure su un nucleo di partenza ipogeo, hail complesso che costituisce il santuario dei Sette Dormientiad Efeso, con sale absidate ed arcosoli.
Attorno ai complessi martiriali, in necropoli subdiali o ipo-gee di ampie dimensioni o anche nell’isolamento di residenzeauliche sorgono svariati tipi di mausolei e cappelle funerarie,la cui icnografia varia dalla semplice pianta absidata a formepiù complesse (polilobate, a triconco, ecc.). I mausolei tar-doantichi non si discostano tipologicamente dai precedentiromani: è questo il caso soprattutto di quelli legati a perso-naggi di rango imperiale. In età tetrarchica si diffonde il mo-dello che si ispira al Pantheon, posto in connessione con altrestrutture comunque di rappresentanza, come avviene ad esem-pio presso i palazzi di Diocleziano a Spalato e di Galerio a Sa-lonicco, all’inizio del IV secolo. Questi schemi costruttivi e,per quanto riguarda strettamente i mausolei ad essi collegati,icnografici ricorrono nel corso dello stesso secolo a Roma, nelmausoleo di Romolo e in quello legato alla villa dei Gordianisulla via Prenestina, e in Spagna, a Centcelles, presso Tarragona.Del monumento funerario di Romolo, voluto da suo padreMassenzio nel complesso palaziale lungo la via Appia, resta ilsolo piano inferiore dei due livelli previsti; è a pianta circola-re e percorso internamente da un corridoio anulare. La strut-tura funeraria catalana, nata sull’impianto di una villa di II se-colo, prevede un’aula quadrata all’esterno e circolare con nic-chie lungo le pareti all’interno, cupolata, con mosaici cherappresentano scene di caccia ed episodi vetero- e neotesta-mentari e con ogni probabilità era destinata ad accogliere lespoglie di Costante II.
Una tappa importante nell’evoluzione concettuale dei mau-solei prevede non solo mutamenti icnografici, quanto piutto-sto nuove connessioni, in relazione alle aule di culto cristianee ai santuari martiriali.
Gli esempi più noti si devono a Costantino e alla sua famiglia: ilmausoleo di Costanza, figlia dell’imperatore, annesso alla basilica cir-ciforme di S. Agnese sulla via Nomentana; il mausoleo di Elena, lega-to ad un’analoga chiesa dedicata ai Ss. Marcellino e Pietro sulla viaLabicana. Quest’ultimo si conserva quasi integralmente nelle sue for-me originarie, con pianta circolare preceduta da un atrio a forcipe,deambulatorio interno voltato a botte, copertura a cupola e decora-
PERIODO TARDOANTICO E MEDIEVALE
173
203
Valva di dittico con scene neotestamentarie. Milano, Castello Sforzesco.
zione musiva con scene dal Vecchio Testamento, Traditio Legis e TraditioPacis, oltre a scene di genere. La pianta centrale viene utilizzata anchenel caso di mausolei ipogei, come in quello di Tipasa, edificato nel IVsecolo come camera funebre vescovile, con sarcofagi posti in arcosoliricavati nelle pareti. A pianta ottagonale era il mausoleo attribuito aMassimino, rinvenuto nell’area della necropoli paleocristiana di S.Vittore a Milano, oltre agli ambienti annessi a S. Lorenzo Maggiore,nella medesima città, che si suppone fossero originariamente mauso-lei e che presentano nicchie alternate circolari e rettangolari. Un ova-le trasformato in ottagono mediate l’aggiunta di lobi laterali vieneutilizzato per il mausoleo di Pécs in Pannonia (V sec.).
Connotazione imperiale ha anche il mausoleo annesso alla basili-ca di S. Croce a Ravenna, a pianta cruciforme e con ricca decorazio-ne musiva, voluto da Galla Placidia nella prima metà del V secolo persé e per esponenti della sua famiglia; anch’esso si presenta ormai sal-damente connesso con l’aula di culto, sia sul piano strutturale che persintassi decorativa, a conferma delle nuove direttrici cultuali date dalcristianesimo. Pianta basilicale mononave presentano piccoli ambien-ti funerari ad al-Bahnasa; sempre in Egitto, la necropoli sviluppatasinei pressi del monastero di Bawit prevede anche cappelle funebri dimodeste dimensioni, con interessante decorazione dipinta. L’omogeneitàdi modelli architettonici appare evidente ad esempio nella necropolidi al-Bagawat, dove i mausolei cristiani possono essere identificati so-lo se recano simboli cristologici inequivocabili. Annessi alle struttureliturgiche compaiono tra IV e V secolo piccoli edifici funerari a pian-ta cruciforme, a tricora, rettangolare anche nell’Europa centrale, convolta a botte o cupolati in Egitto (Bawit). Alcune cappelle finisconoper ospitare le spoglie vescovili, ad esempio a Ravenna. Si differenziadai prototipi romani il mausoleo di Teodorico, voluto a Ravenna dalre goto nella prima metà del VI secolo. Tale differenza si esplica nontanto nella pianta centrale cupolata, con una teoria di arcate che arti-colano il piano inferiore, quanto piuttosto nella tecnica costruttiva,che prevede l’uso di conci litici uniti a secco e la cupola monolitica.
A partire dal VI e soprattutto dal VII secolo la diffusionedelle sepolture urbane comportò l’utilizzo di spazi legati alleaule di culto (portici in Britannia e in Gallia) e soprattutto lacostruzione di cappelle funerarie annesse agli edifici di culto.Le sepolture più importanti finirono con l’invadere gli spaziinterni delle chiese urbane (ad es., l’abbazia di Westminster aLondra, St.-Denis a Parigi, il duomo di Monreale) o mona-stiche (ad es., St.-Étienne a Caen, il monastero di S. María laReal de Huelgas ad Oviedo), fino a trasformarle in veri e pro-pri templi dinastici. Dal IX secolo, si diffondono le cappelle-ossari (come quella dell’abbazia di Fulda), che nei due secolisuccessivi nei Paesi d’Oltralpe, soprattutto in Germania, inAustria, in Svizzera, sono edificate contigue alle chiese.
Bibl.: A. Grabar, Martyrium, Paris 1946; P. Testini, Le catacombe e gli an-tichi cimiteri cristiani di Roma, Bologna 1966; Id., Archeologia Cristiana,Bari 19802; R. Chapmann - I. Kinnes - K. Randsborg (edd.), The Ar-chaeology of Death, Cambridge 1981; Y. Duval - J.-Ch. Picard (edd.), L’in-humation privilégiée du IVe au VIIe siècle en Occident. Actes du Colloque(Créteil, 16-18 mars 1984), Paris 1986; Y. Duval, Auprès des Saints corpset âme. L’inhumation “ad sanctos” dans la chrétienté d’Orient et d’Occidentdu IIIe au VIIe siècle, Paris 1988; W. Gaddoni, Il mausoleo di Teodorico,Ravenna 1990; M. Torelli, Le basiliche circiformi di Roma: icnografia, fun-zione, simbolo, in G. Sena Chiesa - E.A. Arslan (edd.), Felix TemporisReparatio. Atti del Convegno Archeologico Internazionale (Milano 1990),Milano 1992, pp. 203-17; M. Delle Rose, s.v. Cimitero, in EAM, IV, 1993,pp. 770-85; N. Duval - C. Bozzoni, s.v. Cappella, ibid., pp. 229-46; M.Delle Rose, s.v. Mausoleo, ibid., VIII, 1997, pp. 274-80; Ph. Pergola, Lecatacombe romane. Storia e topografia, Roma 1997.
Francesca Romana Stasolla
MONDO BIZANTINO
PREMESSA
I caratteri propri dell’impero bizantino, la cui vicenda si svi-luppò su un arco cronologico di oltre undici secoli (tra il IV eil XV sec.) e su un’area territoriale assai vasta e in continua tra-sformazione, rendono assai problematico individuare e defi-nire caratteristiche unitarie comuni alla sua produzione ar-chitettonica, sia riguardo ai materiali e alle tecniche edilizieprevalentemente impiegati, sia riguardo alla tipologia funzio-nale degli edifici, sia infine all’evoluzione in senso diacronicodei principali tipi architettonici. A una conoscenza sistemati-ca dell’architettura bizantina sotto il profilo archeologico sifrappongono poi ostacoli dettati dal livello qualitativo e quan-titativo degli edifici conservati e dallo stato di avanzamentodella ricerca nei diversi settori. Il patrimonio architettonicobizantino è infatti rappresentato in larga misura dall’ediliziareligiosa e in particolare dalle chiese, la cui sopravvivenza e lacui continuità funzionale come luoghi di culto sono state spes-so assicurate dalla trasformazione in moschee dopo la con-quista islamica. Ben attestate sono poi le architetture a diver-so titolo collegate con le installazioni militari, presenti in qua-si tutto il territorio imperiale, giacché praticamente tutte leregioni storiche dell’impero si trovarono, in tempi e circostanzediversi, ad assumere il ruolo di aree di frontiera. Almeno neicentri maggiori e in primo luogo a Costantinopoli si conser-va poi qualche traccia dell’edilizia residenziale delle élites do-minanti, mentre assai più limitate – anche in ragione delle spo-liazioni subite dalla capitale in occasione del saccheggio cro-ciato del 1204 e della conquista ottomana del 1453 – sono letestimonianze relative all’arredo monumentale urbano, la cuientità e le cui caratteristiche principali possono comunque es-sere ricostruite attraverso le fonti.
Assai più rari sono le fonti e i dati archeologici relativi adaltri aspetti della produzione architettonica bizantina, in pri-mo luogo per quel che concerne l’edilizia residenziale urbanadelle classi intermedie e inferiori, ma anche per tutto quel che
BACINO DEL MEDITERRANEO, EUROPA E MONDO ISLAMICO
174
204
Martyrium della basilica
di S. Maria Formosa
a Pola, Croazia.